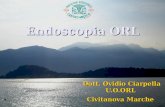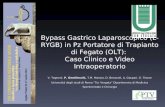Monitoraggio intraoperatorio in chirurgia otorinolaringoiatrica
Click here to load reader
Transcript of Monitoraggio intraoperatorio in chirurgia otorinolaringoiatrica

� I – 46-543
Monitoraggio intraoperatorio in chirurgiaotorinolaringoiatrica
A. Uziel, F. Venail, R. Garrel, C. Cartier
Il monitoraggio può essere definito dall’insieme delle tecniche che permettono di fornire al chirurgoun’informazione sulla funzione di un nervo cranico durante un intervento chirurgico. Esso è divenutoin questi ultimi anni uno strumento di aiuto nella chirurgia otorinolaringoiatrica, in particolare nellachirurgia cervicale, otologica o della base del cranio. Questa tecnica è stata inizialmente sviluppataper il monitoraggio della funzione facciale durante la chirurgia dello schwannoma vestibolare, poi si èampliata ai settori della chirurgia dell’orecchio medio, della parotide e della tiroide. Essa permette diaiutare il chirurgo a individuare le strutture nervose, ma, soprattutto, di avvertirlo mediante un allarmeogni volta che il suo gesto è traumatizzante per il nervo. Parallelamente si sono sviluppate delle tecnicheelettrofisiologiche di monitoraggio dell’attività del nervo cocleare che, benché non scatenino un allarmein tempo reale, forniscono delle informazioni durante l’intervento sulla funzione uditiva e consentono distabilire una prognosi sulla conservazione dell’udito al termine dell’intervento. Attraverso questo articolo,spiegheremo in dettaglio i metodi che permettono il monitoraggio motorio e sensoriale dei nervi della basedel cranio, dalla loro origine fino al loro tragitto extracranico. Preciseremo le indicazioni del monitoraggiodei nervi nella chirurgia della base del cranio, in chirurgia otologica e in chirurgia cervicale, specificandoi risultati attesi, ma anche e soprattutto i limiti di questi metodi, di cui il medico deve essere pienamentecosciente.© 2013 Elsevier Masson SAS. Tutti i diritti riservati.
Parole chiave: Monitoraggio; Paralisi; Tiroidectomia; Parotidectomia; Mastoidectomia;Schwannoma vestibolare
Struttura dell’articolo
■ Introduzione e cenni storici 1■ Monitoraggio del nervo faciale 2
Tecniche di registrazione 2Monitoraggio nei tumori dell’angolo pontocerebellare 3Monitoraggio nella chirurgia dell’orecchio medio 4Monitoraggio nella chirurgia della parotide 4
■ Monitoraggio laringeo nella chirurgia tiroidea 6Monitoraggio dei nervi ricorrenti Nervi laringei inferiori 6Monitoraggio dei nervi laringei superiori 9
■ Monitoraggio della funzione uditiva 9Tecniche di monitoraggio della funzione uditiva 9Indicazioni e risultati del monitoraggio della funzione uditiva inotoneurologia e in otologia 11Conclusioni 13
■ Monitoraggio della funzione motoria dei nervi misti nellachirurgia dell’angolo pontocerebellare e del foramegiugulare 14
■ Conclusioni 14
� Introduzione e cenni storiciLa chirurgia otorinolaringoiatrica (ORL) e cervicofacciale è una
chirurgia a rischio per un certo numero di nervi cranici, in parti-colare per il nervo faciale, il nervo cocleare e i nervi misti. Questinervi possono essere traumatizzati o anche sezionati, con con-seguenze funzionali gravi. L’identificazione dei nervi cranici puòrivelarsi particolarmente difficile nelle patologie che modificano ireperi anatomici, come le patologie tumorali o infiammatorie. Neitumori, sono la struttura propria e il decorso del nervo che pos-sono essere modificati, rendendo la dissecazione particolarmentedifficile e fonte di traumi.
Le lesioni postoperatorie dei nervi cranici determinano deideficit funzionali temporanei o permanenti che possono essereoggetto di richieste di risarcimento e di pregiudizi. Fra questecomplicanze, due sono citate con maggiore frequenza in periziamedicolegale. Una paralisi facciale può comparire dopo chirurgiadell’orecchio, chirurgia della base del cranio (tumori dell’angolopontocerebellare, chemodectomi timpanogiugulari), ma anchedopo chirurgia parotidea. Essa provoca delle conseguenze funzio-nali, ma anche estetiche, particolarmente invalidanti. In chirurgiacervicale, la paralisi ricorrente è la complicanza più grave e piùfrequente della chirurgia tiroidea.
EMC - Tecniche chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale 1Volume 17 > n◦1 > ottobre 2013http://dx.doi.org/10.1016/S1292-3036(13)65429-2

I – 46-543 � Monitoraggio intraoperatorio in chirurgia otorinolaringoiatrica
Per ridurre queste complicanze è stato messo a punto ilmonitoraggio intraoperatorio. Questa tecnica ha l’obiettivo diaiutare il chirurgo a individuare le strutture nervose per lachirurgia e di avvisarlo con un allarme ogni volta che ilsuo gesto chirurgico è traumatizzante per il nervo. L’allarme,quando è emesso senza ritardi, permette al chirurgo di inter-rompere immediatamente il gesto in corso e di modificareeventualmente la sua tecnica di dissecazione e la sua strategiachirurgica.
I chirurghi otologici hanno compreso molto rapidamente lanecessità di prevenire i rischi iatrogeni sul nervo faciale durantela chirurgia dell’orecchio. Nei primi tempi, chiedevano all’aiutodi porre la mano sulla faccia. Essi hanno, così, inventato una tec-nica primitiva di monitoraggio, efficace per i tempi delicati dellachirurgia dell’orecchio, ma inapplicabile nella chirurgia cervico-facciale e della base del cranio.
Il primo approccio strumentale è stato realizzato nel 1965 daJako, a partire da un rilevatore fotoelettrico posto contro la fac-cia interna della guancia e che emetteva un segnale acusticoquando si aveva una contrazione. Nel 1979, Delgado et al. [1] sonostati i primi da utilizzare l’elettromiografia (EMG) per monito-rare il nervo faciale per la chirurgia dell’angolo pontocerebellare.Nel 1985, Silverstein ha rimodernato il dispositivo di Jako uti-lizzando un rilevatore di pressione ultrasensibile fissato a livellodella commissura labiale. Il dispositivo emetteva un segnale diallarme istantaneo ogni volta che il nervo faciale era stimolatomeccanicamente durante la dissecazione. L’apparato incorporavaun dispositivo di stimolazione elettrica a corrente continua chepermetteva di identificare il nervo faciale per mezzo di una sondaisolata fino alla sua estremità.
Nel periodo 1985-2000, esistevano due tipi di monitoraggioper il nervo faciale, i dispositivi a localizzazione meccanica tipoSilverstein e i dispositivi a localizzazione EMG. I dispositivi a loca-lizzazione meccanica avevano come carta vincente il loro bassoprezzo e come principale inconveniente il fatto di emettere degliallarmi senza rapporto con una stimolazione del nervo faciale,ogni volta che vi era un appoggio contro la faccia attraverso i teli.Durante questi anni, sono stati commercializzati diversi disposi-tivi, come il SilversteinTM WR-S8 Facial Nerve Monitor/Stimulatoro i dispositivi Myo Alarm® od OpalarmTM, messi a punto rispet-tivamente da Zini [2] e Uziel [3], che utilizzavano un rilevatore dipressione pneumatico posto contro la faccia interna della guancia.Questi sistemi sono stati progressivamente abbandonati a vantag-gio dei rilevatori EMG, che restano oggi i dispositivi di riferimentograzie alle loro ottime sensibilità e specificità.
Lo sviluppo dei monitoraggi EMG ha permesso il loro utilizzonella chirurgia parotidea [4] e, poi, nella chirurgia tiroidea.
Il monitoraggio della funzione uditiva è molto più complessonel suo principio, in quanto l’acquisizione del segnale non si puòfare in tempo reale e non permette, quindi, di avvertire imme-diatamente il chirurgo durante un gesto traumatizzante. I primimonitoraggi della funzione uditiva sono stati realizzati da Moller eJanetta nel 1983 nel corso di interventi di decompressione vasco-lare nell’angolo pontocerebellare, per mezzo di elettrodi applicatidirettamente a contatto con il nervo cocleare. Si sono sviluppatesuccessivamente le tecniche di registrazione dei potenziali evo-cati uditivi del tronco cerebrale (PEUTC), per mezzo di elettrodiincollati sullo scalpo.
Così, attualmente, il monitoraggio dei nervi cranici sembraessere un metodo imprescindibile nell’esercizio della chirur-gia ORL e cervicofacciale. In questo articolo sono illustratele varie tecniche di monitoraggio applicabili alle chirurgie arischio di lesione dei nervi motori e sensitivi della faccia e delcollo, con le loro indicazioni, i loro risultati e i loro rispettivilimiti.
� Monitoraggio del nervo facialeIl nervo faciale può essere traumatizzato in molti interventi
ORL, ma soprattutto nella chirurgia degli schwannomi vestibo-lari e nella chirurgia parotidea. Le paralisi facciali costituisconoun handicap importante, con conseguenze allo stesso tempo
estetiche e funzionali: impossibilità di chiudere le palpebre, com-plicanze oculari, lacrimazione, ipotonia della guancia e cadutadella commissura labiale e difficoltà nell’alimentazione e nellacomunicazione.
Le cause del trauma che può coinvolgere il nervo faciale sononumerose.
Tecniche di registrazionePrincipi della stimolo-individuazione
Descriveremo qui solo il monitoraggio tramite localizzazioneEMG dell’attività dei muscoli del volto, tenuto conto del fattoche non esistono più oggi in commercio dispositivi di monitorag-gio mediante localizzazione meccanica. L’EMG è la registrazionedell’attività elettrica dei muscoli per mezzo di elettrodi impiantatinel muscolo.
Un dispositivo di monitoraggio EMG comprende, in genere,tre parti: un’unità di localizzazione (composta da un amplifica-tore e da un sistema di trattamento del segnale e di emissionedi un allarme sonoro), un preamplificatore differenziale situatonell’immediata prossimità della testa del paziente su cui sicollegano gli elettrodi di registrazione e, infine, un’unità di sti-molazione elettrica che eroga una corrente regolabile in volt o inintensità.
Si utilizza, in genere, una localizzazione bipolare con unpaio di elettrodi monopolari montati in parallelo e impiantatinell’orbicolare delle palpebre e delle labbra (eventualmente ilmuscolo frontale e zigomatico, se si dispone di un registratorea quattro canali). Per la chirurgia parotidea, il monitoraggio puòessere mirato su un certo gruppo muscolare che dipende dal ter-ritorio del nervo faciale da dissecare, in particolare in caso dichirurgia per recidiva. Occorre anche posizionare un elettrodo dimassa per la localizzazione EMG e un elettrodo di massa per la sti-molazione. Gli elettrodi sono mantenuti con dei cerotti o dei fili disutura, per evitare uno spostamento intempestivo sotto i teli ope-ratori. Non appena gli elettrodi sono stati posizionati, si verifica laloro impedenza e si verifica il buon funzionamento del sistema dilocalizzazione applicando una pressione manuale a contatto congli elettrodi.
Una presa filtrante è connessa al cavo della coagulazionebipolare per eliminare gli artefatti elettromagnetici legati alla sti-molazione. Nella chirurgia parotidea, si lascia generalmente ilvolto visibile attraverso un telo sterile adesivo per si assicurarsiche non vi siano movimenti durante l’utilizzo della coagulazionebipolare, che disattiva solitamente il monitoraggio.
Il segnale elettrico rilevato dagli elettrodi è amplificato e puòessere interpretato in uscita visuale, su uno schermo a cristalliliquidi, o acustica, attraverso un altoparlante. Gli apparecchimoderni visualizzano solo i segnali in rapporto con una stimo-lazione (elettrica o meccanica) e non il rumore di fondo. Alcontrario, il chirurgo percepisce in continuo il segnale EMG difondo ed è avvertito da un allarme di forte intensità non appenauna stimolazione del nervo scatena un’attività EMG. Alcuni appa-recchi dispongono di trattamenti che rendono muti i segnali chenon sono in rapporto con una stimolazione chirurgica, in partico-lare le stimolazioni elettromagnetiche associate all’utilizzo dellacoagulazione bipolare.
Le fibre muscolari sono organizzate in unità motorie, valea dire un gruppo di fibre attivate dallo stesso motoneurone.Quando le fibre nervose sono stimolate in corso di intervento,la placca motrice è attivata e libera un trasmettitore chimico(l’acetilcolina) che scatena la contrazione dei fasci muscolari. È,quindi, importante evitare l’utilizzo di derivati del curaro nelcorso dell’induzione. La stimolazione nervosa provoca una rispo-sta quasi istantanea (con un ritardo di alcuni millisecondi), il chefornisce un feedback quasi in tempo reale.
Le attività EMG sono state classificate in due categorie daPrass [5] (Fig. 1):• le risposte ripetitive corrispondono a delle attività di lunga
durata sotto forma di depolarizzazioni ripetitive che conti-nuano a essere emesse diversi secondi dopo la sospensione dellamanovra chirurgica stimolante. Esse sono state designate con iltermine «treni». Le si può osservare dopo stimolazione termica
2 EMC - Tecniche chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

Monitoraggio intraoperatorio in chirurgia otorinolaringoiatrica � I – 46-543
250 µV
A100 ms
250 µV
B
2
1
100 ms
Figura 1. Tracciati miogenici caratteristici osservabili nel corso di una dissecazione del nervo faciale (secondo [90]).A. Esempi di treni, di durata e di frequenza variabili. Il tracciato in alto mostra un treno continuo di impulsi il cui inizio e la cui fine sono indicati da frecce. Iltracciato in basso mostra la successione di vari treni di una durata di 100 ms, di frequenza variabile.B. Esempi di risposte tipo «impulsi» (1. spikes) e «scariche» (2. bursts). Le frecce bianche e nere indicano degli eventi di ampiezza differente registrati sullostesso canale.
(fisiologica fredda) o meccanica (trazione) e, in quest’ultimocaso, rivelano al chirurgo che il suo gesto è traumatizzante peril nervo;
• le risposte non ripetitive si osservano dopo stimolazione mec-canica diretta o elettrica del nervo faciale. Si tratta di rispostedi breve durata in stretta relazione temporale con lo stimolo,che sono state designate «scariche» (bursts), dopo stimolazionemeccanica, o «impulsi» (spikes), dopo stimolazione elettrica.
Materiali e modalità di registrazione delle attivitànervose
Attualmente, sono disponibili in commercio diverse strumen-tazioni utilizzabili nel monitoraggio del nervo faciale intra- oextracranico. Gli apparecchi più adatti sono i neurostimolatori-rilevatori mono- o multicanale (NeuroSign 100, 400, 800, NIMTM
due-otto canali).Questi apparecchi sono utilizzati con una duplice funzione:
• funzione di localizzazione semplice, in quanto rispondono aqualsiasi stimolazione meccanica (trazione intempestiva, mani-polazione con una pinza, coagulazione) in prossimità di unramo nervoso, il che porta all’attenzione del chirurgo la neces-sità di una maggiore cautela nella prosecuzione del suo gesto;
• funzione di stimolazione-localizzazione nella ricerca di unramo nervoso che sarà rilevato e riconosciuto dalla sonda distimolazione. La stimolazione nervosa è modulabile in inten-sità, il che permette un adattamento dell’intensità in funzionedella distanza rispetto al nervo.Il chirurgo beneficia di un dispositivo di stimolazione elettrica
per permettergli di identificare il nervo e di realizzare delle misurea scopo prognostico.
In genere, la stimolazione elettrica è erogata sotto formadi impulsi rettangolari di una durata di 100 �s. Vi sono statinumerosi dibattiti sulla modalità di stimolazione monopolareo bipolare. La stimolazione monopolare è quella più frequente-mente utilizzata, in quanto il costo dei materiali di consumo èpiù basso. Lo svantaggio della stimolazione monopolare è il suodifetto di precisione legato alla diffusione della corrente in tuttele direzioni. Al contrario, la stimolazione bipolare è molto piùaccurata, in quanto la corrente causa uno stimolo solo quando idue elettrodi sono posti a contatto con il nervo, ma questa meto-dica presenta per tale motivo più rischi di falsi negativi. Si sonoavute anche molte discussioni sulla modalità di erogazione dellastimolazione elettrica a intensità o a voltaggio costanti [6]. I dispo-stivi attuali più comunemente utilizzati funzionano a intensitàcostante.
Il chirurgo deve avere una buona conoscenza delle soglie nor-mali di stimolazione elettrica se vuole identificare correttamenteil nervo faciale e seguire il suo decorso. Così, il nervo faciale sulfondo del condotto uditivo interno può rispondere a stimolazionicomprese tra 0,05 e 0,15 mA. Se si utilizzano delle stimolazionidi intensità più elevata, per esempio 0,3 mA, e una sonda distimolazione monopolare, tutte le strutture anatomiche con lequali la sonda è stata posta a contatto danno luogo a un segnaledi allarme inappropriato di stimolazione facciale. Al contrario,
nell’orecchio medio, non è raro che il nervo faciale nel suo canaleosseo risponda solo a delle stimolazioni di 1 mA o più. Nellaparotide, il tronco del nervo faciale all’emergenza dal forame stilo-mastoideo e i suoi rami di divisione sono generalmente stimolabilia intensità di 0,3 mA. Inoltre, nel quadro della chirurgia dellaregione parotidea, l’intensità di stimolazione è regolata in unagamma di valori che vanno da 0,3 a 0,8 mA, per una frequenzadi quattro stimolazioni/s. La soglia di rilevazione degli eventi è disolito fissata a 100 �V.
Complicanze del monitoraggio faccialeLe complicanze sono rare.
Monitoraggio nei tumori dell’angolopontocerebellare
Il monitoraggio del nervo faciale è stato utilizzato princi-palmente nei tumori dell’angolo pontocerebellare (schwannomivestibolari, meningiomi), ma anche nelle neurotomie vestibolarie nelle decompressioni neurovascolari. Il suo utilizzo risponde atre obiettivi.
Identificare il nervo faciale e determinare il suodecorso
Utilizzando un elettrodo di stimolazione e un’intensità di circa0,2 mA, il chirurgo può individuare molto precisamente il nervofaciale sul fondo del condotto uditivo interno e alla sua emergenzadal tronco cerebrale, fin dall’inizio dell’intervento. Il chirurgo puòutilizzare un elettrodo bipolare o un elettrodo monopolare isolatofino alla sua estremità. Se utilizza un elettrodo monopolare, eglideve, se possibile, aspirare il liquido cerebrospinale intorno allazona di stimolazione, per evitare degli effetti di shunt che potreb-bero causare falsi negativi. Viceversa, se si vuole chiaramenteidentificare il nervo faciale sul fondo del condotto e separarloda una struttura nervosa adiacente, come il nervo vestibolaresuperiore, è preferibile utilizzare una sonda bipolare, molto piùselettiva, per ridurre i rischi di falsi positivi.
Egli può, in seguito, determinare il decorso del nervo facialea contatto con il tumore (mapping). Quest’ultimo, nel corso delsuo sviluppo, stira e appiattisce il nervo in stretto contatto con ilvelo aracnoideo che circonda il tumore, modificando profonda-mente il suo decorso anatomico. Questa identificazione inizialepermette, se può essere realizzata, di ridurre i rischi di trauma o disezione del nervo durante la dissecazione.
Rilevare le stimolazioni vulneranti durantela dissecazione
Uno dei principali interessi del monitoraggio è quello di avver-tire il chirurgo in tempo reale delle stimolazioni indotte dallemanipolazioni meccaniche del nervo faciale. Egli può anche cono-scere le conseguenze funzionali della sua dissecazione e adattare lasua tecnica chirurgica e, se necessario, la sua strategia chirurgica,
EMC - Tecniche chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale 3

I – 46-543 � Monitoraggio intraoperatorio in chirurgia otorinolaringoiatrica
in funzione delle informazioni fornite dal monitor, perché essa siameno traumatizzante possibile. In questo senso, si può dire cheil monitor insegna a operare per preservare al massimo il nervofaciale.
Gli allarmi brevi tipo bursts derivano, in genere, da un contattodolce con il nervo e non testimoniano una sofferenza nervosa.Al contrario, gli allarmi lunghi ripetitivi tipo treni indicano unadepolarizzazione prolungata e testimoniano un certo grado dimicrotraumatismo che deve spingere il chirurgo a interromperela sua dissecazione. Lo stesso vale se si produce un aumentosignificativo dell’attività EMG di base. Si osserva generalmentequesto tipo di risposta in caso di trazioni sul nervo. La ripeti-zione di questo tipo di allarme fa correre un rischio di bloccodi conduzione, che rende il monitoraggio muto durante le dis-secazioni a monte del trauma. Si possono anche osservare deitreni dopo l’irrigazione del sito operatorio con soluzione fisiolo-gica; si tratta, allora, di una stimolazione termica che non ha,ovviamente, alcun carattere prognostico infausto. Se, viceversa, sirealizza una vaporizzazione del tumore con un laser, delle rispostetipo treno indicano un innalzamento della temperatura in pros-simità immediata del nervo faciale e devono spingere il chirurgoa interrompere l’utilizzo del laser e a irrigare il sito operatorio consoluzione fisiologica.
Fornire una prognosi sulla funzione faccialepostoperatoria
Al termine dell’intervento, è possibile valutare l’eccitabilità elet-trica del nervo faciale e definire una prognosi sulla funzionefacciale postoperatoria. Il test più semplice consiste nello sti-molare elettricamente il nervo faciale alla sua uscita dal troncocerebrale.
Si possono schematicamente riscontrare tre condizioni:• il nervo faciale è eccitabile a una soglia vicina alla soglia
misurata prima dell’exeresi chirurgica: si può affermare cheil nervo ha un’integrità anatomica e funzionale e che ilpaziente avrà una funzione facciale postoperatoria subnor-male o un deficit limitato, ma non si può escludere losviluppo di una paralisi facciale ritardata legata a dei fenomeniedematosi;
• il nervo faciale è eccitabile a una soglia superiore rispetto aquella misurata all’inizio dell’intervento: vi sono un’integritàanatomica del nervo faciale, ma anche una lesione fun-zionale che si tradurrà verosimilmente in un deficitpostoperatorio;
• il nervo faciale è ineccitabile a intensità di stimolazioni elevate(più di 1 mA); è il caso più grave; il chirurgo ipotizza o un bloccodi conduzione, che può localizzare, o una sezione del nervofaciale.Nei casi in cui il nervo è eccitabile elettricamente, è possibile
stimare la funzione facciale postoperatoria misurando la soglia distimolazione prossimale. Sobottka [7] ha dimostrato che i pazientiche hanno una soglia superiore a 0,3 mA hanno una funzionefacciale postoperatoria di grado da III a V. Bozorg Grayeli et al. [8]
hanno dimostrato che il 93% dei pazienti che hanno una soglia distimolazione prossimale tra 0,1 e 0,3 mA ha una funzione faccialeanormale (grado I o II) all’8
◦giorno. Selesnick [9] ha mostrato che
il 90% dei pazienti con una soglia di stimolazione prossimale a0,1 mA ha una funzione facciale normale o subnormale a 1 anno(contro il 58%, se la soglia è di 0,2 mA e il 41%, se la soglia è di0,3 mA).
Altri autori [10, 11] hanno dimostrato che si aumenta il valoreprognostico se si associano le informazioni della soglia di stimo-lazione prossimale, dell’ampiezza della risposta e del rapporto diampiezza prossimale/distale.
Monitoraggio nella chirurgia dell’orecchiomedio
Benché nessuno contesti l’utilità del monitor facciale nellachirurgia dei tumori dell’angolo pontocerebellare, il suo uti-lizzo sistematico nella chirurgia dell’orecchio medio è ancoraoggetto di discussioni. L’incidenza delle lesioni del nervo faciale
nella chirurgia dell’orecchio medio resta ancora eccezionale,dell’ordine di un caso su 1 000-4 000 interventi, a seconda degliautori (a eccezione della chirurgia dei chemodectomi).
Il monitoraggio facciale dovrebbe essere ampiamente utilizzatoin quattro casi: la chirurgia del colesteatoma, delle malformazionidell’orecchio, degli impianti e dei chemodectomi. Il rapporto2010 della principale compagnia di assicurazione registra quattrocasi di paralisi facciale dopo chirurgia del colesteatoma, che sonostati oggetto di un contenzioso. Nella chirurgia del colesteatoma,il monitoraggio facciale permette di identificare il nervo faciale edi prevenire una stimolazione meccanica su un nervo deiscente alivello della sua porzione timpanica. Esso permette anche di rea-lizzare una timpanotomia posteriore ampia prevenendo il rischiodi contatto tra il nervo faciale e la fresa a livello della sua porzionemastoidea.
Nella chirurgia delle malformazioni dell’orecchio, il monitorag-gio facciale è indispensabile per individuare il nervo faciale e perprevenire un rischio di lesione. Esso è anche molto utile nellachirurgia degli impianti cocleari e degli impianti dell’orecchiomedio, quando la via d’accesso richiede una timpanotomia poste-riore. Alcuni fabbricanti commercializzano un motore la cui fresadiamantata può essere collegata a una stimolazione elettrica, peravvertire il chirurgo non appena la fresa arriva a poca distanza dalnervo faciale [12].
Infine, il monitoraggio è indispensabile in tutte le chirurgiedell’orecchio medio o della base del cranio che richiedono unaccesso al segmento labirintico, una via sottofacciale o una devia-zione del nervo faciale (chemodectomi, colesteatomi primitividella rocca, granulomi da colesterina).
Si può discutere dell’utilizzo del monitoraggio nelle timpano-plastiche semplici con mastoidectomia, nelle ossiculoplastiche onella chirurgia dell’otosclerosi. Le deiscenze spontanee sono fre-quenti (circa il 40%) e, in questo caso, il nervo faciale può esserestimolato con una soglia media di 0,3 mA a livello della porzionetimpanica e di 0,4 mA a livello della porzione mastoidea [13]. Nonesiste alcuna prova che il monitoraggio riduca il rischio di paralisifacciale in questi tipi di interventi. Uno studio recente ha segna-lato anche tre casi di paralisi facciali conseguenti all’utilizzo diun laser durante interventi per colesteatoma, senza che il moni-toraggio facciale avesse prodotto allarmi [14]. Alcuni consiglianocomunque l’utilizzo sistematico del monitoraggio nella chirur-gia dell’orecchio medio, ritenendo che esso abbia un rapportocosto-efficacia favorevole e che riduca il rischio di paralisi faccialeiatrogena [15]. Ricordiamo, tuttavia, che il monitoraggio non sosti-tuirà mai una buona conoscenza anatomica dell’orecchio medioe dei reperi del nervo faciale.
Monitoraggio nella chirurgia della parotideLa chirurgia della parotide è un intervento i cui rischi e i cui esiti
funzionali sono dominati dalla paralisi facciale postoperatoria. Lariduzione della iatrogenia relativa alla funzione del nervo faciale è,quindi, la prima preoccupazione del chirurgo cervicofacciale, cosìcome del paziente, tanto più che, in materia di parotide, si trattadi una chirurgia per tumore benigno nell’80% dei casi [16]. Inol-tre, esistono delle circostanze particolari dove il rischio di paralisifacciale postoperatoria è aumentato, come nella chirurgia dellarecidiva di un adenoma pleomorfo [17] e nei carcinomi della paro-tide [18]. Anche in queste situazioni si compiono tutti gli sforzi perridurre l’intensità e la durata di una paralisi facciale.
Se la strumentazione operatoria non si è evoluta in questi ultimi30 anni, l’apporto del monitoraggio non ha cessato di alimentarei dibattiti sul suo interesse medico, ma anche sul suo ruolo medi-colegale attraverso, in particolare, la letteratura scientifica, conalcune equipe che lo utilizzano come standard di trattamento ealtre che lo giudicano inutile e fonte di false informazioni [19, 20].
I principali interessi attesi del monitoraggio nella chirurgiaparotidea sono la riduzione dell’incidenza di paralisi facciale, inparticolare di paralisi facciale definitiva, la riduzione dell’intensitàdi questa paralisi, la facilitazione della procedura di parotidec-tomia con un guadagno di tempo, in particolare in caso direintervento, e, infine, l’aspetto pedagogico per ottimizzare lasicurezza durante la fase di apprendimento dei giovani chirurghi.
4 EMC - Tecniche chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

Monitoraggio intraoperatorio in chirurgia otorinolaringoiatrica � I – 46-543
Epidemiologia della paralisi faccialepostoperatoria
L’incidenza della paralisi facciale nella chirurgia della parotidesi situa tra il 7% e il 68%, con sequele a lungo termine segnalatetra lo 0% e il 19%.
Utilizzo del monitoraggio nella chirurgiaparotidea
Nella chirurgia di prima intenzione dove la dissecazione nonpresenta difficoltà particolari, l’attivazione del segnale avvertedella vicinanza del tronco o di un ramo. Una volta individuatoil nervo, la dissecazione prosegue in maniera classica e il monito-raggio è utile in seguito solo per informare dell’importanza dellaripercussione dei gesti operatori sul nervo.
Il feedback ottenuto con il monitoraggio permette al chirurgodi essere avvisato di danni legati alla dissecazione del nervo facialee anche a delle aggressioni intempestive, come un’eccessiva tra-zione da parte dei divaricatori, e questo senza necessità di unaiuto operatorio che controlli grossolanamente una contrazionedei muscoli pellicciai del volto.
Al termine dell’intervento, alcuni accordano un valore pro-gnostico della funzione facciale alla capacità del nervo di esserestimolato. La stampa di un documento cartaceo può aiutare ladiscussione con il paziente sulla prognosi di un’eventuale paralisifacciale [23].
Malgrado ciò, il chirurgo deve essere consapevole dell’esistenzadi artefatti, legati ai movimenti degli strumenti, in particolare deidivaricatori, così come dell’esistenza di segnali falsamente nega-tivi. I segnali falsamente negativi possono manifestarsi in casodi livello di stimolazione insufficiente, subliminare, e quando ilramo stimolato non è monitorato. Così, questo tipo di segnalepuò procurare una falsa sensazione di sicurezza e può causare unasezione di un ramo utile.
Nella chirurgia delle recidive, l’aiuto di un monitoraggio acqui-sta tutto il suo interesse, in quanto la ricerca dei rami nervosi edel tronco del nervo è molto più difficile e la dissecazione si ese-gue, il più delle volte, in modo retrogrado. Una volta identificatii rami distali del nervo in una zona non operata in precedenza,la dissecazione progredisce innanzitutto verso la biforcazione e,quindi, il tronco del nervo, per affrontare la zona della prece-dente exeresi. Le difficoltà di identificazione e di dissecazione deirami nervosi sono, allora, massime, poiché la fibrosi perinervosaimpedisce ogni dissecazione a contatto con i rami, il cui aspettobianco madreperlaceo caratteristico dei filamenti nervosi non èpiù visibile. Il monitoraggio permette all’operatore di seguire ifilamenti nervosi senza denudarli, evitando, così, di danneggiarel’epinevrio. La modulazione dell’intensità di stimolazione per-mette di assicurarsi della maggiore o minore vicinanza del nervo. Èimportante, in queste manovre, non stimolare il nervo con inten-sità troppo forti o inopportune, per evitare la comparsa di cloniduraturi che parassitano la rilevazione e per conservare una buonaeccitabilità del nervo.
Indicazioni del monitoraggioBenché molti operatori si aiutino con un neurostimolatore por-
tatile monouso durante la localizzazione iniziale del nervo faciale,l’utilizzo di un monitoraggio continuo del nervo faciale per qual-siasi chirurgia parotidea non è la regola.
Chirurgia di prima intenzioneIl «monitoraggio intraoperatorio» del nervo faciale non ha
dimostrato il suo interesse in modo formale. Alcuni lavori rife-riscono dei tassi di complicanze facciali meno importanti e unariduzione del tempo operatorio in caso di monitoraggio [21, 22, 24, 25].Questi risultati non sono osservati in altri articoli, dove ilconfronto dei risultati di un gruppo di pazienti operati sotto moni-toraggio e di un gruppo senza monitoraggio non rivela differenzesignificative [20, 26], al di fuori di situazioni chirurgiche partico-lari che possono modificare i reperi abituali di ricerca del tronco(tumori aderenti all’emergenza, tumore molto voluminoso, amaggior ragione a sviluppo sottofacciale, tronco del nervo diffi-cilmente accessibile senza rischio di rottura del tumore o accesso
pericoloso per il nervo, dove il monitoraggio può facilitare la loca-lizzazione del nervo, tanto più che spesso la sua dissecazione saràrealizzata in modo retrogrado).
Infine, in alcuni casi particolari come nella chirurgia dei tumorisviluppati a spese del prolungamento parafaringeo, i dispositivi aquattro vie possono fornire un comfort supplementare, in quantoconsentono il monitoraggio contemporaneo della VII e delle altrecoppie craniche (IX-X-XII-XI).
Chirurgia di seconda intenzione (dopo parotidectomialaterale o totale)
È in questa eventualità che il monitoraggio continuo rive-ste tutto il suo interesse. Si possono incontrare due situazioni:da una parte, una recidiva unica anteriore dopo parotidecto-mia totale sviluppata sul prolungamento peristenonico, dall’altradelle recidive multiple dopo parotidectomia esofacciale o totale(Fig. 2).
In caso di recidiva unica anteriore, il monitoraggio permettedi affrontare rapidamente la zona della recidiva, se necessariocon un’incisione indipendente, e di isolare i rami nervosi situativicino al tumore. Questo evita e limita la dissecazione nei tessutifibrosi, riducendo l’esposizione nervosa e offrendo una maggioresicurezza nei confronti del nervo.
In caso di recidive multiple, il gesto iniziale spesso è stato unaparotidectomia classica esofacciale e la recidiva è o profonda,nel tessuto parotideo sottofacciale, o in periferia, lungo i ramidi divisione del nervo. Questa eventualità è temibile per il chi-rurgo che esegue la ripresa e per la funzione facciale, in quantol’identificazione e la dissecazione dei differenti rami sono moltodifficili.
Tenuto conto di queste difficoltà, per ridurre il rischio faccialeè necessario fare ricorso a tutti i mezzi a nostra disposizione, tracui il monitoraggio intraoperatorio del nervo faciale è uno tra itanti (dissecazione retrograda, microscopio operatorio, strumentidi microchirurgia). Nella nostra pratica, il monitoraggio continuodel nervo faciale si è rivelato un aiuto prezioso, permettendo dievitare di sezionare un ramo del nervo facilitando la sua identifi-cazione, ma non evitando le difficoltà né di localizzazione né didissecazione del nervo faciale.
Infine, occorre in ogni momento essere pronti a verificarele informazioni fornite dal neurostimolatore e diffidare di un«collaboratore elettronico» suscettibile di disfunzione.
RisultatiUna quindicina di studi clinici si incentra sull’evidenziazione
di un interesse obiettivo del monitoraggio nella chirurgia dellaparotide. Questi sono riassunti in una pubblicazione recente diEisele et al. [23]. In sostanza, solo due studi casi-controlli mostranoun interesse obiettivo del monitoraggio in termini di riduzionedella durata della paralisi facciale postoperatoria [22, 26]. Uno stu-dio dello stesso tipo dimostra la riduzione del grado di paralisie una riduzione della durata operatoria in caso di chirurgia perripresa [17].
La maggior parte degli studi è retrospettiva e, quindi, di bassolivello di prova. Solo tre studi sono prospettici [21, 27, 28], ma nonpermettono di oggettivare un guadagno circa la funzione delnervo faciale. Il numero di pazienti in questi studi è basso, da 17a 117, per una media di 46 e con delle casistiche talvolta eteroge-nee in termini di patologia, di tecnica chirurgica e di materiale dimonitoraggio. Infine, il modo di valutazione della paralisi faccialenon è sempre simile.
L’incidenza di una paralisi definitiva è, in queste serie di esperti,relativamente bassa, dell’ordine del 3-5%; così, per ottenereuna potenza statistica sufficiente, uno studio clinico dovrebbecomprendere più di 1 000 pazienti, il che è difficilmente realiz-zabile [23].
Di fronte al razionale scarso degli studi clinici, l’analisi dellepratiche professionali mostra un’altra realtà.
A titolo di esempio, l’American Academy ha pubblicato i suoirisultati nel 2005 [19]: il 60% dei chirurghi che praticano delle paro-tidectomie utilizza un monitoraggio. L’utilizzo è più frequente peri chirurghi che hanno un cursus lungo (resident e fellowship) e peri chirurghi che sono stati formati al monitoraggio durante i lorostudi, qualunque sia la loro durata. Il monitoraggio è utilizzato dai
EMC - Tecniche chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale 5

I – 46-543 � Monitoraggio intraoperatorio in chirurgia otorinolaringoiatrica
A B C
D E
Figura 2. Monitoraggio del nervo faciale durante la chirurgia parotidea per recidiva. Implementazione di un monitoraggio del nervo faciale su quattro canaliche studiano l’attività elettrica del muscolo frontale (elettrodo blu), orbicolare delle palpebre (elettrodo rosso), orbicolare delle labbra (elettrodo violetto) eabbassatore del labbro inferiore (elettrodo arancione) (A-C). L’elettrodo di massa (verde) e l’elettrodo di riferimento per la stimolazione monopolare (bianco)sono impiantati nella regione toracica. Al momento della ripresa chirurgica della parotidectomia, la stimolazione intraoperatoria del tronco del nervo faciale(D) a un’intensità di 0,30 mA permette di visualizzare un’attività elettrica sotto forma di potenziale d’azione su ciascuno dei muscoli monitorati (E).
chirurghi che praticano più parotidectomie per anno. L’inchiestaprecisa che i chirurghi stimano di avere un 20% di opportunità inmeno di trovarsi di fronte a problemi medicolegali se impieganoun monitoraggio.
In questo studio, i criteri più citati a favore dell’utilizzodel monitoraggio erano l’aiuto all’identificazione del nervo,l’interesse medicolegale, il miglioramento della sicurezza e l’ideache si tratti di uno standard di ripresa in carico. I criteri più spessocitati contro l’utilizzo di un monitoraggio sono la sua mancanzadi utilità, la pratica basata sulla conoscenza anatomica e tecnica,l’esistenza di falsi negativi del monitoraggio e di artefatti e, quindi,un’informazione non pertinente.
Dal punto di vista formale, il chirurgo fornisce l’informazionepreoperatoria al paziente e al medico curante, il che rinforza lapercezione che tutti i mezzi siano messi in opera per conser-vare e proteggere la funzione del nervo faciale, il che rassicuranotevolmente il paziente. In realtà, al meglio, il monitorag-gio intraoperatorio del nervo faciale permette di apportareun’informazione che faciliterà alcuni tempi dell’intervento. Nonsi tratta di un antidoto contro una mancanza di esperienzachirurgica, una stima erronea della situazione o una tecnica chi-rurgica inadeguata. In condizioni semplici di tumore benignodella parte esofacciale della parotide, non è stata apportata alcunaprova di una superiorità del risultato funzionale. Viceversa, incondizioni difficili e, in particolare, in caso di tumore parafarin-geo o di chirurgia per recidiva di adenoma polimorfo, l’utilizzodi un monitoraggio presenta un interesse in termini di esitifunzionali.
Tuttavia, dato che alcune situazioni difficili possono nonessere previste e che il chirurgo e il personale di sala operatoriarichiedono una curva di apprendimento, numerose equipe preco-nizzano un utilizzo sistematico di routine del monitoraggio nellachirurgia della parotide.
� Monitoraggio laringeo nellachirurgia tiroidea
Sono presentati l’epidemiologia, le conseguenze funzionali ei principi di prevenzione delle paralisi laringee secondarie allachirurgia tiroidea.
Monitoraggio dei nervi ricorrenti - Nervilaringei inferioriPrincipi
Per ridurre il rischio chirurgico nella chirurgia mono- e bila-terale della tiroide, il monitoraggio dei nervi ricorrenti è statointrodotto nella pratica clinica a partire dal 2000 [27]. Il monito-raggio dei nervi ricorrenti consiste in una localizzazione EMG conelettrodo a contatto con le corde vocali (Fig. 3) oppure all’internodel muscolo vocale (elettrodi intramuscolari).
Sono stati studiati numerosi sistemi di monitoraggio nervoso:la palpazione laringea, la fibroscopia laringea intraoperatoria, lapressione glottica, gli elettrodi intracordali posizionati per viaendoscopica o per via esterna attraverso la membrana cricotiroi-dea, il tubo endotracheale e l’elettrodo di superficie retrocricoideo.Per numerose ragioni di sicurezza e di semplicità, i sistemi dellesonde endotracheali sono i più utilizzati [29].
Il principale obiettivo del monitoraggio è di valutare l’integritàfunzionale del nervo ricorrente con uno studio intraoperatorio.Questa informazione permette di modificare il gesto chirurgico edi evitare di correre il rischio di una paralisi bilaterale. Gli altriobiettivi consistono nell’apportare un’informazione prognosticain caso di constatazione postoperatoria di una paralisi ricorren-ziale. Infine, è utile nella ricerca e nella dissecazione del nervo
6 EMC - Tecniche chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

Monitoraggio intraoperatorio in chirurgia otorinolaringoiatrica � I – 46-543
A B C
D
Figura 3. Monitoraggio dei nervi ricorrenti durante la chirurgia tiroidea.A. L’installazione del paziente avviene in posizione di Rose verificando bene che la testa sia nell’asse delcorpo per non modificare la posizione del tubo tracheale durante la chirurgia.B. La sonda di intubazione comporta due elettrodi di superficie, che sono posizionati sulle corde vocali.Il posizionamento corretto può essere confermato con la misurazione delle impedenze.C. La stimolazione del nervo laringeo inferiore sinistro a 0,30 mA permette di registrare un’attività elet-tromiografica del muscolo vocale sinistro.D. Accanto ai metodi di individuazione con elettrodi di superficie, è possibile anche monitorare ilmuscolo vocale con elettrodi impiantati.
ricorrente in una situazione chirurgica difficile, in particolare incaso di reintervento e di gozzo voluminoso o nella chirurgia deicarcinomi tiroidei localmente invasivi.
InstallazioneDifferenti metodi di monitoraggio del nervo ricorrente sono
riferiti in letteratura: i metodi che utilizzano degli elettrodi disuperficie posizionati sulla sonda di intubazione (Fig. 3) e letecniche per impianto diretto nel muscolo vocale. Le soglie distimolazione sono simili qualunque sia la metodica e i risultatisono paragonabili.
Gli elettrodi di rilevazione possono essere integrati alla sondadi intubazione o incollati su una sonda di intubazione classica.
Il posizionamento della sonda di intubazione è cruciale erichiede una perizia particolare da parte del professionista che lamette in sede, abitualmente un medico o un infermiere aneste-sista. La sonda di intubazione deve essere del calibro più ampiopossibile, per ottimizzare il contatto tra gli elettrodi e le cordevocali. Occorre badare a che non vi sia nessun agente lubrificanteche ricopra la sonda né un accumulo di saliva tra la sonda e lalaringe. Tutto questo disturba sempre la conduzione elettrica.
Una volta posizionati gli elettrodi di rilevazione, gli elettroditransdermici che corrispondono al polo positivo dello stimolatoree alla massa sono posizionati a distanza, solitamente sul torace delpaziente, badando a distanziarli di almeno 2 cm.
Gli elettrodi sono connessi all’interfaccia e il differenziale cheindica l’impedenza all’estremità degli elettrodi di superficie èverificato per un valore ottimale inferiore a 1 K�. Infine, un dispo-sitivo antiparassitario è posizionato intorno alla pinza bipolare.Lo stimolatore collegato all’estremo negativo è posto sul tavoloin maniera sterile. La sua estremità è collegata in maniera nonsterile dall’infermiere di sala al commutatore. Il generatore dellapinza bipolare deve essere mantenuto a distanza dal monitor delmonitoraggio per evitare le interferenze.
La sonda deve essere fissata, secondo la nostra opinione, medial-mente, per evitare qualsiasi mobilizzazione secondaria. Il pazienteè, allora, posto in posizione operatoria secondo le abitudini eil buon posizionamento della sonda è verificato controllando ildifferenziale delle impedenze, che deve restare inferiore a 1 k�.Per Randolph, l’ottenimento di un tracciato di base sul moni-tor fatto di piccole ondulazioni di 30-70 �V garantisce il buon
posizionamento della sonda [29]. L’ultima verifica è realizzata almomento della stimolazione del nervo ricorrente o del nervovago, che produce un potenziale d’azione.
Principi di utilizzo del monitoraggio dei nerviricorrentiScoperta e identificazione del nervo ricorrente
In situazioni di dissecazione classica della loggia tiroidea, ilnervo ricorrente è, il più delle volte, reperito senza difficoltà. Lastimolazione con un’intensità che varia tra 0,2 e 1 mA permette diassicurarsi che si tratti realmente del ramo motorio per la laringe,ottenendo una curva EMG bifasica (Fig. 3) dopo un tempo dilatenza la cui durata dipende dalla distanza che separa il puntodi stimolazione dal muscolo vocale. In caso di divisione bassadel nervo ricorrente, il ramo faringeo più posteriore può esserescoperto per primo e far ritenere, erroneamente, che si tratti deltronco del nervo ricorrente. In questo caso, la stimolazione di que-sto ramo non produce un potenziale d’azione, ma una contrazionedel muscolo cricofaringeo, facilmente visibile. Occorre verificare,in questo caso, che esistano una latenza così come un potenzialebifasico, in quanto un segnale falsamente positivo può essere otte-nuto se la sonda di intubazione è leggermente troppo affondata.Vi è, allora, una stimolazione diretta, facilmente riconosciuta perl’assenza di un tempo di latenza e del potenziale bifasico.
Negli studi recenti, il tasso di identificazione del nervo conl’ausilio del monitoraggio è valutato pari a circa il 99% [30].
Malgrado ciò, occorre insistere sul fatto che il gold standarddella protezione del nervo laringeo resta l’individuazione visivadel nervo ricorrente basata su conoscenze anatomiche affidabili esu un’esperienza chirurgica confermata. Il monitoraggio non puòin nessun caso compensare una tecnica inadatta e una praticainsufficiente della chirurgia tiroidea. L’utilizzo dello stimolatorecome sonda di ricerca del nervo, senza averlo precedentementeindividuato, non è, quindi, raccomandato.
Si deve, d’altronde, confrontare il risultato fornito dal monito-raggio con l’impressione del chirurgo. Reciprocamente, quandouna struttura simile al nervo ricorrente non risponde alla stimola-zione, occorre ricercare un malfunzionamento del monitoraggio.Può trattarsi di uno o di più elettrodi scollegati, dello spostamentodella sonda di intubazione, dell’utilizzo di una sonda di intuba-zione di diametro troppo piccolo, di uno stimolatore difettoso, di
EMC - Tecniche chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale 7

I – 46-543 � Monitoraggio intraoperatorio in chirurgia otorinolaringoiatrica
un problema di fusibile sul commutatore, di un’intensità di sti-molazione troppo debole quando il nervo è rivestito di tessutograsso o connettivo e dell’uso di curari. L’insieme di questi incon-venienti corrisponde ai falsi positivi (nervo funzionale ma perditadel segnale che simula una paralisi).
Una volte escluse queste possibili disfunzioni, si tratta, allora,di un blocco di conduzione nervosa che indica una paralisi ricor-renziale molto probabile.
A quale livello stimolare il nervo ricorrente?Il nervo ricorrente può essere stimolato su tutto il suo decorso.
Per evitare i falsi negativi (paziente che presenta una paralisi men-tre la stimolo-individuazione produce un potenziale d’azione),occorre stimolare il nervo nel punto più basso della zona di disse-cazione per testare tutta la porzione a valle che è esposta al rischiodi trauma (Fig. 3).
La stimolazione del nervo vago permette di eliminare il pro-blema dell’altezza di stimolazione, poiché è testato tutto ildecorso del nervo ricorrente. Si parla, allora, di stimolazione«indiretta» [31]. Tuttavia, questa tecnica implica un accesso chirur-gico alla doccia giugulocarotidea. Data la distribuzione fascicolaredelle fibre del nervo vago, la stimolazione delle fibre nervose desti-nate al nervo ricorrente richiede, a volte, una stimolazione di tuttala circonferenza del nervo vago. La stimolazione del nervo vagoprovoca una risposta motoria sulla corda vocale con una latenzamaggiore rispetto a una stimolazione sul nervo ricorrente. Essa èdell’ordine di 5,4 ms a destra e di 8,1 ms a sinistra. Una tale latenzasu un documento stampato fornisce la certezza che si tratta vera-mente di una stimolazione a livello del nervo vago. La latenza adestra può essere inferiore in caso di nervo laringeo inferiore nonricorrente.
Per alcuni autori, tra cui Dralle, la stimolazione del nervo vago èpiù affidabile della stimolazione del nervo ricorrente [30, 32]. Sensi-bilità, specificità e valore predittivo positivo e negativo sarebberosuperiori a quelli ottenuti con stimolazione del nervo ricorrente.Così, questi autori raccomandano la stimolazione sistematica delnervo vago. Essa si giustifica, per noi, in caso di dubbio su unaparalisi del nervo ricorrente.
Come e a quale intensità stimolare il nervo ricorrente?L’intensità di stimolazione è regolata sul monitor. È possibile
ricercare la soglia di stimolazione che induce una risposta motoriaoppure realizzare una stimolazione sopramassimale e studiare icriteri di ampiezza e di latenza.
Per definizione, l’ampiezza del potenziale d’azione ottenutocon la stimolazione aumenta con l’intensità di stimolazione finoalla soglia detta «sopramassimale», determinata da Randolph a0,8 mA [29]. Oltre questa intensità di stimolazione, l’ampiezza dellarisposta rimane identica.
L’intensità soglia corrisponde all’intensità di stimolazionenecessaria per ottenere una risposta EMG e un segnale sonoro dirisposta. Essa varia in funzione del grado di dissecazione del nervo,della presenza o meno di un campo emorragico e del contatto tral’elettrodo di stimolazione e il nervo.
Alcuni autori raccomandano di confrontare la soglia di stimola-zione al termine dell’intervento con quella ottenuta al momentodella scoperta del nervo ricorrente. Il delta di stimolazione traquesti due istanti permette di determinare se il nervo è funzio-nale o meno. Se, in uno stesso punto di stimolazione, il nervolaringeo inferiore è stimolabile alla stessa intensità prima dellarealizzazione della tiroidectomia e dopo, il delta di stimolazioneè nullo e la probabilità di avere un nervo traumatizzato è estre-mamente bassa. Viceversa, un delta di stimolazione superiore a0,4 mA fa sospettare una paralisi. Tra 0,2 e 0,4 mA, la paralisiè incerta e l’informazione della stimolazione del nervo vago inintensità sopramassimale permette uno studio complementaredell’ampiezza della risposta, che traduce la funzione motoria delnervo ricorrente.
La stimolazione sopramassimale con analisi dell’ampiezza delpotenziale d’azione e della latenza di comparsa di questo poten-ziale è raccomandata da alcuni autori. Il valore soglia allo stessotempo per l’ampiezza e per il ritardo, a partire dal quale il nervoè paralizzato, non è determinato in letteratura. Esso dipendein particolare dall’importanza della dissecazione del nervo edall’interfaccia elettrodo-nervo (emorragica, umida, asciutta).
La persistenza di un potenziale d’azione dopo stimolazionesignifica che almeno una parte del nervo è funzionale, senzagarantire per questo una contrazione efficace dei muscoli cri-coaritenodei e del muscolo vocale. L’alterazione del segnalerappresenta un rischio sostanziale di paralisi, senza poterprevedere se questa sia completa e se sia definitiva omeno.
RisultatiLa tecnica del monitoraggio è valutata in numerosi studi. Sen-
sibilità, specificità e valore predittivo positivo e negativo sonorispettivamente del 53-86%, del 94%, del 33-60% e del 97%. Esisteuna variabilità molto grande dei risultati. Si dovrebbe riscontrareuna certa omogeneità di risultati, se fosse rispettato un algoritmodi utilizzo e di controllo del monitoraggio [29].
Non è, tuttavia, possibile concludere in maniera formale se unnervo è paralizzato o meno. Analogamente, non vi sono argo-menti formali che permettono di stabilire se una paralisi saràtransitoria o definitiva [31, 33–36].
La grande maggioranza degli studi attuali non permette di evi-denziare una differenza statisticamente significativa di paralisi trachirurgia monitorata e non monitorata. Tenuto conto del mode-sto tasso delle paralisi ricorrenziali, sarebbe necessario un numeromolto elevato di casi in ogni braccio. Dralle valuta pari a 9 milioniil numero di pazienti da includere per individuare una differenzastatisticamente significativa tra pazienti monitorati e non moni-torati per un intervento di exeresi di un gozzo benigno. Questonumero di casi è valutato pari a 40 000 in caso di cancro. Solo deglistudi multicentrici prospettici su grande scala permetterebbero ditrarre delle conclusioni, a condizione che i metodi di stimolazionesiano identici.
Malgrado questi limiti metodologici, noi riteniamo che i datidel monitoraggio devono portare a modificare, in alcuni casi, lastrategia chirurgica. Così, nel caso di un intervento programmatodi tiroidectomia totale, se il monitoraggio indica un’anomaliadella conduzione, salvo in casi particolari, il gesto controlateralenon è realizzato [34].
Indicazioni e limiti del monitoraggio dei nerviricorrenti
Le indicazioni all’utilizzo del monitoraggio del nervo ricorrentenon sono ridotte ai casi in cui il reperimento del nervo promette diessere difficile. Queste situazioni a rischio sono note: si tratta delleriprese chirurgiche, della chirurgia tumorale con svuotamento,dei gozzi voluminosi, della chirurgia postirradiazione e delle ano-malie anatomiche (carotide retroesofagea, disfagia lusoria). Il suointeresse è, in particolare, essenziale al momento dell’accesso allaloggia ricorrente per via retrograda, allo stesso tempo per confer-mare la sua identificazione e per la valutazione della sua funzione.
Occorre considerare che la maggior parte dei casi di dissecazioniricorrenziali difficili non è prevedibile. Un ricorrente non ricor-rente, un nervo superficializzato da un nodulo tiroideo posterioree un nervo triforcato sono delle situazioni difficili di reperimentoe di dissecazione; l’utilizzo del monitoraggio in queste condizioniè utile per confermare la posizione del nervo e per risparmiaretempo sul resto della dissecazione. Il monitoraggio non deveessere utilizzato per una prima esperienza in casi di dissecazionedifficile.
Un certo numero di argomenti depone per un ricorso siste-matico al monitoraggio: l’affidabilità del sistema si basa suun’abitudine di utilizzo. Viceversa, il costo di acquisto del moni-tor, della sonda di intubazione e dell’elettrodo di stimolazionespecifico e la possibilità di falsi negativi e di falsi positivi possonorappresentare un freno al suo utilizzo.
L’utilizzo del monitoraggio implica una curva di apprendi-mento da parte del chirurgo ma anche dell’equipe di anestesia edell’equipe del blocco operatorio. Si deve raggiungere una sogliadi alcune decine di casi, ma, soprattutto, la ripetizione in un lassodi tempo breve di questa procedura permette all’equipe operato-ria di essere efficiente e di conoscere le principali cause di falsipositivi e falsi negativi.
8 EMC - Tecniche chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

Monitoraggio intraoperatorio in chirurgia otorinolaringoiatrica � I – 46-543
I falsi positivi (assenza di risposta con un nervo integro) si verifi-cano in caso di spostamento della sonda e, quindi, degli elettrodi,di intensità di stimolazione troppo bassa o assente e di guasti delsistema.
I falsi negativi (nervo paralitico ma risposta ottenuta) possonoriscontrarsi quando la stimolazione avviene a valle della lesionenervosa, quando un segnale elettrico qualsiasi è confuso conun potenziale d’azione, se esiste una lesione isolata del ramoposteriore del nervo (innervazione del muscolo cricoaritenoideoposteriore, solo muscolo abduttore della laringe), quando la sti-molazione elettrica è troppo forte, con diffusione della correnteelettrica al nervo, o in caso di stimolazione transtracheale deglielettrodi di localizzazione [29] oppure quando la sonda di intu-bazione è troppo affondata. In questo caso, non vi è un tempodi latenza e la risposta non è un potenziale bifasico. È la situa-zione più pericolosa, in quanto il chirurgo è falsamente rassicuratodall’informazione fornita dal monitoraggio.
L’informazione fornita intraoperatoriamente dal monitorag-gio deve, quindi, essere ponderata e interpretata attraversol’esperienza del chirurgo per ottenere il massimo vantaggio daun’informazione pertinente e per evitare di essere ingannati daun’informazione errata. La prudenza resta, quindi, di rigore, nonsoltanto al momento dei primi usi, ma anche quando è acquisitauna certa esperienza.
ConclusioniIl monitoraggio laringeo durante una chirurgia tiroidea è un
aiuto tecnico utile, in particolare in caso di difficoltà imprevista.Esso permette di confermare l’identificazione del nervo, di elimi-nare un eventuale dubbio e, quindi, di guadagnare tempo sulladissecazione del nervo ricorrente. In maniera ancora imperfetta,esso informa sulla funzionalità di questo nervo e permette, in casodi sospetto di disturbo della conduzione, di rimandare una tota-lizzazione della tiroidectomia. Il suo utilizzo richiede un tempodi formazione importante da parte dell’equipe medicochirurgicae curante e un uso regolare per padroneggiare i vari parametri delsistema e per permettere un utilizzo ottimale [34].
Monitoraggio dei nervi laringei superioriLa disfonia post-tiroidectomia è frequente quando la funzione
ricorrenziale è normale. Quando è accuratamente ricercata, essaè riscontrata nel 30% dei casi nel periodo postoperatorio imme-diato e nel 14% a 3 mesi [37, 38]. In un certo numero di casi, questadisfonia è legata al trauma del ramo esterno del nervo laringeosuperiore.
Per proteggere questo nervo, si consiglia, nella pratica corrente,di realizzare la legatura ultraselettiva del peduncolo superiore acontatto con la capsula, in quanto il ramo esterno del nervo larin-geo superiore è di calibro molto piccolo e intimamente legatoal peduncolo superiore [39]. A questo titolo, è possibile il moni-toraggio dei nervi laringei superiori. Esso è giustificato, per alcuniautori, da un rischio non trascurabile di trauma del nervo almomento della dissecazione del polo superiore della tiroide, rife-rito nell’1-58% dei casi [37]. Gli studi anatomici riscontrano fino al50% di localizzazioni definite pericolose [40].
La diagnosi di lesione neurogena rimane, tuttavia, difficile. Essapuò essere sospettata in laringoscopia indiretta e in videostrobo-scopia. È confermata al meglio con un’EMG laringea.
La conservazione della funzione del nervo laringeo superiore èun soggetto controverso.
Alcuni autori esperti raccomandano la sua individuazione siste-matica e il suo monitoraggio. Il monitoraggio del nervo laringeosuperiore richiede la sua individuazione e la sua stimolazione.Gli elettrodi di EMG sono introdotti intraoperatoriamente nelmuscolo cricotiroideo.
Il tasso di identificazione del nervo è aumentato in caso di uti-lizzo del monitoraggio [37]. Secondo gli autori, ne derivano unariduzione della lesione nervosa e un miglioramento della vocenel periodo postoperatorio, ad alcuni giorni e a 3 mesi [41, 42].
In assenza di un ampio consenso su questo soggetto, il moni-toraggio del nervo laringeo superiore è considerato un’opzionepossibile durante la chirurgia tiroidea. In tutti i casi, si compiono
tutti gli sforzi per evitare un trauma diretto del muscolo cricoti-roideo, in particolare per la coagulazione intempestiva a contattodi esso e, anche, per una legatura ultraselettiva del peduncolotiroideo superiore a contatto con la capsula della ghiandolaper evitare una lesione del ramo esterno del nervo laringeosuperiore.
� Monitoraggio della funzioneuditiva
Il monitoraggio intraoperatorio della funzione uditiva pone itre problemi inerenti a tutti tipi di monitoraggio intraoperatorio.
È necessario che questo monitoraggio sia facile da implemen-tare e affidabile; esso deve svolgere una funzione di allarme, sepossibile in tempo reale, per avvertire di un rischio di alterazionedella funzione uditiva e, infine, deve essere predittivo del grado difunzionamento del sistema uditivo nel periodo postoperatorio.
Le indicazioni di questo monitoraggio riguardano, nella pra-tica dell’ORL, soprattutto la chirurgia funzionale e tumoraledell’angolo pontocerebellare (schwannomi e altri tumori, neuro-tomia vestibolare e conflitti vascolonervosi, impianti uditivi deltronco cerebrale). In maniera più aneddotica, esso può essere uti-lizzato anche in alcune procedure otologiche come la chirurgiastapediale o la chirurgia del sacco endolinfatico.
Per il monitoraggio della funzione uditiva, sono attualmentedescritte varie tecniche; noi le spiegheremo in dettaglio (cfr. infra)e lasceremo al lettore la cura di consultare, se necessario, l’articolocorrispondente dell’EMC per maggiori informazioni tecniche alriguardo [91].
In una seconda parte, riassumeremo gli apporti di questo moni-toraggio in funzione delle indicazioni operatorie e delle tecnicheutilizzate.
Tecniche di monitoraggio della funzioneuditivaMetodi elettrofisiologici
La maggior parte delle tecniche di monitoraggio utilizzate oggiè basata sulla registrazione delle attività elettriche scatenate dallastimolazione delle vie uditive. È intorno a queste ultime che siarticolano i seguenti paragrafi. Termineremo questa descrizionecon le tecniche acustiche di monitoraggio della funzione uditivabasate sulla registrazione delle otoemissioni acustiche provocate.
Già dalla fine degli anni′70, è stato dimostrato che delle registra-zioni dei PEUTC potevano essere ottenute nel periodo operatoriodurante la chirurgia dell’angolo pontocerebellare [43–48]. Da questecostatazioni si è sviluppato in seguito il concetto di monitoraggioperioperatorio della funzione uditiva, il cui scopo evidente era diridurre la morbilità operatoria.
A tutt’oggi, possono essere utilizzati nel monitoraggio udi-tivo tre diversi tipi di tracciati elettrofisiologici: i PEUTC,l’elettococleografia (ECoG) e i potenziali d’azione compositi delnervo uditivo (PACNU).
PEUTCI PEUTC sono identificati come una serie di onde elettroence-
falografiche, in numero compreso tra cinque e sette [49], registratetra due elettrodi di superficie posti sulla cute dell’estremità cefalicain una banda passante che va da 50 a 1 500 Hz. Questi potenzialidi campo remoto sono raccolti tra un elettrodo non invertitore(+), situato sul vertice o sulla fronte, e un elettrodo invertitore (-), posizionato sulla mastoide o sul lobulo dell’orecchio. Questeonde sono generate da stimolazioni acustiche di breve durata,come delle scariche tonali di 40 ms o, più generalmente, deiclic di 100 �s, a un ritmo compreso tra 25 e 40-50 Hz. La pola-rità della stimolazione può essere realizzata in rarefazione o incondensazione oppure le stimolazioni possono essere alterne. Lascelta della polarità dipende dalla qualità dei tracciati registratie può variare in funzione del materiale ma anche del soggettostudiato (Tabella 1).
EMC - Tecniche chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale 9

I – 46-543 � Monitoraggio intraoperatorio in chirurgia otorinolaringoiatrica
Tabella 1.Vantaggi e inconvenienti delle differenti tecniche di monitoraggio della funzione uditiva nella chirurgia dell’angolo pontocerebellare.
Tecnica Vantaggi Inconvenienti
PEUTC Camporemoto
Registrazione facile e tecnica robusta pocosensibile agli artefattiUtilizzabile quale che sia la dimensione deltumorePossibile confronto con un esamepreoperatorio
Onda V molto sensibile alle alterazionielettricheDurata dell’acquisizione lungaSensibile al protocollo anestetico
ECoG Campovicino
Registrazione facile ma sensibile agli artefattielettriciAcquisizione molto rapidaUtilizzabile qualunque sia la dimensione deltumorePossibile confronto con un esamepreoperatorio
Può ignorare una lesione del nervo inprossimità del tronco cerebrale
PACNU Registrazionedi contatto
P1-N1 con voltaggio correttoL’esame più sensibile e più specifico perpredire la funzione postoperatoriaDurata dell’acquisizione rapida
Registrazione più complessa e invasivaRischio di lesione del nervo da partedell’elettrodoDifficilmente utilizzabile in caso di tumorevoluminoso
PEUTC: potenziali evocati uditivi del tronco cerebrale; ECoG: elettococleografia; PACNU: potenziale d’azione composito del nervo uditivo.
Le onde più riproducibili sono le onde I, III e V, che sono, perciò,usate per il monitoraggio. Dato che l’ampiezza di questi poten-ziali è bassa (dell’ordine di 0,2-0,5 �V), tenuto conto della distanzache li separa dagli elettrodi del generatore cerebrale, il loro tratta-mento richiede un’amplificazione e un averaging importanti perveder emergere in maniera soddisfacente le onde dal rumore difondo elettrico. Ciò richiede una stimolazione acustica soprali-minare di 75-80 dB o anche più, in caso di sordità preesistente.Dato che ogni soggetto rappresenta il proprio controllo, i cui trac-ciati sono analizzati passo a passo durante l’intervento, e tenutoconto del rischio di degradazione intraoperatoria delle onde, èimperativo ottenere dei tracciati preoperatori di qualità ottimale.
Si osserva un’alterazione dei tracciati quando l’ampiezza delleonde decresce e/o quando le latenze tra le onde aumentano.Se la scomparsa dell’onda V è particolarmente infausta perquanto riguarda la conservazione dell’udito, essa non è, tutta-via, interamente specifica per una sordità da postumi. Perciò,devono essere ricercate tutte le modificazioni più precoci delleonde I e, soprattutto, III, in quanto esse segnano delle lesioniiniziali e, a volte, reversibili della funzione uditiva [50]. Dalmomento che l’ottenimento di questi tracciati è soggetto allasincronizzazione delle fibre che codificano le alte frequenzecocleari, anche una lesione demielinizzante o una neuropatia(eventualmente tumorale) possono alterare l’aspetto dei tracciatipreoperatori che possono, in alcune condizioni, normalizzarsidurante l’intervento.
ECoGL’ECoG permette di registrare diversi potenziali elettrici, che
sono il potenziale di sommazione (funzione dell’omeostasiionica della coclea), il potenziale microfonico cocleare (legatoall’accoppiamento tra membrana basilare e cellule ciliate) e ilpotenziale d’azione composito (PAC). Benché i due primi poten-ziali siano interessanti nello studio della fisiologia della coclea,solo lo studio del PAC è realizzato nel corso del monitoraggio.Il PAC si presenta come un’onda bifasica con una prima ondanegativa N1 seguita da un’onda positiva P1. La comparsa di que-ste onde è legata all’attivazione della prima sinapsi uditiva alivello del modiolo. L’ampiezza di queste onde è in funzione delladistanza rispetto al modiolo, con un’ampiezza più marcata graziea elettrodi impiantati attraverso il timpano e posti sul promon-torio, rispetto a quella ottenuta con degli elettrodi timpanici o,ancora, situati nel condotto uditivo esterno [51].
La stimolazione acustica è simile a quella dei PEUTC e può con-sistere in clic o in scariche tonali. Solo la cadenza (intorno a 11 Hz)e il filtraggio del segnale (5-3 000 Hz) differiscono dai PEUTC. Datoche l’ampiezza del segnale registrato è più importante (2-20 �V),l’amplificazione è inferiore che con i PEUTC e l’averaging richiesto
è meno lungo per eliminare il rumore di fondo. Perciò, questoesame riflette meglio «in tempo reale» l’impatto delle manipo-lazioni sulla funzione uditiva rispetto ai PEUTC. Il suo principaleinconveniente è che esso valuta solo la sincronizzazione delle fibrenervose a bassa soglia di attivazione e, soprattutto, unicamentesul segmento laterale del nervo. Contrariamente ai PEUTC, unalesione mediale o a livello del tronco cerebrale può non essereevidenziata dalla misurazione del PAC (Tabella 1).
La valutazione del PAC si basa sulla misurazione della latenzadell’onda N1 e sull’ampiezza N1-P1. L’onda N1 possiede lo stessogeneratore dell’onda I dei PEUTC e la sua latenza corrispondeapprossimativamente a quella dell’onda II dei PEUTC. Delle varia-zioni di ampiezza di N1-P1 segnano un asincronismo della parteprossimale delle fibre uditive, per demielinizzazione o lesioneassonale.
PACNULa misurazione dei PACNU permette in particolare di affrancarsi
dai limiti dell’ECoG. In effetti, in quest’ultima tecnica, l’elettrodoè posto direttamente a contatto con il nervo uditivo, in prossi-mità della fossetta laterale del bulbo, in modo da poter controllarele anomalie che possono comparire a tutti i livelli del nervo,dall’uscita dal meato acustico interno fino al tronco cerebrale. Lavicinanza tra l’elettrodo e il nervo uditivo permette di osservaredei PAC di grande ampiezza, con un’onda N1 che può raggiungerei 50 �V. Per tale motivo, l’ottenimento di tracciati interpretabilirichiede poca amplificazione e poco averaging, il che consente unmonitoraggio «quasi in tempo reale» della funzione del nervo udi-tivo. Gli svantaggi di questa tecnica sono duplici. Se è possibileposizionare correttamente gli elettrodi nel corso di una chirur-gia funzionale dell’angolo pontocerebellare o in caso di piccolitumori, questo posizionamento può essere difficile o impossibilein caso di lesione voluminosa o se è scelta una via d’accessosoprapetrosa. Inoltre, l’elettrodo può rappresentare un elementovulnerante a cui si deve prestare particolare attenzione. Con deimovimenti di trazione, è possibile ledere il nervo o, peggio ancora,danneggiare delle strutture del tronco cerebrale, se l’elettrodo ètrascinato dai movimenti della fresa, nel corso, per esempio, diuna fresatura del meato acustico interno (Tabella 1). Anche in casodi tumori voluminosi, solo i PEUTC e l’ECoG restano dei metodirelativamente affidabili e più sicuri.
In maniera empirica, è stabilito che una riduzione di più del50% dell’ampiezza delle onde o un allungamento della latenzadi più del 10% o di 0,5 ms [52, 53], in modo comparativo tra leregistrazioni ottenute durante i tempi successivi dell’intervento,sono dei segni di lesione assonale. Analogamente, una modifica-zione dell’aspetto delle onde del PEUTC deve essere un segnale diallarme che deve allertare il chirurgo [43, 54, 55].
10 EMC - Tecniche chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

Monitoraggio intraoperatorio in chirurgia otorinolaringoiatrica � I – 46-543
In sintesiQualunque sia la metodica elettrofisiologica impiegata,
l’operatore deve essere conscio dell’esistenza di un certo numerodi artefatti o di condizioni che possono modificare l’aspetto deitracciati osservati.
Come ogni metodo elettrofisiologico, i PEUTC, l’ECoG e iPACNU sono sensibili agli artefatti di suscettibilità elettromagne-tici. Questi ultimi sono responsabili di parassiti a livello delleregistrazioni, degradano la qualità dei tracciati e richiedono lamodifica dei parametri di filtraggio e l’aumento dell’averagingdelle acquisizioni. Ciò nuoce allo stesso tempo alla qualità delmonitoraggio ma anche al suo valore di allarme in temporeale. Così, l’utilizzo di materiale blindato, la messa a massadel materiale e del paziente e la limitazione del rumore elet-trico dell’ambiente (per esempio, telefoni portatili e generatori di50 Hz come il motore delle coperte termiche) sono degli elementiessenziali da verificare all’inizio dell’intervento per assicurare ilsuccesso del monitoraggio. Analogamente, il trasduttore acusticopuò anche, attraverso la sua irradiazione, provocare delle inte-razioni elettromagnetiche. Così, nella misura del possibile, sipreferiscono dei trasduttori connessi a dei tubi con inserti intrau-ricolari a semplici trasduttori posti in faccia o nel condotto uditivoesterno.
Fra queste condizioni che possono alterare il monitoraggio,alcune sono associate all’anestesia. Mentre ECoG e PACNUsono validi qualunque sia il protocollo di anestesia usato, èstato mostrato che l’ampiezza e le latenze dei PEUTC sono leg-germente influenzate da alcuni farmaci come i barbiturici, lebenzodiazepine, la chetamina, il propofol e l’isoflurano [56, 57].Analogamente, il mantenimento della temperatura corporea èun elemento critico durante le registrazioni elettrofisiologichedell’attività uditiva. Un’ipotermia relativa e prolungata influenzala conduzione nervosa e può artificialmente alterare l’ampiezzae le latenze dei PEUTC e, in minor misura, dell’ECoG e deiPACNU.
Infine, alcuni tempi della chirurgia possono di per sé causaredelle alterazioni dei tracciati elettrofisiologici. La fresatura osseaprovoca un rumore trasmesso alla coclea che può arrivare a 120 dB.Questo rumore ha, dunque, un effetto mascherante sulla sti-molazione acustica che si ritiene provochi le onde fisiologiche.Analogamente, l’apertura della dura madre e la retrazione del cer-velletto causano frequentemente una riduzione di ampiezza e unaumento delle latenze, il più delle volte reversibile [56, 58–61]. Tut-tavia, queste variazioni possono anche essere testimonianza dialterazioni definitive della funzione uditiva in caso di retrazioneeccessiva.
Come è stato descritto in precedenza, il monitoraggio dellafunzione uditiva si basa essenzialmente sull’osservazione di ondeelettriche in risposta a una stimolazione acustica. In alcunesituazioni, la stimolazione acustica può essere sostituita da unastimolazione elettrica. Questo tipo di stimolazione può essere uti-lizzato quando il funzionamento della coclea e/o del nervo uditivoè alterato, per esempio durante un impianto cocleare, per moni-torare la qualità della risposta nervosa, o, ancora, al momento delposizionamento di un impianto uditivo del tronco cerebrale perverificare il posizionamento degli elettrodi a contatto con i nucleicocleari [62]. La sorgente della stimolazione elettrica può essereun generatore esterno oppure la stimolazione elettrica può esseredirettamente erogata dall’impianto uditivo. Se la stimolazione èesterna, lo stimolo è spesso un segnale rettangolare di polaritàalternata, di una durata di 100-200 �s e di ampiezza 0,2-1 mAa una frequenza di 10 Hz. Se il segnale è erogato dall’impianto,sono utilizzate, per stimolare la via uditiva, delle serie di impulsile cui caratteristiche e il cui protocollo di stimolazione dipendonodall’impianto.
Metodi fisici acustici per realizzareun monitoraggio uditivo
Accanto a questi metodi elettrofisiologici, è possibile anche uti-lizzare, in alcuni casi, dei metodi fisici acustici per realizzare unmonitoraggio uditivo.
Indicazioni e risultati del monitoraggio dellafunzione uditiva in otoneurologia e inotologiaTumori e chirurgia funzionale dell’angolopontocerebellare
Il monitoraggio uditivo intraoperatorio ha, in questa indica-zione, lo scopo di aumentare il tasso di conservazione dell’uditoal termine dell’intervento. Il monitoraggio scelto è realizzato conPEUTC, ECoG o PACNU, utilizzati da soli o in modo combinato,in funzione delle abitudini delle equipe. Due tipi di informa-zione sono attesi nel corso del monitoraggio. La prima riguardal’influenza del gesto chirurgico sui tracciati. In effetti, essa è essen-ziale per poter adattare il gesto operatorio a eventuali lesionireversibili che potrebbero essere evitate. La seconda informazioneriguarda il carattere predittivo del monitoraggio. In altri termini,si tratta di sapere se la presenza, l’assenza o le modificazionidei tracciati sono predittive della funzione uditiva postoperatoria(Fig. 4).
Come è stato descritto più in alto, ogni riduzione superiore al50% dell’ampiezza delle onde o un prolungamento della latenzasuperiore al 10% o a 0,5 ms nel corso della chirurgia devono farsospettare una lesione nervosa. Analogamente, una scomparsadell’onda III e, quindi, dell’onda V dei PEUTC è un elementodi prognosi funzionale infausta [63–65]. Allo stesso modo, il rag-giungimento di un potenziale d’azione bi- o trifasico sarebbe unelemento di buona prognosi, per quanto riguarda la conserva-zione dell’udito [54]. Tuttavia, questi criteri non sono assoluti e nonspiegano un certo numero di casi particolari. In effetti, è possibileosservare un udito residuo nel periodo postoperatorio, malgradola scomparsa dell’onda V durante l’intervento [66]. Viceversa, supiccoli tumori, è descritta eccezionalmente una normalizzazionedei PEUTC nel corso dell’intervento dopo l’asportazione deltumore, benché questi ultimi fossero alterati nel periodo preopera-torio [67]. Di conseguenza, se delle alterazioni intraoperatorie sonosuggestive di lesioni nervose, esse non possono prevedere fedel-mente il risultato a distanza per diversi motivi. Così, la chirurgiapuò provocare, attraverso la manipolazione del nervo, un bloccodi conduzione temporaneo potenzialmente reversibile a distanza,il che spiega i casi di udito conservato malgrado un monitoraggioche non permetteva l’identificazione di onde uditive al terminedell’intervento. Viceversa, i rimaneggiamenti postoperatori con ilrischio di vasospasmo dell’arteria labirintica possono provocareun’ischemia nervosa e cocleare dopo l’intervento, foriera di unavera cofosi nonostante risultati di monitoraggio intraoperatoriorassicuranti [66, 68].
Se si traccia il bilancio delle conservazioni di udito chehanno beneficiato di un monitoraggio, è opportuno innan-zitutto guardare gli studi pubblicati con un occhio critico.Infatti, questi risultati devono essere considerati in funzione delledimensioni dei tumori trattati, dello stato uditivo preoperatorio,dell’atteggiamento del chirurgo nei confronti del compromessoexeresi tumorale/conservazione nervosa e, soprattutto, dei criteridi valutazione dell’udito postoperatorio. A tutt’oggi, un consensotende a riferire i risultati secondo la classificazione American Aca-demy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery (AAO-HNS) ingradi da A a D in funzione dei dati di audiometria tonale e vocale, esolo i gradi A e B sono considerati indicatori di un udito funzionalee utile.
A causa di un tracciato con voltaggio più alto e, perciò, diacquisizioni più rapide, che permettono un monitoraggio intempo reale della funzione uditiva, ci si potrebbe attendere chel’utilizzo dei PACNU e dell’ECoG permetta una conservazionedell’udito più frequente rispetto ai PEUTC. Tale questione nonè ancora a tutt’oggi completamente definita, poiché gli studi aquesto proposito divergono. In effetti, se i tassi di conservazionedell’udito con monitoraggio variano dal 20,8% al 91% in fun-zione del tipo di monitoraggio, delle dimensioni dei tumori edelle equipe [55, 66, 69–77], esiste una tendenza a ottenere miglioritassi di conservazione con i PACNU e con l’ECoG che con i PEUTC.Tuttavia, esistono solo pochi studi nel corso dei quali sono con-frontati contemporaneamente diversi tipi di monitoraggio. Nel2009, Yamakami et al. [76] confrontavano così, su piccoli tumori,
EMC - Tecniche chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale 11

I – 46-543 � Monitoraggio intraoperatorio in chirurgia otorinolaringoiatrica
A B
+ 100 nv
95 R
95 R1
95 R2
95 R3
95 R4
95 R5
95 R6
dB nHL2 4 6 8 10 12
C
Fineintervento
Finedissecazione
Dissecazionetumorale
Aperturadurale
Fresatura
Preoperator io
Figura 4. Monitoraggio contemporaneo della funzione uditiva e della funzione motoria dei nervi cranici V, VII, IX, X, XI e XII durante la chirurgia di exeresidi uno schwannoma dei nervi misti.A, B. Videocatture del monitoraggio del muscolo temporale (nervo trigemino, canale 1), dei muscoli orbicolari della palpebra e delle labbra (nervo faciale,canali 2 e 3), del muscolo stafilofaringeo (nervo glossofaringeo, canale 4), del muscolo vocale (nervo vago, canale 5), del muscolo sternocleidomastoideo(nervo accessorio, canale 6) e del muscolo genioglosso (nervo ipoglosso, canale 7).C. Monitoraggio della funzione uditiva con potenziali evocati uditivi precoci del tronco cerebrale (PEUTC) nei differenti tempi della chirurgia. La fresatura dellembo di craniotomia è responsabile di un allungamento delle latenze delle onde III e V, senza diminuzione dell’ampiezza dell’onda V, fenomeno reversibileall’interruzione della fresatura. Analogamente, durante la dissecazione del tumore, si può osservare una stimolazione a livello del nervo glossofaringeo e delnervo vago che localizza l’origine della tumore. La dissecazione della parte alta del tumore del fascio acusticofacciale permette di osservare un treno di punte-onde a livello del nervo faciale, ma di breve durata. Contemporaneamente, si nota un allungamento delle latenze delle onde III e V, con una conservazionedell’onda III e una riduzione di ampiezza dell’onda V del 20%. Queste anomalie motorie e sensoriali sono state reversibili all’interruzione della dissecazione,come attesta la normalizzazione dei PEUTC al termine dell’intervento.
l’efficacia dei PEUTC con i PACNU. La conservazione era del 91%e dell’82% rispettivamente. In questo studio, i PACNU si eranodimostrati molto efficaci, poiché avevano una sensibilità e unaspecificità del 100% nel predire la funzione postoperatoria. In unaltro studio, Battista et al. dimostravano, nel 2000 [70], grazie alconfronto dei PEUTC, dell’ECoG e dei PACNU, un tasso di con-servazione del 17%, del 18% e del 40% rispettivamente senza perquesto mostrare differenze significative. Analogamente Jacksonet al. dimostravano, nel 2000 [74], l’assenza di differenze nella con-servazione utilizzando i PEUTC (63%) e i PACNU (67%). Nel 2004,Danner et al. [72] confrontavano PEUTC e PACNU e riscontravanodei tassi di conservazione del 27% e del 43%, ma non fornivanoelementi statistici a favore di una delle metodiche, come ancheZappia et al. [77], che avevano riscontrato, nel 1996, un vantaggiodei PACNU rispetto all’ECoG, grazie a dei tassi di conservazionedell’udito del 46% contro il 23%.
Altri autori suggeriscono che l’utilizzo combinato di diversimetodi permetterebbe di attenuare i rispettivi inconvenienti perottenere dei tassi dei conservazione vicini al 60%, in funzionedegli studi [55, 71, 73, 78].
Alimentando la controversia, un articolo recente di Piccirillo eSanna suggerisce che il tasso di conservazione dell’udito social-mente accettabile non è influenzato dall’utilizzo o meno di
un monitoraggio (26,7% con monitoraggio contro 20,8% senzamonitoraggio su più di 150 casi [75]). Quest’ultimo punto sotto-linea bene il fatto che, come è stato ipotizzato (cfr. supra), laconservazione uditiva è multifattoriale e che, inoltre, il monito-raggio non permette di prevedere una degradazione secondariadell’udito di origine ischemica o neuropatica. In questa indica-zione, lo studio del riflesso trigeminocardiaco potrebbe trovareun suo posto [79], in quanto la sua attivazione sarebbe in rapportocon delle lesioni del tronco cerebrale, spesso ischemiche, che pre-annunciano la comparsa di una sordità secondaria, nonostanteun monitoraggio delle vie uditive non alterato.
In maniera aneddotica, alcuni autori propongono l’utilizzo didistortion product otoacoustic emissions (PDOEA) durante il moni-toraggio intraoperatorio [80]. Questi ultimi possono studiare soloil funzionamento cocleare; non possono, quindi, evidenziarelesioni neuronali e, anche se la loro presenza è ben correlata auna conservazione dell’udito, è probabile che la loro degradazionerifletta solo dei fenomeni ischemici intraoperatori e che la loronormalità ignori una neuropatia postoperatoria, come può essereil caso per l’ECoG.
Anche se i consensi [81] concordano nell’affermare che ilmonitoraggio con PEUTC, ECoG o PACNU può essere utilenella chirurgia dell’angolo pontocerebellare (livello di prova
12 EMC - Tecniche chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

Monitoraggio intraoperatorio in chirurgia otorinolaringoiatrica � I – 46-543
0,1 µV 1,5 ms
OD 80 dB
OD 80 dB
A
N : 1 000 NR : 5 01,5 ms Normale
0,2 µV Amp 1
Off
B
N : 500 NR : 01,5 ms Normale
0,2 µV Amp 1
Off
C
N : 500 NR : 2 91,5 ms Normale
0,2 µV Amp 1
Off
DFigura 5. Monitoraggio intraoperatorio (A) della funzione uditiva nel corso di una decompressione microvascolare del nervo cocleare. Questa figurarappresenta i tracciati in potenziali evocati uditivi precoci del tronco cerebrale (PEUTC) ottenuti prima della chirurgia, all’inizio dell’intervento (B), all’aperturadurale (C) e dopo la rimozione del conflitto (D). Fin dall’apertura durale, si osserva un accorciamento della latenza dell’onda V di circa 0,15 ms. Questofenomeno si conferma al momento della rimozione del conflitto vascolonervoso con l’arteria cerebellare anteroinferiore. Si nota anche un accorciamentodella latenza dell’onda III di 0,15 ms. È possibile, così, confermare l’assenza di degradazione dell’udito legata al gesto operatorio, e l’accorciamento dellelatenze suggerisce la riuscita funzionale della rimozione del conflitto.
C, basato su studi di livello III o inferiore), questa raccoman-dazione è, quindi, basata solo su un consenso di esperti enon su studi randomizzati realizzati in cieco. Perciò, questomonitoraggio, per quanto interessante possa essere, non è rite-nuto indispensabile e non può essere usato come argomentomedicolegale.
Se ci si interessa più specificamente alla chirurgia funzionaledell’angolo pontocerebellare, il monitoraggio uditivo può servireallo stesso tempo come sistema di allarme per le procedure didecompressione microvascolare del nervo faciale e del nervo tri-gemino e di neurotomia vestibolare e come controllo dell’efficaciain caso di decompressione microvascolare del nervo cocleovesti-bolare (Fig. 5). Nella maggior parte dei casi di decompressionedel nervo trigemino, la retrazione cerebellare e la dissecazionesubaracnoidea del nervo cocleovestibolare sono state identificatecome cause di sordità postoperatoria [61, 82] e la realizzazione divie d’accesso più limitate, passando a filo del seno sigmoideo, el’utilizzo di endoscopi hanno permesso di ridurre significativa-mente questo rischio [83].
Quando la decompressione riguarda i nervi del fascio acusti-cofacciale, ancora una volta è stato dimostrato che un aumentodelle latenze delle onde dei PEUTC, in particolare dell’onda V,e, soprattutto, una riduzione della sua ampiezza sono correlatialla prognosi uditiva nel caso della chirurgia dello spasmo emifac-ciale [84–87]. Tuttavia, come per la chirurgia tumorale, questo esamenon ha una sensibilità del 100%, in quanto, come hanno mostratoHuang et al. [88], è in grado di individuare dei casi di sordità posto-peratoria solo in 34 casi su 36. Si deve notare che, se questa sorditàcompare, essa è nettamente meno frequente che per la chirur-gia tumorale (3,6% su 1 156 interventi per Jo et al. [85]) e che lacaduta delle soglie uditive, se si verifica, si avvicina generalmenteai 10 dB [85]. Lo stesso vale per le chirurgie di decompressione delnervo cocleovestibolare [89], con un 3,2% di riduzione dell’uditosu 254 casi.
In un altro registro della chirurgia tumorale ma anche funzio-nale dell’angolo pontocerebellare, il monitoraggio uditivo puòessere utilizzato durante il posizionamento di impianti uditivi deltronco cerebrale.
Chirurgia stapediale e chirurgia del saccoendolinfatico
Sono elencate le procedure di monitoraggio utilizzate in chirur-gia stapediale e in chirurgia del sacco endolinfatico.
ConclusioniIl miglioramento dei risultati funzionali, garantendo una sicu-
rezza ottimale, è la principale motivazione che ha condotto autilizzare le tecniche presentate in questo capitolo per monitorarela funzione uditiva durante la chirurgia dell’angolo pontocere-bellare e la chirurgia otologica. Benché il loro utilizzo si basi susolide basi neurofisiologiche, il loro interesse pratico fatica a esseredimostrato, per mancanza di veri studi randomizzati sul soggetto.In effetti, la conservazione dell’udito è multifattoriale e isolareil fattore monitoraggio rappresenta spesso una sfida. Per questomotivo, benché esso sia raccomandato e spesso rassicurante peril chirurgo, non consente di evitare problemi medicolegali e nondeve frenare il trattamento di tumori a potenziale rischio vitale.
Inoltre, si devono compiere numerosi sforzi da una parte perdimostrare la sua efficacia in maniera indubbia e, dall’altra, nelsettore tecnologico associato. L’utilizzo di un materiale più rapidoe a rendimento più alto, che permetta un vero controllo in temporeale, come anche lo sviluppo di nuove tecniche di esplorazione,basate eventualmente sulla misurazione dell’attività spontanea enon più evocata delle funzioni uditive, dovrebbero permettere dimigliorarne l’utilizzo e di delinearne meglio le indicazioni.
EMC - Tecniche chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale 13

I – 46-543 � Monitoraggio intraoperatorio in chirurgia otorinolaringoiatrica
� Monitoraggio della funzionemotoria dei nervi misti nellachirurgia dell’angolopontocerebellare e del foramegiugulare
I nervi misti cranici non sfuggono alla problematica del moni-toraggio intraoperatorio.
� ConclusioniIl monitoraggio intraoperatorio è una tecnica di aiuto alla chi-
rurgia ORL, che sembra particolarmente indicata per la chirurgiadell’angolo pontocerebellare e per certi interventi di chirurgiadell’orecchio medio e di chirurgia tiroidea o parotidea. Esso puòrivelarsi molto utile, in alcune indicazioni o circostanze particolariper i chirurghi esperti e in tutti i casi per i chirurghi in formazione.Tuttavia, per quanto sofisticata sia questa tecnica, nessuno studioclinico ha ancora dimostrato che il monitoraggio del nervo facialeo del nervo ricorrente diminuisca i rischi di paralisi e, soprattutto,esso non può in nessun caso sostituire una buona conoscenza ana-tomica del sito chirurgico e dei principali reperi che permettono diindividuare i nervi cranici. Inoltre, questa tecnica non ha ancoraun carattere sistematico e obbligatorio e non è utilizzabile in uncontesto medicolegale.
� Riferimenti bibliografici[1] Delgado TE, Bucheit WA, Rosenholtz HR, Chrissian S. Intraoperative
monitoring of facila muscle evoked responses obtained by intracranialstimulation of the facila nerve: a more accurate technique for facilanerve dissection. Neurosurgery 1979;4:418–21.
[2] Zini C, Gandolfi A. Facial-nerve and vocal-cord monitoring duringotoneurosurgical operations. Arch Otolaryngol Head Neck Surg1987;113:1291–3.
[3] Uziel A, Benezech J, Frerebeau P. Intraoperative facial nerve moni-toring in posterior fossa acoustic neuroma surgery. Otolaryngol HeadNeck Surg 1993;108:126–34.
[4] Rea JL. Use of a hemostat/stimulator probe and dedicated nerve loca-tor/monitor for parotid surgery. Ear Nose Throat J 1990;69, 566, 570,573.
[5] Prass RL, Luders H. Acoustic (loudspeaker) facial electromyographicmonitoring: part 1. Evoked electromyographic activity during acousticneuroma resection. Neurosurgery 1986;19:392–400.
[6] Prass R, Luders H. Constant-current versus constant-voltage stimula-tion. J Neurosurg 1985;62:622–3.
[7] Sobottka SB, Schackert G, May SA. Intraoperative facial nerve monito-ring (IFNM) predicts facial nerve outcome after resection of vestibularschwannoma. Acta Neurochir 1998;140:235–42, discussion 242-3.
[8] Bozorg Grayeli A, Kalamarides M, Fraysse B. Comparison betweenintraoperative observations and electromyographic monitoring datafor facial nerve outcome after vestibular schwannoma surgery. ActaOtolaryngol 2005;125:1069–74.
[9] Selesnick SH. Optimal stimulus duration for intraoperative facial nervemonitoring. Laryngoscope 1999;109:1376–85.
[10] Neff BA, Ting J, Dickinson SL, Welling DB. Facial nerve monitoringparameters as a predictor of postoperative facial nerve outcomes aftervestibular schwannoma resection. Otol Neurotol 2005;26:728–32.
[11] Bernat I, Grayeli AB, Esquia G. Intraoperative electromyography andsurgical observations as predictive factors of facial nerve outcome investibular schwannoma surgery. Otol Neurotol 2010;31:306–12.
[12] Bernardeschi D, Meskine N, Otaibi NA. Continuous facial nerve sti-mulating burr for otologic surgeries. Otol Neurotol 2011;32:1347–51.
[13] Choung YH, Park K, Cho MJ. Systematic facial nerve monitoring inmiddle ear and mastoid surgeries: “surgical dehiscence” and “electricaldehiscence”. Otolaryngol Head Neck Surg 2006;135:872–6.
[14] Eskander A, Holler T, Papsin BC. Delayed facial nerve paresisafter using the KTP laser in the treatment of cholesteatoma despiteinter-operative facial nerve monitoring. Int J Pediatr Otorhinolaryngol2010;74:823–4.
[15] Wilson L, Lin E, Lalwani A. Cost-effectiveness of intraoperative facialnerve monitoring in middle ear or mastoid surgery. Laryngoscope2003;113:1736–45.
[16] Johns ME, Goldsmith MM. Incidence, diagnosis, and classification ofsalivary gland tumors. Part 1 Oncology 1989;3:47–56, discussion 56,58, 62.
[17] Makeieff M, Venail F, Cartier C. Continuous facial nerve monito-ring during pleomorphic adenoma recurrence surgery. Laryngoscope2005;115:1310–4.
[18] Jouzdani E, Yachouh J, Costes V. Prognostic value of a three-gradeclassification in primary epithelial parotid carcinoma: result of a histo-logical review from a 20-year experience of total parotidectomy withneck dissection in a single institution. Eur J Cancer 2010;46:323–31.
[19] Lowry TR, Gal TJ, Brennan JA. Patterns of use of facial nerve moni-toring during parotid gland surgery. Otolaryngol Head Neck Surg2005;133:313–8.
[20] Witt RL. Facial nerve monitoring in parotid surgery: the standard ofcare? Otolaryngol Head Neck Surg 1998;119:468–70.
[21] Dulguerov P, Marchal F, Lehmann W. Postparotidectomy facial nerveparalysis: possible etiologic factors and results with routine facial nervemonitoring. Laryngoscope 1999;109:754–62.
[22] Terrell JE, Kileny PR, Yian C. Clinical outcome of continuous facialnerve monitoring during primary parotidectomy. Arch OtolaryngolHead Neck Surg 1997;123:1081–7.
[23] Eisele DW, Wang SJ, Orloff LA. Electrophysiologic facial nerve moni-toring during parotidectomy. Head Neck 2011;32:399–405.
[24] Wolf SR, Schneider W, Suchy B, Eichhorn B. Intraoperative facialnerve monitoring in parotid surgery. HNO 1995;43:294–8.
[25] Olsen KD, Daube JR. Intraoperative monitoring of the facial nerve:an aid in the management of parotid gland recurrent pleomorphicadenomas. Laryngoscope 1994;104:229–32.
[26] Lopez M, Quer M, Leon X. Usefulness of facial nerve monitoringduring parotidectomy. Acta Otorrinolaringol Esp 2001;52:418–21.
[27] Brennan J, Moore EJ, Shuler KJ. Prospective analysis of the efficacyof continuous intraoperative nerve monitoring during thyroidectomy,parathyroidectomy, and parotidectomy. Otolaryngol Head Neck Surg2001;124:537–43.
[28] Grosheva M, Klussmann JP, Grimminger C. Electromyographic facialnerve monitoring during parotidectomy for benign lesions does notimprove the outcome of postoperative facial nerve function: a pro-spective two-center trial. Laryngoscope 2009;119:2299–305.
[29] Randolph GW, Dralle H, Abdullah H. Electrophysiologic recur-rent laryngeal nerve monitoring during thyroid and parathyroidsurgery: international standards guideline statement. Laryngoscope2011;121(suppl1):S1–16.
[30] Dralle H, Sekulla C, Lorenz K. Intraoperative monitoring of the recur-rent laryngeal nerve in thyroid surgery. World J Surg 2008;32:1358–66.
[31] Thomusch O, Sekulla C, Machens A. Validity of intra-operativeneuromonitoring signals in thyroid surgery. Langenbecks Arch Surg2004;389:499–503.
[32] Dralle H, Sekulla C, Haerting J. Risk factors of paralysis and functionaloutcome after recurrent laryngeal nerve monitoring in thyroid surgery.Surgery 2004;136:1310–22.
[33] Bailleux S, Bozec A, Castillo L, Santini J. Thyroid surgery and recur-rent laryngeal nerve monitoring. J Laryngol Otol 2006;120:566–9.
[34] Goretzki PE, Schwarz K, Brinkmann J. The impact of intraope-rative neuromonitoring (IONM) on surgical strategy in bilateralthyroid diseases: is it worth the effort? World J Surg 2010;34:1274–84.
[35] Hermann M, Hellebart C, Freissmuth M. Neuromonitoring in thyroidsurgery: prospective evaluation of intraoperative electrophysiologicalresponses for the prediction of recurrent laryngeal nerve injury. AnnSurg 2004;240:9–17.
[36] Otto RA, Cochran CS. Sensitivity and specificity of intraoperativerecurrent laryngeal nerve stimulation in predicting postoperative nerveparalysis. Ann Otol Rhinol Laryngol 2002;111:1005–7.
[37] Lombardi CP, Raffaelli M, De Crea C. Long-term outcome of func-tional post-thyroidectomy voice and swallowing symptoms. Surgery2009;146:1174–81.
[38] Sinagra DL, Montesinos MR, Tacchi VA. Voice changes after thy-roidectomy without recurrent laryngeal nerve injury. J Am Coll Surg2004;199:556–60.
[39] Tran Ba Huy P, Kania R. Thyroïdectomie. EMC (Elsevier Masson SAS,Paris), Techniques chirurgicales - Tête et cou, 46-460, 2004 : 16p.
[40] Morton RP, Whitfield P, Al-Ali S. Anatomical and surgical considera-tions of the external branch of the superior laryngeal nerve: a systematicreview. Clin Otolaryngol 2006;31:368–74.
14 EMC - Tecniche chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

Monitoraggio intraoperatorio in chirurgia otorinolaringoiatrica � I – 46-543
[41] Lifante JC, McGill J, Murry T. A prospective, randomized trial ofnerve monitoring of the external branch of the superior laryngeal nerveduring thyroidectomy under local/regional anesthesia and IV sedation.Surgery 2009;146:1167–73.
[42] Mangano A, Dionigi G. The need for standardized technique in intrao-perative monitoring of the external branch of the superior laryngealnerve during thyroidectomy. Surgery 2011;149:854–5.
[43] Grundy BL, Jannetta PJ, Procopio PT. Intraoperative monitoring ofbrain-stem auditory evoked potentials. J Neurosurg 1982;57:674–81.
[44] Grundy BL, Lina A, Procopio PT, Jannetta PJ. Reversible evokedpotential changes with retraction of the eighth cranial nerve. AnesthAnalg 1981;60:835–8.
[45] Grundy BL, Procopio PT, Jannetta PJ. Evoked potential changesproduced by positioning for retromastoid craniectomy. Neurosurgery1982;10:766–70.
[46] Hashimoto I, Ishiyama Y, Yoshimoto T, Nemoto S. Brain-stemauditory-evoked potentials recorded directly from human brain-stemand thalamus. Brain 1981;104:841–59.
[47] Levine RA, Ojemann RG, Montgomery WW, McGaffigan PM. Moni-toring auditory evoked potentials during acoustic neuroma surgery.Insights into the mechanism of the hearing loss. Ann Otol RhinolLaryngol 1984;93:116–23.
[48] Raudzens PA, Shetter AG. Intraoperative monitoring of brain-stemauditory evoked potentials. J Neurosurg 1982;57:341–8.
[49] Jewett DL, Romano MN, Williston JS. Human auditory evoked poten-tials: possible brain stem components detected on the scalp. Science1970;167:1517–8.
[50] Neu M, Strauss C, Romstock J. The prognostic value of intraopera-tive BAEP patterns in acoustic neurinoma surgery. Clin Neurophysiol1999;110:1935–41.
[51] Thornton AR. Electrophysiological studies of the auditory system.Audiology 1976;15:23–38.
[52] Colletti V, Fiorino FG, Mocella S, Policante Z. ECochG, CNAP andABR monitoring during vestibular schwannoma surgery. Audiology1998;37:27–37.
[53] Morawski KF, Niemczyk K, Bohorquez J. Intraoperative monitoringof hearing during cerebellopontine angle tumor surgery using trans-tympanic electrocochleography. Otol Neurotol 2007;28:541–5.
[54] Aihara N, Murakami S, Watanabe N. Cochlear nerve action potentialmonitoring with the microdissector in vestibular schwannoma surgery.Skull Base 2009;19:325–32.
[55] Schlake HP, Goldbrunner RH, Milewski C. Intra-operative electromyo-graphic monitoring of the lower cranial motor nerves (LCN IX-XII) inskull base surgery. Clin Neurol Neurosurg 2001;103:72–82.
[56] Edwards BM, Kileny PR. Intraoperative neurophysiologic moni-toring: indications and techniques for common procedures inotolaryngology-head and neck surgery. Otolaryngol Clin North Am2005;38, 631-42, viii.
[57] Saito T, Yamamoto I, Huang XL. Effects of muscle relaxants on EEG,ABR and EMG in rabbits. Hum Exp Toxicol 1999;18:718–23.
[58] Gouveris H, Mann W. Association between surgical steps andintraoperative auditory brainstem response and electrocochleographywaveforms during hearing preservation vestibular schwannoma sur-gery. Eur Arch Otorhinolaryngol 2009;266:225–9.
[59] Legatt AD. Mechanisms of intraoperative brainstem auditory evokedpotential changes. J Clin Neurophysiol 2002;19:396–408.
[60] Polo G, Fischer C, Sindou MP, Marneffe V. Brainstem auditory evo-ked potential monitoring during microvascular decompression forhemifacial spasm: intraoperative brainstem auditory evoked potentialchanges and warning values to prevent hearing loss--prospective studyin a consecutive series of 84 patients. Neurosurgery 2004;54:97–104,discussion 104-6.
[61] Rizvi SS, Goyal RN, Calder HB. Hearing preservation in micro-vascular decompression for trigeminal neuralgia. Laryngoscope1999;109:591–4.
[62] Frohne C, Lesinski A, Battmer RD, Lenarz T. Monitoring the electrodeposition during acoustic neuroma surgery. Am J Otol 1997;18:S95–6.
[63] James ML, Husain AM. Brainstem auditory evoked potentialmonitoring: when is change in wave V significant? Neurology2005;65:1551–5.
[64] Schmerber S, Lavieille JP, Dumas G, Herve T. Intraoperative audi-tory monitoring in vestibular schwannoma surgery: new trends. ActaOtolaryngol 2004;124:53–61.
[65] Watanabe E, Schramm J, Strauss C, Fahlbusch R. Neurophysiologicmonitoring in posterior fossa surgery. II. BAEP-waves I and V andpreservation of hearing. Acta Neurochir 1989;98:118–28.
[66] Phillips DJ, Kobylarz EJ, De Peralta ET. Predictive factors of hearingpreservation after surgical resection of small vestibular schwannomas.Otol Neurotol 2010;31:1463–8.
[67] Roberson Jr JB, Jackson LE, McAuley JR. Acoustic neuromasurgery: absent auditory brainstem response does not contrain-dicate attempted hearing preservation. Laryngoscope 1999;109:904–10.
[68] Sekiya T, Iwabuchi T, Ishida T. Cerebellopontine angle surgery andintraoperative monitoring of the auditory function. The significanceand interpretation of changes of evoked potentials based on animalexperimental models. Neurol Med Chir 1985;25:254–62.
[69] Arts HA, Telian SA, El-Kashlan H, Thompson BG. Hearing preser-vation and facial nerve outcomes in vestibular schwannoma surgery:results using the middle cranial fossa approach. Otol Neurotol2006;27:234–41.
[70] Battista RA, Wiet RJ, Paauwe L. Evaluation of three intraoperativeauditory monitoring techniques in acoustic neuroma surgery. Am JOtol 2000;21:244–8.
[71] Colletti V, Fiorino FG, Carner M. Intraoperative monitoring for hearingpreservation and restoration in acoustic neuroma surgery. Skull BaseSurg 2000;10:187–95.
[72] Danner C, Mastrodimos B, Cueva RA. A comparison of directeighth nerve monitoring and auditory brainstem response in hea-ring preservation surgery for vestibular schwannoma. Otol Neurotol2004;25:826–32.
[73] Han DY, Yu LM, Ji F. Acoustic neuroma surgery for preservation of hea-ring: technique and experience in the Chinese PLA General Hospital.Acta Otolaryngol 2010;130:583–92.
[74] Jackson LE, Roberson Jr JB. Acoustic neuroma surgery: use of cochlearnerve action potential monitoring for hearing preservation. Am J Otol2000;21:249–59.
[75] Piccirillo E, Hiraumi H, Hamada M. Intraoperative cochlear nervemonitoring in vestibular schwannoma surgery – does it really affecthearing outcome? Audiol Neurootol 2008;13:58–64.
[76] Yamakami I, Yoshinori H, Saeki N. Hearing preservation and intrao-perative auditory brainstem response and cochlear nerve compoundaction potential monitoring in the removal of small acoustic neuri-noma via the retrosigmoid approach. J Neurol Neurosurg Psychiatry2009;80:218–27.
[77] Zappia M, Cheek JC, Luders H. Brain-stem auditory evoked poten-tials (BAEPs) from basal surface of temporal lobe recorded fromchronic subdural electrodes. Electroencephalogr Clin Neurophysiol1996;100:141–51.
[78] Attias J, Nageris B, Ralph J. Hearing preservation using combi-ned monitoring of extra-tympanic electrocochleography and auditorybrainstem responses during acoustic neuroma surgery. Int J Audiol2008;47:178–84.
[79] Acioly MA, Carvalho CH, Koerbel A. The role of the trigemino-cardiac reflex in postoperative hearing function in non-vestibularschwannoma cerebellopontine angle tumors. J Clin Neurosci 2011;18:237–40.
[80] Morawski K, Namyslowski G, Lisowska G. Intraoperative monitoringof cochlear function using distortion product otoacoustic emissions(DPOAEs) in patients with cerebellopontine angle tumors. Otol Neu-rotol 2004;25:818–25.
[81] Martin WH, Stecker MM. ASNM position statement: intraopera-tive monitoring of auditory evoked potentials. J Clin Monit Comput2008;22:75–85.
[82] Bond AE, Zada G, Gonzalez AA. Operative strategies for minimizinghearing loss and other major complications associated with micro-vascular decompression for trigeminal neuralgia. World Neurosurg2010;74:172–7.
[83] Miyazaki H, Deveze A, Magnan J. Neuro-otologic surgery throughminimally invasive retrosigmoid approach: endoscope assisted micro-vascular decompression, vestibular neurotomy, and tumor removal.Laryngoscope 2005;115:1612–7.
[84] Hatayama T, Moller AR. Correlation between latency and amplitudeof peak V in the brainstem auditory evoked potentials: intraoperativerecordings in microvascular decompression operations. Acta Neurochir1998;140:681–7.
[85] Jo KW, Kim JW, Kong DS. The patterns and risk factors of hearing lossfollowing microvascular decompression for hemifacial spasm. ActaNeurochir 2011;153:1023–30.
[86] Lee SH, Song DG, Kim S. Results of auditory brainstem responsemonitoring of microvascular decompression: a prospective study of22 patients with hemifacial spasm. Laryngoscope 2009;119:1887–92.
[87] Sindou MP. Microvascular decompression for primary hemifacialspasm. Importance of intraoperative neurophysiological monitoringActa Neurochir 2005;147:1019–26, discussion 1026.
EMC - Tecniche chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale 15

I – 46-543 � Monitoraggio intraoperatorio in chirurgia otorinolaringoiatrica
[88] Huang BR, Chang CN, Hsu JC. Intraoperative electrophysiologicalmonitoring in microvascular decompression for hemifacial spasm. JClin Neurosci 2009;16:209–13.
[89] Moller MB, Moller AR, Jannetta PJ. Microvascular decompression ofthe eighth nerve in patients with disabling positional vertigo: selec-tion criteria and operative results in 207 patients. Acta Neurochir1993;125:75–82.
[90] Romstöck J, Strauss C, Fahlbusch R. Continuous elec-tromyography monitoring of motor cranial nerves duringcerebellopontine angle surgery. J Neurosurg 2000;4:586–93.
[91] Bonfils P, Van Den Abbeele T, Ané P, Avan P. Exploration fonction-nelle auditive. EMC (Elsevier Masson SAS), Oto-rhino-laryngologie,20-175-A-10, 1998.
A. Uziel, Professeur des Universités, praticien hospitalier ([email protected]).F. Venail, Praticien hospitalier universitaire.Département d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervicofaciale, Centre hospitalier universitaire Gui de Chauliac, 80, avenue Augustin-Fliche, 34295Montpellier, France.Inserm U1051, Institut des neurosciences de Montpellier, 80, avenue Augustin-Fliche, 34295 Montpellier, France.
R. Garrel, Professeur des Universités, praticien hospitalier.C. Cartier, Praticien hospitalier.Département d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervicofaciale, Centre hospitalier universitaire Gui de Chauliac, 80, avenue Augustin-Fliche, 34295Montpellier, France.
Ogni riferimento a questo articolo deve portare la menzione: Uziel A, Venail F, Garrel R, Cartier C. Monitoraggio intraoperatorio in chirurgia otorinolaringo-iatrica. EMC - Tecniche chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale 2013;17(1):1-16 [Articolo I – 46-543].
Disponibile su www.em-consulte.com/it
Algoritmi Iconografia Video- Documenti Informazioni Informazioni Autovalutazione Casodecisionali supplementare animazioni legali per il paziente supplementari clinico
16 EMC - Tecniche chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale