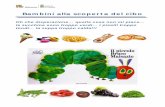MONACHESIMO E SOCIETÀ IN UN DIBATTITO DEL SECOLO XII: LA RISPOSTA DELL'ABATE DI S. MARCO AL...
-
Upload
giuseppe-motta -
Category
Documents
-
view
217 -
download
2
Transcript of MONACHESIMO E SOCIETÀ IN UN DIBATTITO DEL SECOLO XII: LA RISPOSTA DELL'ABATE DI S. MARCO AL...

MONACHESIMO E SOCIETÀ IN UN DIBATTITO DEL SECOLO XII: LA RISPOSTA DELL'ABATE DI S.MARCO AL PREPOSITO DI S. EUFEMIA DI PIACENZA (FIRENZE, BIBL. NAZ., CONV. SOPP., F.4.255)Author(s): Giuseppe MottaSource: Aevum, Anno 59, Fasc. 2 (maggio-agosto 1985), pp. 232-240Published by: Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro CuoreStable URL: http://www.jstor.org/stable/20857958 .
Accessed: 15/06/2014 17:58
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore is collaborating with JSTOR todigitize, preserve and extend access to Aevum.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 62.122.79.78 on Sun, 15 Jun 2014 17:58:43 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

MONACHESIMO E SOCIETA IN UN DIBATTITO DEL SECOLO XII
LA RISPOSTA DELL'ABATE DI S. MARCO At PREPOSITO DI S. EUFEMIA DI PIACENZA (FIRENZE, BIBL. NAZ., CONV. SOPP., F. 4.255)
Con Pessenzialita e la chiarezza che hanno sempre caratterizzato i suoi scritti, Gerard Fransen descriveva, nel 1972, un manoscritto del Decreto di Burcardo di Worms, databile a meta del secolo XII, proveniente da Vallombrosa e attualmente conservato alia Biblioteca Nazionale di Firenze, che trasmette, tra i testi fuori collezione, anche una lettera di Bruno di Segni e un breve scritto, non altrimenti noto, indirizzato da Andrea, ?ultimus omnium monachorum... de monasterio Sancti Marci?, a Giovanni ?preposito ecclesie Sancte martiris Eufemie? K In quella circostanza lo studioso lovaniense, pur non mostrando eccessivo entu siasmo per il testo, suggeriva tuttavia un'indagine per individuare Pambiente in cui si svolse la polemica non nuova tra monaci e canonici, gli attori della stessa e, infine, Pantefatto che determind la risposta di Andrea. Con il testo, che qui viene edito, si vorrebbe rispondere, almeno in parte, a questi puntuali suggerimenti.
Non e stato difficile, per la verita, individuare in Piacenza la citta della polemica: qui, infatti, con il monastero di S. Marco, i monaci vallombrosani ricevettero una fondazione fin dal 10962, ed e nella medesima citta che si trova, proprio a poca distanza dal centro val lombrosano, la canonica di S. Eufemia, una delle istituzioni piu attive nel panorama religioso piacentino del secolo XII3.
Anche i protagonisti del dibattito sono individuabili. Nei documenti piacentini pubblica ti, provenienti dalla medesima canonica, la presenza di un ?Ioannes presbiter et prepositus ecclesie Sancte Eufemie? e pressoche costante a partire dal 1124 fino al 11634. A parte le espressioni di Andrea, polemiche si, ma rivelatrici nel contempo di un indiscusso prestigio del preposito di S. Eufemia alPinterno della citta, qualche indubbia conferma proviene anche dalla documentazione offerta dal Campi. Ad esempio, in una sentenza databile al 1141, il cardinale e legato apostolico Azone, chiamato a dirimere una questione tra Pabate del mona
stero di S. Sisto e alcuni suoi cappellani, ricorre anche al ?consilio sapientum? di Piacenza, ?tam clericorum quam laicorum?. Tra i sottoscrittori della sentenza favorevole al monastero
1 G. Fransen, Reflexions sur I'ttude des collections canoniques a Voccasion de Ve'dition d'une lettre de Bruno de
Segni, ?Studi Gregoriani?, IX, Roma 1972, pp. 526-527. 2 Per le origini del monastero di S. Marco di Piacenza cfr. R. Volpini, Additiones Kehrianae (II), ?Rivista di Storia
della Chiesa in Italia?, XXIII (1969), pp. 347-348, che indica la bibliografia precedente. II monastero piacentino e stato senza dubbio uno dei centri principali della diffusione del monachesimo vallombrosano nell'Italia Settentrionale; per la principale fondazione delParea milanese cfr. P. Zerbi, Un documento inedito riguardante I'abbazia di S. Barnaba in Gratosoglio. Note sugli inizi della vita vallombrosana a Milano, ora in Tra Milano e Cluny. Momenti di vita e cultura ecclesiastica nel secolo XII\ ?Italia sacra?, 28, Roma 1978, pp. 111-1123.
3 Manca uno studio su questa istituzione ecclesiastica piacentina; anche nella recente ed ampia sintesi di P. Racine, Plaisance du Xtme a la fin du XIIFme siecle. Essai d'histoire urbaine, 3 voll., Lille - Paris 1979, si incontrano soltanto cenni saltuari. Tuttavia il ruolo notevole svolto dalla canonica di S. Eufemia risalta dalla documentazione pubblicata da G. Drei, Le carte degli archivi parmensi del secolo XII, Parma 1950.
4 G. Drei, Le carte..., cit., pp. 65 (doc. 73), 249 (doc. 306). Per la presenza di Giovanni, preposito di S. Eufemia, in questa documentazione, si vedano negli India i riferimenti al nome di Giovanni, preposito di S. Eufemia che tuttavia vanno int^grati con Paggiunta di p. 71 (doc. 80).
This content downloaded from 62.122.79.78 on Sun, 15 Jun 2014 17:58:43 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

MONACHES1MO E SOCIETA 233
troviamo, immediatamente dopo Azone ?presbiter cardinalis Sancte Anastasie?, ?presbiter Ioannes et canonicus Sancte Eufemie?. Cosi pure nell'anno 1143, a proposito della fondazio
ne del monastero detto di Quartazzola, si ricorre al ?consilium clericorum et aliorum sapien tum civitatis?, e nella sottoscrizione ?Ioannes Sancte Eufemie prepositus? e al quarto posto5.
Ma vi e un Andrea nel monastero di S. Marco, durante la prepositura di Giovanni? II fondo di quel monastero non ci e pervenuto; ma grazie ad un inventario del secolo XVIII si pud ricostruire per il nostro periodo una serie di abati, tra i quali Andrea e attestato certa mente a partire dal 27 maggio 11566; ed ancora come abate del monastero vallombrosano di Piacenza lo troviamo, insieme all'abate Giovanni da Strumi, quale intercessore del diplo ma con cui, il 30 novembre del 1158, Federico Barbarossa concedeva la protezione imperiale ai monasteri vallombrosani7. L'espressione stereotipa ?ultimus omnium monachorum? lo
rivela responsabile di quella comunita, che or a e detta di S. Marco o di S. Benedetto, oppure, congiuntamente, dei SS. Marco e Benedetto8. Se, pertanto, si tiene presente che Pultimo do cumento a noi pervenuto in cui Giovanni e preposito di S. Eufemia risale al 1163, e la prima attestazione di Andrea come abate di S. Marco e del 1156, non e affatto improbabile colloca re la polemica e lo scritto che ne derivo in questo arco di tempo, ossia tra il 1156 e il 11639.
Per Paltro aspetto sul quale il Fransen invitava ad indagare, ossia Pantefatto alPorigine della risposta di Andrea, va aggiunto che molto probabilmente non si ebbe un intervento scritto da parte del preposito Giovanni, in quanto Andrea sembra rispondere piuttosto ad iterate prese di posizione verbali del preposito di S. Eufemia, come risulta, ad esempio, da
questo riferimento: ?Dixisti nuper, karissime, etiam publice?. II Fransen, infine, ha puntualmente indicato i motivi della polemica, schematicamente
riconducibili a tre: nessun chierico pud passare tra i monaci, a meno che non si sia reso colpe vole di gravi colpe (?criminosus?, appunto); nelle chiese dei monasteri non si possono seppel
5 P. M. Campi, Dell'historia ecclesiastica di Piacenza, vol. I, Piacenza 1651, pp. 539-540 (doc. 131), 541 (doc. 132). Del resto una prova del ruolo svolto dal preposito Giovanni e della sua cultura si pud cogliere nelle stesse espressioni del suo interlocutore Andrea, che lo ritiene ?doctus vir?, ?imitator doctorum?, quasi a sottolineare la sua appartenenza al ?consilium sapientum? di Piacenza. In base alia documentazione pubblicata dal Drei (cit. supra, nota 4), ho rilevato che la presenza di Giovanni e testimoniata dal 1129; ma in base ad un documento edito a suo tempo dal Campi (ibid., p. 528, doc. 112) si pud senz'altro risalire al 1124.
6 Registro delle scritture dell'Archivio dei Canonici Lateranensi di S. Agostino, sec. XVIII (Piacenza, Biblioteca
Comunale, Ms. Pallastrelli 120) f. 13r.; Pultima presenza del predecessore Rodolfo, in questo Registro, e del 25 giugno 1155 (f. 12v). Devo queste indicazioni ed altri suggerimenti al prof. Raffaello Volpini, dell'Universita di Roma, che vivamente ringrazio; tra l'altro mi segnala che in base a documentazione che egli sta studiando, l'abbaziato di Rodolfo si deve protrarre ancora di qualche mese, almeno fino al 6 ottobre di quello stesso anno 1155.
7 MGHDiplomata regum et imperatorum Germaniae, X/2, H. Appelt ed., Hannover 1979, pp. 41-42 (doc. 245): ?...interventu Iohannis scilicet Strumensis abbatis et Andree Placentini, Maryno Vallimbrosane ecclesie presidente, cuncta monasteria Vallimbrosane congregationis ubilibet posita sub nostra imperiali tuitione suscepimus? (p. 41). Probabil mente si basa su questa menzione insieme a Giovanni da Strumi, la notizia ripresa da N. Vasaturo, Vallombrosa. Note storiche, in Vallombrosa nel IX Centenario della morte del fondatore Giovanni Gualberto, 12 luglio 1073, Firenze
1973, pp. 45 e 70, ma non sufficientemente documentata, per cui quando Giovanni da Strumi, nel 1168, divenne l'anti
papa Callisto III, avrebbe creato cardinale il nostro Andrea. Per Callisto III, antipapa, v. ora la voce di K. Jordan, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. XVI, Roma 1973, pp. 768-769.
8 Se dobbiamo prestar fede a chi ha regestato le carte del monastero vallombrosano di Piacenza nel Registro cit.
supra, alia nota 6 ? ne si hanno ragioni per correggerlo ? va subito detto che gia in un documento del 1122 il monastero
e indicato con il doppio titolo dei SS. Marco e Benedetto; nella bolla di Eugenio III del 14 aprile 1150 (v. P. F. Kehr, Italia Pontificia,vo\. V, Berolini 1911, p. 507, doc. 1) appare soltanto l'intitolazione a S. Benedetto, ma nel doc. del 1156 (v. supra, nota 6) il monastero e ancora indicato con i due titoli; successivamente rimarra soltanto quello di S. Benedetto: v. G. Drei, Le carte..., cit., p. 361 (doc. 451 del 1174).
9 In base ai documenti pubblicati da G. Drei, Le carte..., cit., p. 314 (doc. 385), risulta che a partire almeno dall'll
aprile 1170, preposito di S. Eufemia e Opizo; come pure dal Registro delle scritture... (cit. supra, nota 6), f. 15v, appare come abate di S. Marco e/o di S. Benedetto dal 5 maggio 1171 Alberto.
This content downloaded from 62.122.79.78 on Sun, 15 Jun 2014 17:58:43 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

234 G. MOTTA
lire i laici; e, da ultimo, il sacrificio eucaristico celebrato dai monaci non ha grande valore per i laici10.
Dopo alcune espressioni con le quali vuol trasmettere al suo interlocutore il proprio entu siasmo per la vita monastica ed un garbato invito alia eventuale ritrattazione sulPesempio di sant'Agostino, il monaco vallombrosano si introduce nel dibattito riferendo alcune valuta zioni del preposito della vicina canonica: ?Dixisti nuper, karissime, etiam publice, quod nul lus ex clericorum ordine effici debeat monachus, nisi forte criminosus? (p. 237, 26-27). E noto che nel secolo XII il problema del ?transitus? fu sentito specialmente per il passaggio da un monastero alPaltro dello stesso ordine monastico n; anche il passaggio da una cano nica regolare alia vita monastica o viceversa, suscitd notevoli perplessita12, ma nessuno ave
va mai messo in dubbio la possibility, per un chierico, di passare tra i monaci, come e ammesso, a certe condizioni, dalla stessa Regula Benedicti e dalla tradizione della Chiesa antica13. Nel caso, poi, del chierico ?criminosus?, il monastero era stato considerato come luogo idoneo di redenzione, e Giovanni ?- lo riconosce Andrea ? avrebbe potuto valersi di molte autorita in questo senso 14, ma non era lecito estendere tale provvedimento indebitamente ad ogni chie rico per riprovarne il passaggio tra i monaci. Ad Andrea non fu difficile citare casi ben noti di celebri persone che avevano abbracciato la vita monastica, senza essere ?criminosi?. Tut t'altro! Si tratta infatti di santi come Martino, Girolamo, Agostino di Canterbury, lo stesso
Gregorio VII ed altri ancora15. Tali riferimenti offrono motivo al nostro Andrea per ripren dere i temi tradizionali della spiritualita monastica sul valore della rinuncia al mondo e della ricerca di Dio 16.
Con Pespressione ?Denique quia dicis de fidelium oblationibus nihil dandum monachis?
(p. 238, 19), Andrea considera altre voci che gli sono giunte sui discorsi del preposito di S. Eufemia. Non e perd una affermazione esplicita di Giovanni (al limite, sarebbe troppo
?? G. Fransen, Reflexions..., cit., p. 527. 11 Rinvio, a questo proposito, anche per la bibliografia studiata a G. Picasso, San Bernardo e il 'transitus' dei mo
naci, in Studi su San Bernardo di Chiaravalle nelVottavo Centenario della canonizzazione (Convegno internazionale, Certosa di Firenze, 6-9 novembre 1974), Roma 1975, pp. 181-200.
12 In particolare, per questo aspetto, v. D. Roby, Philip of Harvengt's contribution to the question of passage from one religious order to another, ?Analecta Praemonstratensia?, XLIX (1973), pp. 69-100.
13 Benedicti regula, cap. 60: ?De sacerdotibus, qui in monasterio habitare voluerint?: R. Hanslik ed., CSEL 75, pp. 140-141. La tradizione della Chiesa e testimoniata dal canone 49 del IV Concilio di Toledo: ?Clerici qui monacho rum propositum appetunt quia meliorem vitam sequi cupiunt, liberos eis ab episcopo in monasteriis largiri oportet in
gressus nec interdici propositum eorum qui ad contemplationis desiderium transire nituntur? (H. T. Bruns, Canones
Apostolorum et conciliorum veterum saeculorum IV-VI,\o\. I, Berolini 1839, p. 235); per la diffusione di questo testo v. G. Picasso, Monachesimo e canoniche nelle sillogi canonistiche e nei concili particolari, in Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente, 1123-1215, ?Atti della VII Settimana della Mendola, 28 agosto
- 3 settembre 1977?, Milano 1980, p. 145, e, in generale, per il problema dei chierici che desiderano entrare in monastero, pp. 148-149. V. anche, a questo proposito, R. Foreville - J. Leclercq, Un de"bat sur le sacerdoce des moines au Xllsiicle, Analecta
Monastica?, IV (= Studia Anselmiana, 41), Roma 1957, pp. 73-76. 14 Che il chierico ?criminosus? debba essere rinchiuso, ?retrudere?, in monastero e affermato in testi conciliari del
secolo VI ed e ripetuto piu volte nelle lettere di Gregorio Magno: questa tradizione e accolta nel Decretum Gratiani, D. 50 c. 7 (cito, anche in seguito, nella ed. di Ae. Friedberg, Lipsia 1879: Corpus Iuris Canonici, I). Per alcuni testi di Gregorio Magno, v. Registrum 1.42 (CCL 140,54.151-157), 3.27 (p. 172. 19-24), 3.49 (p. 195.14-15), 12-10 (CCL 140A,983.30-33). Del resto tale funzione del monastero e ricordata esplicitamente anche nella carta di fondazione dello stesso monastero piacentino di S. Marco del 1095:?... ibi criminosi et a Deo alienati per secundum baptismum, videlicet
per veram conversionem purgentur et suo creatori reconcilientur? (P. M. Campi, Dell'historia..., cit., p. 524). In tutt'al tro contesto, nella storia della spiritualita monastica ricorre il tema del monastero come prigione, v. G. Penco, Mona sterium - Career, ?Studia monastica?, VIII (1966), pp. 133-143.
15 II riferimento a questi personaggi, ed anche ai due vescovi dell'epistolario gregoriano, Mariniano e Massimiano, non e nuovo nella letteratura sul sacerdozio dei monaci; v., ad esempio, S. Petri Damiani, Apologeticus monachorum contra canonicos, PL 145, 514; R. Foreville - J. Leclercq, Un de*bat..., cit., p. 58.
16 La bibliografia, su questo argomento, e abbondantissima; per qualche riferimento ai contributi piu notevoli v. la voce, di Autori Vari, Monachisme, in Dictionnaire de spirituality, fasc. 68-69, Paris 1979, coll. 1524-1617.
This content downloaded from 62.122.79.78 on Sun, 15 Jun 2014 17:58:43 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

M0NACHES1M0 E SOCIETA 235
scoperta); e una evidente conseguenza di quanto andava dicendo sulla sepoltura dei defunti: non sarebbe lecita nella chiesa dei monaci. A questo proposito Andrea riprende il problema generale del rapporto, nella Chiesa, tra monaci e canonici; e lui, vallombrosano, ammette una distinzione di competenze che certamente nei momenti drammatici dei primi sviluppi val lombrosani, nel secolo XI, non fu rispettata11, ne del tutto pacifica doveva essere neppure durante il secolo XII, almeno se dobbiamo credere ad altri testi di quel periodo 18. L'affer mazione di Andrea e molto chiara: ?Cum enim asseras monachos non debere plebem regere nec penitentiam secularibus dare nec per domos seculares ire et infirmos visitare, scias nos in his cunctis tecum sentire? (p. 238, 37-40). Non si tratta, pertanto, di riprendere la polemica sulFesercizio della ?cura animarum?. II pensiero del monaco Andrea, esposto in termini estre
mamente chiari, riconosce ai canonici e ai monaci diverse competenze specifiche in ordine alia societa ecclesiale: ai primi compete Finsegnamento, ai secondi la preghiera: ?Unus qui instet doctrine, alter orationi assidue? (p. 238, 42). Dei primi hanno bisogno gli uomini du rante la loro esistenza; ma perche non riconoscere che dopo la loro morte hanno bisogno soprattutto delle preghiere dei monaci? A parte qualche osservazione non priva d'arguzia, Andrea rivendica la piena legittimita della pratica di seppellire i morti nei monasteri19, in base al compito specifico della vita monastica nella societa che e, per dirlo con le sue stesse
parole, il compito di Maria20. D'altra parte, nella distinzione dei compiti tra monaci e canonici, ancorata alle stesse
radici teologiche delle rispettive vocazioni, Andrea non insiste al punto da creare una netta
separazione o, addirittura, un contrasto. L'universale tradizione ecclesiastica, che non pud non essere ispirata dallo Spirito Santo, consente che si seppelliscano i morti anche nelle chiese dei chierici21, quasi a voler dire che Finsegnamento e la preghiera sono compiti propri di ciascuno dei due ordini, ma non in modo esclusivo; anche i canonici possono pregare per i defunti ed anche i monaci possono insegnare ai vivi.
Tale visione di singolare chiarezza teologica e, piu di ogni altra, concretamente legata alia situazione storica del monachesimo nel quale il sacerdozio si era diffuso proprio nei secoli centrali del Medio Evo22, offre al vallombrosano Andrea Popportunita di riprendere un'al tra gratuita affermazione del preposito Giovanni, proprio circa il valore del sacerdozio dei
17 Per le origini vallombrosane rimangono fondamentali gli studi di S. Boesch Gajano, Giovanni Gualberto e la vita comune del clero nelle biografie di Andrea di Strumi e di Atto di Vallombrosa, in La vita comune del clero nei secoli XI e XII, ?Atti della I Settimana di studio, Mendola 1959?, II, Milano 1962, pp. 228-235; Storia e tradizione vallombrosane, ?Bullettino delPIstituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano?, LXXVI (1964), pp. 99-215 (specialmente questo secondo); per i rapporti con il movimento patarinico, v. G. Miccoli, Pietro Igneo. Studi sull'eta gregoriana, ?Studi storici?, 40-41, Roma 1960, e C. Violante, I laid nel movimento patarino, in Studi sulla Cristianitd medioevale. Societa istituzioni spiritualita, Milano 19752, pp. 234-244.
18 In una bibliografia assai considerevole, oltre al contributo di R. Foreville - j. Leclercq, Un dibat..., cit., rin vio a due contributi recenti e significativi: C. D. Fonseca, Monaci e canonici alia ricerca di una identitd, in Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali..., cit., pp. 203-222; j. Leclercq, Monachisme, sacerdoce et mission au Moyen Age, ?Studia monastica?, XXIII (1981), pp. 307-323.
19 Testi sulla sepoltura dei cristiani sono raccolti nel Decreto Gratiani, C. 13 q. 2 cc. 4-6, 17-19; in particolare, Gra ziano osserva: ?Ubi autem quisque tumulandus sit, legibus expressum non est, et ideo in voluntate tumulandi consistit?
(C. 13 q. 2 d.p.c. 3); per la liceita di seppelire i morti nelle chiese dei monasteri, lo stesso Graziano (C. 16 q.l c. 13) cita un testo di Gregorio Magno (Reg. 1. 12), al quale premette questa rubrica: ?Missae celebrari, et mortui sepeliri in monasterio non prohibeantur?.
20 Si vedano i testi segnalati su questo tema da j. Leclercq, Etudes sur le vocabulaire monastique du Moyen Age, ?Studia Anselmiana?, 48, Roma 1961, pp. 150-154.
21 I testi segnalati sopra, alia nota 19, generalmente si riferiscono alia chiesa, senza distinguere tra quelle dei cano
nici e dei monaci. La Institutio canonicorum Aquisgranensis dell'816, cap. 145, include anche la raccomandazione: ?mortuos sepeliant? (MGH Concilia 2/1, p. 420.8).
22 Per la clericalizzazione del monachesimo dal secolo X in poi rimando alle indicazioni di j. Leclercq, Monachi
sme, sacerdoce..., cit., pp. 319-323.
This content downloaded from 62.122.79.78 on Sun, 15 Jun 2014 17:58:43 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

236 G. MOTTA
monaci: ?Denique, quia testantur plerique te d i c e r e missas monachorum laicis audire nihil prodesse, nec eas debeant audire? (p. 239, 34-35). Neanche in questo caso sarebbe man cato a Giovanni qualche appoggio per sostenere la sua tesi23. Andrea gli oppone la realta della vita monastica, com'era concretamente sotto gli occhi di tutti, nel monastero piacenti no: si svolgeva nel susseguirsi ordinato della preghiera, di giorno e di notte. Come si poteva sostenere che non rapppresentava un vantaggio per la vita spirituale di quanti vivevano im
mersi nelle occupazioni della vita cittadina? A condizione, ovviamente, che fosse una testimo nianza autentica; come, del resto, quella dei canonici. Se le celebrazioni eucaristiche e le altre
preghiere fossero state fatte ?pro implendo marsupio? (p. 240, 18), allora non avrebbero avuto valore alcuno.
II preposito di S. Eufemia insiste molto, nei suoi discorsi, sulla necessita che tra i monaci e gli abitanti della citta ci sia una netta separazione. Si tratta di una forte accentuazione del
l'aspetto ascetico della vita monastica. II vallombrosano non sa dargli torto: ?Abta quidem, karissime, sunt hec sed indiscreta? (p. 240, 25); e gli ricorda, con Pimmagine del naso del
predicatore24, che e necessaria, in ogni caso, la discrezione. Un monachesimo del tutto se
parata dalla societa, e perfino dal sacerdozio, ormai non sarebbe stato possibile: ?Aliter quippe vel dicere vel agere, potius est monasticam religionem destruere quam retinere? (p. 240, 38-39)25.
In conclusione, Andrea ribadisce d'aver esposto alcune sue convinzioni, basate sull'auto
rita divina delle Scritture e della tradizione (?universalis ecclesie usus?), senza, per questo escludere la ragione; spera che non essendo le sue delle visioni personali, anche il preposito possa farle sue in Cristo. Una conclusione, come si vede, assai garbata; riflette, del resto, il tono piuttosto persuasivo di tutto il discorso , che raramente cede alia tentazione della pole
mica troppo scoperta. Comunque, al di la della capacita espressiva non trascurabile di questo monaco, il testo in se stesso dimostra una notevole evoluzione intorno a problemi che allora vennero affrontati dai personaggi piu in vista nella vita della Chiesa, ma che si ripercuoteva no, proprio intorno alia meta del secolo XII, anche in piu modesti ambiti cittadini, tra due istituzioni ecclesiastiche, il monastero di S. Marco e la canonica di S. Eufemia, poste Puno
accanto alPaltra presso le mura della citta di Piacenza.
Giuseppe Motta
23 Si incontrano, nella tradizione canonistica, indicazioni come questa: ?Ne publice missae fiant in cenobiis?, Ivo, Decretum, 7.13 (PL 161, 548); v. anche R. Foreville - J. Leclercq, Un debat..., cit., p. 66.
24 ?Recte ergo per nasum discretio exprimitur?, v. testo cit. nel Decretum Gratiani, D. 49 c. 1. 25 Significativa, a questo proposito, la citazione dell'esempio dei ?Pauliani?; si incontra anche in altri testi, v. R.
Foreville - J. Leclercq, Un debat..., cit., p. 59.
This content downloaded from 62.122.79.78 on Sun, 15 Jun 2014 17:58:43 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

MONACHESIMO E SOCIETA 237
Firenze, Biblioteca Nazionale, Conv. Sopp. F. 4. 255, ff. 189ra-190rb.
[I]ohanni venerabili preposito canonice ecclesie sancte martiris Eufemie, Andreas ultimus omnium monachorum et fratres ceteri de monasterio sancti Marci salutem et fidelem orationem. Nostras ad te aliquantas scribentes litter as sanctum invocamus Spiritum, ut ea a te caritate, qua a nobis mittuntur, recipiantur. Constat quippe apud nostrum animum 5 te esse doctum virum et religiosum et catholicum, et novimus te que sunt Iesu Chri sti querere opere et sermone. Unde nimirum gaudentes Christi clementiam depreca
mur supplices, ut det tibi sic inreprehensibiliter vivere et docere, quatinus ordo omnis, conditio omnis, sexus omnis post te queat currere gressu securo et inoffenso pede. Inter cetera quippe dona multimoda, tibi a luminum Patre concessa, optamus et ora- 10
mus, ut ab eo tibi detur noscere bona monastice regularis vite, que sint et quanta, sicut novit Gregorius doctor egregius. Quod si esset, proprias si haberes opes, ipsi procul dubio cuncta traderes, etiam si essent multiplices, ut ille. Temet eidem de hinc dares, ut ille. Imperatoris edicto Mauritii non convenires, sed pro viribus resi steres, ut ille. Quod Mauricius enim de militibus sanxit, tu de clericis. Cunctis suaderes 15
mortalibus, nulla excepta persona, mundum relinquere et monasterium petere, ut
ille. Pretio pueros emeres, monachos faceres, ut ille. Porro quia cultori non deest spes quin triticum, dum est in spica vel flore, veniat ad maturitatem quandoque, potens est Deus quandoque concedere te ex integro noscere et diligere quod noscis et diligis ex quantulacumque parte. Rogamus et adiuramus, ut veracium sis imitator 20
doctorum, retractando scilicet sollicite, si quid improvise te contigerit quandoque dixisse. Et cum id noveris, ne omittas quin per temet corrigas. Quomodo hoc sit verorum doctorum noveris proprium, cum studiose inspexeris beati Augustini re tractationum librum. Prestet Christus te benigne et patienter sumere quod nunc tibi sumus dicturi, eius inertes et inutiles servuli. 25 Dixisti nuper, karissime, etiam publice, quod nullus ex clericorum ordine effici de beat monachus, nisi forte sit criminosus. Etsi tibi dicenti documenta faverent mul
ta, quomodo tibi tune locutio defuit discreta, qua fulcienda est omnis doctrina?
Quis, quesumus, tot criminosis divina preberet sacramenta, cum ea nequeat offerre
persona criminosa? Fatemur, si te talia dicentem Martinus obviaret sanctus et doctor 30 Hieronimus et vii papa Gregorius et his aderens esset Augustinus in Anglis missus, pridem a doctore Gregorio in monasterio de ordine clericorum susceptus, et Mari nianus Ravennas presul et Maximianus Siracusanus episcopus forsitan dicerent: ?0 Iohannes frater, cur nos fateris non debuisse ordinem clericalem dimittere et mona
27 tibi inter tin. 31 Hieronymus : h- inter tin.
6-7 cfr. Phil. 2.21 10 cfr. lac. 1.17 1 l-12ex. gr., Reg. 1.5 (CCL 140.5-7) 12-13 cfr. Joannes diac., S. Gregorii Magni vita, 1.5 (PL 75.65) 13-14 ibid., 1.6 (PL 75.65) 14-15 cfr. ibid., 3.50 (PL 75.160); vide etiam Reg. 3.61 (CCL 140.209-211), 3.64 (CCL 140.214-215) et 8.10 (CCL 140A.527-528) 15-17 cfr. Reg. 8.10 (CCL 140A.527) 17 cfr. Joannes diac, S. Gregorii Magni vita, 2.46 (PL 75.107), Reg. 6.10 (CCL 140.378-379) 24 Augustinus, Retractationes: CCL 57 25 cfr. Lc 17.10 26-28 Vide supra, n. 14 28 vide, ex. gr., Gregorius M., Regula Pastoralis, 2.4, 3.14 (PL 77.30-32, 72CD-73A); Homiliae in Ezechielem, 1.11-20 (CCL 142.174-178) 30-33 Martinus: cfr. Sulpicius Severus, Vita S. Martini, 5, 9 {Sources chretiennes, 133.262, 270-272); Hieronimus: S. Hieronimi vita (PL 22.177); Gregorius VII: vide in Bibliotheca Sanctorum, 7.297 (cur. G. Miccoli); Augustinus: cfr. Joannes diac, S. Gregorii Magni vita, 2.33-34 (PL 75.99), et Reg. 6.53 (CCL 140.426); Marinianus: Joannes diac, S. Gregorii Magni vita, 4.5 (PL 75.174-175), v. etiam Reg. 5.51 (CCL 140.345) et 8.17 (CCL 140A.536); Maximianus: cfr. Joannes diac, S. Gregorii Magni vita, 1.33 (PL 75.76-77) et App. II ad Reg. (CCL 140A1094-1095)
This content downloaded from 62.122.79.78 on Sun, 15 Jun 2014 17:58:43 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

238 G. MOTTA
sterium petere, cum id pro iustitia summa fecerimus et quot quivimus hoc agere per suaserimus? Sive enim nos qui id fecimus in culpa sumus, et penitentia egemus, sive tu qui non id facere debuissemus protestaris. Sed pontifex summus Iesus hanc inter nos et te diffinit controversiam clare. Nam cum apud ilium venerimus, non indixit
penitentiam, sed pro hoc perpetua remuneravit gloria. Tibi igitur talia dicenti debe- 5 tur penitentia, non nobis iam remuneratis gloria?. Verum forsitam adhuc aierent:
?Quia te de nostro consortio fatemur et semel tibi loqui cepimus, rogamus ut si adhuc te manere in ordine canonico delectat, cave ne ordo monasticus tibi vilescat?. An vilis est anima, karissime, que relinquit terrena et querit celestia, relinquit seculum et querit Deum? Huiusmodi enim quanta sit apud Deum magnitudo tune cognove- 10
ris, tu non monachus, si ibi oculum posueris, ubi martir Ciprianus, non monachus, suum posuit. ?Qui, inquit, reliquit seculum, maior est omnibus honoribus et regno?. Ilia solida saltim sententia sit tibi in memoria: ?Noli, inquit, prohibere bene facere eum qui potest, si vales et tu benefac?. Sic enim te decet laudare opus Marthe, ut eidem semper preferas opus Marie. Hoc quidem Christus fecit dominus, et nos et 15 omnes sancti viri agere procuravimus. Quod enim pretium id facientibus promiserit Dominus, tuus doctus non ignorat animus: ?Qui pretiosum, inquit, a vili separave rit quasi os meum erit?.
Denique quia dicis de fidelium oblationibus nil dandum monachis, cave ne tali pre dicatione eos oppressos egestate cum peccato cogas subsidia querere vel pre inopia 20
regualerem tramitem dimittere. Forsitan non hoc dicere te respondes. Numquid non hoc dicis, cum profitearis nichil officii gerendum monachis viventibus, et adiungis quod nec etiam debeant sepelire mortuos? Qua alia, quesumus, causa a secularibus oblatio impenditur aliqua? Estne iustum, karissime, ut illis denegentur omnia, qui Christi amore cuncta dimiserunt propria et sua cum vitiis et concupiscentiis crucifi- 25 xerunt membra atque contend parco et vili subsidio que supersunt cuncta per ma nus pauperum condunt in celo? Et vivorum et mortuorum oblationes cuncte illis dentur solummodo qui stipe templi et his que conferuntur ad usus ecclesie abutun
tur in rebus quibus suas expleant voluptates et sunt, ut ait Hieronimus, similes scri barum et phariseorum Iesu sanguinem redimentium. Dicis forsitan monachi tales 30
perpauci; et tales non omnes clerici etiam. Sed doctoris studium omnino debet pro curare, ut omnis sit talis et de clericis nullus talis, et tune exortari, ut Gregorius, arbusta diversa in dominico agro plantata facere fructum secundum debitum pro prium: vitem scilicet, ut proferat uvas; ulmum, ut sustentet vitem; abientem, ut se extendat in aerem, quod fecisse constat omnem verum doctorem. Et Christi sic de- 35 bet columbas nutrire dispensator Christi, ut non necet fame turtures Christi. Utra
rumque enim creator, licet diverse sint nature, esse valet utrarumque nutritor. Cum
enim asseras monachos non debere plebem regere nec penitentiam secularibus dare nec per domos seculares ire et infirmos visitare, scias nos in his cunctis tecum senti re. Cum vero adiungis monachos non debere sepelire mortuos, necesse est te per- 40
pendere utrum dicas iuste. Constat enim apud tuum animum duos or dines in ecclesia ordinatissime a conditore dispositos: unus qui instet doctrine, alter orationi assidue. Donee manet in corpore mortali, homo doctoris eget officio. Cum vero obit, cur
8 canonico : -no- inter I'm. 21 regularem] vitam add. et expun. ms.
9 cfr. Sacramentarium Veronense, 18.2.421 (L. C. Mohlberg ed., Roma 1966, p. 57) 12 fontem non inveni 13-14 cfr. Prov. 3.27 14-16 cfr. Lc 10.40-42 17-18 Ier. 15.19 26 cfr. Matt. 19.27, Marc. 10.28, Lc. 10.28 25-26 cfr. Gal. 5.24 26-27 cfr. Lc. 11.41 27-30 cfr. Hieronymus, In Matheum, 4.28.14 (CCL 77.282), v. etiam Concilium Aqui sgranensea. 816, c. 116 (MGH Cone. 2/1.398) 33-35 cfr. Gregorius M., Homiliae in Evangelia, 1.20.13 (PL 76.1167)
This content downloaded from 62.122.79.78 on Sun, 15 Jun 2014 17:58:43 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

MONACHESIMO E SOCIETA 239
vetas defunctum ad alterius officium ferri, quo magis ex hinc eget quam tuo? Pre sertim cum tibi dicat universorum Dominus: ?Sine mortuos suos sepelire mortuos, tu vero annuntia regnum Dei?. Non decet igitur te alienum preripere officium, cum tibi ab alio preripi nolis tuum. ?Vide, inquid scriptura, ne facias alteri quod tibi nolis fieri?. Mortuos mundo fateris monachos, et Christus fatetur talium mortuo- 5 rum esse defunctos. Cur itaque ipsis conaris auferre, cum a cunctis te videatur Chri stus prohibere? Eorum etiam regula, que eis vetat negotia secularia, mortuos sepeli re omnino imperat. Dicis fortasse de corporibus suorum tantummodo fratrum id
regula precipere. Hanc quippe doctrinam monachis a tarn sancto viro dari omnimo do esset superfluum, cum non solum humanitas, verum etiam intolerandus fetor id 10 eos agere cogeret. Cum enim hoc dicimus, absit ut dicamus quod tantummodo cle rici et nullo modo monachi debeant christianos fideles docere. Nec dicimus quod solummodo monachi et non etiam clerici debeant sepelire corpora defuncta. Quo niam nec hoc nec illud habet universalis ecclesie usus, quam regit et inspirat Dei
Spiritus. Novas quippe opiniones affirmare non debemus, ne subrepat alicuius signum erro- 15 ris, timentes illud quod Augustinus doctor ait: ?Hereticus est qui alicuius tempora lis commodi et maxime glorie principatusque sui gratia falsas ac novas opiniones vel gignit vel sequitur?. Semper quidem et a doctis monachis ad monasteria venien tibus christianis monita sunt data salutis et per christianitatem cunctam ab utroque ordine defunctorum corpora semper sunt sepulta. Hoc quidem fulti antiquo et uni- 20 versali usu ecclesie et exemplo tarn novi quam veteris testamenti dicimus et affirma mus, ut ibi sit sepeliendus defunctus, ubi se, dum vixerit, sepeliri adiudicaverit. Et ibi iacere sibi magis prodesse, ubi studiosius et religiosius assidua agitur pro mor tuis oratio et hostie sacre frequens immolatio, si non adeo sit impius, ut ei post mortem subvenire nequeat ullus. Sicut anime in corpore viventi proficit magis, si in ea eccle- 25 sia frequentetur in qua doctrina assidue exuberat et divinum agitur officium indesi nenter, quam si in ea in qua nulla vel rara et officium segniter. Et hec est causa
qua precipua corpora antiquitus sepeliuntur per monasteria. Mos quippe tarn salu tifer et tarn rationalis potius est venerandus quam damnandus, etiam si unius esset
civitatis, quanto magis quia est ecclesie generalis totius christianitatis, doctore insi- 30 nuante Ambrosio: ?Ad quam forte, inquid, ecclesiam veneris, eius morem serva, si cuiquam non vis esse scandalum nec quemquam tibi?. Et Augustinus: ?Hanc,
inquit, sententiam semper habui, quasi celesti oraculo acceperim?.
Denique quia testantur plerique te dicere missas monachorum laicis audire nichil
prodesse nec eas debeant audire. Quod te dicere, sicut populi intellegunt, absit ut 35 credatur. Quomodo enim potest fieri, ut vir tarn doctissimus tamque religiosissimus dicat christianis viris nichil prodesse hora tertia secularia negotia et fabulas amore divino dimittere, ad monasteria convenire, que Dei sunt reverenter audire, et maxi
me his qui media pene nocte surgunt, psalmos et orationes, quibus anime purifican tur, et lectiones, quibus instruuntur, audiunt, interdum gelu sustinentes et fatigium 40 euntes et redeuntes, suis ceteris vicinis per noctem fere totam soporantibus et carnis
voluptates complentibus? Cum dicat evidentissime Apostolus: ?Unusquisque reci
piet mercedem secundum suum laborem?. Numquid enim cunctis spiritualibus ani marum proficuis monachi omnino sunt mortui, eo quod mundum et cuncta secularia
4 preripi scripsi: preripere ms 17 gratia (gra) corr. ex cura ms 26 indesinenter prima manu : indiligenter ms
2-3 cfr. Lc. 9.60 4-5 cfr. Tob. 4.16 7-8 cfr. Benedicti regula, 4.17 (CSEL 75.30) 16-18 cfr. Augustinus, De utilitate credendi, 1.1 (CSEL 25/1.3.6-9) 31-33 Augustinus, Ep. 54.2.3 (CSEL 34.161.8-13) 43-44 cfr. 1 Cor. 3.8
This content downloaded from 62.122.79.78 on Sun, 15 Jun 2014 17:58:43 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

240 G. MOTTA
reliquerunt negotia? Aliter quippe Fabianus papa vidisse et in suis decretis legitur dixisse: ?Sunt, inquit, multi qui dicunt quod monachi mundo mortui predicare non debeant. Nos vero dicimus quod eorum doctrina tanto sit saluberrime agenda, quanto eos constat die noctuque meditari in lege divina et quod eorum inreprehensibilis sit vita, a negotiis scilicet secularibus omnimodo expedita?. Licet enim te ut iustum 5 et doctum virum nullo modo credamus, ut populi intellegunt, dicere; omnimoda tamen culpa non asserimus te carere, cum eis distincte et plene non facis, que dicis, intelligere. Quod si actenus non fecisti, decet te facere, ne sis obnoxius ille sententie
legis sacre: ?Si quis, inquit, fecerit foveam et non cooperuit et bos vel asinus vicini in ea corruerit, reddere cogatur qui foveam fecerit?. O quam durum est lapides fer- 10 re in celsi montis summitate, deorsum eos dimittere quam est leve! Sic profecto se culares homines multo labore ad divinum cultum vix trahi queunt, sed cum hocca sione satis levi cito dimittunt. Veruntamen quid alii velint credant; nos credimus et confitemur officium divinum a personis catholicis et castis quanto religiosius ac studiosius agitur, tanto potius proficere sicut agentibus ita audientibus, sive sint 15
qui id agunt monachi seu canonici, si tamen illud non sit adulterinum et cupidi neum. Adulterinum et cupidineum dicimus esse illud officium, cum monachi usur
pant pro implendo marsupio, quod eis agere nec regula precipit, et proprium sit agere tantummodo canonicis. Ad confirmationem quippe huius rei, quam dicimus, multa testimonia conferre possemus, sed hoc breviter commemorasse sufficiat, quo- 20 niam non credimus quod vir quilibet doctus aliter sentiat. Preterea aliud, quod te constat certissime dicere, videlicet quod monachi ad populum non debeant progredi et ad eos in claustra frequentare non debeant laici atque monasterium non debeat habere presbiterum nisi monachum. Nostrum huiusmodi caritativum est respon sum: abta quidem, karissime, sunt hec sed indiscreta. Nasus quippe predicatoris 25 esse profecto debet, ut turris Libani, non lingua. Cum enim doces alta et impossibi lia, lingua tua non nasus est, Libani turris, ut omnis sermo veri doctoris. Si enim cenobii regimen nosceres, talia, ut diximus supra, non diceres. O quot conatibus,
quot vicibus sacerdote non monacho carere voluimus! set eo carere et monasticam
religionem tenere et in secularium vicinitate manere non posse fieri probavimus se- 30
pissime. Dicimus tamen quod in canonicorum ecclesiis monasterii sacerdos non de beat agere quicquam absque permissione eiusdem civitatis episcopi vel proprii ali cuius capelle presbiteri. Si enim monachi cuncti fore possent Pauliani, videlicet ut Paulus per annos Lx semper nutrirentur amministratione corvi, officio et cura non
indigerent alicuius presbiteri. Cum vero id nequeant et in claustris quemadmodum 35 cenobite, ut vere fateris, manere debeant dediti silentio et quieti, immo lectioni et
orationi, in venire nequimus quomodo tantum queant vacare contemplationi Marie, nisi adsit exercitatio Marthe. Aliter quippe vel dicere vel agere, potius est monasti cam religionem destruere quam retinere.
Cuncta hec que per homines simplices et inertes, licet sermone inculto et rustico, 40 sunt locuta et scripture auctoritas divine et generalis usus ecclesie necnon qualiscumque ratio subsequens compleat ad Deum oratio. Christus dominus, cuius tu es et nos
sumus, si hec nostra sunt, prestet ut sint tua. Si vero non sua, nec nostra nec tua.
5 ut inter I'm. 9 non inter I'm. 10 corruerit : -er- inter tin. 27 ut om. ms 31 canonicorum : -no- inter lin. 37
queant scripsi: queat ms
2-5 non est Fabiani; haud dubie refertur sententia Ps. -Bonifacii IV, ?Sunt nonnulli? (PL 80.104-106; JE + 1996) 9-10 cfr. Ex. 21.33-34 25-27 cfr. Gregorius M., Super Cantica Canticorum, 7.9 (PL 79,534-535) 33-34 cfr. Hieronymus, Vita S. Pauli primi eremitae, 10 (PL 23.25-26)
This content downloaded from 62.122.79.78 on Sun, 15 Jun 2014 17:58:43 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions












![Eufemia graduatoria Albo - icmarcallo.edu.it · lor 'hvful]lrqh 3urilor 3rvwr &rjqrph 1rph 'dwd 1dvflwd 3xqwhjjlr $$ $66 $00,1,675$7,92 5,&&+,1, $1721 ... $$ $66 $00,1,675$7,92 75$32/,12](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5fbf2ac32b150400b42e9b64/eufemia-graduatoria-albo-lor-hvfullrqh-3urilor-3rvwr-rjqrph-1rph-dwd-1dvflwd.jpg)