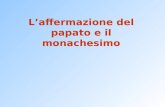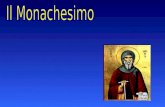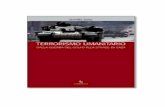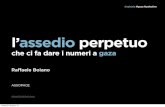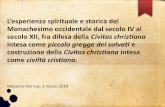Misure del Monachesimo a Gaza
-
Upload
settemontierma1 -
Category
Documents
-
view
30 -
download
0
description
Transcript of Misure del Monachesimo a Gaza
-
164
Misure del monachesimo a Gaza: dal fondatore Ilarione alla scuola monastica di Gaza
di Rosa Maria Parrinello
Ilarione il fondatore del monachesimo di Gaza?
Ilarione nacque a Thavata (otto chilometri a sud-est di Gaza), nel 291, una ventina danni prima delleditto di Costantino, quando dunque Antonio aveva una quarantina danni, laddove Pacomio e Macario il Grande sono della sua stessa generazione. La Vita di Ilarione, scritta da Girolamo intorno al 390, sembra accelerare il processo della storia del santo, che a quindici anni gi frequenta la scuola di Alessandria e trascorre qualche settimana presso Antonio1. Una fonte che ci d qualche informazione su questo personaggio lo storico Sozomeno, nato a Bethelea presso Gaza verso il 380 e la cui famiglia fu assai influenzata dal modello monastico: egli parla sia di Ilarione sia di abba Silvano e dei suoi discepoli. Ancora, a Besanduzio, vicino a Eleuteropolis, Epifanio, un monaco palestinese di origine giudaica e discepolo di Ilarione, fond una delle prime comunit monastiche del luogo: egli altri non che Epifanio di Salamina di Cipro, presumibilmente fonte di Girolamo. Alla morte dei genitori, seguendo il modello antoniano, Ilarione distribuisce leredit ai poveri e comincia a condurre vita solitaria, a otto chilometri a sud-est di Maiuma, il porto di Gaza, attirando ben presto altri eremiti. Egli abbandona definitivamente la Palestina nel 356, anno della morte di Antonio, per sottrarsi ai visitatori che ormai erano assai numerosi, e muore, dopo varie peregrinazioni, a Cipro, ma un discepolo ne trafuga il corpo per portarlo a Gaza2. Scopo della Vita di Ilarione scritta da Girolamo fu non tanto quello di dare un fondatore emulo di Antonio al monachesimo palestinese, quanto di confezionare un libro edificante che narrasse lesistenza esemplare di un monaco vagante3, prima che quello dellitineranza diventasse un problema disciplinare in seno al monachesimo4.
1 Sappiamo che la Vita di Antonio fu lopera grazie alla quale Gerolamo, durante il suo soggiorno a Treviri, alla corte di Valentiniano, aveva scoperto lascetismo intorno al 367. Il movimento ascetico infatti aveva conosciuto a Treviri uno sviluppo particolare, dal momento che vi era stato esiliato negli anni 335-337 Atanasio, autore appunto della Vita di Antonio che era stata tradotta in latino da Evagrio di Antiochia: cf. Jrme, Trois vie de moines (Paul, Malchus, Hilarion), intr. par E.M. MORALES A. DE VOG, tr. par P. LECLERC, notes de la tr. par E.M. MORALES P. LECLERC (SC 508), Paris 2007, p. 13. 2 Barsanuphe et Jean de Gaza, Correspondance. Volume I. Aux solitaires. Tome I Lettres 1-71, intr., texte critique et notes par F. NEYT, P. DE ANGELIS-NOAH. Trad. par L. Regnault (SC 426), Paris 1997, 14-15. 3 Jrme, Trois vie de moines, cit., p. 20. 4 Girolamo parla di tre generi di monaci, cenobiti, anacoreti e remnuoth, che vivono insieme in due o tre, pi raramente in numero maggiore, e sono idioritmici. Parte di quello che essi producono confluisce in un fondo comune per provvedere al sostentamento e alcuni chiedono lelemosina per le strade (Lettera a Eustochio 22.34). Secondo Ewa Wipszycka la spiegazione del termine remnuoth (e sarabaitae di Giovanni Cassiano) fa difficolt, ma certo che si tratta di forme di ascetismo premonastico che continuano a esistere anche dopo lo sviluppo di eremitismo e cenobitismo. La studiosa polacca ha inoltre dimostrato che, se il milieu monastico dovette stigmatizzare i costumi dei vagantes, tale stigmatizzazione non necessariamente fu propria dei semplici membri delle comunit cristiane: E. WIPSZYCKA, Les communauts monastiques dans lEgypte byzantine, in Valeur et distance. Identits et socits en Egypte, Paris 2000, 75-77. Che quello dei monaci vagantes fosse un problema disciplinare non da poco lo dimostra anche il canone 4 del Concilio di Calcedonia del 451, che stabilisce che i monaci di ogni citt devono essere soggetti al
-
ROSA MARIA PARRINELLO Misure del monachesimo a Gaza
165
Senza voler entrare nello specifico della questione, vi sono stati numerosi dibattiti sulla storicit della figura di Ilarione, che alcuni studiosi hanno pensato essere sostanzialmente uninvenzione di Girolamo5; anche la testimonianza di Sozomeno sembra essere infatti debitrice della vita geronimiana, almeno per quanto riguarda Storia ecclesiastica V,10. Tuttavia, poich lesorcismo di cui si parla in Vita ecclesiastica 5,15 nella Vita di Gerolamo non ricorre, Sozomeno forse debitore su questo punto o di una tradizione orale basata sui racconti di Esichio, compagno di Ilarione, o della lettera di Epifanio di cui parla anche Girolamo, ma che non ci arrivata. Lo Stridonense e Sozomeno sembrano essere le uniche due fonti contemporanee a parlare di Ilarione. In realt le recenti acquisizioni archeologiche hanno contribuito a dare una concretezza storica assai maggiore a questa figura dai tratti evanescenti, e che nel monachesimo successivo sembra, a una prima e superficiale impressione, non aver lasciato traccia, anche se Giovanni di Gaza nella lettera 618 cita Ilarione e un episodio tratto dalla Vita di Ilarione (cap. 10,13), che aveva letto probabilmente nella traduzione greca di Sofronio. Assai prezioso in questo senso stato il lavoro del Service des Antiquit de Palestine e dellcole Biblique et Archologique Franaise6, che hanno inventariato a Gaza strati che vanno dallEt del Ferro fino alla Tarda Antichit. Per quanto riguarda lepoca che ci interessa, gli scavi hanno confermato che Ilarione fond il monachesimo eremitico a Gaza prima del 330 nel villaggio di Thavatha, vicino al Wadi Ghazzeh, il cui toponimo compare sulla carta di Madaba, la celebre mappa-mosaico della Terra Santa, fabbricata nel VI secolo da artigiani appunto a Madaba, in Giordania. Ilarione aveva convertito al cristianesimo la famiglia di Sozomeno, lo storico ecclesiastico originario di Bethelia Betulion nella carta di Madaba che ospita successivamente un rifugio monastico, verosimilmente monofisita. Pietro lIberico fond nel 486 una laura che dovette essere sita a Magdal Tutha vicino a Thavatha, nei pressi della chiesa di Ilarione; sempre a Thavatha troviamo in epoca successiva il monastero di Seridos. A Gerara sorgeva invece la laura del monaco Silvano: a fronte delle difficolt di individuare con esattezza il sito, gli scavi propongono di identificarlo con Umm Jarrar, sulle colline di Bani Khamis. Merita rilevare che i monasteri della zona del Wadi Ghazzeh erano cos vicini da vedersi gli uni con gli altri. Per quanto riguarda Ilarione, il punto di partenza la scoperta, a opera di unquipe della cooperazione archeologica franco-palestinese, nellautunno 2003, a una decina di chilometri da Gaza, cio a Umm el-Amir, sul territorio della municipalit di Nuseirat, di uniscrizione che nomina Ilarione ( : Per le preghiere e lintercessione del nostro santo Padre Ilarione, piet)7. Si tratta di un tipo di intercessione indirizzata in generale a Cristo, a Maria, agli apostoli e ai santi, dunque lIlarione in questione non un Ilarione qualunque, ma il padre del monachesimo di Gaza.
vescovo del luogo, restare nel monastero dove hanno fatto la rinuncia, uscendo per mescolarsi agli affari della chiesa e del mondo solo su espresso ordine del vescovo. 5 Sulla questione della storicit o meno di Ilarione, cf. A.A.R. BASTIAENSEN, Jrme hahiographe, in Hagiographies, I, Turnhout 1994, 97-123. 6 J.-B. HUMBERT A. HASSOUNE, Brefs regards sur les fouilles byzantines Gaza e R. ELTER A. HASSOUNE, Le monastre de saint Hilarion: les vestiges archologiques du site de Umm el-Amr, in C. SALIOU (ed.), Gaza dans lAntiquit tardive. Archologique, rhtorique et histoire. Actes du colloque international de Poitiers (6-7 mai 2004), Salerno 2005, 1-40. 7 Il sito coincide con quello identificato da Hirschfeld e dalla sua equipe (Y. HIRSCHFELD, The Monasteries of Gaza: An Archaeological Review, in B. BITTON-ASHKELONY A. KOFSKY [eds.], Christian Gaza in Late Antiquity, Leiden 2004, 61-88) come il sito del monastero di Seridos, Barsanufio e Giovanni di Gaza: e se fosse questo un caso di riutilizzo (di risemantizzazione monastica) di un sito monastico?
-
ADAMANTIUS 16 (2010)
166
Qualche settimana pi tardi fu portata alla luce la sua grotta, e alcuni dei resti del sito di Umm el-Amr furono identificati con quelli del primo monastero di Ilarione fatto distruggere, almeno stando a Vita di Ilarione 23,6, da Giuliano quando divenne imperatore. Probabilmente il monastero cui appartiene lo strato superiore a questo da datare al ritorno dei resti di Ilarione da Creta nel 372, come anche lepigrafe. Ilarione, nel 306-307, cominci a fare vita anacoretica a sette miglia da Gaza: mezzo secolo dopo troviamo riunita attorno a lui una comunit cenobitica; egli poi, come si detto, in cerca della , che diventa un vero e proprio identity marker del monachesimo successivo, si rec in Egitto, in Siria, in Sicilia e in Dalmazia, per poi morire a Cipro nel 371. Integrando le varie fonti su Ilarione, si possono fornire una serie di dati utili sui ritrovamenti monastici: in particolare, i resti del monastero mostrano due poli architetturali affiancati, un complesso ecclesiastico a sud e i bagni e un ospizio a nord. Il complesso ecclesiastico comprende le chiese, la cripta, lingresso e i portici, i battisteri, una cappella, celle, il refettorio, una stradina interna e annessi come granai, cucine, latrine etc. Per quanto riguarda bagni e ospizio, essi probabilmente continuarono ad essere in funzione fino al periodo omayyade. Sono stati individuati otto livelli, scaglionati tra la fine del IV secolo e let moderna: lo strato quinto e sesto, datati tra IV e VI secolo, attestano la prosperit della comunit, testimoniata anche dai ricchi mosaici delle chiese. Fatta questa breve premessa volta a riproporre il dossier della storicit della figura di Ilarione, preciso lo scopo del mio contributo: cercare di capire se possibile enucleare, nella Vita di Ilarione, alcuni tratti che diventeranno tipici del monachesimo successivo, se possibile cio individuare una sorta di definizione minima del monachesimo di Gaza, composta da temi e aspetti di lungo periodo peculiari di esso. Se pensiamo infatti allenorme fortuna del modello performativo costituito dalla Vita Antonii per il monachesimo egiziano in primis e per quello occidentale e orientale pi in generale, non ci si pu non chiedere se quello che viene unanimemente considerato il fondatore del monachesimo di Gaza veramente non abbia lasciato traccia nei posteri, monofisiti o calcedonesi che essi fossero. Anzitutto, tipica dellelaborazione che avviene nel monachesimo successivo a Ilarione e che sembra per gi propria di Ilarione la tendenza verso forme di vita monastica capaci di armonizzare fra loro ideale eremitico e ideale cenobitico: la troviamo nellorientamento monofisita, e nella fattispecie con Pietro lIberico e Isaia di Gaza, monaco recluso attorno al quale si costituisce una comunit di tipo cenobitico che egli dirige attraverso un discepolo (nel suo caso Pietro lEgiziano), formula ripresa poi da Barsanufio e Giovanni.
Il training ascetico
Mi sembra interessante dunque confrontare la misura del monachesimo di Ilarione con altre, nella fattispecie quelle che troviamo in Pacomio, in Isaia, in Barsanufio e Giovanni e nella Vita di Dositeo. Prima di illustrare i testi, credo sia opportuno delineare brevemente ci che larcheologo Hirschfeld, recentemente scomparso, ha ricostruito a proposito della dieta dei monaci del deserto di Giuda, integrando le fonti letterarie e i dati che emergono dagli scavi (presenza nei monasteri di forni, frantoi e torchi etc.)8. La dieta dei monaci contemplava pane, vino e olio, verdure cotte o crude e legumi (ammorbiditi in acqua), frutta e olive, ma anche fave, lupini, piselli, zucche, carrube, datteri,
8 Y. HIRSCHFELD, The Judean Desert Monasteries in the Byzantine Period, New Haven-London 1992, 69-93; Id., The Importance of bread in the diet of monks in the Judean Desert, in Byzantion 66 (1996) 143-155.
-
ROSA MARIA PARRINELLO Misure del monachesimo a Gaza
167
fichi, tutti cibi che hanno il pregio di potersi conservare a lungo. Mangiavano inoltre erbe selvatiche: il manouthion, che corrisponde probabilmente al cardo selvatico, lAtlipex halimus, cio una specie di arbusto salato, i capperi, le mandorle. La carne, il pesce e le uova erano solo per i malati o i visitatori; oltre al vino lastinenza dal quale segno di grande ascetismo, come anche quella dallolio e allacqua, i monaci bevono leukration, una bevanda a base di acqua calda aromatizzata con pepe, cumino e anice. Non di solo pane Se andiamo a leggere alcuni testi, la situazione non sempre cos chiara. Ad esempio Palamone, il maestro di Pacomio, gli illustra la politeia ascetica:
Ti esporr la misura della vita monastica. []. Ecco la regola della vita monastica secondo gli insegnamenti che abbiamo appreso da quelli che ci hanno preceduto: noi infatti passiamo met della notte, e spesso anche dalla sera alla mattina, vegliando, meditando le parole di Dio e facendo molti lavori manuali. [] Quello che eccede i nostri bisogni lo diamo ai poveri []. Fare uso di olio, bere vino, mangiare cose cotte sono cose sconosciute tra noi. Digiuniamo sempre fino a sera: destate mangiamo tutti i giorni, dinverno invece ogni due o tre giorni. La regola della sinassi questa: sessanta preghiere di giorno e cinquanta la notte9.
Dunque sembrano essere ammessi solo il pane e lacqua. In realt, come hanno dimostrato studi recenti, la dieta nei monasteri pacomiani, nella fattispecie shenutiani, era assai pi varia10. Nella Vita di Ilarione, al regime ascetico del santo sono dedicati i paragrafi 3-5: gi la Mohrmann ha messo in evidenza la precisione minuziosa nel descrivere il regime ascetico di Ilarione, in cui ravvede lacribia del filologo11. Ilarione dunque dai 16 ai 20 anni mangia solo 15 fichi secchi dopo il tramonto del sole, e in 3,5 si racconta che, in preda al demone della lussuria, si nutre di succo derbe e di pochi fichi secchi ogni tre-quattro giorni (di Antonio si dice che mangia ogni due giorni e spesso ogni quattro), in 3,6 si dice che intesse canestri di giunco al modo dei padri egiziani. Interessante mi sembra laffermazione in 4,1, in cui si afferma che le dimensioni della cella sono tali che essa sembra una tomba pi che una casa. Questa concezione della cella paragonata a un cimitero mi sembra da mettere in evidenza, soprattutto alla luce del fatto che la cella il luogo in cui si pratica l , termine che si ricollega forse al verbo hesthai, essere seduto, e che nella lingua classica indica la pace, sia quella che segue la guerra, con il sostantivo eiren, sia anche la pace dei cimiteri, della morte (il silenzio di tomba!). Dal momento che nella cella si pratica lesichia, il nesso con le ridotte dimensioni della cella di Ilarione mi sembra voluto e questa accezione viene recuperata appieno da Barsanufio, che nella lettera 141 risponde a un figlio spirituale che gli ha chiesto un piccolo regalo: Fratello, Dio sa quello che serve. Hai chiesto di ricevere del pane dalla mia debolezza e, a parte i tre pani fissati per la settimana, nulla di pi entra nel mio cimitero ( )12; la cella viene dunque chiamata cimitero. Nella lettera 142 Giovanni spiega allo stesso fratello perch Barsanufio ha chiamato la cella cimitero: Perch ha trovato riposo da tutte
9 Pacomio e i suoi discepoli. Regole e scritti, a c. di L. CREMASCHI, Magnano (BI) 1988, p. 12. 10 B. LAYTON, Social Structure and food consumption in an early christian monastery: the evidente of Shenoutes Canons and the white monastery Federation A.D. 385-465, in Le Muson 115, 1-2(2002) 25-54. 11 Vita di Martino. Vita di Ilarione. In memoria di Paola, intr. di C. MOHRMANN, testo crit. e comm. a c. di A.A.R. BASTIAENSEN e J.W. SMIT, trad. di L. CANALI e C. MORESCHINI, Milano 1998, p. XLV. 12 Barsanuphe et Jean de Gaza, Correspondance. Volume I. Aux solitaires. Tome II. Lettres 71-223, intr., texte critique et notes par F. NEYT, P. DE ANGELIS-NOAH, tr. par L. REGNAULT (SC 427), Paris 1997, 518-519; Barsanufio e Giovanni di Gaza, Epistolario, tr., intr. e note a cura di M.F.T. LOVATO e L. MORTARI, Roma 1991, p. 205.
-
ADAMANTIUS 16 (2010)
168
le passioni, morto infatti completamente al peccato, e la sua cella, nella quale sepolto come in una tomba ( ) per il nome di Ges, un luogo di riposo ( )13. Nella lettera 52 Barsanufio aveva definito la cella il luogo in cui il monaco, facendosi morto a ogni altro uomo, pu trovare il riposo ()14, mentre nella lettera 68 ammonisce il fratello Eutimio dicendogli Stattene seduto in cella come morto al mondo15. Giovanni Climaco riprende questa concezione e in Scala 4, 93 afferma: Il luogo in cui dimori sia per te una tomba prima della tomba16. In 4,2 si dice che il santo si taglia i capelli una volta allanno, il giorno di Pasqua, e cambia la camicia solo quando lacera e in 4,3 si precisa che egli pratica lesercizio della presenza di Dio, recitando la Sacra Scrittura come se Dio fosse presente. Dai 21 ai 27 anni, per tre anni mangia mezzo sestiario (cio un quarto di litro) di lenticchie ammorbidite in acqua fredda, per altri tre anni pane secco con sale e acqua, dai 27 ai 30 anni si nutre di erbe di campo e radici crude di certi virgulti (manouthion e Atlipex halimus?), dai 31 ai 35 anni consuma sei once (centosessanta grammi) di pane dorzo e verdura poco cotta, senza olio, e a 35 anni aggiunge a questo un po dolio, perch sente che la vista gli si sta abbassando e sente la pelle inaridirsi come se fosse affetta da scabbia; vive fino a 63 anni senza gustare frutta, legumi o alimenti simili. Dai 64 anni fino agli ottanta si astiene anche dal pane, nutrendosi di una zuppa di farina e di verdura tritata che funge da cibo e bevanda e pesa cinque once. Egli mangia sempre dopo il tramonto del sole, dunque tecnicamente pratica il digiuno. Si notato che Girolamo, pur vivendo a Betlemme quando scrive la Vita, e cio nella pi grande concentrazione religiosa urbana della Palestina, vicino alle laure del deserto di Giuda, non fa allusione alcuna a queste realt17. Penso per che, proprio nella precisione con cui si riferisce alle vivande, che spesso possiamo ricondurre a quelle individuate da Hirschfeld, pi che lacribia del filologo si possa ravvisare un riferimento alle realt monastiche lauritiche. Possiamo ora gettare uno sguardo alla dieta dei monaci di Gaza. Isaia di Gaza in Ascetikon, Logos 4, fornisce la cosiddetta regola aurea, esortando a smettere di mangiare prima di aver raggiunto la saziet:
Quando pratichi lesichia nella tua cella, mangia con misura e da al tuo corpo il necessario, perch ti supporti quando tu svolgi le tue attivit []. Non mangiare nulla per piacere. []. E quando tu devi uscire per una visita, sia a un fratello sia a un cenobio, non dare al tuo corpo tutto ci che trovi di piacevole fino a saziarlo, perch poi non voglia subito rientrare in cella e non si tradisca. [] Mangia una sola volta al giorno e da al tuo corpo il necessario. Veglia con misura e non privare il tuo corpo del necessario []. La met della notte sufficiente per compiere lufficio, mentre laltra met per il riposo del corpo18.
13 Barsanuphe et Jean de Gaza, Correspondance. Volume I. Aux solitaires. Tome II, pp. 520-521; Barsanufio e Giovanni di Gaza, Epistolario, p. 206. 14 Barsanuphe et Jean de Gaza, Correspondance. Volume I. Aux solitaires. Tome I, pp. 268-269; Barsanufio e Giovanni di Gaza, Epistolario, p. 119. 15 Ibid., 330-331; trad. cit., 142 (lettera 69 nella tr. it.). 16 Giovanni Climaco, La scala del Paradiso, intr., tr. e note di R. M. PARRINELLO, Milano 2007, p. 264. 17 Barsanuphe et Jean de Gaza, Correspondance. Volume I. Aux solitaires. Tome I, p. 15. 18 Testo greco in . . 1911. . ,
-
ROSA MARIA PARRINELLO Misure del monachesimo a Gaza
169
Nel Discorso 3, inoltre, egli raccomanda cos: Per il vino, che il monaco si fissi fino a tre bicchieri in caso di necessit19.
Barsanufio e Giovanni di Gaza riprendono Isaia e sostengono la misura del , del poco. Cos, nella lettera 85 (86 nella traduzione italiana), Barsanufio, indirizzandosi a un anacoreta, afferma:
Tu devi un poco () salmodiare, un poco recitare a memoria, un poco esaminare e sorvegliare i tuoi pensieri. [] Non impedirti di leggere e pregare. Un po di questo e un po di quello, e trascorrerai la giornata piacendo a Dio. Poich i nostri padri, che erano perfetti, non avevano una regola fissa. In tutto il giorno la loro regola era di salmodiare un poco a memoria, esaminare un poco i pensieri, occuparsi un poco del cibo, e questo nel timore di Dio20.
Giovanni, nella lettera 146, cos esorta: Riguardo al sonno notturno, prega due ore dalla sera, calcolandole dal tramonto del sole: e dopo aver glorificato Dio dormi sei ore; poi alzati per la veglia e fa le altre quattro ore. Altrettanto destate, solo abbreviando nellestate e con pochi salmi, per la brevit delle notti21. Sempre Giovanni nella lettera 155 si richiama alla tradizione degli Anziani: Essere temperanti alzarsi da tavola un po meno che sazi, come gli anziani hanno prescritto ai novizi22 e nelle lettere 156-157 cos si pronuncia:
I padri dicono, quanto alla misura della temperanza, che, sia per il mangiare sia per il bere, bisogna restare un po al di sotto, cio non avere mai pieno il ventre. Bisogna calcolare la quantit dei cibi cotti e del vino: dinverno non si beve molto, e in proporzione a questo bisogna stare un po al di sotto ( ), e ugualmente nel mangiare. [] Da tutta la quantit di pane e companatico o legumi e frutta, dico di sottrarre fino a circa unoncia. Quanto al vino e allacqua, circa mezza tazza da entrambi. E se fai forza su te stesso e non ti affatichi, bene bere una sola volta al giorno e, se non possibile, anche due; ogni volta per un po al di sotto della misura. Nelle agitazioni e nelle lotte dei pensieri, bisogna sottrarre dal consueto un po al di sotto della misura, cio unoncia dal mangiare e mezza tazza dal bere, sicch in tutto il cibo sia ridotto a circa due once e il bere circa a una tazza [] Di tutta la quantit, intendo dire, di pane e companatico, o di legumi o di frutta, dallesperienza di tutti i giorni possibile imparare che cosa riceve il corpo di cibo o bevanda. Ad esempio, uno beve tre tazze al giorno e mangia una libbra di pane; se vede che il corpo pretende pi di tre tazze senza motivo, o a causa di un affaticamento eccessivo o per aver mangiato cibi salati, questa una tentazione. Se non c tentazione, si asterr da mezza tazza su tre e ugualmente per il cibo, da unoncia su una libbra23.
Barsanufio ribadisce, nella lettera 158, che
Dio ha dato alluomo lintelletto per discernere le cose. Se uno viene dalla fatica di un viaggio o da altri lavori molto pesanti non pu custodire la misura degli altri giorni, ma accondiscende un poco al corpo: se mangia abitualmente mezza libbra di cibo al giorno, e per la fatica mangia unaltra oncia, ha
, Volos 1962, p. 51; tr. it., leggermente modificata, in Isaia di Gaza, Ascetikn, Napoli 2003, pp. 18-19. 19 Testo greco in , cit., p. 46; tr. cit., p. 13. Cf. anche Discorso 9; nel Discorso 12 gli stadi di preparazione del vino vengono paragonati alle tappe del progresso spirituale delluomo. 20 Barsanuphe et Jean de Gaza, Correspondance. Volume I. Aux solitaires. Tome II, cit., pp. 372-375; Barsanufio e Giovanni di Gaza, Epistolario, cit., p. 157. 21 Ibid., 528-529; trad. cit., 207. 22 Ibid., 548-549; trad. cit., 213. 23 Ibid., 548-553; trad. cit., 213-214.
-
ADAMANTIUS 16 (2010)
170
fatto tutto il suo possibile per non mangiare di pi. Se veglia ogni giorno dalla mezzanotte, e per la fatica dorme unora di pi, ha fatto tutto il possibile. [] Il fare secondo la possibilit quel restare un po ( ) al di sotto, sia di nutrimento che di sonno. Se poi mi chiedi qual la misura del sonno, i padri hanno stabilito la met della notte. Quanto alla misura del cibo, che uno si senta sempre desideroso di prenderne ancora un po24.
Infine Giovanni nella lettera 159 cos afferma:
Quanto al vino, per chi in buona salute e vuole essere temperante, basta una tazza al giorno, senza prenderne di pi. Se ha frequenti malattie, ne prenda due intere. E cos per il cibo cotto: deve averne un vasetto e non preoccuparsene. Quanto ai padri, conducevano un regime durissimo perch trovavano ubbidienti i loro corpi. Del resto, quelli che governano se stessi bene e con discernimento, tengono conto del loro corpo e della sua costituzione25.
Anche sul sonno, i due Anziani hanno dato indicazioni precise, dal momento che Giovanni raccomanda sei ore di sonno a partire da due ore dopo il tramonto, mentre Barsanufio indica pi genericamente la met della notte (Cassiano raccomanda tra le tre e le quattro ore di sonno). Mi sembra interessante inoltre che la misura del poco possa valere come criterio guida anche nella misura di ci che i laici del mondo devono donare ai poveri: cos nella lettera 635, in risposta al quesito di quanto bisogna dare ai poveri che passano per le case, Giovanni risponde: Ci che trova la tua mano: sia un bocconcino di pane, sia un po di vino schietto, sia due sesterzi, sia una monetina: soltanto offri di buon cuore, secondo il timore di Dio26.
Nella Vita di Dositeo, la prima vita di un santo cenobita, composta verosimilmente nel cenobio di Doroteo, o comunque da un monaco informato direttamente da lui, Doroteo sottopone il giovane a un training ascetico e gli dice: Mangia fin che sei sazio, fammi sapere soltanto quanto mangi. Dositeo comincia con il mangiare un pane e mezzo, cio circa quattro libbre (2 chili), poi un pane e tre quarti della met, ma gli rimane un po di fame; continua con questa quantit per qualche giorno; Doroteo gli riduce dunque la quantit a un pane e due quarti della met e poi un quarto, fino a passare da sei libbre a otto once, cio 218 grammi27. Ancora, Giovanni Climaco, Scala del Paradiso 2,13, cos afferma: Ti indicheranno la via stretta la mortificazione del ventre, la veglia notturna, la moderazione nel bere acqua, la scarsit di pane28.
I monaci fanno un solo pasto, intorno allora nona, cio alle tre del pomeriggio (Ilarione invece mangia dopo il tramonto del sole, come Antonio): significativo al proposito un apoftegma, tramandato dalla collezione etiopica, in cui un anziano dice: Se un uomo mangia una volta al giorno, un monaco; se mangia due volte al giorno, un uomo carnale, e se mangia tre volte al giorno, una bestia29. Tipico dellinsegnamento della scuola monastica di Gaza, ma anche di Basilio, di sottolineare che occorre una certa flessibilit nellassegnare ai monaci il ritmo di vita, tenendo in considerazione le caratteristiche e le peculiarit di ciascuno, come fa ad esempio 24 Ibid., 552-555; trad. cit., 214. 25 Ibid., 554-555; trad. cit., 215. 26 Barsanuphe et Jean de Gaza, Correspondance. Volume III. Aux lacs at eux vques. Lettres 617-848, intr., texte critique et notes par F. NEYT, P. DE ANGELIS-NOAH, tr. L. Regnault (SC 468), Paris 2002, 62-63; Barsanufio e Giovanni di Gaza, Epistolario, cit., 512-513. 27 Dorothe de Gaza, Oeuvres spirituelles, intr., texte grec, trad. et notes par L. REGNAULT et J. DE PRVILLE (SC 92), Paris 1963, 128-131. 28 Giovanni Climaco, La scala del Paradiso, cit., p. 215. 29 Detti e fatti dei Padri del Deserto, a cura di C. CAMPO P. DRAGHI, Milano 1975, 97.
-
ROSA MARIA PARRINELLO Misure del monachesimo a Gaza
171
ligumeno del cenobio pacomiano secondo la descrizione di Climaco nel Sermone al pastore30. Nelle fonti esaminate, a ben vedere emerge come gli anacoreti siano sostanzialmente idioritmici, cio fissino da soli per s una regola, laddove in regime cenobitico la regola chiaramente unica. Il regime di vita apparentemente pi ascetico quello contemplato nelle due Vite citate, ma mentre in quella di Dositeo si parla unicamente di pane, la dieta di Ilarione sicuramente pi varia e i cibi esaminati trovano riscontro anche nelle Vite dei santi palestinesi composte da Cirillo di Scitopoli e che servono da Hirschfeld come punto di partenza per ricostruire la dieta dei monaci del deserto di Giuda. Ancora, mi sembra interessante notare come in Vita di Pietro lIberico 102-103 si racconti che Pietro, durante il soggiorno a Thabatha, incontr periodicamente Isaia e addirittura avvi uno scambio di cibi con lui: Pietro infatti gli mand tutti i giorni una pagnotta di farina di grano preparata da un fornaio di Gaza e due piccoli pesci, mentre Isaia gli invi in cambio tre piccole pagnotte (Vita di Pietro lIberico 102-103). Al di l della notazione che potrebbe sembrare leziosa, resta comunque il dato interessante dello scambio dei cibi: Pietro vorrebbe infatti inviare quotidianamente a Isaia del pane fatto da un fornaio di Gaza e del pesce, che per non fa parte della dieta abituale del monaco. Peraltro difficilmente il monaco ha a disposizione pane fresco, mentre sia Pietro sia Isaia vogliono reciprocamente inviarsene di fresco tutti i giorni31.
I miracoli di Ilarione
La Mohrmann ha fatto notare come il racconto dei miracoli ai capitoli 11-13 immerga in unatmosfera folklorica e magica32: questo sicuramente vero, ed tipico di altre vite di santi e delle narrazioni agiografiche, che spesso vengono incontro con aneddoti di questo tipo alle esigenze di intrattenimento che le tendenze moralizzatrici del cristianesimo hanno virtualmente censurato con la condanna del romanzo. Mi permetto per di avanzare anche unaltra ipotesi, che tenga conto della fortuna che a Gaza riscontrano le arti magiche, fortuna che perdura ancora nel VI secolo, come ci dato di leggere nellEpistolario di Barsanufio e Giovanni. Il gruppo di lettere 753-755 attesta infatti la permanenza del ricorso alle pratiche magiche anche presso i cristiani, soprattutto a livello popolare. Un laico domanda infatti a Giovanni: Poich la mia bestia malata, sconveniente che qualcuno faccia incantesimi () su di lei?. Giovanni risponde: Gli incantesimi () sono proibiti da Dio, e non bisogna assolutamente farvi ricorso, poich il trasgredire lordine divino perdizione dellanima. Piuttosto applicale gli altri rimedi e trattamenti dei veterinari, poich questo non peccato. Versa anche sopra di lei dellacqua benedetta33. Lacqua benedetta appare dunque come una sorta di incantesimo ortodosso: il ricorso allacqua benedetta come fonte di guarigione una pratica attestata a partire dal IV secolo. Un altro domanda: Se un mio domestico si ammala e va da un mago a mia insaputa, questo mi sar imputato a peccato?. La risposta del Recluso la seguente: Questo non viene ascritto a te ma a lui. Ma se vieni a saperlo, preoccupati di correggerlo, perch non lo faccia di nuovo, avendolo tu ammonito34.
30 Giovanni Climaco, La scala del Paradiso, cit., 531-532. 31 Cf. per mano di chi scrive, La scuola monastica di Gaza, in Rivista di storia del cristianesimo 2 (2008) 545-565. 32 Vita di Martino. Vita di Ilarione. In memoria di Paola, cit., p. XLVI. 33 Barsanuphe et Jean de Gaza, Correspondance. Volume III, cit., 196-197; trad. it. in Barsanufio e Giovanni di Gaza, Epistolario, cit., 556. 34 Ibidem.
-
ADAMANTIUS 16 (2010)
172
Pratiche come quelle della divinazione, e dunque in un certo senso concorrenziali con pratiche tipicamente monastiche come quella del discernimento, furono duramente condannate dalla legislazione imperiale, e con Giustiniano la magia venne condannata come tale, indipendentemente dagli effetti che poteva avere35. Nellultima lettera, alla domanda: Dal momento che il ricorso a un indovino () estraneo a Dio, se una volta vedo qualcuno andarci, devo dirgli di non andare?, Giovanni risponde:
Se egli un tuo amico in Cristo, tu devi dirgli: Fratello, danneggi la tua anima e fai adirare Dio che proibisce questa pratica. E se egli non accetta le tue parole, se la vedr lui. Ma se uno che incontri per caso, non un tuo compito, a meno che egli non ti interroghi al proposito: allora devi dirgli la verit e, se non gliela dici, incorri nella condanna36.
Dunque il vir Dei trova una forte concorrenza nelle pratiche magiche: ad amuleti e unguenti egli contrappone acqua e olio benedetto e altre eulogie, alle formule e ai gesti dei maghi il segno della croce e le preghiere, proprio come Ilarione. Ancora, per quanto riguarda la tipologia dei miracoli di Ilarione, essi sono sostanzialmente guarigioni ed esorcismi, secondo il modello neotestamentario, ma non vi sono miracoli di risurrezione. Questa dimensione di understatement dal punto di vista miracolistico tipica del monachesimo calcedonense: se guardiamo alla Vita di Dositeo, lunico miracolo di cui si parla quello di Doroteo che, pur essendo ancora egli stesso un discepolo, riusc a guidare molto rapidamente il giovane Dositeo lungo la strada che conduce a Dio. Anche nellEpistolario di Barsanufio e Giovanni di Gaza non vi sono miracoli di risurrezione, ma ve ne sono di guarigione e, nelle lettere 220-223 in cui si parla della morte di Dositeo, emerge una certa facolt di controllo sulla morte stessa. Non troviamo dunque il ricorso a miracolo eclatanti, ma a quelli che riguardano il dominio sulla materia. Un discorso a parte merita lepisodio narrato in 29,3, in cui si pone laccento sulla gestualit in un miracolo che il santo opera a Epidauro, citt della Dalmazia (odierna Dubrovnik), in cui egli verisimilmente non potrebbe farsi comprendere mediante la parola infatti il luogo in cui, per xeniteia, si reca per stare in mezzo a popolazioni che parlano una lingua diversa dalla sua , ed lunico miracolo in cui il santo non proferisce verbo. La citt corre il rischio di essere spazzata via da un vero e proprio tsunami tardo-antico (Giuliano appena morto, e un terremoto sta causando disastri e cataclismi) e Ilarione traccia tre segni di croce sulla sabbia e tende le mani davanti ai flutti (in Vita di Antonio 80,4 Antonio fa due o tre volte il segno della croce sui malati per risanarli). In questo caso non ci troviamo di fronte a quella locutio per signa che Pacomio o Cassiano raccomandano per non rompere il silenzio, bens a un gesto che da un lato permette al santo di dominare la materia, dallaltro di comunicare il miracolo: ma anche in questo caso, come nel caso della comunicazione gestuale attraverso il corpo, ci che conta che gli spettatori vedano pi che udire37. Barsanufio sembra condannare nella lettera 40 il linguaggio dei segni e in generale i modi di comunicazione criptici ed enigmatici, perch i segni () non sono per i fedeli ma per gli infedeli38, anche se poi in realt afferma nella lettera 136 che il ricorso agli enigmi pu essere in taluni 35 B. BIONDI, Il diritto romano cristiano. I. Orientamento religioso della legislazione, Milano 1952, p. 277. 36 Barsanuphe et Jean de Gaza, Correspondance, ed. cit., III, 198-199; trad. cit., 556-557. 37 A. DHAENENS, Quotidianit e contesto. Per un modello di interpretazione della realt monastica medievale nei secoli XI e XII, in Monachesimo e ordini religiosi nel Medioevo subalpino, Torino 1986, 17-56, in particolare 38-40. 38 Barsanuphe et Jean de Gaza, Correspondance Volume I. Aux solitaires. Tome I, cit., pp. 242-243; Barsanufio e Giovanni di Gaza, Epistolario, cit., pp. 109-110.
-
ROSA MARIA PARRINELLO Misure del monachesimo a Gaza
173
casi utile39. Nella lettera 436, inoltre, Barsanufio sconsiglia di ripetere il segno della croce, perch segnarsi una volta sia di notte sia di giorno basta a custodia e salvezza, poich se crediamo che il primo sigillo perfettamente saldo, non c bisogno del secondo: cercarne un secondo significa che il primo non saldo40.
Altri aspetti: l , la discretio spirituum e la
In 18,1 si punta lattenzione sulla virt dell posseduta da Ilarione: Ilarione detestava soprattutto quegli eremiti che, per una certa mancanza di fede, mettevano da parte per il futuro le loro cose e facevano attenzione alle spese o al vestito o a qualcuna di quelle cose che muoiono con il mondo41.
La riflessione sulla centrale in Barsanufio e Giovanni di Gaza: essa sia la cattiva non-curanza, dunque una forma di negligenza (Lettera 216), che spesso si traduce nella rilassatezza nei confronti del compito spirituale o materiale da eseguire (Lettera 149), sia la virt che scaccia le preoccupazioni inutili, cio quelle nei confronti dei familiari (Lettera 571), per il proprio sostentamento (Lettere 254, 257, 572, 595), per i beni (Lettere 252, 315, 326), per la propria salute (Lettere 508, 532), preoccupazione di cui bisogna liberarsi (Lettera 259). Quella dellassenza di preoccupazioni una virt che, secondo i due abba di Gaza, si pu acquisire mediante lobbedienza al padre spirituale (Lettera 39), lumilt (quindi attraverso il troncamento della volont propria: Lettera 330) e laccettazione delle prove (Lettera 2). In 18,8 si mette in evidenza il carisma della discretio spirituum esercitato dal santo attraverso lolfatto: il vecchio Ilarione aveva questo carisma, di congetturare dallodore dei corpi e delle vesti e delle cose che uno aveva toccato, di quale vizio e di quale demone costui fosse schiavo42. Il modello sicuramente Vita di Antonio 63,1-3, in cui troviamo il motivo del fetore diffuso dallo spirito malvagio ed Evagrio Pontico parla proprio del carisma che consiste nel discernere il fetore43. Dunque si collega la discretio del santo con luso del senso dellolfatto: probabilmente qui sottintesa la dottrina dei sensi spirituali di marca origeniana. In Origene, infatti, le espressioni semi-figurative, semi-reali come gli occhi del cuore, toccare Cristo, ecc. si trovano integrate in un sistema completo di cinque strumenti di percezione spirituale per le realt soprasensibili44. Questo tema dei cinque sensi tratto da espressioni scritturali figurate o allegorizzate (e probabilmente anche da immagini platoniche), ed esprime lo stato dello spirituale arrivato alla virt suprema, la sapienza45. Per lalessandrino i sensi spirituali sono dati al credente con la grazia della fede e del battesimo e sono
39 Barsanuphe et Jean de Gaza, Correspondance. Volume I. Aux solitaires. Tome II, cit., pp. 554-555; Barsanufio e Giovanni di Gaza, Epistolario, cit., pp. 494-499. 40 Barsanuphe et Jean de Gaza, Correspondance. Volume II. Aux cnobites. Tome II. Lettres 399-616, intr., texte critique et notes par F. NEYT, P. DE ANGELIS-NOAH. Trad. par L. REGNAULT (SC 451), Paris 2001, 514-515; Barsanufio e Giovanni di Gaza, Epistolario, cit., pp. 384-385. 41 Jrme, Trois vie de moines, cit., p. 262 (testo critico); tr. it. Vita di Martino. Vita di Ilarione. In memoria di Paola, cit., p. 113. 42 Ibid., p. 264 (testo critico); tr. cit., p. 115. 43 Evagrio Pontico, Capitoli gnostici 5,78: cf. Atanasio di Alessandria, Vita di Antonio. Antonio abate, Detti-Lettere, a c. di L. CREMASCHI, Milano 1995, p. 185, n. 137. 44 K. RAHNER, Le dbut dune doctrine des cinq sens spirituels chez Origne, in Revue dAsctique et mystique 13 (1932) 113-145: qui p. 114. 45 H. CROUZEL, Origene, Roma 1985, 186.
-
ADAMANTIUS 16 (2010)
174
lespressione metaforica dellattivit di questa grazia nel dominio della conoscenza di Dio; tuttavia lesercizio di essi presuppone la purificazione dellanima e l . Chi esercita i cinque sensi spirituali infatti solo il , il perfetto, colui che ha compiuto il cammino di perfezione46. Il carisma del discernimento degli spiriti centrale nella tradizione monastica e ha alle spalle una lunga tradizione: da un lato quella pagana, nella quale la ha unaccezione tecnica47, dallaltro quella pi propriamente cristiana48. Nella Vita di Antonio scritta da Atanasio emerge chiaramente che la un dono divino, e non il frutto di una tecnica, e permette di distinguere facilmente la presenza degli spiriti buoni e di quelli malvagi: infatti la visione dei santi non causa turbamento, giunge con calma e porta nellanima gioia e coraggio. Gli spiriti malvagi portano invece timore e turbamento allanima. Nella prima Lettera, inoltre, Antonio afferma che il discernimento la capacit del cuore di distinguere i bisogni dellanima da quelli del corpo49. Anche Pacomio (almeno stando alla Vita graeca I,87), dotato del discernimento degli spiriti, ed dunque in grado di riconoscere gli spiriti cattivi e quelli santi: il discernimento diventa un nuovo organo di perfezione, che permette di purificare la visione. Per quanto riguarda la tradizione apoftegmatica, unintera sezione della Collezione Sistematica, la decima, dedicata proprio al discernimento. Tuttavia, negli Apoftegmi manca una trattazione del discernimento in senso tecnico: in Poemen 35 esso citato, insieme con la vigilanza e la cura di s, come virt guida dellanima; in Agatone 5 lo strumento per individuare leresia. Palladio dedica il capitolo 38 della sua Storia lausiaca a Evagrio: nella sua prospettiva il discernimento degli spiriti un carisma che Evagrio riceve, insieme con quelli della conoscenza e della sapienza, dopo 15 anni trascorsi in una grande ascesi che gli permette di purificare la mente. Nella Storia dei monaci in Egitto 20, una parte dedicata sempre a Evagrio, si istituisce un collegamento tra lesperienza e la discretio, mentre nel capitolo 15 si afferma chiaramente che il maestro a trasmettere questo carisma, spesso anche attraverso leredit della propria cella. Per Isaia di Gaza il discernimento un carisma, frutto dellesercizio delle virt, ed egli spiega anche in che cosa consista il discernimento dei pensieri, mostrando al contempo come esso sia al centro del suo insegnamento e del percorso di perfezione del monaco:
Domina dunque il tuo cuore sorvegliando i tuoi sensi: se hai la memoria in pace, catturerai i ladroni che la saccheggiano. Infatti colui che esamina con acribia i pensieri sa che essi vogliono entrare in lui
46 Mi permetto di rinviare al mio Da Origene a Simeone il Nuovo Teologo: la dottrina dei sensi spirituali, in L. PERRONE (ed.), Origeniana Octava. Origen and the alexandrian Tradition. Origene e la tradizione alessandrina. Papers of the 8th International Origen Congress, Pisa, 27-31 August 2001, in collaboration with P. Bernardini and D. Marchini , Leuven 2003, vol. II, pp. 1123-1130; cf. la voce di P. BETTIOLO, Sensi spirituali in A. MONACI CASTAGNO (ed.), Origene. Dizionario. La cultura, il pensiero, le opere, Roma 2000, 443-444 e la messa a punto di E. CATTANEO, La dottrina dei sensi spirituali in Origene: nuovi apporti, in Adamantius 11 (2005) 101-113. 47 Il colui che sa distinguere il vino buono da quello cattivo, colui che sa ben interpretare i sogni, larchitetto che sa sfruttare gli elementi atmosferici nella progettazione degli edifici, il teurgo che sa distinguere tra le apparizioni degli di e quelle dei demoni (cf. Giamblico, I misteri dEgitto 2,3). 48 Cf. Giovanni Climaco, La scala del Paradiso, pp. 130-140; G. THRRIEN, Le discernement dans les crits pauliniens, Paris 1973, p. 33; cf. anche M. RUIZ JURADO, Il discernimento spirituale. Teologia, storia, pratica, Cinisello Balsamo 1997. 49 Cf. Vita di Antonio 35,4-37,3 e Lettera 1,2.
-
ROSA MARIA PARRINELLO Misure del monachesimo a Gaza
175
per corromperlo. Se osservi i comandamenti con cuore fervente, comprenderai con quali pretesti coloro che ti tormentano causano in te un turbamento, per scoraggiarti e farti scegliere un altro luogo per vivere, senza averne motivo []. Infatti i pensieri turbano la mente per renderla vagabonda e oziosa, ma quelli che conoscono la loro malizia rimangono imperturbabili, rendendo grazie al Signore per il luogo nel quale egli ha ordinato loro di rimanere50; Luomo ha dunque bisogno, fratello mio, di grande discernimento, e di troncare ogni volont carnale, e deve vigilare con attenzione lungo tutte le strade che si trova a percorrere, per evitare di essere ingannato e di cadere nelle mani dei suoi nemici51.
Anche nellEpistolario di Barsanufio e Giovanni il discernimento chiaramente considerato un carisma divino (lettera 77 e 570); strettamente legato al taglio della volont (lettera 266), esso cresce o dovrebbe crescere insieme al progresso spirituale del singolo monaco. Il discernimento consiste anche nella rinuncia ad esercitarlo per affidarsi al padre spirituale quando necessario (lettera 288); esso un carisma fondamentale per gli eremiti, per guidarli al taglio della volont propria, laddove i cenobiti, soggetti allobbedienza al padre, si affidano al suo discernimento (lettera 318). Nelle numerose lettere in cui Barsanufio e Giovanni parlano di questo carisma, soprattutto in quelle ad anacoreti e cenobiti, esso risulta essere la facolt di discernere i pensieri che vengono da Dio da quelli demoniaci, il bene dal male, il giusto comportamento in ogni circostanza. In quanto dono divino, pu essere concesso a chiunque, anche a persone che non hanno raggiunto un livello spiritualmente alto, e dunque potr essere suscettibile di un cattivo utilizzo. In alcune lettere i due Reclusi spiegano in concreto come discernere i pensieri, ma non si esplicita mai quale deve essere la preparazione del monaco per ottenere il discernimento: pi che alle caratteristiche del monaco, sembrano interessati alla dei demoni e ai meccanismi di funzionamento della facolt del discernimento. Lultimo aspetto su cui vorrei soffermarmi quello della ricerca della solitudine e della connessa , per i quali particolarmente interessanti risultano i capitoli 20,3 e 28,1: Ilarione infatti non poteva pi abitare in quelle regioni (scil. Sicilia), ma voleva andare presso certe popolazioni barbare, dove sarebbero stati ignoti il suo nome e la sua lingua. La una pratica ascetica tipica dei monaci e consiste nel farsi stranieri rispetto al mondo. Il fondamento di questa pratica, oltre che biblico, e cio lordine impartito da Dio ad Abramo in Gen 12,1 (Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso un paese che io ti indicher) e IPt 2,11 in cui il cristiano presentato come straniero e pellegrino nel mondo terreno52, ha le sue radici negli Apoftegmi: Uno di noi chiese ad abba Pisto: Padre, che cosa significa vivere da stranieri?. Gli disse: Taci, e in qualsiasi luogo tu vada, di: Non mi riguarda. Questo vivere da stranieri53. Insegnamento di Arsenio il seguente: Un monaco forestiero in terra non sua non si immischi a niente e rester in pace54. La strettamente collegata al problema linguistico: il monaco in terra straniera pu infatti scegliere di continuare a parlare la propria lingua (in questa accezione usa il termine Giovanni Climaco), estraniandosi dal contesto darrivo, o parlare la lingua
50 Testo greco in , cit., p. 114 (Discorso 17); tr. it., leggermente modificata, in Isaia di Gaza, Ascetikn, cit., p. 90. 51 Testo greco in ed. cit., p. 161 (Discorso 25); tr. it., leggermente modificata, in Isaia di Gaza, Ascetikn, cit., p. 154. Mi permetto di rinviare al mio La direzione spirituale nella comunit monastica di Isaia di Gaza, in G. FILORAMO (ed.), Storia della direzione spirituale. I. Let antica, Brescia 2006, 352-375. 52 T. SPIDLK M. TENACE R. CEMUS, Questions monastiques en Orient, Roma 1999, pp. 251-252. 53 Vita e detti dei Padri del deserto, a cura di L. MORTARI, Roma 1999, p. 426. 54 Ivi, p. 97.
-
ADAMANTIUS 16 (2010)
176
del paese in cui arriva, estraniandosi dal contesto di partenza, che spesso quello da cui rifugge per cercare la solitudine della contemplazione (secondo linterpretazione di questa pratica monastica in Barsanufio)55. In Isaia di Gaza ritroviamo questo ideale come componente essenziale dellagone ascetico: Se ti sei fatto straniero per Dio, non mescolarti con le persone del luogo, perch sarebbe quasi meglio per te allora restare piuttosto con i tuoi parenti secondo la carne56. La dunque il primo stadio del combattimento spirituale e prepara all , limpassibilit:
Il primo combattimento vivere da straniero, soprattutto se, fuggendo solo, abbandoni ci che tuo e te ne vai in un altro luogo, munito di una fede perfetta, della speranza, e di un cuore saldo contro le tue volont []. Infatti non ti sei fatto straniero per nulla, ma per prepararti e dedicarti a combattere i nemici, per saper respingere ognuno quando si presenta, fino a quando, dopo aver ottenuto il riposo dellimpassibilit, tu sia liberato, poich hai vinto ciascuno combattendo a tempo debito57.
Anche Pietro lIberico, amico e alleato di Isaia nella propaganda monofisita, almeno stando alle fonti, nella Vita di Pietro lIberico scritta da Giovanni Rufo viene presentato come un campione della (aksenaiutha in siriaco), per la quale rifiut di ritornare nel suo monastero tra Gaza e Maiuma per trascorrere i suoi ultimi giorni tranquillo (Vita di Pietro lIberico 20-22). Egli infatti, considerando lattaccamento al monastero figlio dellattaccamento al mondo, volle finire la sua vita come straniero a questo mondo e ricevere la corona della 58. Per quanto riguarda lEpistolario di Barsanufio e Giovanni, la pratica della oggetto di riflessione. Nella Lettera 49 Barsanufio afferma:
Io ti ho scritto dallalfa allomega; da ci che riguarda la condizione di un novizio fino alla sua crescita completa; dallinizio della via fino al suo termine; dallo svestirsi delluomo vecchio con le sue passioni fino al rivestirsi delluomo nuovo creato secondo Dio; dal divenire straniero alla terra sensibile e diventare cittadino del cielo ed erede della terra spirituale delle promesse59.
Centrale la Lettera 55 ( la lettera in cui un monaco egiziano scrive a Barsanufio in copto pensando di instaurare cos un rapporto privilegiato con lui, e Barsanufio gli ribadisce che egli comunica solo in greco, perch se apro a te devo farlo con tutti): Fratello, noi siamo stranieri, viviamo da stranieri, non misuriamo noi stessi in nulla, e nessuno far alcun conto di noi, e saremo in pace60.
Al termine di questo rapido confronto tra il monachesimo fondato da Ilarione e quello successivo, ho cercato di pormi il problema delle caratteristiche identitarie del monachesimo di Gaza, di ci che lo costituisce storicamente sul lungo periodo e lo differenzia da altre forme monastiche: ad esempio laccento posto sulla , che non ritroviamo nellesperienza del monachesimo di
55 A. GUILLAUMONT, Le dpaysement comme forme dascse, dans le monachisme ancien, in Id., Aux origines du monachisme chrtien. Pour une phnomenologie du monachisme, Bgrolles-en-Mauges 1979, 89-116; cf. anche Giovanni Climaco, La scala del Paradiso, cit., pp. 72-75. 56 Discorso 4: testo greco in , cit., p. 49; tr. it., leggermente modificata, in Isaia di Gaza, Ascetikn, p. 16. 57 Discorso 17: ed. cit., p. 112; tr. cit., leggermente modificata, p. 87. 58 B. BITTON-ASHKELONY-A. KOFSKY (eds.), The Monastic School of Gaza, Brill, Leiden-Boston 2006, pp. 62-64. 59 Barsanuphe et Jean de Gaza, Correspondance. Volume I. Aux solitaires. Tome I, cit., pp. 262-265; Barsanufio e Giovanni di Gaza, Epistolario, cit., p. 117. 60 Barsanuphe et Jean de Gaza, Correspondance. Volume I. Aux solitaires. Tome I, cit., pp. 272-275; Barsanufio e Giovanni di Gaza, Epistolario, cit., pp. 120-121.
-
ROSA MARIA PARRINELLO Misure del monachesimo a Gaza
177
Giuda, pu essere considerato come un invarianza, un retaggio comune che risale a Ilarione. Vi sono poi anche variabili di contesto che non interrompono, per, a parer mio la continuit. Credo come altri che insomma si possa attribuire alla figura di Ilarione una certa storicit e che Girolamo non si sia limitato a trasferire su Ilarione le propria personale visione, attribuendogli caratteri che egli mutua dallesperienza monastica a Betlemme, cos come ritengo che Giovanni di Gaza, nella lettera 618, citando Ilarione renda omaggio a una figura che, se proprio non fond il monachesimo di Gaza, incarn comunque alcuni identity markers tipici dellesperienza monastica successiva.
Rosa Maria Parrinello Universit degli Studi di Torino
Dipartimento di Storia Via SantOttavio, 20
10124 Torino [email protected]
-
Copyright of Adamantius is the property of Editrice Morcelliana S.p.A. and its content may not be copied oremailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission.However, users may print, download, or email articles for individual use.