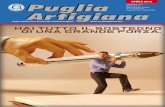marco 06
description
Transcript of marco 06

1
Letteratura cristiana antica
prof. Clementina Mazzucco
a.a. 2006-2007
Modulo specialistico
Problemi critici e interpretativi del Vangelo di Marco
Presentazione 1. Perché studiare il Vangelo di Marco? I Vangeli sono, tra gli scritti del Nuovo Testamento, quelli che più hanno avuto importanza e diffusione e di cui si ha comunque qualche nozione. Si tratta, però, per lo più, di nozioni su singoli brani o sezioni: parabole, episodi, racconti di miracoli, racconto della Passione; manca in genere una visione di insieme di ogni Vangelo, manca la percezione delle peculiarità dei singoli Vangeli e dei loro rapporti. Da ogni punto di vista, è una lacuna grave, da colmare. Il Vangelo di Marco ha poi caratteristiche sue che possono renderlo particolarmente interessante. Il primo fenomeno sorprendente è la strana "peripezia" che questo Vangelo ha subito tra l'antichità e i nostri giorni. Nell'antichità esso, pur riconosciuto subito dalle comunità ecclesiali come libro canonico, viene gradualmente messo in secondo piano rispetto agli altri Vangeli e non viene quasi mai commentato. E questa situazione è perdurata fino a tutto il '700, nell'ambito scientifico, ma nell'uso liturgico si può dire che l'ostracismo è continuato fino alla riforma del 1973, quando, in adempimento alle nuove disposizioni conciliari, le letture evangeliche sono state ripartire in tre cicli, dedicati ciascuno a uno dei Vangeli sinottici (Matteo, Marco, Luca), e il Vangelo di Marco è diventato protagonista del ciclo B. Oggi è il Vangelo più studiato a livello scientifico 1. Il motivo principale è che viene considerato il Vangelo più antico e vicino alle origini, quindi "genuino". L'interesse principale che ha spinto all'indagine sui Vangeli è quello di ricostruire la biografia di Gesù, di risalire ai fatti. Recentemente ha suscitato
1 La bibliografia è ormai immensa: si consideri che nel 1981 uno studioso, H.M. Humphrey, ha pubblicato un intero volume bibliografico relativo agli studi usciti tra il 1954 e il 1980; un altro volume, di ben 718 pagine, ha fatto uscire nel 1992 F. Neirynck sulla bibliografia 1950-1990. Alcuni commenti recenti sono davvero imponenti: si pensi ai due volumi di R. Pesch, rispettivamente di pp.664 e 840, tradotti in italiano nel 1980-1982; al volume, di pp.964, di J. Gnilka, tradotto nel 1987; ai due volumi, complessivamente di pp.842, di J. Ernst, tradotti nel 1991, ecc.

2
curiosità, anche nell'ambito dell'informazione giornalistica, e qualche polemica, la questione della scoperta, tra i papiri di Qumran, di un presunto frammento di questo Vangelo che potrebbe così essere datato in un'età molto "alta" (50 ca.) 2. A livello divulgativo, viene propagandato come il Vangelo più vivo, più realistico, più "pittoresco": contiene pochi discorsi e più fatti, e narrati con maggior vivacità e concretezza. All'estero se ne fanno, a partire dal 1978, anche recite drammatizzate, commenti romanzati 3. A questo Vangelo sono state applicate, per lo più parzialmente, a proposito di singoli episodi, le metodologie moderne più sofisticate, dall'analisi del racconto alla lettura strutturalista, a quella materialista. Un motivo che è venuto emergendo sempre di più nel nostro secolo è quello della speciale visione teologica espressa in questo Vangelo, ossia quella che con una formula viene definita "il segreto messianico" e che presenta un'immagine di Gesù complessa, misteriosa, quasi sfuggente, e perciò, appunto, affascinante e forse più congeniale allo spirito dei tempi moderni. E tuttavia non si può dire che sia ancora molto praticata una lettura davvero "letteraria", cioè attenta alla redazione finale del testo nella sua unità compositiva, nelle sue coordinate interne, nei suoi elementi formali, strutturali, simbolici. Resta prevalente l'interesse storico o teologico che spinge alla ricerca delle fonti, delle tradizioni preesistenti, degli apporti personali dell'evangelista, delle differenze rispetto agli altri evangelisti, per lo più in funzione di risalire alla "storia di Gesù" e alla storia dell'elaborazione dei materiali compiuta nell'ambito della comunità. Si attraversa Marco più che leggere Marco, si cerca soprattutto ciò che non appartiene a Marco, più che ciò che Marco dice. 2. Metodologia e piano di lavoro Il nostro scopo è quello di fornire strumenti per una migliore conoscenza del Vangelo di Marco e per l'acquisizione di una buona famigliarità con un metodo scientifico di studio dei Vangeli. Nella prima parte del modulo, ci occuperemo degli orientamenti degli studi su Marco e delle questioni tradizionali relative all'autore, alla data, al luogo di composizione e ai destinatari. E questo ci darà modo di ripercorrere brevemente le testimonianze antiche e la fortuna di Marco nella tradizione patristica e poi nella ricerca moderna, a partire dai vari aspetti del metodo storico-critico (Critica delle fonti, Storia delle forme, Storia della redazione) fino alle nuove metodologie, in particolare quelle letterarie (Analisi strutturale, Analisi retorica, Analisi narrativa). Cercheremo ogni volta di verificare quali risultati abbiano portato le singole metodologie alla conoscenza del Vangelo di Marco e proporremo esercitazioni su alcuni passi. Dedicheremo una particolare attenzione agli elementi compositivi e strutturali del Vangelo, in modo da avere una visione più adeguata di Marco
2 Ne parleremo più avanti. 3 Cfr. B. Standaert, Il Vangelo secondo Marco, tr.it., Roma, Borla, 1984 (ed. orig. Paris 1983), p.7.

3
come "scrittore" e ideatore del genere "vangelo". L'obiettivo ultimo è appunto quello di arrivare a riconoscere che il Vangelo di Marco, come ogni altra opera letteraria, è un racconto unitario e coerente, che obbedisce a un progetto consapevole sia nella sua sua forma sia nel suo messaggio. Successivamente daremo un inquadramento della critica testuale, una presentazione dell'edizione Nestle-Aland, che renda possibile la lettura dei segni critici e dell'apparato critico, e quindi affronteremo singoli passi o sezioni del testo di Marco che contengano sia problemi critici rilevanti sia questioni interpretative significative 4. L'edizione di riferimento consigliata è quella curata da B. Corsani-C. Buzzetti, Nuovo Testamento greco-italiano, Società Biblica Britannica & forestiera, Roma 1996, che riporta il testo greco secondo la 27ª ediz. Nestle-Aland, 1993, la trad. ital. della CEI, 1971, e le note della TOB (fotocopie delle pagine di questa edizione relative a Marco sono allegate alle dispense). Nota bibliografica generale I principali commenti sul Vangelo di Marco (in ordine alfabetico) - J. Delorme, Lettura del vangelo di Marco, tr.it., Assisi, Cittadella, 19873 (ed.orig. Paris 1972) - J. Ernst, Il Vangelo secondo Marco, tr.it., 2 voll., Brescia, Morcelliana, 1991 (ed.orig. Regensburg 1981) - R. Fabris, Il vangelo di Marco, in I Vangeli, tr. e comm. a cura di G. Barbaglio, R. Fabris, B. Maggioni, Assisi, Cittadella, 1989, pp. 619-916 - M. Galizzi, Vangelo secondo Marco. Commento esegetico-spirituale, Leumann (Torino), LDC, 1993 - J. Gnilka, Marco, tr.it., Assisi, Cittadella, 1987 (ed.orig. Zürich 1978-1979) - B.M.F. van Iersel, Leggere Marco, tr.it., Milano, Ed. Paoline, 1989 (ed.orig. Boxtel 1986) - Id., Marco. La lettura e la risposta. Un commento, tr. it., Brescia, Queriniana, 2000 (ed.orig. Sheffield 1998) - S. Légasse, Marco, tr.it., Roma, Borla, 2000 (ed.orig. Paris 1996) - R. Pesch, Il Vangelo di Marco, tr.it., 2 voll., Brescia, Paideia, 1980-1982 (ed.orig. Freiburg i.B. 1977-19802) - X. Pikaza, Il vangelo di Marco, tr. it., Roma, Borla, 1996 (ed.orig. estella 1995) - J. Radermakers, Lettura pastorale del Vangelo di Marco, tr.it., Bologna, Ed. Dehoniane, 19812 (ed.orig. Bruxelles 1974)
- J. Schmid, L'Evangelo secondo Marco, tr.it., Brescia, Morcelliana, 1966 3 (ed. orig. Regensburg 1955) - A. Schweizer, Il Vangelo secondo Marco, tr.it., Brescia, Paideia, 1971 (ed.orig. Göttingen 1967) - B. Standaert, Il Vangelo secondo Marco, tr.it., Roma, Borla, 1984 (ed. orig. Paris 1983) - V. Taylor, Marco. Commento al Vangelo messianico, tr.it., Assisi, Cittadella, 1977 (ed.orig. London 1952) - F.M. Uricchio-G.M. Stano, Vangelo secondo San Marco, Torino, Marietti, 1966
I parte: Il Vangelo di Marco nella tradizione antica e moderna
4 Chi non conosca la lingua greca legge i vari passi in traduzione e integra il programma con una ricerca concordata con la docente.

4
1. Il Vangelo di Marco nell'antichità Andare a ripercorrere le testimonianze antiche sul Vangelo di Marco non è e non vuole essere un'operazione erudita, ma assolve a vari scopi utili. Il Vangelo di Marco, che ora noi troviamo all'interno di un complesso di scritti ben definiti, "canonici", ha avuto una storia che ha a che fare con le idee e i problemi delle prime generazioni cristiane. Questo si è verificato già nell'elaborazione stessa del testo, che non è frutto del lavoro a tavolino di un solo autore, ma risultato di un lungo processo di trasmissione di ricordi e riflessioni di testimoni, di raccolta dei materiali e infine di sistemazione e interpretazione dei materiali stessi da parte di un redattore-evangelista. Ma anche successivamente abbiamo uno sviluppo storico che riguarda l'accoglienza dell'opera e che ha a che fare con il riconoscimento dell'identità e dell'affidabilità del suo autore, del valore dell'opera in rapporto con le altre opere simili, "parallele" per molti aspetti: i Vangeli. Accostarsi alle testimonianze dei Padri non è inutile, perché, al di là di molte differenze, che vanno tenute in considerazione, molte delle questioni che sono oggi all'ordine del giorno erano già ben presenti allora, e inoltre su molti punti, come quello del nome dell'autore, della datazione dell'opera, dobbiamo ricorrere alle informazioni degli antichi, anche perché i Vangeli in generale, e il Vangelo di Marco in particolare, sono scritti pervenuti anonimi, in cui in genere non c'è un autore che parla di se stesso e dei propri procedimenti (con qualche eccezione: il Vangelo di Luca contiene un prologo informativo sui criteri seguiti; l'evangelista Giovanni indica alla fine lo scopo del suo scritto). Purtroppo non è così facile, qui, come per tante altre questioni critiche che hanno a che fare con l'antichità, raccogliere e ricostruire organicamente queste informazioni, che ci sono giunte per lo più frammentarie e in forma indiretta, e che non sempre concordano. 1.1. Scarsa fortuna di Marco nell'antichità Per il Vangelo di Marco colpisce, e viene spesso notato, il fatto che si tratta di un Vangelo che ha goduto di minor fortuna, rispetto agli altri Vangeli, proprio nel mondo cristiano antico. Un dato già di per sé eloquente è che, a differenza che per gli altri, pochi furono i commenti dedicati ad esso, e tutti tardi. L'attività esegetica dei Padri è una buona pietra di paragone per misurare l'interesse verso un certo libro della Bibbia, perché fu una parte importante della loro produzione letteraria e si sviluppò ampiamente in forma di commenti puntuali, di trattati, di omelie, di glosse marginali, a partire dall'inizio del III secolo. Indubbiamente i Vangeli furono i libri della Bibbia più letti, studiati e commentati. Ma con differenze, appunto. Per il Vangelo di Giovanni sappiamo che già verso la metà del II secolo in ambienti gnostici si scrivevano trattati (a quello di Eracleone risponderà nella prima metà del III secolo il grande biblista Origene con un imponente trattato in ben 32 libri: ce ne sono pervenuti integri 8), e anche in seguito questo

5
Vangelo impegnò dotti esegeti e predicatori di fama: abbiamo infatti tra il IV e il V secolo 88 omelie di Giovanni Crisostomo, 124 di Agostino, un commento di Teodoro di Mopsuestia, uno, in 12 libri, di Cirillo di Alessandria, perfino una parafrasi in versi attribuita a Nonno di Panopoli, ecc. Il Vangelo di Matteo, come ha anche dimostrato la ricerca specifica di uno studioso, E. Massaux 5, fu indiscutibilmente tra tutti il più diffuso e utilizzato nei primi secoli: anche su di esso Origene compose un ampio Commento di 25 libri (ce ne sono pervenuti 8) e varie omelie (ne abbiamo 25). Più tardi abbiamo 90 omelie di Giovanni Crisostomo, tradotte poi in latino e in varie lingue orientali; un commento di Ilario di Poitiers e uno di Gerolamo; il cosiddetto Opus imperfectum in Matthaeum, il più ampio commento di Matteo in latino che possediamo e che ci è pervenuto anonimo : forse è opera di un ariano del V o VI secolo, e fu molto letto nel Medioevo. Ma non basta: dal sec. VIII in poi abbiamo pure commenti di Rabano Mauro, Claudio di Torino, Alberto Magno, Tommaso d'Aquino, ecc. Anche sul Vangelo di Luca, che ebbe rispetto agli altri due una posizione meno rilevante, possediamo comunque 39 omelie sempre di Origene, che saranno tradotte in latino da Gerolamo, una Expositio di Ambrogio in 10 libri, più di 150 omelie di Cirillo di Alessandria. Invece Marco sembra essere stato quasi ignorato dai commentatori e predicatori. Solo con Gerolamo, alla fine del IV secolo, troviamo 10 omelie dedicate a questo Vangelo, omelie che peraltro si limitavano a fornire alcune riflessioni allegoriche e morali su singoli passi e che dovettero avere scarsa diffusione. Circolavano tra l'altro come versione latina di omelie greche di Giovanni Crisostomo. Furono riscoperte nel '900 dal filologo Germain Morin 6. Abbiamo poi un commento, sempre in latino, attribuito questa volta a Gerolamo ma probabilmente non suo, tardo, secondo alcuni del V-VI secolo, ma probabilmente ancora posteriore, forse della fine del VII secolo e proveniente da ambiente anglosassone. Di qui viene anche il commento di Beda il Venerabile, tra fine del VII-inizio dell'VIII secolo. Per la chiesa greca è anche peggio. Il commento più antico è di un certo Vittore di Antiochia, del VI secolo, il quale esplicitamente dichiara di non conoscere commenti precedenti. E neppure il suo risulta essere un lavoro molto impegnato, dato che si limita a una breve compilazione di commenti a Matteo e Luca (di Origene, Cirillo Alessandrino, Tito di Bostra, Giovanni Crisostomo). Dobbiamo arrivare a Teofilatto, arcivescovo di Acrida (XI secolo), per trovare un'ampia serie di prediche esegetiche su Marco, e poi a Eutimio Zigabeno, monaco di Costantinopoli, morto dopo il 1182. Né la sorte di questo Vangelo cambia molto in età medioevale e rinascimentale: contiamo sei o sette commenti in tutto, tra cui quelli di Alberto Magno, di Tommaso d'Aquino, del cardinale Caetano.
5 Influence de l'Évangile de Saint Matthieu sur la littérature chrétienne avant Saint Irénée, Louvain 1950., rist. anast., con supplemento bibliografico (1950-1985), Leuven 1986. 6 Possiamo leggere queste omelie in traduzione italiana nel volume San Girolamo, Commento al Vangelo di san Marco, Roma, Città Nuova, 1965.

6
Tuttavia il Vangelo di Marco entrò nelle "Armonie evangeliche", molto diffuse nel mondo antico e che consistevano nel tentativo di comporre coi quattro Vangeli un unico racconto della "vita di Gesù": la prima e quella che ebbe maggior successo fu il Diatessàron (ossia to; dia; tessavrwn, sott. eujaggevlion: il "Vangelo formato con i quattro") di Taziano, del 170 ca. Forse composto originariamente in greco, fu tradotto ben presto in tutte le lingue antiche, a partire dal siriaco: nella chiesa siriaca fu il Diatessaron il testo ufficiale di base per i Vangeli fino al V secolo. Lo scrittore siro Efrem ne fece un commento nella seconda metà del IV secolo, anch'esso poi tradotto (noi lo conosciamo anche in armeno). Abbiamo così un indizio del tipo di interesse principale che si aveva per il Vangelo di Marco (e per gli altri Vangeli): esso era innanzitutto considerato un documento storico utile per ricostruire la biografia di Gesù, e questo interesse rimarrà costante nel tempo fino ai giorni nostri. Evidentemente, però, il Vangelo di Marco forniva da questo punto di vista un appoggio meno valido, in quanto più breve e quasi tutto parallelo ai Vangeli di Matteo e di Luca. Non a caso, un altro tipo di "Armonia" di cui abbiamo notizia, quella dell'alessandrino Ammonio (inizio del III secolo), prendeva come testo di base il Vangelo di Matteo. Inoltre, era diffusa l'opinione che Marco fosse posteriore a Matteo 7, e Agostino, nel De consensu evangelistarum (I,2), un altro trattato estremamente importante nell'antichità come tentativo di trovare una soluzione al problema, già ben sentito allora, delle discordanze tra i Vangeli, lo dice un po' sprezzantemente "valletto e compendiatore" di Matteo: Marcus eum (sc. Matthaeum) subsecutus tamquam pedisequus et breviator eius videtur. E il suo giudizio influenzerà la tradizione successiva. Ma altre testimonianze fanno intravedere difficoltà connesse con l'identità dell'autore e i suoi rapporti con la tradizione apostolica: a differenza che Matteo e Giovanni, Marco infatti non era un apostolo o un discepolo diretto di Gesù e vediamo che nella formazione del canone neotestamentario il criterio dell'apostolicità ebbe un ruolo di primo piano. Inoltre si insinuano dubbi sul valore del Vangelo, anche nella sua forma espositiva. Conviene a questo punto soffermarsi brevemente su queste testimonianze antiche che direttamente ci parlano di Marco. 1.2. Le testimonianze antiche su Marco Nota bibliografica Su questa parte la trattazione più ampia è quella di M.-J. Lagrange, Évangile selon Saint Marc, Paris 1947, pp.XIX-XXXII; cfr. anche Uricchio-Stano, Vangelo secondo San Marco, cit., pp.1-12; Taylor, Marco. Commento al Vangelo messianico, cit., pp.1-8; Pesch, Il Vangelo di Marco, I, cit., pp.37-49; X. Léon-Dufour, I Vangeli sinottici, in A. George-P. Grelot (edd.), Introduzione al Nuovo Testamento, II, tr.it., Roma, Borla, 1980 (ed.orig. Paris 1976), pp.58-66; A. Wikenhauser-J. Schmid, Introduzione al Nuovo Testamento, tr.it., Brescia, Paideia, 1981 (ed.orig. Freiburg i.B. 1973),
7 Di qui l'ordine dei Vangeli nel canone del Nuovo Testamento: Matteo, Marco, Luca, Giovanni.

7
pp.249-255. Cfr. anche C. Mazzucco, Lettura del Vangelo di Marco, Torino, Zamorani, 1999, pp. 186-193:Appendice: "Il Vangelo di Marco nella Chiesa antica". Una raccolta di tutte le fonti antiche sui Vangeli si trova in appendice a K. Aland, Synopsis quattuor evangeliorum, Stuttgart 1985 13, pp.531-548. 1.2.1. Papia di Gerapoli La prima e la più importante testimonianza, secondo alcuni studiosi l'unica autonoma, perché da essa dipenderebbero tutte le altre, è quella del vescovo Papia di Gerapoli 8. Si tratta di un autore che non conosciamo per tradizione autonoma, ma solo attraverso le citazioni e le notizie che ci riportano altri autori, e principalmente Ireneo di Lione, nel suo Adversus Haereses (verso il 180), ed Eusebio di Cesarea, nella sua Historia ecclesiastica (tra fine del III-inizio del IV secolo). Ireneo (Adv.Haer. V,33,4) mostra di sapere che Papia era stato alla scuola dell'apostolo Giovanni insieme a Policarpo, il futuro vescovo di Smirne, e che aveva composto un'opera in cinque libri, di cui Eusebio (H.E. III,39,1), che a sua volta si rifà a Ireneo, riporta il titolo, jExhvghsi" logivwn kuriakw~n, ossia Spiegazione dei detti del Signore. Eusebio (H.E. III,36,2) conferma che era un contemporaneo di Policarpo e di Ignazio (siamo dunque in età traianea, ma non è possibile precisare di più: esistono controversie sulla datazione, che comunque viene ricondotta ai primi decenni del II secolo) e lo dice vescovo di Gerapoli, ma rifiuta di ammettere che Papia fosse un discepolo dell'apostolo Giovanni: lo ritiene più probabilmente discepolo di un altro Giovanni, il "presbitero" (ovvero "Anziano"), che forse era anche l'autore dell'Apocalisse 9 Proprio Eusebio riporta in citazione la testimonianza che Papia dava nella sua opera sul Vangelo di Marco (H.E. III,39,14-17): si veda il passo in traduzione nell'All. 1. Eusebio cerca e riporta tutta una serie di notizie che ritiene significative ai fini della canonicità degli scritti del Nuovo Testamento, non stabilita ancora definitivamente ai suoi tempi (è questo uno dei grandi temi della sua Storia ecclesiastica). In questo cap. 39 del libro III ha dato, nei paragrafi precedenti, particolare rilievo alla questione dell'autore dell'Apocalisse, che è per lui molto spinosa, ma subito dopo dà uno spazio discreto a Marco, mentre accenna appena a Matteo, alla prima lettera di Giovanni e alla prima lettera di Pietro e al Vangelo secondo gli Ebrei. L'importanza delle notizie di Papia deriva dal fatto che, non solo si tratta di un autore antico, ma riporta a sua volta notizie di un "presbitero" Giovanni a lui anteriore: forse, come si ricaverebbe da Ireneo, l'apostolo stesso o, come pensa Eusebio (non del tutto degno di fede su questo punto), un personaggio
8 Su di lui si veda il volume di E. Norelli, Papia di Hierapolis, Esposizione degli oracoli del Signore. I frammenti, ed. Paoline, Milano 2005. 9 Ma questa opinione potrebbe essere provocata da un pregiudizio negativo sul millenarismo (una credenza condivisa da Papia), che prendeva volentieri spunto da un passo dell'Apocalisse: Eusebio, per invalidare il millenarismo, cercava di dimostrare che l'Apocalisse stessa non era opera dell'apostolo Giovanni, ma di un altro Giovanni, e quindi era di dubbia canonicità.

8
della generazione immediatamente successiva. In ogni caso saremmo in un'epoca pressoché contemporanea a quella della composizione del Vangelo 10. Tuttavia la notizia presenta alcuni elementi poco chiari. Innanzitutto dobbiamo osservare che Papia a sua volta cita un'affermazione del presbitero, ma senza precisarne i limiti: siamo noi a supporre che solo la prima frase sia del presbitero, il resto sia commento di Papia stesso (un indizio che a partire dalla seconda frase sia Papia a parlare potrebbe essere l' wJ" ejvfhn, trasl. hos èfen, "come ho detto"). Anche i termini usati da Papia suscitano difficoltà di comprensione, a cominciare dal termine essenziale che qualifica il rapporto tra Marco e Pietro, eJrmeneuthv" , trsl. hermeneutès, è stato inteso sia nel senso di "traduttore", portavoce (Pietro avrebbe parlato in ebraico e Marco avrebbe tradotto in greco), sia nel senso di "interprete" vero e proprio, cioè di chi spiega e commenta, con allusione appunto all'opera di rielaborazione e trasmissione dell'insegnamento di Pietro nel Vangelo. Quest'ultimo sembra il significato più adatto, sia perché è difficile supporre che Pietro, nato in Galilea, in una regione ai margini della Palestina, a stretto contatto con genti pagane, non fosse bilingue, sia perché questo significato si adatta meglio al contesto, in cui si parla di un lavoro di ricostruzione dei ricordi lasciati dall'insegnamento di Pietro. Il primo aspetto della notizia verte dunque sullo stretto rapporto tra Marco e l'apostolo Pietro. E se ne coglie meglio il risvolto apologetico da quanto Papia aggiunge, notando che Marco non fu discepolo diretto di Gesù, ma fu discepolo di Pietro, l'apostolo di Gesù. Affiora una preoccupazione costante nel mondo antico per quanto riguarda tutti i libri che dovevano essere inseriti nel "canone", e cioè quella di accertare l'attribuzione a uno degli apostoli, in in quanto testimoni diretti dell'insegnamento e della vita di Gesù. 11
Un secondo aspetto che salta agli occhi è ancora di tipo apologetico: l'implicita risposta a un'obiezione sul contenuto del Vangelo, che evidentemente appariva ad alcuni non sufficientemente ordinato nell'esposizione delle parole e dei fatti del Signore. Il presbitero sente il bisogno di compensare la mancanza di ordine con un elogio per l'"esattezza", "accuratezza" del racconto. Una giustificazione può già essere quell' oJvsa ejmnhmovneusen, trasl. hosa emnemòneusen, "quanto ricordò", che fa riferimento a un lavoro di memoria, non necessariamento completo. Papia a sua volta sviluppa questo punto e aggiunge qualcosa di suo: scagiona Marco e attribuisce a Pietro stesso un certo disordine nel suo insegnamento, che viene presentato come un po' "occasionale", privo di preoccupazioni di sistematicità. In qualche modo, per lui il disordine di Marco diventa un pregio, una garanzia di maggiore fedeltà all'insegnamento di Pietro, che era appunto disordinato.
10 Cfr. Pesch, Il Vangelo di Marco, cit., p.39. 11 Un interesse specifico per la definizione di liste di libri "canonici", ossia normativi sul piano della fede, incomincerà dopo la metà del II sec., dopo cioè il primo tentativo fatto da quello che venne subito considerato un "eretico", Marcione, il quale rifiutava tutto l'Antico Testamento, come rivelazione di un Dio diverso e malvagio, rispetto al Dio rivelato da Gesù; accoglieva solo il Vangelo di Luca, senza i primi due capitoli (vangelo dell'infanzia) e le lettere di Paolo, senza la Lettera agli ebrei.

9
Esplicitamente sostiene che "Marco non sbagliò" riportanto "alcuni" (ejvnia, trasl. ènia) di questi insegnamenti sulla base di quanto ricordava. 12 Quell'"alcuni" può anche far pensare che si alluda a un'incompletezza del Vangelo. Papia rivendica comunque a Marco l'esattezza ("non tralasciò nulla") e l'autenticità ("non mentì"), per quanto riguarda l'esposizione degli insegnamenti di Pietro. Molte sono le questioni che sorgono a proposito di questa notizia. In base a quali elementi il presbitero e Papia stabilivano questo rapporto di discepolato tra Marco e Pietro? Dove e quando si sarebbe svolto? Dove e quando sarebbe stato effettivamente scritto il Vangelo? E ancora: quali erano i motivi delle critiche rivolte al "disordine" di Marco? In base al confronto con quali altri Vangeli? Per quanto riguarda il rapporto tra Marco e Pietro, si è pensato a un riferimento alla Prima lettera di Pietro, che nei saluti finali ha: "Vi salutano la chiesa, che è stata eletta come voi e dimora a Babilonia, e Marco, mio figlio" (1 Pt 5,13). Si suppone che questa lettera, che come si vede da Eusebio (III,39,17) Papia conosceva, sia stata scritta a Roma (sarebbe definita "Babilonia" in senso polemico, apocalittico) e che Marco, che doveva essere "figlio" di Pietro in senso spirituale, convertito da lui e suo discepolo, fosse in quel momento a Roma insieme a Pietro. Che sia presupposto in Papia questo riferimento a 1 Pietro è un'ipotesi: il collegamento con il Marco della lettera di Pietro sarà fatto esplicitamente in seguito, a partire da Clemente Alessandrino, e qualcuno (ad es., Pesch) pensa che non si tratti di notizie indipendenti, ma tutte derivate da quella di Papia: cioè Clemente Alessandrino e gli altri dopo di lui non avrebbero avuto altre informazioni oltre a quella di Papia, ma avrebbero a loro volta ampliato e sviluppato quanto già ricavavano di qui. Anche la presenza a Roma di Marco accanto a Pietro verrà indicata più esplicitamente da testimonianze posteriori. Non risulta però chiaro dalla notizia di Papia quando Marco avrebbe scritto il suo Vangelo: si può solo supporre che lo abbia scritto dopo la morte di Pietro, come farebbe pensare il fatto che scrisse "quanto ricordò". Invece le fonti posteriori cercheranno di precisare, ma in modi divergenti. E a proposito delle critiche rivolte a questo Vangelo, le opinioni non sono concordi. In che cosa consisterebbe il "disordine" e rispetto a quale altro Vangelo questo potrebbe essere stato notato? Le ipotesi sono due: o che il confronto fosse stabilito con il Vangelo di Matteo o con quello di Giovanni, i due vangeli di origine strettamente apostolica che a quel momento e in Oriente (dove vivono il presbitero Giovanni e Papia) avevano più prestigio. Dalle parole di Papia si potrebbe ricavare che la critica riguardasse già l'incompletezza dell' esposizione, dato che si osserva che Marco trascrisse "alcuni" dei detti del Signore. Inoltre si accenna ad un'esposizione (che Papia fa
12 Potremmo considerare una testimonianza sull'opinione dell'incompletezza del Vangelo di Marco anche la "finale" del Vangelo di Marco (16,9-20), che, come avremo occasione di analizzare nella seconda parte, è un brano distinto dal resto del Vangelo, forse composto appositamente, e certamente inserito da qualcuno, per integrare la conclusione del Vangelo.

10
risalire a Pietro stesso) forse cronologicamente e logicamente non rigorosa, ma "occasionale", e addirittura ad "errori". Queste critiche possono adattarsi al confronto con Matteo, che si caratterizza, rispetto a Marco, per una ricchezza molto maggiore di "detti" del Signore (tipici sono i suoi cinque grandi discorsi), e inoltre presenta un racconto più completo, dato che inizia dalla nascita di Gesù. Ma si adattano anche al confronto con Giovanni (e pensiamo che queste critiche sembrano circolare in ambiente giovanneo), che si differenzia molto da tutti e tre i sinottici già per la ricostruzione cronologica della vita di Gesù (tre, ad esempio, sono in questo Vangelo i viaggi a Gerusalemme, e non uno solo; anche la ricostruzione della settimana della Passione varia) e poi per l'impostazione, che è incentrata prevalentemente proprio sull'insegnamento di Gesù, rispetto al quale i fatti sono secondari. Giovanni inizia addirittura il suo Vangelo parlando della preistoria divina del Logos. C'è anche chi pensa che il confronto valga per entrambi i Vangeli o per la tradizione orale nota 13. E' possibile riconoscere che la testimonianza di Papia è poi sostanzialmente ripresa dagli autori successivi, con ampliamenti e precisazioni, che rafforzano lo scopo apologetico. Non viene mai messo in discussione il rapporto di Marco con Pietro, ma si forniscono chiarimenti a proposito del luogo di composizione del Vangelo e della data. 1.2.2. Giustino Dal Dialogo con Trifone (par.106) dell'apologista Giustino, scritto poco dopo la metà del II secolo, ricaviamo che il Vangelo di Marco era definito jApomnhmoneuvmata Pevtrou, trasl. Apomnemoneùtata Pètru, ossia "Memorie di Pietro. Questa definizione implica che il Vangelo di Marco fosse allora conosciuto, secondo la testimonianza di Papia, come una sorta di trascrizione della predicazione di Pietro. 1.2.3. Il "Prologo antimarcionita" Si tratta di una delle prefazioni ai Vangeli che furono composte nel II secolo (seconda metà) per contrastare le posizioni di Marcione, il primo a tracciare un canone dei libri sacri, ma un canone ridotto, che ammetteva, tra i Vangeli, solo il Vangelo di Luca e solo parzialmente. Ci sono pervenuti in manoscritti latini antichi (e sono stati pubblicati nel 1928) i prologhi ai Vangeli di Marco, Luca e Giovanni, manca quello a Matteo. Il "Prologo" al Vangelo di Marco, frammentario nella parte iniziale, dice così: [...] (lo) ha affermato Marco, che fu chiamato "dalle dita mozze" (kolobodavktulo", trasl. colobodàctylus), perché ebbe dita più piccole rispetto alle dimensioni del resto del corpo. Questi
13 Cfr. Taylor, Marco, cit., p.2.

11
fu interprete di Pietro. Dopo la morte dello stesso Pietro compose questo vangelo nelle regioni d'Italia. Questo documento contiene la ripresa della tradizione di Papia (Marco interprete di Pietro), con due precisazioni: il Vangelo fu composto dopo la morte di Pietro e in Italia. Contiene però anche un'informazione nuova, piuttosto strana, su una caratteristica fisica di Marco: che aveva dita corte o mozze. Questa informazione trova conferma in un passo di Ippolito di Roma (Refutatio omnium haeresium VII,30,1), dell'inizio del III secolo, in cui pure Marco riceve l'appellativo di colobodàctylus, senza ulteriori spiegazioni. C'è chi pensa che il Prologo dipenda da Ippolito. Questo particolare viene interpretato in due modi, o come riferimento a un difetto naturale, o come indizio di una mutilazione volontaria, in rapporto con la sua scelta di adesione alla fede cristiana: una tradizione più tarda, che si ritrova in un Prologo di tipo "monarchiano"14 (forse della metà del IV secolo) e in Gerolamo (nella prefazione al Commento a Matteo), spiega infatti che Marco, originariamente levita di stirpe e sacerdote di Israele, dopo la conversione e il battesimo impartitogli da Pietro, si sarebbe amputato il pollice per rendersi inabile al sacerdozio (che esigeva persone senza difetti fisici). Qualche studioso mette in rapporto questa mutilazione col detto di Gesù sul dovere di tagliarsi la mano che è motivo di scandalo (Mc 9,43) 15. Tuttavia, non possiamo escludere che il particolare sia leggendario e in ogni caso risulta marginale. 1.2.4. Il Canone Muratoriano E' il primo Canone (ossia lista dei libri ritenuti ispitrati e normativi per la fede dei cristiani) a noi noto: ci è pervenuto in latino attraverso un manoscritto scoperto e pubblicato per la prima volta da Ludovico Antonio Muratori nel 1740, ma forse originariamente era in greco. E' databile negli ultimi decenni del II secolo, in base al riferimento al vescovo Pio (vescovo di Roma tra il 140 e il 155) contenuto nell'ultima parte del documento, e proviene dall'ambiente romano. Si veda il testo in traduzione nell'All. 2. E' una testimonianza frammentaria, perché comincia così: quibus tamen interfuit et ita posuit. Tertium evangelii librum secundum Lucam [...]. ai quali tuttavia fu presente e così espose. Il terzo vangelo secondo Luca [...]. Ma è possibile anche che quibus ("ai quali") sia da integrare in aliquibus ("ad alcuni").
14 Cioè influenzato da una posizione eterodossa sulla cristologia: per rafforzare il monoteismo i monarchiani concepivano la Trinità come una monarchia, in cui la figura del Figlio risultava del tutto subordinata. 15 Cfr. J. Ernst, Marco. Un ritratto teologico, tr.it., Brescia, Morcelliana, 1990 (ed.orig. Düsseldorf 1987), p.163.

12
Evidentemente l'inizio si riferisce proprio al Vangelo di Marco, dato che segue l'accenno al Vangelo di Luca, come terzo (prima di Marco, dunque, si era già parlato di Matteo). Risulta così già fissato l'ordine dei Vangeli che rimarrà canonico. Le parole riportate possono essere interpretate o nel senso che Marco fu presente ad alcuni fatti raccontati o, più probabilmente, con riferimento alla testimonianza di Papia, fu presente all'insegnamento di Pietro e lo riportò nel suo Vangelo. 1.2.5. Ireneo di Lione E' la testimonianza più importante, dopo quella di Papia. Ireneo, nel libro III del suo Adversus Haereses, databile verso la fine del II secolo , accingendosi a confutare gli gnostici sulla base delle Scritture, si sofferma con ampiezza sull'apostolicità dei Vangeli. Di solito si ferma l'attenzione sul passo di III,1,2-4, in cui Ireneo presenta i quattro Vangeli in rapporto appunto con gli apostoli (il testo greco è riportato da Eusebio, Hist.Eccl. V,8,2-4): 16
Matteo tra gli Ebrei pubblicò nella loro stessa lingua una forma scritta di Vangelo, mentre a Roma Pietro e Paolo predicavano il Vangelo e fondavano la Chiesa. Dopo la loro morte (ejvxodon, trasl. èxodon), Marco, il discepolo e interprete (eJrmhneuthv", trasl. hermeneutès) di Pietro, ci trasmise anche lui per iscritto quanto veniva annunciato da Pietro. Poi anche Luca, compagno di Paolo, riportò in un libro il Vangelo annunciato da lui (= Paolo). E infine Giovanni, il discepolo del Signore, colui che riposò sul suo petto, pubblicò anch'egli il Vangelo, mentre soggiornava ad Efeso in Asia. Da questo passo ricaviamo una conferma della testimonianza di Papia su Marco "discepolo e interprete" di Pietro e sul suo Vangelo come trascrizione della predicazione di Pietro (del resto sappiamo che effettivamente Ireneo leggeva l'opera di Papia). In più, risulta precisato dal contesto che il luogo è Roma (abbiamo visto che il Prologo antimarcionita indicava l'Italia). Quanto al momento cronologico, i più intendono che Marco scrisse dopo la morte degli apostoli, notizia che di nuovo coincide con quanto riferisce il Prologo antimarcionita e con quanto si poteva dedurre implicitamente da Papia stesso. Ma poiché, come vedremo, Clemente Alessandrino dice invece espressamente che Marco scrisse durante la vita di Pietro, si è cercato di intendere diversamente il passo di Ireneo, o dando a ejvxodo" il significato di partenza (dalla Palestina) - ma il contesto parla di Roma e non si conosce una partenza da Roma che non sia l'ultima dipartita dalla vita - oppure dando un altro valore all'intera frase, in cui si metterebbe in rilievo non il momento della composizione, ma il fatto che Marco trasmise, "fece continuare" anche oltre la morte la predicazione di Pietro.
16 L'intera opera di Ireneo, in 5 libri, che originariamente era in greco, ci è pervenuta in una traduzione latina.

13
Ma di Ireneo vale la pena di considerare anche altre testimonianze sul Vangelo di Marco, tutte contenute nel libro III. In III,10,6, ad esempio, Ireneo riporta, tra le testimonianze evangeliche che provano l'identità tra il Dio dei profeti antichi e il Padre di Gesù Cristo, l'inizio e la fine 17 del Vangelo di Marco, ancora definito interpres et sectator Petri. In III,11,7 (si veda si veda il testo in traduzione nell'All. 3) Ireneo nota che anche gli eretici ricorrono ai Vangeli per sostenere le loro dottrine, e quindi ne riconoscono l'autorità. Egli ci indica quindi, per i vari tipi di eretici, i Vangeli preferiti:
Gli Ebioniti 18 infatti, che usano solo il Vangelo secondo Matteo, da quello stesso
Vangelo vengono accusati di non avere concezioni giuste del Signore. Marcione 19 invece, che amputa il Vangelo secondo Luca, in base alle parti di esso conservate si dimostra blasfemo contro l'unico Dio esistente. Quelli che invece distinguono Gesù da Cristo e sostengono che Cristo rimase impassibile mentre fu Gesù a patire, e preferiscono perciò il Vangelo secondo Marco, se lo leggono con l'amore della verità, possono correggersi. E infine i seguaci di Valentino, che si servono continuamente del Vangelo secondo Giovanni per dimostrare la
validità delle loro coppie 20, verranno smascherati da questo stesso Vangelo nel loro non dire alcunché di giusto". Risulta di qui che c'era un gruppo di eretici, non ben precisati, che ricorreva più volentieri al Vangelo di Marco: sembra trattarsi di qualche setta doceta 21 o gnostica, che aveva difficoltà ad accettare la realtà della Passione. Idee simili si trovano attribuite a varie figure ereticali, in particolare a Cerinto: questi, a quanto riporta Ireneo stesso (I,26,1), riteneva che Gesù fosse un uomo normale: solo al momento del battesimo su di lui sarebbe disceso il Cristo in forma di colomba per poi abbandonarlo al momento della Passione. E' possibile che questi eretici trovassero nel Vangelo di Marco uno speciale supporto alle loro idee in quanto proprio Marco dà particolare risalto agli aspetti di umanità e anche di "debolezza" di Gesù, soprattutto durante la Passione, e questi aspetti possono apparire in forte contrasto con le manifestazioni, pure presenti nel Vangelo, del Cristo taumaturgo potente e maestro pieno di autorità. In ogni
17 E si noti che Ireneo cita come fine del Vangelo 16,19, un passo cioè della cosiddetta "finale canonica", che evidentemente già circolava ma non doveva aver fatto parte del Vangelo originario, il quale, secondo quanto si può dedurre dalla tradizione manoscritta, si concludeva con 16,8: si vedano su questo punto le osservazioni che faremo nella seconda parte. 18 Questi eretici vedevano in Gesù Cristo solo la natura umana. 19 Distingueva il Dio dell'antica economia dal Dio della nuova e quindi rifiutava tutto l'Antico Testamento e le parti del Nuovo Testamento troppo legate all'Antico. Cfr. sopra, n. 11. 20 Si fa riferimento alla complessa mitologia gnostica che concepiva alle origini del mondo divino e umano una serie di coppie (o sizigie): Logos e Vita, Uomo e Chiesa, ecc. 21 I "doceti" traevano il nome dal greco dokei'n, trasl. dokèin, "sembrare, apparire", perché pensavano che la natura umana di Gesù fosse solo apparente. Il docetismo, più che un'eresia autonoma, era un aspetto caratteristico di varie eresie, soprattutto delle varie correnti gnostiche.

14
caso Ireneo è meno severo verso questi eretici rispetto agli altri e mostra di credere possibile una loro resipiscenza. Un passo particolarmente interessante, e che avrà una grande influenza sulla simbologia e sull'iconografia successiva relativa agli evangelisti, è III,11,8 (vedi All. 3 e 4) che è immediatamente successivo. Qui Ireneo si sofferma a dimostrare che i Vangeli non possono essere né più né meno di quattro, perché quattro sono le regioni del mondo, quattro i venti della terra e perché dunque quattro è il numero dell'universalità e della totalità. Quindi Ireneo ricorre anche alla simbologia biblica e in specie al quadruplice aspetto attribuito da Ezechiele (1,6.10) ai Cherubini e dall'Apocalisse (4,7) ai Viventi che stanno intorno al trono divino: aspetto di leone, di vitello, di uomo e di aquila. Tutti questi aspetti si riferiscono al Figlio di Dio e ne illustrano la natura e l'attività salvifica. Il leone indicherebbe potenza, eccellenza, regalità; il vitello la funzione sacrificale e sacerdotale; l'uomo la venuta in forma umana; l'aquila il dono dello Spirito che vola sulla Chiesa. Ireneo ritiene di poter ritrovare negli inizi di ciascun Vangelo uno di questi aspetti, sicché i quattro Vangeli nel loro insieme costituirebbero il fondamento di Gesù Cristo. Sono davvero curiosi l'ordine e la caratterizzazione data ai Vangeli, soprattutto per quanto riguarda il Vangelo di: Marco: Uno (= il Vangelo secondo Giovanni) racconta la sua (= di Cristo) generazione dal Padre, che è la principale e potente e gloriosa, dicendo: "In principio c'era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio" (Gv 1,1) e: "Tutto fu fatto per mezzo di lui e nulla fu fatto senza di lui" (Gv 1,3). Perciò questo Vangelo è anche pieno di ogni ardire: tale infatti è il suo aspetto (= di leone). Il Vangelo secondo Luca, poiché ha carattere sacerdotale, incomincia col sacerdote Zaccaria che sacrifica a Dio: infatti già si stava preparando il vitello grasso che doveva essere immolato per il ritrovamento del figlio minore (cfr. Lc 15,23.30). Matteo invece annuncia la sua generazione umana, dicendo: "Libro della generazione di Gesù Cristo, figlio di David, figlio di Abramo" (Mt 1,1) e: "La generazione di Cristo avvenne così" (Mt 1,18). Questo Vangelo ha dunque forma d'uomo; per questo anche in tutto il Vangelo si è mantenuto uomo di sentimenti umili e mite. Marco infine prese inizio dallo Spirito profetico che dall'alto scese sugli uomini, dicendo: "Inizio del Vangelo... come sta scritto nel profeta Isaia" (Mc 1,1.2), mostrando l'immagine alata del Vangelo; per questo ha fatto l'annuncio in forma sintetica e rapida: questo infatti è il carattere della profezia. E lo stesso Verbo di Dio parlava ai patriarchi che vissero prima di Mosè secondo la sua natura divina e gloriosa; a coloro che vissero sotto la Legge assegnava una funzione sacerdotale e ministeriale; fattosi successivamente uomo, inviò il dono dello Spirito Santo su tutta la terra, proteggendoci con le sue ali. Quale è l'attività del Figlio di Dio, tale è anche l'aspetto dei Viventi, e quale è l'aspetto dei Viventi, tale è il carattere del Vangelo. Quadriformi sono i Viventi, quadriforme è anche il Vangelo e quadriforme è l'attività del Signore. E per questo furono dati quattro patti di alleanza all'umanità: uno prima del diluvio al tempo di Adamo; il secondo dopo il diluvio al tempo di Noè; il terzo fu la la Legge data al tempo di Mosè; il quarto è quello che rinnova l'uomo e ricapitola in sé tutte le cose, e questo per mezzo del Vangelo, che solleva e fa volare gli uomini nel regno celeste. In questo passo si può notare, in generale, che Ireneo attribuisce un significato positivo alla pluralità e alle differenze tra i Vangeli, cosa che non era e non sarebbe stata sempre ammessa, come testimoniano i tentativi di armonizzare i Vangeli e le discussioni sulle differenze; si pensi in particolare al

15
fatto che negli stessi anni di Ireneo Taziano, in Siria, compone quella che a noi risulta la prima "armonia evangelica", il Diatessaron, nel quale si tentava di combinare insieme i quattro Vangeli, eliminando le differenze. Inoltre vediamo che si instaura per la prima volta il collegamento tra i Vangeli e i simboli apocalittici dei Viventi, collegamento che rimarrà in tutta la tradizione successiva. Ma c'è una particolarità che la tradizione successiva correggerà ed è l'attribuzione dei simboli del leone e dell'aquila rispettivamente a Giovanni e a Marco. Mentre Vittorino di Pettau, nel suo Commento all'Apocalisse (inizio del IV secolo) ancora si atterrà all'esposizione di Ireneo, Gerolamo, che ne fece una riedizione con ritocchi alla fine del IV secolo, la correggerà su questo punto, attribuendo invece il simbolo del leone a Marco e quello dell'aquila a Giovanni. La connessione di Marco col leone venne ritrovata nel fatto che nel suo prologo si parla della "voce di colui che grida nel deserto", mentre il prologo di Giovanni fu associato con l'aquila per il fatto che si innalza verso l'alto trattando del Verbo di Dio. Questa nuova disposizione, che si ritrova anche in Ambrogio, rimarrà definitiva 22. Agostino, nel De consensu evangelistarum (I,6,9), come vedremo, manterrà l'attribuzione dell'aquila a Giovanni, ma per Marco penserà al simbolo dell'uomo, dato che Marco non ha trattato né della stirpe regale di Cristo né della sua consacrazione sacerdotale. Lo scambio dei simboli tra Giovanni e Marco in Ambrogio e Gerolamo e l'attribuzione del simbolo dell'uomo a Marco da parte di Agostino corrispondono a un declassamento del Vangelo di Marco, che del resto risulta evidente dal giudizio negativo espresso da Agostino nei riguardi di Marco "valletto e compendiatore" di Matteo, su cui torneremo. Chiaramente il simbolo dell'aquila premia ora il Vangelo ritenuto più importante e "sublime", che è quello di Giovanni. Però possiamo ora notare anche meglio che con Ireneo le cose non stavano ancora così. Ireneo mostra di ritenere superiori sia il Vangelo di Giovanni sia il Vangelo di Marco e si potrebbe anzi dire che pone il Vangelo di Marco come culmine dei Vangeli, perché gli assegna lo spirito profetico, e lo associa costantemente all'elemento conclusivo e più perfetto delle serie che propone: lo pone, all'interno delle quattro tappe fondamentali della storia della salvezza (patriarchi, legge, incarnazione, invio dello Spirito) nella fase finale, quella del compimento dell'azione del Verbo; lo fa corrispondere al quarto e ultimo dei patti di alleanza tra Dio e l'umanità (Adamo, Noè, Mosè, Gesù Cristo), quello del compimento del vangelo. Si può perfino osservare che la maggior brevità di questo Vangelo, nonché essere considerata un tratto di seriorità e di dipendenza, è associata al carattere della profezia. Con Ireneo, dunque, il Vangelo di Marco non ha neppure bisogno delle difese del tempo del presbitero e di Papia. Evidentemente, però, successivamente la fortuna del Vangelo di Giovanni, che appariva teologicamente più profondo, portò a mettere da parte 22 La ritroviamo anche all'inizio del Commento a Marco di Gerolamo (il primo commento a Marco che ci sia pervenuto). Sarà fissa nell'iconografia. Ma teniamo presente che in ambienti orientali si manterrà ancora l'associazione tra Marco e l'aquila.

16
il Vangelo di Marco. Ma vale la pena di considerare che questo processo non fu immediato e che questo Vangelo, nonostante alcuni fattori di inferiorità (mancanza di un collegamento con una figura apostolica, brevità, incompletezza), non mancò di suscitare apprezzamento. In III,11,9 (vedi All. 4) Ireneo condanna sia coloro che riducono il numero dei Vangeli, come Marcione (che accettava solo il Vangelo di Luca) e come altri che, rifiutando il dono dello Spirito, contestavano il Vangelo di Giovanni, sia coloro che introducono nuovi Vangeli, come gli gnostici, e menziona in particolare i Valentiniani, che avevano composto presuntuosamente un "Vangelo della verità", diverso dai quattro Vangeli. 1.2.6. Clemente Alessandrino Clemente Alessandrino è il primo importante esponente della "Scuola Alessandrina", che, operante in un ambiente culturalmente elevato, sede già in età ellenistica di studi filologici e letterari, rappresenta in ambito una sorta di scuola superiore di studi teologici, con spiccati interessi, soprattutto poi con il successore Origene, per la filologia e l'esegesi biblica. Di lui conosciamo tre testimonianze tratte da un'opera perduta, Ipotiposi (cioè Schizzi, Abbozzi), che forniva spiegazioni su libri della Bibbia: due ce le riporta Eusebio (Hist.Eccl. VI,14,5-7; II,15,1-2) e una ci è pervenuta in una traduzione latina di Cassiodoro (Adumbrationes ad 1 Petr. 5,13). Sono interessanti come sviluppo della tradizione di Papia (si veda anche l'All. 5): Negli stessi libri Clemente riporta una testimonianza dei presbiteri antichi sull'ordine dei Vangeli, che suona così: diceva che furono scritti prima i Vangeli che contengono le genealogie (= Matteo e Luca). Quanto al Vangelo di Marco, avrebbe avuto questa storia. Quando Pietro ebbe annunciato pubblicamente a Roma la Parola e predicato il Vangelo secondo lo Spirito, i presenti, che erano molti, invitarono Marco, in quanto lo aveva seguito da tempo e ricordava le cose dette, di trascrivere le sue parole. Questi lo fece e consegnò il Vangelo a coloro che glielo chiedevano. Quando lo venne a sapere, Pietro non usò esortazioni né per impedirlo né per incitarlo. Quanto poi a Giovanni, che fu l'ultimo, quando vide che i fatti materiali già erano stati esposti nei Vangeli, spinto dai discepoli e pieno di Spirito divino, compose un Vangelo spirituale. Così Clemente. Rifulse a tal punto il lume della fede nelle menti degli ascoltatori di Pietro che non bastò loro di ascoltarlo una sola volta né di ricevere oralmente l'insegnamento dell'annuncio divino, ma con inviti di ogni genere supplicarono Marco, di cui ci è tramandato il vangelo e che era seguace di Pietro, di lasciare loro anche una memoria scritta dell'insegnamento ricevuto verbalmente ed insistettero finché non lo fece: in questo modo divennero causa della redazione del Vangelo detto secondo Marco. Dicono che l'apostolo, quando seppe, attraverso una rivelazione diretta dello Spirito, ciò che era avvenuto, si compiacque dell'ardore di quelle persone e convalidò il testo scritto perché fosse letto nelle chiese. Clemente riporta il racconto nel sesto libro delle Ipotiposi, e lo conferma anche il vescovo di Gerapoli di nome Papia. Marco, seguace di Pietro, allorché Pietro predicava pubblicamente il Vangelo a Roma, alla presenza di certi cavalieri di Cesare, e adduceva molte testimonianze su Cristo, pregato da loro di far sì che essi potessero ricordare ciò che veniva detto, scrisse sulla base di quanto Pietro aveva detto il Vangelo chiamato di Marco.

17
Dalla prima testimonianza si evince che esistevano diverse opinioni sull'ordine in cui sarebbero stati composti i Vangeli e c'era anche chi riteneva che all'inizio si collocassero sia Matteo sia Luca.23
Dai tre passi ricaviamo che Clemente riprende la fondamentale notizia di Papia (Papia viene espressamente citato nel secondo passo), secondo cui Marco avrebbe assistito alla predicazione di Pietro e l'avrebbe riportata nel suo Vangelo, e precisa che questo sarebbe avvenuto a Roma; è più che probabile che l'autore conosca il passo di 1 Pt 5,13 (in cui Pietro menziona il "figlio" Marco e accenna a Roma come "Babilonia"). In più però sostiene che il Vangelo sarebbe stato scritto per richiesta degli ascoltatori (nella terza testimonianza si menziona una categoria particolare, qualificata, di ascoltatori: certi cavalieri di Cesare). Ma non solo: vuole che Pietro sia stato a conoscenza della cosa e che quindi la stesura del Vangelo sia avvenuta mentre era ancora vivo. Questo dato non coincide con quanto si può ricavare da Papia stesso ed è in contraddizione con quanto abbiamo appreso dal Prologo antimarcionita e da Ireneo. Ma si può notare che questo particolare è in funzione del parere che Pietro avrebbe così avuto modo di esprimere, anche se c'è contraddizione tra i primi due passi, perché nel primo si dice che Pietro non si espresse né a favore né contro, nel secondo molto più decisamente si sostiene che Pietro approvò con entusiasmo e addirittura ratificò il Vangelo autorizzandone la lettura ecclesiale e ufficiale: Lagrange 24 suppone che nel secondo passo non sia riportato solo il pensiero di Clemente, ma sia integrato da Eusebio stesso. Possiamo quindi pensare che Clemente non abbia informazioni nuove rispetto a Papia, ma che aggiunga alcuni particolari per rafforzare ulteriormente la difesa del Vangelo di Marco, che a questo punto non risulta soltanto ispirato da Pietro, ma ratificato da lui. La prima testimonianza evidenzia già la stima maggiore che il Vangelo di Giovanni sta guadagnando, per il fatto che appare più "spirituale" rispetto agli altri, i quali si limitano a raccontare fatti "materiali". Il valore assiologico di questi termini contrapposti (spirito/corpo) si comprende meglio tenendo conto della cultura alessandrina, profondamente impregnata, attraverso la mediazione di Filone Alessandrino, dell'influsso filosofico platonico e quindi portata a deprezzare il corporeo rispetto allo spirituale. Incominciamo quindi a intravedere il senso della parabola discendente di Marco, che, come già abbiamo accennato (a proposito di certi eretici gnosticizzanti menzionati da Ireneo), più dà spazio a un Gesù umano e sofferente. Il Vangelo di Giovanni meglio si prestava ad essere utilizzato nella lotta contro gli gnostici, che trovavano lì consonanza con le loro idee : non a caso proprio uno gnostico di nome Eracleone aveva scritto un commento a questo Vangelo nel II sec:, commento a cui risponderà ad Alessandria il successore di Clemente , Origene. E sempre il Vangelo di Giovanni appariva più adatto come punto di riferimento anche nelle controversie contro gli intellettuali pagani che
23 Un ordine tra i Vangeli che si trova in alcuni manoscritti è Matteo Giovanni Luca Marco: in questo caso si tratta di un ordine di importanza e all'inizio vengono posti i Vangeli composti da apostoli. 24 Évangile, cit., p.XXIII.

18
proprio in questo periodo attaccavano i cristiani, tra le altre cose, per la figura del loro fondatore, tanto contrastante con l'idea filosofica di divinità, a causa della meschinità della sua vita e della sua morte, e per il basso livello sociale ed intellettuale attribuito ai cristiani. Di questo tipo erano le obiezioni di Celso, autore, verso il 180, della prima opera pagana a noi nota contro i cristiani, dal titolo jAlhqh;" lovgo", trasl. Alethès Lògos, "Discorso veritiero", a cui risponderà ancora Origene nel Contro Celso. 1.2.7. Origene Di lui (siamo alla metà del III sec.) vale la pena di riportare una sola testimonianza, tratta dall'inizio del suo Commento a Matteo e che conosciamo in greco da Eusebio (Hist.Eccl. VI,25,3-6): Nel primo dei Commenti al Vangelo secondo Matteo, conservando il canone ecclesiastico, (Origene) testimonia di conoscere solo quattro Vangeli, scrivendo così: «Ho appreso dalla tradizione relativa ai quattro Vangeli, che sono anche i soli non contestati nella Chiesa di Dio diffusa sulla terra, che per primo è stato scritto il Vangelo secondo quel Matteo che un tempo fu pubblicano e poi divenne discepolo di Gesù Cristo, e lo pubblicò per i fedeli provenienti dal giudaismo, dopo averlo composto in lingua ebraica; poi il Vangelo secondo Marco, che fece come Pietro gli indicò e che da lui fu riconosciuto come figlio nella lettera cattolica in questi termini: "Vi saluta la chiesa eletta che dimora in Babilonia e Marco, mio figlio" (1 Pt. 5,13). E terzo fu il Vangelo secondo Luca, che scrisse il Vangelo approvato da Paolo per coloro che provenivano dalle genti. Dopo tutti viene il Vangelo secondo Giovanni». Qui abbiamo quell'ordine dei Vangeli che resterà canonico (e che già era presente nel Canone Muratoriano, ma varia da quello presentato da Clemente, che poneva all'inizio Matteo e Luca). La notizia su Marco è nel solco di Papia, ma forse anche di Clemente. In ogni caso Origene esplicita il collegamento tra l'evangelista e il Marco della Prima lettera di Pietro, che già doveva essere di Clemente, perché questi parlava dell'evangelista Marco commentando 1 Pt 5,13, come abbiamo visto. Questo collegamento sarà ripreso da Eusebio alla fine della testimonianza di Clemente sopra riportata come seconda (II,15,2). 1.2.8. Eusebio di Cesarea Eusebio nella Storia ecclesiastica (fine del III-inizio del IV sec.) si attiene alla tradizione di Papia, Ireneo, Clemente, Origene, di cui riporta i passi salienti. Di suo, aggiunge due informazioni (si veda il testo nell'All. 6) molto dubbie che creeranno confusione nella tradizione successiva: La prima (Hist.Eccl. II,16,1) è che Marco sarebbe stato mandato in Egitto a predicarvi il Vangelo, che già aveva scritto, e qui avrebbe fondato chiese ad Alessandria. In seguito (seconda metà del IV sec.) Giovanni Crisostomo crederà che Marco avesse scritto il Vangelo ad Alessandria; ed Epifanio, cercherà di combinare questa con le altre informazioni dicendo che Marco sarebbe stato mandato da Pietro in Egitto, dopo aver scritto il Vangelo. La notizia ha scarse

19
probabilità di essere autentica, dato che proprio gli autori alessandrini (Clemente, Dionigi, Origene) non ne parlano. La seconda (Hist.Eccl. II,24: vedi All. 6) è che il successore di Marco nell'episcopato ad Alessandria avrebbe iniziato il ministero nell'ottavo anno di Nerone (il quale regnò dal 54 al 68, e quindi l'anno sarebbe il 62), il che dovrebbe significare anche (e fu inteso nel senso) che in quell'anno Marco sarebbe morto. Ma il dato non si concilia con le altre notizie sul rapporto con Pietro (e Paolo) a Roma, perché il 62 è anteriore all'anno della morte dei due apostoli, avvenuta secondo la tradizione (cfr. Lettera di Clemente Romano ai Corinzi, del 96) durante la persecuzione di Nerone (tra 64 e 68). Tuttavia Gerolamo lo riprenderà e lo tramanderà nella scheda dedicata a Marco nel suo trattato De viris illustribus, proprio come dato relativo alla morte di lui (cfr. De vir.ill. 8). Di qui deriva la tradizione che è alle origini della Basilica di S. Marco a Venezia: i Veneziani nell'828 avrebbero trafugato ad Alessandria le reliquie di S. Marco e le avrebbero portate a Venezia: per custodirle avrebbero quindi edificato la Basilica intitolata a lui 25. 1.2.9. Gerolamo In effetti Gerolamo, che conosceva la Storia ecclesiastica di Eusebio e tutte le testimonianze ivi raccolte, nella sua notizia su Marco del De viris illustribus (cap. 8: il testo è nell'All. 6), opera composta intorno al 393, fa una sorta di centone di tutte le informazioni della tradizione: presenta Marco come discipulus et interpres di Pietro, dice che scrisse il Vangelo richiesto dai fedeli di Roma e ricevendone l'approvazione di Pietro, richiamandosi esplicitamente a Papia e Clemente Alessandrino. Fa riferimento al Marco della Prima lettera di Pietro, come Clemente e Origene. Riporta le notizie di Eusebio sull'attività di Marco in Egitto e sull'anno della morte. La sua trattazione ha carattere erudito e corrisponde allo scopo dell'opera di illustrare le grandi personalità della letteratura cristiana, da segnalare agli intellettuali e dotti pagani che in genere accusavano i cristiani di incultura. Ma può essere significativo il fatto che egli collochi Marco, non solo dopo Matteo (trattato al cap. 3), ma anche dopo Luca (cap. 7); subito dopo Marco c'è Giovanni (cap. 9). Ricordiamo inoltre il particolare, a cui già abbiamo accennato parlando di Ireneo, che Gerolamo nella sua revisione del Commento all'Apocalisse di Vittorino di Petovio (o Pettau), aveva associato il Vangelo di Marco al leone, e non più all'aquila, come ancora faceva Vittorino. Il suo apprezzamento del Vangelo di Marco non doveva essere troppo alto. 1.2.10. Agostino Ma la posizione più negativa sul Vangelo di Marco viene espressa da Agostino, nel De consensu evangelistarum, opera scritta verso il 400, per
25 Cfr. Uricchio-Stano, Vangelo secondo San Marco, cit., p.3 n.5.

20
dibattere sistematicamente le questioni relative alle discordanze tra i quattro i Vangeli e dimostrare il loro sostanziale accordo. I passi più pertinenti sono tre, tutti tratti dal I libro (si veda l'All. 7). Nel primo passo (I,2,3) possiamo constatare che Agostino riprende alcune idee di Ireneo e le condivide: quella che i Vangeli debbano essere quattro e il valore simbolico attribuito a questo numero (i quattro angoli della terra, ossia tutta la terra): parla in particolare dell'estensione della Chiesa su tutta la terra. Conferma anche l'ordine Mt-Mc-Lc-Gv, ma distingue il momento della composizione dei Vangeli, a cui si riferisce tale successione, da quello della conoscenza dell'insegnamento di Gesù e della predicazione operata per incarico del Signore: da questo secondo punto di vista la priorità è di Matteo e di Giovanni, che furono testimoni diretti e apostoli. Gli altri due, che non hanno questi caratteri, stanno in mezzo e vengono come protetti dagli altri due: sono dunque inferiori. Nel secondo passo (I,2,4) nota che ogni vangelo ha caratteristiche proprie e lo attribuisce al fatto che, oltre all'ispirazione, è intervenuto anche un apporto personale degli evangelisti. In particolare osserva che ciascuno sembra seguire un proprio ordine, ma presuppone anche che ciascuno abbia conosciuto i predecessori. Definisce alcuni caratteri peculiari dei diversi Vangeli e si distingue subito da Ireneo, perché per Matteo, pur prendendo in considerazione la genealogia con cui inizia e l'interesse per la vita umana di Gesù, individua nella genealogia come aspetto tipico il fatto che viene messa in evidenza la discendenza regale di Gesù. Marco viene invece chiaramente svalutato perché è subito definito pedisequus et breviator (valletto e compendiatore) di Matteo, si notano la differenza totale rispetto a Giovanni e quella quasi totale rispetto a Luca, mentre si rilevano le somiglianze strette con Matteo. In sostanza non viene riconosciuto nessun tratto specifico a Marco. Per Luca viene ripresa l'opinione di Ireneo (carattere sacerdotale), ma a partire dalla sua genealogia. Nel terzo passo (I,6,9) Agostino discute esplicitamente l'attribuzione dei simboli agli evangelisti e contesta le attribuzioni fatte da Ireneo, senza nominarlo (uomo-Mt, aquila-Mc, vitello-Lc, leone-Gv), mentre esprime la sua preferenza per altre associazioni: leone-Mt, uomo-Mc, vitello-Lc, aquila-Gv. Si tratta però di una sistemazione che non coincide neppure con quella di Gerolamo, che collegava il leone a Marco e l'uomo a Matteo. Non è altrimenti attestata e si vede comunque che corrisponde al parere di Agostino, il quale, non solo vuole mettere sul gradino più alto Giovanni, ma vuole anche anteporre Matteo a Marco. Insiste infatti a dimostrare che il leone è pertinente a Matteo, che anche nell'episodio dei Magi parla di Gesù bambino come re, mentre Marco non parlerebbe né della stirpe regale di Gesù (come Matteo), né della consacrazione sacerdotale (come Luca), ma "appare occuparsi delle cose compiute da Cristo come uomo", e perciò a lui spetterebbe il simbolo dell'uomo, che risulta il più basso. Del resto tutti e tre i primi Vangeli rimangono fermi agli eventi relativi al Gesù incarnato, e questo fatto sarebbe ben espresso da simboli legati alla terra (leone, uomo, vitello), mentre a

21
Giovanni, che vola alto nella sua capacità di penetrare nella luce della verità, si addice il simbolo dell'aquila. Come si vede, con Agostino abbiamo un netto rovesciamento della posizione di Ireneo e della valutazione del Vangelo di Marco: dal più importante dei Vangeli al meno importante. 1.2.11. Conclusione sul Vangelo di Marco nell'antichità Dalle testimonianze esaminate si evince che il Vangelo di Marco presentò alcune difficoltà ai primi cristiani: innanzitutto il fatto che l'autore a cui veniva attribuito non facesse parte della lista degli apostoli, ovvero dei testimoni diretti di Gesù, e inoltre alcune difficoltà inerenti ai caratteri del Vangelo stesso. Alla prima difficoltà si ovviò presto attraverso lo stretto collegamento con Pietro, che la tradizione ha via via rafforzato: il Vangelo sarebbe la pura trascrizione della predicazione di Pietro e Pietro lo avrebbe approvato espressamente. Questa convinzione consentì al Vangelo di essere inserito tra i Vangeli "canonici" senza discussione, di essere letto ufficialmente nelle assemblee liturgiche, di essere considerato conforme alla dottrina "ortodossa", di essere utilizzato nelle "armonie evangeliche". Marco sarebbe stato successivo a Matteo e dipendente da lui. Alcune notizie leggendarie, come quella della predicazione ad Alessandria di Egitto e dell'episcopato, tendono a noblitare la figura di Marco, mentre più oscure, ma forse ancora in funzione positiva, potrebbero essere altre tradizioni, come quella dell'avere "le dita mozze" (origine levitica o sacerdotale?). Il Vangelo stesso sembra aver suscitato, nel confronto con gli altri Vangeli, riserve a proposito di una sua incompletezza e di un certo disordine. Ma su questo punto appaiono opposte le valutazioni di Ireneo e di Agostino: il primo vede in questo Vangelo, anche nella sua brevità, un carattere profetico e spirituale, che ne fa il Vangelo più elevato (di qui il simbolo dell'aquila); il secondo, accentuando una tendenza già presente nell'ambiente alessandrino e in Gerolamo (preferenza per il Vangelo di Giovanni, a cui viene trasferito il simbolo dell'aquila), non trova in Marco nulla di originale rispetto a Matteo e vuole degradarlo ulteriormente dando a lui il simbolo dell'uomo, a Matteo quello del leone. Il fatto che il Vangelo di Marco non sia stato quasi mai commentato autonomamente nella fase in cui i Padri della Chiesa elaborano commenti scritti ai libri del NT (a partire dall'inizio del III sec.) conferma che non gli veniva conferito un messaggio particolare e rilevante. 2. Il Vangelo di Marco nella ricerca moderna Nota biliografica Per questa parte fornisce indicazioni soprattutto il commento di Taylor, Marco, che dedica il cap.II dell'Introduzione (pp.9-25) a "La storia del Vangelo nella critica moderna" e

22
inoltre esamina ancora gli studi antecedenti a proposito del capitolo su "Le fonti di Marco" (pp.34-45). Uricchio e Stano nel loro commento (Vangelo secondo San Marco) presentano nel cap.8 dell'Introduzione (pp.127-133) un "Panorama degli studi esegetici su Mc", ma lo suddividono, poco opportunamente, in Esegesi acattolica ed Esegesi cattolica. Una presentazione recente dei vari metodi di studio si trova nell'opuscolo della Pontificia Commissione Biblica, L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Città del Vaticano 1993. Utile, non solo per le informazioni, ma anche per l'esemplificazione metodologica del metodo storico-critico, il volume di H. Zimmermann, Metodologia del Nuovo Testamento. Esposizione del metodo storico-critico, tr.it., Torino, Marietti, 1971 (ed.orig. Stuttgart 1967). La ricerca moderna ha elaborato nel tempo una serie di metodi per leggere, studiare e interpretare i libri biblici. Il metodo che ha avuto il maggiore peso è stato il metodo storico-critico, ma più recentemente sono state applicate anche nuove metodologie attinte ai diversi ambiti scientifici. Di volta in volta verificheremo quali acquisizioni siano derivate per lo studio del Vangelo di Marco dall'applicazione dei vari metodi. In generale possiamo però già dire che il Vangelo di Marco ha tratto notevole giovamento dagli studi moderni, chi quali, rovesciando la situazione dei tempi antichi, lo hanno privilegiato rispetto agli altri Vangeli. 2.1. Il Vangelo di Marco e il metodo storico-critico Il metodo storico-critico, così come è conosciuto e usato oggi, si è costituito nel tempo, a tappe progressive. Il suo carattere specifico è quello di trattare i libri biblici secondo gli stessi criteri adottati per i documenti e le opere antiche: prescinde dalla loro natura di "libri sacri", non dà per scontate le opinioni trasmesse dalla tradizione (su autori, date, ecc.), ma le sottopone a verifica e le rifiuta nel caso che risultino non confermate da criteri scientifici; ne analizza l'origine, la composizione, le finalità, collocandoli nel loro contesto storico. Per questo il metodo ha incontrato difficoltà in ambienti di fede, di più nell'ambito cattolico rispetto a quello protestante: si temeva che venissero indeboliti o messi in discussione l'autorità e il carattere ispirato dei libri. Tuttavia è stato, seppure tardi, accettato e convalidato anche dal magistero cattolico, almeno a partire dall'enciclica Divino afflante Spiritu del 1943 e dalla costituzione Dei Verbum del Concilio Vaticano II (1966). Il principale merito che gli viene riconosciuto è quello di contrastare le letture letterali o fondamentaliste, che possono portare a gravi pericoli dottrinali. Il metodo storico-critico, innanzitutto, presta attenzione al testo di ogni libro biblico e cerca di ricostruire la forma più attendibile sulla base dell'esame sistematico della tradizione manoscritta pervenuta e della scelta ponderata tra le varianti presenti nelle diverse copie esistenti. A partire dalla metà del 1800 nasce la "Critica testuale" neotestamentaria fondata su criteri scientifici moderni. 26
26 Sulla Critica testuale in rapporto al Vangelo di Marco ci soffermeremo nella seconda parte.

23
Un altro ambito in cui opera il metodo è, come si è detto, quello delle notizie riportate dalla tradizione su autori e libri biblici, per discuterne l'attendibilità e tentare di stabilire in modo più solido autenticità dei libri, paternità, datazione, ecc. Il metodo affronta anche altri aspetti storici pertinenti ai contenuti e di chiarire il contesto storico ("Analisi storica"). Ricerca le fonti dei vari libri e gli eventuali rapporti reciproci tra i libri stessi (si parla di "Critica delle fonti"): nasce, come vedremo, una questione specifica sui rapporti tra i Vangeli, ovvero la "questione sinottica" (che riguarda Matteo, Marco, Luca, in quanto sono più simili e, se trascritti in colonne parallele, li si può abbracciare in una synopsis, ossia in una "visione d'insieme"). Analizza le unità letterarie isolabili nei libri e cerca di ricostruire per ciascuna le origini e gli sviluppi avvenuti durante la trasmissione orale e scritta, nonché le modifiche subite al momento in cui è stata inserita nell'attuale contesto letterario ("Storia delle forme"). Si sofferma anche sugli specifici interventi del redattore finale di ogni libro (che coincide per i Vangeli con l'evangelista) e tenta di definire le tendenze soggiacenti al suo lavoro redazionale ("Storia della redazione"). 2.1.1. L'Analisi storica e la valutazione moderna delle testimonianze antiche: le questioni relative ad autore, luogo e data del Vangelo Partiamo da alcune questioni affrontate dall'Analisi storica a proposito delle testimonianze antiche su Marco Sulla valutazione della testimonianza di Papia, che è quella fondamentale per tutta la tradizione antica su Marco, possiamo dire che non c'è accordo tra gli studiosi. C'è chi tende a svalutare del tutto l'affidabilità di Papia, per il fatto che riporta, come risulta da Eusebio, anche notizie leggendarie 27, o perché si attiene troppo alla tradizione orale 28, o perché appare troppo condizionato dallo scopo apologetico 29. L'unico dato che viene accettato comunque è che il nome dell'evangelista fosse effettivamente Marco 30 e che si tratti di una figura secondaria non altrimenti nota. Tuttavia la maggior parte degli studiosi propende per accettare la validità della testimonianza di Papia, almeno per quanto riguarda l'identità di Marco e il suo stretto rapporto con Pietro, eventuamente anche per l'origine romana del Vangelo. Anzi, si ricercano ulteriori elementi che la comprovino. 2.1.1.1. L'identità di Marco
27 Cfr. Schweizer, Il Vangelo secondo Marco, cit., p.26. 28 Cfr. R.M. Grant, La formation du Nouveau Testament, tr.fr., Paris 1969, p.72. 29 Cfr. Pesch, Il Vangelo di Marco, cit., p.41.; J. Ernst, Il Vangelo secondo Marco, tr.it., I, Brescia, Morcelliana, 1991 (ed.orig. Regensburg 1981), p.30; J. Gnilka, Marco, tr.it., Assisi, Cittadella, 1987(ed.orig. Zürich 1978-1979), p.28. 30 Il Vangelo in origine non riportava il nome dell'autore, così come del resto gli altri Vangeli.

24
In base ai dati esterni, provenienti da altri scritti del Nuovo Testamento, alcuni ritengono di poter identificare questo Marco con il Giovanni Marco, o semplicemente Marco o semplicemente Giovanni, più volte menzionato negli Atti degli Apostoli e in lettere di Paolo (Marco risulterebbe quindi il prenome latino di un giudeo di nome Giovanni). Anzi, da questi cenni si traggono elementi per ricostruire una vera e propria "vita" di Marco 31: In Atti 12,12 si racconta che Pietro, dopo essere uscito di prigione a Gerusalemme, si recò alla casa di Maria, "la madre di Giovanni chiamato Marco, dove erano radunati in preghiera un buon numero di persone". Di qui si ricaverebbe che Marco doveva essere un personaggio ben noto e di famiglia benestante, dato che la sua casa era abbastanza grande per ospitare le riunioni della comunità cristiana. Le altre informazioni desumibili dagli Atti e dalle lettere di Paolo, fanno pensare che Marco fosse cugino di Barnaba (Col 4,10) e avesse partecipato per un periodo all'attività missionaria di Paolo e Barnaba come loro "aiutante", durante un viaggio in Asia Minore (At 12,25; 13,5). Ma a Perge, in Panfilia, Giovanni Marco li lasciò e ritornò a Gerusalemme (At 13,13). Questo abbandono dovette irritare profondamente Paolo, tanto che, quando decise di intraprendere con Barnaba un secondo viaggio missionario e questi voleva ancora portare con sé Giovanni Marco, Paolo entrò in dissidio aperto con Barnaba e preferì separarsi anche da lui: si scelse un altro collaboratore, mentre Barnaba partì per diversa meta col cugino (Atti 15,36-41). Se si tratta sempre del medesimo Marco, si può supporre che Paolo si fosse riconciliato poi con lui, dato che in alcune lettere scritte durante la prigionia (a Roma?) lo menziona come collaboratore al suo fianco (Col 4,10; Fm 24) e, più tardi, in 2 Tm 4,11, quando Marco non si trova più accanto a lui, chiede al destinatario (che forse è a Efeso) di condurglielo. Sicché si dovrebbe dedurre che Marco sia stato prima in contatto con Pietro a Gerusalemme, poi con Paolo e infine ancora con Pietro. Il che non manca di suscitare alcune perplessità. Tuttavia, resta predominante il rapporto con Pietro, tanto che si parla del Vangelo di Marco come di "vangelo di Pietro". E si cercano anche elementi interni al testo a favore di questo rapporto. Tra i dati interni al testo che potrebbero avvalorare la tradizione del rapporto di discepolato tra Marco e Pietro si adducono il rilievo dato alla figura di Pietro in molti casi, ma anche, talora, il fatto che proprio Pietro nel Vangelo di Marco non di rado faccia una "brutta figura" (indizio dell'umiltà di Pietro stesso!); la vivacità descrittiva di molti episodi che presupporrebbe il racconto di un testimone oculare, perfino la "spontaneità dello stile", ecc. Ma non sono in realtà elementi determinanti, perché non si può dimostrare che Pietro abbia nel Vangelo di Marco un ruolo maggiore rispetto agli altri Vangeli, anzi: sono omessi alcuni episodi importanti, come il primato di Pietro (cfr. Mt 16,17-19). La ricerca, poi, nel Vangelo, di tracce di una "teologia petrina", così come di una "teologia paolina", non dà poi frutto, anche perché una "teologia petrina" non esiste e le eventuali affinità con la teologia di Paolo, che invece conosciamo, si limitano a concetti non caratteristici. In vari casi sembrerebbe che l'autore del Vangelo non conoscesse esattamente i luoghi della Palestina (cfr. 7,31; 8,10; 10,1), fatto che contrasterebbe con l'ipotesi che i racconti provenissero da un testimone come Pietro. In ogni caso, quand'anche Marco avesse effettivamente attinto ai ricordi di Pietro, oggi si tende a pensare che non siano questi l'unica fonte utilizzata da
31 Cfr. in particolare Uricchio-Stano, Vangelo secondo Marco, cit., pp.1-4, paragrafo intitolato: "Cenni biografici su Marco".

25
lui, sebbene, essendo il suo il primo Vangelo (come oggi viene riconosciuto) e non avendo quindi termini di confronto, sia difficile sceverare nel Vangelo le diverse possibili fonti. Qualcuno ha supposto che Marco sia stato presente ad alcuni fatti della vita di Gesù e che parli di se stesso quando riporta lo strano episodio, non ripreso dagli altri Vangeli, del giovinetto che al momento dell'arresto di Gesù prima si mette al suo seguito avvolto in un lenzuolo, poi fugge nudo (Mc 14,51-52). Ma si tratta di un'ipotesi priva di fondamento e del tutto improbabile 32. 2.1.1.2. Luogo di composizione del Vangelo e destinatari Per quanto riguarda l'ambientazione a Roma del Vangelo, affermata da molte testimonianze antiche, le conferme interne al testo potrebbero essere: - i latinismi 33, più frequenti in Marco che non in Matteo e in Luca; - certe spiegazioni di costumi ebraici (cfr. 7,1-3: l'usanza di purificarsi di ritorno dal mercato, prima di mangiare, ecc.), che fanno presupporre un pubblico non famigliare con essi; - la spiegazione di termini aramaici, anch'essi molto frequenti (cfr. 5,41: talithà kum, "ragazza, àlzati"; 7,34: effathà, "apriti"); Si pensa normalmente che il Vangelo di Marco, a differenza di quello di Matteo, più nettamente di carattere giudaico, si rivolgesse a fedeli di provenienza pagana. Tuttavia, neppure questi elementi sono univoci: ad es., i latinismi, in quanto termini tecnici del gergo militare, giuridico ed economico erano diffusi in tutto l'impero romano. Alcuni studiosi pensano alla Siria come luogo di composizione, per il rilievo che questa regione, e Antiochia in particolare, hanno avuto nei primi temoi del cristianesimo, e in particolare per la missione ai pagani. 2.1.1.3. Data di composizione del Vangelo Per quanto riguarda la data, di solito, più che sulle indicazioni della tradizione, ci si basa su elementi interni al testo, e principalmente sul discorso escatologico (cap.13), in cui c'è la predizione della distruzione del Tempio (13,2), che viene messa in rapporto con il fatto storico della caduta di Gerusalemme avvenuta nel 70. Poiché la profezia in Marco appare più generica (cfr. anche 13,14), rispetto a quella di Matteo (cfr. 24,15) e Luca (cfr. 21,20), si ritiene per lo più che la composizione del Vangelo sia anteriore al 70, con vari tentativi di precisazione. In genere si pensa a una data di poco anteriore al 70 (tra il 65 e il 70): i riferimenti alle guerre di 13,7-8 talora sono collegati con le
32 Su questo episodio cfr. il mio articolo L'arresto di Gesù nel Vangelo di Marco (Mc14,43-52), in "Rivista Biblica" 35 (1987), pp.257-282. 33 Cfr. kenturivwn , trasl. kenturìon (lat. centurio), dhnavrion, trasl. denàrion (lat. denarius), legiwvn, trasl. legiòn (lat. legio), praitwvrion, trasl. praitòrion (lat. praetorium); costrutti latinizzanti. Notevole è il fatto che talora il redattore spiega un termine greco con un latinismo (in 12,42 spiega leptav, trasl. leptà ("spiccioli"), con kodravnth", trasl. kodràntes (lat. quadrans), "quattrino"; in 15,16 spiega aujlhv, trasl. aulè, "cortile", con praitwvrion, trasl. praitòrion (lat. praetorium), "pretorio".

26
prime fasi della guerra giudaica (che iniziò nel 66), talora con i disordini politici successivi al 68 (morte di Nerone). Questa data si concilierebbe con la notizia della tradizione per cui Marco avrebbe scritto dopo la morte di Pietro. Altri studiosi pensano invece a una data posteriore al 70 e alla distruzione del Tempio, che comportò la dispersione e lo smarrimento della comunità ebraica (cfr. 13,14). Ma in tempi recenti da più parti si è tentato di rivedere, ed anticipare, la datazione dei Vangeli, e in specie del Vangelo di Marco, sulla base di alcuni argomenti: la scoperta di papiri presunti di Mt e Mc che sarebbero anteriori al 68; l'ipotesi che Mt e Mc siano traduzioni di Vangeli precedenti scritti in ebraico. Per quanto riguarda la scoperta di papiri, abbiamo avuto negli anni '70 gli studi di J. O' Callaghan su un frammento papiraceo rinvenuto in una grotta di Qumran (scoperta nel 1947), la settima grotta (donde la sigla di 7Q5 per il frammento): lo studioso arrivò ad identificare il passo riportato (in tutto neanche una ventina di lettere disposte su cinque righe) con Mc 6,52-53 34 e, in base al fatto che la grotta dovrebbe essere stata chiusa nel 68 (nel periodo della guerra giudaica), suppose che il Vangelo di Marco fosse stato composto anteriormente. Anzi, la forma della scrittura, attestata in altri documenti databili tra il 50 a.C. e il 50 d.C., induceva ad anticipare a prima del 50. Fece molto scalpore questa datazione, che contraddiceva l'opinione dominante, ma anche il fatto che in queste grotte, dove si sono trovati scritti giudaici e veterotestamentari, e che sono state collegate con una comunità essena, risultasse presente uno scritto cristiano. Se ne discusse molto e ancora se ne discute. Contro queste ipotesi sono però state sollevate obiezioni, che mettono in dubbio sia l'identificazione stessa del frammento 7Q5 col passo di Mc (sono molto poche le lettere di lettura sicura, quasi soltanto kaiv, trasl. kài, "e"), sia la datazione della scrittura (potrebbe essere stata usata anche dopo il 50), sia il fatto che la grotta sia stata effettivamente chiusa nel 68 e non più utilizzata: esistono indizi di una sua utilizzazione posteriore, e inoltre questa grotta presenta troppe peculiarità rispetto alle altre: contiene solo frammenti greci, mentre tutte le altre contengono testi in ebraico.35
Si può anche menzionare le tesi di J. Carmignac, che rivaluta le testimonianze antiche, in particolare quella di Papia. Nel suo studio del 1984 su
34 Si veda in allegato (All. 8) la fotocopia della p. 35 del manuale di A. Passoni dell'Acqua, Il testo del NT, Leumann (To), LDC, 1994, dove viene riprodotto, in trascrizione, il testo del frammento e a fianco la ricostruzione del passo di Mc. 35 Per una breve rassegna dei problemi e delle soluzioni intorno a 7Q5 cfr. G. Ghiberti, Marco a Qumran?, in «Parole di vita» 37 (1992), n.2, pp.126-132. Per una critica delle tesi di Thiede cfr. G. Ravasi, Matteo fu davvero testimone oculare?, in «Il Sole 24 ore. Domenica» 2.6.1996, p.21. Sull'argomento si veda inoltre la recente raccolta di studi dedicata appunto a "Il Vangelo di Marco e Qumran" in Marco e il suo Vangelo. Atti del Convegno internazionale di studi "Il vangelo di Marco". Venezia, 30-31 maggio 1995, a cura di L. Cilia, Cinisello Balsamo (Milano), San Paolo, 1997, pp.117-156, con contributi di J. O'Callaghan, C.P. Thiede, G. Ghiberti, J. Carrón e J.G. Núñez.

27
La nascita dei Vangeli sinottici, 36 egli arriva alle seguenti conclusioni (pp.103-104): - è certo che Marco, Matteo e i documenti utilizzati da Luca sono stati redatti in una lingua semitica (probabilmente l'ebraico e non l'aramaico); - è molto probabile che il nostro Vangelo di Marco sia stato composto in lingua semitica dall'apostolo Pietro;37
- è possibile che l'apostolo Matteo abbia redatto una raccolta di discorsi utilizzata dagli evangelisti Matteo e Luca; - la redazione greca del Vangelo di Luca è verosimilmente da collocare intorno al 58-60, quella semitica di Matteo nello stesso periodo, quella semitica di Marco intorno al 50; - ma, se si può riferire a Luca (come fanno alcuni antichi) l'accenno di 2 Cor 8,18-19 al "fratello, la cui lode, a motivo del vangelo, è diffusa in tutte le chiese" e che viene designato ad accompagnare Paolo nel suo viaggio, intendendo che Paolo pensi al Vangelo scritto, e non solo a quello predicato, allora la redazione di Luca risalirebbe al 50-53, 38 e lì vicino quella definitiva di Matteo, mentre il Marco semitico si collocherebbe nel 42-45; - il Vangelo semitico di Pietro sarebbe stato tradotto in greco da Marco, a Roma, verso il 63 (Carmignac interpreta in questo modo la notizia di Papia sopra analizzata); - è verosimile che il traduttore greco di Mt abbia utilizzato Lc. Ma tutte queste ipotesi non hanno finora potuto scalzare le tesi più tradizionali e rimangono pure ipotesi. Una confutazione sistematica di queste tesi, con rilettura di tutta la documentazione, è stata elaborata da P. Grelot e pubblicata in italiano nel 1989.39
2.1.1.4. Altri aspetti dell'Analisi storica: problemi storici e linguistici L'Analisi storica indaga inoltre questioni che riguardano la storicità di fatti, luoghi e personaggi menzionati nel Vangeli, a partire dalla questione del "Gesù storico", ossia di quanto si può ritenere più attendibile tra le notizie che vengono riportate su di lui. 40 In particolare si confrontano i dati relativi al
36 J. Carmignac, La nascita dei Vangeli sinottici, tr. it., Milano, Ed. Paoline, 1986 (ed.orig. Paris 1984), in particolare pp. 61 ss. 37 A proposito dei Vangeli di Mt e Mc Carmignac (insieme ad altri) utilizza la presenza di semitismi, ossia di costrutti che non appartengono alla lingua greca, ma risentono della struttura della lingua ebraica, per dedurne l'ipotesi che si tratti di traduzioni dall'ebraico o dell'aramaico. Ma la presenza dei semitismi può essere spiegata anche in altri modi: come traccia del fatto che l'autore ha l'aramaico come lingua madre; come risultato di una cosciente imitazione dello stile della traduzione dei Settanta, che ricalca volutamente l'ebraico, per fedeltà al testo sacro. 38 La II Lettera ai Corinzi dovrebbe essere stata composta verso il 57. Tutte le lettere autentiche (e 1 Cor è tra queste) sono databili tra il 50 e il 58. 39 P. Grelot, L'origine dei Vangeli. Controversia con J. Carmignac, Città del Vaticano, Libreria ed. Vaticana, 1989. 40 Su tale questione, tra gli studi più recenti si possono citare: G. Theissen, Il Gesù storico. Un manuale, tr. it., Brescia, Queriniana, 1999 (ed. orig. Göttingen 19992); G. Barbaglio, Gesù ebreo di

28
racconto della passione che vengono riportati da Marco e dagli altri due sinottici (Matteo e Luca), con quelli, discordanti, riportati da Giovanni: è noto che secondo i primi Gesù sarebbe morto il giorno della Pasqua ebraica, mentre secondo Giovanni alla vigilia. Anche l'esposizione marciana dei processi nel sinedrio e davanti a Pilato solleva numerose difficoltà dal punto di vista storico. Il Vangelo di Marco, insieme agli altri due sinottici, viene ampiamente utilizzato per ricostruire il contesto giudaico a cui Gesù apparteneva e in cui ha operato. Certamente questo metodo spinge a informarsi adeguatamente per capire i numerosi riferimenti a istituzioni giudaiche contenute nel Vangelo. Ad es., in Mc 7,11-12, all'interno della polemica con scribi e farisei sul puro e sull'impuro, Gesù osserva: "Voi andate dicendo: Se qualcuno dice al padre o alla madre: 'Quanto tu potresti avere come sostegno da me sia invece qorban', vale a dire, dedicato a Dio, non concedete loro alcuna possibilità di fare alcunché per il padre e la madre". Ma a quale usanza fa riferimento? Quale logica sta dietro queste espressioni? Per capire il ritratto che Mc fa di Gesù e del suo comportamento qui, occorre prendere in considerazione tali questioni e altre analoghe.41 Qorban è una formula di giuramento con cui un individuo, secondo un'istituzione giudaica, dichiarava dono sacro a Dio un bene di sua proprietà, e in questo modo lo sottraeva al diritto di usufrutto che avevano i suoi genitori; poteva dar luogo ad abusi per aggirare l'obbligo di assistenza nei loro confronti. La Critica storica si è talora inaridita nella ricerca della documentazione, delle fonti e delle circostanze storiche, trascurando il messaggio teologico. Va quindi utilizzata senza perdere di vista l'obiettivo che è quello di spiegare il testo. Molti e minuziosi sono gli studi sulla lingua usata da Marco, con le sue peculiarità, a cui già abbiamo accennato: latinismi, semitismi. Vengono rilevate e classificate tutte le particolarità: ad es., è riconosciuta la preferenza di questo evangelista per una lingua vicina a quella parlata, con prevalenza della paratassi ("e...e...e") rispetto alla subordinazione, del presente storico rispetto ai tempi del passato, con frequenti ripetizioni di vocaboli generici ("dice...dice...dice", "allora...allora", "subito"), uso di pronomi al posto dei nomi propri od omissione del soggetto, uso di diminutivi, ecc. 2.1.1.5. Un esempio di applicazione dell'Analisi storica: la chiamata di Levi e il banchetto coi pubblicani(Mc 2,13-17) Nell'episodio della chiamata di Levi (Mc 2,13-17: si veda l'All. 9) Gesù chiama al suo seguito un pubblicano e successivamente, partecipando a un banchetto insieme a numerosi pubblicani e peccatori, viene attaccato da alcuni scribi dei farisei. Le nozioni che devono essere tenute presenti riguardano, da una parte, il discredito che colpiva nella società giudaica i pubblicani, ovvero
Galilea. Indagine storica, Bologna, EDB, 2002. 41 Cfr. Brown, Introduzione al NT, cit., pp. 57, 75 ss.

29
gli esattori delle imposte, da una parte, e le posizioni dei farisei e degli scribi, che facevano invece parte delle autorità religiose, dall'altra, nonché le concezioni sul puro e sull'impuro che regolavano la vita del pio giudeo e i suoi rapporti con gli altri. I "pubblicani" erano malvisti, non solo perché, avendo appaltato la riscossione delle imposte, tendevano ad approfittarne a proprio vantaggio, e quindi potevano essere considerati degli strozzini e dei ladri, ma anche perché, per i loro contatti con monete e persone non giudee, erano più facilmente "impuri". Anche la categoria dei "peccatori" comprendeva tutti coloro che non erano osservanti della Legge e delle norme di purità. Viceversa, gli scribi erano gli esperti e i tutori della Legge e i farisei si atteggiavano a giudei particolarmente rigorosi nell'osservanza. La condivisione della mensa era un momento molto delicato e foriero di discriminazioni, proprio perché esistevano norme precise sui cibi puri e impuri e sulla necessità di praticare i precetti di purificazione prima di andare a tavola (cfr. Mc 7,2-5): chi aveva contatti con persone impure si contaminava automaticamente. Per rendersi meglio conto dell'importanza della questione, che è perdurata anche nella comunità cristiana primitiva, si tenga presente l'episodio del centurione Cornelio negli Atti degli apostoli, capp. 10-11, dove sorgono problemi e polemiche a proposito del fatto che un cristiano di origine giudaica (nel caso specifico l'apostolo Pietro) fosse entrato in casa di pagani e avesse mangiato con loro. Bisogna però evitare eccessi di erudizione in cui talora incorrono gli studiosi, i quali si concentrano su singole questioni, dimenticando che lo scopo principale di queste indagini è quello di fornire elementi utili alla comprensione del testo. Nel caso del brano in oggetto, ad esempio, il commento di Taylor dedica ampio spazio al problema dell'identificazione di "Levi, figlio di Alfeo" e del suo rapporto con gli apostoli; al significato e all'uso dei termini aJmartwlov", trasl. hamartolòs, "peccatore", e maqhthv", trasl. mathetès, "discepolo"; alla spiegazione di chi fossero i farisei (compresa l'etimologia del termine). Ancora più ridondante, quando non farraginoso, è il commento di Uricchio e Stano, che, oltre a tutte queste cose, si preoccupano anche di precisare in quale luogo potrebbe essere avvenuto l'incontro con Levi; per quanto riguarda il patronimico "figlio di Alfeo", cercano quale potrebbe essere il corrispondente ebraico di Alfeo; ecc. 2.1.2. La Critica delle fonti e la priorità di Marco rispetto agli altri Vangeli La fortuna del Vangelo di Marco, almeno in rapporto alle opinioni che sono prevalse a partire dal IV sec., e in specie da Agostino, si è rovesciata a partire dal XIX secolo, da quando cioè la critica moderna ha aderito alla tesi della priorità cronologica di questo Vangelo rispetto agli altri. Ha spinto a questa conclusione il confronto tra i quattro Vangeli, da cui emergono immediatamente la differenza tra quello di Giovanni, ritenuto già nell'antichità più tardo rispetto agli altri, e le somiglianze più strette tra gli altri Vangeli, detti sinottici, perché, posti su colonne parallele, mostrano di poter essere abbracciati in una visione di insieme (synopsis). Accanto alle somiglianze il confronto consente di riconoscere che tra Matteo, Marco e Luca esistono anche differenze. In comune hanno uno schema di base che va dal racconto del

30
battesimo di Gesù fino alla tomba vuota e che comprende una prima fase di attività missionaria (predicazione, miracoli, dispute) in Galilea, seguita da spostamenti fuori dalla Galilea e quindi dal viaggio verso Gerusalemme in occasione della Pasqua; si conclude col racconto della passione. Numerose sono le somiglianze anche in singole sezioni e singoli episodi, accanto a differenze. Il Vangelo di Marco risulta il più breve (solo 661 versetti, escludendo 16,9-20 che rappresentano una finale non autentica, come vedremo) e ha solo una trentina di versetti senza paralleli negli altri due: la parabola del seme che cresce da sé (4,26-29), la guarigione del sordomuto (7,31-37), la guarigione del cieco di Betsaida (8,22-26), la scena del giovinetto che fugge nudo al momento dell'arresto (14,51-52), e poco altro. I Vangeli di Matteo e Luca sono ben più estesi: 1068 versetti Matteo, 1149 Luca. Sia in Matteo sia in Luca buona parte del testo trova riscontro in Marco (600 versetti circa in Matteo, 314 in Luca): come si vede, le coincidenze sono più strette tra Matteo e Marco (e questo aveva fatto pensare agli antichi che Marco fosse un riassunto di Matteo). Matteo e Luca hanno poi anche 230-240 versetti in comune tra loro, tra cui soprattutto parabole e vari discorsi, oltre a materiali propri a ciascuno. Per quanto riguarda le parti comuni con Marco si riscontrano sia modi differenti, tra Matteo e Luca, di inserimento dei materiali marciani nella struttura del proprio Vangelo, sia tutta una serie di variazioni. In un confronto più serrato, si è incominciato a notare che le differenze tra questi Vangeli risultavano minori se si mettevano in parallelo separatamente Marco con Matteo e Marco con Luca. Ogni volta si potevano riconoscere indizi di una dipendenza di Matteo o di Luca rispetto a Marco piuttosto che viceversa: miglioramenti stilistici, spiegazioni e ampliamenti di passi oscuri, omissioni di particolari, inserzioni di nuovi materiali. Quella che si è costituita in due secoli come la "questione sinottica", al di là delle numerose e complesse proposte formulate, ha a lungo trovato una soluzione soddisfacente nella cosiddetta "teoria delle due fonti", ipotesi in base alla quale Matteo e Luca avrebbero utilizzato - l'uno indipendentemente dall'altro -, per la parte di materiale comune, il Vangelo di Marco, soprattutto per quanto riguarda i racconti, e, per quanto riguarda invece i discorsi (che mancano in Marco), una fonte Q (Q dal termine tedesco Quelle, che significa appunto "fonte"), contenente soltanto detti e che non ci è pervenuta. Marco non avrebbe conosciuto questa fonte Q. La teoria si può schematizzare così: Mc Q Altre fonti Altre fonti Mt Lc Anche gli sviluppi ulteriori della questione, che hanno ritenuto insufficiente la soluzione delle due fonti e che hanno postulato un più

31
complesso e reciproco rapporto tra i Vangeli al livello di redazioni antecedenti (per cui anche Marco potrebbe aver avuto conoscenza di strati antecedenti degli altri Vangeli),42 non hanno smantellato l'idea che nella forma attuale questo Vangelo sia il più antico rispetto agli altri. Di conseguenza, le ricerche hanno privilegiato il Vangelo di Marco e si sono concentrate sul tentativo di distinguere in questo Vangelo le fonti usate, le stratificazioni intervenute nella sua elaborazione, eventuali redazioni successive, sempre allo scopo di isolare le parti più antiche e più vicine alle origini, quindi storicamente più fondate. Gli sforzi più accaniti sono stati rivolti alla ricerca di un Vangelo di Marco primitivo (in tedesco Ur-Markus), quello (forse identificabile con la predicazione di Pietro), da cui Marco avrebbe attinto e che avrebbe o integrato o ridotto. Accanto a questo tentativo, e spesso a suo completamento, si è cercato talora di riconoscere tracce di una o più redazioni successive, attribuibili al medesimo Marco o ad altri, si è cercato cioè di ripercorrere le varie fasi di composizione del Vangelo. In genere però non si è arrivati ad esiti positivi e accettabili su tali questioni, dato il carattere sempre ipotetico, spesso arbitrario, delle proposte e la discordanza tra esse. Mancano conferme nella tradizione manoscritta, nella documentazione esterna e nello stile di Marco. Invece il confronto tra i paralleli sinottici è sempre utile e disponiamo di "Sinossi", sia in greco sia in italiano, che facilitano il compito di analizzare i rapporti reciproci. 2.1.2.1. Un esempio di applicazione della Critica delle fonti: La chiamata di Levi e il banchetto coi pubblicani (Mt 9,9-13; Mc 2,13-17; Lc 5,27-32) 43. Traduzione dei brani 44: Mt 9 Mc 2 Lc 5 9 Andando via di là, Gesù vi- 13 Uscì di nuovo lungo il 27 E dopo ciò egli u- de un uomo, chiamato Mat- mare; e tutta la folla veni- scì e vide un pubblicano teo, seduto al banco delle im- va a lui e li ammaestrava. di nome Levi seduto poste e gli dice: "Seguimi". 14 Nel passare, vide Levi, al banco delle, il figlio di Alfeo, seduto e gli disse: "Seguimi". al banco delle imposte e 28 E, lasciando tutto, si
42 Costituisce un problema il fatto che alcuni passi di Mc sembrano fondere i paralleli di Mt e Lc: cfr. la doppia notazione cronologica di Mc 1,32 ("venuta la sera, quando tramontò il sole"), che risulta una combinazione di Mt 8,16 ("venuta la sera") e Lc 4,40 ("mentre tramontava il sole"). Abbiamo anche casi in cui Mt e Lc concordano contro Mc in passi in cui dipendono da Mc. 43 Cfr. Zimmermann, Metodologia, pp.74-88; 157-160; 208. 44 I testi sono presentati sinotticamente (in italiano e in greco) nelle tavola allegate (All. 9 e 9 bis). Vengono usate le Sinossi di K. Aland (in greco) e di A. Poppi (in italiano). La Sinossi di Poppi già evidenzia graficamente i fenomeni da rilevare: usa il corsivo per le parti comuni a due o tre Vangeli, il tondo per le parti proprie a ciascuno, il maiuscoletto per sottolineare le concordanze tra Matteo e Luca contro Marco.

32
E si alzò e lo seguì. gli dice: "Seguimi". E si alzò e lo seguiva.. alzò e lo seguì. 10 E avvenne che, mentre 15 E accade che egli sedes- 29 E Levi gli preparò egli sedeva a mensa in casa, se a mensa in casa di lui, un grande banchetto in sopraggiunsero molti pubbli- e molti pubblicani e pecca- casa sua e c'era una gran cani e peccatori e si misero a tori si misero a mensa in- folla di pubblicani e di mensa insieme a Gesù e ai sieme a Gesù e ai suoi di- altra gente che sedeva a suoi discepoli. scepoli: infatti erano molti mensa con loro. e lo seguivano. 11 E vedendo ciò i farisei 16 E gli scribi dei farisei 30 E i farisei e i loro scri- dicevano ai suoi discepoli: vedendo che mangiava bi mormoravano con i "Perché il vostro maestro con i peccatori e i pubbli- suoi discepoli dicendo: mangia con i pubblicani e i cani dicevano ai suoi di- "Perché mangiate e be- peccatori?". scepoli: "Mangia con i vete con i pubblicani e i pubblicani e i peccatori". peccatori?". 12 Egli udì e disse: "Non so- 17 E Gesù udì e dice loro: 31 E Gesù rispondendo no i forti che hanno bisogno "Non sono i forti che hanno disse loro: "Non sono i del medico, ma i malati. 13 bisogno del medico, ma i sani che hanno bisogno Andate a imparare che cosa malati. del medico, ma i malati. significa: Voglio misericordia e non sacrifici (Osea 6,6). Infatti non sono venuto Non sono venuto per chia- 32 Non sono venuto per per chiamare i giusti ma i mare i giusti, ma i peccato- chiamare i giusti, ma i peccatori". ri". peccatori perché si con- vertano". La critica delle fonti o della tradizione cerca di stabilire attraverso il confronto sistematico dei Vangeli, versetto per versetto, parola per parola, se esistano rapporti di dipendenza tra i testi e quale testo costituisca la fonte dell'altro. Se è possibile accertare concordanze molto strette, letterali, si può ipotizzare un contatto diretto tra i testi, mentre le differenze servono a individuare quale testo sia stato usato come modello e chi abbia corretto e perché. Si può pensare che un testo dipenda da un altro - quando vi apporta miglioramenti stilistici (nella scelta dei termini, del tempo dei verbi, della costruzione del periodo); - quando abbrevia omettendo particolari oscuri o difficili o ripetizioni; - ma anche quando amplia introducendo elementi conformi al proprio punto di vista (commenti, citazioni scritturali, ecc.); - quando collega meglio i brani; - quando fornisce chiarimenti, ecc. Confronto tra Mt e Mc E' possibile constatare che esistono, tra Matteo e Marco, numerose concordanze di termini, espressioni e frasi in tutti i versetti, concordanze che inducono a supporre l'esistenza di una tradizione comune. Ma quanto all'esistenza di un rapporto di dipendenza di Matteo rispetto a Marco, non tutti gli studiosi sono d'accordo: viene considerato un impedimento, in questo senso, la differenza del nome del personaggio (Matteo in Mt e Levi in Mc) e c'è anche

33
chi pensa ad una derivazione autonoma di ciascuno dei due da una tradizione orale. Tuttavia l'analisi precisa del tipo di concordanze, induce i più a ritenere che non possano essere casuali, che implichino cioè un rapporto testuale. Significativi sono in particolare: - l'uso di termini e nessi che compaiono solo qui in tutto il Nuovo Testamento: telwvnion, trasl. telònion, "banco delle imposte", ijscuvonte", trasl. ischùontes, "che sono forti, sani"; l'espressione telw~nai kai; aJmartwloiv, trasl. telònioi kài hamartolòi, "pubblicani e peccatori" (si trova solo qui in Mt e Mc); - l'uso di tempi, modi e costrutti, che avrebbero potuto essere diversi: ad es., in Mt 9,9 e Mc 2,14 kai; levgei aujtw/~, trasl. kài lèghei autò, "e gli dice" (Lc ha eij~pen, trasl. èipen, "disse"); in Mt 9,11 e Mc 2,16 ejvlegon, trasl. èlegon, "dicevano", + dat. (Lc ha ejgovgguzon, trasl. egònguzon, "mormoravano", con pro;", trasl. pros, "verso, nei confronti di", + acc.); - l'identità di intere frasi in Mt 9,12; Mc 2,17 (ouj creivan ejvcousin..., trasl. ou chrèian èchusin, "non hanno bisogno") e Mt 9,13; Mc 2,17 (oujk hj~lqon..., trasl. ouk èlthon, "non sono venuto"). Ma numerose sono anche le differenze e consentono di specificare quale dei due testi sia la fonte dell'altro. E' possibile cioè riconoscere che è Matteo ad essere intervenuto sul testo di Marco correggendolo. I mutamenti principali sono: - miglioramenti stilistici: ad es., in 9,10, Mt introduce un genitivo assoluto (tradotto con "mentre egli era a tavola...") al posto dell'infinito katakei~sqai, trasl. katakèistai, "trovarsi a tavola" di Marco 2,15 (tradotto con "che egli si trovasse a tavola"): usa quindi una costruzione più classica al posto di una più difficile e dura. Introduce nel medesimo versetto un ijdouv, trasl. idoù, "ecco", per mettere in rilievo la dichiarazione successiva, secondo un uso che gli è familiare (ijdouv compare 62 volte in Mt contro 7 volte in Mc). Soprattutto è notevole il fatto che, mentre Mc in 2,17 usa la congiunzione paratattica kaiv, trasl. kài, "e", Mt in 9,12 la sostituisce con il dev, trasl. de, particella usata comunemente nella lingua greca con valore avversativo ("ma") o continuativo ("poi"): anche questo è caratteristico: Mt usa dev 491 volte contro 160 di Mc, mentre il kaiv è prediletto da Mc, che lo usa più di 400 volte, evitato da Mt che se ne serve solo 250 volte. Anche la sostituzione in Mt 9,12 di eij~pen, trasl. èipen, "disse", al levgei, trasl. lèghei, "dice", di Mc 2,17 è un miglioramento stilistico che corrisponde a un procedimento consueto in Mt. In Mt 9,11 l' oJvJvti, trasl. hoti, di Mc 2,16 (particella che si usa normalmente con valore dichiarativo o causale e qui forse ha valore interrogativo "45) viene mutato nella forma interrogativa più normale dia; tiv, trasl. dià tì, "perché?". Il personaggio incontrato da Gesù viene prima definito genericamente ajvnqrwpo", trasl. ànthropos, "uomo", poi denominato (9,9); - chiarimenti: in 9,9 Mt nomina esplicitamente il soggetto "Gesù"; anche in 9,11 viene introdotto il soggetto: oJ didavskalo" uJmw~n ("il vostro maestro");
45 La costruzione di Mc risulta ambigua e si può notare che già la tradizione manoscritta corregge.

34
- abbreviazioni e aggiustamenti: Mt in 9,9 omette la scena introduttiva di Mc 2,13 e introduce un ejkei~qen, trasl. ekèithen, "di là", per collegare l'episodio più strettamente con l'episodio precedente (guarigione del paralitico); in 9,11 dopo "vedendo" omette la dichiarativa di Mc 2,16 ("che mangiava con i peccatori e i pubblicani"), che risulta una ripetizione rispetto alla frase successiva. Probabilmente anche l'omissione, in Mt 9,10, della frase di Mc 2,15: "erano infatti molti e lo seguivano" è dovuta all'intento di evitare una ripetizione (era già stato detto che "i pubblicani e i peccatori" erano "molti"). Mt semplifica in 9,11 l'espressione non del tutto chiara di Mc 2,17 "gli scribi dei farisei" (in Mc si trova solo qui: già la tradizione manoscritta corregge) in "i farisei"; - modificazioni interpretative: il personaggio è chiamato Matteo invece che Levi (9,9) per farlo coincidere con uno dei dodici apostoli, di cui si dice esplicitamente in 10,3 che era telwvnh", trasl. telònes, "gabelliere". E' questo un caso che mostra più chiaramente il rapporto di dipendenza di Matteo da Marco, perché l'inverso - una correzione di Matteo in Levi - risulta molto più difficile da spiegare: Levi non compare altrove nel Vangelo e non avrebbe senso sostituirlo a un personaggio noto e importante; - sviluppi teologici: il più importante, e caratteristico di Matteo, è l'introduzione in 9,13 della citazione della Scrittura (qui Osea 6,6), che assume una funzione centrale e perciò la conclusione è subordinata ad essa con un gavr, trasl. gar, "infatti, perché". Naturalmente anche molti degli altri cambiamenti possono avere un valore teologico. Se ne conclude che è probabile che il testo di Mc sia stato la fonte di Mt per le numerose e strette somiglianze, così come è chiaro che Mt è intervenuto sul testo di Mc per migliorarlo, chiarirlo e integrarlo, in funzione della propria prospettiva teologica. L'inverso (che sia stato Mc a usare e modificare Mt) appare molto meno probabile. Confronto tra Lc e Mc Le concordanze tra Luca e Marco sono molto inferiori a quelle tra Matteo e Marco, tuttavia permettono di pensare a un rapporto di dipendenza letteraria, dato che esistono molte somiglianze puntuali di termini ed espressioni: nell'ordine: - Lc 5,27 e Mc 2,13-14a: coincidono ejxh~lqen, trasl. exèlthen, "uscì"; il nome Levi; l'espressione che lo qualifica ("seduto al banco delle imposte"); il comando di Gesù (ajkolouvqei moi, trasl. akoloùthei moi, "seguimi"); - Lc 5,28 e Mc 2,14b: è comune l'espressione che descrive la reazione di Levi: ajnasta;"..., trasl. anastàs, "alzatosi"; - Lc 5,29 e Mc 2,15: in entrambi c'è "nella sua casa"; - Lc 5,30 e Mc 2,16: è particolarmente significativa l'identità del nesso telwnw~n kai; aJmartwlw~n, trasl. telonòn kài hamartolòn, "pubblicani e peccatori", perché Luca non aveva menzionato i "peccatori" in 5,29 (aveva scritto: "pubblicani e altri"); - Lc 5,31-32 e Mc 2,17: c'è identità quasi completa nei detti di Gesù riportati.

35
Risulta piuttosto evidente dalle differenze che il testo che dipende dall'altro è quello di Luca, che per lo più corregge e rielabora. I cambiamenti sono: - miglioramenti stilistici: Lc evita il presente storico e sostituisce il "dice" di Mc con "disse", in 5,27 e 31; in 5,31 aggiunge "rispondendo"; due volte (5,30 e 31) preferisce al dativo, dopo verbi di dire, il pro;", trasl. pros, "verso, nei confronti di, a",+ acc. Come Mt, sostituisce in 5,30 l'oJvti di Mc 2,16 con dia; tiv, trasl. dià tì, "perché...?". Potrebbero essere miglioramenti stilistici anche l'uso, in 5,30, di "mormoravano (ejgovgguzon) dicendo" al posto del più banale "dicevano" di Mc2,16 e il cambiamento, in 5,31, del participio ijscuvonte", trasl. ischùontes, "che sono forti" (tradotto con "sani") usato da Mc 2,17, in uJgiaivnonte", trasl. hyghiàinontes, "che sono sani". - una chiarificazione, rispetto all'insolita definizione di Mc 2,16 ("gli scribi dei farisei"), è il nesso, in Lc 5,30, "i farisei e gli scribi"; - abbreviazioni con omissione di particolari secondari o ripetitivi (come in Mt): si veda in 5,29 l'omissione di "erano infatti molti..." di Mc 2,15 e in 5,30 l'omissione di "che mangia con i peccatori e i pubblicani" di Mc 2,16. L'omissione in 5,27 della qualificazione di "figlio di Alfeo" attribuita a Levi risolve una difficoltà: nel catalogo degli apostoli Mc 3,18 (ripreso da Lc 6,15) si parla di un Giacomo figlio di Alfeo, mentre non si sa nulla di un Levi figlio di Alfeo: 46) Lc ne fa un personaggio più generico e perciò più esemplare; - collegamenti più precisi: come Mt, Lc collega più strettamente l'episodio col precedente (guarigione del paralitico) con l'espressione "dopo queste cose"; omette perciò anche il primo versetto di Mc, 2,13 (il cui contenuto del resto Lc aveva già presentato in 5,1); ma anche all'interno dell'episodio collega più strettamente la chiamata alla sequela al banchetto spiegando che è Levi a organizzare il banchetto (5,29), mentre in Mc, e Mt, la situazione risulta non del tutto chiara: di chi era la casa? Da Mc potrebbe sembrare che fosse quella di Gesù stesso; - modificazioni e sviluppi teologici: tra i più significativi c'è l'aggiunta, in 5,28, di "lasciando tutto", che accentua il valore esemplare del gesto, e l'aggiunta, in 5,32, di eij" metavnoian, trasl. eis metànoian,"per la conversione", che specifica e delimita il valore dell'invito subordinandolo, appunto, alla conversione. Ma interessanti, e da considerare in questa prospettiva, sono anche altre correzioni: il rimprovero dei farisei si rivolge in Lc 5,30 ai discepoli e non più a Gesù direttamente; il fatto che sia Levi, e sicuramente non Gesù, l'ospitante, attenua l'aspetto scandaloso dell'invito rivolto a pubblicani e peccatori, ecc. 2.1.2.2. Conclusione Anche per Luca vale quanto già si è detto per Matteo: deve aver avuto a disposizione un testo che è quello di Mc o uno a lui molto vicino e deve averlo
46 Si noti che già la tradizione manoscritta denuncia la difficoltà: una parte di questa tradizione sostituisce appunto a "Levi" "Giacomo".

36
modificato in vista di una maggiore precisione ed efficacia, nonché per mettere in evidenza concetti a lui cari. In tutti e due i casi è possibile accertare che il racconto di Marco risulta più oscuro e primitivo rispetto a quelli di Matteo e di Luca, i quali risultano dipendere da Marco e correggerlo. Questo almeno si può dire secondo la "teoria delle due fonti". 47
Si tenga però conto che, secondo altre ipotesi sinottiche, è possibile che i rapporti tra i Vangeli non siano stati diretti, ma che ci siano state già fonti scritte antecedenti a Marco, oppure che Matteo e Luca abbiano conosciuto una redazione di Marco diversa, almeno parzialmente, dall'attuale, ecc. Le osservazioni precedenti mantengono il loro valore, purché non le si leghi rigidamente all'opinione che Matteo e Luca avessero di fronte esattamente questo testo di Marco. Il lavoro di confronto che è stato fatto per questo brano deve essere ripetuto anche per gli altri, in modo da poter convalidare le conclusioni a cui si è giunti. 2.1.3. La Storia delle forme e i materiali utilizzati da Marco La critica del '900 ha poi sviluppato, sempre nell'ambito dello studio sulla storia antecendente alla redazione ultima e definitiva del Vangelo, due metodologie particolari, denominate alla tedesca (perché tedeschi sono stati i promotori) Formgeschichte, ossia "Storia delle forme", e Redaktionsgeschichte, ossia "Storia della redazione". La "Storia delle forme", che fa capo agli studi di M. Dibelius (1919) e R. Bultmann (1921) 48, si è interessata della formazione e della trasmissione dei materiali confluiti nei Vangeli. E' partita dalla constatazione che si possono riconoscere nei testi attuali dei Vangeli piccole unità letterarie o "perìcopi" (= passi che si possono ritagliare), contraddistinte da indizi formali formali e/o contenutistici: formule introduttive ("dopo questo", "allora", "in quel tempo, ecc.), cambiamenti di luogo, tempo, personaggi, azioni, ecc.; talora questi brani si ritrovano in più Vangeli, in collocazioni diverse. L'ipotesi di fondo è che queste unità letterarie o "forme" abbiano avuto in origine una storia autonoma che si può ripercorrere. La Storia delle forme ha quindi studiato ognuna di queste unità letterarie cercando di classificarla, con risultati invero non concordi e non sempre chiari, e poi di ricostruirne la forma originaria, eliminando gli elementi che, anche attraverso il confronto con i paralleli, risultino essere delle aggiunte; quindi ha 47 Mt e Lc potrebbero aver operato ciascuno in modo indipendente: l'unico accordo tra loro che li differenzia da Mc è il mutamento della forma del "perché?: dià tì invece che hoti, ma potrebbe essere casuale, dato che dià ti è la forma più comune in greco. 48 M. Dibelius, Die Formgeschichte des Evangeliums (La Storia delle forme del Vangelo), Tübingen 1919, 19665; R. Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Tradition (La storia della tradizione sinottica), Göttingen 1921, 19615, Ergänzungsheft 19623.

37
tentato di individuare il suo significato e la sua funzione nella situazione in cui fu elaborata (Sitz im Leben, "collocazione nel contesto vitale") e anche la sua storia successiva con gli adattamenti e le modificazioni legate a nuove situazioni e nuovi bisogni della comunità cristiana. Per quanto riguarda la classificazione 49, le forme sono state distinte innanzitutto in due categorie: quella delle "parole" e quella della "storia" o dei "racconti". Le parole si possono raggruppare essenzialmente in - detti profetici: ad es., Mc 13,2 (cfr. Mt 24,2); Lc 21,6): "Non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia distrutta"; Mc 13,30 (cfr. Mt 24,34; Lc 21,32): "In verità vi dico: non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute"; - detti sapienziali: ad es. Mc 6,4 (cfr. Mt 13,57; Lc 4,24): "Non c'è profeta disprezzato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e nella sua casa"); - detti-io o detti cristologici: sono per lo più introdotti da formule come h|lqon, trasl. èlthon, "sono venuto", o oujk h|lqon, trasl. ouk èlthon, "non sono venuto": ad es. Mc 2,17: "Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori"; ma talora hanno come soggetto "il Figlio dell'uomo": ad es. Mc 10,45 (cfr. Mt 20,28): "Il figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire...", ecc. - precetti: ad es. Mc 10,11 (cfr. Mt 5,32; 19,9; Lc 16,18): "Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei..."); - parabole: 50 sono spesso introdotte da wJ", wJvsper, trasl. hos, hosper: ad es. Mc 4,31: "Esso - ossia il Regno - è come un granellino di senapa che..."; ma anche da espressioni generali come oujdeiv", trasl. oudèis, "nessuno": ad es. Mc 2,21 (cfr. Mt 9,16): "Nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio...". Spesso si sviluppano in racconti ampi e articolati. Le parabole hanno suscitato nell'ultimo secolo una folta serie di studi specifici, in quanto appaiono una forma di comunicazione tipica di Gesù (cfr. Mc 4,34: "non parlava se non in parabole"), legata alla sua missione e ai suoi rapporti con i contemporanei, soprattutto con gli avversari: è stato riconosciuto che la sua funzione caratteristica è "dialogico-argomentativa". Gli studiosi cercano di distinguere il messaggio originario delle parabole di Gesù dalle interpretazioni, di tipo allegorico, introdotte dalle comunità cristiane e di cui alcune sono state tramandate dagli evangelisti: si veda in particolare la spiegazione della parabola del seminatore (Mc 4,14-20 e paralleli). Si è anche ritenuto che nel corso della tradizione gruppi di detti siano già stati accorpati in sequenze fisse: per il Vangelo di Marco si pensa, ad es., che le
49 Cfr. Zimmermann, Metodologia, cit., pp.125-140. 50 Le parabole hanno suscitato nell'ultimo secolo una folta serie di studi specifici, in quanto appaiono una forma di comunicazione tipica di Gesù, legata alla sua missione e ai suoi rapporti con i contemporanei, soprattutto con gli avversari: è stato riconosciuto che la sua funzione caratteristica è "dialogico-argomentativa". Cfr. in particolare il saggio di V. Fusco, Oltre la parabola. Introduzione alle parabole di Gesù, Roma, Borla, 1983, ma anche J. Dupont, Il metodo parabolico di Gesù, Brescia, Paideia, 1990.

38
composizioni di detti di 9,33-50 (relativi a istruzioni ai discepoli) e 10,1-45 (sul divorzio) e la raccolta di parabole del cap.4, preesistessero al lavoro dell'evangelista. Le forme dei racconti hanno presentato maggiori difficoltà alla classificazione, perché spesso si incontrano forme miste. Di fatto, i risultati di Dibelius e Bultmann divergono molto su questo punto, e anche successivamente non si sono trovati procedimenti uniformi. Si può parlare di paradigmi (secondo la denominazione di Dibelius) o apoftegmi (secondo Bultmann), nel caso di racconti esemplari, anche di miracoli, che hanno il loro punto focale in un detto di Gesù: ad. es., gli episodi di guarigione del paralitico, in Mc 2,1-12 (il miracolo viene compiuto per dimostrare che il Figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati); dell'uomo dalla mano inaridita, in Mc 3,1-6 (la guarigione viene compiuta per dimostrare che il sabato è fatto per fare il bene e per salvare vite); della spigolatura del sabato, in Mc 2,23-28 (anche qui conta l'insegnamento di Gesù sul bisogno che giustifica violazioni della Legge); dell'unzione di Betania, in Mc 14,3-9 (il vertice sono le parole di Gesù in elogio del gesto della donna). Vengono distinte, tra i paradigmi, le storie di chiamata (es.: Mc 1,16-20; 2,14). E' possibile poi distinguere (secondo Zimmermann, ma né Dibelius né Bultmann distinguevano dal gruppo precedente) le dispute (ce ne sono cinque in Mc, tra 11,27 e 12,37: sull'autorità di Gesù, sul tributo a Cesare, sulla risurrezione, sul più grande comandamento, sul Messia), che talora si presentano come dialoghi dottrinali (ad es. Mc 7, 1-23: sul puro e sull'impuro); presentano una sorta di schema fisso: un comportamento strano di Gesù o dei suoi discepoli suscita una critica degli avversari; segue la risposta di Gesù, che per lo più 'spiazza' gli interlocutori e li zittisce. I racconti di miracoli si distinguono dai racconti pure di miracoli, ma classificati come paradigmi, in quanto non sono tanto orientati a evidenziare una parola di Gesù, quanto a dimostrare la sua potenza divina. Si possono citare come esempi: la guarigione della suocera di Pietro (Mc 1,29-31); la guarigione dell'emorroissa (Mc 5,25-34); l'esorcismo della figlia della donna siro-fenicia (Mc 7,25-30); la guarigione del cieco di Gerico (Mc 10,46-52),ecc. Gli episodi della trasfigurazione (Mc 9,2-10), e di Gesù che cammina sulle acque del lago (Mc 6,45-52) si possono includere in questa serie, e sono definibili più specificamente miracoli-epifanie (perché sono miracoli finalizzati alla rivelazione dell'identità divina di Gesù). Si possono distinguere ulteriormente sottogeneri: guarigioni di malattie, esorcismi, miracoli sulla natura o miracoli-dono (moltiplicazioni di pani, tempesta sedata), ecc. Anche nel caso di racconti di miracoli si può rilevare la presenza di elementi fissi: descrizione di una situazione di bisogno, richiesta a Gesù di intervenire (da parte della persona stessa o di altri per lei), pronto intervento di Gesù che risolve la situazione, constatazione degli effetti dell'intervento, stupore dei presenti. Ma ciascun sottogenere ha caratteristiche sue. Ad es., negli esorcismi è il demonio che, alla presenza di Gesù, si rivolge per primo a lui, lo riconosce e lo sfida cercando di

39
spingerlo a non intervenire ("Che c'è tra me e te?"), ma inesorabilmente viene zittito e scacciato (cfr. Mc 1,21-28; 5, 1-20). L'individuazione dello schema di base consente poi di analizzare le variazione introdotte nelle diverse applicazioni e di valutare la funzione di esse: ad es., nel racconto dell'esorcismo della figlia della sirofenicia (Mc 7,25-30) diventa qualificante il fatto che, diversamente dalla norma, qui Gesù in un primo tempo si mostra restio ad accogliere la richiesta della madre; nel racconto dell'indemoniato epilettico (Mc 9,17-27), acquista un rilievo eccezionale il dialogo tra Gesù e il padre del ragazzo. Una narrazione storica a parte viene considerata, in Marco, quella della morte di Giovanni Battista (Mc 6,17-29; cfr. Mt 14,3-12), che nel suo nucleo originario sembra quasi autonoma rispetto alla storia di Gesù. Un complesso indipendente e ben fissato nelle sue linee essenziali, probabilmente il più antico come composizione unitaria, è la storia della passione (Mc 14-15). Anche per il materiale narrativo si ipotizza l'esistenza di raccolte primitive, ma non tutti sono d'accordo sull'identificazione di queste raccolte: ad esempio, alcuni pensano che sia esistita una raccolta premarciana di miracoli, corrispondente all'incirca ai racconti dei capp. 4-5 (tempesta sedata, esorcismo sull'indemoniato di Gerasa, risurrezione della figlia di Giairo, guarigione dell'emorroissa), altri lo negano. La Storia delle forme ricerca inoltre il Sitz im Leben (la situazione vitale) di ciascuna delle forme individuate, nelle varie fasi della sua trasmissione, a partire dagli inizi. Normalmente questo Sitz im Leben viene ritrovato nelle varie circostanze della vita della comunità cristiana: predicazione, catechesi, liturgia, polemica con avversari, ecc. Si ritiene, cioè, che i singoli testi abbiano avuto origine e siano stati usati da cristiani che svolgevano un determinato ruolo ecclesiale, si rivolgevano a un determinato pubblico in circostanze specifiche e per rispondere a bisogni specifici, e si cerca quindi di ricostruirli. Poiché, inoltre, la Storie delle forme pensa di poter rintracciare nei Vangeli gli indizi di adattamenti successivi del medesimo materiale, la ricerca riguarderà non un solo Sitz im Leben , ma tanti Sitze im Leben quanti sono gli strati ricostruibili della storia del brano. Anche ogni Vangelo ha avuto un proprio Sitz im Leben che si può cercare di ricostruire. La Storia delle forme mette dunque in secondo piano l'aspetto della storicità e si concentra sulla parte che ha avuto la comunità cristiana nell'elaborazione della tradizione evangelica. Questo atteggiamento, soprattutto nel modo in cui si è espresso con le ricerche di Bultmann, ha suscitato in passato perplessità e difficoltà a chi pensava che fosse minacciato il fondamento della fede. Oggi invece il metodo viene accettato comunemente e integrato nell'analisi, senza problemi. 2.1.3.1. Un esempio di applicazione della Storia delle forme: la chiamata di Levi e il banchetto coi pubblicani (Mc 2,13-17)

40
Dopo che il confronto sinottico ha portato come conclusione più probabile che sia il testo di Marco quello più antico, l'analisi storico-formale si concentra su di esso per identificare il materiale tradizionale che è stato utilizzato. Il Vangelo di Marco risulta quindi privilegiato in questo tipo di ricerca, almeno in quanto offre una versione più primitiva, meno elaborata, dei materiali trasmessi dalla tradizione. E per far questo, cerca, innanzitutto, di distinguerlo dagli interventi redazionali dell'evangelista. Si suppone che siano redazionali i moduli e le espressioni che ritornano più frequentemente in questo Vangelo, a differenza che negli altri; tuttavia non c'è accordo tra gli studiosi nella specificazione di ciò che appartiene alla mano dell'evangelista e di ciò che appartiene alla tradizione a lui antecedente. Nel caso presente, risulta a tutti chiaro che abbiamo due brani collegati tra loro (il principale elemento di collegamento è il riferimento ai pubblicani e al fatto che Gesù li accoglie con sé), e questi brani si possono classificare, rispettivamente, come "storia di chiamata" (9,14), un sottogenere del paradigma, e "disputa" (9,15-17). All'interno della disputa abbiamo poi due detti di Gesù, di cui uno ha la forma del proverbio o detto sapienziale ("non sono i sani..."), l'altro è un detto-io o detto cristologico o giudizio sulla propria missione ("non sono venuto..."). La storia di chiamata presenta strette analogie con le precedenti storie di chiamata di 1,16-20; si veda in particolare il parallelo con 1,16-18, dove sono narrate le chiamate di Pietro e Andrea (simile è anche la chiamata di Giacomo e Giovanni in 1,19-20): 1,16-18 2,14 Testo kai; paravgwn para; th;n qavlassan th~" kai; paravgwnGalilaiva" eij~den Sivmwna kai; jAndrevan eij~den Leui;n to;n tou~ jAlfaivou to;n ajdelfo;n Sivmwno" ajmfibavllonta" kaqhvmenon ejpi; to; telwvnion, ejn th/~ qalavssh/: h|san ga;r aJliei~". kai; ei|pen aujtoi~" oJ jIhsou~" : deu~te kai; levgei aujtw~/ : ajkolouvqei moi. ojpivsw mou, kai; poihvsw uJma~" genev- sqai aJliei~" ajnqrwvmwn. kai; eujqu;" ajfevnte" ta; divktua hjkolouv- kai; ajnasta;" hjkolouvqhsen aujtw/~. qhsan aujtw/~. Traduzione E passando lungo il mare della Galilea E passando vide Simone e Andrea, fratello di Simone, vide Levi, il figlio di Alfeo, intenti a gettare le reti nel mare: erano infatti seduto al banco delle imposte, pescatori. E disse loro Gesù: "(Venite) qui, dietro di me, e gli dice: "Seguimi". e vi farò diventare pescatori di uomini". E subito, lasciate le reti, lo seguirono. E, alzatosi, lo seguì:

41
La storia di chiamata segue uno schema comune: - la descrizione di Gesù che passa in un luogo; - vede delle persone - queste persone vengono indicate col nome e con il rapporto di parentela; - si specifica ciò che stanno facendo in quel momento in rapportò alla loro attività lavorativa; - si riportano le parole di Gesù rivolte a loro, parole che indicano una cosa sola: il comando di seguirlo; - si sottolinea la pronta esecuzione da parte delle persone interpellate; - si mostra che viene lasciato ciò che si stava facendo. La storia di chiamata illustra in rapidi tratti due elementi principali: la modalità della chiamata di Gesù, che arriva improvvisa nelle circostanze della vita quotidiana, durante il proprio lavoro, e la modalità con cui il vero discepolo risponde alla chiamata, ossia la pronta e incondizionata obbedienza che impone il distacco immediato dalla vita precedente. Lo scopo del racconto è quello di fornire un esempio di comportamento per colui che si accosta alla fede in Cristo. Il Sitz im Leben originario potrebbe essere stato quello della predicazione. L'episodio del banchetto (2,15-17) si caratterizza come disputa tra Gesù e i farisei a proposito del suo mescolarsi con pubblicani e peccatori, ritenuti persone corrotte e impure dai giudei e quindi da evitare. Esso segue lo schema ordinario di altre dispute, articolate in tre momenti: - un insolito comportamento di Gesù - provoca una domanda di rimprovero degli avversari, - a cui segue una risposta decisiva di Gesù che li fa tacere. Esempi analoghi di dispute ritroviamo in Mc 2,12 (Gesù assicura al paralitico che gli sono rimessi i suoi peccati, alcuni scribi protestano increduli, Gesù dimostra loro il suo potere guarendo il paralitico), 3,22-27 (dopo alcuni esorcismi di Gesù, gli scribi lo accusano di essere lui stesso indemoniato, Gesù risponde loro con una parabola su satana), 7,1-23 (alcuni farisei e scribi che hanno notato come i discepoli di Gesù non si lavino le mani prima di mangiare ne fanno rimprovero a Gesù, che a sua volta li critica aspramente e poi parla della vera impurità), ecc. Il Sitz im Leben di questo brano viene identificato in un momento in cui erano vive all'interno della comunità cristiana le polemiche col giudaismo a proposito dell'accoglienza verso i "peccatori", ossia, soprattutto, i pagani, ma anche altre categorie considerate impure. Già Paolo (cfr. Gal 2,12) e gli Atti (11,1-3) testimoniano le difficoltà che sorgevano in alcune comunità a proposito della partecipazione a pasti comuni tra ex ebrei ed ex pagani 51.
51 Gal 2,12: "Prima che giungessero [ad Antiochia] alcuni da parte di Giacomo, egli [Pietro] prendeva cibo insieme ai pagani; ma dopo la loro venuta cominciò a evitarli e a tenersi in disparte, per timore dei circoncisi"; At 11,2-3: "E quando Pietro salì a Gerusalemme, i circoncisi

42
Una volta combinati insieme, i due brani acquistano la forma di un unico paradigma, in cui il primo brano fa da introduzione e l'accento cade sul detto finale di Gesù. Tuttavia, va rilevato pure che nella ricerca di ciò che è tradizionale e ciò che appartiene alla mano del redattore restano molti punti incerti. Alcuni (Taylor, Zimmermann, Gnilka) ritengono che entrambi i brani derivino dalla tradizione, altri (Pesch) invece pensano che il primo sia stato elaborato da Marco, solo il secondo sia antecedente, altri (Bultmann) al contrario che sia una composizione di Marco la scena del banchetto. Secondo Pesch il brano del banchetto farebbe parte della raccolta premarciana di dispute che si estende da 2,15 a 3,6 e contiene, oltre a questa disputa, quella sul digiuno e quelle sul sabato 52. Anche sugli interventi redazionali apportati dall'evangelista per introdurre e collegare i brani, non c'è univocità. C'è accordo solo nell'attribuire a Marco il v.13 e la frase causale in 15c ("erano infatti molti"): nel v.13 ricorrono termini e indicazioni (sulla riva del mare, la gran folla, Gesù intento a insegnare) che sono correnti anche altrove nel Vangelo. Ma, ad es., per il detto finale di Gesù ("non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori"), alcuni pensano che facesse parte del brano tradizionale (Pesch), altri (Bultmann, Dibelius) che sia un'elaborazione di Marco. Il detto precedente ("non hanno bisogno del medico i sani, ma i malati") si dimostra più facilmente appartenente alla tradizione perché è stato tramandato anche autonomamente (ad es., nella Lettera di Barnaba 5,9; in Giustino, I Apol. 15,8); presenta paralleli anche nella letteratura classica. Ma, mentre per i più è uno degli ipsissima verba di Gesù (ossia delle parole più autentiche di Gesù), Schweizer, ad esempio, si mostra convinto che sia un'elaborazione successiva della comunità, come anche il detto successivo. 2.1.3.2. La forma o genere letterario del "vangelo" Anche ogni Vangelo nel suo complesso costituisce una "forma" particolare, che è stata variamente applicata dai diversi evangelisti, ma che possiede tratti comuni. Marco potrebbe essere stato l'"inventore" di questa forma, oppure potrebbe aver attinto ad esempi precedenti: nel prologo del suo Vangelo (Lc 1,1-4) Luca, che probabilmente ha conosciuto e utilizzato Marco, parla di "molti" che avevano tentato di raccontare la stessa materia: forse allude a più "vangeli" esistenti prima di lui? La forma "vangelo" è stata accostata al genere della biografia e letta come una "vita di Gesù", ma se ne differenzia per l'assenza di attenzione ad aspetti propri della biografia, come il carattere del personaggio, l'educazione, l'aspetto fisico, le indicazioni cronologiche, ecc. Certo, si avvicinano di più alla biografia
lo rimproveravano dicendo: 'Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro'". 52 Altri (cfr. Schmid, L'Evangelo secondo Marco, cit.) pensano che anche la disputa di Mc 2,1-12, che riguarda il potere di rimettere i peccati, facesse parte della raccolta premarciana.

43
i Vangeli di Matteo e di Luca, che incominciano dalla nascita; Marco ne è più lontano. Oggi si parla del vangelo come di un "genere storico kerygmatico" (da kèrygma, "annuncio"), in quanto è il racconto di una storia che parla al presente, è una testimonianza di fede che mira a suscitare e rafforzare la fede nei destinatari. Gli evangelisti scrivono non semplicemente per conservare e tramandare il ricordo di Gesù, non semplicemente per ricostruire una vicenda, ma cercando di cogliere e trasmettere il significato profondo di essa: ciascun evangelista prospetta, in un'ottica particolare, una interpretazione teologica dei fatti. Si può estendere a tutti i Vangeli la dichiarazione che l'autore del Vangelo di Giovanni fa alla fine della prima edizione dell'opera (20,31): "Queste cose sono state scritte perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e credendo abbiate vita nel suo nome". Il Vangelo di Marco già implica un concetto simile nelle sue parole iniziali, che suonano come un titolo: "Inizio del vangelo di Gesù Cristo, [Figlio di Dio]". Il termine eujaggevlion, trasl. euanghèlion, "vangelo" (ma letteralmente: "buona notizia") usato da Marco riprende un termine che nell'uso classico si riferiva soprattutto a notizie relative ad eventi fausti come nascite o vittorie di imperatori (ma lo reinterpreta), ma soprattutto si riaggancia all'accezione religiosa che il verbo eujaggelivzesqai, trasl. euanghelìzesthai, "portare il lieto annuncio", aveva assunto nella traduzione greca dell'Antico Testamento (quella dei Settanta): portare l'annuncio della salvezza, quella definitiva, instaurata dal Messia (cfr. il passo messianico di Is 61,1-2, citato da Lc 4,18-19: "lo Spirito del Signore è su di me; ... mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio..."). Nella forma "vangelo" creata da Marco la struttura di base corrisponde all'intenzione di dimostrare, o piuttosto di "annunciare", che Gesù è il Messia predetto dai profeti e il Figlio di Dio stesso, che ha compiuto interamente la volontà di Dio, le promesse contenute nell'Antico Testamento e le imprese attese dal Messia, tra le quali non ci sono solo i miracoli, le guarigioni e le opere potenti, ma anche la passione e la morte. 2.1.4. La Storia della redazione e la scoperta del lavoro compositivo di Marco La "Storia della redazione", che si è sviluppata soprattutto dagli anni '50 in poi del 1900 (uno studio fondamentale è quello di W. Marxsen del 1956 proprio dedicato al Vangelo di Marco 53), ha integrato la "Critica delle fonti" e la "Storia delle forme", in quanto ha posto l'accento sulle caratteristiche e sugli apporti del redattore finale del Vangelo, che la Critica delle fonti aveva considerato a proposito delle differenze tra i Vangeli, ma solo allo scopo di definire i rapporti tra essi, e che la Storia delle forme aveva distinti dai materiali tradizionali, ma per poter concentrarsi su questi ultimi. La Storia della
53 Der Evangelist Markus. Studien zur Redaktionsgeschichte des Evangeliums (L'evangelista Marco. Studi sulla storia della redazione del Vangelo), Göttingen 1956.

44
redazione, secondo le parole di un esponente autorevole del metodo, 54 mira invece a "spiegare l'opera nella sua forma attuale". La Storia della redazione si interessa particolarmente di alcuni elementi presenti nei Vangeli che si presume siano opera del redattore finale o evangelista: - La scelta del materiale. Si può applicare a tutti i Vangeli l'ammissione che fa Giovanni, in 20,30, di non aver scritto tutto: in questo caso si tratta di scelta nel senso di omissione di una parte del materiale a disposizione; talora, invece, l'evangelista aggiunge, rispetto a un altro, materiale attinto ad altra fonte (ad esempio, nella controversia sul divorzio, Matteo, in 19,3-12, aggiunge, rispetto a Mc 10,2-12, un detto sul farsi eunuchi che cambia profondamente il significato del brano). Per quanto riguarda Marco, è più difficile determinare quali omissioni possa aver fatto rispetto al materiale a a lui noto. Si può immaginare che non abbia parlato della nascita di Gesù perché non conosceva le tradizioni utilizzate da Matteo e Luca. Ma si può supporre con qualche maggiore probabilità che abbia intenzionalmente omesso i racconti della apparizioni del Risorto (abbiamo già accennato al fatto che il Vangelo verosimilmente si concludeva con la scena della tomba vuota, in 16,8 e su questo punto torneremo in seguito), perché, come ricaviamo da Paolo, 1 Cor 15,1 ss., la fonte più antica relativa all'annuncio primitivo del vangelo (tra il 50 e il 60), le apparizioni del Risorto erano parte di questo annuncio, dopo passione, morte, sepoltura, risurrezione. Una tale omissione è di grande peso nella definizione della prospettiva teologica di Marco. Certo egli deve aver introdotto delle aggiunte: tra queste possiamo includere l'episodio del giovinetto che fugge nudo durante l'arresto di Gesù (14,51-52). - La disposizione e la strutturazione del materiale. E' in gran parte opera degli evangelisti il collegamento di brani che nella tradizione comparivano isolati; è possibile constatare che ciascun evangelista colloca diversamente dagli altri singoli brani o parti di un brano, e in questo modo conferisce loro un diverso significato. Ad esempio, la chiamata dei primi discepoli in Marco è posta in rilievo, proprio all'inizio del ministero di Gesù, in 1,16-20, come primo gesto qualificante della sua missione, mentre in Luca si trova più avanti, in 5,1-11, dopo una serie di episodi di predicazione e di guarigione. Inoltre è significatico che Marco, diversamente dagli altri, presenti come primo miracolo un esorcismo (1,23-28). Propria di questo evangelista è la costruzione della "sezione dei pani" (Mc 6,6b-8,26), una sezione nella quale in tutti gli episodi, sia nei racconti (soprattutto due moltiplicazioni dei pani) sia nelle parole si menziona il pane o altra cosa connessa (lievito), evidentemente per dare rilievo simbolico a questo elemento.
54 H. Conzelmann, Die Mitte der Zeit. Studien zur Theologie des Lukas (Il centro del temoi. Studi sulla teologia di Luca), Tübingen 1954, p.1.

45
- Le modificazioni di vario genere apportate al materiale tramandato. Appartengono a questo ambito le correzioni stilistiche: modificazione dei tempi dei verbi, della struttura sintattica, di termini, ecc. Talora si hanno anche variazioni nel senso che, ad esempio, Matteo, in 22,41-46, trasforma in dialogo articolato con gli avversari quella che in Mc 12, 35-37 era una questione posta da Gesù a proposito della definizione del Messia come Figlio di Davide. Vengono talora introdotte spiegazioni di termini o concetti che risultano, in una nuova situazione, poco chiari: ad esempio, Marco introduce, in 7,3-4, una spiegazione sulle usanze purificatorie dei giudei, evidentemente rivolgendosi a un pubblico pagano, che non le conosce. Può capitare che un'immagine venga trasformata, sempre in rapporto con una situazione diversa: ad esempio, a proposito della medesima similitudine della casa, mentre Matteo, in 7,24-27, parla di casa costruita o sulla roccia o sulla sabbia, Luca, in 6,47-49, parla di casa costruita con solide fondamenta o senza fondamenta: probabilmente, l'uno ha in mente l'ambiente palestinese, l'altro l'ambiente ellenistico. Significative sono le omissioni di una frase o di un'espressione ritenuta difficile: ad esempio, Mt 8,3 e Lc 5,13 omettono il termine ojrgisqeiv", trasl. orghisthèis, "adiratosi", di Mc 1,41, probabilmente perché sentito come troppo forte e inadatto per Gesù: anche la tradizione manoscritta di Marco registra varianti a proposito di questo termine 55. L'affermazione di Mc 13,32 e Mt 24,36 secondo cui "neanche il Figlio" conosce il giorno e l'ora della venuta del Figlio dell'uomo è stata depennata da Lc 21,34-35, perché teologicamente inaccettabile. Anche in questo caso la difficoltà è segnalata dalle omissioni della tradizione manoscritta di Mc e di Mt. Si riscontrano inoltre abbreviazioni, specialmente di particolari: si nota in Matteo rispetto a Marco: si veda, ad esempio, l'episodio dell'indemoniato di Gerasa, che in Mc 5,1-20 occupa ben 20 versetti, ed è ridotto a 7 in Mt 8,28-34. Si hanno infine inserzioni di citazioni e commenti scritturali: è tipico di Matteo aggiungere accenni al compimento della Scrittura, secondo la formula "E questo avvenne affinché si adempisse la parola..."; cfr. però anche Mc 14,49). - Sono per lo più opera dei redattori i sommari, ossia brani, spesso di collegamento o conclusione, in cui viene descritto in termini riassuntivi e generali il comportamento abituale di Gesù in un certo periodo della sua attività. Prendendo in considerazione i casi più chiari, possiamo dire che ne abbiamo un buon numero, soprattutto nella prima parte del Vangelo. Ad esempio, 1,39: "E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni"; 6,6 b: "Gesù andava attorno per i villaggi, insegnando" 56. Alcuni di questi sommari hanno funzione introduttiva nei riguardi di singoli episodi o anche di sezioni. - la cornice, con cui si intende essenzialmente la serie dei brani di introduzione e di conclusione delle pericopi, che dovrebbero appunto essere di mano 55 Su questo passo ci soffermeremo nella seconda parte. 56 Per altri sommari cfr. 1,14-15; 2,13; 3,7-12; 6,12-13; ecc.

46
dell'evangelista; ogni evangelista ha un suo modo di legare e introdurre i brani. Si può notare che Marco spesso si limita a giustapporre, mentre gli altri collegano spesso con espressioni generiche che indicano un rapporto temporale, di contemporaneità o di successione (Matteo con tovte, "allora", ejn ejkeivnw/ tw~/ kairw~/, "in quel tempo", Luca e Giovanni con meta; tau~ta, "dopo queste cose"). Importanti sono le indicazioni geografiche e cronologiche, che in gran parte devono essere attribuite ai redattori e che acquistano spesso un valore simbolico: normalmente gli studiosi pensano che Marco ne abbia fatto uno scarso uso personale (per lo più avrebbe riportato indicazioni della tradizione), mentre Matteo e soprattutto Luca le avrebbero sviluppate: si sottolinea a questo proposito il significato fondamentale che hanno la Galilea in Marco e Gerusalemme in Luca (è centrale nel suo Vangelo il "viaggio verso Gerusalemme"); inoltre, anche indicazioni come monte, mare, ecc., dovrebbero essere intese secondo una valenza simbolica e non semplicemente locativa. Aulla "geografia" di Marco si veda l'Excursus più avanti. 2.1.4.1 . Un esempio di applicazione della Storia della redazione: la chiamata di Levi e il banchetto coi pubblicani (Mt 9,9-13; Mc 2,13-17; Lc 5,27-32) 57. Come abbiamo visto, la Storia della redazione si occupa in particolare degli interventi redazionali dell'evangelista (già riconosciuti dalla Critica delle fonti e dalla Storia delle forme) per cogliere la sua prospettiva particolare e capire anche in quale situazione vitale (Sitz im Leben) abbia operato. Su tutti i punti questo tipo di ricerca incontra difficoltà maggiori quando si occupa del Vangelo di Marco, perché non si hanno nel suo caso termini precisi di confronto con i precedenti, come invece si hanno per Matteo e Luca (presupponendo che conoscessero appunto Marco e questo Marco). Perciò per Marco più che per gli altri sinottici si procede per via ipotetica. Nel caso del brano in oggetto, esamina pertanto la redazione di ciascun evangelista confrontandola con quella degli altri Vangeli e confrontando gli interventi specifici di ogni testo con gli altri elementi redazionali ricavabili dall'analisi di tutto il Vangelo. Partiamo da Matteo e Luca per arrivare alla fine a Marco. Matteo Gli interventi più significativi attribuibili a Mt sono la sostituzione del nome proprio "Matteo" a "Levi" e l'inserzione della citazione biblica nel detto finale di Gesù. Il nome Matteo si ritrova nella lista dei dodici apostoli che Mt dà in 10,3 e si può pensare che l'evangelista abbia voluto qui presentare la chiamata specifica di un apostolo, come già in 4,18-22 aveva parlato della chiamata di altri quattro futuri apostoli: Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni. La
57 Cfr. Zimmermann, Metodologia, pp.74-88; 157-160; 208.

47
sostituzione del nome, come osserva un commentatore di Matteo 58, "corrisponde alla linea ecclesiologica di Matteo che identifica i discepoli di Gesù con i 'dodici'", attribuisce un ruolo essenziale ai Dodici, che saranno i capostipiti e il fondamento della Chiesa. Altri pensano che sia stata qui accolta una tradizione relativa a quello che si riteneva l'autore del Vangelo stesso (Matteo). Caratteristica è l'inserzione della citazione biblica, qui Osea 6,6 ("Misericordia voglio, non sacrificio"), che Matteo cita pure in un altro passo (12,7), ancora a proposito di una polemica coi farisei, questa volta sul rispetto del sabato. La citazione diventa il perno di tutto il brano in Matteo, per cui il comportamento di Gesù, che, in contraddizione con la condotta legalistica dei farisei, frequenta anche i peccatori, anzi li chiama a sé, si dimostra pienamente conforme alla Scrittura. Questa accentuazione di Matteo è un indizio della situazione della chiesa del suo tempo, impegnata a controbattere l'intransigenza e la tendenza legalistica dei cristiani di origine giudaica, che si opponevano ad una apertura universalistica. Luca Per Luca valgono come principali indizi significativi le due aggiunte dei vv.5,28 ("lasciando tutto") e 5,32 ("perché si convertano"). Lasciando tutto Levi adempie alla condizione richiesta da Gesù per mettersi alla sua sequela (cfr. 18,22: episodio del giovane ricco), condizione che già i primi discepoli avevano osservato (cfr. 5,11: ajfevnte" pavnta, "lasciato tutto"). Luca ama accentuare la radicalità come carattere della conversione. Con l'aggiunta "perché si convertano", poi, la chiamata - afferma Zimmermann - "non riguarda più, come in Marco, l'invito a partecipare alla tavola di Gesù come segno della partecipazione di Dio offerta ai peccatori, bensì significa la chiamata alla conversione. Il paradosso di Marco che consiste nel fatto che proprio i peccatori vengono invitati a partecipare al pranzo, è eliminato; la conversione è la condizione per la remissione dei peccati, e con ciò per la comunione con Cristo" 59. A questa restrizione del senso di kalei~n, trasl. kalèin, "chiamare", contribuisce anche il fatto che il banchetto è stato chiaramente organizzato da Levi, non da Gesù, e quindi non è Gesù che ha invitato direttamente i peccatori. E' un tema comune in Luca quello di sottolineare la necessità della conversione (cfr. 3,3; 15,7.10; 24,47). In questo orientamento a fornire esempi e insegnamenti soprattutto di tipo etico, si può collocare probabilmente anche il fatto che il rimprovero dei farisei e degli scribi è rivolto ora (5,30) ai discepoli e non a Gesù: questo sembra riflettere più da vicino l'esigenza di rivolgersi a tutta la comunità del tempo dell'evangelista.
58 R. Fabris, Matteo, Roma, Borla, 1982, p.217. 59 Zimmermann, Metodologia, pp.87-88.

48
Marco Nonostante la maggior ampiezza, il testo di Marco è quello più ambiguo e pieno di punti oscuri. E' stato osservato che in Marco è evidente l'operazione di cucitura di due episodi autonomi, perché egli si limita ad introdurre il secondo brano con un kaiv ("e") e non si preoccupa di appianare le difficoltà che derivano dalla combinazione: non chiarisce il tempo del banchetto né l'identità del padrone di casa (è possibile che originariamente fosse Gesù stesso); resta oscura anche la presenza di un folto gruppo di discepoli, di cui non si era ancora prima parlato nel Vangelo; anche la comparsa degli scribi e le circostanze in cui pongono la domanda ai discepoli non sono specificate: non si può facilmente pensare che fossero tra gli invitati e ancor meno tra i seguaci di Gesù. Marco anzi sembra voler sottolineare gli aspetti paradossali e i contrasti. Sottolinea più volte il gran numero dei seguaci di Gesù (2,13 e 15), facendo supporre che fossero in particolare, tra i suoi seguaci, molti proprio "i pubblicani e i peccatori". Eppure, dal suo testo si può intendere che fosse Gesù stesso a invitarli alla sua mensa, così come lui stesso aveva chiamato al suo seguito il pubblicano Levi. La comunione alla mensa, che già nella mentalità comune era il segno di una comunanza di vita e di sentimenti, acquista in un contesto religioso un alto valore simbolico: è comunione alla salvezza. Il comportamento di Gesù risulta dunque tanto più "scandaloso" rispetto a quello che risulta da Luca. L'indignazione degli avversari viene accresciuta dalla ripetizione dell'espressione ejsqivei meta; tw~n aJmartwlw~n kai; telwnw~n, "mangia con i pubblicani e i peccatori", in 2,16 (si noti l'inversione dei due termini nel primo caso: mentalmente gli scribi considerano quelle persone prima "peccatori", poi "pubblicani", dimostrando così il loro pregiudizio). L'impressione sconcertante della sua condotta è infine accentuata dal carattere assoluto dell'affermazione finale: "Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori", rispetto agli altri due evangelisti, che hanno appunto voluto qui correggere e attenuare. Marco vuole sottolineare che, per volontà di Gesù stesso, la comunità cristiana accoglie tutti, senza discriminazioni. 2.1.5. Un esempio di applicazione del metodo storico critico: Il battesimo di Gesù (Mt 3,13-17; Mc 1,9-11; Lc 3,21-22; Gv 1,29-34) 60
Ci troviamo di fronte ad un episodio fondamentale, riportato dall'intera tradizione evangelica all'inizio dell'attività pubblica di Gesù. Applicazione della Critica delle fonti
60 Si veda la sinossi allegata (All. 11 e 11 bis). Sull'episodio nei sinottici cfr. R. Infante, Il battesimo di Gesù (Mt 3,13-17 par.), in M. Laconi e collaboratori (a cura di), Vangeli sinottici e Atti degli apostoli, "Logos" 5, Leumann (Torino), LDC, 1994, pp. 199-211.

49
Appare netta la discrepanza tra la versione di Giovanni rispetto a quella dei sinottici: in Giovanni avviene soltanto un incontro tra il Battista e Gesù, manca il battesimo vero e proprio, e tutto è raccontato dal Battista come sua testimonianza. L'unico elemento comune tra Giovanni e i sinottici è la discesa dello Spirito come colomba su Gesù. Non c'è una voce celeste, ma si accenna a una rivelazione divina, rivolta al Battista. Tra i sinottici sono invece molti gli elementi comuni: il fatto che Gesù viene battezzato, l'apertura del cielo, la discesa dello Spirito come colomba, la voce dal cielo e soprattutto coincidono quasi perfettamente le parole con cui la voce si esprime, che sono una combinazione di passi veterotestamentari. Le differenze sono consistenti soprattutto tra Mt e Mc: Mt introduce un dialogo tra Giovanni e Gesù che manca in Mc; l'apertura dei cieli precede la visione; la voce dal cielo parla in terza persona, invece che in seconda. Confrontando Mc e Lc si nota, come differenze, il fatto che Lc colloca il battesimo di Gesù sullo sfondo del battesimo dell'intero popolo; presenta Gesù subito dopo il battesimo intento alla preghiera; menziona la "forma corporea" dello Spirito Santo. Sia nel caso di Mt sia nel caso di Lc le differenze fanno pensare al carattere secondario delle particolarità di queste due versioni rispetto a Mc. La versione di Mc, che risulta più breve, si mostra anche più primitiva. Però ci sono accordi tra Mt e Lc, contro Mc (Mt e Lc: "si aprirono i cieli"/ "si aprì il cielo"; Mc: "i cieli squarciati"),61 che fanno supporre qualche rapporto diretto tra Mt e Lc e rendono difficile accettare senza discussione la teoria delle due fonti. Applicazione della Critica storica Occorre collegare i particolari principali della scena, l'aprirsi dei cieli, la discesa dello Spirito, con i precedenti biblici e giudaici: l'aprirsi dei cieli è un tratto tipicamente apocalittico, che allude a una rivelazione speciale proveniente dal mondo celeste, ultraterreno; la discesa dello Spirito, o il dono dello Spirito, è collegata spesso con la figura del Messia (cfr. Is 11,2). E' invece più difficile spiegare il simbolo della colomba, che viene usato nelle varie fonti, bibliche e giudaiche, con significati differenti. Fondamentale, poi, è l'identificazione dei testi a cui le parole della voce celeste si richiamano: Sal 2,7; Is 42,1; Gen 22,1 (vedi oltre). Applicazione della Storia delle forme Il brano ha una sua unità letteraria, ma è difficile definire esattamente la forma, che risulta composita: c'è racconto di un fatto (battesimo di Gesù) e c'è una visione con audizione. Il senso stesso della visione e delle parole non è univoco: indica una vocazione? una sorta di investitura all'inizio della missione? è una visione interpretativa dell'evento descritto? è una rivelazione
61 Nella sinossi di A. Poppi allegata tali accordi sono segnalati graficamente col carattere maiuscolo.

50
teofanico-apocalittica? C'è rivelazione dell'identità di Gesù? Alcuni parlano di un genere letterario particolare. In ogni caso il fulcro dell'episodio è nella proclamazione celeste, che fondendo passi del Sal 2,7 ("Tu sei mio Figlio"), di Gen 22,2 ("figlio diletto", detto di Isacco), di Is 42,1 ("in te mi sono compiaciuto", detto del Servo sofferente), identifica Gesù: - col Messia potente destinato a dominare la terra (cfr. Sal 2,7-9: "Egli mi ha detto: Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra. Le spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla le frantumerai"); - col figlio unico di cui Dio chiede al padre, Abramo, il sacrificio (in tutto l'AT solo per Isacco ricorre l'espressione "il mio figlio diletto"); - col Servo sofferente di Iahvè, sul quale la divinità pone il suo spirito, e che è incaricato di ristabilire la giustizia sulla terra con mezzi pacifici e nonviolenti (cfr. Is 42,1-3: "Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta"). Applicazione della Storia della redazione Marco Quella di Mc risulta la versione più enigmatica. Il racconto pone l'accento proprio sul fatto del battesimo compiuto per mano di Giovanni, mentre Mt e Lc ne parlano secondariamente. Sia i fenomeni visivi sia quello auditivo sono rivolti a Gesù e non appaiono conosciuti da altri; lo stesso Giovanni sembra rimanere estraneo: nulla suggerisce che egli riconosca Gesù. Si tratta di un colloquio intimo tra Dio e Gesù, attraverso il quale Gesù prende coscienza della propria missione. Si può intuire che egli accetti il battesimo, un battesimo impartito "per la remissione dei peccati" (cfr. 1,4), proprio come il Servo di Is, che si carica dei peccati del popolo (cfr. Is 53,5-6), ma Marco non esplicita il significato dei fatti. Si affida ai contrasti che emergono dal racconto stesso: ad esempio, il contrasto tra le solenni assicurazioni fatte poco prima dal Battista, a proposito del "più forte" che deve "venire" e che deve impartire una battesimo superiore al suo (1,7-8), e la descrizione di Gesù che "venne" da Nazaret di Galilea (località abbastanza malfamata agli occhi dei giudei gerosolimitani)62 e fu semplicemente battezzato, senza clamori. Matteo Mt rielabora a fondo l'episodio con l'inserzione del dialogo tra i due personaggi (si noti la cornice costituita da due riferimenti al battesimo: v. 13:
62 Cfr. a questo proposito il dialogo, nel Vangelo di Giovanni (1,45-46) tra Filippo, che ha incontrato Gesù e lo riconosce come Messia, e Natanaele, che sentendo parlare di Gesù di Nazaret ribatte: "Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?". Si veda inoltre, nel medesimo Vangelo (7,41), il dibattito tra una parte della gente che riconosce in Gesù il Cristo e l'altra parte che dice: "Il Cristo viene forse dalla Galilea?".

51
"per essere battezzato", v. 16: "essendo stato battezzato"). Con questo dialogo rende esplicita la perplessità suscitata dal fatto che Gesù si faccia battezzare come un peccatore qualsiasi. In questo modo viene posta in bocca a Gesù una dichiarazione programmatica: "Ci conviene adempiere così ogni giustizia". Il termine e il concetto di "giustizia" (dikaiosuvnh, traslitt. dikaiosyne) sono caratteristici di Mt, che usa il vocabolo sette volte, mentre Mc non lo usa mai, Lc una volta sola e Giovanni due. Inoltre Mt attribuisce ad esso un significato molto forte, come indicano i passi in cui ricorre: cfr. 5,6 ("Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia"); 5,10 ("Beati i perseguitati a causa della giustizia"); 5,20 ("se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli"); 6,1 ("badate di non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro"); 5,33 ("cercate il innanzitutto il Regno e la sua giustizia"); 21,32 ("venne a voi Giovanni nella via della giustizia"): indica l'adempimento pieno della volontà di Dio, l'accettazione incondizionata del suo progetto salvifico, anche nei suoi risvolti più duri e fino alle estreme conseguenze. Le parole della voce celeste, che sono in terza persona ("Questi è il mio Figlio") e non in seconda, come in Mc ("Tu sei mio Figlio"), diventano un riconoscimento ufficiale, rivolto a tutti, dell'identità di Gesù, un conferimento solenne di autorità divina, un'approvazione esplicita della sua "giustizia". L'episodio forma "inclusione" con la parte finale del Vangelo, in particolare con le parole di Gesù che invia i discepoli a battezzare tutte le genti (28,19).63 Il comportamento di Gesù si propone quindi anche come una prefigurazione del battesimo cristiano e un esempio da seguire per tutti i credenti. Si può riconoscere una corrispondenza tra il richiamo trinitario del comando a battezzare ("nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo") e la presenza implicita della Trinità nel racconto del battesimo (il Figlio, la voce del Padre, lo Spirito). Luca Lc segue la versione di Mc più da vicino e si permette pochi cambiamenti. Collegando il battesimo di Gesù a quello di tutto il popolo sottolinea la condivisione da parte di Gesù della sorte del popolo peccatore. Introducendo il tema della preghiera (più di tutti Lc menziona la preghiera e presenta Gesù nell'atto di pregare: cfr. 5,16; 6,12; 9,18.28-29; 11,1; 22,41) esalta la comunione tra Gesù e il Padre e fa di Gesù il modello di ogni vero credente. Escludendo la figura di Giovanni, pone al centro la figura di Gesù. Accennando alla forma corporea dello Spirito sottolinea la sua visibilità: anche per Lc, come per Mt, la rivelazione è dunque rivolta, non soltanto a Gesù, ma ai presenti, al popolo.
63 L'inclusione è la ripetizione a distanza di termini, immagini, scene, che determina l'unità letteraria di tutto quanto sta in mezzo: in questo caso, i due riferimenti al battesimo, all'inizio della missione pubblica di Gesù e alla fine, ne determinano l'unità. Dell'inclusione parleremo ancora a proposito di uno dei nuovi metodi: l'Analisi strutturale.

52
2.1.6. La ricerca teologica 64
Tutti gli interventi apportati dal redattore ed esaminati secondo il metodo della Storia della redazione vanno intesi come espressioni di una propria e particolare interpretazione teologica, da parte dell'evangelista, della figura e della vicenda di Gesù. Ma per quanto riguarda l'aspetto teologico dei racconti evangelici, si può riconoscere che l'interesse a prenderlo in considerazione ha avuto anche un rilievo autonomo negli studi del '900 e ha comportato si può dire un'altra "rivoluzione" nella valutazione dei Vangeli e in particolare del Vangelo di Marco, soprattutto perché ha incominciato a incrinarsi la convinzione di poter servirsi dei Vangeli fondamentamentalmente come documenti storici e di poter quindi arrivare sulla base di essi a una "biografia di Gesù". Proprio partendo dalla lettura di Marco W. Wrede nel 1901 65 individuava la presenza in questo Vangelo di una intenzione teologica determinante, che presiede alla ricostruzione dei fatti, e che egli identificava con il famoso "segreto messianico": Marco cioè avrebbe di proposito sottolineato, fino al punto di farne un motivo caratteristico del suo Vangelo, la volontà di Gesù di imporre il silenzio sulla sua messianicità. Lo si vede da tutta una serie di episodi analoghi: l'imposizione ai demòni di tacere sulla sua identità di Figlio di Dio, il comando più volte ripetuto a coloro che sono stati guariti da lui di non dirlo a nessuno, fino all'ordine dato anche ai discepoli, dopo il riconoscimento da parte di Pietro che egli è il Cristo, di tacere; anche a proposito della rivelazione avvenuta nella trasfigurazione Gesù chiede loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, ma questa volta precisa: "fino alla risurrezione" (9,9). Questo motivo - è la scoperta conseguente di Wrede - è una costruzione artificiosa, frutto di riflessione teologica, dell'evangelista, il quale ha ribaltato sulla vicenda di Gesù la consapevolezza acquisita dalla comunità cristiana, a proposito dell'identità di Gesù, dopo la risurrezione. Il Gesù presentato dal Vangelo non è dunque tanto il Gesù storico (sebbene Wrede sia convinto che in Marco più che negli altri Vangeli restino comunque tracce di questo Gesù storico), quanto il Gesù rivisto dalla comunità cristiana. Un aspetto importante da mettere in rilievo è che Wrede è arrivato a queste conclusioni (a intravedere, cioè, la presenza nel Vangelo di uno schema unitario) attraverso un'analisi globale e sistematica del Vangelo, non limitandosi più, come spesso facevano gli studiosi precedenti, a studiare singoli passi.
64 Per questa parte mi rifaccio a V. Fusco, Il Vangelo di Marco. Il racconto ed il segreto, dispense del Seminario organizzato dall'Associazione Biblia, a Vallombrosa, nei giorni 28-31 agosto 1992, a cura di A. Celano Chiummariello. 65 Das Messiasgeheimnis in den Evangelien zugleich ein Beitrag zum Verständniß des Markusevangeliums (Il segreto messianico nei Vangeli insieme a un contributo per la comprensione del Vangelo di Marco), Göttingen 1901.

53
Anche se la tesi specifica di Wrede sarà per più versi criticata e corretta successivamente 66, si è però imposta l'esigenza di dare adeguato rilievo alla personalità dell'evangelista e alla sua visione teologica, di non limitarne il ruolo a quello di un semplice compilatore e raccoglitore di tradizioni. Un'importante sintesi storiografica di A. Schweizer sulle ricerche intorno alla "vita di Gesù" si intitolerà Von Reimarus bis Wrede, "Da Reimarus a Wrede", 67 proprio a evidenziare il mutamento di rotta che si è avuto negli studi a partire da questo momento. Per quanto non siano mancati eccessi e conflitti tra impostazione storica e impostazione teologica, la ricerca esegetica più avvertita di oggi cerca di tener presenti entrambi i punti di vista: non nega il fondamento storico del contenuto dei Vangeli, ma ammette che ogni evangelista ha scelto e disposto il materiale secondo una sua prospettiva teologica, che comporta accentuazioni diverse e correzioni rispetto agli altri. Per tutti i Vangeli vale la dichiarazione di Giovanni: "Questi [segni] sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome" (20,31). Ma al di là di questo scopo fondamentale, è diversa l'interpretazione della figura di Gesù e della sua opera nei diversi Vangeli, almeno in quanto ciascuno ha messo in rilievo aspetti diversi. Per il Vangelo di Marco, tradizionalmente considerato il più "primitivo", non solo perché più antico, ma anche nel senso di ingenuo, semplice, immediato, legato ai fatti, privo di elaborazione, e quindi di una vera e propria teologia, questa scoperta ha comportato conseguenze di rilievo per una nuova valutazione della sua opera 68. Un tempo veniva visto come l'estremo opposto rispetto al Vangelo di Giovanni, che appare indiscutibimente il più teologicamente elaborato; oggi si riconosce invece che ci sono affinità tra i due. E così quella che sembrava semplicità, trasparenza, limpidezza, oggi si è tramutata in ambiguità e oscurità per gli studiosi. Oggi si ammette che il Vangelo di Marco è il più sfuggente e misterioso, quindi il più difficile da interpretare. E' ancora aperto il dibattito su quale sia effettivamente la teologia di Marco. La domanda "Chi è Gesù?" è il grande tema del Vangelo di Marco, ma gli studiosi non sono d'accordo sulla risposta. C'è chi pensa che il Gesù di Marco sia innanzitutto il Risorto, il Vivente, il Signore; chi lo vede come taumaturgo, "uomo divino" (qei~o" ajnhvr), superiore agli uomini divini dei pagani; chi nota la
66 Nel senso che si è pensato che già Gesù avesse effettivamente consapevolezza della propria morte e risurrezione e intendesse già lui servirsi del segreto a scopo didattico: per guidare gradualmente a comprendere il senso della sua missione. 67 Von Reimarus bis Wrede (Da Reimarus a Wrede) era il titolo della prima edizione (Tübingen 1906), che voleva appunto delineare una rassegna degli studi a partire dall'iniziatore, H.S. Reimarus, vissuto nel '700, fino ai suoi tempi; la seconda edizione, del 1913, si intitolerà specificamente Geschichte der Leben-Jesu-Forschung (Storia dell'indagine sulla vita di Gesù). 68 E' significativo da questo punto di vista uno studio come quello di J. Ernst, che si intitola Marco. Un ritratto teologico, Brescia, Morcelliana, 1990.

54
centralità della croce, l'orientamento dominante di tutto il Vangelo verso la passione. Sembrano soprattutto in opposizione il Gesù dei miracoli, quale emerge dalla prima parte del Vangelo, e il Gesù della croce, che caratterizza la seconda parte, ma già si affaccia nella prima (cfr. 3,6). Se la centralità della croce è un punto acquisito dalla ricerca, resta da spiegare la funzione della storia antecedente di Gesù, dei miracoli (che pure sono particolarmente ampi in Marco) e della presenza dei discepoli accanto a Gesù, che è costante e caratteristica (Gesù non fa nulla senza i discepoli); in particolare il rapporto di Gesù coi discepoli, la loro crescente "incomprensione" e cecità nei riguardi delle cose dette e fatte da Gesù è un altro tema peculiare di Marco, che non si può trascurare. E' importante non puntare tutto su un solo aspetto, tener conto dell'insieme, ripercorrere tutti i momenti dall'inizio alla fine, seguire passo passo l'andamento drammatico del racconto. E' possibile riconoscere comunque che questi temi dell'identità di Gesù e dell'incomprensione dei discepoli sono alla base di uno schema complessivo del Vangelo (vedi All. 16). Certo Marco presenta, rispetto agli altri evangelisti, più contrasti, sproporzioni, paradossi, oscurità, tensioni. Gli altri cercano di semplificare, attenuare, facilitare. Un caso è già l'episodio del battesimo di Gesù che Marco pone nel prologo stesso del suo Vangelo (1,9-11): non c'è qui nessuna premessa: "venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni". Invece Matteo (3,13-17) cerca di prevenire dubbi e difficoltà spiegando le ragioni di questo battesimo con un dialogo tra Giovanni Battista e Gesù. Si veda pure la chiamata dei primi discepoli (Mc 1,16-20): Luca la introduce (5,1-11) dopo aver parlato della predicazione di Gesù e di alcuni miracoli e la inserisce nell'episodio della pesca miracolosa, sicché si capisce meglio perché questi pescatori (Pietro, Giacomo e Giovanni) avessero seguito Gesù. Marco invece la pone proprio all'inizio della missione di Gesù e delinea una scena assolutamente essenziale, ellittica, quasi astratta, in cui all'improvviso ordine di seguirlo consegue l'immediata risposta dei chiamati. Gesù non si era ancora manifestato in alcun modo, era uno sconosciuto che passava di là, eppure quei pescatori intenti al lavoro a una semplice sua parola lasciano tutto, barca, famiglia, per andargli dietro. Un altro esempio è quello del grido di Gesù sulla croce che in Marco ha un carattere drammatico, quasi disperato (15,34: "Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?"), e viene sostituito in Luca (23,46) dall'invocazione rasserenante del Salmo 31,6: "Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito". Per non parlare della conclusione, che è sorprendente: dopo la scoperta della tomba vuota e l'annuncio dell'angelo, le donne fuggono spaventate senza dire niente a nessuno (16,8). Non abbiamo le apparizioni del risorto, come negli altri vangeli. Oggi si è portati a leggere il Vangelo di Marco appunto come un dramma aperto. Guardando all'episodio del banchetto coi pubblicani secondo una prospettiva teologica, potremmo evidenziare il motivo dell'ostilità che

55
accompagna quasi subito la missione di Gesù e proietta fin dall'inizio l'ombra della croce su tutta la sua azione. Questo ci conferma la centralità che ha il tema della passione nel Vangelo di Marco. Non è però questo l'unico tema: c'è anche quello del Regno a cui allude l'immagine del banchetto, c'è quello del rapporto di Gesù coi discepoli, ecc. 2.1.7. Excursus. La geografia di Marco E' difficile sopravvalutare l'importanza che nel Vangelo di Marco hanno la Galilea e Gerusalemme : qui, più che in tutti gli altri Vangeli, l'attività di Gesù viene inquadrata in questi due luoghi fondamentali 69, in modo che spesso i commentatori ne deducono anche uno schema compositivo di tutto il Vangelo: una prima parte (1,14-10,52), in cui Gesù svolge il suo ministero in Galilea e dintorni, una seconda parte tutta ambientata a Gerusalemme (11-16) 70. Una variante di questo schema si articola invece in tre parti: ministero di Gesù in Galilea (1,14-7,23); viaggi di Gesù fuori della Galilea con ritorno in Galilea (7,24-9,50); salita a Gerusalemme e ministero a Gerusalemme (10,1-16,8) 71. Anche questa variante non risulta pienamente soddisfacente, perché già in 5,1-20 abbiamo un trasferimento di Gesù fuori dalla Galilea. Alcuni commentatori (Pesch, Ernst) pretendono che questo quadro rifletta semplicemente, seppure in modo vago, la cornice effettiva dell'attività di Gesù, anche se già dal punto di vista storico crea difficoltà il fatto che la linearità dell'itinerario di Gesù, che in Marco prevede una sola e definitiva andata a Gerusalemme, si scontra con le informazioni di Giovanni, secondo il quale invece Gesù si è recato più volte nella Città Santa a celebrare la Pasqua. Del resto, è stato fatto notare (da Rigaux) che anche Matteo e Luca, che pure seguono fondamentalmente il medesimo schema geografico di Marco, presuppongono una pluralità di viaggi a Gerusalemme, e lo stesso svolgimento dei fatti quali vengono presentati da Marco fa supporre che Gesù, quando entra in Gerusalemme, fosse già noto. Tutto ciò porta a riconoscere il carattere artificioso di questa costruzione imperniata su due poli geografici e ci avvia a comprendere la geografia di Marco essenzialmente come una "geografia teologica" 72. Indubbiamente la Galilea e Gerusalemme sono concepite da Marco, non semplicemente come luoghi determinati, ma piuttoso come emblemi di posizioni, anche religiose, contrapposte. Risulta con tutta evidenza che Gerusalemme rappresenta, non solo il luogo della condanna e della crocifissione di Gesù, ma in generale dell'ostilità da parte delle autorità religiose giudaiche verso di lui e verso il suo insegnamento. E questo si manifesta fin dagli inizi della missione in Galilea, quando scribi venuti da Gerusalemme lo accusano di essere addirittura un indemoniato (3,22 ss.) e, in altra occasione, criticano i discepoli perché non si attengono alle norme giudaiche di purità (7,1 ss.). Che ci sia un vero e proprio contrasto tra Galilea e Gerusalemme è suggerito dal fatto che la Galilea non ha buona fama presso gli abitanti della Giudea e di Gerusalemme, come indica l'atteggiamento sprezzante della serva del sommo sacerdote che, durante il processo di Gesù, guarda con sospetto Pietro perché dalla parlata lo riconosce come "galileo" (14,70). Le altre fonti evangeliche confermano e precisano questa impressione. In Giovanni la gente e soprattutto i farisei escludono che dalla Galilea possa mai venir fuori il Messia o anche solo un profeta (7,41.52) 73. Da Matteo apprendiamo che la Galilea era anche chiamata, evidentemente
69 Si noti che negli altri sinottici il racconto della nascita a Betlemme comporta invece un inizio in Giudea. Inoltre, si noti che Marco non parla mai della Samaria (la regione intermedia tra Galilea e Giudea), che è invece menzionata, e più volte, dagli altri Vangeli, specie da Giovanni. 70 Così Rigaux, p.23. Vedi All. 16. 71 Seguita, ad esempio, dalla Bibbia di Gerusalemme. 72 Cfr. Delorme, p.16. 73 Natanaele aveva anche chiesto ironicamente: "Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono"? (Gv1,46).

56
con giudizio negativo, "Galilea delle genti (Galilaiva tw~n ejqnw~n)" (Mt 4,15), probabilmente perché per la sua posizione di confine aveva contatti più frequenti con i pagani: proprio per questo era considerata dai giudei "ortodossi" più esposta alle contaminazioni rituali e alle deviazioni dottrinali. Ma quello che per scribi e farisei era un aspetto deteriore di questa regione, diventa per Gesù occasione positiva per la sua missione. Nel racconto di Marco, infatti, la Galilea, pur all'interno di una certa ambiguità (Nazaret resta un luogo refrattario alla fede: 6,1-6), costituisce sostanzialmente un luogo aperto alla predicazione e all'opera taumaturgica di Gesù, il luogo in cui egli raccoglie i suoi discepoli e ottiene molti successi. E Gesù promette alla fine di ritornare ancora in Galilea dopo la risurrezione, per mettersi di nuovo alla guida dei suoi discepoli (14,28): anche il messaggero celeste lo ricorderà nella tomba vuota (16,7). La Galilea dunque si pone come luogo di partenza ma anche di ritorno per un nuovo inizio: è in qualche modo il luogo ideale per l'evangelizzazione. Perché? Se teniamo conto della finalità che Gesù ha stabilito per il suo vangelo, che deve essere annunciato "a tutte le genti" (eij" pavnta ta; ejvqnh) e in tutto il mondo (13,10; 14,9), si può pensare che la Galilea, proprio per la sua posizione confinante con regioni pagane, meglio si prestasse all'allargamento della missione. E infatti vediamo Gesù oltrepassare più volte nel Vangelo i confini della Galilea per operare anche in terra straniera, e con successo: nella regione dei Geraseni (c.5), a Tiro e Sidone e nella Decàpoli (c.7):74 l'incontro con la sirofenicia (7,24-30), anzi, costituisce una tappa molto importante della missione, tappa che esplicitamente si ricollega con la polemica sempre più aspra verso il rigorismo assurdo e ottuso di scribi e farisei (7,1 ss.) e segna una vera e propria presa di coscienza, da parte di Gesù, della necessità di rivolgersi anche ai non giudei. Osserva opportunamente Delorme 75 che la rottura con le tradizioni cultuali degli ebrei espressa nella discussione "si traspone nella geografia", cioè nell'andare in terra pagana, incontro a una pagana. Inoltre non sarà un caso che una serie di eventi che segnano una sorta di spartiacque nel Vangelo: il riconoscimento della messianicità di Gesù da parte di Pietro a Cesarea di Filippo, il primo annuncio della passione, con le istruzioni sul vero discepolato (c.8), la Trasfigurazione (c.9), si verifichino in territorio pagano, durante una deviazione fuori dalla Galilea, ma con ritorno in Galilea (9,30). Del resto, come già si è detto, il culmine del riconoscimento dell'identità di Gesù sarà realizzato effettivamente da un pagano, ossia dal centurione, nella scena della morte (15,39). Un elemento caratteristico della Galilea è quello che Marco chiama "il mare della Galilea" (1,16; 7,31), o semplicemente "il mare" (hJ qavlassa), ossia il lago di Tiberiade 76: è intorno ad esso che ruota molta dell'attività di Gesù, dalla chiamata dei primi discepoli sulle rive del mare, all'insegnamento in parabole svolto sulla barca, ai due miracoli che si svolgono sul mare in tempesta, all'attraversamento del mare per raggiungere più volte il territorio pagano. "L'altra riva del mare" (cfr. 5,1) rappresenta infatti la terra straniera anche in senso religioso e andare "all'altra riva" (8,13) segna la volontà di allontanarsi dall'ambiente dei giudei. Il centro del movimento che porta da un certo momento in poi Gesù a spostarsi continuamente tra la riva giudaica e quella pagana è dunque il mare di Galilea. Esso rappresenta come il ponte di passaggio (anche metaforico) verso i pagani. Perciò forse è menzionato in 7,31 77, all'interno di una serie di indicazioni geografiche che sulla carta tracciano un itinerario apparentemente assurdo e del tutto improbabile (Gesù si dirigererebbe da Tiro verso il lago di Galilea, in mezzo
74 Si consulti la cartina sulla Palestina nell'All. 10. 75 Delorme, p.17. 76 L'interesse particolare di Marco per "il mare" emerge già dai dati: Marco lo menziona ben 19 volte, contro 17 di Matteo, 3 di Luca e 9 di Giovanni. 77 7,31: "E di nuovo, uscito dal territorio di Tiro, venne attraverso Sidone verso il lago della Galilea, in mezzo al territorio della Decapoli".

57
alla Decapoli, attraversando Sidone 78: uno degli indizi, secondo i commentatori, della geografia confusa e scorretta di Marco!), ma che si può spiegare, almeno in parte, appunto con la volontà di ribadire l'intenzione di Gesù di andare verso tutto il mondo pagano che è oltre la Galilea. Emblematicamente, il mare rappresenta il dominio delle forze ostili, demoniache, che Gesù vuole sconfiggere con il suo insegnamento e la sua opera e che ha bisogno di sconfiggere per raggiungere anche i pagani. Il carattere ostile e demoniaco del mare, oltre che già ben presente nella tradizione biblica (dal Mar Rosso al mare da cui salgono le bestie apocalittiche di Daniele, c. 7) è suggerito dai tratti descrittivi delle scene di tempesta, in cui Gesù si comporta col mare come con i demòni (simili sono i termini con cui li zittisce: cfr. 1,25: ejpetivmhsen, "minacciò", e fimwvqhti, "taci"; 4,39: ejpetivmhsen e pefivmwso). Parlando del mare abbiamo notato una certa convenzionalità nell'uso del termine. Questo stesso fenomeno si può riconoscere anche per altre indicazioni generiche, come monte, deserto, casa, ecc. Ciascuna di esse ha senso, non tanto come riferimento a località precise, quanto come rinvio a situazioni connotate in questo modo, con richiamo non di rado a precedenti veterotestamentari. Non sempre i commentatori sono disposti a seguire questa linea interpretativa e si affannano nella ricerca dell'identificazione dei luoghi così suggeriti, con risultati che su questo piano non possono che essere fallimentari. Sono tipici i casi del "monte" (to; ojvro") su cui Gesù chiama i Dodici e del monte su cui avviene la Trasfigurazione. Marco si esprime in modo molto sobrio: "E salì sul monte" (3,13), "E li (i discepoli) portò su un alto monte loro soli, in disparte" (9,2). A proposito del primo monte alcuni commentatori (cfr. Uricchio e Stano) hanno rilevato qualche difficoltà, perché nelle vicinanze del lago dove Gesù si trovava in quel momento (cfr. 3,7) non si trovano vere e proprie montagne; a proposito del monte della Trasfigurazione, che ha interessato ancora di più gli studiosi, da tempo si discute se sia il Monte Hermon (m.2814), che si trova a nord della Galilea e in territorio pagano, non lontano da Cesarea di Filippo, che è il luogo menzionato poco prima (cfr. 8,27), o il Monte Tabor (m.588), che invece si trova in Galilea, a sud-ovest del lago, e a cui ha pensato la tradizione cristiana fin dal IV secolo. Ora, seguendo le indicazioni date da Marco, è senz'altro più opportuno ritenere che l'avvenimento abbia luogo in terra pagana, come già si è detto. Inoltre, sono più importanti le connotazioni simboliche legate al monte. Il monte rappresenta, già nella tradizione ebraica antecedente, il luogo della vicinanza di Dio e della rivelazione. Il rinvio obbligato è al Monte Sinai, su cui Mosè ricevette le Tavole della Legge, o al Monte Horeb, su cui Elia ebbe una manifestazione divina. In quanto luogo di distacco dalla folla e dalle attività quotidiane e di accostamento alla divinità, il monte è menzionato inoltre nel Vangelo come sfondo della preghiera di Gesù (cfr. 6,46). Il Monte degli Ulivi (13,3) è sede dell'importante "discorso escatologico", ma anche della preghiera di Gesù nell'orto del Getsemani (14,26). Anche "il deserto" (hJ ejvrhmo", hJ hJremiva) è fortemente connotato dai tratti veterotestamentari, fin dal prologo, dove Giovanni Battista compare nel deserto a battezzare e poi Gesù stesso viene spinto dallo Spirito a rimanere nel deserto per quaranta giorni (tentato da satana e assistito dagli angeli). Già nella citazione di Isaia (40,3), fatta in 1,3, è il deserto il luogo in cui deve essere preparata la strada per la venuta del Signore. Giovanni è poi descritto coi tratti di Elia, che secondo il racconto dei Libri dei Re operò nel deserto. Ma, ancor prima, l'avvenimento fondamentale di riferimento sono i quarant'anni trascorsi dal popolo ebraico nel deserto (ad essi rinvia inequivocabilmente il periodo di Gesù nel deserto), durante le peregrinazioni che intercorsero tra l'esodo dall'Egitto e l'ingresso nella Terra Promessa: nel deserto l'antico Israele ricevette le Tavole della Legge e sperimentò la bontà provvidente di Dio in numerosi eventi straordinari (manna, quaglie, acqua dalla roccia, colonna di fuoco, ecc.) e insieme subì molte prove e punizioni per le sue deviazioni dalla fede nell'unico Dio.
78 Sidone è alquanto a nord rispetto a Tiro, mentre il lago di Galilea è a sud rispetto a Tiro, e la Decapoli ancora più a sud. E' possibile che la menzione di Sidone in connessione con Tiro dipenda dal legame fisso che le due città avevano sempre nella tradizione.

58
Il deserto è dunque essenzialmente un luogo ambiguo: è il luogo della tentazione demoniaca e insieme il luogo che favorisce l'incontro con Dio, perché luogo di raccoglimento e di ritiro. In questo senso più volte nel Vangelo viene menzionato ancora il deserto, ma in questo caso "luogo deserto" (ejvrhmo" tovpo"), come luogo di preghiera e di isolamento di Gesù (1,35.45) e di riposo per i discepoli (6,31). Nel deserto avvengono le due moltiplicazioni dei pani (6,32.35; 8,4). "La casa" (hJ oijkiva, oJ oij~ko") è più volte menzionata nel periodo galilaico come punto di riferimento di Gesù. Si parla esplicitamente di una casa a Cafarnao (2,1; 9,33), che si è voluta identificare con la casa del discepolo Simone (1,29), dove Gesù opera la guarigione della suocera di lui 79. Spesso però si parla di casa in modo generico. Talora risulta chiaro che anche altrove Gesù abita in casa: in 7,24 egli si trova nel territorio di Tiro, ma anche qui entra "in casa". Anche quando va a Gerusalemme egli preferisce abitare in una casa di Betania (la casa di Simone il lebbroso: 14,3). Ancora una volta contano le connotazioni che assume la "casa" per Gesù. E' già di per sé importante il fatto che Gesù non ha una sola casa, ma si sposta di casa in casa, secondo le regole della missione itinerante che egli dà anche ai suoi apostoli (6,10). Del resto egli afferma esplicitamente la necessità per chi intende seguirlo di lasciare la propria casa e la propria famiglia, con la compensazione, però, di ritrovarle moltiplicate (10,29.30). Di fatto, le case in cui viene di volta in volta a trovarsi non coincidono con la casa d'origine, la casa di famiglia, anzi questa gli si rivela come un luogo ostile, quando ritorna a Nazaret (6,4). Anche in un altro episodio Gesù prende le distanze dalla tentazione di far coincidere la casa con la famiglia di sangue: a un certo momento, infatti, i suoi parenti carnali vanno da lui, mentre è in casa (probabilmente a Cafarnao), per portarselo via, perché pensano che sia pazzo (3,20): essi però restano "fuori" (3,31.32), mentre Gesù riconosce in coloro che gli stanno "intorno" la sua vera madre e i suoi veri fratelli (3,34). In questo caso le mura della casa sono diventate confini che delimitano la vera parentela di Gesù, in quanto accolgono coloro che fanno la volontà di Dio. In ogni modo la casa rappresenta il luogo in cui Gesù si rifugia per trovare respiro dalla calca e parlare più intimamente coi discepoli, fornire loro insegnamenti più profondi (7,17; 9,28.33; 10,10). Il miracolo della risurrezione della figlia di Giairo, compiuto davanti ai discepoli prediletti, avviene in casa (5,38). Quando è in casa, Gesù vorrebbe che non si sapesse per sfuggire alla gente (7,24), ma non gli riesce mai. La casa di Gesù resta sempre una casa aperta: la folla preme alla sua porta al punto da non lasciare più spiragli (2,2), gli porta tutti i malati della città (1,32-33), talora scoperchia perfino il tetto per far entrare un paralitico (2,4); anche in terra straniera, subito viene qualcuno a chiedergli una guarigione (7,24-25). La folla di norma invade la casa: entra e siede intorno a Gesù (3,32); va e viene e impedisce a lui e ai suoi discepoli perfino di mangiare (3,20; 6,31). Perciò, per trovare davvero solitudine e intimità, essi devono talora uscire e andare nel deserto (1,35; 6,31). Anche "la sinagoga" (hJ sunagwghv) è un luogo con un significato ben preciso: come luogo della presenza di Gesù viene menzionata poche volte e soltanto nella parte dedicata alla missione in Galilea, ma dal sommario di 1,39 risulta essere stata il campo più comune dell'annuncio di Gesù in Galilea. Le menzioni particolari di episodi ambientati in una sinagoga non sono mai casuali. L'insegnamento impartito di sabato in due sinagoghe (quella di Cafarnao e poi quella di Nazaret) incornicia tutta la prima sezione dell'attività di Gesù (1,21 ss.; 6,2 ss.), mentre ancora un miracolo compiuto di sabato nella sinagoga di Cafarnao sta al centro di questa sezione (3,1 ss.) e segna un momento culminante della polemica con gli avversari (essi decidono addirittura di ucciderlo). La sinagoga, luogo tradizionale di riunione cultuale per gli ebrei, e in particolare dell'insegnamento degli scribi (cfr. 1,22; 12,38-39), viene connotata negativamente e in modo crescente, perche l'insegnamento di Gesù, che pure si accompagna alla cacciata dei demòni, viene accolto dapprima con stupore, poi con scandalo e infine decisamente con incredulità. Ben si accorda con questa immagine negativa il preannuncio che Gesù fa anche ai suoi discepoli di essere flagellati nelle sinagoghe (13,9).
79 Con eccessiva disinvoltura e molto impropriamente van Iersel (p.81) parla di un pied-à-terre di Gesù a Cafarnao.

59
Gesù finisce con l'abbandonare definitivamente la sinagoga come luogo di insegnamento, a favore dei luoghi aperti, di passaggio: la riva del mare, il deserto, i villaggi, i campi, fino al luogo aperto per eccellenza, la strada. Il corrispettivo delle sinagoghe della Galilea è, a Gerusalemme, "il tempio" (to; iJerovn). Come l'inizio della missione in Galilea è segnato dall'entrata in una sinagoga, così l'ingresso in Gerusalemme coincide con l'ingresso nel tempio (11,11) e l'insegnamento nel tempio occupa si può dire buona parte dell'attività di Gesù prima dell'arresto ed è spesso esplicitamente rilevato, in modo quasi formulare (cfr. 11,15.17; 12,35 80; 14,49). Come nella sinagoga di Cafarnao, così nel tempio di Gerusalemme Gesù si scontra con le autorità religiose giudaiche (sommi sacerdoti, scribi, anziani, farisei, sadducei) in una serie di cinque dispute. Il distacco dalla sinagoga trova il suo corrispettivo nella condanna dell'uso che del tempio hanno fatto i capi giudei (da casa di preghiera a "covo di briganti": 11,17) e addirittura nella predizione della sua distruzione (13,1-2). La conclusione ultima sarà lo squarciarsi simbolico del velo del Tempio al momento della morte. "La strada" (hJ oJdov") è indubbiamente, non tanto un luogo, quanto un tema specifico di tutto il Vangelo 81, che non a caso viene presentato fin dalle prime righe, nella citazione biblica imperniata appunto sulla preparazione della strada del Signore (1,2-3) e si ripropone, implicitamente, anche nella conclusione, con l'annuncio da parte del messaggero celeste di un nuovo cammino dei discepoli in Galilea sotto la guida di Gesù (16,7). Ma è soprattutto significativo l'intensificarsi di questo motivo nella sezione centrale del Vangelo, in coincidenza con gli insegnamenti di Gesù relativi alla propria passione e alla condotta che devono tenere i suoi seguaci. "Per strada" (la strada verso Gerusalemme, ossia verso la croce) Gesù chiede ai suoi discepoli quale opinione la gente abbia di lui (8,27) e ottiene da Pietro il famoso riconoscimento che egli è il Cristo; "per strada", dopo che Gesù ha loro fatto il secondo preannuncio della passione, i discepoli, che non hanno compreso, si interrogano su chi di loro sia il più grande (9,33-34); "per strada" Gesù impartisce il suo insegnamento sui pericoli della ricchezza (10,17) e fa il terzo preannuncio della passione (10,32); "per strada" il cieco di Gerico viene guarito e segue Gesù nel cammino verso Gerusalemme, facendosi così modello di vero discepolato (10,46.52). Si può dire che sia la strada il luogo più conforme allo stile di vita di Gesù e dei suoi discepoli (cfr. 6,8: i discepoli sono inviati in cammino), quello che corrisponde meglio allo scopo ultimo: la diffusione del vangelo a tutte le genti, in tutto il mondo. Particolarmente parco è Marco nelle indicazioni di nomi propri di luoghi, a parte Gerusalemme. Menziona quattro volte Betania, tre volte Cafarnao, tre volte Tiro, due volte Betsaida, una volta Nazaret, Genesaret, Sidone, Gerico, Betfage, ecc. Ma bisognerebbe anche notare le quattro ricorrenze del Giordano, le due della Decapoli, la ricorrenza dell'Idumea, ecc. Certamente Marco riporta notizie della tradizione, ma è già significativo che, in questo caso, probabilmente operi una scelta cosciente: ad esempio, non menziona Corazin, dove sappiamo da Matteo e Luca che avvennero numerosi miracoli 82. In qualche caso la menzione dei nomi di luoghi può acquistare sfumature più intense per le reminiscenze bibliche di cui sono carichi. Ad esempio il Giordano (citato in 1,5.9; 3,8; 10,1) era noto come il fiume che il popolo ebraico attraversò prima di entrare nella Terra Promessa; il passaggio del fiume sotto la guida di Giosuè, simile al passaggio del Mar Rosso, era stato celebrato con un monumento commemorativo 83: attraversare il fiume segna un momento solenne. Non potrebbe essere,
80 Si noti il parallelismo di espressione tra 6,2: "Insegnare nella sinagoga", e 12,35: "insegnando nel tempio". 81 Esiste anche una monografia specifica: E. Manicardi, Il cammino di Gesù nel Vangelo di Marco, Rome, Biblican Institute Press, 1981. 82 Cfr. Rigaux, p.24. 83 Cfr. van Iersel, p.65, che nota il valore della menzione del Giordano, come allusione al tema della conversione e del cambiamento di vita, per il prologo: Giovanni Battista battezza nel Giordano, Gesù viene al Giordano per essere battezzato.

60
allora, che l'indicazione strana che Marco dà in 10,1 ("viene nel territorio della Giudea e oltre il Giordano": l'ordine logico è inverso) e che ha fatto dire ancora una volta che "senza dubbio Marco ha un'idea sbagliata della geografia" 84 - oppure ha indotto a intendere diversamente il pevran (come "lungo" invece che come "oltre, al di là", che è più comune) 85 - si spieghi con l'intenzione di introdurre una connotazione teologica legata al "passaggio del Giordano"? Si tratta in effetti per Gesù di compiere un passo decisivo verso Gerusalemme (cfr. 10,36) 86, verso la morte e la risurrezione, che sono oggetto di ben tre preannunci in questa medesima sezione. Verso la morte e la risurrezione, che saranno strumento di salvezza e di riscatto per molti (10,45. 14,24), in qualche modo, quindi, la vera e definitiva Terra Promessa. Anche la collocazione dell'episodio della guarigione del cieco a Gerico (il nome della città è menzionato due volte nel medesimo versetto: 10,46), subito prima dell'ingresso in Gerusalemme, può non essere casuale, se si ricorda che al tempo di Giosuè la conquista di Gerico aveva costituito una tappa fondamentale ai fini dell'ingresso vero e proprio nella Terra Promessa 87. Dovremmo dunque postulare che le indicazioni di luogo non siano mai prive di significato, anche se talora a noi sfugge questo significato, perché ci mancano informazioni sulle connotazioni che certi nomi potevano avere. Dobbiamo stare attenti anche a squalificare certi itinerari apparentemente scombinati, perché non trovano rispondenza sulla carta. Una questione particolare riguarda il viaggio a Betsaida: lo esamineremo nella seconda parte. La cronologia Anche la cronologia del Vangelo, come la geografia, risulta piuttosto vaga. Ancor meno che gli altri Vangeli il Vangelo di Marco presenta la struttura di una biografia: non incomincia neppure dalla nascita del protagonista e non fornisce nessuna indicazione storica, a differenza, ad esempio, di Luca, che invece, sia a proposito della nascita di Gesù, sia a proposito della predicazione del Battista, e quindi del battesimo di Gesù (2,1ss.; 3,1 ss.), fissa precisi riferimenti cronologici richiamandosi alle autorità di governo della Palestina e dell'impero, e anche alla successione dei sacerdoti. Anche per quanto riguarda l'attività pubblica di Gesù la tendenza di Marco è quella di fornire un quadro schematico ed essenziale: l'impressione che se ne potrebbe ricavare è che tutto il ministero di Gesù si sia svolto nell'arco di un anno solo, mentre sappiamo da Giovanni che dovette durare senz'altro di più (oltre due anni). Manca l'interesse a fissare con esattezza la datazione dei singoli avvenimenti, che per lo più sono collegati da notazioni molto generiche, come: "e", "di nuovo", "in quei giorni", "dopo che", "poi", "mentre", "subito": di "subito" (eujquv") Marco sembra abusare, dato che vi ricorre almeno 41 volte, contro le 18 di Matteo, 7 di Luca e 6 di Giovanni. Raramente abbiamo l'accorpamento di più avvenimenti in periodi determinati: è stata spesso notata la costruzione, proprio all'inizio del Vangelo, della "giornata di Cafarnao" (1,21-38), che contiene la guarigione dell'indemoniato nella sinagoga, la guarigione della suocera di Pietro e altre guarigioni alla sera, si conclude al mattino del giorno dopo, quando Gesù, dopo aver pregato, si trasferisce coi discepoli in altri villaggi della Galilea. Un particolare interesse è stato rivolto alla cronologia della passione, che, contrariamente alla tendenza generale, è caratterizzata da abbondanza e minuzia di particolari: ritroviamo infatti a partire dal cap.11 tutta una serie di indicazioni precise: sera, alba, riferimenti ai giorni della Pasqua e, per il giorno della morte, addirittura le ore, e poi la vigilia del sabato, il giorno dopo il sabato; indicazioni che complessivamente scandiscono i giorni di una settimana.
84 Schweizer, p.214. Cfr. anche Uricchio-Stano, p.438. 85 Cfr. Pesch, II, p.190. Le difficoltà furono sentite già dai copisti che introdussero varianti. 86 Schweizer (p.214) accenna invece alla possibile sottolineatura, sempre teologica, della Giudea, il luogo della croce. 87 Cfr. Radermakers, p.241.

61
Si è spesso ritenuto che i collegamenti per lo più imprecisi e stereotipati dipendano dalla necessità di connettere in qualche modo brani della tradizione che erano circolati autonomamente, senza collocazione precisa, e dall'estremo rispetto di Marco per la tradizione, dal suo ritegno a rielaborare in proprio il materiale ricevuto. Conseguentemente, si è pure pensato che i collegamenti di più episodi in periodi di tempo delimitati fossero già stati fatti prima di Marco e che Marco li erediti dunque anch'essi dalla tradizione. Questo si rivela particolarmente importante per la cronologia della passione, che è stata studiata (ad es., da Schmid, Pesch) soprattutto allo scopo di identificare storicamente il giorno della morte di Gesù e risolvere il problema delle differenze tra la tradizione sinottica, che pone la morte di Gesù nella ricorrenza della Pasqua ebraica, subito dopo la cena della vigilia pasquale (il che corrisponderebbe al 15 del mese ebraico di Nisan), e la tradizione giovannea, che invece pone la morte di Gesù un giorno prima, il 14 di Nisan, nel giorno della vigilia. Il giorno della settimana sarebbe sempre il venerdì, diversa sarebbe la data mensile. La questione aveva provocato controversie tra le chiese già nell'antichità, perché influenzava la scelta del giorno da celebrare annualmente come Pasqua: le chiese dell'area giovannea si caratterizzavano per la celebrazione il giorno 14 di Nisan ed erano perciò denominati quattordecimani. La cronologia marciana (e sinottica) è stata talora preferita (da Schmid, Pesch) perché risulterebbe, a differenza di quella giovannea, priva di tendenze teologiche: Giovanni, o una tradizione a lui anteriore, avrebbe modificato i dati per presentare Gesù come vero agnello pasquale, dato che sarebbe morto nel giorno stesso in cui si sacrificavano gli agnelli per la cena. Pesch 88 è in generale convinto che la cronologia di Marco abbia valore storico e che non vi si debba normalmente attribuire un più profondo significato simbolico. Ma è vero? Si noti che la questione manterrebbe il suo valore, anche se si potesse accertare che in molti punti Marco riprende semplicemente dati della tradizione: già nella tradizione può essersi verificata un'intenzionalità e Marco l'ha fatta propria. In realtà, in alcuni casi è possibile riconoscere chiaramente che certe indicazioni cronologiche hanno valore simbolico. Un caso tipico sono i 40 giorni di permanenza di Gesù nel deserto (1,13), che rinviano, come già si è notato a proposito dell'immagine del "deserto", a varie indicazioni veterotestamentarie imperniate sul numero 40 (innanzitutto i 40 anni del popolo ebraico nel deserto, poi i 40 giorni di cammino di Elia per raggiungere il Monte Horeb, ecc.): in questo modo il periodo di prova di Gesù viene assimilato a quelli della storia antica e ne ricava nuovi significati. Per altre indicazioni, è meno facile individuare un riferimento chiaro: ad esempio, per l'indicazione, apparentemente strana, "dopo 6 giorni" che introduce il racconto della Trasfigurazione (9,2), indicazione certamente non casuale, dato che sono pochissime le specificazioni cronologiche di tipo numerico, a parte quelle del racconto della passione. C'è chi ha pensato, di nuovo, a un precedente biblico: a Mosè che attende 6 giorni sul Monte Sinai, prima di essere chiamato da Dio (Esodo 24,15-16). Per la settimana della passione, già vari studiosi si sono preoccupati di trovare un significato teologico alla scansione cronologica dei giorni, con risultati però contraddittori 89. E questo sia perché c'è spesso la preoccupazione di distinguere tra ciò che appartiene alla tradizione e ciò che Marco come redattore ha aggiunto di suo, sia perché spesso la ricerca risulta in qualche modo condizionata da preconcetti: quelli di accentuare l'importanza, nella teologia marciana, del giorno della morte (venerdì) oppure del giorno della risurrezione (domenica), per cui si cerca di far coincidere il settimo giorno indicato da Marco col giorno ritenuto più importante. Ma per far questo si trascurano a volte indicazioni contenute nel testo. Se si seguono tutte queste indicazioni risulta che i giorni scanditi da Marco incominciano con la domenica (ingresso di Gesù a Gerusalemme) e si concludono con il giorno dopo il sabato, ancora la domenica, giorno della risurrezione. Il punto di riferimento è l'indicazione relativa al venerdì (15,42).
88 I,p.73. 89 Una rassegna di posizioni e un contributo originale sul tema dà E. Corsini nell'articolo La settimana della passione nel Vangelo di Marco, in "Civiltà Classica e Cristiana" 6 (1985), pp.241-251.

62
La prima indicazione è quella di 11,11: "essendo ormai l'ora tarda, se ne andò a Betania" = sera del 1° giorno (domenica); abbiamo poi: "11,12: "E al mattino, partiti da Betania" = mattino del 2° giorno (lunedì); 11,19: "E quando fu sera, uscirono dalla città" = sera del 2° giorno; 11,20: "E passando di là di buon'ora" = mattino del 3° giorno (martedì); 14,1: "mancavano due giorni a Pasqua e agli Azzimi" = 4° giorno (mercoledì); 14,12: "E il primo giorno degli Azzimi" = 5° giorno (giovedì); 14,17: "E venuta la sera" = sera del 5° giorno; 15,1: "E subito di buon'ora" = mattino del 6° giorno (venerdì); 15,25: "Era l'ora terza" = le nove; 15,33: "E giunta l'ora sesta si fece buio su tutta la terra fino all'ora nona": da mezzogiorno alle tre ; 15,34: "E all'ora nona" = alle tre; 15,42: "E giunta ormai la sera, poiché era la Parasceve (preparazione), cioè la vigilia del sabato" = sera del 6° giorno; 16,1: "E trascorso il sabato" = 7° giorno; 16,2: "E molto di buon'ora, il primo giorno dopo il sabato ... al sorgere del sole" = 8° giorno (domenica). La presentazione dei giorni di questa settimana si offre a molte considerazioni, la prima delle quali è che siamo di fronte a uno schema sicuramente costruito intenzionalmente, e che ha importanza per Marco, mentre gli altri evangelisti la modificheranno. I primi tre giorni, o almeno i primi due fino all'alba del terzo giorno, giorni in cui Gesù va e viene nel Tempio (entra solennemente al suo ingresso in Gerusalemme, scaccia i mercanti) si succedono con ritmo incalzante (11,11.12.19.20), poi abbiamo una lunga pausa: il terzo giorno è dilatato per la gran quantità di cose che vi capitano: almeno cinque dispute con i capi giudei nel Tempio (cap.12) e tutto il lungo discorso escatologico del cap.13 pronunciato davanti al Tempio. Comunque questi primi tre giorni sono tutti collegati col Tempio. La scansione cronologica degli altri tre giorni, l'ultimo dei quali è quello della passione, segna come un nuovo inizio perché le indicazioni cronologiche si appuntano ora sulla Pasqua: perciò si indicano il quarto e il quinto giorno in base ai giorni che mancano alla Pasqua e agli Azzimi (abbiamo una sorta di "conto alla rovescia"). Al sesto giorno, quello della condanna, crocifissione e morte, abbiamo un rallentamento temporale che scandisce, oltre alla sera e alla mattina, le ore (terza, sesta, nona). Sia nell'elencazione dei giorni, sia delle ore, si può notare la tendenza a una scansione ternaria, che raggruppa giorni e ore a tre a tre. Come per i giorni, anche le ore gravitano sugli ultimi tre elementi (gli ultimi tre giorni sono quelli della Pasqua; dall'ora sesta alla nona c'è il buio che precede la morte). Tutto converge a sottolineare l'importanza della morte, che è nel contempo la Pasqua. Si noti che, secondo il modo semitico di calcolare, anche l'evento della risurrezione viene sempre posto "tre giorni dopo" la morte (8,31; 9,31; 10,34), intendendo il terzo giorno. Poi abbiamo nuovamente un cambiamento e una pausa: le successive indicazioni cronologiche spostano l'attenzione sul sabato, ma il sabato è un giorno vuoto, in cui non succede nulla, in cui Gesù è nella tomba. Alla vigilia c'è la sepoltura, il giorno dopo c'è la risurrezione. L'interesse vero è per quel primo giorno dopo il sabato, che segna un nuovo inizio, e la posività di questo giorno è sottolineata anche dalla notazione, apparentemente ridondante, del sorgere del sole. Le caratteristiche di questa settimana consentono di trarne varie riflessioni. Possiamo osservare ora che il giorno della morte risulta, in questo schema, il sesto. Questo potrebbe allora essere messo in rapporto con l'indicazione "dopo sei giorni" (9,2), della Trasfigurazione che non fa riferimento al settimo giorno, ma al sesto (nelle predizioni sulla passionem morte e risurrezione "dopo tre giorni" significa "il terzo giorno"). Interpretando così l'indicazione, avremmo come risultato che la Trasfigurazione, che ci presenta un Gesù glorioso, allude alla morte vista, allo stesso modo in cui la vedrà Giovanni nel suo Vangelo, come momento di glorificazione. Questo schema della settimana, come ha suggerito nel suo articolo E. Corsini, fa pensare, anche per le analogie con l'Apocalisse, che adotta pure uno schema settenario e si compiace di simboli numerici, sia alla settimana della creazione e all'importanza che ha in essa il sesto giorno come giorno della creazione dell'uomo, sia alla profezia delle 70 settimane

63
(profezia di Geremia) che Daniele interpreta nel cap.9 90. Sono le settimane riservate all'intervento salvifico di Dio a favore del suo popolo. L'ultima settimana è quella in cui viene ucciso un Unto, un Cristov", la città e il santuario sono distrutti, cessano i sacrifici e le libazioni e nel Tempio compare l'"abominio della desolazione". E si precisa (nella traduzione greca di Teodozione) che è a metà della settimana che viene abolito il culto. Ecco il testo della profezia: "Settanta settimane sono fissate per il tuo popolo e per la tua santa città per mettere fine all'empietà, mettere i sigilli ai peccati, espiare l'iniquità, portare una giustizia eterna, suggellare visione e profezia e ungere il Santo dei Santi. Sappi e intendi bene, da quando uscì la parola sul ritorno e la ricostruzione di Gerusalemme fino a un principe consacrato, vi saranno sette settimane. Durante sessantadue settimane saranno restaurati, riedificati piazze e fossati, e ciò in tempi angosciosi. Dopo sessantadue settimane, un consacrato sarà soppresso senza colpa in lui; il popolo di un principe che verrà distruggerà la città e il santuario; la sua fine sarà un'inondazione e, fino alla fine, guerra e desolazioni decretate. Egli stringerà una forte alleanza con molti per una settimana e, nello spazio di metà settimana, farà cessare il sacrificio e l'offerta; sull'ala del tempio porrà l'abominio della desolazione e ciò sarà sino alla fine, fino al termine segnato sul devastatore" (Dan 9,24-27). Nel Discorso escatologico del cap. 13 si fa esplicito riferimento a questa profezia quando si parla dell'"abominio della desolazione" (13,14): ne riparleremo nella seconda parte. Un altro spunto offerto dalla settimana della passione riguarda il significato del sabato. Non sembra casuale questo isolamento del sabato rispetto agli altri giorni, questa accentuazione, si può dire, negativa, del sabato: il sabato è il giorno in cui Gesù è nella tomba e non succede nulla. In realtà il tema del sabato ha un'importanza particolare, e si potrebbe dire strutturale, in tutta la prima parte del vangelo: i capp.1-6 sono incorniciati da indicazioni relative al sabato (oltre che alla sinagoga): Gesù, subito dopo la chiamata dei primi discepoli inizia la sua attività entrando di sabato nella sinagoga di Cafarnao (1,21), conclude la sua attività di predicazione concentrata sulla Galilea andando di sabato nella sinagoga della sua patria, ossia di Nazaret (6,2). Dopo di che non si menzioneranno più né le sinagoghe né il sabato fino alla risurrezione. Il sabato poi, o meglio l'osservanza giudaica del sabato, è oggetto diretto di controversia con gli avversari in due episodi specifici (le ultime due, delle cinque, dispute): quando i discepoli spigolano e mangiano spighe di sabato (2,23-28) e quando Gesù guarisce di sabato un uomo con la mano paralizzata (3,1-6). Il sabato non è dunque una pura indicazione cronologica in nessun caso, e c'è evidentemente un collegamento interno a queste indicazioni. La polemica sul sabato porta, da una parte, ad affermare che "il Figlio dell'uomo (il titolo è comunemente usato da Gesù per parlare di se stesso) è padrone anche del sabato" (2,28), dall'altra esaspera gli avversari al punto che proprio l'ultima violazione del sabato li induce a concepire il progetto di uccidere Gesù. La morte di Gesù porta però a superare il sabato, a vanificarlo in tutto ciò che cultualmente significava per i giudei. Un altro indizio in questo senso è la corrispondenza tra la notazione del sorgere del sole che accompagna il primo giorno dopo il sabato (16,2) e il tramonto del sole che invece veniva evidenziato per il giorno di sabato che inaugurava l'attività di Gesù (1,32): sono le uniche due menzioni relative ai movimenti del sole in tutto il Vangelo. Il sabato è destinato a tramontare, mentre la domenica diventa il giorno che incomincia, ma non finisce. Le indicazioni temporali che si riferiscono a momenti del giorno (sera, notte, mattino) contribuiscono spesso a sottolineare l'atmosfera di certi episodi: la sera e la notte possono connotare momenti di tenebre anche spirituali, momenti in cui il male sembra dominare; il mattino è invece momento lieto di speranza, momento di intervento della divinità.
90 Corsini nota (in Apocalisse prima e dopo, Torino, SEI, 1980, p.63) che questa profezia "è fondamentale per la comprensione dell'Apocalisse": in questo testo la maggior parte delle indicazioni simboliche di tempo si riferiscono ad essa: 1260 giorni, 42 mesi, 3 giorni e mezzo: tutte sono equivalenti ai tre anni e mezzo corrispondenti a ciascuna delle due mezze settimane in cui Daniele aveva diviso l'ultima delle settanta settimane di anni.

64
Così, vediamo che di sera (ojyiva" genomevnh") portano a Gesù tutti gli ammalati di Cafarnao (1,32); avviene la traversata del lago sconvolto dalla bufera, con i discepoli travolti dalla paura (4,35) e poi di nuovo l'altra faticosa traversata del lago col vento contrario (6,47); di sera, durante l'ultima cena, Gesù annuncia il tradimento di Giuda (14,17); di sera avviene la sepoltura (15,42). Di notte avverrà il tradimento di Pietro (14,30). All'alba, invece, alla quarta vigilia della notte, ossia tra le tre e le sei, Gesù va incontro ai discepoli stanchi e impauriti, camminando sulle acque (6,48); di buon mattino (prwiv) Gesù si alza per andare a pregare (1,35) e le donne vanno alla tomba, che troveranno vuota, perché Gesù è risorto (16,2). Guardando complessivamente alla cronologia del Vangelo, si può notare che tutta la prima parte è povera di indicazioni cronologiche precise, a parte la "giornata di Cafarnao" e i sabati, mentre il ritmo degli eventi è in qualche modo accelerato dalla frequenza dei "subito". La seconda parte, invece, subisce un rallentamento ed è quasi tutta concentrata nell'arco della settimana della passione. Lo schema delle settimana mira a mostrare che proprio questi eventi ultimi costituiscono il compimento della grande profezia messianica di Daniele e anche una "nuova creazione". 2.2. Il Vangelo di Marco e le nuove metodologie Bibliografia. Una panoramica ampia sulle nuove metodologie si può trovare nel documento recente della Pontificia Commissione Biblica, L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1993, ristampato, con ampio commento di un'équipe di studiosi, in Pontificia Commissione Biblica, L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Commento a cura di G. Ghiberti e F. Mosetto, Leumann (Torino), LDC, 1998. Si può ricorrere a quest'ultimo volume per un'illustrazione dei singoli metodi e per indicazioni bibliografiche; Si veda inoltre nella recente ediz. it. dell' Introduzione al NT di R.E. Brown (Brescia, Queriniana, 2001), le pp. 60-66; 85-88. Abbiamo anche applicazioni di varie metodologie a singoli brani biblici. Alcuni volumi esemplari da questo punto di vista sono: AA. VV., Analisi strutturale ed esegesi biblica, tr. it., Torino, Sei, 1973, su Gen 32,23-33 e Mc 5,1-20; AA.VV., Exegesis. Problèmes de méthode et exercises de lecture (Genèse 22 et Luc 15), par F. Bovon et G. Rouiller, Neuchâtel-Paris 1975. Il metodo storico-critico, nelle articolazioni di Critica delle fonti, Analisi storica, Storia delle forme, Storia della redazione, che abbiamo illustrato, è il più praticato a livello scientifico nei commenti ai Vangeli. Ma ha pregi e difetti. I pregi consistono nel fatto che abitua a prestare attenzione alle unità letterarie, a riconoscerne gli schemi di base e le formule ripetitive, a ricercare analogie e precedenti in forme presenti nella letteratura veterotestamentaria e giudaica, a considerare i rapporti di somiglianza e differenza rispetto agli altri Vangeli, e quindi ad apprezzare meglio il processo attraverso cui si è arrivati alla composizione dei singoli Vangeli. E non bisogna dimenticare le ricerche di tipo storico sull'ambiente, la geografia, gli usi sociali e religiosi del tempo e del luogo a cui i racconti evangelici fanno riferimento. Tutta una serie di acquisizioni, sulla lingua, lo stile, la struttura dei Vangeli derivano dalla massa enorme di studi che sono stati compiuti con questo metodo. Bisogna però riconoscere che spesso il metodo storico-critico resta fermo allo studio della storia precedente e persegue più un procedimento di accumulo di materiali che di interpretazione del significato finale, del messaggio teologico; trascura a volte la forma definitiva assunta dai testi, l'unica che

65
possediamo e che possiamo valutare. Inoltre non va esente da soggettività e arbitrarietà quando pretende di distinguere sempre tra forma originaria e apporti successivi, di conoscere l'estensione di raccolte più ampie di detti o racconti. Gli si può rimproverare la tendenza a frammentare e sezionare i testi come cadaveri, dimenticando che un testo, come dice la parola stessa textus, è un tessuto, ossia un intreccio di fili, è un organismo funzionante nella sua unità. Soprattutto per quanto riguarda il Vangelo di Marco, poi, da parte degli studiosi che seguono il metodo storico-critico e che sono anche quelli che hanno prodotto i migliori commenti (cfr. V. Taylor, E. Schweizer, R. Pesch, J. Gnilka, J. Ernst), è stata volutamente dedicata minore attenzione al lavoro redazionale e all'intenzione finale dell'evangelista, sia per la maggiore difficoltà che questo Vangelo, in quanto il più antico e quindi senza precedenti noti, presenta a una analisi del lavoro del redattore rispetto al materiale tradizionale, sia però anche per il presupposto, che non viene quasi mai messo in discussione, del suo conservatorismo e del suo rispetto estremo della tradizione, per cui si dà per scontato che il suo intervento redazionale sia stato comunque scarso. Ma negli ultimi decenni è stata sviluppata una serie di nuovi metodi o approcci per ovviare alle carenze del metodo storico-critico, in qualche caso per integrarlo, in qualche caso per sostituirlo e guardare i testi in una prospettiva nuova, in particolare abbandonando la dimensione diacronica propria di questo metodo a favore della dimensione sincronica, attenta al testo nel suo insieme così com'è. Inoltre la crescita di nuove metodologie scientifiche sorte all'interno di altre discipline ha portato a tentativi di sottoporre anche i testi biblici a nuovi approcci. Accenniamo ad alcuni di questi nuovo metodi, per dedicare maggiore attensione all'esegesi femminista, ma soprattutto per sviluppare i metodo letterari. 2.2.1. Metodi o approcci basati sulla Tradizione Bibliografia F. Mosetto, Approcci basati sulla tradizione, in Pont. Comm. Bibl., L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, a cura di G. Ghiberti e F. Mosetto, cit., pp. 162-194. I principali sono: Approccio canonico; Approccio mediante il ricorso alle tradizioni interpretative giudaiche; Approccio attraverso la storia degli effetti del testo. Il Metodo canonico presta attenzione alla funzione che i singoli libri svolgono nel complesso della Bibbia così com'è stata definita dal Canone. E' un metodo (già presente nell'esegesi patristica) che è stato avviato in tempi moderni da studiosi dell'AT e sta acquistando sempre maggiore importanza, perché guarda all'intenzione di chi ha ordinato i libri della Bibbia stabilendo un collegamento e un rapporto tra essi, oppure tenendo conto di un rapporto tra essi che già esisteva. Non sostituisce il metodo storico-critico, ma lo completa. Questo tipo di lettura varia a seconda dei canoni: non può essere la stessa se si parte dal canone ebraico o da quello cristiano. E' il metodo favorito in una prospettiva di fede.

66
Il Ricorso alle tradizioni interpretative giudaiche ha assunto un rilievo specifico soprattutto dopo la scoperta dei rotoli di Qumran che ha portato all'attenzione la complessità del mondo giudaico in cui è vissuto Gesù e si è formato il cristianesimo. Di qui l'esigenza di approfondire la conoscenza della documentazione giudaica, delle tradizioni giudaiche, della letteratura giudaica biblica e apocrifa, dell'esegesi giudaica, come sfondo e termine di confronto per una migliore comprensione dell'AT e del NT. Il metodo della Storia degli effetti (in tedesco Wirkungsgeschichte) analizza la fortuna e il riuso dei libri biblici o di singole sue parti, nella tradizione culturale successiva, sia religiosa, sia laica: nella letteratura, nell'arte, nella musica, nel cinema, ecc. Mette in evidenza il ruolo del lettore nella comprensione dell'opera, e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo per quanto riguarda il tipo di lettura che un'opera ha avuto. Questo metodo può avere una funzione utile anche per sgombrare il campo da preconcetti, preletture che si sono imposte e talora si sono sovrapposte ai testi. Su questo aspetto cfr. in particolare A.-M. Pelletier, La Bibbia e l'Occidente. Letture bibliche alle sorgenti della cultura occidentale, tr. it., Bologna, Ed Dehoniane, 1999 (ed. orig. Paris 1995); B. Salvarani, A scuola con la Bibbia. Dal libro assente al libro ritrovato, Bologna, Ed. Missionaria Italiana, 2001, e i vari Atti dei convegni dell'Associazione Biblia su: Dante e la Bibbia; La musica e la Bibbia; L'arte e la Bibbia; Il teatro e la Bibbia. Ma dedicano spazio a questo aspetto anche i volumi di G. Ravasi, Il racconto del cielo. Le storie, le idee, i personaggi dell'Antico Testamento, Milano, Mondadori, 1995; La Buona Novella. Le storie, le idee, i personaggi del Nuovo Testamento, Milano, Mondadori, 1996. 2.2.2. Metodi o approcci attraverso le scienze umane Bibliografia M. Pesce, Approccio secondo le scienze umane, in Pont. Comm. Bibl., L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, a cura di G. Ghiberti e F. Mosetto, cit., pp. 195-221. I principali sono: Approccio sociologico; Approccio antropologico; Approcci psicologici e psicanalitici. L'Approccio sociologico tiene conto del fatto che i testi nascono in specifici ambienti culturali e sociali, per rispondere a problemi e aspettative di quegli ambienti, e riflettono quindi i caratteri della società e della cultura del loro tempo. Anche se questo punto di vista non era certo estraneo al metodo storico-critico, negli ultimi anni l'interesse si è sviluppato particolarmente e ha utilizzato le nuove acquisizioni delle ricerche sociologiche moderne. Si guarda in particolare alle istituzioni, all'economia, ma anche ai vari aspetti della vita concreta. Tra gli aspetti che attirano l'attenzione ci sono, ad es., per quanto riguarda l'AT, le forme di organizzazione del popolo ebraico antico nelle sue varie fasi; le legislazioni delle società orientali coeve come punto di riferimento per capire meglio il senso di tante norme legali di Israele. Per il NT interessa definire meglio il movimento carismatico itinerante di Gesù e dei suoi discepoli, le strutture delle comunità paoline, ecc. L'Approccio antropologico (o meglio: l'Approccio attraverso l'antropologia culturale) è affine a quello sociologico, ma prende in

67
considerazione particolarmente le varie manifestazioni culturali che caratterizzano i popoli: la lingua, l'arte, i riti religiosi, le tradizioni, i rapporti di parentela, i valori culturali, ma anche l'abbigliamento, le feste, le danze, i calendari, le leggende, i tabù, la posizione della donna, e in genere tutto ciò che rientra nell'attuale etnografia. Si costituiscono su queste basi delle tipologie e dei modelli culturali. Come esempio di questo tipo di studi si possono citare due volumi di A. Destro-M. Pesce: Antropologia delle origini cristiane, Roma-Bari, Laterza, 1995; Come nasce una religione. Antropologia ed esegesi del Vangelo di Giovanni, Bari, Laterza, 2000. Gli Approcci psicologici e psicanalitici (nelle varietà delle scuole) cercano di applicare alla lettura dei testi biblici le nuove cognizioni relative alla psicologia e, per quanto riguarda in particolare la psicanalisi, relative all'inconscio (un aspetto che è strettamente legato alla religione). Trovano un campo fertile di ricerca nella vasta sfera dei simboli, delle immagini, dei riti, dei sogni e delle visioni. Per l'approccio psicanalitico si vedano: l'imponente commento sul Vangelo di Marco di E. Drewermann, Das Markus Evangelium, 2 voll., Olten-Freiburg i.B. 1987 (1989 4)-1988, ora tradotto in parte in italiano, e F. Dolto e G. Sévérin, Psicanalisi del Vangelo, tr. it., Milano, Rizzoli, 1978 (ed.orig. Paris 1977). L'approccio di Drewermann è stato ampiamente discusso da C. Marcheselli Casale, "Il caso Drewermann". Psicologia del profondo: un nuovo metodo per leggere la Bibbia?, Casale Monferrato, Piemme, 1991. Per un approccio psicologico cfr. F. Monuschi-G. Cirignano, La personalità di Paolo. Un approccio psicologico alle lettere paoline, Bologna, Ed. Dehoniane, 1996. 2.2.3. Metodi o approcci contestuali Bibliografia G. Segalla, Approcci contestuali: ermeneutica liberazionista e femminista, in Pont. Comm. Bibl., L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, a cura di G. Ghiberti e F. Mosetto, cit., pp. 222-242. Sotto l'etichetta di Metodi contestuali (o di Critica contestuale) si intendono due metodi in particolare: l'Approccio liberazionista e l' Approccio femminista. Si tratta di metodi che nascono da esigenze concrete e urgenti di ambienti e strati sociali emarginati e pongono domande alla Bibbia per trovare indicazioni utili a cambiare la situazione. La lettura della Bibbia è qui determinata dal "contesto" sociale e politico in cui si trovano i lettori ed ha obiettivi pratici. Inoltre è una lettura che rifiuta espressamente la neutralità, ma presuppone una precisa scelta di campo (l'opzione per i poveri). Più che di nuovi metodi si deve parlare di nuovi punti di vista (alcuni parlano di ermeneutiche), dato che è presupposto l'uso del metodo storico-critico. L'Approccio liberazionista è in rapporto con la teologia della liberazione, che è nata e ha avuto sviluppo soprattutto in America latina, ma si è propagata poi anche in Africa, in Asia, soprattutto tra le popolazioni povere e sfruttate. Viene utilizzato in funzione delle attuali lotte di liberazione e quindi guarda soprattutto alle parti della Bibbia in cui sono in primo piano i temi della salvezza del popolo oppresso ad opera di Dio, della giustizia, del favore di Dio

68
verso gli umili, ecc. Suscita diffidenza negli ambienti ecclesiastici perché rischia di risultare parziale e adotta talora l'ideologia materialistia. L'Approccio femminista nasce all'interno del movimento femminista, che ha pure uno scopo pratico: quello di combattere le condizioni di subordinazione della donna nelle società patriarcali, e anche all'interno delle Chiese. 2.2.3.1. L'esegesi femminista Bibliografia Per una presentazione del metodo cfr. E. Schüssler Fiorenza, In memoria di lei. Una ricostruzione femminista delle origini cristiane, tr.it., Torino, Claudiana, 1990 (ed.orig. New York 1983). Per una rassegna di contributi cfr. Interpretazione femminista della Bibbia, a cura di L.M. Russel, tr. it., Assisi, Cittadella, 1991 (ed. orig. 1985). Si vedano anche M. Bührig, Donne invisibili e Dio patriarcale. Introduzione alla teologia femminista, tr. it., Torino, Claudiana, 1989 (ed. orig. Zürich 1987), pp. 27-44; M.-T. van Lunen-Chenu e R. Gibellini, Donna e teologia, Brescia, Queriniana, 1988, pp. 125-134. Per una valutazione più aggiornata: M. Perroni, Una valutazione dell'esegesi femminista: verso un senso critico integrale, in "Studia Patavina" 43 (1996), pp. 67-92; M. Navarro Puerto, Tendenze attuali nell'esegesi femminista: Mc 5, in Donne e Bibbia. Storia ed esegesi, a cura di A. Valerio, EDB, Bologna 2006, pp. 329-366. Oggi alcune riviste di teologia ed esegesi biblica (ad es., "Concilium") dedicano una sezione specifica alla produzione femminista. Per un commento femminista a più voci della Bibbia cfr. La Bibbia delle donne. Un commentario, a cura di C.A. Newsom e S.H. Ringe, 3 voll., tr. it., Torino, Claudiana, 1996-1999 (ed. orig. Westminster 1992-1998) L'esegesi femminista è sorta recentemente sulla scia delle ricerche sviluppate dal movimento femminista, prima negli ambienti anglosassone e tedesco, e oggi si sta estendendo anche in Italia. Le sue origini si fanno risalire alla pubblicazione della "Bibbia delle donne" (The Woman's Bible) ad opera dell'americana E; Cady Stanton nel 1895 (oltre un secolo fa). Si presenta, nelle sue forme più coscienti e articolate, come uno sviluppo e un'applicazione particolare dell'analisi storico-critica, della storia delle forme e della storia della redazione. Parte dal presupposto che i Vangeli non sono trascrizioni obiettive di fatti, ma scritti di impegno pastorale, in cui gli autori hanno rielaborato i materiali tradizionali in base alle proprie convinzioni teologiche e alle proprie finalità pratiche. In particolare, evidenzia che gli evangelisti erano influenzati, come tutti gli uomini del loro tempo (sia appartenenti al mondo greco-romano sia a quello ebraico), da una mentalità e da una cultura patriarcali, che hanno condizionato la loro posizione verso le donne. Evidenzia inoltre il fatto che anche la critica successiva, antica e moderna, è rimasta monopolio maschile e spesso risente ancora dei medesimi pregiudizi maschilisti. Di conseguenza, l'esegesi femminista, al di là delle differenziazioni interne, si propone fondamentalmente, da una parte, di far riemergere una presenza femminile che nelle fonti risulta marginale, ma che vari indizi consentono di rivalutare, dall'altra parte, di dimostrare il carattere

69
androcentrico di molti testi. E' fortemente influenzata dall'esigenza di favorire una coscienza "femminista" nelle donne di oggi e quindi è portata a partire dai problemi dell'oggi e a sviluppare l'attualizzazione dei testi, a farne degli strumenti per la moderna lotta di liberazione femminista. Negli studi finora usciti, perciò, l'interesse non è tanto rivolto ai singoli scritti biblici, quanto agli elementi che nei vari scritti consentono di ricostruire un quadro storico più adeguato (per quanto riguarda le figure di donne, ma non solo) o di puntualizzare la deformazione tendenziosa dei racconti. Grande spazio hanno, in questa esegesi, l'esperienza e la sensibilità femminile di chi si accosta ai testi, e non di rado, quindi, anche un certo soggettivismo. Ma è fondamentale, soprattutto, una lettura in filigrana dei testi, perché si tratta per lo più di sfruttare piccoli indizi, anche i silenzi, di leggere tra le righe, di porre domande nuove ai testi; la Schüssler-Fiorenza parla di "ermeneutica del sospetto": l'idea ispiratrice è che i testi sono parziali (per quanto riguarda le indicazioni sulle donne) e bisogna prestare un'attenzione speciale per cogliere e far emergere i segni di questa parzialità. Quando si sofferma sulle versioni specifiche dei singoli Vangeli, questo tipo di lettura può contribuire, non soltanto a recuperare un aspetto trascurato della storia, ma non di rado anche ad approfondire l'interpretazione del testo con la scoperta di particolari inediti. In effetti, accenni presenti nei testi mostrano che un atteggiamento nuovo di Gesù nei riguardi delle donne e una loro presenza rilevante nella comunità primitiva hanno creato incomprensione e imbarazzo già nei discepoli, scontrandosi con una mentalità, una cultura e una condizione sociale che invece poneva la donna su un piano di inferiorità. Questa situazione affiora chiaramente già nei Vangeli: si veda l'episodio della Samaritana, in Giovanni 4, dove i discepoli mostrano meraviglia e disagio per il fatto che Gesù parla apertamente con una donna (4,27). I problemi che emergono nelle comunità cristiane a questo proposito si riflettono poi nelle lettere di Paolo, che oscillano tra il riconoscimento pieno dell'uguaglianza dei sessi in Cristo (Gal 3,18: "Non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo e donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù"), e le riserve sul piano pratico: si pensi all'obbligo per le donne di portare il velo e di tacere in assemblea (1 Cor 11,2-16; 14,34-36). Le lettere pastorali, le più tarde, mostrano un adeguamento delle comunità cristiane alle norme tradizionali su questo punto, con il pieno recupero del precetto della sottomissione della moglie al marito nei vari "codici domestici" (cfr. Col 3,18; Ef 5,24; Tt 2,5; 1 Pt 3,1.5), con l'inasprimento dell'obbligo del silenzio fino al divieto di insegnamento (1 Tm 2,11-12), ecc.). Perfino la tradizione manoscritta fa trapelare la difficoltà, coi tentativi, in certi casi, di correggere i testi allo scopo di ridimensionare la presenza femminile.91 Secondo l'esegesi femminista, questa situazione conflittuale condiziona anche i racconti dei fatti, nel senso che gli evangelisti devono essere stati portati 91 Abbiamo accennato sopra, nel paragrafo sulla Critica testuale, all'atteggiamento misogino che manifesta il codice D e altri testimoni della tradizione manoscritta occidentale.

70
a tacere, a minimizzare o modificare informazioni relative a donne. Molti dati, quindi, si presuppone che siano andati perduti. Per ricostruire un quadro più adeguato della realtà, solo un attento recupero dei cenni rimasti e il confronto tra tradizioni diverse, a volte contraddittorie, possono portare a qualche risultato. Come esempio di silenzi relativi a donne si può considerare il comportamento degli evangelisti a proposito del gruppo delle "discepole" di Gesù: solo Lc ne parla trattando della fase galilaica dell'attività di Gesù (8,1-3); invece Mc e Mt vi accennano, retrospettivamente, solo quando menzionano la presenza delle donne al momento della morte di Gesù (cfr. Mc 14,40-41; Mt 27,55-56). Dalle parole dell'angelo alle donne nella tomba, secondo le versioni di Mc (16,7) e Lc (24,6-8), si potrebbe dedurre che le donne erano state presenti anche durante l'ultima cena, quando Gesù predisse che avrebbe incontrato ancora i discepoli in Galilea (Mc 14,28), e già in occasione delle predizioni della passione (Lc 9,22.44), luoghi in cui i testi evangelici avevano parlato genericamente di discepoli. Un esempio di contraddizione tra le fonti sono i resoconti sui testimoni della risurrezione di Gesù: Paolo, in 1 Cor 15,5-8, non menziona affatto le donne, mentre i Vangeli sono concordi nel documentare che le donne furono le prime testimoni della tomba vuota, e anche le prime a vedere Gesù risorto (su questo punto cfr. Mt 28,9; Gv 20,14). L'atteggiamento di Paolo si spiega col fatto che secondo il diritto ebraico le donne non avevano capacità giuridica, non potevano fare una testimonianza valida legalmente. Negli studi femministi, specialmente quando si tratta di raccogliere materiale per ricostruire la situazione alle origini del cristianesimo, il Vangelo di Marco viene preferito per la sua maggiore antichità, per il fatto che contiene tradizioni più antiche. Però, anche l'impostazione dell'evangelista suscita interesse dal punto di vista dell'atteggiamento verso le donne. Episodi più volte commentati, e messi a confronto con la redazione degli altri Vangeli,
sono quelli della donna di Betania, che unse il capo a Gesù (14,3-9) 92 e della Sirofenicia (7,24-
30).93 Ma anche la presentazione del gruppo delle seguaci di Gesù è molto studiato (cfr. 15,40-
41).94
Per quanto riguarda Matteo, c'è apprezzamento per alcune figure femminili presenti soltanto in questo Vangelo: la madre dei figli di Zebedeo (20,20-21; 27,56), la moglie di Pilato
(27,19),95 oltre che interesse per i racconti di episodi che ricorrono già in Mc (donna di Betania: 26,6-13; Cananea, corrispondente della sirofenicia: 15,21-28). Più controversa è la valutazione della posizione di Luca: c'è chi guarda positivamente al gran numero di donne presenti nella sua opera, ai vari episodi solo lucani in cui sono
92 Cfr. E. Moltmann-Wendel, Le donne che Gesù incontrò, tr.it., Brescia, Queriniana, 1989 (ed.orig.
Gütersloh 1985 5), pp. 103-115; A. Lissner, Storia di un amore senza parole. L'unzione a Betania, in Donne alla riscoperta della Bibbia, a cura di K. Walter-M.C. Bartolomei, Brescia, Queriniana, 1988 (ed.orig. Freiburg i.B. 1986), pp. 89-95. La Schüssler-Fiorenza (pp. 153-154) cerca di ricostruire quello che doveva essere il racconto originario, trasmesso dalla tradizione più antica. 93 Cfr. S.H. Ringe, La storia di una donna pagana, in Interpretazione femminista della Bibbia, cit., pp. 88-100. La Schüssler-Fiorenza (pp. 163-165) tenta anche qui di ricostruire il nucleo originario del racconto. 94 Cfr. Schlüsser-Fiorenza, pp. 347-355; Moltmann-Wendel, pp. 117-128. 95 Si vedano gli studi della Moltmann-Wendel (Le donne che Gesù incontrò) e di L. Sebastiani (Donne dei Vangeli, Milano, Ed. Paoline 1994).

71
protagoniste donne (la vedova di Nain, la donna curva guarita di sabato, la vedova e il giudice, la donna che aveva perso una dracma, Marta e Maria, ecc.; in particolare le figure di Elisabetta,
di Maria e di Anna, nel racconto dell'infanzia),96 e alle notizie che dà sull'esistenza di un gruppo di "discepole" di Gesù fin dall'inizio della sua missione (cfr. Lc 8,1-3), ma c'è anche chi, analizzando i singoli passi, ritiene che Lc in realtà riproponga un'immagine della donna molto
tradizionale, addirittura repressiva.97
Un passo come quello della chiamata di Levi e del banchetto coi pubblicani (All. 9 e 9 bis), più volte qui analizzato, benché non parli di donne, viene preso in considerazione dalla Schüssler-Fiorenza 98 perché, come altre interpreti femministe della Bibbia, è interessata a recuperare tutti gli aspetti di liberazione ed egualitarismo inerenti al movimento creato da Gesù, anche quelli relativi ai poveri, ai malati, ai pubblicani, ai peccatori e alle prostitute. Essa nota, appunto, che anche le prostitute, i peccatori e i pubblicani facevano parte della sua comunità riunita intorno alla mensa. Nota che queste categorie definiscono una classe sociale povera, perché dedita a professioni disonorevoli. I "peccatori" potevano indicare vari tipi di persone: i trasgressori della Legge, i criminali, gente che esercitava mestieri sconvenienti o servizi considerati impuri, anche i pagani. Si trattava sempre, comunque, di emarginati, molti dei quali erano donne. Ebbene, proprio costoro, da ultimi diventano primi, da esclusi invitati. In questo modo "nel ministero di Gesù Dio viene sperimentato come amore che non esclude nessuno", come "Dio di grazia e di bontà che accetta tutti e porta giustizia e benessere per tutti, senza eccezioni". 99
2.2.4. Metodi di analisi letteraria Bibliografia A. Pitta, Nuovi metodi di analisi letteraria, in Pont. Comm. Bibl., L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, a cura di G. Ghiberti e F. Mosetto, cit., pp. 145-161. Alcuni dei nuovi metodi mirano ad approfondire gli aspetti letterari dei testi procedendo oltre la Storia della redazione, che già aveva abituato a una visione complessiva, non frammentaria, dei Vangeli. Sono l'Analisi strutturalista o semiotica, l'Analisi (o Critica) retorica, l'Analisi narrativa (che si applica, ovviamente, ai testi narrativi della Bibbia). I metodi strutturalisti e semiotici analizzano le strutture e le relazioni profonde che si instaurano tra gli elementi interni ai testi e spesso si servono di formule matematiche o logiche per evidenziare gli schemi soggiacenti. Possono risultare talora molto complicati e perfino astrusi; sono discutibili, quando pretendono di escludere totalmente l'aspetto storico.
96 Cfr. Sebastiani, Donne dei Vangeli, che commenta con simpatia le figure di Maria, Elisabetta, Anna, della vedova di Nain, della donna curva, di Marta e Maria. 97 Cfr. J. Schaberg, Luca, in La Bibbia delle donne, cit., vol. III, pp. 51-81. In realtà questa studiosa talora interpreta in modo forzato e tendenzioso i testi, senza tener conto della prospettiva degli evangelisti: ad esempio, ritiene che la definizione che Maria fa di se stessa come "serva del Signore" fornisca un'immagine di donna passiva, "l'antitesi di una donna liberata" (p. 67). 98 Cfr. In memoria di lei, pp. 151 ss. 99 Ivi, p. 156.

72
L'Analisi retorica prende in considerazione gli elementi retorici e formali dei testi o attingendo alla retorica classica o ricorrendo alla retorica biblica. L'Analisi narrativa presta attenzione agli elementi caratteristici di ogni racconto: personaggi e ruoli svolti, intreccio, tempo, spazio. 2.2.4.1. L'analisi strutturale Bibliografia Per una presentazione del metodo cfr. J. Radermakers, Lettura pastorale del Vangelo di
Marco, tr. it., Bologna, Ed. Dehoniane, 1981 2 (ed. orig. Bruxelles 1974), pp. 23-26. Commenti che si ispirano all'analisi strutturale: cfr. J. Radermakers, Lettura pastorale del
Vangelo di Marco, tr. it., Bologna, Ed. Dehoniane, 1981 2 (ed. orig. Bruxelles 1974); J. Delorme, Lettura del Vangelo di Marco, tr.it., Assisi, Cittadella, 1987. L'analisi strutturale applica allo studio dei testi le acquisizioni tratte dalle ricerche sulla lingua di F. De Saussure 100, mira soprattutto a esaminare il testo da un punto di vista "sincronico", in contrapposizione alle metodologie storiche, che invece lo indagano "diacronicamente". Punto di vista sincronico significa attenzione alle molteplici correlazioni interne al testo, ricerca del principio dinamico di unità che costituisce la sua coerenza interna. Il presupposto è appunto che ogni Vangelo (come ogni opera letteraria) sia un organismo vivente dotato di una propria coerenza e intenzionalità, non un insieme composito di pezzi staccati tra loro. Il procedimento seguito mira pertanto a riferirsi costantemente all'insieme del testo. Si tratta, perciò, di una prospettiva opposta a quella della ricerca storico-critica tradizionale, che invece operava sui Vangeli come raccolte di materiali indipendenti e li apprezzava tanto più quanto meno risultavano influenzati dalla visione unitaria del redattore finale. In concreto, questo metodo cerca innanzitutto le articolazioni letterarie e i procedimenti di composizione che consentono di delineare la struttura del Vangelo nel suo complesso e nelle sue singole parti. Si basa pertanto fondamentalmente sui fenomeni di ripetizione (sommari, formule o termini ricorrenti, gruppi di racconti o di parabole secondo certi schemi costanti, parallelismi di situazioni, ecc.). Inclusione Un particolare tipo di ripetizione che serve a delimitare unità interne al testo è l'"inclusione", che si verifica con la riproduzione di uno o più termini caratteristici all'inizio e alla fine di uno sviluppo che l'autore considera come un tutto. Per quanto riguarda il Vangelo di Marco, un esempio interessante si ha nel prologo: il termine eujaggevlion, trasl. euanghèlion, "vangelo", ricorre subito all'inizio (1,1: "Inizio del vangelo di Gesù Cristo, [Figlio di Dio]") e due volte in
100 Fondamentali sono i suoi appunti raccolti e pubblicati postumi nel Cours de linguistique générale, 1916 (tr. it., Bari, Laterza, 1957).

73
1,14.15 ("Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù venne in Galilea a predicare il vangelo di Dio, e diceva: 'Si è compiuto il tempo ed è vicino il regno di Dio: convertitevi e credete nel vangelo"). E' possibile che la ripetizione della parola costituisca un'inclusione e in particolare racchiuda l'intero prologo, che abbraccerebbe 1,1-15. 101 Si può notare che il termine "vangelo" ricorre poi nel Vangelo molto più avanti (8,35; 10,29; 13,10; 14,9). Non sembra casuale la ricorrenza ravvicinata in questo contesto. Potrebbe essere un'inclusione per tutto il Vangelo l'espressione prwi÷⁄ livan, trasl. proì lìan, "molto di buon mattino", che si trova in 1,35 e 16,1, ossia in due punti importanti: nella descrizione del mattino che conclude la "giornata di Cafarnao", ossia la prima giornata della missione di Gesù, e nella mattina della risurrezione. Anche simbolicamente i due momenti si corrispondono. La combinazione dei termini savbbaton ("sabato"), sunagwghv ("sinagoga"), didavskw ("insegnare"), ejkplhvssw ("colpire") si ritrova in 1,21-22, ossia all'inizio dell'esorcismo nella sinagoga di Cafarnao ("E subito, essendo di sabato, entrato nella sinagoga, insegnava. Ed erano colpiti dal suo insegnamento, perché insegnava loro come chi ha autorità e non come gli scribi"), e poi ancora in 6,2, nell'episodio di Gesù nella sinagoga di Nazaret (" E, venuto il sabato, incominciò a insegnare nella sinagoga, e molti ascoltandolo erano colpiti ..."): la parte che è racchiusa da questi elementi costituisce in effetti una sezione unitaria: la prima parte del Vangelo. Si potrebbe notare che appunto in questa sezione sono caratteristici gli interventi di Gesù nelle sinagoghe. A sua volta il sabato e la sinagoga si ritrovano sia in 1,21 sia in 3,1-6 e anche in questo caso la combinazione dei due lementi racchiude una sezione. Si può attribuire valore di inclusione anche ad episodi, immagini, ecc. Ad esempio, i due episodi di guarigione di ciechi (gli unici del Vangelo), quello di Betsaida (8,22-26) e quello di Gerico (10,46-52), sono inclusivi della parte centrale del Vangelo, caratterizzata dalle tre predizioni della Passione. Si corrispondono, con la differenza che il primo è un miracolo in due tempi, e segnala l'inizio di un cammino faticoso, mentre il secondo propone nel cieco una sorta di modello compiuto. La cecità ha valore simbolico nel Vangelo e allude all'incomprensione nei confronti di Gesù da parte dei discepoli. Le due menzioni di Betsaida, in 6,45 e in 8,22, includono una sezione unitaria, caratterizzata da una serie di spostamenti tra le due rive del "mare", che assumono un valore pedagogico. Vi ritorneremo. Costruzione "a sandwich" Analoga, ma applicata a piccoli brani, è la tecnica detta "a sandwich", o "a incastro", per la quale un episodio risulta incastonato all'interno di un altro, che viene spezzato in due parti e disposto a cornice dell'altro: ne abbiamo numerosi esempi nel Vangelo di Marco, tanto che si può considerarla una tecnica a lui particolarmente cara. Questa costruzione mette bene in evidenza l'aspetto "letterario" del racconto: non corrisponde all'ordine dei fatti ma non è
101 Ci sono però altri studiosi che preferiscono limitare il prologo a 1,1-13.

74
neppure un semplice artificio, ma è un'indicazione precisa che spinge a interpretare unitariamente i due episodi intrecciati, quello interno, alla luce di quello esterno e viceversa. Non tenerne conto compromette la possibilità di comprendere il messaggio voluto dall'autore. Consideriamo alcuni di questi esempi. 3,20-35: è un caso che ha creato difficoltà agli studiosi di mariologia. Il brano si articola in tre parti: la prima (vv.20-21) presenta un gruppo di parenti di Gesù (così si deve intendere più probabilmente l'espressione oiJ par j aujtou', lett. "quelli da lui") i quali, avendo sentito dire che Gesù era a Cafarnao ed era in una casa (forse quella di Pietro: cfr. 1,29), partono (da Nazaret) per andare prenderlo e portarlo via, perché pensavano che fosse fuori di sé. Segue un episodio (vv. 22-30) di aspra polemica tra gli scribi di Gerusalemme e Gesù: i primi andavano dicendo che Gesù scacciava i demòni essendo lui stesso indemoniato. Gesù ribatte che un regno diviso al suo interno non può reggersi (e quindi satana non può combattere contro i demòni, che fanno parte del suo regno), e condanna duramente come peccato contro lo Spirito Santo l'opione che egli sia posseduto da uno spirito impuro. In seguito ritroviamo la madre e i fratelli di Gesù che mandanp a chiamare Gesù, il quale si trova in casa in mezzo a una folla di seguaci. Gesù ribatte che la sua vera famiglia è costituita da quanto fanno la volontà di Dio. Anche se non tutti gli studiosi sono disposti ad ammetterlo, l'ultima scena è la continuazione della prima e sempre si tratta dei parenti di Gesù (tra cui la madre e i fratelli) che manifestano un atteggiamento di incomprensione nei confronti di lui. L'incastonamento dell'episodio di disputa con gli scribi segnala l'intenzione di Marco di mettere in parallelo i due tipi di opposizione nei confronti di Gesù: da parte dei famigliari e da parte delle autorità religiose giudaiche. Del resto Gesù dirà a Nazaret, parlando di sé stesso: "Non c'è profeta disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi congiunti e a casa sua" (6,4). E' significativo che né Matteo né Luca riportino nei loro Vangeli la prima parte dell'episodio dei parenti di Gesù, solo la seconda parte, e modificata. 5,21-43: questo è l'unico caso di costruzione a sandwich conservata anche dagli altri due sinottici (Mt 9,18-26 e Lc 8,40-56). Abbiamo due episodi, quello della guarigione dell'emorroissa (5,25-34) e quello della risurrezione della figlia di Giairo (5,21-24.35-43), di cui il primo è inserito in mezzo al secondo. L'evangelista ha collegato anche in altri modi i due episodi: entrambe le protagoniste sono donne, e la figlia di Giairo ha 12 anni, l'emorroissa è malata da 12 anni; la condizione di entrambe si presenta irrimediabile dal punto di vista umano (l'emorroissa non ha potuto essere guarita da nessun medico, la ragazza è agli estremi e muore nel frattempo); ad entrambe la fecondità e il dono di dare vita è impedito (dall'emorragia cronica; dalla morte); entrambe, per gli stessi motivi, sono impure, secondo la legge ebraica. 11,12-25: l'episodio della maledizione del fico senza frutti (11,12-14.20-25) è spezzato in due momenti dalla cacciata dei mercanti dal tempio (11,15-19). Il riconoscimento dell'esistenza della costruzione a sandwich risulta particolarmente necessario per una retta comprensione del passo. In particolare la scena del fico, letta a sé, appare assurda, e Marco sembra voler accrescere

75
l'assurdità quando spiega che Gesù non trovò nulla se non foglie "perché il tempo non era dei fichi" (per lo più si traduce: "non era infatti quella la stagione dei fichi"). Si può notare che nel parallelo, Matteo elimina i particolari più assurdi e non conserva la costruzione a sandwich, Luca elimina del tutto l'episodio del fico maledetto e parla, in un contesto diverso, di un fico sterile, ma in tutt'altra prospettiva (13,6-9): al fico viene lasciato ancora un po' di tempo per vedere se porterà frutti.102
Ma il gesto di Gesù acquista valenze simboliche e profetiche se messo in collegamento, come appunto vuole l'autore, con il tema del tempio: la mancanza di frutti del fico è in rapporto con il fatto che il tempio, che avrebbe dovuto essere "casa di preghiera per tutte le genti", è stato trasformato dai capi religiosi in "spelonca di ladri". Gesù "maledice" il fico così come condanna la corruzione del tempio: entrambi sono diventati sterili. ". Gesti di questo tipo erano propri già degli antichi profeti. Più avanti a questo episodio si riconnetteranno la parabola dei vignaioli omicidi, che pure rifiutano di consegnare al padrone della vigna i frutti dovuti (12,1-12), e le parole di Gesù sulla distruzione del tempio nel discorso escatologico (cap. 13). L'evangelista vuole mettere in evidenza il fatto che nel tempo di Gesù non ci possono essere scuse per non rispondere alla chiamata: cfr. 1,15: "il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino: convertitevi e credete nel vangelo"; il termine che indica il "tempo" è sempre kairov", trasl. kairòs, che indica un momento importante, un'occasione imperdibile e urgente. 14,53-72: il processo di Gesù nel sinedrio (14,55-65) è inserito nell'episodio del rinnegamento di Pietro (14,54.66-72). L'evangelista vuole mettere in parallelo due forme di rinnegamento di Gesù come Messia e Figlio di Dio. Costruzioni concentriche o parallelistiche Basandosi sulle corrispondenze, l'analisi strutturale individua nei brani, o in una sequenza di brani, schemi fondati sul parallelismo (ABA'B') o su una costruzione concentrica (ABCB'A'). Come esempi di costruzioni concentriche, si vedano, nell'All. 15, quelli della sezione delle parabole (4,1-34) e quello del discorso escatologico (cap. 13). Si tratta dei due principali discorsi presenti nel Vangelo di Marco e risultano costruiti con molta cura. Nel discorso sulle parabole è riconoscibile una struttura concentrica del tipo ABCDC'B'A', dove - la cornice esterna (AA') è costituita dalla descrizione di Gesù come maestro che si serve particolarmente delle parabole per insegnare; - l'inizio (B) e la conclusione del discorso (B') sono formati da parabole raccontate a tutti, e tutte incentrate su una semina (parab. del seminatore all'inizio, due parabob. gemelle alla fine: quella del seme che cresce da sé e
102 Si veda, per i paralleli, l'All. 12.

76
quella del granello di senapa). Nella sezione centrale abbiamo insegnamenti privati ai discepoli, ripartiti in tre momenti: - la cosiddetta teoria delle parabole esposta da Gesù in risposta a una domanda dei discepoli (C), - a cui fa da pendant una serie di 4 detti enigmatici (C'). Al centro (D) sta la spiegazione della parabola del seminatore, che costituisce l'insegnamento principale. C'è però chi coglie una struttura diversa: collega in un unico punto parabola del seminatore (B), teoria delle parabole (C) e spiegazione della parabola (D), e pone al centro i detti (C'). Ma in questo modi rompe la divisione tra insegnamenti a tutti (parabole) e insegnamenti ai discepoli. Per quanto riguarda il discorso escatologico, per lo più gli studiosi, che lo leggono in chiave escatologica, come se predicesse la fine del mondo, propongono schemi concentrici, ma pongono al centro la venuta del Figlio dell'uomo, che interpretano come parusia. Guardando alle formule ricorrenti più significative ("badate", "quando vedrete"), si può ricavare uno schema del tipo ABCB'A', che presenta - nella cornice iniziale e finale una serie di avvertimenti ai discepoli per il tempo prima della fine (A, A'), - nelle sezioni intermedie le descrizioni dei segni dell'"abominio della desolazione" (B) e della "venuta del Figlio dell'uomo" (B'), che risultano in parallelo, - e al centro (C) gli avvertimenti sui falsi cristi e falsi profeti. Il discorso contiene quindi un'alternanza tra predizioni ed avvertimenti. Per un altro schema concentrico si veda anche più avanti quello sulla sezione delle dispute galilaiche tra cui è compreso l'episodio della chiamata di levi e del banchetto coi pubblicani. 2.2.4.2. L'analisi retorica Bibliografia Per un'illustrazione del metodo secondo la retorica biblica cfr. R. Meynet, L'analisi retorica, tr.it., Brescia, Queriniana, 1992 (ed.orig. Paris 1989); di carattere più elementare e pratico: Id., "E ora, scrivete per voi questo cantico". Introduzione pratica all'analisi retorica, Roma, Ed. Dehoniane, 1996. Commenti che si ispirano all'analisi retorica: secondo la retorica classica, cfr. B. Standaert, Il Vangelo secondo Marco. Commento, tr. it., Roma, Borla, 1984 (ed. orig. Paris 1983); secondo la retorica biblica, cfr. R. Meynet, Il Vangelo secondo Luca. Analisi retorica, tr. it., Roma, Ed. Dehoniane, 1994 (ed. orig. Paris 1988). L'analisi retorica è anch'essa molto interessata alle strutture compositive e ne fissa gli schemi. Ma c'è chi, come Standaert, applica le regole della retorica classica, e quindi ritrova nel Vangelo di Marco le parti tradizionali del discorso: narrazione o esposizione, argomentazione, conclusione, e chi, come Meynet, fondandosi sulla retorica ebraica (essenzialmente biblica), ricerca soprattutto i

77
parallelismi e le strutture concentriche o chiastiche. Standaert individua nel Vangelo di Marco fondamentalmente un'impostazione drammatica, proprio nel senso che corrisponderebbe alle convenzioni del dramma antico (compresa la scena finale del deus ex machina, che sarebbe rappresentato dall'angelo nella tomba vuota). Meynet ritrova in tutti i Vangeli, sia nelle singole parti, sia in sequenze più ampie, sia nella struttura dell'intera opera, il predominio della composizione a chiasmo, che pone al centro l'elemento più importante. L'analisi retorica è stata applicata anche alle lettere di Paolo, nelle quali sono state individuate corrispondenze con le orazioni della retorica classica anche nella struttura. Proponiamo come esempio di analisi retorica quella che R. Meynet applica all'episodio della guarigione del cieco di Gerico, Bartimeo, in Mc 10,46-52, messo in rapporto con l'episodio della richiesta dei due figli di Zebedeo, in Mc 10,35-40.103
L'episodio del cieco, come risulta dalla prima scheda allegata (All. 13), presenta una struttura concentrica, in cui i vari elementi si corrispondono simmetricamente (ABCB'A'). Alla descrizione del personaggio all'inizio, cieco, seduto lungo la strada (A) corrisponde, e si contrappone, la descrizione finale di lui che ha recuperato la vista e segue Gesù sulla strada (A'). Alle richieste del cieco, che due volte, in forma parallela, grida, chiama Gesù "Figlio di Davide" e invoca pietà (B), interrotto dal tentativo della gente di tacitarlo, corrisponde il dialogo con Gesù che, menzionato due volte, due volte gli parla, e a cui egli si rivolge chiamandolo questa volta "Rabbunì" (= mio maestro) (B'). Al centro abbiamo, ancora, un triplice elemento: il comando di Gesù, l'invito della folla ad aver coraggio e ad alzarsi, e la reazione pronta di Bartimeo, che getta il mantello e si slancia verso Gesù (C). L'episodio è carico di simbolismo: in Bartimeo si intravede il modello del discepolo che, alla chiamata da parte di Gesù, non esita a lasciare tutto quello che ha e si mette a seguire Gesù (cfr. gli episodi di chiamata di discepoli: 1,16-20; 2,13-14). Questo significato profondo viene ulteriormente sottolineato se si mette l'episodio in rapporto con quello, precedente, dei due discepoli, Giovanni e Giacomo, i figli di Zebedeo (10,35-40), come fa Meynet nella seconda scheda (All. 14). Qui è evidenziata la ripetizione nei due episodi di una situazione in cui i personaggi "chiedono" qualcosa, e soprattutto è messa in rilievo la domanda di Gesù che a sua volta chiede: "Che cosa volete/vuoi che io faccia per voi/per te?". Ma i figli di Zebedeo chiedono posti di prestigio nella gloria del Regno, senza sapere quello che chiedono, e non lo ottengono, mentre il figlio di Timeo chiede di poter riavere la vista, lo ottiene e segue Gesù sulla strada, quella che lo porta a Gerusalemme e alla passione. Bartimeo è più vicino al discepolo ideale delineato da Gesù: quello che è disposto a seguirlo portando la croce (cfr. 8,34); Giacomo e Giovanni invece ne sono molto lontani, perché
103 R. Meynet, Un'introduzione ai Vangeli sinottici, Bologna, Centro edit. dehoniano, 2000, pp. 44-49; 82-85. Vengono allegati alle dispense i testi dei passi (in traduzione) riprodotti da Meynet in modo da evidenziare graficamente gli elementi di richiamo interni (ad es., i parallelismi).

78
non pensano affatto alla passione e al momento dell'arresto fuggiranno. 4.2.4.3. L'analisi narrativa Bibliografia Per una presentazione del metodo cfr. B.M.F. van Iersel, Leggere Marco, tr.it., Milano, Edizioni Paoline 1989 (ed.orig. Boxtel 1986), pp. 13-19. Commenti che si ispirano all'analisi narrativa: cfr. B.M.F. van Iersel, Leggere Marco, cit.; Id., Marco. La lettura e la risposta. Un commento, tr. it., Brescia, Queriniana, 2000 (ed. orig. 1998);
J.D. Kingsbury, Matteo, tr. it., Brescia, Queriniana, 1998 (ed. orig. Philadelphia 19882); S. Grasso, Matteo. Il vangelo narrato, Milano, Paoline, 2000; J.-N. Aletti, L'arte di raccontare Gesù Cristo. La scrittura narrativa del vangelo di Luca, tr. it., Brescia, Queriniana, 1991 (ed. orig. Paris 1989); Id., Il racconto come teologia. Studio narrativo del terzo Vangelo e del libro degli Atti degli Apostoli, tr. it., Roma, Ed. Dehoniane, 1996. Anche D. Marguerat, in La prima storia del cristianesimo. Gli Atti degli apostoli, tr. it., Cinisello Balsamo (Milano), Ed. San Paolo, 2002 (ed. orig. Paris 1999) utilizza i nuovi strumenti dell'analisi narrativa. L'analisi del racconto, che prende le mosse dall'analisi strutturale e dalle ricerche sulle fiabe russe di V. Propp 104 e ha i suoi pionieri in A. Greimas e R. Barthes,105 presta particolare attenzione alle "funzioni", sia come azioni che determinano lo sviluppo della narrazione sia come indicazioni qualificanti (ad es., le indicazioni geografiche e cronologiche), e ai ruoli svolti dai personaggi, inoltre ricerca all'interno del testo ciò che il testo dice di se stesso. Si accosta insomma al Vangelo come ad una narrazione. In pratica, l'analisi del racconto prende in considerazione innanzitutto i personaggi, i luoghi e i tempi presenti nel Vangelo. Si preoccupa meno di commentare parola per parola che non di ricercare le grandi linee del racconto. 2.2.4.4. Applicazione dei metodi di Analisi letteraria all'episodio di Levi e del banchetto coi pubblicani (Mc 2,13-17) Esaminato secondo questi metodi, l'episodio viene innanzitutto inserito nel complesso delle cinque dispute galilaiche che si estende in Marco da 2,1 a 3,6 (cfr. All. 15): 1. Mc 2,1-12 (guarigione del paralitico): la disputa verte sul perdono dei peccati; 2. Mc 2,13-17 (chiamata di Levi e banchetto coi pubblicani): la disputa è sul mangiare coi pubblicani; 3. Mc 2,18-22: disputa esplicita sul digiuno; 104 Fondamentale è la sua Morfologia della fiaba, tr.it., Torino, Einaudi, 1966 (ed.orig. 1928), in cui riconosce che i vari racconti popolari, al di là delle differenze, presentano un'identica struttura di base e un'identica sequenza di "funzioni" o atti narrativi (allontanamento, lotta, vittoria, ecc.). Anche i ruoli svolti dai personaggi sono limitati e costanti (eroe, antagonista, aiutante, ecc.). 105 A. J. Greimas, Sémantique structurelle, Paris 1966 (tr.it., Milano, Rizzoli, 1968); R. Barthes, Introduzione all'analisi strutturale dei racconti, in AA.VV., L'analisi del racconto, tr. it., Milano,
Bompiani, 1969, 1977 3 (ed. orig. Paris 1966), pp. 5-46; una sintesi del loro metodo è presentata da F. Bovon in AA.VV., Analisi strutturale ed esegesi biblica, cit., pp. 18-24.

79
4. Mc 2,23-28: disputa esplicita sul mangiare spighe di sabato; 5. Mc 3,1-6 (guarigione dell'uomo damma mano inaridita): disputa sul guarire di sabato. Questo complesso vede una progressione drammatica per cui l'ostilità degli avversari, che dapprima è tacita (2,6), si esprime nel nostro brano con una battuta rivolta ai discepoli (2,16), quindi con critiche rivolte direttamente a Gesù (2,18 e 24) e infine con un atteggiamento provocatorio che induce Gesù a smascherarli, ma nel contempo sfocia nella decisione radicale di costoro di provocarne la morte (3,1-6). Standaert (pp. 49-50) ritrova in questo complesso altre corrispondenze e analogie, che mostrerebbero una disposizione concentrica dei cinque elementi: il primo e l'ultimo sono racconti di guarigione e terminano con le reazioni dei presenti, prima positiva (2,12), poi negativa (3,6); le tre controversie centrali (di cui la nostra è la prima) menzionano la presenza dei discepoli (2,15; 2,18; 2,23), si concludono con parole sentenziose di Gesù (217; 2,22; 2,27), ma non con reazioni di altri. La controversia sul digiuno (2,18-22) sarebbe il perno di tutta la sezione con il primo cenno allusivo da parte di Gesù alla propria morte ("lo sposo sarà tolto"). Ancora più precisi sono i parallelismi che trova J. Dewey 106 tra il nostro episodio e quello dei discepoli che colgono e mangiano spighe di sabato, all'interno di una sezione di dispute che presenta lo schema ABCB'A'. Essa nota, ad esempio, che anche formalmente i due episodi si assomigliano, in quanto sono costituiti da una disputa che si conclude con un proverbio ("Non hanno bisogno i sani..."; "Il sabato è fatto per l'uomo...") e con un detto cristologico ("Non sono venuto per..."; "Il Figlio dell'uomo è padrone del sabato"). Entrambi hanno per tema il mangiare, un mangiare che contrasta con la "legge", in entrambi viene in primo piano il "bisogno" (i malati hanno bisogno del medico; Davide, secondo l'esempio citato da Gesù, ebbe bisogno di mangiare). Van Iersel (p. 46) ritrova un parallelismo tra la sezione 1,21-3,30 (ambientata in Galilea), in cui Gesù manifesta la sua autorità ai seguaci e alla folla e suscita l'opposizione degli avversari, e la sezione 11,12-12,40 (ambientata a Gerusalemme), in cui abbiamo pure cinque controversie e attacchi all'autorità di Gesù da parte di avversari. Caratteristico è il suo commento (pp. 73-111), che non si sofferma sui singoli episodi e sui singoli versetti, ma esamina l'intera sezione 1,14-3,35, soffermandosi sugli spostamenti di Gesù, sui vari tipi di personaggi che compaiono (sostenitori e collaboratori, avversari, malati, folla), sulle notazioni di tempo, sulle allusioni all'Antico Testamento, sullo sviluppo del racconto, sui commenti del narratore, sull'imposizione del silenzio da parte di Gesù a proposito della sua identità. Dal punto di vista del racconto coglie la "tattica del dilazionamento", per cui un esito atteso (la conclusione dei piani ostili degli avversari) non ha sùbito luogo, e l'ambiguità del comportamento di Gesù che 106 The Literary Structure of the Controversy Stories in Mark 2,1-3,6, in W. Telford (ed.), The Interpretation of Mark, pp. 109-118.

80
proprio quando ha più successo impone il segreto. 2.2.4.5. Conclusione sui metodi di analisi letteraria Anche le metodologie strutturaliste e narratologiche presentano i loro rischi e i loro difetti. Hanno pretese di oggettività e scientificità, ma non sempre evitano il pericolo dell'arbitrarietà e questo avviene quando si pretende di imporre ai testi schemi e corrispondenze che non ci sono. Un'altra manchevolezza di questi metodi, quando siano applicati "puri" e senza integrazioni, è quella di ignorare programmaticamente il contesto storico e culturale, pretendendo di leggere l'opera antica senza mediazioni (talora anche soltanto in traduzione e senza sussidi filologici), come se fosse stata scritta per il lettore moderno oppure per un lettore astratto, né antico né moderno. Ma questa posizione si rivela spesso insostenibile, perché per capire occorre per lo più rifarsi alle nozioni presupposte dal testo e note ai suoi lettori primitivi; perciò obbliga a incoerenze. E' questo un limite del commento di van Iersel. Talora poi l'apparato tecnico messo in opera appare troppo complicato, farraginoso e sproporzionato rispetto ai risultati. Si tratta tuttavia di metodologie ancora in corso di sperimentazione, che hanno bisogno di essere applicate con discrezione e sensibilità. 2.3. Considerazioni finali sui metodi Innanzitutto crediamo più opportuno partire dalle esigenze di unitarietà e organicità di lettura affermate dalle metodologie letterarie, in quanto sembrano corrispondere meglio alle caratteristiche e alle intenzioni stesse dei testi evangelici, che sono stati trasmessi come libri unitari, appunto, e libri che hanno l'andamento di racconti .107 Anche se gli autori hanno usato materiali a loro antecedenti, occorre tener ferma la convinzione che essi li hanno comunque fatti propri e li hanno inseriti in un insieme in cui acquistano una nuova funzione e un nuovo significato per le relazioni interne che si instaurano tra i brani e tra le parole. E' opportuno però cercare di evitare, nella ricerca delle strutture e delle corrispondenze presenti nel testo, schematismi troppo rigidi e superficialità. Un altro presupposto di queste metodologie che va accettato è quello che ogni Vangelo debba essere letto innanzitutto a sé, senza sovrapporlo o confonderlo con quanto si ritrova nei Vangeli paralleli, proprio per coglierne l'individualità e originalità. D'altra parte, uno sguardo ai paralleli degli altri Vangeli può essere utile, sia perché, ad esempio per Matteo e Luca, si deve presupporre un rapporto spesso di dipendenza nei confronti di Marco, sia perché tutti gli evangelisti appartengono a un medesimo contesto culturale e religioso e possono aiutare a comprendere meglio certi presupposti. Non si deve, certo, mettere da parte lo sfondo storico e culturale ed è
107 Per Luca il richiamo al "racconto" (dihvghsin) è esplicito già nel prologo (Lc 1,1).

81
bene cercare di mettersi dal punto di vista dell'autore e del lettore del suo tempo, perché un'opera letteraria, pur contenendo un messaggio valido per tutti i tempi, resta storicamente datata negli strumenti di cui si serve e nelle finalità che si propone. Ignorare, ad esempio, le allusioni all'Antico Testamento e alla cultura ebraica porterebbe a un grave fraintendimento. Non si tratta però di ricostruire tutto il retroterra del Vangelo, né di studiare ogni nozione (luogo, situazione, usanza, personaggio, ecc.) in sé e per sé, ma di subordinare ogni conoscenza utile allo scopo di verificare il significato che i vari elementi assumono nel contesto del Vangelo stesso, il contributo che dànno all'interpretazione complessiva del testo. Bisogna lavorare molto proprio sul testo, leggendo innanzitutto "Marco con Marco", "Matteo con Matteo" (un principio che già i filologi alessandrini avevano formulato per lo studio di Omero: "leggere Omero con Omero"), prestando molta attenzione alle parole che ciascuno usa,108 ai richiami che egli stesso inserisce nel testo, e tenendo presente la sua cultura biblica. In concreto, si possono recuperare quasi tutte le annotazioni che siamo venuti via via raccogliendo dalle diverse letture, specialmente quelle ricavate attraverso il metodo della Storia della redazione, però occorre verificarle sempre sul testo. 2.3.1. Ancora qualche considerazione sul brano di Levi e del banchetto coi pubblicani In genere i commenti hanno concluso che il brano nel suo complesso gravita intorno alla disputa con gli scribi, rispetto alla quale la chiamata di Levi sarebbe solo un'introduzione. Ora, proprio tenendo conto di ciò che il testo dice, è possibile osservare che il tema del discepolato è tutt'altro che secondario. Il primo versetto, che, come tutti riconoscono, è redazionale, stringe un forte collegamento con l'episodio della chiamata dei primi discepoli: "E passando lungo il mare..." (1,16); "E uscì di nuovo lungo il mare... E passando..." (2,13-14). Dopo 1,16, è la prima volta che viene di nuovo menzionato il "mare" e in entrambi i casi Gesù opera qui la chiamata di discepoli. Un altro termine-chiave è ajkolouqevw, "seguire", che risulta un termine tecnico per indicare il comportamento del "seguace" e del discepolo: compariva già in 1,18, a proposito della chiamata di Simone e Andrea, ricompare qui, a proposito di Levi (2,14), ma anche poi nell'episodio del banchetto, dove, con un'annotazione che è parsa a molti lettori superflua (anche Matteo e Luca la omettono) Marco osserva che "erano molti (i discepoli? i pubblicani e i peccatori?: come in tanti casi, c'è forse una voluta ambiguità) e lo seguivano" (2,15). E infine il termine kalevw, "chiamare", usato da Gesù nel detto conclusivo ("Non sono venuto per chiamare..."), è di nuovo il termine che già ricorreva nell'episodio della chiamata dei primi discepoli (1,20: "E subito li chiamò") e riporta l'attenzione sull'azione di Gesù di raccogliere a sé seguaci. In questa prospettiva, la situazione del banchetto diventa lo scopo per cui Gesù chiama: per "essere con 108 Uno strumento essenziale sono da questo punto di vista le Concordanze del Nuovo Testamento (ad esempio, quelle di A. Schmoller), che forniscono per ogni vocabolo tutte le ricorrenze.

82
lui" (cfr. 3,14: a proposito della chiamata dei dodici), per fare comunione con lui nel senso più pieno (si vedano i termini sunanevkeinto, "erano a tavola con ", ejsqivei metav..., "mangia con"). E' già significativo che la chiamata avvenga sempre, esemplarmente, "lungo il mare", perché, come abbiamo già accennato, e come è possibile constatare attraverso un'analisi di tutte le ricorrenze del termine (e secondo un uso già proprio dell'immaginario biblico), il mare appare il luogo in cui dimorano e si scatenano le potenze maligne, è immagine del mondo corrotto. La chiamata diventa un modo per salvare dal male. Al chiamare sulla riva del mare, o dal mare (come nel caso dei primi quattro discepoli, pescatori), corrisponde così bene l'espressione "chiamare i peccatori" (i pubblicani sono visti come una categoria di peccatori). I due racconti (chiamata di Levi e banchetto coi pubblicani) si possono così vedere collegati innanzitutto da questo tema. Il rapporto col precedente episodio di chiamata di discepoli indica che sempre Gesù si comporta così. Un altro tratto che emerge facendo attenzione alle connotazioni connesse con la terminologia usata, è il collegamento tra il detto di Gesù sul medico e le guarigioni da lui operate. Un' espressione comune è oiJ kakw~" ejvconte", "i malati", che già ricorreva insistentemente in 1,32 e 34: "gli portavano tutti i malati"; "guarì molti malati che soffrivano di varie malattie". "Malati" e "peccatori" diventano così, grazie all'applicazione metaforica in questo brano del banchetto, due categorie simili e interconnesse ed è in qualche modo sempre la stessa l'azione terapeutica di Gesù che si rivolge alle malattie fisiche e al peccato. Orientava già in questo senso l'episodio precedente del paralitico (2,1-12), in cui Gesù provocatoriamente, contro l'aspettativa generale, prima perdona i peccati al malato, e solo in un secondo tempo lo risana, proprio per dimostrare che il suo potere si estende all'una e all'altra cosa, ma soprattutto per mostrare visibilmente il suo potere di rimettere i peccati, che è l'effetto più importante. Siamo così avvertiti anche della valenza simbolica che possono acquistare, allora, i vari miracoli di guarigione: come vedremo, questa connotazione risulta importante in particolare per i miracoli relativi a cecità e sordità. Inoltre si può notare che sia nel caso delle guarigioni sia nel caso dell'accoglienza dei peccatori Gesù risponde a un "bisogno", senza chiedere nulla in cambio (neppure, almeno esplicitamente, la conversione). L'accento è posto, qui come là, sul "potere o autorità" (ejxousiva) di Gesù come Figlio dell'uomo: autorità che si manifesta nell'insegnamento (1,27) e nel potere di rimettere i peccati (2,10), così come nella capacità di scacciare i demoni o di guarire le malattie (Gesù è il Medico), insomma, di annientare ogni male. Scaccia il male e dona la gioia dello stare insieme nel banchetto, cioè nella forma più caratteristica della convivialità e della festa. Emerge dunque anche il carattere della gratuità dell'opera salvifica di Gesù. Da questo punto di vista l'episodio si collega con quelli seguenti, che riguardano, rispettivamente, il fatto che i discepoli di Gesù non digiunano (2,18-22) e la raccolta delle spighe, sempre da parte dei discepoli, di sabato

83
(2,23-28). Ancora una volta lo stare dei discepoli con Gesù, che è lo Sposo (oJ numfivo" met jaujtw~n, "lo sposo con loro"), si accompagna all'idea del mangiare insieme (è implicito nell'idea che non si può digiunare). E questo mangiare può avvenire anche di sabato, perché, da una parte, risponde a un "bisogno" (creivan ejvscen, "ebbe bisogno"), dall'altra è reso possibile (ejvxestin) da Gesù stesso che è "padrone" del sabato 109. Come conclusione provvisoria possiamo allora dire che ci sono almeno due fili che si intrecciano nel nostro episodio (oltre che negli episodi collegati): da una parte, un filo positivo che illustra il potere benefico e salvifico di Gesù che si estende, gratuitamente e indiscriminatamente, a tutti quelli che chiama; dall'altra, il filo negativo dell'opposizione che via via cresce a causa di coloro che al fare il bene preferiscono un legalismo mortifero (cfr. 3,4), invece di mangiare con Gesù digiunano e nonché seguirlo se ne allontanano pensando perfino di ucciderlo. 2.3.2. La struttura complessiva del Vangelo di Marco I commentatori tradizionali non hanno sempre mostrato interesse per la struttura del Vangelo così come attualmente si presenta: l'interesse è andato, semmai, all'individuazione di articolazioni corrispondenti alle suture tra materiali e raccolte antecedenti, oppure ci si è basati sugli spostamenti dello sfondo geografico (dalla Galilea a Gerusalemme, come si è visto), o su nuclei tematici e teologici. D'altra parte, chi ha cercato criteri letterari interni al testo, lo ha fatto partendo da elementi di vario tipo, talora anche sovrapponendo al testo schemi precostituiti. La conseguenza è che non esiste accordo su questo punto tra gli studiosi. Eppure, è importante, se si ammette l'intenzione letteraria del redattore, la sua volontà, non di fornire semplicemente una raccolta di materiali, ma un racconto unitario e coerente, riconoscere l'esistenza di un'articolazione interna. Il criterio più valido sarà essenzialmente quello di partire dalle indicazioni fornite dall'opera stessa, senza rigidezze e forzature. Anche volendo servirsi di elementi presenti nel testo stesso, occorre seguire criteri elastici e tener conto che molti elementi, che certamente hanno la funzione di delimitare delle parti, possono essere plurivalenti, nel senso che possono essere considerati sia in rapporto alla parte precedente, sia in rapporto alla successiva, rendendo oscillante il limite vero e proprio tra le sezioni. Così, ad esempio, per il prologo del Vangelo, il sommario di 1,14-15 ("Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù venne nella Galilea annunciando il vangelo di Dio e dicendo: Il tempo è compiuto ed il regno di Dio è vicino: convertitevi e credete nel vangelo") viene considerato un elemento di delimitazione: ma alcuni (Radermakers) lo pongono come inizio di una nuova
109 Il tema del mangiare, specialmente del mangiare con Gesù, ha un grande rilievo nel Vangelo di Marco: un'intera sezione, che è incorniciata da due moltiplicazioni dei pani, è detta "sezione dei pani", ma pensiamo anche all'episodio della donna di Betania, all'istituzione dell'eucarestia, ecc.

84
sezione, altri (Pesch) come conclusione del prologo stesso. Indubbiamente la ripresa ripetuta del termine eujaggevlion,"vangelo", come già avevamo osservato, costituisce un'inclusione rispetto al titolo e fa pensare che il sommario sia parte integrante del prologo. D'altra parte, la struttura costituita da un sommario + un racconto relativo ai discepoli (1,16-20: chiamata; 3,13-19: scelta dei dodici; 6,7-13: invio in missione) si ripropone costantemente nella prima parte del Vangelo per indicare le prime tappe della missione di Gesù, così che si è portati a collegare strettamente 1,14-15 con l'episodio successivo. Volendo individuare le articolazioni del Vangelo a partire dagli elementi più chiari, sia di tipo formale sia di tipo contenutistico (vedi All. 17), il primo nucleo che spicca per la sua omogeneità è il racconto della passione, che si sviluppa tra 14,1 e 15,47. Tutti gli elementi (la geografia, la cronologia, il tema) lo confermano e anche lo studio della tradizione porta a concludere che si tratta del nucleo più antico, anche se non si può probabilmente dire che Marco abbia riportato, neppure qui, tutto e soltanto ciò che trovava nella tradizione, senza suoi interventi personali. L'importanza del racconto della passione come parte determinante di tutto il Vangelo, centro di gravitazione di tutto il racconto, è sempre stata riconosciuto, tanto che è diventata famosa la definizione data al Vangelo di Marco (da uno studioso tedesco dell'inizio del '900, Martin Kähler) come "racconto della passione con una introduzione". Il cap.16,1-8 110, che si riferisce all'annuncio della risurrezione, da alcuni (cfr. Pesch) è considerato parte integrante del racconto della passione, da altri - e forse meglio - una sorta di "epilogo" autonomo, che fa da pendant al prologo. In realtà, però, la collocazione geografica (a Gerusalemme) e le indicazioni cronologiche (la scansione della "settimana della passione", di cui già abbiamo parlato) indurrebbero a individuare un'unità narrativa omogenea più ampia, che comprende tutti i capitoli 11-15, e che a sua volta si divide in due parti: i capp.11-13, relativi ai primi tre giorni della settimana, e i capp.14-15, relativi agli ultimi tre giorni. Da questo punto di vista, il giorno della risurrezione, o ottavo, sta effettivamente a sé, e costituisce come un nuovo inizio, mentre il settimo giorno, il sabato, è menzionato, ma esce dal racconto, perché in esso non succede nulla. Molto spesso il cap.13 ("discorso escatologico") viene considerato come una zeppa, un'inserzione non ben amalgamata nell'insieme: guardando invece alla struttura elaborata da Marco, potremmo notare che occupa una posizione centrale nel racconto della settimana della passione, e quindi assume un ruolo fondamentale in essa. Anche la sezione che va da 8,27 a 10,52 appare costruita da Marco in modo unitario, almeno per il fatto che è imperniata su tre annunci della passione (8,31; 9,31; 10,33-34), seguiti ogni volta da manifestazioni di
110 I versetti 9-20 ("finale canonica"), con i racconti relativi alle apparizioni del risorto, non sono probabilmente da considerare marciani, per ragioni sia filologiche sia linguistiche sia stilistiche. Esamineremo la questione nella seconda parte.

85
incomprensione dei discepoli e da insegnamenti di Gesù che illustrano il vero discepolato. Una funzione di delimitazione di questa sezione si può dire che svolgano i due miracoli corrispondenti di guarigione di ciechi, il cieco di Betsaida (8,22-26) e il cieco di Gerico (10,46-52). Dal punto di vista della geografia, si può notare che questa sezione è più volte percorsa da indicazioni sul fatto che Gesù e i discepoli sono "in viaggio", per strada: ejn oJdw/~ "per strada", si trova, in particolare, sia all'inizio (8,27) sia alla fine (10,52). Questa sezione introduce chiaramente al racconto della passione ed è in funzione di esso. Da questo punto di vista, tutta la seconda parte del Vangelo, che incomincia con 8,27, è quasi interamente incentrata sulla passione e 8,27 (ma secondo altri, 8,30) costituisce una specie di spartiacque nel Vangelo. Per quanto riguarda la prima parte, l'impressione è che sia più difficile individuare articolazioni precise. Abbiamo già detto che è forse possibile riconoscere alcuni momenti decisivi in episodi che riguardano i discepoli, ogni volta preceduti da sommari. Ma anche fattori cronologici e geografici possono contribuire a delimitare le parti. Esiste in ogni caso un certo accordo tra gli studiosi nell'individuare le seguenti sezioni: una prima sezione da 1,14 (o 1,16) a 3,6, cioè a partire dalla chiamata dei primi discepoli fino alla fine della serie di cinque controversie. Questa prima sezione è incentrata soprattutto in Cafarnao di Galilea e anche temporalmente presenta elementi di richiamo interni: inizia e finisce con episodi di miracolo compiuti di sabato in una sinagoga; una seconda sezione, da 3,7 a 6,6 a, inizia con la scelta dei dodici e si conclude ancora con un episodio che avviene di sabato, in una sinagoga (a Nazaret), tratto che si riallaccia a 1,21 e 3,1-2. Anche questa sezione ruota intorno alla Galilea, ma con un passaggio in terra straniera, mediante l'attraversamento del lago o mare di Galilea, che porta Gesù a Gerasa, tra i pagani (c.5). Questa sezione ha al suo centro il discorso in parabole del cap.4; Tutta la parte tra 1,14 e 6,13 viene incorniciata da, e trova perciò un motivo di ulteriore unificazione in, due ampi riferimenti alla figura di Giovanni Battista, di cui prima viene presentata la predicazione (1,4-8) e poi la morte (6,14-29). una terza sezione da 6,6 b a 8,26 inizia con l'invio dei discepoli in missione e si conclude col miracolo del cieco di Betsaida o, se vogliamo lasciare a parte il miracolo, che ha anche la funzione di incorniciare la sezione centrale, col rimprovero di Gesù ai discepoli per la loro incredulità (8,14-21). Questo rimprovero ha in effetti funzione di richiamo e conclusione rispetto ai due episodi di moltiplicazione dei pani (6,30-44 e 8,1-9) che stanno all'inizio e alla fine della sezione. Per quanto riguarda la geografia, vediamo che gli spostamenti si intensificano e portano anche al di là delle rive opposte del lago, decisamente in regioni pagane. Abbiamo suggerito l'ipotesi che il viaggio a Betsaida (città fuori dalla Galilea, di fronte a Cafarnao), progettato in 6,45 e concluso in 8,22, possa costituire un itinerario anche metaforico e unificante di questa sezione.

86
Come si può notare, tutta la prima parte del Vangelo attribuisce un posto centrale ai discepoli, perché è inquadrata tra la prima chiamata e il duro e ampio rimprovero rivolto a loro. Tuttavia, accanto ai discepoli, compare molto spesso la folla, che assiste e reagisce ai miracoli, e si affacciano in più casi gli avversari, che domineranno poi nella seconda parte del Vangelo. C'è chi vede in queste prime sezioni un orientamento a sottolineare la crescente opposizione verso Gesù (che anticipa e spiega la passione successiva). Già la prima sezione, dopo le prime manifestazioni di entusiasmo, assiste al sorgere di polemiche che si inaspriscono via via e si concludono con la decisione di uccidere senz'altro Gesù (3,6). La seconda sezione, che già aveva avuto tra i primi episodi quello dei parenti di Gesù che lo credono pazzo (3,20 ss.), ha pure come conclusione un episodio di ostilità, tanto più grave e sorprendente, in quanto si esprime nel paese stesso di origine di Gesù, da parte dei suoi compatrioti (6,6). La terza sezione vede intensificarsi l'incomprensione dei discepoli stessi (che già si era manifestata all'ascolto delle parabole e durante la tempesta sedata), in molte occasioni tanto da provocare l'amarezza e le critiche di Gesù. L'incomprensione dei discepoli continuerà e si aggraverà nella seconda parte arrivando a forme di tradimento (Giuda, Pietro) e all'abbandono completo del maestro. E' un grande tema strutturale del Vangelo di Marco. Un filo che percorre tutta questa prima parte è quello della ricerca, da parte dei vari personaggi, dell'identità di Gesù: costantemente, i miracoli provocano stupore e interrogativi su chi sia questo taumaturgo, ma anche i discepoli, di fronte alle sue manifestazioni di potenza, si chiedono chi sia. D'altra parte, il riconoscimento che viene da parte dei demòni ("tu sei il Figlio di Dio") non vengono accettati da Gesù e anzi vengono zittiti. Due momenti-chiave che indicano questo filo conduttore della prima parte sono 6,14-16 e 8,27-29, che si richiamano esplicitamente: in entrambi i passi si dice che la gente ipotizzava che Gesù fosse Giovanni Battista redivivo oppure Elia opure un profeta. Da questo punto di vista, il riconoscimento da parte di Pietro che Gesù è il Cristo segna la conclusione della prima parte della ricerca ma contemporaneamente, a causa della reazione di Gesù, che anche questa volta impone il silenzio, apre una seconda parte, che è legata a precisare ulteriormente questa identità mettendola in rapporto con la passione. Alcune pietre miliari sono collocate da Marco in momenti decisivi, all'inizio, al centro e alla fine del Vangelo, e sono le dichiarazioni che vengono dalla voce celeste, durante il battesimo (1,11) e la Trasfigurazione (9,7), e dal centurione pagano, durante la crocifissione (15,39): in tutte Gesù viene definito Figlio di Dio, ma c'è un progressivo allargamento del pubbblico a cui la rivelazione è destinata: nel battesimo è Gesù soltanto che può udire, nella Trasfigurazione alcuni discepoli, nella crocifissione tutti i presenti, anche gli avversari. Anche il soggetto del riconoscimento cambia: prima Dio, poi l'uomo. La struttura globale del Vangelo è quindi, in parte concentrica, perché ha un punto centrale che è determinante per la struttura, ma insieme è proiettata

87
verso la fine, grazie al progresso della rivelazione che si realizza soltanto al momento della morte.
II parte: Problemi critici e interpretatividel Vangelo di Marco In questa seconda parte presentiamo, particolarmente per chi sa il greco, alcune nozioni di Critica testuale che consentano di leggere un'edizione critica come quella del Nestle-Aland, e discuteremo alcuni problemi, sia di tipo testuale sia di tipo interpretativo. 1. La Critica testualedel Nuovo Testamento Bibliografia Sulla critica testuale, a parte i capitoli pertinenti contenuti nelle introduzioni al NT citate (tra cui va segnalato il contributo di R. Dupont-Roc in D. Marguerat, Introduzione al Nuovo Testamento, tr. it., Torino, Claudiana, 2004 [ed. orig. 20012], abbiamo saggi specifici: - K. e B. Aland, Il testo del Nuovo Testamento, tr. it., Genova, Marietti, 1987; - A. Passoni dell'Acqua, Il testo del Nuovo Testamento. Introduzione alla critica testuale, Leumann (Torino), LDC, 1994; - B.M. Metzger, Il testo del Nuovo Testamento. Trasmissione, corruzione e restituzione, ed. it., "Introduzione allo studio della Bibbia". Suppl. 1, Brescia, Paideia, 1996 (ed.orig., Oxford 1992). La critica testuale è la base del metodo storico-critico, perché riguarda l'accertamento dell'affidabilità dei testi: vale per i Vangeli come per ogni altro libro del NT. Viene esercitata in forma specifica dai filologi che operano sulla tradizione manoscritta e discutono in modo specifico i problemi delle varianti per arrivare ad approntare le edizioni critiche; tuttavia interessa in qualche misura anche i lettori, ai quali può capitare di trovarsi di fronte a qualche questione rilevante per l'interpretazione. I criteri piuttosto sofisticati con cui oggi si affrontano le questioni testuali sono il risultato di secoli di ricerche 111. La Bibbia è stata la prima opera ad essere pubblicata dopo la scoperta della stampa, ma inizialmente si tendeva ad attenersi al testo più facilmente reperibile e ritenuto più affidabile. A livello scientifico, la critica testuale è sorta nel 1800 per incrinare la rigidità del textus receptus, ossia della forma del testo più diffusa e autorevole, che si era imposta fino al '700, e per contrastare le resistenze a modificarlo. C'è stato un imponente lavoro di verifica su gran parte della documentazione manoscritta pervenuta, ossia papiri, manoscritti, lezionari, traduzioni antiche, citazioni patristiche; tale documentazione si è inoltre arricchita per effetto di scoperte importanti: pensiamo ai rotoli di Qumran, per l'AT, che hanno consentito di accedere a
111 Già nell'antichità era praticata la critica del testo: abbiamo il caso di Ireneo di Lione che discute sulla variante 616 rispetto al numero 666 della Bestia dell'Apocalisse (13,18), in Adv. Haer. V,30,1; abbiamo Origene, che compone un'edizione dell'AT su sei colonne (donde il titolo Hexapla da hex, "sei"), contenenti testo ebraico, traslitterazione dell'ebraico in lettere greche, traduzione greca dei Settanta e altre tre traduzioni greche, e segnala a margine le varianti; abbiamo Gerolamo, autore della versione latina più diffusa della Scrittura, la "Vulgata", e che discute nei commenti di problemi critici, ecc.

88
copie molto più antiche di quelle prima possedute, che erano di età medievale; pensiamo alle raccolte di papiri per il NT, che si costituiscono tra fine '800 e inizio '900. C'è stato, soprattutto a partire dalla metà dell'800, un affinamento dei criteri di scelta tra le varianti, per l'adozione dei criteri filologici invalsi nell'ambito classico (K. Lachmann).112
Oggi, nonostante i progressi, non si è ancora arrivati a risultati definitivi su tutti i punti dubbi, date alcune caratteristiche che sono proprie alla trasmissione del NT. 1.1 I testimoni del testo I libri del NT furono copiati molto di più di qualsiasi altro testo antico e questo significa che il numero dei testimoni della tradizione manoscritta è molto grande e ha continuato ad arricchirsi anche nel nostro secolo grazie a ricerche più accurate: oggi risultano oltre 5500. Il grande numero di testimoni comporta un grande numero di varianti, e quindi un grande numero di scelte da compiere, non sempre facili. Quando si parla di "testimoni" del testo del NT si intendono alcuni tipi distinti di documenti che riportano il testo del NT, che sono: - i papiri (ossia i testi scritti sui fogli prodotti a partire dalla pianta omonima); - i manoscritti (scritti su pergamena), distinti, a seconda della forma di scrittura usata, in maiuscoli e minuscoli; - i lezionari, che contengono i passi biblici usati nella liturgia secondo il calendario liturgico; - le traduzioni nelle varie lingue antiche (latino, siriaco, copto, ecc.) che conosciamo attraverso manoscritti ed edizioni; - le citazioni bibliche riportate dagli autori cristiani antichi nelle loro opere. Al momento attuale (cioè sulla base dei dati forniti da R. Dupont-Roc nel 2004) il numero dei primi tre tipi di testimoni è: 115 papiri, 309 manoscritti maiuscoli, 2862 minuscoli, 2412 lezionari.113 Non tutti questi testimoni sono stati letti, valutati e confrontati adeguatamente. Nelle edizioni critiche (si veda in particolare quella del Nestle-Aland, che risulta oggi la più aggiornata: la presenteremo più avanti) l'apparato critico posto a fondo pagina, che mira a fornire il maggior numero possibile di informazioni sullo stato della questione intorno ai passi che presentano varianti tra i testimoni, per ogni variante indica i testimoni in ordine di importanza: prima i papiri, poi i manoscritti maiuscoli, poi quelli minuscoli, poi i lezionari,
112 K. Lachmann era un filologo classico, ma applicò la sua metodologia anche al NT, di cui pubblicò nel 1831 un'edizione. 113 Si consideri che tale numero è enormemente maggiore che per qualunque altro testo antico: dell'Iliade, la "bibbia" dei greci antichi, abbiamo 457 papiri, 2 mss. (= manoscritti) maiuscoli e 188 minuscoli; di Euripide, tra i più letti: 54 papiri, 276 mss., quasi tutti bizantini. Di molti autori la documentazione è minima, anche un solo ms.

89
poi le traduzioni, e alla fine i Padri. Si veda come esempio la pagina del Prologo di Marco (1,1-8), allegata (All. 18). Per i papiri la sigla usata è P (talora scritta in carattere gotico: così nel Nestle-Aland) seguita da un numero in esponente che corrisponde al numero d'ordine dato da C.R. Gregory: ad es., P 46, P 65, ecc. I manoscritti in maiuscola sono indicati in modi differenti, perché risentono dei criteri adottati nelle varie epoche e adeguati di volta in volta alla crescita del loro numero. Quelli scoperti per primi vengono tuttora indicati con lettere maiuscole dell'alfabeto latino (A,B,C,D, ecc.) oppure, con lettere maiuscole dell'alfabeto greco (Q, D, ecc.), che vennero introdotte quando le prime risultarono insufficienti. Il famoso codice Sinaitico, scoperto da C. von Tischendorf nel 1859, fu da lui designato con la prima lettera dell'alfabeto ebraico, Å, 'alef (così compare anche nel Nestle-Aland, mentre l'editore Merk lo cita con S). Ma per i manoscritti maiuscoli si usa anche indicarli con numeri arabi preceduti da uno zero (0233, 0250, ecc.), ulteriore espediente adottato quando le lettere dei due alfabeti furono esaurite; tale numerazione è stata applicata anche ai manoscritti indicati comunemente con lettere, sicché negli elenchi generali i primi manoscritti hanno una doppia sigla (ad es., A è anche 02, B è anche 03, ecc.).114 I manoscritti in minuscola sono indicati tutti con numeri arabi. I lezionari sono indicati con una l corsiva seguita dal numero d'ordine dato da chi li ha classificati (Gregory). Le traduzioni sono indicate con abbreviazioni in lettere latine minuscole: it (= Itala, antiche versioni latine anteriori alla Vulgata), vg (= vulgata), latt (= tutte le versioni latine), sy (= traduzioni siriache), co (= traduzioni copte), ecc. Sempre con lettere latine minuscole sono indicati singoli manoscritti delle versioni latine più antiche (a, b, c, ecc.). Le citazioni patristiche sono indicate con abbreviazioni dei nomi latini dei Padri: Ir (= Ireneus), Or (= Origenes), ecc. Oggi viene attribuita una grande importanza ai papiri, nonostante che per il loro carattere frammentario riportino quantità ridotte di testo, perché in qualche caso sono databili
ai primi decenni del II secolo. Tra i papiri abbiamo infatti il testimone più antico del NT, P 52,
che è datato al 125 e contiene un frammento di Gv (18,31-33.37-38). Verso il 200 sono datati P 46,
che contiene nove epistole paoline, e P 66, di ben 104 pagine, contenente alcune parti di Gv (i
primi sei capitoli e i capp. 6-14). P 46 e P 66 appartengono a due importanti collezioni che sono state costituite nel XX secolo, ripettivamente quella Chester Beatty di Dublino e quella Bodmer
di Ginevra.115
114 Questo sistema risulta molto più pratico di quello adottato inizialmente: i manoscritti in maiuscola erano indicati con denominazioni che facevano riferimento al luogo di provenienza (Codex Alexandrinus [oggi A o 02]: proveniente da Alessandria) o al luogo di conservazione (Codex Vaticanus [oggi B o 03]: della Biblioteca Vaticana; di norma si aggiunge anche il numero di catalogazione), o al nome del proprietario (Codex Bezae [oggi D o 05]: trovato e acquistato da Teodoro Beza) o a particolarità (Codex Ephraemi rescriptus [oggi C o 04]: palinsesto, ovvero manoscritto del NT raschiato e riutilizzato per trascrivere l'opera di Efrem). 115 Le collezioni prendono nome dai primi acquirenti.

90
I manoscritti maiuscoli, o onciali, sono tutti anteriori al IX secolo, dato che posteriormente venne introdotta la scrittura minuscola e non si usò più quella maiuscola. Meno di un centinaio contengono più di due fogli, ma alcuni arrivano a contenere l'intera Bibbia, AT e NT. Sono pochissimi quelli anteriori al IV secolo (cinque in tutto), mentre al IV secolo risalgono 14 mss., e poi ne abbiamo 8 tra IV e V sec., 36 del V, ecc. I più importanti sono: - Å (o S nel Merk) o 01 o codice Sinaitico: è del IV sec. e originariamente conteneva tutta la Bibbia greca; ora contiene comunque tutto il NT: è l'unica copia completa del NT greco in caratteri maiuscoli. Anche per la qualità è ritenuto di fondamentale importanza. - A o 02 o codice Alessandrino: è del V sec. e contiene AT e NT con lacune: per il NT manca quasi tutto Mt. E' di qualità varia, a seconda dei libri, che furono copiati da mano diverse. E' importante per l'Apocalisse. - B o 03 o codice Vaticano: è del IV sec. e contiene AT e NT con lacune: per il NT mancano alcune lettere paoline e l'Apoc. E' il primo codice che contenga una suddivisione del testo. E' importante. - D o 05 o codice di Beza o Cantabrigiensis (si conserva a Cambridge): è del V sec. ed è bilingue, con greco e latino a fronte. Presenta i Vangeli nell'ordine Mt, Gv, Lc, Mc. Ha la caratteristica di riportare numerose e significative varianti, sia con omissioni sia con aggiunte, e non solo di parole o espressioni, ma di intere frasi. Negli Atti degli apostoli D è più lungo di circa un decimo rispetto al testo comunemente tramandato e presenta, talora insieme ad altri testimoni del cosiddetto "testo occidentale", alcune correzioni che rivelano un atteggiamento misogino: ne parleremo più avanti. I manoscritti minuscoli sono molto più numerosi dei maiuscoli, ma anche più tardi; appaiono in generale più corrotti, ma possono contenere lezioni valide. Sono classificati in varie categorie, a seconda del periodo in cui furono trascritti: i più antichi sono quelli tra IX e XIII sec. (vetustissimi, IX-X, vetusti, X-XII), mentre si dicono recentiores quelli tra XIII e XV sec. e novelli quelli copiati dopo dopo l'invenzione della stampa. Solo 58 minuscoli contengono tutto il NT. Alcuni gruppi di mss. minuscoli risultano così strettamente imparentati in base al tipo di errori
che contengono, da essere classificati unitariamente: sono le famiglie indicate con f 1 (cinque
mss.) e f 13 (una dozzina di mss.). I lezionari sono manoscritti di uso liturgico: contengono i passi usati per le letture, secondo il calendario liturgico. Una particolarità dei lezionari è che non riportano mai testi dell'Apocalisse, perché, a causa delle controversie sulla sua canonicità, non entrò nell'uso liturgico della chiesa greca. La maggior parte dei lezionari pervenuti non è anteriore al IX sec.; a differenza degli altri mss., continuarono ad essere trascritti in maiuscola, almeno fino all'XI, anche quando ormai era invalso l'uso della minuscola. Il lezionario più antico che possediamo è l 1596, del V sec. Due lezionari del IX sec. (l 961 e l 1566) sono tra i pochi testimoni della finale "intermedia" di Mc. Le traduzioni nelle varie lingue antiche possono essere di grande rilievo come testimoni del testo originale, perché risalgono ai primi secoli, ma comportano anche difficoltà, sia perché la struttura linguistica cambia, rispetto a quella del greco, sia perché non sempre si tratta di traduzioni rigorosamente letterali. Non interessano la critica testuali traduzioni che non siano state fatte direttamente a partire dal greco o rivedute sulla base del greco. Le traduzioni più importanti sono quelle latine, siriache e copte, ma abbiamo anche traduzioni armene, georgiane, etiopiche, gotiche, paleoslave, ecc. Il NT fu tradotto in latino già a partire dal II sec. nell'Africa del Nord, e poi in Italia,
Gallia, ecc.116 Queste versioni latine anteriori alla fine del IV sec. risultano molto letterali, e quindi particolarmente preziose per la ricostituzione dei testi greci da cui dipendono. Ma le versioni che conosciamo presentano molte differenze tra loro: sotto la denominazione di Vetus latina si indica pertanto, non una singola traduzione, ma il complesso delle traduzioni latine anteriori alla Vulgata di Gerolamo (e talora si distinguono l'Afra, l'Itala, ecc.). Possiamo ricostruire queste versioni sia attraverso le citazioni letterali fatte dai Padri latini del III-IV sec. (a partire da Tertulliano), sia attraverso i mss., che in genere riportano ciascuno solo parti del
116 Fino a tutto il II sec. era diffuso anche in occidente, nella liturgia, l'uso del greco, che tuttavia era poco compreso a livello popolare.

91
NT (Vangeli oppure Atti, oppure lettere di Paolo, oppure l'Apocalisse). Tra i mss. della Vetus latina il più importante è il codex Bobbiensis (proveniente dal monastero di Bobbio, ora alla Biblioteca Nazionale di Torino), indicato con la lettera k: fu scritto in Africa verso il 400, contiene circa metà di Mt e Mc ed è l'unico ms. del NT latino che riporti la finale "intermedia" di Mc. Non possediamo ancora un'edizione critica completa della Vetus latina. Col termine Vulgata (ossia "diffusa") si indica la traduzione latina del NT, attribuita a Gerolamo, e databile verso il 380; è incerto però se Gerolamo abbia effettivamente riveduto tutto il NT, o solo i Vangeli. Comunque questa traduzione divenne la più diffusa nella chiesa romana a partire dal VII sec. 117 e fu riconosciuta come quella ufficiale con le edizioni promosse da Sisto V (1590) e Clemente VIII (1592): nelle sigle con cui si citano le attestazioni della Vulgata
(vg), il Nestle-Aland indica in esponente, con s e cl, appunto queste edizioni (vg s e vg cl). In tempi moderni abbiamo avuto due edizioni della Vulgata: quella pubblicata a Oxford tra 1898 e
1954, da J. Wordsworth, H.J. White e H.F.D. Sparks (= vg ww) e quella pubblicata a Stuttgart
nel 1969, 19833 (= vg st). Paolo VI ha promosso una revisione della Vulgata sulla base dei testi originali, perciò dal 1979 (e in 2º ed. dal 1986) abbiamo la neo-Vulgata, che viene riprodotta a fronte del testo greco nelle edizioni bilingui del NT. Delle traduzioni siriache del NT esistono cinque tipi, a parte la versione siriaca del Diatessaron di Taziano, che conosciamo attraverso le citazioni di Efrem (un Padre siriaco che fece un commento al Diatessaron): 1. la Vetus syra, che è la più antica; la conosciamo principalmente attraverso due mss., uno della
fine del IV sec., trovato sul Monte Sinai, e perciò detto siro-sinaitico (sigla: sy s), l'altro, del V
sec., trovato in Egitto da W. Cureton, e perciò detto siro-curetoniano (sigla: sy c);
2. la Peschitta o Vulgata siriaca (sigla: sy p), la versione ufficiale, ancora oggi, della chiesa sira: non contiene alcune lettere cattoliche né l'Apoc. Ne possediamo molti mss. ed è in corso l'ed. crit.;
3. la versione detta filosseniana (sigla: sy ph), perché promossa dal vescovo Filosseno di Mabbug all'inizio del VI sec.;
4. la versione detta harclense (sigla: sy h), perché opera del vescovo Tommaso di Harqel, che compì una revisione della versione filosseniana sulla base di alcuni mss. greci, nel 616; 5. la versione siro-palestinese, poco nota: la testimonianza più estesa è quella di un lezionario dei Vangeli giunto in mss. dell'XI-XII sec. Importanti sono anche le traduzioni copte: sono almeno una mezza dozzina le forme dialettali del copto: le più antiche e importanti sono il sahidico (sigla: sa) e il bohairico (sigla: bo), poi abbiamo il medioegiziano (sigla: mae), l'achmimico (sigla: ac), ecc. Per la conoscenza di queste versioni è stata fondamentale la scoperta di molti papiri. Le citazioni dei Padri sono utili da molti punti di vista: per il loro numero e la loro estensione, consentono di ricostruire quasi tutto il NT; permettono di localizzare e datare i tipi di testo documentati nei mss. e nelle versioni; quando discutono esplicitamente di varianti documentate nei mss. a loro disposizione o esprimono opinioni sul testo. Presentano anche problemi, che dipendono sia dalla difficoltà di accertare se citino in modo letterale o libero, sia da possibili fenomeni di armonizzazione intervenuti nel corso della tradizione manoscritta delle opere stesse dei Padri. Sono particolarmente importanti le citazioni (letterali) dei Padri tra II e IV sec. (Ireneo, Origene, Cipriano, Eusebio di Cesarea, ecc.). 1.2. Princìpi di critica testuale Molte volte ci si trova di fronte a lezioni differenti senza che sia possibile scegliere con certezza la lezione "giusta". Negli ultimi 150 anni si è molto
117 Dopo l'invenzione della stampa il Nuovo Testamento venne dapprima pubblicato nella versione latina della Vulgata.

92
lavorato per stabilire dei criteri scientifici in questo senso. E si è lavorato in due direzioni principali: cercando di valutare attentamente le caratteristiche dei testimoni per accertarne l'affidabilità e cercando di fissare regole per scegliere tra diverse lezioni (o varianti) quella che più plausibilmente è quella originaria. Oggi si parla di "prove esterne" per quanto riguarda le considerazioni sul valore dei testimoni, di "prove interne" per quanto riguarda le considerazioni sulle singole varianti. Le prove esterne. Un primo elemento da prendere in considerazione è l'affidabilità dei singoli testimoni: sono generalmente ritenuti più importanti i testimoni più antichi. Ma non si tratta di un principio assoluto: ciò che conta realmente è la qualità dei singoli testimoni (la cura nella trascrizione e quindi un minor numero di errori meccanici), ma anche il fatto che una lezione sia attestata da più testimoni validi. Non è decisiva la quantità: il fatto che una lezione sia riportata dal maggior numero dei testimoni esistenti non rende la lezione più raccomandabile, anzi. Un problema di grande rilievo, per la critica testuale del NT, è stato, ed è ancora, quello di riconoscere (attraverso la comunanza di errori di particolare rilievo) i rapporti di parentela tra i codici, per determinare, non solo quali singoli codici siano affidabili, ma anche quali famiglie di codici lo siano. La filologia moderna, seguendo il metodo elaborato da K. Lachmann nell'800, ha in genere per i testi antichi cercato di stabilire i rapporti di parentela tra i codici, fissando uno stemma codicum, o albero genealogico, che ha al proprio vertice l'archetipo, cioè quel codice, che non possediamo più, ma che è all'origine di tutta la tradizione manoscritta esistente di una data opera e a cui si può tentare di arrivare nella ricostituzione del testo. Nel caso del NT però questa operazione non è possibile, sia per il grande numero dei testimoni, che non sono stati neppure tutti presi in considerazione, sia per quei fenomeni di contaminazione,118 che si verificano anche per altri testi e che sconvolgono la linearità dei rapporti. Tuttavia, a partire dal sec. XVIII, ma soprattutto dal XIX, gli studiosi del testo del NT hanno constatato che è possibile, in base al tipo di varianti dei codici, raggruppare i codici in famiglie e riconoscere che in vari periodi e zone si sono determinate recensioni particolari del testo (tipi testuali). Anche se la scoperta di nuovi documenti ha portato a modificare le valutazioni, si è d'accordo nel distinguere tra i testimoni tre o quattro gruppi o famiglie, a cui sono state attribuite dai diversi studiosi denominazioni diverse. Semplificando, possiamo dire questo. 1. Al primo posto, almeno quantitativamente, si pone il cosiddetto testo bizantino o koiné, che è quello rappresentato dalla grande maggioranza dei mss antichi (tra cui, per i Vangeli, A,W, Y, ecc.) e di quelli minuscoli. Prevalse nella
118 La contaminazione avviene quando un copista non copia semplicemente da un codice, ma da più codici contemporaneamente, seguendo ora l'uno ora l'altro.

93
chiesa greca e fu il più usato fino al XVI sec.; venne stampato per primo,119 diventando il textus receptus, cioè quello universalmente accolto. E' il più corrotto, perché ha subito numerose revisioni e tentativi di rendere il testo scorrevole e accettabile, anche dogmaticamente, e di armonizzare i Vangeli. E' un gruppo complesso, con vari sottogruppi. La scoperta dei papiri, che in taluni casi presentano lezioni comuni a questo tipo testuale, ha portato a rivalutarlo, in quanto risulta così che non si tratta soltanto di una recensione tarda. A questo tipo testuale si devono, ad es., alterazioni dottrinali come quelle di Mt 24,36 (omissione di "neppure il Figlio") e di Lc 2,33.43 (correzioni delle denominazioni di Giuseppe come padre di Gesù). 2. Anteriore al testo bizantino è il cosiddetto testo occidentale, in realtà diffuso, già nel II sec., in Oriente e in Occidente; si affermò soprattutto in Occidente. E' rappresentato dai due mss. del V e VI sec. indicati con la sigla D (e contenenti, l'uno, Vangeli e Atti, l'altro lettere paoline), da alcune versioni latine (la Vetus Latina) e dalle citazioni dei Padri occidentali, ma anche da versioni siriache. Ha la tendenza a parafrasare, omettere, ampliare, soprattutto armonizzare. E' importante per le varianti degli Atti e di Lc: per il testo degli Atti il tipo occidentale fornisce un testo più lungo quasi del 10 % rispetto a quello riportato da altri tipi testuali. E' curioso, ed è stato studiato, l'atteggiamento misogino che manifesta in alcuni passi, soprattutto degli Atti:120 in Atti 1,14 aggiunge alla menzione delle donne che si riunivano in preghiera con gli apostoli nel cenacolo: "e i figli", in modo che si pensi alle "mogli" degli apostoli stessi e non a donne indipendenti; in 17,12, nella menzione della conversione di donne e uomini nobili, inverte l'ordine dei termini "donne e uomini" in "uomini e donne"; in 17,34 cancella il
119 Fu il cardinale di Toledo, Francisco Ximenes de Cisneros a promuovere per primo, nel 1502, l'edizione a stampa del NT greco, all'interno di un'edizione in più volumi di tutta la Bibbia, che fu pubblicata nelle diverse lingue (ebraico, aramaico, greco e latino) ad Alcalà, vicino a Madrid, in latino Complutum, donde il nome di questa edizione della Bibbia: la Poliglotta Complutense. Il NT, che costituiva il V volume dell'opera, venne pubblicato per primo, nel 1514, ma solo nel 1522 avvenne la diffusione dell'intera opera, e quindi la pubblicazione ufficiale. Non si sa quali codici siano stati utilizzati, perché Ximenes, nella lettera di dedica a papa Leone X, si limita ad affermare che erano stati usati codici molto antichi provenienti dalla Biblioteca Vaticana. Di fatto, la prima edizione che andò sul mercato fu un'altra, curata dal celebre umanista olandese Erasmo da Rotterdam, che ne aveva avuto l'idea, ma si decise all'impresa nel 1515 per sollecitazione dello stampatore J. Froben, che aveva fiutato l'affare di pubblicare per primo il NT greco. Erasmo procedette in gran fretta, usando i mss. che aveva a disposizione a Basilea, ossia una mezza dozzina di minuscoli, alcuni di qualità molto scadente. La stampa del testo, accompagnato dalla versione latina del medesimo Erasmo a fronte, avvenne tra l'ottobre del 1515 e il febbraio 1516 (1º marzo 1516 è la data ufficiale dell'edizione). Risultò piena di errori tipografici, oltre che debole criticamente. Erasmo non aveva trovato mss. completi per tutto il NT, ma ne aveva usati diversi per le diverse parti, mss. alquanto scorretti, che aveva cercato di emendare alla meglio, ma in modo insufficiente. Addirittura, poiché per l'Apocalisse disponeva di un codice lacunoso, che mancava del foglio finale, con gli ultimi sei versetti del libro, e che in altri punti risultava confuso, fece lui stesso, per questi passi, una retroversione dal latino della Vulgata in greco, producendo un testo che spesso non trova riscontro in alcun ms. esistente. 120 Cfr. B. Whitherington, The anti-feminist tendencies of the "western" text in Acts, in «Journal of Biblical Literature» 103 (1984), pp.82-84. Questo aspetto è preso in considerazione da Metzger, nell'appendice di aggiornamento al suo manuale sul testo del NT, pp. 269-270.

94
nome di Damaris; in 18,26 pospone il nome di Priscilla a quello del marito Aquila. In Col 4,15 abbiamo un caso simile: D intende il nome Ninfa come maschile (il Merk ha anche lui la forma maschile Numfa'n invece che Nuvmfan) e sostituisce il pronome aujth'" ("di lei") con aujtou' ("di lui"). E' stata riscontrata anche una tendenza antigiudaica nella riproduzione del testo degli Atti.121
3. Il tipo testuale più apprezzato è quello "alessandrino" detto anche "neutrale", perché ritenuto il più genuino e indipendente, e dunque quello che più di tutti ha conservato le lezioni autentiche. Oggi però si ammette che neppure questo gruppo conserva il testo originale puro. E' rappresentato principalmente dai codici Sinaitico (Å) e Vaticano (B), del IV sec., ma anche dal rescritto di Efrem (C), e da alcuni papiri molto antichi (P 66 e P 75 soprattutto). 4. Nel '900 è stato individuato il testo cesariense o palestinese, così definito perché è testimoniato nelle opere composte a Cesarea di Palestina da Origene e nelle opere di Eusebio di Cesarea. Ma è possibile constatare che compare già in opere origeniane composte ad Alessandria. E' un testo misto, che somiglia in parte all'alessandrino e in parte all'occidentale. E' ancora oggetto di studi e non tutti ne ammettono l'esistenza. I suoi rappresentanti più caratteristici sono P 45, Q e le famiglie di minuscoli f 1 e f 13. Di norma, di fronte a varianti testimoniate da più manoscritti, si tende a trascurare le lezioni riportate dalla koiné e a preferire le lezioni del testo alessandrino; autorevole è ritenuta una lezione documentata da tipi testuali distanti geograficamente: perciò l'accordo tra testo occidentale e testo alessandrino risulta spesso decisivo. Tuttavia oggi si ha minor fiducia nei criteri esterni e non si esclude che anche la koiné o il testo occidentale possano conservare lezioni genuine. Neppure i codici minuscoli, i più tardi, debbono essere accantonati. In ogni caso le prove esterne vanno confermate dalle prove interne. Le prove interne. Sono i criteri specifici che guidano a scegliere tra le varianti, sia tenendo conto delle tendenze più comuni nei copisti sia tenendo conto dello stile dell'autore stesso. Per quanto riguarda l'opera dei copisti, si cerca di rispondere alla domanda: che cosa è probabile che i copisti abbiano fatto di fronte al testo? E quindi si procede in senso inverso. - Poiché la tendenza comune dei copisti è quella di rendere più facile e comprensibile il testo dove presenta difficoltà, tra diverse varianti si sceglierà la lectio difficilior, cioè la lezione più ostica, dal punto di vista linguistico, grammaticale, stilistico, contenutistico. A meno che sia una lectio impossibilis! - Poiché la tendenza comune dei copisti è quella di ampliare il testo, per chiarirlo e migliorarlo, tra diverse varianti si sceglierà la lectio brevior, a meno, ovviamente, che non si possa riconoscere una omissione per omeoteleuto o per motivi dottrinali. - Poiché la tendenza comune dei copisti è quella di armonizzare i passi coi
121 G. Schneider, Gli Atti degli Apostoli, I, tr. it., Brescia, Paideia, 1985, p. 230 n. 82.

95
paralleli o, in caso di citazioni, con i testi originali e la versione dei Settanta, tra diverse varianti si sceglierà quella che presenta discordanze rispetto ai paralleli e ai testi citati. Per quanto riguarda l'autore del testo, si cerca di rispondere alla domanda: che cosa è probabile che l'autore abbia scritto? Perciò si esamina l'usus scribendi dell'autore e si preferisce la variante che più concorda con le caratteristiche linguistiche e stilistiche dell'autore e del testo e con il contesto immediato e remoto dell'opera. Conclusione. La critica testuale è più un'arte che una scienza esatta e, anche se esistono delle regole utili, nessuna va applicata in modo meccanico. Ogni caso va attentamente considerato secondo tutti i criteri. In genere una buona strada è quella di scegliere, tra le varianti, quella che spiega meglio l'origine delle altre. La congettura, o divinatio, ossia la correzione di un presunto errore in base a un'ipotesi propria, è quasi sempre da evitare e gli editori migliori non vi ricorrono se non in casi disperati: nell'edizione Nestle-Aland risultano in tutto circa 200. 1.3. Le edizioni critiche recenti del NT Le principali usate in Italia sono quelle del Nestle-Aland e del Merk. L'ed. Nestle-Aland, oggi la più diffusa e aggiornata, ha una lunga storia. Iniziò Eberhard Nestle con la sua ed. del 1898, comparsa a Stoccarda, presso la Württembergische Bibelanstalt. Si fondava sulle grandi edizioni allora esistenti, ossia l'8ª del Tischendorf e quelle di Westcott-Hort e di R.F. Weymouth (1886), quest'ultima sostituita con l'ed. B. Weiss (1894-1900) a partire dalla 3ª ed. del 1901. Le edizioni di riferimento venivano messe a confronto e si sceglieva la lezione adottata da due edizioni su tre. Il lavoro editoriale passò al figlio, Erwin Nestle, a partire dalla 13ª ed. (1927). Dal 1952 fu associato all'impresa K. Aland, e si incominciò a collazionare direttamente mss e papiri. Una nuova edizione, ormai Nestle-Aland, si ebbe con la 25ª del 1963, più volte ristampata e diventata una sorta di nuovo textus receptus. La fortuna di questa edizione era dovuta al fatto che rendeva accessibili, in un volume molto maneggevole ed economico, le più importanti acquisizioni critiche sul testo del NT e, con un sistema essenziale di segni grafici, consentiva di fornire in apparato, in uno spazio concentrato, una ricchezza straordinaria di informazioni. A partire dalla 25ª ed., l'ed. Nestle-Aland diventa una vera edizione critica e la più aggiornata sul mercato. Nel 1979 si ha una 26ª ed., a cura di una équipe costituita, oltre che da K. Aland, da M. Black, C.M. Martini, B.M. Metzger, A. Wikgren. In essa vengono apportati numerosi cambiamenti in apparato, perché si tiene conto del progresso degli studi, e cambiamenti si hanno anche nelle scelte delle varianti del testo rispetto all'ed. precedente. Di questa ed. del 1979, curata dalla Deutsche Bibelgesellschaft, a Stoccarda, si sono avute anche edizioni bilingui, in

96
greco-inglese (1981), greco-tedesco (1986) e greco-latino (con la Neovulgata: 1983). Una 27ª ed. ha avuto luogo nel 1993, ma ha riguardato in questo caso soltanto la sistemazione dell'apparato. Il testo greco di quest'ultima ed. Nestle-Aland è stato pubblicato, con trad.it. a fronte, a cura di B. Corsani e C. Buzzetti, Roma, Società Biblica Britannica e Forestiera, 1996. Un'ed. semplificata per traduttori e studenti, dal titolo The Greek New Testament, è stata curata dalla medesima équipe di filologi (K. Aland, M. Black, B.M. Metzger, A. Wikgren, e poi anche C.M. Martini, B. Aland), per iniziativa di cinque società bibliche di varie nazioni (United Bible Societies). E' uscita nel 1966, ha avuto una seconda ed. nel 1968, una terza nel 1975, con profonde modifiche (il testo coincide con quello della 26ª ed. Nestle-Aland). E' stata ripubblicata una terza edizione corretta nel 1983 e una quarta nel 1993. Il Metzger ha elaborato un commento filologico alla terza ed. nel 1971, 1975 2. Il gesuita Augustin Merk pubblicò la sua edizione, che riporta testo greco e Vulgata latina a fronte, per la prima volta nel 1933, a Roma, per i tipi del Pontificio Istituto Biblico. Si basava sull'apparato del von Soden, integrato con nuove testimonianze manoscritte e modificato nel sistema di sigle, che è quello del Gregory. Merk curò altre quattro edizioni del suo lavoro; dopo la sua morte, avvenuta nel 1945, altri gesuiti curarono le edizioni successive: la 7ª, S. Lyonnet; l'8ª, J.P. Smith; la 9ª, C.M. Martini. La nona edizione è uscita nel 1964 e riporta in appendice alcune varianti contenute nei papiri di recente scoperta. Il testo bilingue del Merk è stato ristampato da G. Nolli, a Roma nel 1955, e poi ancora nel 1981, con l'aggiunta della Nova Vulgata. Una nuova edizione si è avuta nel 1990 (2ª ed. 1991), a Bologna, presso il Centro Dehoniano, a cura di G. Barbaglio: accanto al testo greco del Merk, fornisce la traduzione italiana della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), e in calce alla traduzione pone note che dànno conto delle varianti dei papiri e delle differenze tra l'ed. Merk e l'ed. Nestle-Aland (la 26ª). 1.4. Caratteristiche formali dell'edizione critica del Nestle-Aland Il testo è suddiviso in capitoli e versetti 122 e i numeri dei capitoli e dei versetti sono indicati all'interno del testo. L'uso del corsivo nel testo (più raramente l'uso del neretto) segnala le citazioni veterotestamentarie. L'apparato critico è a fondo pagina. Esiste anche un apparato di riferimenti a passi paralleli (dell'AT, del NT e della medesima opera): è collocato nel margine esterno, in corrispondenza coi versetti relativi. I libri dell'AT e del NT richiamati sono indicati con sigle (Gen=Genesi; Lc=Luca, ecc.), accompagnate dai numeri dei capitoli e dei
122 Si ricordi che tale numerazione non è originaria, ma è stata introdotta successivamente: quella in capitoli in età medievale, quella in versetti nel '500.

97
versetti; invece quando i riferimenti riguardano altri passi del medesimo libro si dànno solo i numeri di capitoli e versetti. I segni grafici variano da edizione a edizione e vengono illustrati nell'introduzione alle singole edizioni, ma anche elencati alla fine e in apposite schede volanti inserite nel volume. Abbiamo segni grafici presenti nel testo. Nell'ed. Nestle-Aland sono molti perché servono a segnalare varianti riportate nell'apparato critico; complicano la lettura del testo, ma avvertono il lettore dei problemi che pone: [ ] parentesi quadre: per indicare testo dubbio; ma probabile [[ ]]‚ doppie parentesi quadre: testo non autentico, ma autorevole ° pallino in alto: omissione della parola seguente in alcuni mss ™ \ quadratino in alto seguito a distanza di alcune parole da una lineetta obliqua: omissione delle parole contenute tra i due segni £ piccola tau in alto: aggiunta due s oblique che racchiudono più parole: trasposizione di parole angolo retto in alto: variante per la parola successiva due angoli ottusi simmetrici in alto: variante per le parole contenute tra i due segni. Se ci sono più casi analoghi nel medesimo versetto si contraddistinguono i segni successivi al primo con puntini o numeri: ad es., ° 1, ° 2, ecc. Abbiamo segni grafici presenti nell'apparato critico. Nel Nestle-Aland sono riportati i segni presenti nel testo; in più abbiamo: | lineetta: separa le lezioni lineetta interrotta: separa le varianti di una stessa lezione txt abbreviazione di textus: introduce l'elenco dei testimoni del testo edito ° pallino nero: distingue i versetti indicati col numero p) indica che la variante deriva da un passo parallelo, per armonizzazione. Abbiamo segni grafici nell'elenco dei testimoni. ( ) parentesi rotonde: racchiudono sigle di testimoni che presentano lievi varianti oppure parole non riportate da tutti ˜ M gotica: indica la maggioranza dei codici minuscoli
mg in esponente: lezione a margine. Abbiamo segni grafici nell'apparato dei riferimenti: | lineetta: separa i riferimenti di diversi versetti . punto: separa i riferimenti di diverse parti del medesimo versetto ! punto esclamativo: contrassegna passi per i quali sono dati a suo luogo ulteriori riferimenti p indica che vanno considerati anche i passi paralleli. 2. Problemi specifici del Vangelo di Marco 2.1. L'inizio del Vangelo: Mc 1,1-3

98
Il primo versetto del Vangelo pone numerose problemi, sia di tipo testuale, sia di tipo interpretativo: problemi testuali sono sia l'autenticità dell'espressione "figlio di Dio", che il Nestle pone tra parentesi quadre, sia la punteggiatura; problemi interpretativi riguardano il significato dei singoli termini e dell'insieme del versetto. Già questo inizio, così denso in ogni parola e carico di significati fino all'ambiguità, ci mostra un Marco fortemente teologo, più vicino a Giovanni che non a Matteo e Luca. Matteo incomincia con la genealogia terrena di Gesù ("Libro della generazione di Gesù Cristo, figlio di David, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco..."), Luca ha un prologo di tipo classico, che osserva le convenzioni del genere storiografico ("Poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra noi ... così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne ..."). Giovanni invece ha un prologo metafisico che subito ci immerge nella natura divina di Gesù Cristo: " In principio (ejn ajrch/') c'era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio ...". Marco è più essenziale, e quasi ellittico, nel modo di esprimere l'identità del protagonista: manca il verbo e tutto il senso della frase sta nella pregnanza del termine eujaggevlion ("vangelo") e nel valore predicativo degli appellativi "Cristo" e "Figlio di Dio". Più difficile afferrare il significato preciso di ajrchv ("inizio"). E' un titolo? Teniamo presente che l'opera non aveva originariamento il titolo che oggi le attribuiamo, e che già entrò nell'uso a partire dal II secolo, "Vangelo secondo Marco" (anche i manoscritti titolano così). Il Vangelo originariamente non circolava sotto il nome dell'autore, ma si qualificava attraverso le sue prime parole. In Marco si può dire che la prima frase assuma carattere di vero titolo: ajrch; eujaggelivou jIhsou' Cristou' uiJou' qeou', "inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio". Si può in effetti notare che questo inizio riecheggia altri inizi di opere dell'Antico Testamento, soprattutto quello di Osea: ajrch; lovgou Kurivou pro;" JWshve, "inizio della parola del Signore in Osea". Tuttavia, come si può notare, Marco omette la menzione dell'autore. Ma non tutti sono d'accordo sul fatto che tali parole costituiscano un titolo autonomo, anche perché esiste una questione di punteggiatura, che nell'ed. Nestle-Aland è segnalata con i due punti: c'è chi (come Pesch) pone il punto fermo alla fine dell'espressione, la isola e ne fa quindi un titolo vero e proprio, e chi (come Uricchio-Stano) preferisce porre una virgola o comunque collegare l'espressione con quanto segue ("come sta scritto..."): in questo caso la frase indicherebbe, non il titolo di tutta l'opera, ma l'argomento, e particolarmente l'argomento del prologo (l'"inizio" farebbe riferimento appunto alla predicazione di Giovanni Battista). Il significato di eujaggevlion ("vangelo")

99
L'analisi del termine eujaggevlion ("vangelo") consente di coglierne sfumature interessanti sia sul versante dell'uso classico, sia su quello dei Settanta (Antico Testamento). Come è già stato ampiamente studiato 123, e come abbiamo già accennato, nel greco classico, soprattutto di età imperiale, eujaggevlion, che è "buona notizia", soprattutto di vittoria, era arrivato a designare il "lieto annunzio" di eventi relativi alla vita e all'opera politica dell'imperatore (nascita, salita al trono, visita, decreti). E' famosa l'iscrizione di Priene (9 a.C.) dove è detto che "la nascita del dio (Augusto) fu per il mondo l'inizio dei fausti annunzi dovuti a lui" (h\rxen de; tw/' kovsmw/ tw'n di jaujto;n eujaggelivwn hJ
genevqlio" tou' qeou') 124. Ma particolarmente significativo è l'uso che si riscontra nella versione greca dell'Antico Testamento, dove, non tanto il sostantivo, quanto il verbo derivato eujaggelivzesqai, a partire dal significato di "annunciare la notizia della vittoria", acquista, soprattutto in contesti profetici (in Isaia, nei Salmi), il significato teologico di portare l'annuncio della salvezza messianica. Testi fondamentali, da questo punto di vista, sono Is 40,9, dove il profeta invita il messaggero ad annunciare la venuta del Signore, che inaugura un nuovo esodo dopo la fine dell'esilio babilonese: "Sali su un alto monte, tu che rechi liete notizie (oJ eujaggelizovmeno") in Sion; alza la voce con forza, tu che rechi liete notizie (oJJ eujaggelizovmeno") in Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia alle città di Giuda: 'Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il braccio egli detiene il dominio...'"; 52,7, dove il messaggero proclama l'instaurazione del regno di Dio a Gerusalemme: "Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunci che annuncia (eujaggelizomevnou) la pace, messaggero di bene che annuncia (eujaggelizovmeno") la salvezza, che dice a Sion: 'Regna il tuo Dio'". Soprattutto importante Is 61,1, in cui il termine assume un valore assoluto; è il profeta stesso a proclamare: "Lo spirito del Signore è su di me perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto annuncio (eujaggelivsasqai) ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri ...". Con questo significato ormai tecnico di "annunciare la salvezza" il verbo ricorre poi nei Salmi (39[40],10; 67[68],12; 95[96],2) e in Nahum (2,1). I passi sopra citati di Isaia risultano particolarmente suggestivi, perché sono certamente presenti all'evangelista: subito dopo l'intestazione, il testo di Marco continua con una citazione appunto di Isaia (in realtà mista di Esodo, Malachia e Isaia), tratta appunto da Is 40,3 ("Voce di chi grida nel deserto ..."), mentre il testo di Is 61,1 è citato da Gesù in un passo di Luca (4,18-19), in cui Gesù identifica se stesso con l'Unto inviato a eujaggelivsasqai ("portare la buona
123 Cfr. G. Friedrich, Eujaggevlion, in Grande Lessico del Nuovo Testamento, tr. it., III, Brescia 1967 (ed.orig., II, Stuttgart 1933), coll. 1023-1106. 124 Si è pensato che nell'uso del termine da parte degli autori del Nuovo Testamento possa esservi una sfumatura polemica nei riguardi dell'accezione che il termine aveva acquistato nell'uso profano, e in particolare nei riguardi della concezione divina dell'imperatore: cfr. Uricchio-Stano, p.20 n.3.

100
novella, evangelizzare") e invita a considerare la sua opera di guaritore e di predicatore come il compimento di questa profezia: anche se Marco non cita a sua volta direttamente il passo, certamente lo tiene presente, sia nella descrizione della figura di Gesù taumaturgo e maestro, sia nella conclusione del prologo, che non a caso riprende (in forma di inclusione) il termine centrale dell'intestazione: qui si dice infatti che "Gesù andò in Galilea annunciando il vangelo (to; eujaggevlion) di Dio e dicendo: 'Si è compiuto il tempo ed è vicino il regno di Dio: convertitevi e credete nel vangelo (ejn tw/' eujaggelivw/)'" (1,14-15). Secondo l'uso molto diffuso che il termine ha avuto in Paolo e in Marco stesso, che tra gli evangelisti è quello che lo predilige 125, eujaggevlion indica sia l'annuncio orale della salvezza portata da Gesù Cristo sia il contenuto, l'evento stesso. Il vangelo è strettamente legato a Gesù, tanto da identificarsi con lui. Almeno due volte Gesù in Marco usa l'espressione "per me e per il vangelo" come un tutt'unico (8,35; 10,29). A sua volta Paolo usa frequentemente l'espressione "il vangelo di Gesù Cristo" o equivalenti (Rm 1,9; 1 Cor 9,12; 2 Cor 2,12; 9,13; 10,14; ecc.). Eujaggevlion (vangelo) non fa riferimento al Vangelo come opera scritta, ma l'uso solenne e qualificante che Marco ne fa in questa intestazione certamente contribuirà a farlo diventare il termine specifico per indicare il genere letterario del suo scritto e degli altri che ad esso si conformeranno. Il valore di jIhsou' Cristou' ("di Gesù Cristo") Si è soliti osservare che, rispetto al termine eujaggevlion ("vangelo") il genitivo successivo, "di Gesù Cristo", ha una duplice funzione, sia oggettiva sia soggettiva: Gesù Cristo è infatti l'oggetto della buona notizia che porta salvezza (e in questo senso tutto il Vangelo non parla che di Gesù Cristo, si identifica con Gesù Cristo), ma nel contempo è anche colui che reca questo annuncio con le sue parole e le sue azioni (il Vangelo di Marco lo rappresenta così, già a partire dalla fine del prologo). Però dobbiamo anche considerare che la denominazione "Gesù Cristo" ha una valenza più forte e "Cristo" si può intendere non come un semplice appellativo aggiunto a "Gesù" (mai Marco usa altrove il binomio Gesù Cristo), ma secondo un valore predicativo: la buona notizia non ha soltanto come oggetto "Gesù Cristo", ma consiste principalmente nel fatto che Gesù è il Cristo, ossia il Messia atteso, l'Unto destinato a portare la salvezza. Non a caso il riconoscimento di Gesù come "Cristo" da parte di Pietro assume una funzione centrale in tutto il Vangelo (8,29) ed è il perno stesso della sua struttura, mentre un altro riconoscimento, questa volta da parte del Sommo Sacerdote e in forma interrogativa (14,61: "Sei tu il Cristo, il Figlio del
125 Se ne serve sette volte (1,1.14.15; 8,35; 10,29; 13,10; 14,9), mentre Matteo e Luca preferiscono al sostantivo il verbo e Giovanni non ricorre né all'uno né all'altro.

101
Benedetto?"), riceve l'assenso di Gesù ("Sono io") ed è centrale nel racconto della passione. Marco condividerebbe insomma sostanzialmente l'idea dell'evangelista Giovanni che, a conclusione del suo Vangelo (nella prima stesura) diceva infatti, proprio a proposito dello scopo del Vangelo stesso: "queste cose sono state scritte perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio" (20,31). Tuttavia, come abbiamo già detto, Marco con eujaggevlion non allude direttamente al suo testo scritto, ma all'evento che ne è alla base. L'autenticità di JuiJou' qeou', "Figlio di Dio" Un punto più difficile da definire è se faccia parte dell'intestazione anche l'espressione "Figlio di Dio", per cui la buona notizia consisterebbe, oltre che nell'essere Gesù il Cristo, nell'essere anche Figlio di Dio. Vediamo che nel passo appena citato di Giovanni (20,31) si trova anche questa espressione. Ma questo elemento non ha valore, qui, e anzi potrebbe essere un indizio sfavorevole, dato che il testo di Giovanni è posteriore e riflette una elaborazione teologica ulteriore. In ogni caso la questione è già di tipo filologico: i due termini sono infatti omessi da una parte della tradizione manoscritta, e autorevole: la prima mano del Sinaitico, il codice Q, un minuscolo (28), un lezionario (l 2211), una parte della versione saidica, Origene (ma anche Ireneo ed Epifanio, che omettono anche "Gesù Cristo"). La maggior parte dei testimoni li riporta e per lo più con l'aggiunta dell'articolo tou' davanti a qeou' ("Dio"). Un minuscolo (1241) riporta invece uiJou' tou' kurivou, "Figlio del Signore", che è chiaramente una reinterpretazione di Figlio di Dio. Alcuni commentatori (ad es., Pesch) non considerano genuina l'espressione, altri, i più, la accolgono. Un argomento contro l'autenticità è che la lezione più breve dovrebbe anche essere considerata lectio difficilior, perché è più comune che i copisti aggiungano appellativi sacri piuttosto che ometterli, specie in un'intestazione. Un argomento che va a favore dell'autenticità e che può spiegare la caduta dei due termini è che i nomina sacra venivano regorlarmente abbreviati e in questo caso hanno desinenza uguale a quella delle parole precedenti, per cui è facile un'omissione per omeoteleuto. Coloro che sono propensi ad accogliere "Figlio di Dio" fanno inoltre appello all'usus scribendi di Marco: fanno cioè notare che si tratta di un'espressione che percorre tutto il Vangelo, e in momenti-chiave: in 3,11 e 5,7 i demòni riconoscono esplicitamente in Gesù il "Figlio di Dio" (uiJo;" tou' qeou'). In 14,61, un passo decisivo del racconto della passione, già sopra citato, il Sommo Sacerdote chiede a Gesù se sia il "Cristo, il Figlio del Benedetto (ossia di Dio)". Ma soprattutto alla fine del Vangelo, sotto la croce, abbiamo la dichiarazione del centurione, che rappresenta un po' il culmine della rivelazione su Gesù: "Veramente quest'uomo era Figlio di Dio (uiJo;" qeou')" (15,39). In più, bisognerebbe considerare anche le proclamazioni della voce celeste, che si fa udire sia al momento del battesimo (1,11: "Tu sei il mio figlio diletto"), sia durante la Trasfigurazione (9,7: "Questi è il mio figlio diletto"). Battesimo,

102
Trasfigurazione e Crocifissione risultano nel Vangelo i momenti salienti della vicenda di Gesù e sono caratterizzati da questi riconoscimenti della sua figliolanza divina. Si deve prendere seriamente in considerazione la possibilità che l'espressione facesse parte del titolo generale. Ma rimane un ostacolo il fatto che si spiega meno l'omissione dell'espressione da parte di un copista, piuttosto che l'inserimento. Non a caso l'editore pone le parentesi quadre, segno di grave incertezza. Il significato di jajrchv, "inizio" Non c'è accordo tra gli studiosi sul significato preciso del termine, che può variare sia in rapporto con le sue diverse accezioni ("inizio" in senso cronologico oppure "principio" come fondamento), sia in rapporto con la duplice valenza di eujaggevlion (messaggio di salvezza, ma anche annuncio del messaggio), sia in rapporto con i collegamenti che si possono stabilire tra la frase iniziale e il contenuto del prologo oppure di tutto il Vangelo. In ogni caso va escluso che segnali un incipit di tipo letterario, quasi che l'autore volesse dire: "Qui, con queste parole incomincia ...". Nel senso di "fondamento", e intendendo con eujaggevlion ("vangelo") l'annuncio dei predicatori cristiani (così Pesch), il titolo equivarrebbe a "il fondamento dell'annuncio che ha per oggetto Gesù Cristo" e con fondamento ci si riferirebbe a tutta la storia di Gesù Cristo, dal battesimo alla morte in croce, che è l'argomento del Vangelo. Ma si può altrettanto bene pensare al concetto di "inizio" in senso temporale, inizio del messaggio o inizio dell'annuncio che trasmette il messaggio, ma soprattutto inizio del messaggio stesso, dell'evento che costituisce la buona notizia. In tal caso però si aprono più possibilità (non sempre alternative) per comprendere quale sia questo inizio. La spiegazione più comune, che tiene conto del contesto immediato, è che con "inizio" Marco alluda alla predicazione di Giovanni Battista e agli avvenimenti raccontati nel prologo, con cui inizia la missione di Gesù. E' anche possibile che con inizio si intendano tutte le profezie, a partire da quelle di Isaia, che hanno preparato la venuta di Gesù. C'è anche chi pensa a Dio stesso come "inizio": subito dopo, nella citazione scritturale, è lui la prima persona implicita che parla e comunica il suo progetto (di inviare un messaggero) a un tu, che è Gesù stesso. Al di là dei significati puntuali, il termine è carico di risonanze, soprattutto bibliche, che lo arricchiscono. Abbiamo visto che esso riecheggia l'analogo titolo del libro di Osea (anche qui però non sappiamo esattamente quale fosse il valore esatto): sappiamo che inaugurava la serie dei profeti. Una suggestione obbligata è che si tratti di un richiamo alla Genesi, che inizia (nella versione dei LXX) con jEn ajrch/' ejpoivhsen oJ qeo;" to;n oujrano;n kai;

103
th;n gh'n, "all'inizio Dio fece il cielo e la terra". Il prologo del Vangelo di Giovanni, con cui l'intestazione di Marco presenta qualche affinità, contiene appunto questo richiamo e in modo del tutto evidente: jEn ajrch/' h\n oJ lovgo" ..., "all'inizio era il Logos". Di fatto, in almeno due degli altri tre casi in cui ricorre ajrchv ("inizio") in Marco, il termine è proprio usato nell'espressione ajp jajrch'" ktivsew", "dall'inizio della creazione" (10,6; 13,19), quindi, in senso temporale, e con riferimento alla Genesi. Se è valida questa ipotesi, si può spiegare l'allusione nel senso che Marco vorrebbe fare dell'opera di Gesù come una sorta di nuovo inizio della creazione di Dio e della storia umana. Con Gesù, per il fatto che egli è il Cristo, il Figlio di Dio, la buona notizia della salvezza incomincia davvero. Si potrebbe perciò anche vedervi la volontà di sottolineare la "novità" dell'evento, rispetto al passato. La presenza di un inizio indica comunque, senz'altro, la storicità dell'evento salvifico, il suo calarsi, in un certo momento preciso, nel tempo e nella storia umana. C'è chi vi associa poi l'idea, che Marco esprimerà nella parabola del seme di senapa (4,32), di una realtà che ha avuto un grande sviluppo a partire da un inizio piccolo e umile 126. L'idea è suggestiva, perché, come si può notare da 1,14-15, il vangelo è strettamente connesso col Regno di Dio e la parabola del granello di senapa illustra appunto la realtà misteriosa del Regno. Certamente questo inizio è, per Marco, apertura su uno sviluppo illimitato, come accennano i passi in cui Gesù fa riferimento a un annuncio del vangelo che deve toccare "tutte le genti" (13,10), "tutto il mondo" (14,9). Considerando la fine del Vangelo di Marco (ce ne occuperemo tra poco), e in particolare le parole del messaggero celeste nella tomba vuota che invitano i discepoli a tornare in Galilea per ritrovare Gesù (16,7), e quindi invitano in qualche modo a ripercorrere le tappe del suo cammino iniziato appunto in Galilea (cfr. 1,9.14), si potrebbe dire che questo inizio è destinato a riproporsi sempre a chi si fa ascoltatore della "buona notizia" e vuole conoscere e seguire Gesù. Probabilmente occorre mantenere la plurivalenza del testo. Conclusione Anche se questa intestazione resta sfuggente nei significati precisi dei singoli termini, e non del tutto chiaro è il suo rapporto con il contesto immediato, va tenuto fermo che il termine eujaggevlion ("vangelo") ci rinvia, innanzitutto, a un messaggio di fede (Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio), che esige una risposta di fede (1,15: "Credete nel vangelo!"). Ci illumina, quindi, in qualche modo, sull'impostazione e sul carattere letterario dello scritto, che si fa portavoce di questo messaggio. Ci fa capire che l'interesse di questo scritto non
126 Cfr. B. Maggioni, Il racconto di Marco, Assisi, Cittadella, 1991, p.15.

104
è focalizzato sulla vita di Gesù in sé e per sé, ma su quanto di lui lo ha rivelato come Messia, Figlio di Dio. Ci immerge, anche, nelle attese e nelle concezioni del popolo ebraico (attesa di un Messia, idea di Figlio di Dio), che erano pure quelle dei cristiani e per le quali i cristiani videro in Gesù lo sbocco decisivo, ma non senza fraintendimenti: è quanto si propone di evidenziare Marco. Questo titolo, che enuncia nei suoi termini essenziali tutta la storia del protagonista, ben si accorda con la struttura drammatica, a suspence, del Vangelo di Marco. Un primo motivo è che il titolo già fornisce, in qualche modo, la soluzione del dramma, ma è fuori dal racconto; è noto al lettore, non ai personaggi. All'interno del racconto l'identità di Gesù, sempre ricercata, rimarrà misteriosa fino alla fine: tutta la prima parte è costellata dagli interrogativi della gente e dei discepoli: Che è mai questo? Chi è costui? Le proclamazioni dei demòni vengono zittite da Gesù. Anche quando Pietro finalmente vede in lui il Cristo, Gesù impone il silenzio e subito dopo con i suoi annunci della passione fa capire che questo riconoscimento non basta. La soluzione arriva, inaspettata, solo nella scena della crocifissione e della morte: è il centurione, un pagano anonimo, un nemico, che vede proprio nel crocifisso il "Figlio di Dio". Ma anche il lettore, che crede all'inizio di sapere, rimane sconcertato fino alla fine, perché sa che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, ma proprio per questo non si aspetta quell'entrata in scena del protagonista senza clamore, quelle difficoltà che lo circondano (opposizione di avversari, incomprensione perfino dei discepoli), il suo stesso atteggiamento poco propenso ad accettare riconoscimenti trionfalistici. Anche il lettore deve percorrere tutto il cammino del Vangelo per arrivare a capire che tipo di Messia sia Gesù. Anzi, alla fine sembrerebbe che solo il lettore sia in grado di capire o abbia gli elementi per capire, perché i discepoli, alla rivelazione del centurione, non sono presenti, e le donne fuggono dalla tomba vuota spaventate, senza dire alcunché ad alcuno. Sicché, a mettere a confronto titolo e conclusione, si assiste a un nuovo fatto sconcertante: quella che è stata presentata come una buona, lieta notizia (euj-aggevlion), suscita nel suo esito paura e sbigottimento, addirittura fuga (16,8: ejvfugon ... ejfobou~nto gavr, "avevano paura infatti"). Quel vangelo che esigeva una risposta di fede provoca nei primi destinatari, e proprio nel momento decisivo, solo spavento. Quel vangelo che doveva essere divulgato a tutti i popoli si scontra con il silenzio delle donne che avevano il compito di trasmetterlo per prime. Come mai? Anche alla fine non c'è un "lieto fine" tradizionale. Siamo, in qualche modo, ancora solo ad un inizio: per ora c'è un'unica persona, il centurione, che ha dimostrato di credere. Eppure Marco, con quel suo modo sconcertante di procedere, è sicuro che quello che sta presentando è "inizio della buona notizia di Gesù Cristo, Figlio di Dio". E' la scommessa della fede.

105
2.2. La finale del Vangelo: Mc 16,9-20 Il capitolo finale (cap. 16) del Vangelo di Marco presenta una situazione testuale complessa (vedi All. 19). Si può notare, guardando l'apparato critico, che già alla fine del v. 16,3 ("E si dicevano: 'Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ngresso del sepolcro?") il cod. k, o codice Bobbiense, che riporta un'antica versione latina, integra il testo con un passo con la descrizione di fenomeni prodigiosi (oscuramento della luce del giorno; discesa di angeli dal cielo che accompagnano il Risorto nella sua ascensione. ricomparsa della luce). Tale descrizione cerca di compensare un racconto, quello di Marco, troppo pacato, privo di effetti spettacolari, che invece compaiono negli altri Vangeli. Ma soprattutto interessante è la varietà di soluzioni riportate dalla tradizione manoscritta dopo il v.8 (si veda l'apparato critico): - La totalità delle edizioni e traduzioni riporta i versetti 16,9-20, che sono chiamati "finale canonica", in quanto sono riconosciuti dalla Chiesa come pienamente ispirati alla pari del resto del Vangelo e appartengono al textus receptus. Questi versetti sono attestati dalla maggioranza dei codici greci, maiuscoli e minuscoli, da alcune versioni latine, siriache, copte, e da molti Padri della Chiesa (ad es. l'Ireneo latino, ossia la traduzione latina di Ireneo, che in greco è andato quasi del tutto perduto), già a partire dal II secolo, anzi forse già prima del 150, poiché sembra che l'apologista Giustino la conoscesse e fu inserita nel Diatessaron di Taziano. Alcuni testimoni della tradizione manoscritta però la riportano con segni critici che avvertono dell'esistenza di dubbi. Per di più molti Padri provano che non sono autentici questi versetti: Clemente Alessandrino e Origene, in particolare, non la conoscono. Eusebio di Cesarea (Quaest. ad Marinum 1) e Gerolamo (Ep. ad Hebid. 120,3) discutono espressamente la questione e sostengono di non aver trovato questa finale in codici greci del tempo. - Questa finale non viene però riportata dai due codici onciali più antichi e importanti: Å e B, dal minuscolo 304, dal codice Bobbiense (k), il più antico testimone della Vetus Latina (IV-V sec.), da un'antica versione siriaca, dalla maggior parte dei codici armeni e georgiani più antichi, in quasi tutta la tradizione sahidica. In vari testimoni compaiono segnalazioni esplicite sul fatto che Mc doveva concludersi con 16,8. - Ancora il cod. k riporta una finale breve (così chiamata per distinguerla dalla finale lunga), la cui traduzione suona così: "Raccontarono in breve a quelli che erano con Pietro tutto ciò che era stato loro esposto. Poi Gesù stesso fece portare per mezzo loro, dall'oriente fino all'occidente, il santo e incorruttibile annuncio dell'eterna salvezza. Amen". L'Amen indica un uso liturgico del testo. Ma questa finale non è entrata nel testo ufficiale del Vangelo di Marco.

106
- Nel cod. k compare solo questa come finale di Marco, ma essa viene riportata da vari codici greci maiuscoli e minuscoli (L Y 083 099, 274 a margine, 579), dal lezionario l 1602, da manoscritti delle versioni siriache e copte e dalla maggioranza dei manoscritti etiopici, prima della finale lunga. In vari mss c'è la segnalazione che si tratta di un'aggiunta. - Il cod. W riporta i vv. 9-20, ossia la finale lunga, e in più, tra i vv. 14 e 15, un ampliamento (il cosiddetto "loghion di Freer", dal nome di colui che acquistò il codice),127 che era già noto a Gerolamo (Adv. Pelag. 2,15). A un esame critico delle diverse finali, si può facilmente riconoscere che la finale breve non è marciana, perché presenta molti termini e concetti estranei al linguaggio e al pensiero di Marco (pensiamo all'enfasi posta sul successo universale della predicazione apostolica), ed è relativamente tarda (pensiamo all'espressione "sacro e incorruttibile annuncio dell'eterna salvezza"). Anche il "loghion di Freer" risulta un ampliamento della finale lunga che tenta di giustificare le ripetute annotazioni dell'incredulità degli apostoli. Per quanto riguarda la finale lunga, le prove esterne, ossia l'autorevolezza dei testimoni (il Sinaitico e il Vaticano) e l'accordo tra i più importanti tipi testuali (l'alessandrino e l'occidentale), sembrano essere a favore dell'inautenticità dei vv. 9-20. Ma soprattutto le prove interne confermano questa opinione: il linguaggio di questa parte non è marciano (ben 17 parole non si trovano nel resto di Mc o sono usate altrove con significato diverso); tra i vv. 8 e 9 è evidente una frattura stilistica; il contenuto dei vv. 9-20 si presenta come un compendio delle parti finali degli altri Vangeli, soprattutto di Luca e Giovanni (cfr. All. 20). Si ha l'impressione che questa finale sia stata composta per ovviare all'assenza sconcertante di apparizioni del Risorto che rendevano Mc manchevole rispetto agli altri Vangeli. Deve essere stata composta molto presto, subito dopo la composizione degli altri Vangeli. Benché quasi tutti gli studiosi siano convinti del fatto che la finale lunga non sia della mano di Marco, il comportamento di editori e traduttori non appare coerente: il Nestle-Aland la riporta tra le doppie parentesi quadre (segno di testo autorevole, ma non autentico); invece il Merk la riporta senza alcun segno grafico. E lo stesso fanno normalmente le traduzioni. Tuttavia l'idea che Mc si concludesse originariamente col v. 8 non lascia soddisfatti molti studiosi, perché è davvero strano questo finale, con le donne
127 La traduzione del loghion (il cui testo non è sempre sicuro) suona così: "E quelli (= gli undici) si scusavano (di non aver creduto alla risurrezione di Gesù) dicendo: 'Questo secolo di iniquità e incredulità è sotto il dominio di satana, il quale non permette che la verità e la potenza di Dio siano accolte dagli spiriti impuri. Perciò rivela la tua giustizia ormai', dicevano al Cristo. E il Cristo rispondeva loro: 'E' compiuto il termine degli anni della potenza di satana, ma si avvicinano altri eventi terribili. Anche a beneficio di coloro che hanno peccato io sono stato consegnato alla morte, perché si convertano alla verità e non pecchino più, ma ereditino nel cielo la gloria spirituale e incorruttibile della giustizia'".

107
che fuggono atterrite dalla tomba senza dire niente a nessuno proprio per la paura. Le ultime parole sarebbero ejfobou'nto gavr, "avevano paura infatti", una forma che non trova se non sporadici corrispondenti. Perciò alcuni (e Metzger, che fa parte dell'équipe dei curatori dell'ed. Nestle-Aland, è tra questi) ritengono che neppure 16,8 sia la vera conclusione di Mc e ipotizzano che il Vangelo o sia stato interrotto o sia andato perduto un foglio durante la trasmissione del testo. Ma altri studiosi difendono invece con forza l'adeguatezza della finale al v. 8, perché il suo carattere rotto e perfino assurdo ben si conforma allo stile e alle intenzioni di Mc, quali si riconoscono nel resto del Vangelo. E in effetti appare più probabile l'idea che il Vangelo si fermasse originariamente al v. 8, con la paura e la fuga delle donne dalla tomba vuota. A conferma di questa idea stanno anche gli altri sinottici, che procedono paralleli fino al v. 8 e poi procedono ciascuno per conto proprio, ma cercando di ovviare a quella che appariva una manchevolezza del testo: l'assenza di apparizioni del Risorto e un finale più consolante, meno punitivo nei confronti dei discepoli. In realtà risulta invece proprio più conforme al pensiero di Marco che anche le donne, le discepole più fedeli, cedano alla fine, come già avevavo fatto i discepoli maschi prima, perché solo Gesù, che aveva promesso di tornare in Galilea a precedere i suoi seguaci (e la promessa viene ricordata dall'angelo alle donne) può di nuovo segnare la via e riaprire il cammino, lui che è passato attraverso la passione, morte e risurrezione. E l'omissione dei racconti di apparizioni è coerente con il concetto severe di fede che propone Marco: una fede che non ha bisogno di vedere per credere, come indicano l'esempio negativo dei sommi sacerdoti e degli scribi, che pretendono di vedere per credere (15,32), e l'esempio positivo del centurione romano, che riconosce in Gesù il Figlio di Dio vedendolo morire, non risorgere (15,39). 2.3. Due questioni nell'episodio del lebbroso: Mc 1,40 (inginocchiato?); 1,41 (Gesù impietosito o adirato?) L' episodio del lebbroso è presente nei tre sinottici, ma è posto in contesti differenti: in Matteo dopo il discorso della montagna (8,1-4), in Luca dopo la chiamata dei primi discepoli (5,12-16). In Marco è centrale all'interno della prima sezione del Vangelo e ha funzione di cerniera tra la prima sottosezione, che contiene il racconto della "giornata di Cadfarnao", o giormata-tipo di Gesù, caratterizzata da miracoli (esorcismi e guarigioni) e la seconda sottosezione, che contiene una serie incalzante di cinque dispute con i capi religiosi giudei. Si distingue dagli altri episodi perchè è privo di ambientazione geografica o cronologica. In questo episodio (Mc 1,40-45: vedi All. 21 e 22) abbiamo due questioni rilevanti: la prima riguarda l'espressione kai; gonupetw'n kai;, trasl. kài gonypetòn kài, ("e inginocchiato e") del v. 40, e il problema è segnalato dall'editore con le parentesi quadre, la seconda riguarda il participio splagcnisqeiv", trasl.

108
splanchnistèis, ("impietosito, mosso a compassione") del v. 41, e in questo caso l'editore non pone segni critici. Mc 1,40 Guardando l'apparato critico troviamo che la prima mano del Sinaitico riporta kai; gonupetw'n e omette il kai; successivo. Invece il codice Vaticano, un codice minuscolo (2427) e i manoscritti della versione sahidica omettono tutte e tre le parole. Altri codici maiuscoli, il cod. D (o di Beza, il più importante testimone del testo occidentale), i codd. W e G e pochi altri maiuscoli, alcuni testimoni delle versioni latine, con qualche differenza (segnalata dalle parentesi rotonde), omettono kai; gonupetw'n. Riportano tutte e tre le parole la seconda mano del Sinaitico, altri due maiuscoli (L Q), la famiglia 1 di minuscoli, altri minuscoli, una parte delle versioni latine. Riportano kai; gonupetw'n con l'aggiunta di aujto;n kai; tre maiuscoli: l'Alessandrino, C e 0130, la famiglia 13 di minuscoli, un altro minuscolo importante (33), la maggior parte dei codici tardi, un codice della Vetus Latina (q), con qualche differenza. In sostanza, la stragrande maggioranza dei codici riporta l'espressione kai; gonupetw'n, ma è singolare l'omissione da parte di alcuni, non trascurabili (ad es. D). Il Nestle-Aland avverte con la sigla p) che l'omissione potrebbe essere frutto di armonizzazione. Ora, possiamo constatare che la stessa espressione manca effettivamente in Mt e Lc, però compaiono espressioni equivalenti: Mt ha prosekuvneu, "si prostrava"; Lc pesw;n ejpi; provswpon, "caduto faccia a terra", epressioni che indicano sempre un gesto di omaggio e di adorazione, e appaiono anche più forti di quella di Marco. Il participio gonupetw'n viene usato da Marco anche in 10,17, a proposito del ricco di fronte a Gesù; lo usa due volte Matteo: in 17,14 (per l'indemoniato epilettico) e 27,29 (per i soldati che deridono Gesù travestito da re). Un atteggiamento rispettoso da parte del lebbroso appare, non solo adatto a un questuante ("lo supplicava"), ma anche conforme con le parole che pronuncia ("se vuoi, puoi purificarmi") e quindi opportuno; proprio per questo l'omissione potrebbe essere considerata una lectio difficilior, e quindi preferibile. Mc 1,41 Qui abbiamo il caso di una variante, che non è presa in seria considerazione dagli editori (anche il Nestle-Aland la segnala soltanto in apparato) e dai traduttori, ma viene invece discussa dai commentatori, con esiti diversi da quelli a cui indurrebbero editori e traduttori.128 Si veda la nota alla traduzione italiana nell'ediz. Nestle-Aland curata da Corsani-Buzzetti. La valutazione del problema richiede un'accurata ricognizione della tradizione manoscritta, ma soprattutto del contesto e del punto di vista di Marco. La questione riguarda il comportamento di Gesù, subito dopo la richiesta del lebbroso: il testo riporta che Gesù splagcnisqeiv", "mosso a 128 Per una discussione sistematica cfr. C. Mazzucco, Un Gesù impietosito o adirato? Il problema testuale e interpretativo di Mc 1,41, in "Quaderni del Dipartimento di Filologia, linguistica e tradizione classica 'A. Rostagni'" 2000, pp. 191-203;

109
compassione", stese la mano, lo toccò e gli dice: "Lo voglio, sii purificato". Ma esiste una variante: ojrgisqeiv", trasl. orghiszèis, "incollerito, adirato", al posto di splagcnisqeiv". E' una variante che non vale la pena di prendere in considerazione o merita qualche attenzione? E' abbastanza strana a tutta prima. Se guardiamo alla prova esterna, ossia alla situazione dei testimoni delle due lezioni, constatiamo che la stragrande maggioranza riporta splagcnisqeiv" (l'editore non li elenca neppure); solo pochi attestano ojrgisqeiv", "adirato": il codice D e codici dell'antica versione latina (a ff2 r1*), dunque tutti testimoni del testo occidentale. Possiamo dire che la prova esterna è a favore della lezione splagcnisqeiv", "impietosito". Se consideriamo gli elementi interni, possiamo dire che a favore di questa lezione c'è il fatto che in molti casi di miracolo viene attribuita a Gesù la compassione, espressa con questo medesimo termine (cfr. Mc 9,22; Mt 14,14; 15,22; Lc 7,13) o con altri, mentre non sarebbe attestata una reazione di collera, e inoltre apparirebbe strana una tale reazione. Alcuni studiosi (favorevoli alla lezione "impietosito") suppongono però che la variante "adirato" sia stata introdotta per indicare una reazione negativa di Gesù verso la violazione della legge compiuta dal lebbroso nel momento in cui si avvicina a Gesù (per lo statuto di esclusione del lebbroso cfr. Lv 13-14). Si adduce il fatto che nello stesso episodio Gesù si mostra osservante della legge, quando invia il lebbroso risanato dal sacerdote a compiere il rito prescritto da Mosè (1,44). Ma ci sono in realtà elementi piuttosto forti per preferire ojrgisqeiv", "adirato": innanzitutto il fatto che si tratta inequivocabilmente di una lectio difficilior, perché si può ben immaginare che qualcuno abbia sostituito la compassione alla collera, proprio perché la compassione sembra adattarsi meglio alla figura di Gesù; è molto più difficile supporre che qualcuno abbia introdotto la collera se nel testo c'era la compassione. Una conferma in questo senso viene dall'omissione del participio in Matteo e Luca: se avessero trovato l'annotazione sulla compassione l'avrebbero certamente conservata, mentre si spiega che abbiano tralasciato la collera, più ostica da accettare nella situazione specifica di incontro con un sofferente. Ma Marco attribuisce la collera a Gesù anche in un'altra situazione di miracolo: nell'episodio della guarigione dell'uomo dalla mano inaridita (3,5: guarda i presenti "con collera", met jojrgh'", trasl. met'orghés; e l'annotazione è conforme all'atteggiamento tenuto da Gesù di fronte al lebbroso: nell'episodio abbiamo un altro suo gesto analogo: egli scaccia il lebbroso "sbuffando, con sdegno" (ejmbrimhsavmeno", trasl. embrimesàmenos: 1,43). Naturalmente non si può pensare che Gesù provi qualche forma di collera o irritazione nei confronti del lebbroso: questi dimostra una straordinaria fede in Gesù e nei suoi poteri: si può dire che intuisca le sue facoltà divine: infatti nell'AT veniva affermato che solo Dio può guarire dalla lebbra (cfr. l'episodio di Naaman il Siro in 2 Re 5,7). Inoltre la guarigione dalla lebbra era un chiaro segno messianico, come risulta chiaramente da Mt 11,6, dove Gesù richiama espressamente antiche profezie in questo senso e le applica a sé. Come nel caso dell'uomo dalla mano inaridita, dove è chiaro l'intento di

110
Gesù di polemizzare con un gruppo di avversari che guardano con ostilità il fatto che Gesù guarisce di sabato, così si può supporre che Gesù manifesti un intento polemico anche a proposito del lebbroso, soprattutto della condizione di emarginazione sociale e religiosa a cui era sottoposto a causa della sua impurità, secondo la normativa legale contenuta nel Levitico. Egli, non solo non condanna il gesto del lebbroso di avvicinarsi a lui, ma lo tocca con la sua mano, violando a sua volta la legge; e quando invia il lebbroso purificato dal sacerdote lo fa "a testimonianza per loro" (eij" martuvrion aujtoi'", trasl. eis maryrion autòis: 1,44). L'espressione "a testimonianza per loro" ha sempre in Marco questa valenza negativa, di condanna: in 6,11 si applica a quanti non accoglieranno gli apostoli durante la loro missione (per questo gli apostoli se ne andranno scuotendo la polvere dai calzari "a testimonianza per loro"); in 13,9 si applica ai persecutori degli apostoli (essi staranno loro davanti "a testimonianza per loro"). Nel nostro episodio Gesù manda l'ex lebbroso dal sacerdote come atto dimostrativo, e polemico, nei confronti dell'intera categoria sacerdotale: per far vedere che è possibile eliminare radicalmente il male della lebbra, e non limitarsi a stilare certificati di impurità o purità, come prevedevano le norme. Di qui il suo sdegno, la sua irritazione, che ovviamente non sono dirette al lebbroso, ma alla condizione in cui si trova e a quanti applicano la legge in modo rigido, a scapito dell'umanità e della misericordia. Tenendo conto del fatto che la terminologia usata da Marco parla di "purificazione" dalla lebbra e che la lebbra viene personificata (cfr. 1,42), e tenendo conto del contesto, in particolare del fatto che il demonio è definito nell'episodio dell'esorcismo di Cafarnao "spirito impuro" (1,23), possiamo leggere l'episodio del lebbroso come una manifestazione della lotta contro le potenze del male che opprimono l'umanità e che Gesù vuole distruggere dalle radici. 2.4. La teoria delle parabole: Mc 4,10-12 Quella che chiamiamo "teoria delle parabole" è la risposta che Gesù dà ai discepoli, dopo che essi lo hanno interrogato a proposito delle parabole, avendo ascoltato l'esposizione della parabola del seminatore: "A voi è stato dato il mistero del regno di Dio; ma per quelli di fuori tutto avviene in parabole, affinché guardando guardino e non vedano, e ascoltando ascoltino e non comprendano, perché non si convertano e sia loro perdonato" (4,11-12: cfr. All. 23 e 24). Una tale dichiarazione solleva diverse e gravi questioni, che riguardano innanzitutto il senso complessivo delle parole di Gesù, le quali sembrano dire che egli parla in parabole per impedire che i destinatari capiscano e si convertano, e sembrano quindi inficiate da un tono deterministico. Inoltre appare inaccettabile la netta distinzione tra due categorie, che sembrano identificarsi con i discepoli, i quali sarebbero privilegiati, e gli esterni, che invece sarebbero pregiudizialmente esclusi dalla salvezza.

111
Il confronto coi paralleli di Matteo e di Luca, che mostra un buon numero di variazioni, evidenzia le difficoltà del testo marciano. E' possibile riscontrare che l'espressione piuttosto contorta "quelli intorno a lui (Gesù) con i Dodici" (Mc 4,10) è stata corretta e chiarita, ma anche reinterpretata, dagli altri due sinottici, che parlano più semplicemente di discepoli (Mt 13,10: "i discepoli"; Lc 8,9: "i suoi discepoli"); in corrispondenza, l'espressione "uqlli di fuori" (Mc 4,11) diventa "quelli" in Matteo (13,11) e "gli altri" in Luca (8,10). Rilevante è la modificazione della forma devdotai ("è stato dato") in devdotai gnw'nai ("è stato dato di conoscere") sia in Matteo sia in Luca; anche il givnetai ("avviene") di Marco viene fortemente trasformato da Mt e Lc, che si limitano a riprendere, o sottintendere, la medesima espressione già usata ("è stato dato di conoscere"), in forma negativa: 129 mentre Marco parla di una realtà in atto, quella del Regno, Matteo e Luca portano il discorso su un piano strettamente intellettuale, di comprensione delle parabole. Né va trascurato il cambiamento di "mistero" in "misteri": anche qui si passa da un concetto religioso profondo, il mysterion, che allude a una realtà divina al di là delle capacità umane, a specifici elementi oscuri da capire. Anche la forma della citazione finale, tratta da Is 6,9-10, è diversa negli altri due sinottici. Per quanto riguarda i due gruppi di destinatari per lo più sono stati identificati, i primi, anche tenendo conto dei paralleli, con i discepoli, i secondi, anche tenendo conto di altri testi del NT, con i pagani (cfr. 1 Cor. 5,12.13, che parla di quelli di fuori) o con i giudei increduli (cfr. Gv 12,40; At 28,26-27, che citano il passo di Is 6,9-10). Ma una possibile chiave di lettura di essi può essere quella di interpretare le definizioni ("quelli intorno a Gesù" e "quelli di fuori") tenendo presente l'episodio immediatamente precedente, quello della "vera famiglia di Gesù" (3,31-35: vedi All. 25), che già abbiamo considerato a proposito delle costruzioni a sandwich. Qui - ed è di nuovo un particolare che non viene conservato nei testi paralleli – abbiamo pure due gruppi contrapposti, quello dei parenti di Gesù e quello della folla che ascolta Gesù, e tali gruppi sono insistentemente qualificati, l'uno con l'avverbio "fuori" (3,31: "viene sua madre e i suoi fratelli e stando fuori lo mandarono a chiamare; 3,32: "ecco, tua madre e i tuoi fratelli fuori ti cercano"), l'altro con la preposizione "intorno" (3,32: "e sedeva intorno a lui una folla"; 3,34: "e guardando tutt'intorno quelli che sedevano in cerchio intorno a lui"). Già in questo episodio si vuole alludere a due categorie spirituali: quella dei "vicini", come ad es. i famigliari, e quella di coloro che pur lontani (una folla generica) compiono però la volontà di Dio e ponegono Gesù al centro della loro vita. Possiamo pensare che anche nel cap. 4 Marco voglia far riferimenti a queste due categorie, che non sono rigide e predeterminate, ma mobili, dipendenti dalle scelte che si fanno di volta in volta. Nella spiegazione della parabola del seminatore, immediatamente successiva, si rileverà appunto l'importanze della qualità dei terreni, ossia della qualità dell'ascolto, ai fini del risultato.
129 E' possibile notare che l'influsso dei paralleli si fa sentire anche nelle traduzioni correnti di Marco, per cui la forma devdotai, che letteralmente si deve rendere con "è stato dato" viene tradotta dalla Cei con "è stato confidat"o, e la forma "avviene" (givnetai) diventa "viene esposto".

112
Certamente Gesù non parla in parabole per impedire la comprensione agli estranei, tant'è vero che proprio in questa sezione sollecita continuamente l'ascolto sia rivolgendosi alla folla sia ai discepoli (cfr. 4,9.23) e alla fine si dice che "diceva loro la Parola come erano in grado di ascoltare" (4,33). D'altra parte, è vero che Gesù rivolge spiegazioni particolari ai discepoli (cfr. qui e anche 7,17-23), ma sempre rimproverandoli di non capire ciò che dovrebbero capire senza spiegazioni. D'altra parte, una comprensione intellettuale delle parabole non è impedita (cfr. 12,12, a proposito della parabola dei vignaioli omicidi), ma può portare a un accanimento maggiore nell'ostilità. E la citazione della profezia di Isaia, da una parte richiama la Parola di Dio a testimonianza del fatto che l'indurimento degli ascoltatori della Parola è un fenomeno che sempre si ripete, è una sorta di prova necessaria, ma non ha nulla di aprioristico e preclusivo. Dipende da una presa di posizione precedente che condiziona l'ascolto e che è volontaria: dipende dalla scelta di stare intorno, ovvero, se vogliamo, dietro a Gesù, o al contrario rimanere fuori dalla sua cerchia, ai margini della sua strada, come or ora vedremo. Nel corso del Vangelo Marco mostrerà che tante volte saranno i discepoli a estraniarsi da Gesù, a non capirlo, a mettersi nella stessa condizione degli avversari di Gesù e riceveranno rimproveri analoghi (si veda il rimprovero di avere il cuore indurito che tocca agli scribi in 3,5 e ai discepoli in 6,52 e 8,17). In particolare la reprimenda ai discepoli di 8,17-21 conterrà una citazione profetica (tratta da Ger 5,21 ed Ez 12,2) che richiama quella inserita nella "teoria delle parabole": "avete occhi e non vedete? avete orecchie e non udite?" (8,18). Invece ci saranno pagani che riusciranno a dimostrarsi vicini a Gesù, a comprenderlo, ben più dei discepoli. E' il caso della Sirofenicia, che capirà al volo l'intenzione di Gesù manifestata nelle due moltiplicazioni dei pani, quando dirà: "Anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli" (7,28), a significare che anche i pagani, seppure estranei al rapporto di figliolanza con Dio proprio dei giudei, hanno diritto a ricevere la salvezza; invece i discepoli, seppure ripetutamente sollecitati, non arrivano proprio a capire che il pane della salvezza è sovrabbondante e basta, con i tanti avanzi, a nutrire tutti (cfr. 8,19-21). 2.5. Chi sono "quelli lungo la strada" (Mc 4,15)? Nella spiegazione della parabola del seminatore solleva difficoltà quanto viene detto del primo terreno, ossia del primo tipo di ascoltatori (per il testo si veda l'All. 26): Il testo greco è piuttosto contorto, ma molte traduzioni e tentativi di interpretazione accrescono le difficoltà. Ad es. la traduzione ufficiale della Cei rende così: " Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola; ma quando l'ascoltano, subito viene satana, e porta via la parola seminata in loro". Ci si può chiedere - e in effetti ci è chiesti – per quale motivo questo tipo di ascoltatori si trovi tanto penalizzato, quali siano le caratteristiche di questo tipo di ascolto che rendono immediatamente sterile la

113
Parola, questo gruppo appare diverso en on ben qualificato, a differenza degli altri. Bisogna però notare che Marco, seppure in modo piuttosto duro, attira l'attenzione proprio sulla collocazione, sul fatto dell'essere para; th;n oJdovn, "lungo la strada, ai margini della strada" (si veda l'avverbio relativo oJvpou, "là dove"). Si potrebbe tentare di tradurre così: "Ecco chi sono quelli lungo la strada: (sono coloro) nei quali la Parola viene seminata lì e, quando ascoltano, subito viene satana e porta via la Parola" (4,15). E poi si potrebbe cercare di capire che senso ha questa collocazione "lungo la strada", quale ostacolo costituisca. Talora non si è fatta differenza, anche considerando la parabola, tra l'essere "lungo la strada" e l'essere "sulla strada", e si è pensato, lavorando di immaginazione, a durezza, impermeabilità dovuta ai ripetuti passaggi di persone. Ma già il contesto invita a diversificare il significato: nella cornice della sezione si distingue tra la posizione della folla che si trova "lungo il mare" e Gesù che siede in barca "sul mare" (4,1). Soprattutto, un contrasto molto importante per la valenza simbolica si ha nell'episodio della guarigione del cieco di Gerico (10,46-52), che abbiamo esaminato a proposito dell'Analisi retorica: qui è qualificante il contrasto tra la posizione iniziale del cieco, seduto "lungo la strada" (10,46), e quella finale che lo vede seguire Gesù "sulla strada" (10,52). La collocazione iniziale indica la sua originaria estraneità al cammino di Gesù, ma la sua capacità tutta interiore di intuire l'identità di Gesù ("Figlio di Davide", "Rabbunì"), la sua volontà e la sua prontezza di andare verso di lui e percorrere la sua strada ne fanno alla fine un modello di discepolo. La strada, con tutta evidenza, è quella che porta a Gerusalemme e porta alla passione. In questo il cieco si mostra l'opposto di Pietro, che, "sulla strada" (8,27) aveva, sì, riconosciuto che Gesù era il Cristo, ma aveva poi rifiutato la prospettiva della passione, uscendo fuori dalla posizione di discepolo ed attirandosi il rimprovero di Gesù e l'ordine di tornare "dietro di lui" (8,33) 130, di riprendere cioè il posto proprio del discepolo, secondo tutti i racconti di chiamata, come abbiamo visto. Il tema della "strada" è molto importante nel Vangelo di Marco, fin dall'inizio, dalla citazione biblica, dove la fusione di diversi testi scritturali permette all'evangelista di mettere in evidenza e in parallelo le espressioni "il quale preparerà la tua strada" (1,2) e "approntate la strada del Signore" (1,3). Il termine "strada" (oJdov"), come già abbiamo visto a proposito della "geografia di Marco", ricorre ben 16 volte nel Vangelo, e con particolare densità nei punti sopra segnalati (due in 1,2-3, due nel cap. 4, due in 10,46-52, una in 8,27) e poi ancora in 10,32: è la strada per Gerusalemme e Gesù precede i discepoli; in 12,14: è la strada di Dio. 2,6: Il viaggio a Betsaida dei discepoli di Gesù: Mc 6,45-8,22
130 Anche in questo caso per lo più le traduzioni travisano, perché rendono comunemente l'espressione uJvpage ojpivsw mou ("va' dietro di me") con "lungi da me" (così la Cei 1971).

114
Un caso davvero curioso è quello che riguarda il viaggio a Betsaida. Non c'è commentatore che non noti la difficoltà del passo ai vv. 6,45 ss., dove Gesù invia i suoi discepoli in barca "verso Betsaida" (si conosce storicamente una Betsaida sulla riva orientale del lago: vedi All. 10), mentre poi succede che essi sbarchino a Genesaret (che era sulla riva occidentale) 131; e più in generale la difficoltà di tutto l'itinerario percorso nei capp. 6-8, dove inoltre abbiamo degli spostamenti nei territori di Tiro e Sidone (7,24), poi un ritorno verso il mare di Galilea, nella zona della Decapoli (7,31), e ancora un viaggio verso Dalmanuta (8,10: località non identificabile, probabilmente in Galilea), un reimbarco verso l'altra riva (8,13) e infine un arrivo a Betsaida in 8,22. A questo proposito è stato detto che Marco "evidentemente ha un'idea approssimativa della geografia della Palestina" (Pesch), "la geografia del brano è confusa" (Schweizer). Innumerevoli e di vario tipo sono stati i tentativi per spiegare l'espressione un po' contorta di 6,45: Kai; eujqu;" hjnavgkasen tou;" maqhta;" aujtou~ ejmbh'nai eij" to; ploi'on kai; proavgein eij" to; pevran pro;" Bhqsai>davn, "e subito costrinse i suoi discepoli a imbarcarsi e a precederlo sull'altra sponda (lett. verso l'al di là) a (o: in direzione di) Betsaida". C'è chi ha eliminato l'espressione eij" to; pevran, "sull'altra sponda, al di là", come se fosse una glossa derivante da Mt 14,22; chi vorrebbe cancellare invece proprio pro;" Beqsai>davn, "verso Betsaida", come glossa; chi ha interpretato il prov", "verso", come "di fronte a"; la soluzione estrema è quella di ritenere che Marco abbia conservato dati della tradizione senza cercare di chiarirli, e quindi lasciando l'incoerenza geografica. Chi ricorre alle informazioni dei passi paralleli degli altri vangeli incontra ulteriori difficoltà perché non coincidono con quelle di Marco. Matteo nel passo corrispondente (14,22) elimina Betsaida; Giovanni (6,16) parla di Cafarnao come meta del viaggio 132. Peraltro, là dove questi altri Vangeli parlano di Betsaida, sembra che la collochino in Galilea: Giovanni usa esplicitamente l'espressione "Betsaida di Galilea" (12,21); Matteo (11,21) e Luca (10,13) la associano a Corazim per contrapporle entrambe a Tiro e Sidone, in quanto città in cui Gesù ha operato miracoli nella sua missione precedente, che si è svolta tutta in Galilea. Pertanto fin dal XVI secolo c'è stato chi ha pensato all'esistenza di due Betsaida, una sulla riva orientale e una su quella occidentale. Indubbiamente Marco ha fissato una propria geografia 133, che non è però semplicemente approssimativa e confusa, ha un significato che va scoperto. Una spiegazione "naturalistica" è che il cambiamento di meta del primo viaggio in barca sia dipeso dalla violenza del vento contrario. Ma è una spiegazione riduttiva, che per di più non dà conto del raggiungimento dell'obiettivo solo dopo un lungo giro. Elementi chiari sono l'anomalia di Gesù che per la prima volta si separa 131 Uricchio-Stano, p.347; Schweizer, p.151; Pesch, I, pp.558-559; Manicardi, p.30; van Iersel, p.142; ecc. 132 Com'è noto, Luca tralascia tutta la sezione ("Grande omissione"). 133 Pesch (I, p.559) e altri prima di lui escludono invece decisamente che Marco abbia collegato di proposito le due menzioni di Betsaida.

115
dai discepoli e li manda da soli in un posto senza spiegare perché; questo luogo è "al di là", un'espressione che sempre indica l'altra riva, ma l'altra riva come luogo che sta fuori dal territorio giudaico, in terra pagana (cfr. 4,35; 5,1: l'al di là è il territorio dei geraseni); questo trasferimento sembra corrispondere a un progetto preciso, che in parte già era stato realizzato da Gesù insieme ai discepoli (cfr. 4,35: "Andiamo all'altra riva") e che adesso viene affidato ai discepoli, i quali già sono stati mandati in missione, in territorio giudaico e hanno svolto bene il loro compito (6,7-12.30). Ma durante la moltiplicazione dei pani non hanno saputo svolgere il ruolo che Gesù chiedeva loro: "Date voi da mangiare a loro" (6,37). Da qui incomincia un continuo andirivieni tra le due rive guidato da Gesù, un percorso che, nell'intenzione di Gesù, ha come punto di arrivo Betsaida, sull'altra riva. E' forse possibile comprendere il senso di tutto l'itinerario, con il rinvio dell'arrivo a Betsaida, appunto se lo si mette in rapporto con il contesto della vicenda, una vicenda che ha per protagonisti i Dodici e la loro mancanza di fede. L'itinerario è in stretto rapporto infatti con le due moltiplicazioni dei pani (6,30-44; 8,1-9), il cui significato, come viene più volte sottolineato in questi capitoli (6,52; 8,17-21), e rimproverato da Gesù, sfugge ai discepoli, così come non capiscono neppure la parabola che riguarda il puro e l'impuro, che è al centro di tutta questa sezione (7,18). In effetti l'ordine di Gesù (così imperativo!) di recarsi a Betsaida (6,45) è immediatamente successivo alla prima moltiplicazione dei pani e ad essa si accenna alla fine di questo primo viaggio in barca, durante il quale i discepoli non riconoscono Gesù che cammina sull'acqua e rimangono turbati dal suo intervento che placa la bufera: "non avevano infatti capito il fatto dei pani, ma il loro cuore era indurito" (6,52). Questo richiamo all'episodio della moltiplicazione dei pani costituisce così come una cornice del racconto di Gesù che cammina sul lago, e una chiave di interpretazione per esso 134. A sua volta, l'arrivo a Betsaida (8,22) è successivo alla seconda moltiplicazione dei pani e viene immediatamente dopo l'aspro rimprovero di Gesù, che richiama duramente i discepoli i quali, saliti ancora in barca, erano preoccupati per il fatto di avere un solo pane: li rimprovera di non aver capito nulla di tutti e due i miracoli dei pani: "Perché discutete che non avete pani? Non avete cervello e non capite ancora? Avete il vostro cuore indurito? 'Avete occhi e non vedete? Avete orecchie e non udite?' (Ger 5,21; Ez 12,2) E non ricordate quando spezzai i cinque pani per i cinquemila, quante ceste piene di pezzi portaste via?". Gli rispondono: "Dodici". "E quando (spezzai) i sette (pani) per i quattromila, quante sporte piene di pezzi portaste via?". E gli rispondono: "Sette". E diceva loro: "Non capite ancora?" (8,17-21). Il mancato raggiungimento della meta la prima volta e il raggiungimento dilazionato poi possono essere intesi come il corrispettivo, sul piano geografico, delle difficoltà intellettive dei discepoli; l'itinerario tortuoso percorso sulla terra si accompagna ad un itinerario spirituale altrettanto tortuoso. Il senso di queste
134 Si potrebbe parlare della tecnica "a sandwich" di cui Marco si serve frequentemente e che già abbiamo esaminato.

116
difficoltà si può poi comprendere cercando di capire il senso delle due moltiplicazioni dei pani e il collegamento con la polemica sul puro e sull'impuro che sta al centro delle moltiplicazioni e che è ugualmente non compresa dai discepoli: "Siete così privi di intelligenza anche voi? non capite che ...?" (7,18). Vari indizi nel racconto di queste due moltiplicazioni inducono a ritenere che, nonostante le forti somiglianze, non costituiscano semplicemente il doppione di un unico miracolo, ma che alludano al mistero della salvezza (tante volte espresso con l'immagine del banchetto) donata, prima ai giudei e poi ai pagani. Già i numeri, che sono un tratto insistito di questi racconti, e vengono ulteriormente fatti notare nel rimprovero di Gesù di 8,17-21 sopra citato, rinviano nel loro valore simbolico rispettivamente al popolo ebraico (5, 12, 5.000) 135 e a quello pagano (7, 7, 4.000) 136 o comunque a un popolo composto anche di pagani. Altri elementi ancora sembrano alludere a queste diverse componenti: nel primo caso la gente è "come pecore senza pastore", che richiama immagini già applicate nell'Antico Testamento ad Israele; invece la folla della seconda moltiplicazione contiene persone che vengono "da lontano", allusione, sul piano religioso, ad una loro maggiore lontananza dal vero Dio. E il territorio in cui ciascun miracolo si svolge dovrebbe essere, il primo, quello palestinese, il secondo, quello pagano: nel secondo caso risulta piuttosto chiaro, perché precedentemente è stata menzionata la Decapoli (7,31), nel primo caso si deduce appunto dal fatto che Gesù spinge i discepoli nella direzione di Betsaida, indicata come "sull'altra riva" rispetto alla riva su cui erano e che dovrebbe essere quella della Galilea. A chiarire ulteriormente quale sia la questione di fondo che i discepoli non riescono ad affrontare serve poi la parte che sta in mezzo alle due moltiplicazioni. Qui abbiamo essenzialmente la discussione con farisei e scribi a proposito del concetto di purità (7,1-23) e poi due miracoli che si svolgono in terra straniera: l'esorcismo in favore della figlia della Sirofenicia (nella zona di Tiro e Sidone: 7,24-30) e la guarigione del sordomuto (nella zona della Decapoli: 7,31-37). I tre episodi sono funzionali l'uno all'altro e alle due moltiplicazioni, di cui forniscono la chiave interpretativa. Risulta chiaro soprattutto dall'incontro con la Sirofenicia la difficoltà, che Gesù supera, di allargare l'annuncio della salvezza dai "figli", ossia gli ebrei, da sempre popolo eletto da Dio, ai "cagnolini", ossia gli infedeli, i pagani (coi quali è connessa l'idea di impurità : lo si vede bene già nel racconto dell'indemoniato di Gerasa, 5,1 ss., che porta per la prima volta a contatto coi pagani 137). Il 135 I numeri 5 e 5.000 rinviano ai 5 libri di Mosè (Pentateuco), il numero 12 alle 12 tribù di Israele. 136 Il numero 7 sembra particolarmente collegato con i pagani (cfr. Atti 6,3: 7 diaconi per cristiani provenienti dal paganesimo; c'è invece chi pensa ai 7 comandamenti di Noè); il numero 4 richiama i 4 punti cardinali, la totalità della terra. 137 Tutto l'ambiente è descritto con forti tratti di impurità: lo spirito "impuro", le tombe, i porci, ecc. Si noti che anche la figlia della Sirofenicia è preda di uno "spirito impuro". Sull'impurità dei cani cfr. Mt 7,6, in cui i cani sono associati appunto ai porci e si dice: "Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle ai porci". Cfr. anche Ap 22,15. Nella tradizione ebraica i pagani erano chiamati cani: cfr. Taylor.

117
concetto di impurità dei giudei ortodossi implicava conseguenze che andavano oltre le pratiche rituali: implicava il rifiuto anche dei pagani, in quanto impuri 138. Si noti anche che la risposta della Sirofenicia al primo rifiuto di Gesù di compiere il miracolo, con il riferimento alle briciole di pane che cadono della mensa e vengono mangiate dai cagnolini, allude ancora a un concetto tipico delle due moltiplicazioni: quello dell'abbondanza che sopravanza i bisogni dei commensali e di cui possono beneficiare i pagani (i "cagnolini") 139. E' appunto in questa direzione che Gesù vuole spingere i discepoli. E questo dopo che li ha mandati per la prima volta in missione (6,7-13.30), per far capire quali obiettivi abbia la missione, a chi debba rivolgersi 140. Durante la prima moltiplicazione, più che durante la seconda, si nota l'insistenza di Gesù a coinvolgere i discepoli nell'impegno di nutrire la folla (6,37: "Date voi da mangiare a loro", 6,38: "Quanti pani avete? Andate a vedere"; 6,39: "E ordinò loro di farli sedere tutti; 6,41: "E li dava ai discepoli perché li porgessero loro"). Ma questo tentativo si scontra già qui con la resistenza dei discepoli e Gesù riprende personalmente l'iniziativa. Ulteriori indizi che è in primo piano un insegnamento di Gesù che i discepoli stentano ad accettare sono sia la "costrizione" da parte di Gesù a partire per Betsaida (6,45), sia forse anche il suo tentativo di "oltrepassarli, superarli" quando cammina sull'acqua (6,48), quasi per guidarli oltre: 141 entrambi i tentativi falliscono. Per questo il suo cammino percorre subito dopo insistentemente regioni pagane (Tiro, Sidone, Decapoli) e sfocia poi nella seconda moltiplicazione dei pani. Per questo egli mette in guardia i discepoli dal "lievito" di farisei ed erodiani (8,15): anche al lievito è connesso il concetto di impurità (cfr. Delorme)142. Il miracolo del sordomuto (7,31-37) è allusivo alla condizione dei discepoli che fanno fatica ad aprire la loro mente e il loro cuore a questo messaggio (cfr. 7,34: "Apriti!"). Anche il miracolo della guarigione del cieco, che avviene a Betsaida (8,22-26), e si svolge in due tappe (prima il cieco vede approssimativamente, poi chiaramente), sembra ribadire lo sforzo dei discepoli per comprendere. E non a caso il rimprovero di Gesù che precede questo miracolo menziona esplicitamente "occhi" che non vedono e "orecchie" che non odono (cfr. Delorme). Letta secondo questo filo conduttore, tutta questa sezione del Vangelo
138 Per la connessione tra il mangiare cibi impuri e l'accogliere i pagani alla fede cfr.l'episodio della conversione del centurione Cornelio in Atti 10. 139 L'osservazione è in Schüssler-Fiorenza, p.164. 140 Si noti che Betsaida significa in ebraico "casa della pesca" e Gesù aveva promesso ai primi discepoli chiamati di farli "pescatori di uomini" (1,17). 141 Vi ritorneremo sopra al punto 2.7. 142 E' significativo che il "lievito (zuvmh) dei farisei sia in contrasto col pane azzimo (ajvzumo") della Pasqua (cfr.14,1.12), e implicitamente col pane che è il corpo di Gesù. Si noti che l'avvertimento avviene in rapporto con la preoccupazione dei discepoli di avere "un solo pane"(allusione appunto a Gesù stesso). Sul contrasto tra "lievito" e "azzimo", con connessa l'idea di impurità del lievito (vecchio) cfr. 1 Cor 5,6-8.

118
appare molto omogenea e ben connessa 143, e in essa tutti gli elementi concorrono all'elaborazione del messaggio, anche la geografia (cfr. Delorme144). Betsaida è davvero la meta da raggiungere, ma esige di andare "al di là" 145 di un mondo che rischia di essere troppo chiuso, di una mentalità che è quella del rifiuto dell'"altro". Non a caso subito dopo Betsaida Gesù conduce i discepoli a Cesarea di Filippo 146, punto di svolta di tutta la vicenda perché qui avviene il riconoscimento della sua messianicità e inizia il suo insegnamento sulla passione futura, che apre una prospettiva totalmente nuova. Fa parte di questa prospettiva il servire e il dare la vita in riscatto "per molti" (10,45), il versare il proprio sangue "in favore di molti" (14,24). Così come il vangelo deve essere annunciato "a tutte le genti" (13,10), "in tutto il mondo" (14,9). E questa prospettiva porta, nel racconto del Vangelo, a sfociare emblematicamente in un riconoscimento di fede che viene per la prima volta in modo compiuto da parte di un pagano, il centurione (15,39). 2.7. "E voleva oltrepassarli": Mc 6,48 Abbiamo già accennato a questa espressione, che si trova nel racconto di Gesù che cammina sull'acqua, e che è apparso un vero enigma. Le varie spiegazioni proposte non sono risultate soddisfacenti e la via più corretta è quella di collocare la frase nel contesto del brano e di tutta la sezione, dove abbiamo visto che è centrale lo sforzo pedagogico di Gesù di preparare i discepoli a svolgere la missione di portare il messaggio della salvezza a tutti, e dove si riscontra, in parallelo, le difficoltà dei discepoli di capire e assecondare il maestro. Importante nella sezione è anche la ricerca dell'identità di Gesù, come indica il fatto che all'inizio (6,14-16) e alla fine (8,27-28) si descrivono le varie
143 Ma Koch, p.157 nega che la sezione 6,6 b-8,26 sia collegata in modo organico. Van Iersel (p.148) considera "arbitraria" la sequenza dei fatti tra 4,35 e 8,21, e i particolare l'ordine delle guarigioni. 144 Radermakers, p.181, dubita che la spiegazione tradizionale dell'incoerenza geografica sia valida, ma non dà una spiegazione. Egli suppone che l'arrivo a Genesaret sia voluto da Gesù, che avrebbe fatto cambiare rotta alla barca. 145 Si noti che l'espressione eij" to; pevran, "al di là", di 6,45 è ripetuta anche in 8,13, a indicare nuovamente la direzione, che porterà a Betsaida (8,22). Anzi, si può notare che anche altre volte l'espressione è usata preferibilmente per sottolineare il passaggio in terra straniera, pagana: è usata di nuovo insistentemente in riferimento al trasferimento nel territorio dei Geraseni: prima c'è l'invito di Gesù (4,35: "Andiamo all'altra riva"), poi avviene lo sbarco (5,1: "E giunsero all'altra riva del mare"), poi di nuovo il ritorno (5,21: "E dopo che Gesù ebbe fatto la traversata di nuovo all'altra riva"). Le altre due volte in cui l'espressione ricorre si riferisce all'altra riva del Giordano (3,8; 10,1): nel primo caso si fa riferimento sicuramente alla gente pagana che abita oltre il Giordano; il secondo caso è più dubbio. Si noti che il passaggio nel territorio dei Geraseni costituisce il primo contatto con i pagani ma tutto il racconto parla soltanto di Gesù, come se i discepoli non ci fossero: al ritorno si parla solo di lui (5,18.21). L'invio a Betsaida rappresenta la prima volta in cui Gesù spinge i discepoli, e da soli, in terra pagana. 146 Anche Betsaida faceva parte dei territori amministrati da Filippo: cfr. V. Polentinos, Betsaida, in Enciclopedia della Bibbia, I, Torino 1969, c.1225.

119
opinioni che circolavano su chi fosse Gesù. Possiamo notare che in questo racconto Gesù si manifesta come Dio, camminando sull'acqua, un'azione che nell'AT era attribuita appunto soltanto a Dio (cfr. Gb 9,8; Sal 77[76],20), e anche rivelandosi con l'espressione "Io sono" (6,50), che riecheggia quella con cui Dio si rivelò a Mosè parlandogli nel roveto ardente (Es 3,14). Ma i discepoli non lo riconoscono. Anche la volontà di Gesù di mandarli da soli sull'altra riva, in terra pagana, fallisce in un primo tempo a causa del vento contrario contro cui i discepoli non hanno la forza di resistere. Il tentativo successivo di Gesù di manifestarsi e di sorpassarli si può probabilmente spiegare con l'intenzione di aiutarli a raggiungere la meta lasciando loro la guida della barca, ma "precedendoli", così come farà anche in seguito (10,32) e vorrà continuare a fare in futuro (14,28; 16,7).147 Ma neppure in questo modo riesce a ottenere che lo seguano proprio perché non lo riconoscono e non hanno capito il senso della moltiplicazione dei pani (cfr.6,52). Gesù ripiega quindi sul rimedio di salire in barca con loro e di compiere un cammino più lungo e complesso insieme a loro. 2.8. Un discorso pieno di misteri: il "discorso escatologico": Mc 13 Abbiamo già preso in considerazione questo discorso per quanto riguarda la sua struttura concentrica e vi abbiamo accennato nell'Excursus sulla "cronologia di Marco", dove abbiamo attirato l'attenzione sulla sua collocazione alla fine del terzo giorno della settimana a Gerusalemme. Ma questo discorso - chiamato per lo più "discorso escatologico" perché predice fatti futuri e si pensa che riguardino gli eventi ultimi della storia, (ejvscata, trasl. èschata, in greco significa "cose ultime"), oppure "apocalisse sinottica", perché presenta nel linguaggio e nei concetti somiglianze con gli scritti apocalittici, in particolare con l'Apocalisse, e si trova nei tre Vangeli sinottici - presenta molte difficoltà critiche e interpretative e costituisce un vero rompicapo per gli studiosi. Perciò si tende nella lettura dei Vangeli a trascurarlo o a ometterlo del tutto. Gli studiosi lo hanno spesso considerato un blocco eterogeneo rispetto al resto del Vangelo, si sono chiesti se dipenda da un'apocalisse preesistente (Pesch) oppure da materiali tradizionali disparati (un'apocalisse, detti, parabole,148 elementi catechetici) non ben inseriti nel contesto e non ben amalgamati (Lambrecht). Si sono interrogati sui significati delle singole parti e dell'insieme, senza giungere a risultati sicuri e concordi.
147 Si intravede un'allusione alla morte e alla risurrezione sia nel fatto che Gesù va incontro ai discepoli "verso la quarta vigilia della notte" (= tra le tre e le sei), ossia verso l'alba, e anche nelle parole: "Coraggio, sono io, non temete!", che riecheggiano quelle dell'angelo nella tomba vuota (cfr. 16,6). 148 Come elementi parabolici si veda l'immagine del fico nel v.28 e quella del padrone di casa e dei suoi servi (vv.34-37), che richiama la parabola dei talenti (Mt 25,14-30).

120
A parte gli interrogativi sulle fonti usate, sul genere letterario, sui riferimenti biblici, sono rilevanti ai fini della comprensione alcune questioni che occorre affrontare: - quale rapporto c'è tra il discorso di Gesù e la predizione fatta a proposito delle costruzioni del tempio tanto ammirate dai discepoli: "Non sarà lasciata qui pietra su pietra senza che sia distrutta" (v. 2)? - come risponde alle domande successive dei discepoli: "Dicci: quando avverranno queste cose e quale sarà il segno che tutte queste cose staranno per compiersi?" (v.4); - quale è il significato dell'"abominio della desolazione" (v. 14) e della "venuta del Figlio dell'uomo" (v.26), e in particolare: si riferiscono a personaggi e fatti della fine del mondo (anticristo l'uno, parusia l'altra) oppure a fatti contemporanei? In particolare l'abominio della desolazione si riferisce alla distruzione del tempio del 70 d.C.? Inoltre è un fatto che il linguaggio risulta effettivamente oscuro e si possono rilevare apparenti contraddizioni cronologiche: ad es., nel v. 30 si accenna a un accadimento prossimo ("non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute"), mentre nel v. 32 si dice che nessuno conosce i tempi. Ma cercando di leggere questo discorso nel suo contesto e tenendo conto dei collegamenti col resto del Vangelo, è forse possibile individuare una funzione e un significato più adeguati e soprattutto è possibile pensare a un rapporto stretto con il racconto della passione che incomincia subito dopo. L'inserimento nel terzo giorno della settimana fa del discorso il culmine di una fase importante, quella degli insegnamenti nel tempio e relativi al tempio, e lo pone im parallelo con gli eventi del sesto giorno della settimana che riguardano la condanna, la morte e la sepoltura, ma anche con gli eventi del giorno dopo il sabato (anch'esso "terzo giorno" rispetto al giorno della morte, come sempre viene sottolineato nelle predizioni della passione). Del resto abbiamo anche una serie di collegamenti contenutistici precisi: l'oscuramento del sole di 13,24 richiama le tenebre durante la crocifissione (15,33); la predizione della venuta del Figlio dell'uomo sulle nubi viene ripresa da Gesù stesso durante il processo nel sinedrio (14,62: "E vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo"); le esortazioni pressanti a vegliare (vv. 35-36) anticipano quelle di Gesù ai discepoli nel Getsemani (14,34.38); le quattro ore della notte menzionate nel v. 35 a proposito della venuta del padrone ("o alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino") trovano riscontro nell'ora dell'ultima cena con l'annuncio del tradimento (14,17: "alla sera"), con l'abbandono dei discepoli e il rinnegamento di Pietro (cfr. 14,30: "questa notte", "prima che il gallo canti due volte"), con il mattino del processo davanti a Pilato (15,1: "al mattino") e con quello della scoperta della tomba vuota (16,2:di buon mattino"). Non sembrano collegamenti casuali. Per quanto riguarda l'oscurità del linguaggio e delle immagini, dobbiamo considerare che dipende dall'uso intensivo di profezie

121
veterotestamentarie, in specie di profezie di Daniele. Avevamo già visto che lo schema stesso della settimana deriva dalla profezia delle settanta settimane che Daniele riprende da Geremia e reinterpreta. Ma dipendono da Daniele anche espressioni particolari di tono apocalittico, come "bisogna che avvengano" (dei' genevsqai: v.7; cfr. Dn 2,28s.45); l'espressione che descrive il tempo di tribolazione collegato all'abominio della desolazione (v.19: "quei giorni saranno una tribolazione tale quale non c'è mai stata a partire dall'inizio della creazione..."; cfr. Dn 12,1). Soprattutto vengono da questo profeta i due grandi "segni" annunciati ("quando vedrete"): l'abominio della desolazione (Dn 9,27; 11,31; 12,11) e la venuta del Figlio dell'uomo sulle nubi (Dn 7,13 s.). In questo caso Marco cita letteralmente i testi (vv.14 e 26: in corsivo nel testo greco) e invita esplicitamente a capire il senso del primo segno andando a leggere il passo biblico relativo (v. 14: "chi legge capisca"). 149 E' chiaro che quelle profezie, che sono di tipo messianico, vengono reinterpretate e applicate alla nuova situazione, ma quale? vv. 5-13: Seguendo lo sviluppo del discorso, secondo le articolazioni dello schema proposto (cfr. All. 15), possiamo osservare che Gesù innanzitutto lancia una serie di avvertimenti ("badate") che devono indurre i discepoli a non lasciarsi ingannare. Nella loro domanda sui tempi e sui segni (v.4) essi avevano dimostrato in effetti di credere che la distruzione materiale del tempio avrebbe rappresentato la fine dei tempi e sarebbe quindi stata accompagnata da altri avvenimenti prodigiosi. Il loro punto di riferimento dovevano essere già le profezie di Daniele, interpretate alla lettera: l'espressione stessa che usano "tutte queste cose che staranno per compiersi" riecheggia Dn 12,7. Secondo Daniele facevano parte dei tempi finali la distruzione di Gerusalemme e del santuario (Dn 9,25), ma anche la venuta del Messia e l'instaurazione del suo regno. Probabilmente essi si attendono che le cose avvengano a breve scadenza. Ora, Gesù vuole proprio mettere in guardia da attese messianiche sconsiderate, perché c'è il rischio di lasciarsi suggestionare da falsi Messia (v.6); inoltre mette in guardia dal credere che segni della fine del mondo siano guerre, terremoti, carestie, che facevano parte degli eventi apocalittici nella tradizione (cfr. Ap 6,1 ss.; per le guerre cfr. Is 19,2; Dn 9,25; per i terremoti: Is 13,13; per le carestie: Is 8,21). Sono piuttosto eventi normali nella storia umana. Semmai, ciò per cui i discepoli devono essere consapevoli e preparati sono le persecuzioni che inevitabilmente li colpiranno, da parte dei correligionari e delle autorità politiche, le divisioni che interverranno anche all'interno delle famiglie a causa della fede in Gesù. Il loro compito è quello di predicare il vangelo in tutto il mondo e di testimoniare davanti ai persecutori, e di resistere fino alla fine.
149 Questo invito è stato interpretato anche in altri modi, ad es., supponendo che l'oggetto possa essere il discorso stesso o l'apocalisse originaria. Ma il verbo ajnaginwvskw, "leggere", in Marco si usa sempre a proposito di passi biblici (cfr. 2,25; 12,10.26). Nel parallelo di Mt il riferimento a Daniele è esplicito: vedi Sinossi negli All. 29-32.

122
In questa prima sezione Gesù parla del futuro, ma di un futuro dilatato nel tempo. Distoglie l'attenzione dalla fine dei tempi, la attira su questo tempo di impegno e attenzione. vv. 14-31: questi versetti si possono più opportunamente considerare unitariamente, tenendo conto del parallelismo tra i due segni. Il segno dell'abominio della desolazione(vv.14-20), anche in rapporto alla fonte di Daniele, deve essere inteso più come una profanazione che non come una distruzione (come pensano coloro che vi vedono un riferimento agli eventi storici del 70):150 il senso dell'espressione bdevlugma th'" ejrhmwvsew", "abominio della desolazione", è letteralmente quello di una cosa abominevole per la sua impurità, tale che induce all'abbandono. In effetti il discorso, con abbondanza di immagini "apocalittiche" invita subito dopo a una fuga che deve essere immediata e senza ripensamenti. Si tratta di una "fuga" spirituale, non fisica, dal giudaismo nelle sue forme degenerate (cfr. la fuga di Lot da Sodoma: Gen 19,17). Si intravede un rapporto con le parole di condanna pronunciate da Gesù nel tempio in 11,17. Si sottolinea inoltre che si tratta di una profanazione senza confronto nella storia. Secondo E. Corsini, studioso dell'Apocalisse, ma anche del discorso escatologico, 151 questo evento di profanazione di una gravità inaudita è il rifiuto della messianicità di Gesù da parte delle massime autorità religiose giudaiche, che si verifica in tutta una serie di dispute avvenute nel tempio durante i primi tre giorni a Gerusalemme (cfr. 11,27-12,12; 11,18), rifiuto che culmina nella condanna a morte pronunciata dal sommo sacerdote. Al centro di questa sezione (vv. 21-23) sta la ripetizione degli avvertimenti dell'inizio del discorso, a proposito dei falsi Messia e falsi profeti. Segue la predizione dei fenomeni che accompagnano la venuta del Figlio dell'uomo (vv. 24-27), con citazioni da Isaia, Gioele e Daniele, e la scena culmina con la raccolta degli eletti, ossia dei salvati. In coerenza con l'interpretazione del primo segno questo secondo segno deve essere identificato con la rivelazione messianica di Gesù e il compimento del Regno: secondo Marco questa rivelazione è innanzitutto quella che avviene alla sua morte (cfr. l'oscuramento del sole), con la proclamazione del centurione, che "vede" in Gesù morente il Figlio di Dio (15,39). Il centurione per questo diventa il prototipo dei pagani che crederanno ed entreranno nella schiera degli eletti. Marco inserisce qui la parabola del fico con l'indicazione che questi eventi (entrambi i segni) capiteranno a breve, entro questa generazione, ad evitare, di nuovo, che si pensi a una fine del mondo lontana.
150 Semmai accenni più chiari alla distruzione del tempio del 70 si trovano nei paralleli sinottici (cfr. Mt 24,15; Lc 21,20). 151 Cfr. E. Corsini, Apocalisse prima e dopo, Torino, Sei, 1980, pp.71-81. Il libro è stato di recente rielaborato e ristampato col titolo Apocalisse di Gesù Cristo secondo Giovanni.

123
vv. 32-37: L'ultima parte è ancora, come la prima, incentrata sugli avvertimenti ("badate"), soprattutto nel senso di inviti a vigilare e a stare attenti per saper riconoscere il momento in cui il Signore viene, che può essere in qualunque ora, ma soprattutto nelle ore in cui è più facile cedere alla debolezza, come sono le ore della passione che metteranno alla prova i discepoli. L'attenzione è di nuovo attirata sul futuro, ma quello della storia, non quello della fine del mondo. Gli scopi principali di questo discorso sembrano dunque quelli di smentire certe false attese messianiche condivise dai discepoli; dimostrare che le profezie di Daniele stanno per compiersi negli eventi prossimi, quelli della passione, morte e risurrezione di Gesù; preparare a cogliere il senso profondo del racconto di questi eventi. La predizione della distruzione del tempio posta all'inizio del discorso deve essere intesa soprattutto in senso spirituale. Nel discorso si allude a una profanazione che distrugge la sacralità e la funzione cultuale del tempio. Successivamente, la predizione della distruzione del tempio verrà ripresa tra le accuse, peraltro non valide, mosse a Gesù nel sinedrio (14,58), ma ciò che davvero avverrà, al momento della morte di Gesù, è la lacerazione del velo del tempio (15,38), che rappresenta la fine dell'esclusione di pagani, laici e donne dal santuario, e quindi l'apertura a tutti del contatto diretto con la divinità. Non a caso subito dopo, o insieme, c'è la confessione di fede del centurione, un pagano.

124
Indice Presentazione 1 1. Perché studiare il Vangelo di Marco? 1 2. Medologia e piano di lavoro 2 Nota bibliografica generale 3 I parte: Il Vangelo di Marco nella tradizione antica e moderna 3 1. Il Vangelo di Marco nell'antichità 3 1.1. Scarsa fortuna di Marco nell'antichità 4 1.2. Le testimonianze antiche su Marco 6 1.2.1. Papia di Gerapoli 6 1.2.2. Giustino 9 1.2.3. Il Prologo antimarcionita 10 1.2.4. Il Canone Muratoriano 10 1.2.5. Ireneo di Lione 10 1.2.6. Clemente Alessandrino 14 1.2.7. Origene 16 1.2.8. Eusebio di Cesarea 16 1.2.9. Gerolamo 17 1.2.10. Agostino 17 1.2.11. Conclusione sul Vangelo di Marco nell'antichità 18 2. Il Vangelo di Marco nella ricerca moderna 19 2.1. Il Vangelo di Marco e il metodo storico-critico 20 2.1.1. L'Analisi storica e la valutazione moderna delle testimonianze antiche 20 2.1.1.1. L'identità di Marco 21 2.1.1.2. Luogo di composizione del Vangelo e destinatari 22 2.1.1.3. Data di composizione del Vangelo 22 2.1.1.4. Altri aspetti dell'Analisi storica: problemi storici e linguistici 24 2.1.1.5. Un esempio di applicazione dell'Analisi storica. la Chiamata di Levi 25 2.1.2. La Critica delle fonti e la priorità di Marco rispetto agli altri Vangeli 26 2.1.2.1. Un esempio di applicazione della Critica delle fonti: la Chiamata di Levi 28 2.1.2.2. Conclusione 32 2.1.3. La Storia delle forme e i materiali utilizzati da Marco 32 2.1.3.1. Un esempio di applicazione della Storia delle forme: la Chiamata di Levi 35 2.1.3.2. La forma o genere letterario del "vangelo" 38 2.1.4. La Storia della redazione e la scoperta del lavoro compositivo di Marco 39 2.1.4.1. Un esempio di applicazione della Storia della redazione: la Chiamata di Levi 41 2.1.5. Un esempio di applicazione del metodo storico-critico: il Battesimo di Gesù 43 2.1.6. La ricerca teologica 46 2.1.7. Excursus: La geografia e la cronologia di Marco 49 2.2. Il Vangelo di Marco e le nuove metodologie 57 2.2.1. Metodi o approcci basati sulla tradizione 58 2.2.2.Metodi o approcci attraverso le scienze umane 59 2.2.3. Metodi o approcci contestuali 60 2.2.3.1. L'esegesi femminista 60 2.2.4. Metodi di analisi letteraria 63 2.2.4.1. L'Analisi strutturale 64 2.2.4.2. L'Analisi retorica 68 2.2.4.3. L'Analisi narrativa 69 2.2.4.4. Applicazione dei metodi di analisi letteraria all'episodio della Chiamata di Levi 70

125
2.2.4.5. Conclusione sui metodi di analisi letteraria 71 2.3. Considerazioni finali sui metodi 71 2.3.1. Ancora qualche considerazione sul brano di Levi 72 2.3.2. La struttura complessiva del Vangelo di Marco 73 II parte: Problemi critici e interpretativi del Vangelo di Marco 77 1. La Critica testuale del Nuovo Testamento 77 1.1. I testimoni del testo 78 1.2. Princìpi di critica testuale 82 1.3. Le edizioni critiche recenti del NT 85 1.4. Caratteritiche formali dell'ed. Nestle-Aland 86 2. Problemi specifici del Vangelo di Marco 87 2.1. L'inizio del Vangelo: Mc 1,1-3 87 2.2. La finale del Vangelo: Mc 16,9-20 93 2.3. Due questioni nell'episodio del lebbroso: Mc 1,40 e 1,41 95 2.4. La teoria delle parabole: Mc 4,10-12 98 2.5. "Quelli lungo la strada": Mc4,15 100 2.6. Il viaggio a Betsaida dei discepoli di Gesù: Mc 6,45-8,22 101 2.7. "E voleva oltrepassarli": Mc 6,48 105 2.8. "Il discorso escatologico": Mc 13 106 Elenco degli Allegati 1.La testimonianza di Papia 2.Il Canone Muratoriano 3 e 4.Ireneo di Lione 5. Testimonianze di Clemente Alessandrino 6. Eusebio di Cesarea e Girolamp 7. Agostino 8. Il frammento 7Q5 9. Sinossi della Chiamata di Levi 9 bis. Sinossi greca della Chiamata di Levi 10. Cartine 11. Il battesimo di Gesù (Sinossi) 11 bis. Sinossi greca del battesimo di Gesù 12. Esempio di costruzione a sandwich: Mc 11,12-14.20-21 13. Esempio di Analisi retorica: Mc 10,46-52 14. Esempio di Analisi retorica: Mc 10,35-52 15. Schemi di singole sezioni del Vangelo di Marco 16.Schemi del Vangelo di Marco 17. Schema formale e contenutistico 18. Il testo di Mc 1,1-8 nell'ed. Nestle-Aland 19. Testo della finale del Vangelo di Marco nell'ed. Nestle-Aland 20. La finale di Marco in Sinossi 21. La guarigione del lebbroso nella sinossi greca 22. La guarigione del lebbroso nella sinossi italiana 23. La teoria delle parabole: Mc 4,10-12 nella sinossi greca 24. La teoria delle parabole nella sinossi italiana 25. La "vera famiglia di Gesù": Mc 3,31-35 26. "Quelli lungo la strada": Mc 4,15

126
27. Gesùcammina sulle acque: Mc 6,45-52 nella sinossi greca 28. Gesù cammina sulle acque nella sinossi italiana 29-32. Discorso escatologico in sinossi

127
Elenco dei passi del Vangelo di Marco da tradurre (per chi sa il greco) 1,1-8: prima parte del prologo 1,40-45: purificazione del lebbroso 2,13-17: Chiamata di Levi e banchetto coi pubblicani 2,31-35: La vera famiglia di Gesù 4,1-20: prima parte della sezione sulle parabole 6,45-52: Gesù cammina sulle acque 8,27-33: la confessione di Pietro 10,35-52: i figli di Zebedeo e Bartimeo 11,12-25: il fico senza frutti e la cacciata dei mercanti dal tempio 13: il discorso escatologico 14,55-65: il processo nel sinedrio 15,29-41: sotto la croce 16: la tomba vuota e la finale lunga

128
Testimonianze su Marco di Clemente Alessandrino (inizio del III sec.) Ipotiposi VI (in Eusebio di Cesarea, Hist.Eccl. VI,14,5-7): "Negli stessi libri Clemente riporta una testimonianza dei presbiteri antichi sull'ordine dei Vangeli, che suona così: diceva che furono scritti prima i Vangeli che contengono le genealogie (= Matteo e Luca). Quanto al Vangelo di Marco, avrebbe avuto questa storia. Quando Pietro ebbe annunciato pubblicamente a Roma la Parola e predicato il Vangelo secondo lo Spirito, i presenti, che erano molti, invitarono Marco, in quanto lo aveva seguito da tempo e ricordava le cose dette, di trascrivere le sue parole. Questi lo fece e consegnò il Vangelo a coloro che glielo chiedevano. Quando lo venne a sapere, Pietro non usò esortazioni né per impedirlo né per incitarlo. Quanto poi a Giovanni, che fu l'ultimo, quando vide che i fatti materiali già erano stati esposti nei Vangeli, spinto dai discepoli e pieno di Spirito divino, compose un Vangelo spirituale. Così Clemente". Ipotiposi VI (in Eusebio di Cesarea, Hist. Eccl. II,15,1-2): "Rifulse a tal punto il lume della fede nelle menti degli ascoltatori di Pietro che non bastò loro di ascoltarlo una sola volta né di ricevere oralmente l'insegnamento dell'annuncio divino, ma con inviti di ogni genere supplicarono Marco, di cui ci è tramandato il vangelo e che era seguace di Pietro, di lasciare loro anche una memoria scritta dell'insegnamento ricevuto verbalmente ed insistettero finché non lo fece: in questo modo divennero causa della redazione del Vangelo detto secondo Marco. Dicono che l'apostolo, quando seppe, attraverso una rivelazione diretta dello Spirito, ciò che era avvenuto, si compiacque dell'ardore di quelle persone e convalidò il testo scritto perché fosse letto nelle chiese. Clemente riporta il racconto nel sesto libro delle Ipotiposi, e lo conferma anche il vescovo di Gerapoli di nome Papia". Adumbrationes ad 1 Petr. 5,13 (nella trad.lat. di Cassiodoro): "Marco, seguace di Pietro, allorché Pietro predicava pubblicamente il Vangelo a Roma, alla presenza di certi cavalieri di Cesare, e adduceva molte testimonianze su Cristo, pregato da loro di far sì che essi potessero ricordare ciò che veniva detto, scrisse sulla base di quanto Pietro aveva detto il Vangelo chiamato di Marco".

129
Schemi del Vangelo di Marco: schema geografico Prologo: 1,1-15 deserto I parte I sezione: 1,16-3,6 Galilea II sezione: 3,7-6,6a Galilea III sezione: 6,6b-8,26 spostamenti intorno alla Galilea II parte IV sezione: 8,27-10,52 viaggio verso Gerusalemme V sezione: 11-13 Gerusalemme VI sezione: 14-15 Gerusalemme Epilogo: 16,1-8 tomba vuota schema teologico Prologo ( 1,1-15): la voce celeste durante il battesimo proclama che Gesù è Figlio di Dio I parte (1,16-8,30): le persone si interrogano su chi sia Gesù, si meravigliano, non capiscono (cfr. 1,27: «Che è mai questo?»; 4,41: «Chi è costui?»; 6,3: «Non è costui l'artigiano...?»; 6,14-16: le varie opinioni su Gesù) i demòni lo riconoscono (cfr. 1,24: «Io so chi tu sei: il santo di Dio»; 3,11: «gli spiriti immondi quando lo vedevano gli si gettavano ai piedi gridando: «Tu sei il Figlio di Dio»; 5,7: l'ossesso si rivolge a Gesù chiamandolo «Figlio del Dio altissimo»), ma Gesù ogni volta li zittisce perché non vuole che manifestino la sua identità 8,29: dopo che i discepoli, in risposta a una domanda precisa di Gesù: «Chi dice la gente che io sia?», hanno riportato ancora le varie opinioni su Gesù, Pietro riconosce che Gesù è il Cristo (il Messia): è la prima rivelazione, da parte umana, dell'identità di Gesù, ma Gesù non vuole che sia divulgata, perché non risulta sufficiente. II parte (8,31-15,47): Gesù incomincia ad annunciare che il Figlio dell'uomo (il Messia) deve subire la passione, morire e risorgere. Pietro rifiuta questa prospettiva e viene duramente rimproverato da Gesù. Nella Trasfigurazione la voce celeste ripete che Gesù è Figlio di Dio (9,8) e invita i discepoli ad ascoltarlo. Gesù ripete altre due volte le predizioni della passione (9,31; 10,33- 34), ma ogni volta si scontra con l'incomprensione dei discepoli. Durante il processo nel Sinedrio, alla domanda provocatoria e incredula del sommo sacerdote: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Benedetto?», Gesù risponde. «Io lo sono» (14, 61-62) e viene condannato a morte.

130
15,39: Sotto la croce, al momento della morte di Gesù, avviene il primo riconoscimento da parte umana di Gesù come «Figlio di Dio». il centurione romano proclama vedendolo morire così: «Veramente costui era Figlio di Dio»). Epilogo (16,1-8): il giovinetto nella tomba vuota dice: «Cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso. E' risorto, non è qui».
Schemi di singole sezioni del Vangelo di Marco La sezione delle dispute in Galilea (2,1-3,6a) A. Guarigione del paralitico (2,1-12): questione sul perdono dei peccati; reazioni dei presenti (positive) B. La chiamata di Levi e il banchetto (2,13-17): questione sul mangiare coi peccatori; Gesù conclude con un duplice detto (sapienziale e cristologico) C. Controversia sul digiuno (2,18-22): non si digiuna quando si è invitati a nozze; accenno al momento in cui lo sposo sarà tolto (passione) B'. I discepoli colgono e mangiano spighe di sabato (2,23-28): questione del mangiare di sabato; Gesù conclude con un duplice detto (sapienziale e cristologico) A'. Guarigione dell'uomo dalla mano inaridita (3,1-6a): questione se si possa salvare una vita di sabato; reazioni dei presenti (negative) La sezione delle parabole (4,1-34) A. Introduzione narrativa (vv. 1-2) B. Parabola del seminatore (vv. 3-9): a tutti C. Insegnamenti sulle parabole (vv. 11-12): ai discepoli D. Spiegazione della parabola del seminatore (vv. 14-20): ai discepoli C'. Insegnamenti, in forma di detti (vv. 21-25): ai discepoli B'. Due parabole: il seme che cresce da sé, il granello di senapa (vv. 26-32): a tutti A'. Conclusione narrativa (vv. 33-34) Il discorso escatologico (cap. 13) Introduzione (vv. 1-4): Dialogo di Gesù coi discepoli A. Avvertimenti di Gesù sul tempo prima della fine (vv. 5-13): «Badate» (vv. 5 e 9)

131
B. Raccomandazioni relative alla comparsa dell'"abominio della desolazione" (vv. 14- 20): «quando vedrete...» (v. 14) C. Avvertimenti sui falsi Cristi e falsi profeti (vv. 21-23): «Badate» (v. 23) B'. L'annuncio della venuta del Figlio dell'uomo (vv. 24-31): «quando vedrete...» (v. 29) A'. Avvertimenti per il tempo della vigilanza (vv. 32-37): «Badate» (v. 33)

132
Schemi del Vangelo di Marco: Schema formale e contenutistico Prologo 1,1: "vangelo" Giov. battezza e annuncia (1,1-15) 1,15: "vangelo" Gesù viene battezzato e annuncia I parte 1,21: sabato, sinagoga, insegnare Missione in Galilea (1,16-6,6a) 6,2: sabato, sinagoga, insegnare I sezione 1,21-28: sabato, sinagoga, miracolo Inizio della missione e dispute (1,16-3,6) 3,1-6: sabato, sinagoga, miracolo I sottosezione 1,16-20: chiamata di 4 discepoli Inizio della missione (1,16-45) II sottosezione 2,13-14: chiamata di Levi Dispute (2,1-3,6) II sezione: barca, lago Insegnamenti e miracoli (3,7-6,6a) I sottosezione 3,13-19: elezione dei Dodici Insegnamenti (Disc. parab.) (3,7-4,34) II sottosezione I miracoli e la fede (4,35-6,6a) II parte strada, pane Viaggi fuori dalla Galilea (6,6b-10,52) III sezione: 6, 14-16: opinioni su Gesù "Sezione dei pani" e missione (6,6b-8,26) 8,27-28: opinioni su Gesù dei Dodici I sottosezione 6,7-13: invio in missione dei Dodici La missione ai giudei (6,6b-56) 6,30-44: 1° moltiplicaz. dei pani II sottosezione 8,1-9: 2° moltiplicaz. dei pani La missione ai pagani (7,1-8,26) IV sezione: 8,22-26: guarigione di un cieco (a Betsaida) Annunci della passione e (8,27-10,52) 10,46-52: guarigione di un cieco (a Gerico) difficoltà dei discepoli I sottosezione 1° annuncio; trasfigurazione (8,27-9,29) II sottosezione 2° e 3° annuncio e insegnam. (9,30-10,52) III parte settimana, Gerusalemme La settimana a Gerusalemme (cc. 11-15) V sezione i primi 3 giorni (cc. 11-13) I sottosezione nel tempio Dibattiti nel tempio (cc. 11-12) II sottosezione davanti al tempio Discorso sulla fine (c. 13) VI sezione i secondi 3 giorni (verso la Pasqua) La passione (cc. 15-16)

133
I sottosezione Tradimenti e rinnegamenti (c. 14) II sottosezione Condanna a morte (c. 15) Confessione del centurione Epilogo il giorno dopo il sabato Un messaggero annuncia la (16,1-8) risurrezione
AVVISO
SONO PRONTE
LE DISPENSE DEL MODULO SPECIALISTICO DI LETTERATURA CRISTIANA ANTICA
2006-2007
"Problemi critici e interpretativi del Vangelo di Marco"
Si possono trovare sia presso il personale all'ingresso del Dipartimento,
sia nella Copisteria di fronte a Palazzo Nuovo