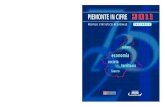Mafie in piemonte
-
Upload
il-tosco-pistolesi -
Category
Documents
-
view
3.929 -
download
0
Transcript of Mafie in piemonte

Lo scorso 8 giugno con “Minotauro”, la più grande operazione anti ’ndrangheta sul territorio piemontese, la magistratura torinese ha messo nero su bianco il reticolo di interessi e affari dell’organizzazione calabrese trapiantata al Nord.Una colonizzazione lenta e capillare, capace di toccare gangli vitali della politica e dell’economia locale
inchiesta

Nel marzo 2006, in previsione della “Giornata della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime di tutte le ma�e” organiz-
zata da Libera a Torino, realizzammo un numero monogra�co
di «Narcoma�e» dedicato alle in�ltrazioni ma�ose in Piemonte.
Non fu affatto facile riempire quelle 80 pagine. Ricordiamo bene
la perplessità di magistrati e di uomini delle forze dell’ordine
di fronte alle nostre domande sulla presenza dei clan all’ombra
della Mole. La sensazione era che, in fondo, non ci fosse molto
da dire. La nostra intenzione di accendere i ri�ettori sull’ar-
gomento ma�a era benemerita ma – cercavano di farci capire
con rispetto e benevolenza – in Piemonte non
c’era alcuna emergenza e se mai le questioni
calde erano altre. Dopo i processi degli anni
90 le ma�e italiane, compresa la ’ndrangheta,
stavano vivendo una fase di appannamento,
dunque, senza scadere in imprudenti sotto-
valutazioni, la tendenza era quella di rassi-
curare. Il problema più concreto sembrava
la criminalità straniera, albanese, rumena e
maghrebina, che si era imposta, ci dicevano,
nei traf�ci di esseri umani e di stupefacenti, e
che rappresentavano anche la maggior fonte
di allarme sociale per i cittadini.
La procura di Torino e la Direzione distrettuale
antima�a erano guidate da due magistrati di
assoluto valore come Marcello Maddalena,
allora procuratore capo e attuale procurato-
re generale, e il compianto Maurizio Laudi
(improvvisamente scomparso il 24 settembre 2009), all’epoca
procuratore aggiunto coordinatore della Direzione distrettuale
antima�a. Di Maddalena mi colpì un passaggio dell’intervista
sullo stato dei rapporti ma�a-politica in regione: «Detto chiara-
mente, penso che neanche a Bardonecchia (primo comune sciolto
per ma�a al Nord, nel 1995, nda) ci fosse quella compenetrazione
che si è veri�cata in altre situazioni che hanno portato poi allo
scioglimento di altri comuni». Mentre di Laudi, che condivideva il
giudizio di Maddalena su Bardonecchia – dove politici e impren-
ditori protagonisti dei fatti alla base del commissariamento furono
poi assolti in sede processuale – mi impressionò una dichiarazione
in merito al pericolo in�ltrazione negli appalti pubblici: «Anche
nei momenti di maggiore forza militare di questi gruppi ma�o-
si, non c’è stata mai una pervasiva opera di in�ltrazione nella
pubblica amministrazione, che è la condizione fondamentale
per inquinare gli appalti. E ciò va a titolo di merito di chi ha
gestito la cosa pubblica a livello locale». Questo era lo stato
delle risultanze giudiziarie all’inizio del 2006.
Cinque anni dopo ci troviamo a fare i conti con l’inchiesta Mi-
notauro, la più vasta operazione anti ’ndrangheta della storia
del Piemonte. 151 arresti, sequestri preventivi di beni per circa
117 milioni di euro, una mappatura aggiornata della presenza
radicata dei clan in Piemonte. E scopriamo che l’inchiesta Mi-
notauro è nata proprio nel lontano 2006, pochi mesi dopo il 21
marzo celebrato a Torino. Nell’autunno di quell’anno, infatti,
il pentimento di Rocco Varacalli, af�liato al locale di Natile di
Careri a Torino, ha aperto scenari nuovi,
che raccontiamo nelle prossime pagine,
a tinte ben più fosche di quello registrato
all’epoca. Un contributo decisivo quello
di Rocco Varacalli, che ha consentito di
battere sentieri inesplorati e di tirare le
�la di altre inchieste il cui destino, forse,
sarebbe stato più incerto. Minotauro ha
svelato, da un lato, una presenza massic-
cia (a centinaia) di uomini dei clan nel
capoluogo e nella provincia. ’Ndranghetisti
che riproducono fedelmente le loro con-
suetudini, eseguono i loro lugubri rituali di
af�liazione e regolano i loro conti interni
ed esterni con la violenza. Un radicamento
sul territorio che, nel nostro piccolo, ave-
vamo provato a denunciare �n dal 2007
(“Viaggio in Aspropiemonte”, n.10/2007)
e poi seguendo le operazioni “Gioco duro” (“La carica dei
colonnelli”, n.5/2009) e “Pioneer” (“’Ndrangheta, la faccia
nascosta dell’economia”, n.10/2010). Dall’altro l’inchiesta ha
scoperchiato un intreccio di rapporti con uomini delle istituzioni
e delle amministrazioni locali, privo in molti casi di rilevanza
penale, ma di cui non può sfuggire il signi�cato politico. Alla
luce anche di un attivismo frenetico degli ’ndranghetisti nel
comparto fondamentale dell’edilizia, che può rappresentare la
chiave di lettura di un rapporto con la politica che non è mai
ideologico, ma sempre sinallagmatico.
L’inchiesta Minotauro, pur nella precarietà conoscitiva propria
di qualunque inchiesta non ancora sottopposta al vaglio del
processo, ci conduce dunque sulla soglia di un labirinto ancora
tutto da esplorare. E la sensazione, condivisa dagli inquirenti,
è che ancora molto ci sia da scoprire.
(m.neb.)
2009) all’epoca
Ca
ch
a ti
all’
di R
ba
�la
sare
svel
cia
capo
ch
su
af�l
ed
su
va
(“Vi
e poi seguendo le oper

La ’ndrangheta bussò e la politica, sventurata, rispose. O forse fu la politica a bussare, avendo capito che dopo l’ondata migratoria degli anni 50/60 potevano essere replicati anche al Nord, in scala ridotta, meccanismi di raccolta del consenso ampiamente collau-dati nel meridione. Meccanismi in grado di pescare “a strascico” nei settori più bisognosi e meno istruiti della popolazione. E pa-zienza se a essere “grattato” e inaridito è il fondamento stesso della democrazia rappresentati-va, il voto libero e consapevole dei singoli cittadini. L’accordo con la ma#a è stato visto, da settori trasversali della politica, come una scorciatoia verso quella vittoria sul cui altare sacri#care qualunque valore. Primum vivere (o meglio, vincere), deinde phi-
losophari. Non stupisce dunque
che in Piemonte la liaison tra ma#a e politica locale abbia radici lontane e che ciò che abbiamo letto nelle carte dell’operazione Minotauro sia solo l’ultimo capi-tolo di una vicenda che si trascina da almeno 40 anni. E quando storia e cronaca si assomigliano troppo, vuol dire che qualcosa, a livello politico e giudiziario, non ha funzionato.
Il punto centrale e più delicato di tutta la questione è il rapporto tra po-litica e le comunità di immigrati calabresi, le quali, piaccia o non piaccia, hanno sempre costitui-to un bacino elettorale ambito da tutti i partiti politici. Questi pacchetti di voti sono spesso controllati, in parte signi#cativa, da “capibastone” che alla vigilia delle elezioni, amministrative o
politiche, li piazzano sul mercato elettorale. Si tratta di persone che non godono di particolare prestigio per motivi personali o professionali, che tuttavia sono in grado di portare centinaia, migliaia di voti e di preferenze. Molti di questi, come provano le inchieste, sono legati alla ’ndran-gheta e fondano su questa appar-tenenza la loro capacità di per-suasione. Ovviamente non tutti i voti calabresi sono controllati, ma molti sì. Un dato di fatto che proietta un’impalpabile ombra di ambiguità su alcune epopee politiche che, a partire dagli anni 60, si sono basate sul rapporto stretto, quasi simbiotico, con le comunità degli immigrati. L’ex deputato socialista Francesco Froio è stato forse uno dei primi e dei più abili nel costruire la sua carriera sulla gestione – legittima
L’inchiesta Minotauro ha fatto scalpore per le intercettazioni che hanno rivelato i rapporti tra i boss arrestati e alcuni noti politici piemontesi. Che alla vigilia delle elezioni bussano re-golarmente alle porte di certi personaggi in grado di controllare fette consistenti del voto calabrese. In cambio di che cosa? Con quale grado di consapevolezza? Viaggio all’esplorazione di una palude antica che il processo penale non riesce a risanare
di Marco Nebiolo

– del voto calabrese. Negli anni 60 fu amministratore delegato delle acciaierie di Stato “Cogne”, in Valle D’Aosta, che portarono centinaia di famiglie calabresi in quella regione. Trasferitosi a Torino alla #ne degli anni 60, divenne segretario regiona-le del Psi, e fu tra i padri della Sitaf, la società nata per la realizzazione del nuovo traforo automobilistico del Frejus – da af#ancarsi a quello ferroviario – e che curerà negli anni 80/90 la costruzione dell’autostrada Torino-Bardonecchia. Due grandi opere che ancora oggi gestisce. Sono gli anni d’oro dell’edilizia in Val di Susa. C’è lavoro per tutti, arrivano per la torta dei subappalti decine di imprese calabresi tra cui, come ha segnalato la commissione antima#a, quelle dei Mazzaferro di Marina di Gioiosa ionica (di orien-tamento democristiano, secondo il pentito Giacomo Lauro), clan ’ndranghetista di grande rilievo che per anni farà il bello e il cattivo tempo in quei territori. Nei primi anni 70 Froio diventa deputato al Parlamento dell’area mancinia-na. Poi nel 1979 lascia la politica istituzionale per assumere il ruolo di amministratore delegato della Sitaf, la sua creatura, divenuta una straordinaria macchina di #nanzia-mento dei partiti e di raccolta di consenso elettorale, in particolare, proprio tra gli immigrati calabresi. Froio rimane in sella #no al 1993, quando tangentopoli si abbatte anche su di lui, ma le numerose imputazioni non si sono tradotte in alcuna condanna. Ma ancora oggi i suoi consigli vengono ascoltati in ambito politico e sotto elezioni in molti bussano alla sua porta.
Sono numerosi i nomi di rappresen-tanti delle istituzioni locali che compaiono, a vario titolo, nell’inchiesta Minotauro. Il fatto
che l’unico a essere arrestato sia stato l’imprenditore Nevio Coral, ex sindaco di Leinì, non deve indurre a imprudenti sot-tovalutazioni, visto che appare evidente che ancora molto ci sia da scoprire sull’argomento. Pochi giorni dopo Minotauro è #-nito in manette Giuseppe Caridi, consigliere comunale di Alessan-dria, nell’ambito dell’operazione “Albachiara-Maglio” (cfr box pag. 38, ndr). Il procuratore capo Gian Carlo Caselli, nella conferenza stampa dell’8 giugno, si era detto amareggiato e stupito del fatto che «vi siano numerosi esponenti politici a intrattenere rapporti pro#cui con esponenti ma#osi, in un amorevole intreccio», ag-giungendo che «è una vergogna inaccettabile che nella città in cui è stato ucciso Bruno Caccia, vi siano persone con ruoli anche istituzionali che mantengano simili rapporti».Come distinguere tra rapporti e rapporti, questo è il dilemma. Perché in campagna elettorale si stringono molte mani, e può capitare di stringere, inconsape-volmente quelle sbagliate. Come potrebbe essere capitato all’asses-sore regionale Claudia Porchietto (Pdl), #lmata il 23 maggio 2009 mentre, alla vigilia delle elezio-ni provinciali cui è candidata, entra nel bar Italia di Giuseppe Catalano in via Veglia a Torino, a pochi passi dal commissariato di polizia di zona. Catalano è uno dei destinatari delle ordinanze di custodia cautelare eseguite l’8 giugno, già arrestato nel luglio 2010 nell’ambito dell’operazio-ne “il Crimine” della procura di Reggio Calabria assieme al fra-tello, Giovanni, imprenditore di Orbassano. Giuseppe Catalano, originario di Siderno, 69 anni, è uno dei boss più importanti
della ’ndrangheta piemontese, al vertice nella città capoluogo. È ritenuto dai magistrati il capo della locale di Siderno (Rc) a To-rino, candidato, in virtù del suo prestigio criminale, a far parte della futura “camera di controllo” del Piemonte, l’organo demandato a dirimere le questioni interne ai clan e a mantenere i rapporti con la casa madre calabrese. La Por-chietto è accompagnata nel bar da Luca Catalano, allora consigliere comunale di Orbassano e membro del comitato elettorale, nipote del presunto boss. All’incontro, che dura solo 7 minuti, partecipa anche Francesco d’Onofrio, nato a Mileto, in provincia di Vibo Valen-tia, componente del Crimine con la dote di Padrino. La Porchietto non è indagata per tale episodio, che lei ha spiegato come uno dei tanti – e tra i più sbrigativi – in-contri pre elettorali che si fanno senza avere l’esatta conoscenza dei propri interlocutori. Senza chiede-re documenti o certi#cati penali. Luca Catalano darà le dimissioni qualche tempo dopo l’arresto del padre Giovanni, a casa del quale furono trovati dei foglietti con la descrizione dei rituali di af#lia-zione (cfr box p.55, ndr).Lo stesso Giuseppe Catalano è protagonista della vicenda che riguarda la candidatura nella lista del Pdl, sempre nel 2009, di Fabrizio Bertot, sindaco di Rivarolo Canavese, alle elezioni europee. Neanche Bertot è inda-gato, come non lo è la Porchietto, ma le due posizioni, pur entrambe penalmente irrilevanti, appaiono differenti. Il “luogo del delitto” è sempre il bar Italia di Catalano che, su sollecitazione del segreta-rio comunale di Bertot (Antonino Battaglia, arrestato) organizza un incontro elettorale in favore del giovane sindaco. Il 27 maggio

2009 all’ora di pranzo i carabinieri registrano un lungo elenco di con-vitati: su tutti, scrive il Gip, «sussi-stono gravi indizi di colpevolezza in ordine alla loro af#liazione all’organizzazione criminale». Tra i presenti spiccano alcuni nomi: Francesco D’Onofrio, lo stesso presente all’incontro con la Porchietto; Salvatore Demasi, detto Giorgio, capo locale di Leinì, sulla cui #gura ci soffermeremo diffusamente più avanti; e Gio-vanni Iaria, membro del locale di Cuorgné, imprenditore edile con un burrascoso passato po-litico, #gura fondamentale per comprendere la ma#a canavesana di ieri e di oggi.
Bertot, classe 1967, originario di Rivaro-lo, prende la parola per illustrare il suo programma elettorale, sof-fermandosi su questioni relative all’edilizia, che evidentemente sa essere l’argomento di mag-giore interesse dei convitati. Dopo essersi scusato per non parlare dialetto, né piemontese né calabrese, parla delle grandi opere che potrà favorire dallo scranno del Parlamento euro-peo («…sono convinto che il Piemonte abbia bisogno, come terra, di tutta una serie di opere, grosse… importanti…, pensiamo al collegamento con Genova per il porto, pensiamo all’Alta velo-cità…») sottolineando allo stesso tempo che manterrà la carica di sindaco e quindi continuerà a occuparsi direttamente del terri-torio. Chiede voti “porta a porta”, anche in Liguria, Valle D’Aosta e Lombardia (essendo candidato nel collegio del nord-ovest), tutti territori dove i convitati possono vantare numerose conoscenze.Bertot non è indagato, lo ribadia-mo. Il pranzo è stato organizza-
to dal suo segretario comunale, Antonino Battaglia, calabrese di capo Spartivento (Rc), che invece è stato arrestato con l’accusa di voto di scambio. Secondo quanto emerso dall’inchiesta, Battaglia, con un imprenditore di nome Giovanni Macrì, avrebbe favorito il contatto di Bertot con la rete dei calabresi, concordando il pa-gamento con Giovanni Catalano, all’insaputa di Bertot, di circa 20mila euro.Bertot all’uscita del suo nome sui giornali si è difeso affermando di «essere per carattere e per natu-ra quanto di più lontano esista da quel mondo. In campagna elettorale si incontrano molte persone ma nessuno mi ha mai fatto proposte ambigue né tanto meno le avrei considerate». Ber-tot, tra l’altro, non ottenne i voti sperati (surclassato da un pezzo da novanta come Vito Bonsigno-re, che lo seguiva in lista), e in diverse occasioni è stato intercet-tato mentre si lamenta del +op “della rete dei calabresi” descrit-ti come «millantatori in buona fede». In una telefonata Bertot sottolinea però di aver chiarito di non essere disponibile a “certi tipi di richieste” («sin dall’inizio ho detto... certi discorsi fateli con altri… non è il mio modo di fare politica»), facendo capire di aver presente il rischio insito nella frequentazione di certi eletto-ri. Tuttavia desta perplessità il fatto che il primo accordo con i “calabresi”, che porterà alla riunione con Catalano e gli altri, sia stato stretto con Giovanni Iaria, secondo i magistrati af#-liato al locale di Cuorgné, una storia politica, imprenditoriale e giudiziaria quarantennale alle spalle, una di quelle persone che chi governa il territorio non può permettersi di non conoscere.
Se la Porchietto, con la normale diligenza, poteva verosimilmente non sapere nulla di Giuseppe Catalano, l’ignoranza della perso-nalità di Giovanni Iaria nell’area del canavese implica un livello di diligenza molto al di sotto del minimo sindacale. Il che, sia ben inteso, non costituisce reato.
Giovanni Iaria è un volto noto alle cro-nache giornalistiche da diversi decenni. La sua storia è riportata anche in un paragrafo del volu-me Ma�e vecchie ma�e nuove
(Donzelli, 2009) del professore Rocco Sciarrone. Immigrato in Piemonte ancora minorenne da Condofuri (Rc) negli anni 60, Iaria arriva a Cuorgné come ap-prendista muratore, con tanta voglia di fare strada. In pochi anni mette su con il fratello maggiore Carmelo un’impresa edile che accoglie con particolare generosità pregiudicati calabre-si – usciti in semilibertà anche grazie alla richiesta diretta della sua azienda – e immigrati che lavorano in nero. Questa gestione del personale rende competitiva l’impresa, che diventa una delle più importanti del canavese. Iaria ha il controllo della manovalanza calabrese della zona, e questo lo pone in una posizione di vantag-gio sui concorrenti. Ma sarebbero diverse, in quegli anni, le ditte riconducibili allo spregiudicato imprenditore. Un episodio è utile per descrivere il temperamento della famiglia Iaria e il clima che si respira a Cuorgnè in quel periodo. Il 13 novembre 1976 tre individui tentano un furto nel cantiere sbagliato, quello dei fratelli di Condofuri. I tre vengo-no sorpresi, due fuggono, uno viene bloccato sotto la minaccia di un fucile. Giovanni quella

sera non è a Cuorgné, perciò il prigioniero viene portato a casa di Carmelo Iaria, dove viene pestato per fargli dire i nomi dei complici. Il ladro non parla e così lo portano in un campo. Il ladro capisce che lo vogliono fare fuori e tenta una fuga disperata. Si prende 3 colpi di pistola alla schiena, si salva perché si #nge morto, ma rimane paralizzato. Per quell’episodio Carmelo vie-ne condannato a nove anni di reclusione nel 1978. Ma è Iaria Giovanni, il fratello più piccolo, il capo. È balzato agli onori delle cronache dal 1975, quando viene sequestrato e ucciso a bastonate l’industria-le Mario Ceretto. Un imputato, Giovanni Caggegi, afferma che il mandante è proprio l’impren-ditore di Cuorgné. La moglie al processo ricorda come all’indo-mani del rapimento Iaria si sia presentato da lei offrendosi di acquistare alcune quote della società del marito, offerta ri#u-tata per la cattiva fama dell’im-prenditore. La responsabilità di Iaria nell’omicidio Ceretto non trovò ulteriori riscontri. I due si erano scontrati anche per motivi politici. Ceretto, liberale, aveva ri#utato di inserire Iaria nella sua lista elettorale, così dopo un litigio Iaria aveva spostato il suo pacchetto di voti (circa 500, afferma) sul partito socialista. Che lo accoglie a braccia aperte e lo fa assessore allo Sport e commercio, nella giunta di sinistra guidata dal sindaco comunista Bosone.
Fu l’inizio di una carriera con alti e bassi all’interno del partito, che si tra-scina #no agli anni 90. Nel 1979 Iaria è espulso dal Psi, ma non si dimette da assessore. Viene anche arrestato, lo stesso anno,
con l’accusa di truffa, bancarotta, falsi#cazione di libri contabili; i reati sarebbero stati commessi in relazione alla gestione assai opaca della «cooperativa Auro-ra» di Borgaro. Per quei fatti, fu arrestato (e poi assolto) anche un avvocato, tale Mario Borghezio, un giovane promettente che farà una folgorante carriera politica nella lega Nord. Questa vicenda tornò a galla nel 1992, quando era componente della commissione antima#a, ma lui si difese affer-mando di non aver avuto mai alcun contatto con Iaria. Negli anni Ottanta, Iaria trova il modo di farsi riammettere nel Psi. Troppo importanti, eviden-temente, i suoi voti, per stare dietro a una cattiva fama che non si traduceva mai in condanne pe-nali de#nitive. I vecchi militanti ancora ricordano con disappunto la carica di quei calabresi che in pochi anni fecero nel canavese un carriera fulminante, nonostan-te ci fosse chi, come il vecchio sindaco di Pont Canavese, Igino Balagna, denunciasse apertamen-te l’anomalia del gruppo di Iaria. Il suo peso politico e imprendi-toriale è corroborato dai buoni rapporti con il procuratore di Ivrea Luigi Moschella, ex pm antiterrorismo travolto poi da una serie di inchieste su rapporti impropri con la malavita. Il tem-peramento sanguigno è quello di sempre. Una sera, contrariato dal discorso pronunciato al consiglio comunale di Lanzo da Ivan Grotto (proconsole di Giusy La Ganga, ex deputato, craxiano di ferro, oggi membro del Pd), Iaria gli arriva da dietro e di fronte a tutti gli ri#la un sonoro ceffone.Nel 1989 il tribunale di sorve-glianza di Torino, presidente Vla-dimiro Zagrebelsky, lo sottopone alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale, con divie-to di soggiorno per tre anni in Piemonte e Valle D’Aosta. Sotto la lente dei giudici, le frequen-tazioni documentate dalle forze dell’ordine con boss calabresi del calibro di Francesco Mazzaferro (al battesimo della #glia in un albergo di Bardonecchia in cui erano presenti oltre 350 persone, Iaria portò ad esibirsi l’amico cantante Mino Reitano), Rocco lo Presti, Mario Mesiani Maz-zacuva (boss di Bova i cui affari si estendevano in Valle D’Aosta e nel Canavese), la sua attività nel racket dell’edilizia, ma anche attività speculative a Condofuri, in Calabria, suo paese natale. Im-barazzante, per un politico che al congresso del partito era indicato pochi mesi prima come membro del direttivo provinciale nonché vice segretario provinciale in pectore. Anche questo provvedi-mento giurisdizionale, tuttavia, avrà vita breve e dopo tre mesi sarà annullato dalla cassazione. Il 12 marzo 1990 viene segnalato dai carabinieri al Caffè Torino, in piazza San Carlo, con il capo corrente Psi Antonio Salerno, ex presidente di Atm, padre del deputato Gabriele, assieme a Gio-vanni Giampaolo, ex vicesindaco socialista di Ciriè (arrestato per un omicidio nel 1972 a San Luca, paese d’origine, e poi prosciolto, sotto osservazione da parte degli inquirenti per presunti legami con la cosca ’ndranghetista degli Strangio). È lui il dominus di Cuorgné. Quando nel 1991 don Aldo Salus-soglia, parroco di San Dalmazzo, denuncia apertamente che «a Cuorgnè si vive in un continuo stato di tensione. La ma#a qui c’è per davvero e non può che sconvolgere», tutti sanno che c’è lui al centro della ragnatela

denunciata dal sacerdote. Quan-do tangentopoli spazza via il suo partito, Iaria esce dai radar della politica e sceglie il pro#lo basso nella sua Cuorgné. Fino all’ope-razione Minotauro, che oltre allo “struscio” con Bertot, segnala un suo ruolo nell’affaire Coral, l’unico politico locale di peso #nito in manette l’8 giugno per concorso esterno in associazione ma#osa e voto di scambio.
Nevio Coral, quando entra in politica nel 1994 nelle #le di Forza Italia candidandosi alla poltrona di primo cittadino di Leinì, è un nome nuovo della politica locale. Originario di Gruaro (Ve), di umi-li origini, è un imprenditore che si è fatto da sé, a capo di un gruppo industriale attivo nel settore della depurazione e del trattamento dell’aria, dell’acqua e del rumore con base a Volpiano e sedi nel nord Italia, in Francia, Germania e Gran Bretagna. Il pro#lo ideale dell’uomo politico della seconda Repubblica. Leinì è una città di 15mila abitanti della seconda cintura torinese, nota come “la porta del Canavese”. Coral sarà il suo sindaco dal 1994 al 2005. Suo #glio Ivano, ingegnere, è l’attuale primo cittadino, succeduto al padre nel 2005. Leinì è dunque guidata ininterrottamente da un Coral da 17 anni. Alle ultime elezione amministrative Nevio si è candidato alla poltrona di primo cittadino di Volpiano, una cittadina con#nante, sede del centro direzionale della sua impresa. Insomma, voleva pren-dersi anche Volpiano, ma si è fermato al 33% dei voti. Un altro #glio, Claudio è imprenditore nel settore della ristorazione, marito dell’ex assessore regionale alla Sanità Caterina Ferrero, eletta
per la prima volta in regione a 27 anni nel 1995, travolta nel mese di maggio da una inchiesta sulla corruzione che l’ha portata agli arresti domiciliari. Il suo braccio destro, Piero Gambarino (in ma-nette nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione nella sanità dal 27 maggio), risulta socio di alcuni degli arrestati nell’operazione Mi-notauro, in particolare di Achille Berardi (ritenuto af#liato al loca-le di Cuorgné) e Valerio Ierardi (sospettato di appartenere alla cosiddetta Bastarda [vedi box p.55, ndr]).Ma che cosa c’entra questo im-prenditore di successo, origina-rio del nord est e felicemente cresciuto nel nord ovest, con la ma#a calabrese? Un politico che nel 2002, nel decennale della morte di Giovanni Falcone, de-dicava sentite parole di elogio per il magistrato, a cui nel 1999 l’amministrazione di Leinì ave-va intitolato il Palazzetto dello sport, con una cerimonia cui aveva presenziato – gli scherzi del destino – l’allora procurato-re capo di Palermo Gian Carlo Caselli. Gli vengono contestati fondamentalmente due fatti: la richiesta esplicita di voti a espo-nenti di rilievo della ’ndranghe-ta in cambio di denaro e altre utilità (appalti); l’aver concesso gli appalti di realizzazione del centro direzionale della Coral di Volpiano alle ditte degli stessi personaggi.
Partiamo dalla richiesta di voti. È il 18 maggio 2009. Coral è consigliere comu-nale a Leinì. Sono alle porte le elezioni provinciali, alle quali è candidato, per il Pdl, il #glio Iva-no, sindaco dal 2005. Gli investi-gatori intercettano una telefonata sul cellulare di Vincenzo Argirò,
originario di Locri, classe 1957, residente a Caselle. Secondo gli in-vestigatori Argirò fa parte del Cri-mine (la sovrastruttura composta da af#liati che possono decidere le azioni violente, cfr p.57, ndr), è uno ’ndranghetista di livello, fa parte della società maggiore con la dote di Quartino. Proprietario di un bar a Caselle torinese, ha la nomea del “ma#oso”. Almeno secondo quanto dichiarato da un imprenditore edile di Casel-le, Giorgio Vercelli, che aveva subìto alcune richieste di pizzo. Argirò è comunque un pluripre-giudicato, che si fa forza dei suoi precedenti penali per intimorire le proprie vittime. Dall’altra parte del telefono c’è Coral, il quale si rivolge in termini amichevo-li, quasi affettuosi, al presunto boss: «Bisogna proprio dire che gli amici si trovano sempre quando si va a casa di altri eh! (Coral si trova a casa di tale Emilio Gallo, che gli ha passato la telefonata)». L’incontro viene #ssato per il 20 maggio nel ristorante dell’albergo “Verdina” di Volpiano, di pro-prietà dell’altro #glio di Coral, Claudio. I Carabinieri si appo-stano e rilevano i partecipanti alla riunione pre elettorale: oltre a Nevio Coral e Vincenzo Argirò, i militari registrano la presenza di Vincenzo Todarello, Antonio Ruperto, Emilio Gallo, Eduardo Cataldo, Gioacchino Giudice, Massimiliano Lastella. Coral si ri-volge ai commensali chiamandoli “imprenditori”: «Credo che qui siamo tutti imprenditori, ognuno nella sua misura, non è vero che siamo dei disonesti, abbiamo solo bisogno di lavorare».
Ma chi sono gli “imprenditori” convocati da Argirò? Todarello, originario di Ardore (Rc), è un muratore im-

Era arrivata anche lì, all’ombra del tartufo e delle nocciole delle Langhe. Perché nella geogra#a delle ’ndrine in Piemonte non c’è solo Torino, il capoluogo. Ci sono anche Alba, Asti, Cu-neo, Alessandria, Novi Ligure. I tentacoli della mala calabrese si erano rami#cati in provincia. Con personaggi di spessore, affari tra-dizionali imbevuti nelle betoniere dell’edilizia, riti di af#liazione carichi di pathos criminale, legami con la politica (è stato arrestato il consigliere comunale di Alessan-dria Giuseppe “Peppe” Caridi). L’operazione Albachiara – che prende il nome da uno stralcio delle formule rituali trovate dai carabinieri durante le perquisi-zioni – ha svelato l’esistenza di due locali (di cui uno “atipico” declassato a Società Minore). Co-ordinate spaziali: Novi Ligure e
di Giuseppe Legato
Alba. A capo delle strutture c’erano Bruno Pronestì, discendente di quella famiglia che ha fatto la storia della mala di Orbassano, e Rocco Zangrà, camionista di Rizziconi, intimo del capo dei capi Domenico Oppedisano. Proprio Zangrà era #nito in manette durante l’operazione “Crimine”. Era luglio del 2010. Correvano voci che presto sarebbe successo qualcosa di grosso che avrebbe spazzato via quel campanilismo bieco che ha impedito a molti di accettare che la ’ndrangheta fosse nel tinello di casa propria e non solo nei paesi arram-picati sull’Aspromonte calabrese. Una sorta di Aspro-Piemonte, come intitolavamo in un articolo pubblicato nell’ottobre del 2007 di questa rivista. Con “Minotauro” e “Albachiara” il puzzle si compone. Ci sono altre 17 persone in carcere, l’organizzazione è stata disarticolata, ma il romanzo delle indagini spiega bene come la ’ndrangheta non sia un fenomeno disattento agli spazi di conquista, anche quelli, apparentemente meno appetibili rispetto ai grandi centri urbani. L’inizio di questa storia di ’ndrine di periferia lo registrano i carabinieri di Reggio Calabria in un agrumeto di Rosarno – piana di Gioia Tauro – dove vive Domenico Oppedisano, il “grande vecchio”, #gura apicale della ’ndrangheta nel mondo. È il 30 agosto 2009. Sette giorni dopo, a Polsi, si sarebbe svolta la rituale riunione dei capi di tutti i locali calabresi e non. Si sarebbero decise strategie, nuove aperture, in-vestimenti e – soprattutto – le cariche. Le “ambientali” piazzate dai militari del Ros registrano il rumore di un’auto che parcheggia. Ci sono ospiti. Sono Rocco Zangrà e Michele Gariuolo. Si sono fatti 1.300 km per arrivare #n qui da Alba, paradiso dell’economia, imbevuto di grandi vini e pezzi da Novanta dell’economia. Don Mico li accoglie, si siedono fuori attorno a un tavolaccio di legno. Zangrà appar-tiene al locale di Novi Ligure a capo del quale c’è Bruno Pronestì. Vuole aprirne uno per fatti suoi e – davanti al sommo – tira fuori un romanzo
strappalacrime per ottenere l’autoriz-zazione. La motivazione è #n troppo banale per essere l’unica credibile: «Ci vogliono 100 km per andare alle riu-nioni, eppure siamo un certo numero di persone. Non possiamo fare per conto nostro?». Oppedisano ascolta e annuisce: «È giusto. Se per portare un pezzo di pane alla famiglia ogni mese vi restano in tasca 100 euro di benzina è meglio. Loro non si possono opporre, al massimo i mandamenti. Comunque fra pochi giorni io salgo a Polsi, venite pure voi e vediamo come fare». Loro sono quelli che fanno capo a Bruno Pronestì che non ne vuole sapere di dividere la torta con Zangrà. Purtroppo don Mico non è dalla sua parte: «Bruno non si deve arrabbiare», dice, e batte il pugno sul tavolo quasi come un timbro che suggella la decisione. Così nasce il “localino” di Alba. Zangrà è riuscito nel suo intento e – forse – si prepara a in#larsi negli appalti che di lì a poco, rivoluzioneranno le autostrade del Roero. Eccolo – con una certa ragio-nevolezza – il motivo più autentico di tanta fretta. Nella nuova struttura convergeranno gli af#liati di Alba e di Asti, gli altri resteranno sotto l’egida di Pronestì nel locale di Novi. In questo spaccato di ’ndrine distaccate non poteva mancare la politica. Ad Alessandria è #nito in manette Giu-seppe Caridi per gli amici “compare Peppe”. Nato a Taurianova 54 anni fa, titolare di un calzaturi#cio in via San Pio V ad Alessandria (da qui il nomignolo di “u scarparu” ricorrente nelle intercettazioni”) rappresenta un caso quasi unico di giurisprudenza. È considerato infatti af#liato alla ’ndran-gheta col grado di picciotto. “Non gli si contesta dunque il classico concorso esterno in associazione ma#osa. Lui è proprio organico”, dice il procuratore Gian Carlo Caselli. Peppe è stato battezzato il 28 febbraio 2010 a casa sua. In quell’occasione sono state distribuite anche le doti di santista ad altri componenti, Caridi si accontentò della “ginestra” (prima dote). Il suo ingresso nell’onorata società è uno strappo all’ordinamento delle ’ndrine
che non consentono a un politico di appartenere uf#cialmente alla grande famiglia. «Per Peppe abbiamo fatto un’eccezione, è un bravo amico, si è voluto chiudere un occhio, sappiamo che è un cristiano che si comporta bene. Se è un buono cristiano, in un locale, un politico ci fa comodo» dirà Domenico Gangemi, #gura apicale delle ’ndrine liguri, a un interlocu-tore rimasto sconosciuto che replica come un politico di razza: «L’Italia è cambiata, anche noi dobbiamo fare le riforme». Per la cronaca: al tempo, in Comune, “u scarparu” rivestiva il ruolo di presidente della commissione territorio. Eletto nel 2007 nelle #le del Pdl era, allo stato dell’arresto, segretario amministrativo del partito “Alleanza Democratica”. Caridi è una #gura centrale di questa storia. E non bisogna farsi ingannare dal suo livello di “picciotto liscio”. Scrive il gip: «La posizione del Caridi va ben al di là del suo ruolo, rappresentando la presenza della ’ndrangheta nel consiglio comunale di Alessandria. Sebbene, quindi, costui, più per il suo ruolo, che lo pone nei gradini più bassi della gerarchia ’ndranghe-tista, che per un’effettiva volontà di mantenere un pro#lo più distaccato, non abbia partecipato in prima per-sona alle riunioni e alla vita fattiva dell’organizzazione, Tuttavia, per il ruolo ricoperto nella società civile asservito al mandato conferitogli alla volontà criminale della ’ndrangheta, rappresenta più di altri un concreto pericolo per la libertà e la democra-zia». Tra i molti brogliacci dei riti di af#liazione recuperati dai carabinieri c’è un foglio bianco stropicciato che ha attirato più di altri, la curiosità degli investigatori. C’è scritto: «Fio-ri da prendere» e «Fiori mandati a casa». In mezzo una linea di cesura. Sembrano elenchi di nomi ed esercizi commerciali corredati da cifre, ma potrebbero anche essere ordinativi per un funerale. “Ci mandamu i #uri a la casa” è una tipica frase calabrese utilizzata in occasione di lutti a cui la ’ndrangheta deve partecipare. La procura indaga.

plicato, secondo i magistrati, in alcuni traf#ci di stupefacenti, ed è considerato un uomo di #ducia di Argirò. Come Antonio Ruperto, altro personaggio ritenuto dai cara-binieri dedito al traf#co di stupefa-centi. Emilio Gallo, l’organizzatore dell’incontro tra Argirò e Coral, ha precedenti di polizia per reati inerenti agli stupefacenti. Eduardo Cataldo, di Locri, residente a To-rino, vanta precedenti di polizia e penali per porto abusivo di armi, ricettazione, favoreggiamento per-sonale, rapina, estorsione, minacce, lesioni personali, violazione della legge sugli stupefacenti e falsi in genere, esponente a Torino della ’ndrina Cataldo di Locri. Gioachino Giudice, originario di Canicattì (Ag), residente a Borgaro Torinese, ha precedenti di polizia e penali per violazione della legge sugli stu-pefacenti. Massimiliano Lastella, nato a Torino nel 1976, residente a Borgaro Torinese, con precedenti di polizia e penali per minacce, lesioni personali e rissa. Ruperto sottolinea, rivolgendosi a Coral: «Dottore, le posso garan-tire che tavolate come queste ce ne sono veramente poche! Per le persone che sono sedute a questo tavolo… per la serietà delle persone. Perché tavolate se ne possono fare tantissime... ma non con le persone che ci sono a questo tavolo…». E Coral con-ferma: «Non ho dubbi… non ho dubbi…». E aggiunge: «Secondo me questo è già un miracolo… che abbiamo una tavolata di persone per bene». Dalle inter-cettazioni si evince chiaramente lo scopo della serata: gli uomini portati da Argirò garantiranno voti nelle zone di Leinì, Volpiano e Borgaro Torinese. In cambio Coral prospetta lavoro. «Quan-do le strade si fanno, i lavori si fanno, gli appalti vanno avanti …
(inc)…, le cose si fanno, allora se questo principio lo adottiamo... su un gruppo che... e innanzitutto prendiamo uno lo mettiamo in Comune, l’altro lo mettiamo nel consiglio, l’altro lo mettiamo in una proloco, l’altro lo mettiamo in tutta altra cosa, magari arri-viamo che ci ritroviamo persone nostre che... (sembra dica: non ce le facciamo togliere dagli altri)... e diventiamo un gruppo forte». Una frase normale all’interno di qualunque sezione di partito in qualunque città d’Italia, dalla rossa Emilia al bianco Veneto. Ma che assume connotati del tutto particolari se si considera la platea a cui era rivolta. Lui per gli astanti è “il sindaco”, il vero punto di riferimento sul territorio in forza della sua esperienza e del suo prestigio. Il #glio brilla di luce ri+essa. I calabresi lo votano perché sanno che dietro c’è il padre. E Coral fa capire quanto ci tiene all’appoggio dei calabresi quando esclama: «La comunità dei calabresi è la nostra ricchezza».
Ma la ’ndrangheta non si ac-contenta di promesse, esige un ritorno immediato per il proprio impegno elettorale. Gli ’ndran-ghetisti sono persone concrete, il futuro è nelle mani di Giove. E come accaduto in relazione alla campagna elettorale di Bertot, anche in questo caso l’appoggio elettorale pare avere un prezzo. Dalle intercettazioni risulta, nei giorni successivi alla cena pre-elettorale, una dazione di denaro di 24mila euro da parte di Coral a favore degli uomini di Argirò. Una cifra che appare inverosimile imputare alla remunerazione dell’attività di volantinaggio pre-elettorale concordata durante la
riunione al ristorante. Il costo di distribuzione di 20mila volantini da parte di una società specializ-zata (abbiamo controllato) è di circa 800 euro più Iva. I rapporti di Coral registrati dai magistrati della Dda di Torino con uomini legati alla ’ndran-gheta vanno ben oltre la cena incriminata. È lo stesso Argirò, la sera del 20 maggio 2009, a fare riferimento a pregressi rapporti risalenti all’epoca della sindaca-tura di Coral padre: «... dottore, noi siamo qua e siamo felici di esserlo perché ...(parole inc)... e da chi sono andato, sanno che noi siamo qua con voi e saremo felici come lo siamo stati ... anni fa ... se voi vi ricordate bene ...».In una intercettazione che coin-volge il capo locale di Cuorgné Bruno Iaria, risulta poi evidente il rapporto tra Coral e Giovanni Ia-ria. Bruno Iaria afferma in una in-tercettazione dell’aprile 2009 che lo zio Giovanni avrebbe ottenuto da Coral degli appalti in cambio del sostegno elettorale del clan. Un accordo che avrebbe evitato a Coral di pagare “3-400mila euro” di pizzo, e che avrebbe consen-tito al gruppo, secondo quanto affermato da Iaria, di spendere presso le banche il nome di Coral come committente – «il nostro biglietto da visita» – dandogli maggiore credibilità. Da altre intercettazioni si evin-ce come Coral abbia nel tempo intrattenuto rapporti con diver-se famiglie mafiose. Giuseppe Gioffrè, capo del locale di Natile di Careri a Torino #no al 29 di-cembre 2008, giorno in cui vie-ne assassinato a Locri (cfr p. 52, ndr), avrebbe per anni tenuto la “guardianìa” dei cantieri di Coral in cambio di denaro. Un’impresa riconducibile a Gioffré, la “Misiti Antonio”, avrebbe avuto sede in

un capannone di Coral senza pa-gare il canone di locazione. I suoi cantieri hanno fatto gola a diverse famiglie, dagli Iaria di Cuorgné agli Zucco di Natile di Careri, e lui ha cercato di non scontentare nessu-no, senza mai denunciare, anzi, come si legge nelle carte del Gip, mostrandosi ben disposto verso gli ’ndranghetisti, che avrebbero lavorato alla costruzione della nuova sede di Volpiano della Coral spa e all’edi#cio produttivo della Altari srl di Leinì. A Bruno Iaria, inoltre, avrebbe fatto pervenire del denaro mentre si trovava in carcere. Gli uomini della ma#a lo consideravano il loro “giocattolo”, una macchina da soldi, e lui, si serviva di loro, secondo l’ipotesi investigativa, per avere la comu-nità calabrese dalla sua parte al momento opportuno.
Ma se il canavese piange, gli altri territori della cintura non ridono. A Rivoli è stato arrestato Salvatore Demasi, classe 1944, imprenditore edile originario di Martone (Rc) con il vezzo di farsi chiamare Giorgio. Sarebbe lui il capo locale di Rivoli, anche se il suo ruolo sarebbe stato messo in discussione negli ultimi anni, in seguito ad alcuni problemi seri di salute. Il suo nome compare moltissime volte nell’inchiesta Mi-notauro, riprova del ruolo apicale rivestito nell’organizzazione. Ma il suo nome rileva soprattutto per i numerosi contatti registrati dagli investigatori con esponenti politici di centrosinistra, che si rivolgevano a lui per la capacità di pescare voti nel mare magnum della comunità calabrese. Gli episodi, che risalgono al gennaio/febbraio di quest’anno, sono tre: la richiesta telefonica di voti, intercettata lo scorso febbraio, da parte dell’onorevole Mimmo Lucà (Pd) a Demasi in favore di
Piero Fassino, impegnato nelle primarie per la scelta del candidato sindaco; gli incontri tra Demasi e Antonino Boeti, consigliere regio-nale del Pd, ex sindaco di Rivoli dal 1995 al 2004, prima a casa di Boeti e poi in un bar di Alpignano, a cui ha partecipato anche Carmelo Tromby, assessore dell’Italia dei Valori al comune di Alpignano. E in#ne l’incontro tra Demasi e l’on. Gaetano Porcino, deputato dell’Idv e consigliere comunale a Torino, in un bar del capoluogo. Per quanto riguarda gli incontri che vedono coinvolti Porcino, Tromby e Boeti non esistono intercettazioni che ne rivelino, almeno in parte, il contenuto. Tutti i protagonisti hanno recisamente negato di aver la minima coscienza della cara-tura criminale del Demasi. Boeti, medico originario di Taurianova (Rc), ha ammesso di conoscerlo da oltre 30 anni, di essere suo amico, e tuttavia di non aver mai avuto la minima percezione dei suoi lega-mi con la ma#a. Con Lucà, Boeti ha partecipato, pochi giorni dopo l’uscita sui giornali delle notizie che hanno sconcertato la base del partito, a due incontri pubblici, a Rivalta Torinese e a Rivoli, nei quali i due politici hanno spiegato le loro ragioni e manifestato la loro assoluta estraneità a qualunque tipo di vicinanza con ambienti ma#osi. Il partito democratico ha dimo-strato solidarietà a tutti i livelli, dalle sezioni locali, passando per gli ex sindaci di Torino Castellani e Chiamparino, #no al segretario Bersani. Anche se, per la verità, qualche mugugno a microfono spento lo abbiamo registrato tra diversi esponenti locali. Perché questa lettura dei fatti fondata sulla totale inconsapevolezza dei protagonisti, in particolare Boeti e Lucà, politici calabresi di lungo corso, è dura da digerire da una
base che, ai propri avversari, nella stessa situazione non avrebbe fatto sconti.
Ma chi è Salvatore “Giorgio” Demasi”? Un calabrese arrivato negli anni 60, muratore, che con i fratelli è riuscito a mettere su l’impresa di famiglia e a diven-tare un imprenditore affermato. Frequentava il circolo culturale dei calabresi locali, il “Sestante”, e da quella frequentazione sarebbe nata l’amicizia con Nino Boeti. Demasi aveva la fama del gran-de collettore di voti. «Lo ricordo nei primi anni 90, sotto elezioni, con una serie di fogli protocollo, compilati con un elenco #tto di nomi: le persone da contattare per chiedere voti, a uno a uno», dice un politico di lungo corso del Pd che chiede l’anonimato. «Una persona gentile, di una cordialità estrema, che salutava sempre per prima. Sempre vestito con cura, giacca e cravatta». Che come costruttore si è fatto una buona reputazione. Le sue case costano, ma sono ri-#nite con cura. La sua villa sulla collina di Rivoli è di pregio ma non particolarmente vistosa. Unica concessione al kitsch, due statuette di leoni a presidiare il cancello di ingresso. A Rivoli non ha ottenu-to appalti pubblici, ha lavorato nell’edilizia privata, interventi a macchia di leopardo mai invasivi o deturpanti. Niente a che vedere con certi grandi costruttori inseguiti dalla fama di speculatori. Ma al di là di questo pro#lo ri-servato, qualche brutta voce su di lui circolava negli ambienti politici rivolesi. Si dice che fosse in grado di muovere #no a 800 preferenze, ma chi può dirlo con esattezza. Quel che è certo è che in molti bussavano alla sua porta, in particolare a sinistra. Perché il

presunto boss non ha mai portato acqua al mulino del centro destra, neanche dopo la diaspora del Psi, che ha portato in Forza Italia parte dell’elettorato del Garofano. La sua in+uenza si estendeva a Tori-no e a varie città dell’hinterland, come dimostra l’interessamento, documentato in Minotauro, per il candidato sindaco di Ciriè, Fran-cesco Brizio. In ogni realtà poteva decidere di appoggiare candidati di correnti diverse, in base a logiche non facilmente intelligibili. Quel che è certo è che era un punto di riferimento sotto elezioni e che in molti si sono rivolti a “Giorgio” nel corso degli anni. Lui però non si è mai visto in un circolo politico, non si è mai visto alle feste di partito, e neanche ai festeggiamenti post elettorali. Ma come faceva una persona così normale a muovere tanti voti? Mistero. O forse no, se non si vuole mettere a tacere del tutto il buon senso.
L’unico dia-logo registrato dagli inquirenti è quello tra Demasi e Lucà. E me-rita di essere riportato in alcune battute. Mimmo Lucà, originario di Gioiosa ionica ma trapiantato a Torino giovanissimo, si rivolge al “rivolese” Demasi per chiedere voti alle elezioni primarie del Pd di Torino. Agli atti ci sono due telefonate. La prima, qualche gior-no prima delle elezioni. È Lucà a chiamare e dopo i convenevoli di rito chiede esplicitamente un aiuto tra gli amici di Giorgio: «Se magari hai qualche amico a Torino, cui passare la voce…».Demasi: «Certo! Certo che ne ho!…” e poi “ne ho più di uno grazie a Dio, quindi…».Lucà: «... prova a sentire che aria tira…».Demasi: «sì… sì… e facciamo …facciamo, diciamo, questi che cono-
sciamo facciamo votare Fassino… 1375».E poi la frase poco evidenziata dai media, ma che ha fatto storcere il naso a più di un calabrese vicino al partito.Lucà: «.. e poi io… subito dopo io e te ci vediamo a bere un caffè… magari così…».Demasi: « quando vuoi… quando vuoi… con piacere…».Lucà: «... facciamo una chiacchie-rata…».Demasi: «quando vuoi… sono a tua disposizione».Lucà: «un abbraccione».La telefonata sembra chiusa ma Demasi, riprende il discorso e dopo aver sottolineato di aver già iniziato a fare campagna per Fas-sino per conto suo trova lo spazio per ribadire l’appuntamento del caffè: «...ciao.. sempre un piacere sentirti… ci sentiamo questi giorni, prendiamo un caffè…». Ecco, nel signi#cato di quel caffè e di quella chiacchierata a quattr’occhi – ir-rilevante, lo sottolineiamo, per i magistrati – si innesta la radice del mugugno di quei militanti di-sposti a mettere la mano sul fuoco sull’assenza di legami penalmente rilevanti tra la criminalità calabrese e il loro deputato, ma che sarebbero più incerti se la posta in gioco fosse l’assoluta mancanza di percezione da parte di Lucà di qualunque for-ma di ambiguità nell’interlocutore Demasi. La seconda telefonata risale al giorno delle elezioni primarie, quando Demasi richiama Lucà, informandolo che anche gli uomini di Davide Gariglio, avversario di Fassino, si sono «mossi bene» con i calabresi. A dimostrazione che anche qualcuno dell’entourage di Gariglio aveva avuto l’idea di andare a pescare nello stesso am-bito bacino a cui, tramite Demasi, voleva arrivare Lucà.
A Chi-vasso alle ultime elezioni ammini-strative è stato scon#tto il sindaco uscente del Pdl Bruno Matola dal candidato di centrosinistra Gianni De Mori. Decisiva per la vittoria l’al-leanza con l’Udc. Peccato che con l’inchiesta Minotauro si è scoperto che Bruno Tron#o, coordinatore della campagna elettorale e vicese-gretario dell’Udc locale, sia il #glio del presunto capolocale di Chivas-so Pasquale Tron#o, imprenditore edile con solo un precedente per ricettazione. Padre e #glio sono #niti in manette l’8 giugno e adesso gravi interrogativi pesano sulla nuova giunta. Che ruolo hanno avuto i voti calabresi controllati dal-la ma#a nelle elezioni? Domande che ci si è posti a Volpiano, dove se avesse vinto Nevio Coral, ora il comune sarebbe commissariato. E che ci si pone da tempo in diverse altre realtà della cintura. Come Moncalieri, la più popolosa città della provincia torinese, che è stata toccata dall’inchiesta Minotauro solo a livello di ma#a militare. Nell’autunno del 2009, sull’onda delle denunce del deputato Stefano Esposito e del senatore Giuseppe Lumia, che richiamavano all’atten-zione della Commissione antima#a un presunto “caso Moncalieri”, facemmo una ricognizione della situazione locale. Registrammo lo stesso malessere che l’inchiesta Minotauro ha riscontrato in altri paesi dell’hinterland. Nel 2008 Giuseppe Artuffo, assessore di Ri-fondazione comunista nella giunta Ferrero, si era dimesso denun-ciando la presenza di una “lobby calabrese” in grado di condizionare l’amministrazione locale: «Qual-siasi cosa succeda, loro prendono sempre gli stessi voti. Hanno una capacità di controllo del consenso spaventosa». E ancora: «Ci sono lobby e interessi che s#orano il

concetto di in#ltrazione». Per tali affermazioni fu querelato dagli ex colleghi di giunta Rocco Cuzzilla e Vincenzo Quattrocchi (deceduto ad aprile) e lo scorso 11 maggio è stato rinviato a giudizio per diffa-mazione. Artuffo aveva toccato un argomento tabù, con#nato #no ad allora nei sussurri di strada. Dopo di lui altri parlarono. Un ex consigliere di An raccontò a «La Stampa» l’offerta ricevuta da un “piazzista” per l’acquisto di 200 voti della zona di corso Trieste (ad alta densità demogra#ca di origine calabrese). E don Ruggero Marini rese pubblica la confessione di un elettore che si vergognava di aver venduto il proprio voto per pochi euro. Il sacerdote denunciò anche la presenza di persone “arrivate da fuori” per organizzare il consenso in città alle elezioni del 2007, sot-tolineando che la ’ndrangheta era entrata «nelle sfere economiche della città. E in quelle politiche».
Come giu-dicare allora i politici che nel loro percorso incocciano nella richiesta di voti alla ’ndrangheta? Cavarsela con una sospensione del giudizio in attesa della conclusione del procedimento penale è un lus-so che una società pesantemen-te compromessa sotto il pro#lo dell’inquinamento ma#oso non può più concedersi. La delega alla magistratura delle questioni morali e politiche, come dimostra la storia recente da tangentopoli in poi, non funziona. Altrettanto improduttiva l’opzione opposta, lo sparo ad alzo zero nei confronti di tutti coloro che si trovano a stringere mani sbagliate trascinandoli nel gorgo di una responsabilità “oggettiva” incapace di distinguere e per questo intrinsecamente ingiusta. Un conto è incontrare occasionalmente per-sone sbagliate, un altro è chiedere
voti e promettere favori. In questo caso approfondire la natura del rapporto è un obbligo.Tutto dipende, ovviamente, dal gra-do di coscienza con cui il politico si rapporta alle cosche. Pensiamo, per chiarire il ragionamento, a un incidente stradale. L’automobilista che volontariamente (dolosamente, in termini giuridici) investe un pedone, risponde di omicidio vo-lontario. Così il politico che volon-tariamente si rivolge alla ma#a per chiedere voti, cosciente della sua capacità di condizionare l’elettora-to, e in cambio promette vantaggi, può rispondere a seconda dei casi di voto di scambio, concorso ester-no etc. Ma risponde di omicidio volontario anche l’automobilista che va ai 100 all’ora in un vicolo dove il limite è dei 30 e che, pur cosciente del pericolo che possa attraversare la strada improvvi-samente un pedone, continui a correre, accettando il rischio che per la sua folle corsa qualcuno possa morire. Per la legge, se av-viene l’incidente, l’automobilista risponde di nuovo a titolo di omi-cidio volontario (la dottrina parla di “dolo eventuale”). Allo stesso modo potrebbe essere imputabile per reati di ma#a il politico che si rivolge a personaggi fortemente am-bigui e pesantemente chiacchierati per ottenere voti, cosciente che il loro potere di condizionamento possa derivare da rapporti con la criminalità, e accettando il rischio di diventare loro debitore.Ma se l’autista che corre ai 100 all’ora nel vicolo con il limite dei 30 è convinto di essere in grado, per le sue doti di pilota, di evitare un eventuale ostacolo, dunque è convinto che non morirà alcun pedone per la sua guida sperico-lata, allora in caso di incidente non risponde più per omicidio volontario, ma per colpa (la con-
dizione di chi commette un fatto per imprudenza o imperizia). Nel caso descritto, la dottrina parle-rebbe, per l’esattezza, di “colpa cosciente”. Potrebbe essere il caso del politico che intuisca qualcosa di anomalo nell’abnorme capa-cità di convogliare voti di certi personaggi, ma che tuttavia non ritenga conveniente approfondire la questione, perché convinto che non sia suo compito (“sono un politico, non un poliziotto”) e per non rinunciare ai vantaggi di un rapporto che, non essendo espli-citato nella sua reale natura, non potrà mai essergli rimproverato. Per questa condotta nessun politi-co verrà mai condannato in tribu-nale, visto che non si risponde per reati di ma#a a titolo di colpa. Ma tale condotta, lasciando aperto un canale di dialogo – anche se impli-cito – tra ma#a e partiti, costituisce il cuore di quella responsabilità politica da più parti auspicata come strumento di prevenzione interna volta a prevenire l’inter-vento della magistratura. Rimane in#ne, oltre alla colpa “co-sciente”, quella “incosciente”, o colpa tout court. Siamo nel campo dell’imprudenza e dell’imperizia in buona fede assoluta, quella cui si aggrappa la maggior parte dei politici rimasti imbrigliati nell’in-chiesta Minotauro. Il politico che non ha capito, non sapeva, che non ha mai sospettato nulla. Può capitare, per carità, a tutti è giusto concedere il bene#cio del dubbio nel nome della presunzione di non colpevolezza. Ma se la col-pa cosciente con#na con il dolo eventuale, l’“incoscienza” assoluta con#na con la sprovvedutezza e la semplicioneria. Peccati capitali per chi ambisce a occuparsi della cosa pubblica. E chi ne risultasse affetto farebbe forse bene a trarne le dovute conseguenze.

Tutti i più importanti ’ndranghetisti operanti in Piemonte hanno interessi diretti o indiretti nel mondo dell’edilizia. Un esercito di “imprenditori” controlla il territorio e in forza dei rapporti instaurati con le amministrazioni locali, imper-versa negli appalti pubblici e privati. A discapito delle imprese estranee alla ma#a
di M. Neb.
Francesco è un imprenditore edile di origine napoletana che da alcuni anni lavora nella cin-tura sud di Torino. È specializ-zato nella ristrutturazione e nel frazionamento di vecchi casci-nali. Ha lasciato Napoli con suo padre perché non voleva pagare il pizzo. In Piemonte afferma di non essere mai stato avvicinato da uomini della ma#a, «forse per le piccole dimensioni della mia impresa. Se capitasse, un minu-to dopo sarei dai carabinieri». Però sa bene che il pizzo si paga anche qui. «Qualche settimana fa ho incrociato per strada un muratore calabrese, che abita dalle mie parti e con cui ogni tanto scambio due parole. Era da tempo che non lo vedevo, supponevo fosse tornato in Ca-labria o fosse via per lavoro. Ci siamo salutati, e per prima cosa mi ha chiesto come girano gli affari. Io gli ho risposto che il momento non è facile, ’ste case non si vendono. Quando gli ho chiesto come andassero le cose
per lui mi ha risposto: “Io non lavoro, vado a riscuotere…”. Lo ha detto guardandomi #sso negli occhi, in modo strano, non si capiva se dicesse sul serio o scherzasse, come per saggiare la mia reazione. Mi è venuto spontaneo rispondergli in dia-letto napoletano “se vieni da me ti spezzo le gambe”. L’ho detto ridendo, e lui pure ha sorriso. Ma la cosa non mi è piaciuta. A mio padre non ho detto niente, se no gli viene un infarto».
Che vadano a “riscuotere” per il servizio di guardianìa (la pro-tezione imposta ai cantieri), che lavorino direttamente con im-prese regolarmente intestate, che operino attraverso prestanome, per i ma#osi l’edilizia mantiene una forza di attrazione irresisti-bile. L’operazione Minotauro non fa altro che confermare la vitalità della tradizione, che in Piemonte non fa eccezione. Impressiona vedere come tutti i
boss coinvolti abbiano interessi rilevanti, diretti o indiretti, nel settore edile – «il vero centro di interesse dell’organizzazione operante a Torino e provincia», secondo il Gip che ha ordinato gli oltre 150 arresti dello scorso 8 giugno – o in quelli satel-liti dell’impiantistica e della carpenteria. Il motivo è presto detto: per fare l’imprenditore edile non ci sono barriere all’in-gresso, non ci vogliono titoli di studio né certi#cati penali puliti, chiunque può aprire una partita Iva e iniziare l’attività, senza dover dimostrare di essere in grado di tirare su un muro. L’ambiente ideale per dare la-voro a picciotti senza arte né parte, per fare un po’ di soldi o semplicemente per farli girare, riciclando i proventi di attività illecite. Edilizia, poi, signi#ca gestione e controllo del territorio, musica per le orecchie dei boss, che hanno nella capacità di tesse-re rapporti con la politica e la

pubblica amministrazione la radice del proprio successo. Rapporti fondamentali non solo in relazione all’aggiudicazione di appalti pubblici, ma anche nel campo dell’edilizia priva-ta, dove brulicano le impre-se criminali più piccole. Uno spesso cordone ombelicale le lega alle amministrazioni locali per l’ottenimento dei permessi, i cambi di destinazione d’uso, le varianti ai piani regolatori e così via. Per non parlare dei controlli nei cantieri, che con le conoscenze giuste si possono del tutto disinnescare. Come registrato dagli investigatori in relazione alla ditta di Domenico Racco (presunto af#liato al lo-cale di Cuorgné con il grado di “Trequartino”), che nel 2007, in seguito alla denuncia del geome-tra Flavio Novaria, ha subìto un controllo in cantiere a Cuorgné (To) da parte di carabinieri. Dalle intercettazioni è risultato che il maresciallo del Nucleo ispetto-rato del lavoro, Massimo Pizzuti, avendo riscontrato la presenza di un lavoratore in nero, avreb-be suggerito al commercialista dei Racco una “via d’uscita”: l’assunzione immediata per
via telematica, concedendo il tempo per istruire la pratica ed evitare la denuncia. Allo stesso modo, da ulteriori conversazioni è emerso il rapporto dei Racco con un medico dell’Asl, con il quale si concordavano tempi e modi del sopralluogo, rendendo del tutto #ttizio il controllo in cantiere. Com’è facile immagi-nare, il geometra che si è per-messo di sporgere denuncia è stato malmenato e pesantemente minacciato di morte, facendogli passare la voglia di rivolgersi alle autorità. Come avviene nella più classica tradizione delle storie di ma#a.
Decine di imprese ma#ose, dunque, operano quotidianamente nelle nostre città. Ma quali sono le loro caratteristiche? Un pro-totipo d’impresa ma#osa non esiste. L’edilizia è un mondo ete-rogeneo che spazia dalle grandi opere pubbliche sul modello Tav ai modesti interventi privati di ristrutturazione residenziale. La ’ndrangheta non butta via nulla. E le imprese ma#ose si adeguano alla fetta di torta cui ambiscono. Ci sono imprese piccole o piccolissime che lavorano esclusivamente nel settore privato, che abbattono i costi sfruttando manovalanza in nero, come nel caso della ditta Racco. Queste imprese presentano preventivi compe-titivi, non emettono fattura per i lavori eseguiti o lo fanno per importi inferiori al reale costo della prestazione, garantendo ai committenti privati l’evasione dell’Iva. A questo livello è facile che emerga il dna ma#oso dei titolari, che non disdegnano l’uso della violenza nei con-fronti di eventuali concorren-
ti e degli stessi committenti in caso di dispute sul prezzo. Come dimostra il caso Novaria, meglio non aprire contenziosi con costoro. Le imprese che intendono inve-ce partecipare agli appalti o su-bappalti pubblici, non possono permettersi livelli di illegalità palesi: le norme sul contratto pubblico le escluderebbero a priori. In quelle imprese i lavora-tori sono infatti assunti in regola. «Certo, a volte ci provano, e qualche lavoratore in nero, nel mucchio, lo in#lano – afferma Antonio Castaldo segretario provinciale della Filca-Cisl –. Se il lavoratore si lamenta degli straordinari non corrisposti o dei ritardi nei pagamenti ci può scappare la pistola sul tavolo, di fronte alla quale il lavoratore rinuncia ai suoi diritti. Ma se la vertenza arriva a livello sin-dacale, l’imprenditore-ma#oso paga di buon grado quanto do-vuto e mette tutto a tacere. Il loro interesse non è sollevare polveroni, ma essere in rego-la. Con il sindacato evitano lo scontro, e, una volta pagati, i lavoratori perdono interesse a portare avanti le denunce». I lavoratori sanno che qualcosa non torna e che al sindacato i segnali non mancano. «Hanno una bassissima con+ittualità in cantiere – conferma Dario Boni, segretario provinciale del-la Fillea-Cgil –. Non sono ostili al sindacato, come si potrebbe immaginare ragionando per ste-reotipi. Al contrario, cercano di essere in regola anche sotto il pro#lo della sicurezza». Eppure ci sono elementi che le rendono riconoscibili dalle altre. «Le voci girano, quando abbiamo a che fare con certi impresari ci ren-diamo conto istintivamente di

avere a che fare con persone per lo meno sospette. Nonostante la crisi economica, il modo di lavorare lo trovano sempre. Oggi operano in una città, ma sanno già che tra sei mesi lavoreranno altrove, anche se uf#cialmente non è stata neanche indetta la gara d’appalto». È la marcia in più dell’impresa ma#osa. Oltre alla disponibilità di capitali di origine illecita che le affran-ca dalle secche del rubinetto creditizio, i contatti politici garantiscono informazioni in esclusiva e corsie preferenziali sui cantieri pubblici. Mentre le imprese pulite sono in crisi, strozzate dalle banche e dai ritardi dei pagamenti degli enti pubblici (che giungono in casi estremi a 200 giorni) stretti dai vincoli del patto di stabilità, le imprese della ma#a prosperano e possono permettersi di inter-venire in aiuto delle imprese in dif#coltà. «Se le comprano – afferma Boni –, per intero o acquistano semplici rami di azienda, con i relativi certi#cati Soa (necessari per comprovare la capacità dell’impresa a par-tecipare ad appalti pubblici con importo a base d’asta superiore a 150mila euro, nda). In questo modo concorrono a gare cui altrimenti non potrebbero am-bire. E così espandono la loro capacità di in#ltrazione senza che nessuno se ne accorga».
Ma cosa avviene sui grandi appalti, in particolare sulle grandi opere che tutti immaginiamo obiettivo delle organizzazioni criminali, ma che poi dif#cilmente vengono colte sul fatto nonostante i con-trolli serratissimi? Un ex alto dirigente della Co.ge.fa, società
leader nella realizzazione di grandi opere che ha realizzato tratti dell’Alta Velocità Torino-Milano e della metropolitana di Torino, ha accettato una dialogo con «Narcoma#e» solo con la garanzia dell’assoluto anoni-mato. Nega recisamente che il problema si sia mai posto in modo concreto alla dirigenza della società: «A rischio di ap-parire ingenuo, posso dire che noi non abbiamo avuto mai percezione di pressioni di al-cun genere per fare lavorare nei subappalti certe imprese al posto di altre. D’altra parte le norme sugli appalti pubblici sono molto stringenti: avevamo controlli quasi quotidiani di carabinieri e Guardia di #nanza anche con agenti in borghese. Che poi, con il meccanismo del massimo ribasso, negli appalti qualcosa di strano possa ac-cadere, lo immagino. Come fa un’impresa a stare nei costi se si presenta con un ribasso del 40% sull’offerta? Da qualche parte troveranno il modo di ri-sparmiare. Probabilmente sulla mano d’opera che lavorerà oltre l’orario dichiarato. Oppure sulla velocità di realizzazione dei la-vori. Se prima di posare il manto stradale il progetto prescrive di rullare 100 volte il terreno, e io invece il rullo lo passo solo 10 volte, si risparmia parecchio. Poi però capiamo perché certe grandi opere sono sempre in manutenzione». Colpa anche del sistema, dunque, che con il massimo ribasso costringerebbe le imprese a pratiche illegali per contenere i costi. O comunque che favorirebbe le imprese che riciclano denaro, per le quali è razionale lavorare con gua-dagni esigui o addirittura in perdita. Dario Boni ricorda che
«per la realizzazione dell’Alta velocità Torino-Milano sono arrivate moltissime imprese dal Sud e moltissimi lavoratori meridionali. Per lavorare nelle grandi opere è necessaria la regolarità contributiva relativa a tutti i cantieri aperti sul ter-ritorio nazionale – altrimenti la cassa edile non rilascia il Durc (documento di regolarità contributiva) – e senza Durc non vengono pagati i Sal (stato avan-zamento lavori). In quel periodo abbiamo registrato un fenomeno nuovo, una sorta di caporalato legalizzato: la mano d’opera era gestita da determinati per-sonaggi – a volte meridionali, a volte di nazionalità stranie-ra – che gestivano i rapporti della manovalanza, italiana o straniera. La quale era formal-mente perfettamente in regola. Questi personaggi gestivano con autoritarismo assoluto modalità lavorative, orari, pause pranzo e così via. Quello che sappiamo è che gli orari effettivi erano nettamente superiori a quelli dichiarati, che le pause erano ridotte al minimo vitale e che nessuno si sognava di denuncia-re, per paura proprio di questi “gestori di mano d’opera” cui si af#davano le imprese».
Il con-trollo del territorio è l’essenza primordiale del potere ma#oso. Come ha dichiarato il collabora-tore Rocco Marando, ex af#liato alla locale di Volpiano, «quando vi è un appalto di opere edilizie da realizzare nella zona rientran-te nel territorio della “società”, debbono “mangiare” le ditte che sono gestite da esponenti della medesima società. Se ad esem-pio vincesse una ditta estranea alla società, viene dapprima

convinta con le buone a lavorare altrove, poi con le cattive e si può arrivare anche a uccidere. In sostanza, la ditta della “società” che si aggiudica un appalto poi ripartisce i vari lavori (elettrici, tubature, etc.) ad altre ditte che fanno parte “dell’onorata socie-tà”». Il controllo del territorio in Piemonte non è omogeneo ma “a macchia di leopardo”, come direbbe il procuratore Grasso. Signi#ca che esistono ancora numerose zone franche, ma se si ricade nella “macchia”, come quella canavesana, la pressione è soffocante. Pagano persino le stesse ditte della ma#a in trasfer-ta. «Quando una ditta ma#osa vuole lavorare oltre i con#ni del territorio di competenza – ha ribadito Marando – deve informare le famiglie del luogo e pagare qualcosa». Non sempre lo fanno di buon grado. Nelle intercettazioni dell’inchiesta Minotauro sono registrate deci-ne di discussioni, anche molto violente, tra ’ndranghetisti che cercano di “eludere”, almeno in parte, la tassa, e coloro che ne esigono la riscossione. Chi immagina la ’ndrangheta come un monolite senza crepature interne, contrapposto come un sol uomo al mondo degli esterni, i cosiddetti “contrasti”, è fuori strada. Tra di loro è un continuo lottare anche per poche centina-ia di euro, come formiche che si accapigliano sullo stesso tozzo di pane. Pochi spiccioli, che però valgono l’accettazione o il ri#uto della sovranità altrui sul territorio in questione, principio per il quale vale la pena morire nella cultura ma#osa.Quando un’impresa “esterna” alla società riesce ad aggiudi-carsi un appalto in una zona controllata dalle ’ndrine viene
costretta a pagare il pizzo per pagare la guardianìa, in denaro o attraverso la concessione di subappalti alla ma#a. Un’affer-mazione estrapolata da un dia-logo tra Bruno Iaria, capolocale di Cuorgné, e Giuseppe Gioffré, caposocietà del locale di Natile di Careri a Torino #no al 2008, quando fu assassinato a Locri, è particolarmente signi#cativa. È il 2007, i due boss stanno discutendo della costruzione di 180 alloggi a Rivarolo Canave-se da parte di una non meglio identi#cata “società Parisi”, che sarebbe disponibile a concedere in subappalto a ditte dei boss parte dei lavori.
Iaria dice a Gioffrè: «Compà, dobbiamo andare a trovare a coso, a Nino Occhiuto (componente della co-siddetta Bastarda, ndr), perché, mi ha parlato mio zio Giovanni (Giovanni Iaria, cfr art. p. 33, ndr) l’altro giorno, che a Riva-rolo hanno 180 alloggi e passa, però la pratica è bloccata in Regione, è andato, praticamente “Natino” e ha fatto bloccare, perché l’ha fatta bloccare, mio zio mi ha detto vai, così in modo che noi entriamo, dice però la possiamo tenere bloccata un mese, due, poi che succede andiamo da compare Nino, … , giustamente il lavoro se non gli interessa tutto a loro almeno la metà li dobbiamo fare noi, ci sono 180 alloggi da fare, i ponteggi da fare, qui la cosa è grossa e grassa, poi so che, questi dei Parisi, so che lui li ha messi sotto per i cantieri... (incomprensibile) avete capito? Là quando avevano fatto gli altri cantieri.... Ora vogliamo andare, a trovare compare “Nino” per anticiparlo noi, capito? “Com-
pare Nino vedete che passa così, io non voglio, noi ci rispettiamo, la carpenteria so che voi non la fate, non la fanno ... a farla altri la facciamo noi...”».Dalle affermazioni di Iaria emer-ge innanzitutto che, tramite delle non meglio speci#cate “conoscenze” in Regione, il gruppo ’ndranghetista ha ostacolato il rilascio di certe autorizzazioni richieste dalla società Parisi per realizzare un importante intervento edilizio, al #ne di consentire a Gioffré e allo stesso Iaria di concordare con Antonino Occhiuto (af#lia-to alla “Bastarda”, competente territorialmente sul cantiere di Rivarolo) la spartizione dei subappalti («Parisi ce l’ha la ditta, però lo dà via il lavoro, capito?»). È la conferma che “Parisi” non essendo della zona di Rivarolo, deve pagare. La mo-neta sono i subappalti. Dall’altro lato si evidenzia come i ma#osi abbiano bisogno di tempo per discutere tra loro di spartizioni interne (territorialmente spette-rebbero ad Occhiuto, che «li ha messi sotto», ma Iaria e Gioffrè vogliono entrare nell’affare di Occhiuto, che non sarebbe in grado di fare tutti i lavori («a te la carpenteria non interessa»). Ecco il valore aggiunto dei rap-porti con l’amministrazione e la politica. Dall’inchiesta non è ancora emerso quali fossero i contatti in Regione vantati o millantati da Iaria. Ma è abba-stanza evidente dove cercare. «Sono gli uf#ci tecnici – sot-tolinea Antonio Castaldo – i luoghi dove si prendono le decisioni fondamentali relati-ve all’edilizia. Se in quei posti chiave dell’amministrazione ci sono persone avvicinabili, il gioco è fatto».

Dinastie di fratelli che hanno seminato sangue e crimine, minacce e delitti. Frammenti di storia della ’ndrangheta di Torino da aggiornare. Dopo Domenico e Salvatore “Sasà” Bel#ore, dopo Francesco e Pa-squalino Marando, ecco Adol-fo e Cosimo Crea, per tutti “i nuovi capi” della mala, nati a Locri e cresciuti a Stilo, rispet-tivamente mare e montagna di quella Calabria jonica che sotto la Mole ha sempre avuto ruoli di comando dell’organiz-zazione. Adolfo 40 anni, Cosi-mo 37. Giovani, ma, secondo le risultanze dell’operazione Minotauro, già “padrini” del Crimine, la struttura superiore alle ’ndrine che decide omici-di, rapine, estorsioni e impone la sua volontà su tutte le altre famiglie (cfr art. pag. 55, ndr). Sono loro i veri vertici del torinese. Spregiudicati, cinici, violenti, arrivisti, sanguinari. «Abbiamo Torino in mano» dice Giacomo Lo Surdo, uno dei loro soldati, alla #danzata che gli chiede conto dei sol-di a palate che girano nelle sue tasche. «Mio compare è
il capo di Torino, comanda tutto. Qualsiasi cosa si debba fare, lo decidiamo noi. Anche se devi ammazzare uno devi chiedergli il permesso». Suo compare è Adolfo Crea.
Quando arrivano a Torino nel 2001 i fratelli di Stilo stanno scappando da una faida tra le famiglie Ruga-Metastasio e Gullace-Novella. Non c’è pau-ra negli occhi di Adolfo e Cosi-mo, ma una certezza. «Qui non ci fanno lavorare». Il treno per il Piemonte li aspetta al binario della stazione di Locri. Diciotto ore stipati nei vagoni dell’espres-so 1608 Lamezia-Torino. In città sono anni dif#cili. È sta-to appena ammazzato Pasqua-lino Marando, che a Volpiano era un re (la notizia si sparse velocemente tra le famiglie di ’ndrangheta, ma solo dopo un anno arrivò alle orecchie della Dia). Gli Ursino-Scali-Bel#ore-Macrì resistono a Moncalieri (ma Mario Ursino è in carcere e uscirà solo nel 2006 bene#-ciando dell’indulto). A Nord però c’è il vuoto. Perché il fratello di Pasqualino – Do-
menico – è in carcere per un duplice omicidio. E il resto della famiglia – Rosario, Rocco e Nicola – è già sotto la lente di ingrandimento della procura di Reggio Calabria. Indaga su di loro Nicola Gratteri agli albori dell’operazione Stupor Mundi, che nel maggio 2007 avrebbe sgominato una delle più potenti consorterie ma#ose della Locri-de dedita al narcotraf#co.Spazio, dunque, ce n’è. Adolfo e Cosimo non si fanno pregare. E per entrare nell’onorata so-cietà si appoggiano a Vincenzo Argirò, che al tempo deteneva il controllo dei videopoker nella zona di Settimo, Leinì e Brandizzo. Il primo sponsor della scalata dei Crea è lui. Ma non è il solo. Per arrivare a comandare le ’ndrine torinesi i Crea devono creare una rete. Per questo motivo Adolfo fa in modo di entrare in affari con Luciano Ursino, nipote di Rocco Lo Presti, il capobasto-ne di Bardonecchia morto il 23 gennaio 2009, pochi giorni dopo la sua prima condanna per associazione a delinquere di stampo ma#oso.
L’operazione “Gioco duro” del 2008 li aveva già individuati – benché senza riuscire a fermarli – come i nuovi boss del capoluogo piemontese. Oggi l'inchiesta Minotauro ribadisce il loro ruolo apicale
di Giuseppe Legato

Le intercettazioni svelano un’amicizia fraterna tra Adol-fo e Luciano, che fa leva anche sulle collusioni di alcuni rap-presentanti delle forze dell’or-dine. È il caso di Aldo Galasso, ispettore di polizia, e Vittorio Falbelli, proli#co informatore delle forze dell’ordine. Insieme procureranno ai fratelli Crea uno scanner per boni#care gli uf#ci dalle cimici. Non solo: l’ispettore Galasso, verosimil-mente su richiesta di Adolfo e Cosimo, si sarebbe informato con alcuni colleghi di lavo-ro sull’esistenza di indagini in corso sul loro conto, ma anche su quello di Giusep-pe Bel#ore, Vincenzo Argirò e Luciano Ursino. Eccola la rete dei Crea. Bel#ore però entrerà in scena molto dopo nel contesto del “salto” dei Crea dalle “macchinette” alle bische clandestine. Per la cronaca, l’ispettore Galasso, rientrato in servi-zio nel 2009 alla Questura di Vercelli, è stato destituito un anno fa dall’incarico (e quindi espulso dalla polizia) dopo la sentenza de#nitiva della Corte di cassazione (10 maggio 2010) a un anno e nove mesi per aver favorito in modo fraudolento personaggi della mala torinese. Galasso, che in carriera aveva ricevuto 20 encomi e ambiva a entrare nella Dia, è stato ritenuto colpe-vole nonostante il suo avvocato Francesco Traversi sostenga di aver assistito alla creazione «di un mostro giudiziario sulla base di ricostruzioni fantasiose del pm. Al tempo in cui l’ispettore fu contattato da Adolfo Crea, lo stesso Crea era un emerito sconosciuto con due precedenti
per emissione di assegni a vuo-to». È ancora in piedi il ricorso contro l’espulsione dal corpo di appartenenza.
Nella squa-dra dei due fratelli di Stilo c’è un personaggio centrale. Si chiama Giacomo Lo Surdo. È il telefonista del gruppo. È lui che chiama gli imprenditori dalle vecchie cabine Telecom: «O pagate o saltate in aria» dice. Ed effettivamente qualcosa suc-cede. Il 15 ottobre del 2002 il titolare della ditta Turin Carta srl di San Maurizio Canavese si ritrova la casa dilaniata da una bomba. L’hanno piazzata i Crea nel muro di cinta che sostiene la camera da letto dell’impren-ditore che poi racconterà ai carabinieri di Ciriè: «Mi hanno anche bruciato un deposito di pneumatici e una gru. È gente che vuole il pizzo, da tempo ricevo telefonate di minacce, sono terrorizzato. Non so più cosa devo fare». Nasce così l’operazione “Poker” coordi-nata dal sostituto procuratore Antonio Malagnino. Le inter-cettazioni telefoniche svelano un sodalizio «molto lontano – diranno in procura – dalla semplice banda di usurai af-famati di soldi». Il capo è lui: Adolfo Crea, all’epoca 33 anni, impresario edile. I suoi compari sono quelli finiti in carcere nell’operazione Minotauro: Lo Surdo, Argirò, Candido (cugino dei Crea). Cercavano di convin-cere i proprietari di bar e locali pubblici a installare i videopo-ker, forniti dai fratelli Antonio ed Elio Cappiello, abitanti a Santena e Cambiano. Incassi record: 800 euro al giorno e 25 mila euro al mese. Chi si ri#utava #niva in un incubo:
botte, minacce, bombe.Perché la forza dei Crea è que-sta: da un lato sono abili e diplo-matici nel conquistare la #ducia dei boss torinesi e calabresi e dall’altro paiono altrettanto ancestrali nelle modalità di esercizio della violenza, metodi ma#osi tout court. Bombe e cortesie: cocktail micidiale.Giugno 2003: la banda dei Crea cosparge di benzina venticin-que metri di corso Giulio Cesare per minacciare due ditte edili che si affacciano sulla strada e non vogliono pagare. Nello stesso mese i carabinieri sor-prendono Vito Candido (pure lui originario di Stilo e – so-prattutto – cugino di Adolfo) mentre cospargeva di benzina i capannoni della ditta Edil Jonica di strada della Pronda. I carabinieri di Venaria deci-dono che è ora di chiudere l’indagine.Gli arresti li portano in carcere, ma Adolfo e Cosimo – insieme ad Argirò – escono presto: è l’autunno del 2005, Argirò già nel 2004 per motivi di salute.
La scalata è ini-ziata. E sembra inarrestabile nel momento in cui i Crea de-cidono – dopo aver maturato l’esperienza carceraria – che è ora di passare dalle macchi-nette di videopoker alle bische clandestine. Un salto notevole che ha bisogno di uno sponsor. E chi meglio di Giuseppe Bel-#ore, ultimo avamposto della storica famiglia ma#osa che ha sulle spalle l’omicidio del procuratore capo Bruno Cac-cia? In pochi mesi mettono le mani su quasi tutte le bische del capoluogo. Conquistano la #ducia di Peppe che nota

– e non disdegna – la grande scaltrezza dei fratelli di Stilo. Lui diventa il terminale di con#denze e lamentele. I Crea riconoscono la portata stori-ca del personaggio. Mai uno sgarro, anzi rispetto assoluto. Ma la fame porta fretta. In quel mondo di dadi e carte ci sono regole dif#cili da far digerire ai Crea che vogliono tutto e subito. Un uomo potente #nisce presto nel mirino di Adolfo e Cosimo. Si tratta di Renatino Macrì, nipote di Mario Ursini. Macrì sottovalu-ta la portata criminale dei due “stiloti” e decide di alzare la posta. È il 10 ottobre del 2007. Il boss apre un’altra bisca in-sieme a Raffaele Dragone e a Cosimo Papandrea. Si chiama “Blu notte”, via Borgaro. Tra i tavoli verdi si comincia subito a giocare a poker texano, ma un accordo in cui i Crea hanno spuntato l’esclusiva, genera at-triti forti. Uno della loro banda si presenta alla sala dei dadi e interrompe la serata: «A texano si può giocare solo nella bisca di via San Paolo», dice. Fa vedere una pistola e se ne va a piedi indisturbato.E se non bastasse – com’è tra-dizione nella carriera criminale dei Crea – arrivano le bombe. È la mattina del 1° novembre 2007. E il povero meccanico Antonino D’Elia da Gerocarne (Vibo Valentia) trova davanti alla sua of#cina un ordigno esplosivo collegato con dei #li elettrici a un detonatore.Gli arti#cieri del comando pro-vinciale dei Carabinieri di Torino hanno accertato che si trattava di due candelotti di materiale esplosivo del tipo plastico da cava del peso complessivo di circa grammi 500 assemblati con nastro da imballaggio e dotati di
un detonatore elettrico collegato con un #lo di massa.No, non è per lui quella bomba. Che invece serve a spaventare il titolare del circolo privato di fronte. È l’Ermitage di Renato Macrì. Lui non cede. Bel#ore prova a mediare, ma non ci riesce. E il 2 febbraio 2008 le bombe tornano. Stessa scena di qualche mese prima. Esplo-sivo plastico davanti al circolo di Macrì. Stavolta però non è un esercizio dimostrativo: le bombe potevano fare una strage. I fratelli di Monaste-race sono quasi al top, hanno messo un po’ in disparte pure Peppe Bel#ore che conta e non poco, ma è uomo di dialogo. Qualcuno lo critica: «Se ci fossero i suoi fratelli fuori, certe persone sarebbero già sottoterra». Quelle persone sono Adolfo e Cosimo Crea. La Mobile del dirigente Marco Martino a quel punto però è già avanti nell’inchiesta “Gioco duro” (vedi «Narco-ma#e» 05/2009) condotta dal pm Onelio Dodero (oggi alla procura antima#a di Calta-nissetta). Le manette scattano anche in considerazione del fatto che sta per scoppiare una guerra di ma#a. Lo di-cono gli stessi ’ndranghetisti intercettati: «Si è creata una situazione delicatissima, hanno fatto un casino (i Crea). È già tre volte che l’abbiamo rischiata (la guerra)» dice Bruno Iaria.
In cel-la #niscono Adolfo e Cosimo, ma anche Peppe Bel#ore. La pax di Torino è salva. Per tutti l’accusa iniziale è di associa-zione a delinquere di stampo ma#oso, imputazione che non regge in dibattimento e viene
derubricata in associazione a delinquere semplice. I Crea fanno due anni di carcere. Le sbarre però non rallentano la loro scalata al Crimine. Tutti li ossequiano. Soprattutto i loro soldati. Fortunato Currà, Benvenuto Praticò, Ercole Lo Surdo (fratello di Giacomo) e Massimo Troiano si fanno in quattro per turnare una volta alla settimana (ogni mercole-dì) e accompagnare al carcere di Bologna Franca Murace, la moglie di Adolfo. Anche Fran-cesco D’Agostino ha il suo bel lavoro da svolgere: organizza gli incontri del suo “capo” con gli ospiti che devono confe-rire con lui (e con Vincenzo Argirò), paga la benzina per arrivare in Emilia, smista la corrispondenza di Adolfo in carcere. Non solo: risulta dagli atti che lo stesso D’Agostino abbia partecipato al tentativo di coinvolgere il cappellano del carcere di Torino, don Piero Stavarengo, per ottenere ra-pidamente – senza successo – il trasferimento di Crea dal carcere di Bologna presso un istituto di pena più vicino e facilmente raggiungibile, scri-vono i carabinieri. Per capire quanto i Crea siano forti anche dietro le sbarre è illuminante la vicenda relativa alla disputa nata attorno alla riapertura del locale di Rivoli, chiuso (sospeso) dopo il loro arresto. Alcune famiglie pensano sia arrivato il momento di ridarlo a Salvatore “Giorgio” Demasi che ha il grado di padrino ed è già capo locale di San Mauro. I Crea però, sfruttano abilmente i loro rapporti con San Luca e col boss Giuseppe Pelle detto “Gambazza”. È lo stesso Pelle a decidere che bisogna aspettare

Tra le mille pieghe dell’operazione Minotauro, ce n’è una destinata ad aggiornare gli archivi dell’an-tima#a. Da qualche giorno, sulle foto segnaletiche di Pasqualino Marando, narcotraf#cante di stanza a Volpiano, e di Rocco Vincenzo Ursini, nipote del boss Mario af-#liato al locale di Moncalieri, c’è una “x” disegnata con un penna-rello nero. Che signi#ca “morti”. Cambio di status anagra#co: da missing (scomparsi) a deceduti. Meglio sarebbe scrivere uccisi. Luce dunque – #nalmente – sulla storia delle ultime due lupare bianche sotto la Mole. I carabinieri ne sono certi. «Non ci sono più margini ragionevoli per ritenere che Ma-rando e Ursini siano vivi». Storie diverse per caratura criminale che però #niscono nell’imbuto della stessa pratica ma#osa: omicidio e sparizione del cadavere.
Chissà dov’è #nito il corpo del vangelista Marando, boss made in Platì, uomo di coca e di containers, contatto privilegiato dei narcos di Bogotà col crimine italiano. Un’im-presa rimase storica nell’immagina-rio della mala: con una telefonata Pasqualino ordinò un carico di 500 kg di polvere bianca. I colombiani la stoccarono e la spedirono al porto di Genova. I calabresi la ritirarono, la tagliarono nelle raf#nerie clan-destine, iniziarono a venderla sul mercato milanese di Buccinasco. Il tutto senza che Pasquale avesse ancora pagato una lira. Per una situazione analoga – ma con in-terlocutori diversi – i colombiani avevano sequestrato due emissari della “stidda” siciliana. La dura legge delle foreste del Sud America è chiara: non pagare equivale a morire. Non per Pasquale Maran-do, capostipite di una famiglia di quattro fratelli, che sono poi il suo esercito: Rosario, Domenico, Nicola e Rocco (tutti in carcere tranne quest’ultimo, ex collabo-ratore di giustizia) tutti residenti
nell’hinterland nord di Torino. Di lui si #davano tutti. Pasquale però è un re dal destino amaro, quasi beffardo. Morirà di lupara bianca nel 2001 a Platì, ucciso – secondo le testimonianze di Varacalli e di Rocco Marando (suo fratello) – per mano dei cognati Trimboli. Per la serie: chi di arma ferisce di arma perisce. Lui di “lupare bianche” ne sapeva qualcosa.
Un passo indietro. L’omicidio di Antonino e Antonio Stefanelli (padre e #glio, parenti di Pasquale Marando) è una storia di violenza atroce. Tutto cominciò quando nei boschi di Chianocco, un paesino sperduto nella Valsusa attraversato dai #umi delle profonde gorghe dell’Orrido, fu trovato un cadavere carbonizza-to. Nei verbali di sopralluogo dei carabinieri viene riportata una data: 3 giugno 1996. Il giorno prima, lì, si è consumato un omicidio. È l’inizio, in provincia di Torino, di una delle faide più sanguinose del nord Italia. Da una parte la famiglia Stefanelli da Oppido Mamertina con base a Varazze e con un +orido mercato di stupefacenti; dall’altra i Marando di Platì. Sono parenti, soci in affari. Si sono sposati tra di loro per rinsaldare – com’è uso nelle famiglie calabresi – i rapporti dei “locali” distaccati al Nord. Si siedono allo stesso tavolo, man-giano dallo stesso piatto, bevono lo stesso vino e traf#cano la stessa cocaina. Che è poi quella che ar-riva in Italia grazie a Pasquale. Il cadavere ritrovato nei boschi della Val Susa non può parlare. Il fuoco non ha risparmiato quasi niente se non i bossoli di una 7.65 col quale i sicari lo hanno freddato. E allora, in un epoca in cui non ci sono ancora i Ris e le investigazioni scientifiche sono agli albori, ci pensa un medico legale – Roberto Testi – a svelare il mistero. Sul comodino dell’obitorio accanto
ai resti dell’uomo senza nome c’è anche un anello che ha resistito alle #amme. È una fede nuziale con un’incisione precisa: “Maria. 09-06-1990”. Quella Maria è Maria Stefanelli, 26 anni all’epoca, #glia di Antonino Stefanelli, capo della locale di Varazze in Liguria, sorella di Antonio, rampollo emergente della famiglia, e moglie del morto: Francesco “Ciccio” Marando. A quel tempo Pasquale è un fratello promettente, mentre Ciccio è già un boss che sa fare bene il suo lavoro. A Platì si #dano molto di lui: «È uno serio. Se dice che la cocaina arriva, tu comincia a tagliarla col pensiero» racconta in dialetto uno dei suoi parenti in un’intercettazione tele-fonica. Il movente dell’omicidio di “Ciccio” è la droga. Negli ultimi anni era cresciuto molto. Qualcuno della sua famiglia voleva liberar-sene. Lui lo aveva capito. E 9 mesi prima di morire era scappato dal repartino dell’ospedale di Genova dove si era fatto ricoverare nel corso della detenzione simulando una crisi isterica. Da lì si era rifugiato in Aspromonte, poi era tornato a Torino per gestire i traf#ci illeciti sui quali aveva messo il suo timbro per vent’anni. E a Torino trovò il capolinea. La famiglia capisce e deve reagire. Per Pasquale, in particolare, dietro la morte del fratello non potevano che esserci gli Stefanelli: Antonio e Antonino, per l’esattezza cognato e suocero di Ciccio. Maria Stefanelli, moglie del morto, è infatti sorella di Antonino e zia di Antonio. La condanna a morte è già scritta nelle intercet-tazioni del Gico. Due compari di Marando parlano tra di loro: «Cic-cio se lo sono fatto loro. Fanno i furbi, ma tanto a Torino ci devono tornare». I furbi sono Antonio e Antonino Stefanelli che un anno dopo perderanno la vita nella faida di Volpiano. Padre e #glio tentarono a lungo una mediazione. Vengono invitati a Volpiano, ma hanno pau-ra. Al terzo diniego, i bonus sono #niti. Antonino capisce chi deve
di G. L.

incontrare. E contatta un mediatore che risponde al nome di Giuseppe “Pino Lezzi”, 68 anni ai tempi dei fatti. È un incensurato, impren-ditore edile originario di Staiti. Lui è un fedelissimo di Domenico Marando, fratello di Pasquale, ed è al corrente della vendetta che stanno preparando a Volpiano, ma è l’unico uomo che può por-tare i killer di Ciccio nella tana del lupo. Quando Leuzzi chiama i parenti a Oppido Mamertina (Rc) per chiedere perché non arrivano all’appuntamento, padre e #glio sono già morti. Avevano 55 e 35 anni. I loro corpi non sono mai stati trovati. Fantasmi. È una mattanza senza cadaveri in cui anni dopo #nirà anche Pasquale. Suo nipote Antonio lo idolatra ancora oggi. Tanto è l’alone quasi mitologico che Pasquale ha lasciato dal giorno della sua scomparsa. Quando i giornali ripercorrono la carriera criminale del boss il tono è cele-brativo «questo era mio zio – dice a Domenico Agresta indicando la foto – vedi che non lo lasciano in pace neanche da morto». I due pentiti Rocco Varacalli e Rocco Marando completano il quadro: «Mi hanno riferito che a ucciderlo è stato Sa-verio Trimboli (detto Savetta). Lo hanno fatto a cavallo dei giorni in cui è entrato in vigore l’euro» (chia-ramente ciò che viene registrato non equivale a una chiamata in correità di Trimboli). Dettaglio: nei giorni successivi all’uccisione pare che le scarpe di Pasquale siano state consegnate alla madre, abbando-nate davanti alla porta di casa. Un gesto evocativo: «Tuo #glio non c’è più». I suoi parenti non lo hanno dimenticato e – nelle telefonate allegate all’ordinanza di Minotauro – lo rievocano quasi con nostalgia. Lo chiamano “la buonanima”. Un epitaf#o affettuoso.
Su Pasquale però pende anche il dubbio (di responsabilità) sulla #ne – sconosciuta – di Bruno Minasi.
Siamo nel 1994 quando i carabinieri si dicono sicuri che Minasi, 42 anni, all’epoca residente a Settimo Torinese – ironia beffarda – in via Carlo Alberto dalla Chiesa 21, sia stato ucciso a colpi di revolver e poi fatto sparire. C’è il sospetto che, insieme alla sua Clio nera, sia stato gettato all’interno di uno scavo, realizzato nel corso di un’opera stradale, alle porte di Torino. I militari del Nucleo operativo ave-vano anche un’idea sul possibile assassino: Pasquale Marando, che – all’epoca – ricevette un avviso di garanzia per questo omicidio (ma fu poi prosciolto). Piuttosto chiaro sarebbe stato anche il movente: Bruno Minasi, che era autista e persona di #ducia dei Marando, aveva cominciato a intrattenere rapporti troppo stretti con gli uo-mini della cosca Ursini (il cui capo, Mario, ha risieduto a lungo nella casa dove abitava Minasi). L’ucciso aveva stretto legami con Renato Macrì, cugino di Ursini. Con lui avrebbe anche acquistato una forte partita di cocaina (64 chilogrammi), poi sequestrata dai carabinieri nel corso di un’operazione compiuta in Francia. C’erano anche ragionevoli certezze sulla data dell’omicidio: il 10 gennaio del ’92. Quel giorno Bruno Minasi era stato visto uscire dalla sua casa, a Settimo. Poi più nulla. L’assassinio del Minasi fu uno degli elementi emersi dalla collaborazione di due pentiti con i magistrati torinesi.
Diversa è la storia di Rocco Vincenzo Ursini, nipote di Mario Ursini, scomparso a 29 anni da Chivasso. Era aprile del 2009. L’ultima cella che aggancia il suo telefonino lo colloca sulla tangen-ziale nord all’uscita per Mappano. Poi più niente. Nel provvedimento di fermo firmato dai carabinie-ri di Reggio Calabria nell’ambito dell’operazione “Crimine” contro le cosche milanesi c’è un passaggio cristallino: «Il giovane se lo sono
fatti a Torino perché non aveva restituito 20 mila euro ai Macrì» dicono due calabresi. La sua auto viene ritrovata a Mappano tre mesi dopo la scomparsa. È in divieto di sosta. Rocco invece è sottoterra. Lo scrivono i carabinieri: «Con una certa ragionevolezza si desume da alcune intercettazioni che sia stato ucciso». Morto pure lui, che, nell’ordinanza del gip di Torino, era destinatario di una custodia cautelare in carcere per 416 bis (as-sociazione a delinquere di stampo ma#oso). Figurava nella popolosa famiglia del locale di Moncalieri. E – ironia della sorte – anche il padre della #danzata (e quindi il futuro suocero) è #nito in carce-re. Ai cronisti – due anni fa – la ragazza aveva raccontato: «Rocco ha un cognome ingombrante, ma è pulito, è uscito dal giro. Ha fatto degli errori in passato (condanna per spaccio), ma ora ha mollato quell’ambiente, si è riscattato. E vuole sposarmi». Tutto falso, tran-ne che per l’ultimo particolare. Rocco Ursini, 29 anni, partecipa a molte riunioni importanti del-la commissione provinciale della ’ndrangheta, presenzia a funerali di boss uccisi (Francesco Scali), porta la sua testimonianza. Però muore. Lo ammazzano. Il motivo è ancora da chiarire e su questo aspetto gli inquirenti sono al lavoro. Dalle intercettazioni emerge un ragazzo perfettamente integrato nel tessuto della “mala” che si occupa di gestire una parte dei proventi delle bische clandestine. Soldi che servono ai carcerati, a rendere meno “pesante” la loro detenzione. Unico neo: la condotta. All’interno delle organiz-zazioni ci sono regole ferree. Ursini le elude spesso. E una volta scatena l’ira dei compari non presentandosi a una cena importante, una riunione strategica del locale di Moncalieri a cui lui appartiene: «È indisciplinato» dicono i boss intercettati: «Non mi è piaciuto per niente il comporta-mento di Rocco». Forse anche per questo ha pagato il conto.

che Adolfo e Cosimo escano: «Sennò poi fanno tragedie e dicono che non li abbiamo aspettati». San Luca dunque è dalla loro parte.
I boss con-correnti commentano inaciditi. Il più arrabbiato di tutti è Giu-seppe Gioffrè, quartino nella società maggiore, esponente di spicco della malavita, collante delle ’ndrine con Nevio Coral, secondo quanto emerge dalle carte dell’operazione Minotau-ro. A lui, Gioffrè garantisce la “guardianìa” nei cantieri della provincia. E grazie a questo Coral gli consente di insediare la sua ditta senza peraltro pagare nem-meno un euro di af#tto. Gioffrè patisce i Crea e non ha nemmeno un buon rapporto con Giuseppe Marvelli referente dalla Cala-bria per le ’ndrine piemontesi. Quando – febbraio 2008 – apre una bisca a Leinì insieme agli Agresta, Adolfo e Cosimo man-dano qualcuno a riscuotere la loro parte. Peppe perde le staffe. Comincia a inveire contro i suoi
nemici: «Che stiano alla larga dove ci sono io – dice a Pasquale Barbaro –. Se questo rompe i c... davvero ci saranno brutte discussioni. Questo zingaro di m... (Adolfo Crea) che è scappato da casa sua... e viene qua... e comanda qua sopra». Pasquale Papalia, genero di Pelle raccoglie le lamentele di Domenico Agre-sta e manda ai Crea l’ambasciata di non immischiarsi nella bisca di Leinì. Gioffrè va addirittura a San Luca di persona a trovare Gambazza: «Io faccio pace con loro solo se non devo dargli più niente della mia bisca, perché loro non dividono con nessuno». Ancora al telefono viene fuori l’astio nei confronti di Adolfo: «Gli ho attaccato i bottoni al culo quando era giovane e pieno di ignoranza...». Tutto inutile. Sia-mo a maggio del 2008. Cinque mesi dopo – è il 28 dicembre – Giuseppe Gioffrè viene ucciso a Bovalino in Calabria. I sicari gli tendono un agguato sotto casa. Sparano a lui e al #glio Arcan-gelo (af#liato alla ’ndrangheta da quando è minorenne). Il giovane
si salva, i medici gli asportano due proiettili dal costato, Peppe invece muore crivellato di colpi. Chi è stato? È questo un omicidio ancora irrisolto per gli inquirenti. Ma per Giuseppe Commisso e Giuseppe Catalano non ci sono dubbi: «Sono stati i Crea». Inter-cettato dai carabinieri Catalano dice: «Io i Crea li conosco». E Commisso: «L’azione che gli han-no fatto in due minuti a Gioffrè... Poi sotto casa, alle spalle...». Catalano annuisce e chiude il discorso: «Questi possono fare quello che vogliono e quando vogliono». Eccolo il vertice. I Crea sono già “Il Crimine”. Di-spongono della vita e della morte altrui, si muovono in prima per-sona, hanno un esercito accanito e militarizzato. Nessuno mette in discussione la loro leadership. Tanto che quando Adolfo esce dal carcere – è il 24 marzo 2010 – Francesco D’Onofrio, che ha fatto il reggente in sua assenza e che detiene lo stesso grado dei Crea nel Crimine odierno, non ci pensa su un attimo e restituisce i galloni.
Adolfo e Aldo Cosimo Crea, ritenuti membri del “Crimine” dalla Dda di Torino e arrestati lo scorso 8 giugno in quanto elementi di spicco della ’ndrangheta piemontese, il 23 aprile 2010, solo un anno fa, venivano assolti dalle accuse più gravi mosse nei loro confronti nell’ambito del processo “Gio-co duro”, che li aveva portati alla sbarra nel 2009 con imputazioni che andavano dall’associazione ma#osa, all’estorsio-ne, al gioco d’azzardo. Quest’ultima fattispecie, la meno grave essendo una
semplice contravvenzione, è l’unica che ha retto al vaglio processuale. Nella primavera del 2009 i giudici di primo grado avevano derubricato l’accusa più grave, 416 bis, associazione a delinquere di stampo ma#oso, in associazione a delinquere semplice, non avendo riscontrato «gli indici caratteristici di una associazione ma#osa»: per esempio non vi era certezza, secondo i giudici, che la reticenza mostrata da alcuni testimoni, gravitanti nel mondo del gioco d’azzardo, «fosse espressione
di omertà ma#osa, e ciascun membro sembrava libero di recedere in qualun-que momento dal gruppo». In appello, un anno dopo, neanche l’imputazione per 416 c.p è stata ritenuta fondata. Per i giudici di secondo grado i Crea erano dei semplici organizzatori di bische, punibili con la pena dell’arresto a un anno e 11 mesi. Ora nella valutazione della personalità criminale di questi soggetti, è evidente che tra la Dda di Torino e la Corte di appello qualcuno ha commesso un grave errore.
di M. Neb.

di G. Leg.
Due pentiti. “Infami, reietti e tradi-tori” per la ’ndrangheta. “Fonda-mentali, credibili, autenticamente redenti” per la procura di Torino. In cinque anni hanno disintegrato le maglie della mala calabrese sotto la Mole. Svelando misteri, facendo luce su omicidi, traf#ci di droga, estorsioni, famiglie, strut-ture, riti di af#liazione. Eccoli qui Rocco Varacalli e Rocco Marando. Il primo è af#liato dal 23 ottobre 1994 alla ’ndrina Cua-Pipicella e fa parte del locale distaccato di Natile di Careri a Torino. Il secondo è l’ultimo di cinque fratelli terribi-li, af#liato alla triade di ’ndrine Marando-Agresta-Trimboli e attivo presso il locale di Volpiano dal 20 aprile 1990. Diversi per psicologia e vissuto, ma anche per abbondan-za di rivelazioni, hanno maturato entrambi in carcere la scelta di collaborare con la giustizia.
È il 25 ottobre del 2006. Palagiustizia Bruno Cac-cia, stanza 62719, ore 16. Davanti al sostituto procuratore Roberto Sparagna, si presenta Rocco Va-racalli, nato a Natile di Careri il 1° giugno 1970. Insieme a lui c’è l’avvocato difensore Ugo Colonna. Rocco è detenuto da cinque mesi. Lo hanno arrestato per storie di droga. Ha deciso di voltare pagi-na. Il verbale dell’interrogatorio fotografa il momento “clou” della redenzione: «Intendo rispondere
e collaborare con la giustizia. Ho effettuato questa scelta in quanto ho deciso di cambiare vita dopo 18 anni trascorsi nell’illegalità. La mia decisione in tal senso è di intraprendere un’esistenza onesta e corretta. Prendo atto che devo rendere una dichiarazione com-pleta nulla tralasciando e nulla trascurando. Ho deciso di colla-borare con la giustizia dopo aver conosciuto il dottor Sparagna e il maresciallo [omissis]. Costoro mi hanno ispirato #ducia e #n dalla loro conoscenza nel carcere di Asti ho deciso di collaborare». Rocco parlerà per quattro anni. E per essere da subito credibi-le consegnerà ai carabinieri un manoscritto con i primi 90 nomi (ne farà oltre 400) di af#liati alla ’ndrangheta torinese. Farà luce sull’omicidio Donà e su quello di Roberto Romeo. Si autoaccuserà di reati in merito al traf#co di stupefacenti. Omicidi no, non ne confessa. La svolta arriva da una nuova coscienza: «Perché devo continuare – dice al magistrato – a fare il ma#oso se gli altri non rispettano le nostre leggi? Io ero orgoglioso di essere un af#liato. Pensavo che fra calabresi fosse giusto aiutarci. Poi hanno iniziato ad infangarmi. Come quando ci trovavamo al night di Cuorgnè. Se i capi andavano con le ragazze, tutto a posto. Se lo facevo io, dicevano che non rispettavo più la famiglia.
Mettevano voci in giro. Facevano delle tragedie». Varacalli fa i nomi e i cognomi delle ditte edili colluse col sistema ’ndranghetistico, svela i rituali, i locali battezzati, la #ne – ingloriosa – del boss Pasqualino Marando. Consente ai carabinieri di risolvere l’omicidio di Roberto Romeo, odontotecnico di Rivalta freddato nel 1998 con cinque colpi di pistola al torace e alla nuca. Parla diffusamente di un ex mare-sciallo dell’Arma che frequentava night e consumava droga (oggi congedato). Imprime alle indagini torinesi una svolta decisiva. La sua scelta di collaborare «è talmente genuina – scrive la Procura – che il suddetto Varacalli si autoaccusa di reati che non gli sono mai stati contestati». Credibile dunque. «Non si spiegherebbe altrimenti – annota il gip Salvadori nell’ordi-nanza dell’operazione Minotauro – il comportamento della famiglia all’indomani della pubblicazione delle rivelazioni dell’ex af#liato». Il 21 aprile 2008, davanti al Gup del Tribunale di Reggio Calabria, nell’ambito del procedimento denominato “Stupor Mundi”, il sostituto procuratore Nicola Gratteri deposita le dichiarazioni rese da Varacalli. Tre giorni dopo alcuni parenti scrivono una lettera che ha tutta l’aria di un funerale anticipato. In sintesi si legge: «Non siamo più la sua famiglia. Non è degno come non lo è mai stato di

dire che fa parte di una famiglia pulita e onesta come la nostra. Non abbiamo parole davanti a un elemento del genere. Sta cer-cando di distruggere e logorare la nostra famiglia e le famiglie altrui, ma non glielo permettere-mo. Sta cercando di gon#are tutto per rendersi credibile agli occhi della legge». Il tentativo è chiaro: i parenti prendono le distanze da Rocco. Conoscono la ferocia della ’ndrangheta e avvertono il rischio delle vendette trasversali. Inaugurano una sorta di pressione indiretta (che si con#gura come “reato di subornazione”) af#nché ritratti la confessione. In partico-lare è lo zio Sebastiano Pipicella a marcarlo stretto. Nonostante lo status di collaboratore di giustizia, Rocco viene contattato sette volte al telefono. In due occasioni – come riscontrato con certezza dai carabinieri – incontra addirittura alcuni parenti nella località segreta in cui vive sotto protezione. «Hai ucciso tua madre in poche parole», dice lo zio che poi si raccomanda af#nché Rocco salvi la vita del fratello Mimmo, che corre seri pericoli in Calabria: «La vita di tuo fratello – gli dice – è nelle tue mani». Siamo nel maggio del 2008. Il 1° giugno Varacalli incontra lo zio Sebastiano e Pietro Demana (anch’esso uno zio) arrivati in aereo da Cagliari per non destare sospetti (i carabinieri sapevano tutto). Provano a convincerlo a ritrattare, ma lui non molla, non cambia versione. Resiste alle pres-sioni pur con qualche momento di confusione. Il 22 febbraio 2010, Varacalli racconta alla polizia di essere stato contattato telefonica-mente dalla sorella Maria, che si era lamentata molto del fatto che Rocco, durante l’incidente proba-torio, non solo avesse conferma-to le sue precedenti confessioni,
ma avesse anche reso pubbliche le pressioni esercitate su di lui. Qualche giorno prima lo aveva cercato il fratello Mimmo. Era il 9 febbraio 2010, vigilia della deposizione al processo: «La mia vita dipende da quello che dirai». Mimmo ha paura. È stato avvicina-to da Antonio Spagnolo, capo del locale di Ciminà, e da suo cognato, Giuseppe Monteleone. Lo avreb-bero minacciato di ritorsioni nei confronti suoi e di tutta la famiglia, se Rocco avesse confermato la vicenda relativa all’omicidio di Roberto Romeo. L’ordine è chiaro: «Che parli di droga e di quello che vuole, ma lasci fuori la storia degli omicidi». Varacalli conferma tutto. E lo annuncia a suo zio al telefono: «Ormai gli atti sono quelli che leggete sui giornali. E’ tutta lì la verità».
Nei corridoi del comando provinciale dei carabinieri lo hanno già sopran-nominato il pentito dei bunker. Ne ha fatti trovare sei tra Platì e Natile di Careri. Non erano na-scondigli qualunque, ma luoghi segreti a cui si accedeva tramite tombini e vecchi forni del pane. Le roccaforti per la latitanza degli af#liati erano stati edi#cati sotto la casa di alcuni dei suoi parenti: Domenico Trimboli, Pasquale Pangallo, Domenico Marando (suo fratello), Antonio Barbaro, Anna Trimboli, Antonio Porto-lesi. Di Marando si sa che non crede a molte delle cose che ha riferito Varacalli (in particolare disconosce la responsabilità del fratello Domenico nell’omicidio Romeo: «Il mandante – sostiene – è l’altro mio fratello Pasqua-lino, e non Mimmo, che non conosceva Romeo nemmeno di vista». Il gip però rileva spesso la coincidenza delle testimonianze
e dei riconoscimenti fotogra#ci. Conoscono le stesse persone, riferiscono circostanze molto simili che divergono spesso solo su dettagli non sostanziali. È il caso dell’uccisione di Pa-squalino Marando. Sul decesso non v’è dubbio, sulle modalità dell’omicidio insistono diver-genze narrative. Eppure Rocco Marando è un pentito “attivista”. Non disdegna di accompagnare i carabinieri sul luogo di vecchi omicidi. Come quello di Fran-cesco Mancuso (#nora lupara bianca). La sua auto – una Fiat 500 – venne bruciata in Val Chiu-sella il 1° giugno del 1997. Par-ticolare inedito #no ad oggi. «È dunque evidente che – scrive il gip – trattandosi di informazioni estremamente riservate, solo un intraneo alla compagine crimina-le poteva conoscere». Rocco parla diffusamente della mattanza di Antonio e Antonino Stefanelli. Aggiunge particolari, tira in ballo altre persone, completa il puzzle di quella “Duisburg” torinese che ha visto sangue e lupare bianche per colpa di una faida familiare. Questo merito gli è riconosciuto dai giudici nell’ordinanza: «A seguito delle dichiarazioni di Rocco Marando – scrivono – sono stati raccolti numerosi riscontri individualizzanti, tanto da emet-tere provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di Gaetano Napoli, Natale Trimboli, Rosario Marando, Giuseppe Perre (ha l’Alzhaimer, probabilmente non sconterà un’eventuale condanna in carcere, ndr) e Santo Giuseppe Aligi, poiché, in concorso tra loro e in concorso con Giuseppe Leuzzi e Domenico Marando – nei cui confronti si è proceduto separatamente — nonché insie-me ai deceduti Pasquale Marando e Rosario Trimboli, cagionavano

Entrare a far parte della ’ndrangheta a Torino «è bello perché vedi la fratellanza, la vera fratellanza. Se vado via una settimana ad esempio, lo devo comunicare perché devono sapere che non possono contare su di me. Ci sono giuramenti che tengono valore, facciamo parte di una grande famiglia. E questo, mia cara Corinne, non ha prezzo. È bello e basta». Giacomo Lo Surdo, componente del Crimine di Torino e braccio destro di Adolfo Crea, non poteva trovare sintesi migliore per fotografare – alla sua #danzata dell’epoca (2003) che gli chiedeva conto del perché volesse in#larsi in questo pasticcio – la mala calabrese a Torino. Una famiglia. Dalle regole ferree, dagli equilibri matematici, dall’organizzazione svizzera. Una piramide di ruoli e poteri cementata di riti ancestrali e massonici.
Im-magini sacre, cerimonie quasi esoteriche, ma soprattutto senso di appartenenza. Chi fa parte del-la ’ndrangheta deve tenerci. Per dirla con le parole di Bruno Iaria, capolocale di Cuorgné, «la deve sentire dentro, la deve avere nel sangue». Di contro chi lo fa per interesse viene emarginato dagli af#liati. Nicola Iervasi usa termini diretti nel dialogo del 2008 con Antonio Carrozza (entrambi af#-liati al locale distaccato di Natile di Careri a Torino). A proposito di Domenico Guarneri (un af#liato tornacontista) dice: «Non è degno della dote. Perché lui lavora, gua-dagna lo stipendio e gli va bene così. Dell’azienda però non gliene frega niente».Sangue dunque. Forse è per questo che per entrare a far parte dell’ono-rata società a Torino – come in Cala-bria – ai due pentiti Rocco Varacalli e Rocco Marando (cfr art p.53, ndr) venne chiesta la stessa cosa: «Cosa vai cercando?». Replica: «Onore e sangue». Il sangue suggella, uni-sce, certi#ca solennemente. Un giuramento.
La ’ndrangheta si divide in tre mandamenti che corrispondono ad altrettante zone della Calabria: jonica, tirrenica e centrale. Alla base dei mandamenti ci sono i lo-cali a loro volta formati da diverse ’ndrine (famiglie). In ogni locale perciò convergono af#liati facenti parte di più ’ndrine contemporane-amente. Quelli di Torino sono locali distaccati da quelli originari che si trovano in Calabria, ma rispondono in tutto e per tutto alla “mamma”. Non ci si muove senza l’assenso della ’ndrina “originaria”.
Anche la ’ndrangheta cambia. Varacalli ne traccia l’evo-luzione più importante: «So che negli anni Novanta, a Torino era operativo un unico crimine, perché era un unico locale. Ne facevano parte Macrì Renato, Ursini Mario, e i Bel#ore». Gli interessi – e quindi gli appetiti – sono poi aumentati. Più soldi, più famiglie. Risultato: i locali sono nove e coprono il territorio in maniera molto più capillare.La struttura del locale è rimasta invariata negli ultimi duecento anni. Ovvero: funziona a doppia compartimentazione. Ogni locale di Torino è formato dalla società maggiore e dalla società minore.La società maggiore è l’insieme degli ’ndranghetisti che possiedono almeno la dote di “santa”, ovvero le “doti” superiori al grado di sgarrista o camorrista di sgarro.In sostanza fanno parte della “so-cietà maggiore” gli affiliati che ricoprono i gradi apicali della compagine. Dettaglio: la società maggiore non dà conto delle proprie decisioni alla “minore”, viceversa “la minore” deve dare conto alla “maggiore”.A queste si accede attraverso il conferimento delle “doti” che sono ben diverse dalle “cariche” anche se in fondo proporzionali. La “dote” corrisponde al “grado” rivestito. Si acquisisce solo con il rituale aven-done i requisiti e rappresenta una quali#ca non temporanea. Di contro
più volte nelle varie conversazioni, si coglie la possibilità di togliere o diminuire di spostare (o far girare) le cariche dall’uno all’altro af#liato o anche la possibilità che una ca-rica passi ad altro soggetto, senza – peraltro – che si faccia allusione ad un particolare rituale per detti riconoscimenti.I locali sono attivi (aperti) quando la loro costituzione è stata autorizzata dalla ’ndrangheta. A Torino sono due (Siderno, Natile di Careri), nell’hinterland sono sei: Volpiano, Chivasso, Moncalieri, San Giusto Canavese, Cuorgnè, Rivoli. Aperto non vuol dire sempiterno. Il gip annota il racconto di un af#liato in cui si parla del caso di Rivoli: «Quando compare Giorgio (Demasi) aveva il Locale era tutto in regola. Poi si è distaccato per motivi di salute. E hanno sospeso il loca-le». Locale chiuso è quello che non gode dell’assenso dei vertici della ’ndrangheta. È il caso della cosiddetta “Bastarda” che opera nei comuni di Favria, Castellamonte e Rivarolo canavese. Fa capo ad Antonino Occhiuto, titolare di una ditta edile. Verso questo locale, i “torinesi” non dimostrano parti-colare entusiasmo. In particolare Iaria, che al telefono circoscrive la portata associativa dei “bastardi”: «Uno può dire ma tu chi sei? Non sei niente perché non ti conosco... per esempio questi Occhiuto... loro conoscono a noi che siamo... però noi a loro non li conosciamo come...(af#liati, ndr)». La Bastarda, per questa ragione, è un locale atipi-co che non può partecipare alle riunioni delle famiglie. In que-sto caso risponde direttamente al locale originario che è quello di Solano (Rc).
Nella società minore (e quindi nell’organizza-zione vera e propria) si entra col battesimo o taglio della coda. Si diventa “picciotti”. Prima però ci sono due stadi preparatori. Il primo: “contrasto onorato”, ov-
di G. L.

vero colui che, in virtù della sua af#dabilità, potrebbe entrare a far parte dell’organizzazione, ma non è ancora af#liato. Il secondo è vin-colato a un periodo di osservazione durante il quale si assume la dote di “giovane d’onore”, data per di-ritto di discendenza ai #gli maschi degli appartenenti alla ’ndranghe-ta, dei quali si suppone la futura appartenenza nell’associazione. I picciotti sono la carica più bassa della società minore. Subito dopo ci sono il camorrista e lo sgarrista. Per i veterani sono ruoli di basso cabotaggio, per i giovani rimangono un sogno, un traguardo.Il trasporto e l’attesa di quel mo-mento si toccano quasi con mano nel dialogo intercettato su una Punto il 24 aprile del 2008 a Vol-piano. In auto ci sono Domenico Agresta, 20 anni, e Antonio Ma-rando, 19 anni (#glio di Domenico detenuto a Rebibbia), discendenti di famiglie che hanno riempito di sangue e droga la storia di Torino e dell’hinterland. Giocano a fare i boss. Sognano il giuramento per diventare sgarristi: «Quale pollice ti incidono?» chiede Agresta. Maran-do è preparato: «Quello sinistro». Poi affrontano la questione della “croce” del vangelista che viene incisa sulla spalla dell’affiliato «Quella ti distingue dagli sciac-quini qualunque. La danno solo ai capi. A quel punto – dice Domenico – ce l’hai nel sangue».La dote dunque come riscatto so-ciale per differenziarsi dalla massa, per emergere nell’unica famiglia a cui i ragazzi sentono di appar-tenere. Che non è semplicemente quella degli affetti (padre, madre) o quella sociale (comunità, stato). È quella della ’ndrangheta. «Perché noi siamo in giro che ci sdirru-piamo (scapicolliamo, ndr) per le strade per onorare gli impegni della società, mentre altri – dice Bruno Iaria – sono a letto con le mogli. Potevamo esserci noi no? E invece abbiamo scelto questa famiglia». Il concetto è chiaro: c’è
un dualismo familiare in cui le mogli e i #gli vengono dopo gli interessi della società.Da questo momento scattano degli obblighi. Ed è ancora Varacalli, un’autentica miniera per la pro-cura torinese, a ricostruirli mi-nuziosamente: «L’affiliato deve essere a disposizione dell’onorata società; deve fornire assistenza e ospitalità agli altri af#liati, so-prattutto ai latitanti, deve essere disposto a compiere per la società qualsiasi condotta, anche illecita, dall’omicidio all’estorsione, dal-le aggressioni alle minacce, dai sequestri alle rapine». E ancora: deve dare contezza al picciotto di giornata dei suoi spostamenti se superiori ai tre giorni, deve ricordare la composizione della sua copiata (coloro che hanno partecipato al suo rito di af#lia-zione, ovvero soltanto soggetti già organici alla ’ndrangheta) e a richiesta di un af#liato deve rife-rirne la composizione; non deve “camminare” con “contrasti’ o con “carduni’(estranei all’onorata società), deve, in caso di discus-sioni, comunque dare ragione ai fratelli af#liati piuttosto che ai “contrasti”. In#ne: deve rispettare tutti gli af#liati alla ’ndrangheta specie i più anziani; non deve frequentare infami e carabinieri (nel gergo ’ndranghetistico sono pressocchè equiparati), non deve dire a nessuno – neanche agli altri af#liati – di essere entrato a far parte dell’onorata società spettando la presentazione del novello accolito solo ai presenti al rito; deve for-mulare la domanda “conosci Zio Peppino Montalbano?” al #ne di sapere se l’interlocutore sia af#liato alla ’ndrangheta e, se la risposta fosse stata “la conosco, la servo, la indosso #no all’ultimo sangue”, solo allora avrebbe avuto senso (e legittimità) averci a che fare.Fatta salva la dote, sono tre le cariche che un af#liato può ri-vestire nella società minore. Il capo giovani è colui che comanda
e detiene la cosiddetta “mezgd’, funzione che dà la facoltà di fare da tramite tra la società minore e la società maggiore. Per effetto della mezza, il capo giovani riferisce al capo-bastone del locale. Al secondo gradino c’è il puntaiolo che è colui che vigila sul com-portamento dei giovani af#liati e riferisce al capo-giovane. In#ne il picciotto di giornata che annota gli spostamenti degli af#liati e le comunicazioni tra gli stessi.
Finita la scalata alla società minore si punta alla maggiore. Prima però bisogna avere “la base”. Di cosa si tratta? Nell’interrogatorio del 9 ottobre di fronte al maresciallo della prima sezione dei carabinieri di Torino, Varacalli è illuminante: «Avere la “base” nel linguaggio della ’ndran-gheta vuol dire avere conseguito tutte le doti della società minore, ossia arrivare al grado di camor-rista #nalizzato. La persona che ha la “base” è pronta per ricevere la dote di “Santa».Eccolo il salto alla società mag-giore. La Santa è il primo tassello della sovrastruttura. Anche nella “Maggiore” la scalata è lunga e ricca di livelli gerarchici. Come una piramide verticale, una pianta organica aziendale, un ordina-mento religioso. Dopo la Santa, c’è “il Vangelo”. È questa una dote fondamentale per la vita dell’as-sociazione perchè chi la detiene può battezzare una persona sia in carcere che fuori senza aver bisogno dell’autorizzazione della commissione. Traduzione: arruola af#liati, promuove picciotti, di-stribuisce “i #ori” (sinonimo di doti), alimenta alla base l’esercito della ma#a.Il vangelista torinese passato alla storia nella lunga epopea crimina-le delle ’ndrine torinesi fu Pasqua-lino Marando, narcotraf#cante di livello internazionale, scomparso dal 2001 e ora uf#cialmente morto secondo le più recenti intercetta-

zioni (cfr box p.50, ndr). Non chie-deva permessi a nessuno Pasquale. Tanto da battezzare i sodali nella sua cella del carcere di Opera a Milano. «Perché lui – racconta Varacalli – fu uno dei primi a Torino ad avere il vangelo». Seguono – in ordine rigorosamente gerarchico – il trequartino e il quar-tino (lo era Giuseppe Gioffrè ucciso il 28 dicembre 2008 a Bovalino da due sicari delle ’ndrine), preludio alla carica massima della Maggiore: il Padrino, che Cosimo Capece (af#-liato al locale di Cuorgnè) trasforma al telefono in “Quintino”. Chi ce l’ha? Rodolfo Scali e Bruno Iaria non hanno dubbi. Parlano in auto: «Quella ce l’ha compare Cosimo» (Aldo Cosimo Crea).Suo fratello invece – Adolfo – aspira ad avere la cosiddetta dote supe-riore (o sopradote), la punta della stella che è in mano a Giuseppe Catalano per sua stessa ammis-sione: «Quando me l’hanno data la croce... pensavo che se poi me la tolgono...» dice mentre viene intercettato nella lavanderia Ape Green di Siderno.Fatte salve le doti, anche nella Maggiore ci sono le cariche. Chi co-manda? Il capo locale, detto anche “capo bastone”. È una #gura unica, irripetibile, perché – a differenza delle altre cariche – svolge il suo mandato senza limiti temporali: salvo problemi di salute o fami-liari. Un’investitura vitalizia. A Torino sono Paolo Cufari, Bruno Iaria, Francesco Perre, Salvatore “Giorgio” Demasi, Natale Romeo, Giuseppe Catalano, Pasquale Trun-#o e Rocco Raghiele. Il vice del capolocale si chiama”caposocietà”, che, parafrasando gli organigrammi aziendali può essere considerato alla stregua di un amministratore delegato sottoposto al presidente (capo locale). È lui che presiede la riunione della “società”.I conti economici della società mag-giore li tiene il contabile che è un po’ il banchiere del gruppo, mentre il controllo del territorio e il raccordo
tra gli af#liati della società maggiore e minore è di esclusiva competenza del mastro di giornata.
Della società maggiore fa in#ne parte anche “Il Crimine” una sorta di sovrastruttura com-posta dagli af#liati che hanno la responsabilità delle azioni violente riconducibili ai locali. Decidono della vita e della morte altrui, au-torizzano azioni da commando, omicidi, rapine, estorsioni. Un potere apicale, quasi illimitato. Ne fanno parte Adolfo e Cosimo Crea, Giacomo Lo Surdo, Francesco D’Onofrio. Vito Marco Candido, Giuseppe Mangone, Vincenzo Ar-girò, Giuseppe e Benvenuto Prati-co, Fortunato Currà e Francesco D’Agostino. Giuseppe Marvelli fa da trait-d’union con il Crimine di Polsi a San Luca. I carabinieri lo scoprono ascoltando le ambientali della lavanderia di Siderno. Parlano Catalano e Commisso: «Compa-re Peppe, guardate che io i Crea li conosco, sentite quello che vi dico, questi sono roba del Crimine. Hanno i giovanotti e sono amici di Peppe Pelle... di Gambazza. Com-pare non lo so se questo l’hanno capito tutti...».I giuramenti, le promozioni, gli avanzamenti dell’onorata socie-tà calabrese avevano proprio in Giovanni Catalano il tesoriere. Di cosa? Delle formule e dei riti che i carabinieri hanno trovato a casa dell’uomo. Li custodiva in un cas-setto nel comodino del letto. «Buon vespero ai santisti in questa notte di stelle...» si legge. Erano scritti in un italiano semi-letterato, su carta bianca, intestata alla ditta di costru-zioni Femia, con sede a Gioiosa Jonica. Accanto c’era anche il libro Fratelli di sangue scritto dal sostitu-to procuratore antima#a di Reggio Calabria Nicola Gratteri: «Avevo trovato quei foglietti per caso – ha spiegato Catalano al gip – ed ero curioso di vedere se fossero uguali a quelli che aveva raccontato Gratteri nel libro». Certo, come no.
la morte di Francesco Mancuso, Antonino e Antonio Stefanelli uccisi con colpi di arma da fuoco materialmente esplosi da Rosario Marando e Natale Trimboli». Con l’aggravante di aver commesso il fatto con premeditazione, per futili motivi (ovvero al#ne di vendicare il precedente omicidio di Francesco Marando ucciso e bruciato nei boschi di Chianocco nel 1996) e di aver agito al #ne di rafforzare il predominio sul territorio torinese e piemontese del sodalizio criminoso facente capo alla cosca Marando. Rocco parla anche dell’omicidio dell’av-vocato Antonino Lugarà ucciso a Platì nel marzo del 1999: «Era il legale di famiglia, lo ammazzaro-no a colpi di pistola, fu vittima di un agguato ma#oso». Anche qui i riscontri gli danno ragione. Il programma di protezione che gli hanno garantito i magistrati lo costringe, per qualche tempo, a emigrare in una località segreta, distante da Volpiano. Trascorsi alcuni mesi, Rocco va incontro a qualche dif#coltà. Psicologica e umana. Torna allora a casa di recente. È il momento più com-plesso. Qualcuno lo irride: battute per strada, sfottò sul suo ruolo di pentito degli sbirri. La rabbia è troppa e così, pochi giorni prima della #ne dell’inchiesta, prende la sua Ford Ka e va a sfondare le serrande del bar “Timone”, via Caduti per la Libertà a Volpiano. Non è un locale qualunque, quello. È intestato alla moglie di Antonio Agresta. Rocco usa l’auto come un ariete. Poi scappa. I carabinieri lo troveranno nel centro di Volpiano di notte, alle due circa, mentre vaga senza meta. Lo arrestano e lo portano in una località protetta. Il giorno dopo le manette dell’ope-razione Minotauro saranno già ai polsi di oltre 150 af#liati.