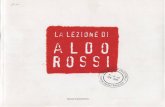L’origine del Comune e la sua natura di ente territoriale · Elisa Occhipinti, L’Italia dei...
Transcript of L’origine del Comune e la sua natura di ente territoriale · Elisa Occhipinti, L’Italia dei...

14
Parte Seconda
1. L’origine del Comune e la sua natura di ente territoriale
La fase della storia del Medioevo, che coincide con la nascita e l'affermazione
dei comuni in Europa occidentale, va dall’ XI al XIV secolo.
La formazione e l’evoluzione delle istituzioni comunali sono sicuramente un
fenomeno complesso, che avvenne in momenti e circostanze diverse nelle differenti
città. Si assiste, però, alla presenza di elementi comuni.
Il comune nasce come una forma di autogoverno cittadino. Il passaggio dei
poteri di controllo della città dal vescovo, in quanto autorità pubblica, alla comunità
cittadina fu il portato del periodo della lotta per le investiture e della riforma della
Chiesa. Una volta entrato in crisi il potere vescovile, si aprono degli spazi per la
gestione laica del potere.
La stessa autorità imperiale, nella sua lotta contro il Papato, indirizza ai cives le
concessioni fino allora riservate al vescovo, in quanto rappresentante della civitas.
Inizia un processo che porterà alla formazione di entità autonome di autogoverno
cittadino: le città-stato del periodo della maturità comunale.
Oltre al bisogno di sganciarsi dalla giurisdizione temporale del vescovo, è
importante l’esigenza di ripristinare la pace cittadina, venuta meno a causa dei
conflitti sociali e religiosi. Si sente altresì l’esigenza di coprire il vuoto dell’autorità
statale, dovuto alla crisi dell’Impero nella seconda metà del XI secolo.
Nacque nei cittadini un nuovo spirito civico, un senso di comune appartenenza
che li portò a preoccuparsi per le sorti della propria città e a cercare soluzioni di
interesse collettivo. La richiesta di innovazioni politiche ed amministrative, fu anche
la risposta a trasformazioni economiche, sociali e ideologiche delle collettività
cittadine.
Dapprima l’autogoverno cittadino prese la forma collegiale del consolato,
modellato sulla suprema magistratura della Roma repubblicana, ma con
un’estensione dei poteri diversa. A capo della nuova organizzazione cittadina furono
eletti i consoli. Non si trattò di una coppia come nell’antica Roma, ma di un collegio
più numeroso, composto rispecchiando la volontà del gruppo che voleva dare alla
città un nuovo governo.

15
In questo periodo storico, tale ceto di cittadini autorevoli1, era costituito da
aristocratici terrieri, vassalli vescovili e comitali, mercanti e giurisperiti, che riempiranno
il vuoto di potere locale dovuto alla lotta per le investiture e alla crisi del potere
imperiale.
Coloro che avevano acquisito capacità amministrative e politiche, collaborando con il
vescovo o con il conte, si assumeranno il compito della gestione della città. Il loro
intento fu anche quello di contrastare la pressione di nuovi elementi sociali, come il
popolo minuto e le classi artigianali. Ogni elemento di questo gruppo eterogeneo diede
il suo contributo nel promuovere il patto che stava alla base del comune. L’interazione
tra le diverse componenti della classe dirigente comunale, si espresse con molte
variabili; la gestione del potere era comunque riserva ad un gruppo composto
dall’aristocratica, dal ceto mercantile e dai ceti delle professioni. Questi ultimi, in qualità
di giudici e notai, si configurarono come garanti della legalità e della gestione politico-
amministrativo dell’organismo comunale in formazione. Comunque fossero assortite,
queste grandi famiglie svolsero un ruolo propulsivo nella costituzione del comune.
. Per permettere lo sviluppo della città, fu necessario garantire una condizione di
pace interna, la cui tutela fu alla base della concordia, cioè dell’accordo stretto da un
gruppo di cittadini eminenti, da cui trasse origine il consolato: la prima magistratura in
cui prese forma il governo della città. Tale accordo poteva essere giurato (coniuratio).
Era, comunque, un giuramento di reciproca solidarietà; un accordo che più tardi
includerà tutti i cittadini.
In quanto espressione della cittadinanza, il comune rappresentava tutti i cives quali
abitanti della città, indipendentemente dal ceto sociale di appartenenza. Si assiste,
infatti, ad uno sviluppo di un’assemblea generale che progressivamente includerà tutti
gli abitanti della città.2 Le fonti ci parlano di consilium, parlamentum, concio, colloquium,
arengo.
1 Anche nei momenti di maggiore difficoltà economica e politica le città rimasero sede di autorità laiche ed ecclesiastiche che mantennero il controllo del territorio circostante e relazioni con le città vicine. In pratica l’autonomia comunale in Italia ha radici remote. 2 Si tratta di un accordo a più livelli: solo tra i promotori, tra i promotori e la base, tra i componenti della base. Questo non significa che fosse di natura privata. Si deve tener conto per il Medioevo dell’ “inadeguatezza di categorie quali pubblico e privato , intese in senso rigoroso” . Elisa Occhipinti, L’Italia dei Comuni, Secoli XI-XIII, Carocci editore, Roma 2000, p. 23. La natura dell’intesa finirà per portare al coinvolgimento dell’intera comunità a livello istituzionale.

16
Il periodo consolare: “consoli”, “parlamento” e “consiglio” (O. Capitani)
“E’ indubbio che il nucleo intorno al quale si forma il Comune è costituito da persone
di rango sociale elevato. Non necessariamente nobili, ma certamente di cospicua
qualità sociale, espressione appunto delle forze che ha tempo hanno rilievo nella vita
della comunità; la quale, tuttavia, non rinuncia ad una sua parte, è presente al
parlamentum (o concio, o arengo), testimone dei giuramenti solenni dei consoli fatti al
consiglio, è il segno tangibile che vuole essere coinvolta nell’azione politica, militare, di
governo insomma, in cui si è riconosciuta a determinate garanzie.
Strumento di queste garanzie era il consiglio, la cui struttura e la cui consistenza
furono mutevoli da luogo a luogo e da periodo a periodo, ma che certamente connota
l’identità del Comune in maniera ben più peculiare che non l’esistenza formale dei
consoli: o se si vuole la motivazione profondamente innovativa che dà ai consoli il loro
significato di espressione del Comune. […]
Anche se i ceti dominanti del “vecchio ordine di cose” possono essere agevolmente
ritrovati in quelli della nuova situazione, almeno nella prima fase della storia di tante
comunità cittadine, rimane il fatto che nell’organismo assembleare si poneva in maniera
nettissima la questione della rappresentanza allargata a tutti coloro che si sentivano
tuta la comunità, per quanto solo parte di quest’ultima, tutta quella collettività in nome
della quale agivano in comune .” 3
L’assemblea generale era convocata al suono di una campana; si riuniva per
discutere i problemi della città e stabilire le linee di governo.
Inizialmente l’assemblea generale accoglieva solo coloro che partecipavano
all’accordo giurato. Probabilmente uno dei suoi compiti era l’elezione dei consoli per
acclamazione. Quando l’unione giurata si allargò a tutta la popolazione maschile, ed
essendo impossibile convocarla nella sua totalità, per l’elezione dei consoli si
utilizzarono sistemi di elezione indiretta.
3 Ovidio Capitani, Storia dell’ Italia medievale, Laterza 1986, pp. 368-369.

17
I primi consoli del comune (R. Bordone)
La comunità cittadina, forte del riconoscimento dei suoi diritti - ufficiale, come nel caso di Pisa,
o di fatto, come in molti altri casi -, è ormai in grado di esprimere una nuova istituzione che la
rappresenta. Con la comparsa dei consoli siamo davvero di fronte a un ente che si configura
giuridicamente in maniera autonoma: esso ha trovato uno spazio politico nella città, deve ora
trovare il modo di convivere con il potere vescovile che formalmente continua a sopravvivere.
Ad Asti, uno dei primi comuni attestati in Italia, la soluzione di compromesso avviene tramite il
ricorso all'istituto vassallatico: i consoli, a nome della città, diventano formalmente vassalli del
vescovo che concede loro in beneficio un'importante fortezza extraurbana.4
L'anno dell'incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo 1095, il 28 marzo, terza indizione,
alla presenza dei maggiorenti i cui nomi sono in calce elencati, il signor vescovo Oddone
dell'episcopato della santa chiesa di Asti fece investitura ai consoli della città i cui nomi
seguono: Lanfranco, Benzo, Uberto, Bulgaro, Uberto giudice, Crescenzo, Saraceno,
Bonbello, Bonsignore, Bonomo, tanto a nome proprio, quanto a nome di tutti i cittadini di
Asti, del castello di Annone, con edifici, cappelle e tutte le costruzioni che contiene, col
villaggio e tutti i diritti connessi, con terre arabili, vigne, prati, incolti, selve maggiori e
minori, aree, pascoli, boscaglie, ripaggi e scoscendimenti, mulini, diritti di pesca, colto e
incolto, diviso e indiviso, insieme con i confini, i diritti di accesso, l'uso delle acque, degli
acquedotti, con ogni diritto e pertinenza che sono spettanti a tale castello e alla corte per
intero, in modo tale che tutti i cittadini di Asti abbiano in beneficio da parte del signor
vescovo Oddone e dei suoi successori per utilità comune di questi cittadini e facciano d'ora
in poi qualunque cosa riterranno opportuno fare, senza opposizione dello stesso vescovo
Oddone e dei suoi successori che devono aiutare [i cittadini] a conservarlo in perpetuo.
Fatto nella città di Asti, presso l'atrio di S. Maria, nella canonica della stessa chiesa,
felicemente.
Io Oddone per grazia di Dio vescovo di Asti ho sottoscritto. […]
Fonte: Q. SELLA (a cura di),Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur, Roma, 1880 («Atti dell'Accademia dei Lincei», serie II, VI), III, doc. 635, p. 651.
I consoli risposero all’esigenza di una magistratura stabile, con la possibilità di un
intervento continuo e sistematico, rispetto ai boni homines, cioè persone fidate,
incaricate, in specifiche situazioni, di farsi portavoce degli interessi cittadini. Non
4 R. Bordone, La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

18
casualmente questi magistrati comunali furono chiamati consules civitatis, per
rimarcarne il ruolo pubblico, la loro funzione di rappresentanza giuridica dell’assemblea
dei cives. Essi esercitavano, cioè, funzioni pubbliche a tutela degli interessi comuni.
Esercitavano funzioni giuridiche, amministrative e di difesa, imponendo tributi,
amministrando la giustizia e stabilendo gli obblighi militari.
Perché fu impiegato il termine consul? L’uso di questo termine nasce da un’esigenza
di legittimazione derivante dalla ripresa delle categorie giuridiche romane (uso vivo
nell’Italia bizantina). L’obiettivo era quello di affermare la legittimità di questa funzione
pubblica nuova, attraverso una tradizione giuridica consolidata. I consoli dovevano
salvaguardare la pace della città e garantire la concordia fra i cittadini.
All’inizio in molte città fu cercata la collaborazione con il vescovo. Sotto la tutela
dell’autorità vescovile il nuovo organismo comunale poté crescere e rinforzarsi e anche
legittimare la propria autorità. In questa fase si trovarono ad interagire protagonisti
diversi come il vescovo, le antiche famiglie aristocratiche e i gruppi economicamente
emergenti. A volte i rapporti non furono di collaborazione ma di opposizione. In città
diverse diedero luogo a combinazioni differenti.5
Questa prima organizzazione cittadina, nata come soluzione di emergenza, si
stabilizzò gradualmente e il governo del comune affermò la propria autonomia.
La progressiva evoluzione politico-istituzionale si evidenzia nelle scelte lessicali
utilizzate. Quando nelle fonti si usa il termine comune significa che l’istituzione è ormai
un fatto consolidato. Il vocabolo comune originariamente fu usato come aggettivo nel
significato di “generale” accanto al sostantivo populus, per indicare gli abitanti della
civitas. Quest’ultimo termine indica sia la cittadinanza nel suo insieme sia il nuovo
ordinamento pubblico cittadino. Dal terzo, quarto decennio del secolo XII fu sempre più
usato come sostantivo per indicare l’ordinamento pubblico cittadino.
E’ importante sottolineare che i due termini di comune e civitas continuarono a lungo
a sussistere insieme, come a voler sottolineare i legami del nuovo organismo con la
tradizione. Il termine comune nel senso di civitas indica il comune interesse dei cives;
fin dalle origini il nuovo organismo ha un carattere territoriale e nel suo ruolo di governo
vuole coinvolgere la totalità dei cittadini.
5 Un forte peso fu esercitato dalla feudalità a Milano, da ricche famiglie mercantili a Genova, al contrario di Mantova, che si oppose ai conti di Canossa.

19
“Il comune nacque come creazione dal basso, non fu oggetto di un esplicito atto di
fondazione, né di un riconoscimento ufficiale dall’alto”.6
L’esercizio di diritti e funzioni di carattere pubblico, già nelle mani di conti e vescovi,
passò, di fatto, nelle mani del comune di fronte alla latitanza del potere statale.7
In quest’esercizio di fatto dei poteri fiscali, giudiziari e militari, il nuovo organismo si
sperimentò empiricamente; si autolegittimò crescendo e consolidandosi.
2. Il governo dei consoli e gli organi comunali
La nascita dei consoli rispose all’esigenza del nuovo organismo di definire un
proprio profilo giuridico. Sebbene non si possa individuare una fisionomia univoca del
consolato (numero dei membri, durata e contenuti del mandato), troviamo sempre nella
prima fase la magistratura consolare. Rispetto ai due della Roma repubblicana il numero
dei consoli variò tra 4 e 20.
In una prima fase i consoli avevano potere esecutivo e giudiziario. Più tardi i poteri
furono separati: ai consules de communi furono affidate le funzioni politiche, ai consules
de placitis (o consules iustitie) le funzioni giudiziarie. Il consolato sul piano politico si
basava sull’appoggio della cittadinanza, su quello tecnico-giuridico utilizzava il lavoro dei
giurisperiti.
Il consolato inizialmente ebbe durata diversa, poi annuale. La durata delle cariche
fu breve, per garantire la collettività contro l’affermarsi del potere del singolo. Terminato
l’incarico, l’operato dei consoli era sindacato, cioè valutato, ed i consoli erano tenuti,
nell’eventualità di danni e abusi, al risarcimento.
Nel momento in cui entravano in carica dovevano prestare giuramento (breve).
S’impegnavano a salvaguardare la città su tutti i piani e ad affrontare eventuali problemi
locali. Il giuramento coinvolgeva anche i cittadini che s’impegnavano a sostenere i loro
rappresentanti. Erano utilizzate delle formule che sottolineavano i doveri degli aderenti
all’unione giurata. Attorno a queste formule si formò la legislazione comunale, gli Statuta.
Nel comune di Genova l’esistenza dei consoli è attestata dai documenti già dal
1099. I consoli prestavano giuramento al momento dell’assunzione della carica
6 Op.cit. p.32 7 “Il comune dei consoli […] non presume di monopolizzare le funzioni di carattere pubblico nella città, non contesta diritti di esazione e di controllo – su mercati, su pesi e misure, su posti di dazio o pedaggio-, spettanti ad enti ecclesiastici o trasmessi ereditariamente nelle famiglie comitali o viscontili”. Tabacco, Egemonie sociali, p.235 in op.cit. p. 32 s.

20
In nome di Dio, amen. Dalla prossima festa della Purificazione di santa Maria per un anno noi
consoli eletti ci impegneremo per il bene del comune e agiremo secondo l’onore del nostro
arcivescovato e della nostra madre Chiesa e della nostra città, in tutte le circostanze, riguardanti
beni mobili e immobili, con e senza querele, tenendo presenti gli interessi della comunità. In piena
consapevolezza non pregiudicheremo l’onore della nostra città, né gli interessi e l’’onore della
nostra madre Chiesa. Non pregiudicheremo i diritti di alcuno dei nostri concittadini, ma
osserveremo e terremo fermi i dettami della giustizia, secondo quanto valuteremo essere meglio in
base alla ragione e alla buona fede.8
e indicavano i provvedimenti disciplinari che pensavano di prendere a difesa e
tutela del benessere della collettività.
Se da una torre sarà gettato qualcosa con uno scopo offensivo e senza il permesso dei consoli e
verremo a sapere che per quel lancio qualcuno è rimasto ucciso, distruggeremo la torre oppure
imporremo la penalità di mille soldi al proprietario o ai proprietari di quella torre […] Se un abitante
della nostra città, dai 14 anni in su, porterà un coltello o un’arma proibita oppure una spada e una
lancia senza il nostro permesso e non in vista di uscire fuori della città, gli imporremo la multa di 20
soldi […].9
8 Questo documento, datato 1143, costituisce uno degli esempi più antichi di statuto sulle funzioni dei consoli. Codice diplomatico della Repubblica di Genova, a cura di C. Imperiale di Sant’Angelo, Istituto storico italiano per il Medioevo, Fonti per la storia d’Italia, Roma 1936, vol.I, doc. 128, p.154 in op.cit. p.34 9 Codice diplomatico della Repubblica di Genova, a cura di C. Imperiale di Sant’Angelo, Istituto storico italiano per il Medioevo, Fonti per la storia d’Italia, Roma 1936, vol.I, doc. 128, p.163, 164.

21
Il «Breve della Compagna» del comune di Genova (R. Bordone)
L'instaurarsi del regime consolare nelle città italiane implica una nuova realtà politica,
anche se prosegue e porta a compimento quella naturale tendenza del ceto superiore ad
affiancare il vescovo nella gestione della cosa pubblica. La presenza stessa di una
magistratura permanente eletta dai cittadini rappresenta una conquista definitiva
dell'autodeterminazione politica in senso istituzionale: tramite i consoli tutta la cittadinanza
detentrice di beni fondiari partecipa al comune, impegnandosi in un giuramento di mutuo
soccorso e di obbedienza. A Genova, dove il comune, sorto fra XI e XII secolo, assume il
nome di «Compagna», tale giuramento veniva ripetuto ogni quattro anni e conteneva di
fatto lo statuto originario del comune, definito «Breve». Il «Breve» che qui si pubblica è del
1157. 10
Nel nome della santa e individuale Trinità e della concordia eterna. Dalla prossima festa della
Purificazione di Maria io giuro a onore di Dio la Compagna per quattro anni.
Nel presente anno avrò quattro consoli per il comune e otto per i placiti che saranno
pubblicamente eletti nel parlamento e giureranno il consolato. Trascorso questo anno avrò altri
consoli, come la maggioranza dei consoli del comune e dei placiti e la maggioranza dei consiglieri
che partecipano al consiglio avrà stabilito di comune accordo per quanto riguarda il numero, la
durata e le modalità della loro elezione.
Qualsiasi cosa avranno stabilito e decretato i consoli eletti, secondo quanto è stabilito nei loro
Brevi, […] osserverò ed eseguirò [mettendo a disposizione] case, torri, persone, figli e servi senza
inganno e senza cattive intenzioni. E se avrò saputo che qualcuno dei consoli di Genova, […]
reputi secondo il suo arbitrio di fare guerra, lo aiuterò in buona fede e senza cattive intenzioni fino
alla conclusione della guerra. Come sentirò la campana che suona per il parlamento andrò a quel
parlamento a sentire le decisioni dei consoli, a meno che non venga autorizzato a rimanere dai
consoli che hanno fatto radunare il parlamento, […]
Sugli affari che sono di pertinenza dei consoli del comune mi atterrò alle loro decisioni; su ciò che
riguarda i consoli dei placiti starò alle loro sentenze come è stabilito nel Breve del loro consolato
[…] Tutto ciò che è scritto sopra osserverò e farò in modo di eseguire in buona fede e senza
cattive intenzioni secondo le decisioni dei consoli, salvo il nostro uso, se non quanto non potrò
fare per giusto impedimento.
Fonte: C. IMPERIALE DI SANT’ANGELO (a cura di), Codice diplomatico della Repubblica di Genova, Roma, 1936 (FSI, 77), I, pp. 350-59 (parziale).
10 R. Bordone, La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

22
I doveri e le funzioni dei consoli erano ripartite secondo i mesi dell’anno.
Capitoli delle cose che i consoli di Pavia sono tenuti a fare.
1.Febbraio. I consoli sono tenuti innanzitutto a far venire ad abitare a Pavia, per tutto il mese di
Febbraio i castellani e capitanei cittadini di Pavia, con le loro famiglie.
2.Gennaio.sono tenuti nel mese di Gennaio ad eleggere due saggi e a farli giurare che in febbraio
sceglieranno cento persone fra balestrieri e arcieri a cavallo, traendoli dagli uomini di tutti i borghi
della terra di Pavia. Costoro devono tenere pronti i loro cavalli e restare a disposizione per tutta la
durata del consolato, se dovesse protrarsi lo stato di guerra. […]
6. entro il primo mese della funzione consolare saranno eletti uno o due boni homines di fiducia
per parrocchia, che dovranno informarsi se gli uomini delle loro parrocchie sono forniti di cavalli e
armi. […]
15. Gennaio. Eleggeranno tre uomini idonei, due laici ed un giudice, che si prendano cura dei forni
e dei mulini di Pavia, dopo aver prestato giuramenti in proposito. […]
26. Cose da fare in febbraio. Prima di tutto informarsi sulla situazione dei posti di pedaggio di
Pavia […]
31. Marzo. Eleggere quattro saggia ciò idonei che […] raccolgano e conservino gli atti e i decreti
che riguardano il comune di Pavia […]
41. Maggio. Il fodro (i foraggi da consegnarsi da parte del contado) che non è stato ancora
consegnato dagli addetti, sia raccolto con tutti i pagamenti consueti […]
45. Agosto. Far rifare o riparare la strada Romea (o Francigena: è la strada che veniva usata da
chi faceva il tragitto Francia-Roma), se ancora non è stato fatto con tutti i ponti ad essa necessari.
[…]
50 ottobre. Capitolo sulla quantità stabilità di approvvigionamenti granari da introdurre in Pavia
entro la festa di S. Michele (29 settembre).
51. Inoltre, capitolo dei consoli e del podestà da eleggere per la festa di S.Martino (11 novembre).

23
52. Inoltre capitolo sul rendiconto delle entrate e delle spese che va fatto ogni tre mesi […]
57. Inoltre, capitolo sul divieto di passare più di tre notti al mese durante il consolato fuori della città
di Pavia e del suo territorio. 11
Nella tabella che segue12, le datazioni relative alla presenza dei primi consoli, si
riferiscono a documenti cittadini pervenuti, ma nulla esclude che consoli fossero presenti
già prima. E’ evidente leggendo i dati come la comparsa dei consoli in molte città della
Toscana e dell’Emilia è concentrata negli anni immediatamente successivi alla morte della
contessa di Toscana, Matilde di Canossa (avvenuta nel 1115). Le date riportate in tabella
tra parentesi si riferiscono alla presenza di podestà stranieri.
Pisa 1081-1085 Bergamo 1117
(1189)
Biandrate 1093 Cremona 1112 –
1116
Asti 1095 Bologna 1123
Milano 1097 (1187) Siena 1125
Arezzo 1098 Piacenza 1126
Genova 1099 Mantova 1126
Pistoia 1105 Brescia 1127 (1182)
Ferrara 1105 Modena 1135
Pavia 1112 (1219) Verona 1136
Lucca 1115 Firenze 1138 (1207)
Parma 1149
Per quanto riguarda l’elezione dei consoli, poi, non esiste un’ampia
documentazione. Si è già detto che probabilmente all’inizio erano acclamati
11 Il documento, risalente al XII secolo, riepiloga un sommario dei doveri e delle funzioni dei consoli di Pavia. P.Brezzi, I comuni cittadini italiani. Origine e primitive costituzioni, ISPI, Milano 1940, pp.159-161. 12 G. Fasoli, Dalla civitas al comune nell’Italia settentrionale, Pàtron, Bologna 1969, p.129, nell’adattamento degli autori in A. De Bernardi, S. Guarracino, Laboratorio storico, Dal Medioevo all’età moderna, vol. I, ed. scol. Bruno Mondadori 1987, p.99

24
nell’assemblea generale dei cittadini su designazione dei consoli uscenti. Si potevano
anche utilizzare meccanismi di elezione indiretta.13
Anche l’assemblea cittadina non era definibile nello stesso modo ovunque. I
partecipanti alla concordia di volta in volta potevano essere o i capifamiglia o la
popolazione maschile sottoposta agli obblighi militari. Si trattava, in ogni caso, come si è
detto, delle famiglie che avevano dato origine al comune, cioè i proprietari terrieri, i
mercanti, i ricchi artigiani. Soprattutto nelle grandi città ad essere coinvolti erano solo i
maggiorenti (per l’impossibilità di convocare un parlamento dalle notevoli dimensioni).
Nel primo statuto dei consoli di Pistoia, degli inizi del XII secolo, l’assemblea
designa cinque cittadini, che prestano giuramento dichiarando di agire a favore della
cittadinanza; provvedono, poi, all’elezione dei consoli.
Questo è il giuramento degli elettori dei consoli. Non sono assoggettato ad alcuna consorteria o
dipendenza nel dare o ricevere il consolato della città di Pistoia; e non mi è stato comunicato alcun
proposito, né suggerito alcun accorgimento, né dato alcun ordine, perch’io fossi elettore dei
consoli; e non ho prestato né accolto giuramento alcuno di dare o ricevere il consolato della città di
Pistoia. E converrò coi miei colleghi, eletti nell’arengo, sull’elezione a consoli dei cinque uomini che
mi si appalesino più idonei e dotati per l’onore, l’interesse e la sicurezza della città e del popolo di
Pistoia, cosicchè amore e odio non siano né di vantaggio né di ostacolo.14
Nel sistema politico che si va formando troviamo alla base l’assemblea ed al vertice
i consoli. Tra questi due estremi si inserì il Consiglio, che costituì un organo di raccordo.15
Al parlamento fu riservato un ruolo più formale, limitandosi a ratificare le deliberazioni del
Consiglio.
Anche il Consiglio durante le fasi di sperimentazione fu diversamente articolato per
consistenza e per composizione. Generalmente si formarono un Consiglio maggiore con
poteri decisionali ed un Consiglio minore, che affiancava i consoli nell’esercizio del potere
esecutivo e seguiva, inoltre, gli aspetti formali amministrativi. Se il Consiglio maggiore
arrivò a comprendere anche un centinaio di membri nel XIII secolo, il Consiglio minore fu
composto solo da qualche decina di persone. Venne anche detto Consiglio di credenza,
dei savi, degli anziani. Provvisorie ed in via sperimentale furono anche le modalità di
elezione dei consiglieri: per cooptazione, sorteggio e votazione.
13 Vedasi l’esempio di Pisa, nel 1162 nella citazione in op. cit. p.34 14 In op.cit. p.35 15 E’ certo che già nel 1164 a Pisa accanto ai consoli agiva un Consiglio formato dai senatori e da 24 rappresentanti delle 4 circoscrizioni, che raccoglievano 6 quartieri ciascuna.

25
Con il procedere di queste sperimentazioni il governo comunale si rafforzò e
cominciò a voler controllare il territorio circostante ed i suoi abitanti. Questo desiderio di
espansione fu contrastato dalle differenti realtà locali dando luogo a conflitti e contrasti.
(per esempio Milano assalì Pavia, Lodi, distrutta nel 1111 e nel 1158, e Como).
L’espansione dei comuni maggiori e le lotte tra comune e comune (P. Lamma- R. Manselli) “Ogni Comune, mentre cercava di svincolarsi da ogni autorità che ne limitasse o ne
comprimesse l’autonomia, doveva, per sopravvivere, disporre di strade e vie di
comunicazioni libere per il suo vettovagliamento, prima di tutto, e poi per il suo commercio,
per i suoi traffici. S’inizia così una politica d’espansione, sempre più viva, sempre più
audace, che cercherà di combattere e sottomettere i signori feudali circostanti.
In questa tendenza espansionistica sorgono assai preso le lotte tra alcune città, che la
parità delle forse obbliga ad un equilibrio, instabile certo, quanto inevitabile: è il caso di
Milano con Cremona, di Firenze con Pisa e di Lucca con Pisa. Intorno a queste città
maggiori si dispongono come in un sistema di forze contrapposte tutte le altre, iniziando
una serie di lotte minute, continue, accanite, di cui non è sempre possibile allo storico
rendersi precisa ragione. Persino al tempo del Barbarossa, quando la minaccia d’una
perdita della tanto sospirata autonomia fece unire intorno a Milano la maggior parte delle
città dell’Italia settentrionale, non mancarono quelle che preferirono la sottomissione
all’impero piuttosto che a Milano: si pensi a Como o a Pavia”. 16
16 P. Lamma- R. Manselli, I comuni italiani e la vita europea, in Storia d’ Italia, I, Il Medioevo, Utet 1968, pp.279-280.

26
3. Lo scontro con l’Impero al tempo di Federico I
Le terre del Regno d’Italia erano formalmente soggette all’Impero. Poiché i comuni
gestivano moneta, fisco, giustizia, reclutamento militare, fu inevitabile lo scontro.17
La lotta, protrattasi per oltre trent’anni nella seconda metà del XII secolo, costituì
un’importante reazione in difesa delle autonomie comunali contro la pretesa dell’impero di
continuare ad esercitare un controllo diretto sulle regioni italiane.
Agli inizi del XII secolo l’impero aveva attraversato un periodo di crisi dovuto allo
scontro tra le casate di Svevia e di Baviera, cioè tra ghibellini e Guelfi, che si
contendevano il trono tedesco. Alla fine, nel 1152, era salito al trono Federico I di
Hofenstaufen.
Lo zio del nuovo imperatore, il cronista Ottone di Frisinga, nell’opera Gesta
Friderici, descrive in modo articolato la ricchezza e la potenza dei comuni della Lombardia
e condanna le loro attitudini autonomistiche. La morte di Ottone, avvenuta nel 1158,
interruppe la narrazione al 1156, prima della risoluzione definitiva dello scontro tra
l’imperatore e i comuni.
[…] [I Lombardi] così sono affezionati alla libertà loro, che ad evitar la insolenza de’ reggitori
amano meglio essere governati da consoli che da principi. E poiché sono fra loro tre ordini, quel
dei capitanei, quel de’ valvassori e quel della plebe, a tener giù l’arroganza, questi predetti consoli
sono scelti non da uno solo ordine ma da ciascuno, e affinchè non li vinca la cupidigia del potere,
essi quasi ogni anno sono mutati.18
Ottone sottolinea l’amore per la libertà, di cui il governo consiliare è l’espressione,
da parte dei Lombardi
[…]a stento troverebbesi uom nobile o grande con tanto potere da esser franco (o libero)
dell’obbedienza alle leggi della città sua[…]19
e la ragione del loro successo, legata all’operosità, ma anche all’assenza dell’autorità
imperiale.
17 Il conflitto tra Federico I e i comuni si inserisce nel quadro internazionale che, alla metà del XII secolo, vede “ le rinnovate tensioni tra l’Impero e il Papato, le rivalità tra i due Imperi d’Oriente e d’Occidente, l’ostilità antimperiale del regno normanno, le difficoltà degli Stati latino-cristiani in Oriente”. In op.cit. p.37 18 Ottone di Frisinga, Gesta Friderici, II, 13, tr. in V: Balzani, Le cronache italiane nel Medioevo, Hoepli, Milano 1900, p. 242 19 ibidem

27
[…] avviene che essi avanzano ogni altro del mondo per loro ricchezza e potenza. E a ciò […]
sono aiutati dall’indole loro laboriosa e dalla lontananza dei loro principi residenti di solito a
settentrione dell’Alpi.20
Ottone rimprovera ai lombardi di non rispettare, così agendo, le leggi.
[…] mentre si vantano di vivere secondo la legge, pure alle leggi non obbediscono. Imperocchè di
rado o non mai accolgono riverenti il principe a cui sarebbero in obbligo di mostrare una
volenterosa reverenza di soggezione, né accettano obbedienti quel ch’egli impone secondo la
giustizia delle leggi, se non sentono l’autorità sua costretti dal coadunarsi di molto esercito. Onde
egli accade frequente che mentre il cittadino dovrebbe essere frenato sol dalla legge e il nemico
secondo la legge essere costretto dall’armi, essi veggono colui presso il quale come lor principe
dovrebbero trovar clemenza, aver più spesso ricorso alle armi per mantenere i diritti suoi. Di che
viene allo Stato un doppio danno, che il principe deve torcer sue cure al raccogliere un esercito per
tenere in freno i cittadini, e questi debbono esser costretti ad obbedire al principe non senza grave
dispendio della sostanza sua. Onde per la sua stessa ragione che il popolo è in tal caso colpevole
di improntitudine, vuolsi scusare il principe innanzi a Dio e agli uomini per la necessità del caso.
Tra le altre città di questa nazione, è principale ora Milano posta tra il Po e le Alpi. […] Ed è stimata
più famosa d’altre città non solo in ragione di sua maggiore ampiezza e del suo maggiore numero
d’uomini d’arme, ma sì anche perché entrano nella giurisdizion sua altre due città poste nella
regione medesima, ciò sono Como e Lodi. Quindi come avviene nelle umane cose pel blandir della
ridente fortuna, essa per tal modo si gonfiò in ardimento d’orgoglio, che non solo non s’astenne
dall’assalire i vicini suoi, ma perfino s’avventurò senza sgomento a incorrere nella recentemente
offesa maestà del principe.21
Nel 1154 Federico I discese nella penisola con l’intento di mettere fine allo stato di
continue tensioni e scontri tra le città italiche e di riprendere il controllo delle città del nord
e in pratica delle regalie, cioè dei tributi fiscali dovuti, ma disattesi, dalle città italiane.
Nella dieta convocata a Roncaglia nel 1158, dichiarò, perciò nulle, tutte le regalie di
cui i comuni si erano appropriati
Emanò, quindi, una costituzione sui diritti regi definendo i poteri pubblici che i
comuni italiani avevano esercitato di fatto negli ultimi decenni e dei quali voleva
riappropriarsi. Pose in questo modo una base giuridica alla lotta contro i comuni.
20 ibidem

28
Queste sono le regalie: le arimannie (le imposte personali percepite sugli uomini liberi, arimanni);
le strade pubbliche; i fiumi navigabili e quelli dai quali sono derivati i corsi navigabili; i porti (luoghi
di deposito di merci), i diritti percepiti all’attraversamento di un fiume (ripatici), le imposizioni
chiamate comunemente telonei (che colpivano le merci in transito su posti daziari); le monete; le
somme pagate come multe e penalità; i beni che si trovano senza titolare e quelli che per legge
vengono tolti a persone indegne, tranne quelli concessi a qualcuno con un provvedimento
speciale; i beni di coloro che contraggono nozze incestuose, quelli dei condannati e dei proscritti,
secondo quanto è stabilito nelle recenti costituzioni; le prestazioni riguardanti le angarie e le
parangarie (servizi imposti ai sudditi, come i trasporti), i carri e le navi; i contributi straordinari
imposti per la riuscita di una spedizione regia; il potere di costituire magistrature per
l’amministrazione della giustizia; le miniere d’argento; i palazzi pubblici nelle città dove esistono
per consuetudine; i redditi della pesca e delle saline; i beni di coloro che hanno commesso delitti di
lesa maestà; la metà dei tesori trovati in luoghi di proprietà imperiale […] o in luoghi di proprietà
ecclesiastica; in caso di collaborazione, tutto il tesoro spetta all’imperatore.22
Sono quindi diritti regali, quelli patrimoniali, il fodro e il diritto di nominare i magistrati
che amministravano la giustizia. I primi sono, per tradizione, appartenenti al demanio
dell’Impero: il controllo delle vie di comunicazione mediante dazi e pedaggi, la potestà di
coniare monete e di riscuotere multe, acquisizione di patrimoni privi di proprietari per
diversi motivi, disponibilità dei palazzi regi. Il fodro è la somma dovuta come sostegno per
le campagne militari al posto del servizio militare.
Nella situazione del momento, vista la sconfitta di Milano, i comuni italiani furono
costretti ad accettare le clausole imposte dall’imperatore. La realizzazione, però, dei
deliberati della dieta apparve subito difficile. Soprattutto in Lombardia dove era più vivo lo
spirito autonomistico.
In seguito a varie vicende Federico I fu battuto a Legnano dalle forze militari
milanesi. Il conflitto si concluse con la pace di Costanza nel 1183.
I Comuni dell’Italia settentrionale ottennero la loro autonomia in cambio di una
formale sottomissione all’Imperatore. L’atto si presenta come una pace “benignamente
accordata” dall’imperatore alle città della Lega lombarda (l’alleanza militare in cui si
unirono molti comuni della Lombardia, del Veneto, dell’Emilia-Romagna).
21 ibidem 22 Constitutiones et acta publica Imperatorum et regum, in Monumenta Germaniae Hostorica, Leges, IV, vol. I, a c. di L. Weiland, Hahn, Hannover 1893, pp. 244-245.

29
In nome della santa individua Trinità. Federico per divina clemenza Imperatore dei Romani
Augusto e suo figlio Enrico Re dei Romani Augusto. La mite serenità della clemenza imperiale
tenne sempre tal costume nel distribuire grazie e favori a’ suoi sudditi, che potendo e dovendo
punire con stretto rigore l’enormità dei delitti, tuttavia vuole reggere il Romano impero, e richiamare
l’insolenza dei ribelli alla debita fede e devozione, colla tranquillità della pace e coi pietosi affetti
della misericordia. […] per tanto abbiamo comandato di sottoscrivere e di confermare col sigillo
della nostra autorità la pace che nella presente pagina abbiamo loro benignamente accordata.tale
ne è il tenore e la serie.
Noi Federico imperatore dei Romani ed il nostro figlio Enrico re dei Romani concediamo a voi città,
terre e persone della Lega (dei comuni italiani) le regalie e le consuetudini vostre tanto in città che
fuori […] in perpetuo. Che nella città abbiate ogni cosa come avete avuto sin qui ed avete, fuori poi
esercitiate senza nostra contraddizione tutte le consuetudini come avete sino ad oggi esercitate.
Cioè sul fodro (diritto di prelevare foraggi sul contado), sui boschi, sui pascoli, sui ponti, sulle
acque e molini come usaste ad antico […] ed in tutte le l’altre cose che appartengono agli utili delle
città.23
23 In C. Vignati, Storia diplomatica della Lega lombarda (1867), Bottega d’ Erasmo, Torino 1966, pp. 375 ss.

30
Gli elementi costitutivi del comune come ente politico (R. Bordone) Nonostante il clima di continua sperimentalità istituzionale, il comune cittadino riuscì a
imporsi come vera entità politica all'interno e all'esterno della città, fondando la propria
struttura su tre elementi costitutivi che compaiono fin dagli anni dello scontro con il
Barbarossa e sono avvertibili nei trattati stipulati all'interno della Lega lombarda. In
questo trattato del 1168, si riconosce infatti alle città partecipanti il diritto di esercitare la
propria giustizia e di esigere imposizioni economiche all'interno di un territorio
giuridicamente circoscritto. Territorio, giurisdizione ed economia appaiono così gli
elementi indispensabili al funzionamento dell'ente cittadino e nei loro confronti i regimi
che si succederanno al governo rivolgeranno sempre le principali attenzioni.24 Tenore del breve che il marchese Obizzo Malaspina e i consoli di Cremona, Milano, Verona,
Padova, Mantova, Parma, Piacenza, Bologna, Brescia, Bergamo, Lodi, Como, Novara, Vercelli,
Asti, Tortona e Alessandria, città nuova, su proposta del comune di Lodi unanimamente hanno
accettato:
1. Nessuna persona del predetto marchese né delle predette città né di altre che sono o
saranno in tale alleanza arrestino qualcuno al posto di un altro di qualche città […] ma quando
ritengano uno debitore non solvente lo accusino e chi ha mancato sia arrestato dai consoli della
sua città e se i suoi consoli non lo avranno obbligato alla restituzione del pegno o all'ammenda
[…] entro quaranta giorni dopo la richiesta dei consoli di chi è stato defraudato o offeso, allora i
consoli della città del danneggiato avranno il potere di sequestrare i beni della città alla quale
appartiene la persona che ha contratto il pegno o ha commesso reato contro gli statuti, e
tratterranno ciò che hanno sequestrato […]
2. Nessuna città né il suddetto marchese accolgano qualcuno bannito dai propri consoli, e se lo
avranno accolto nel loro territorio entro i quindici giorni successivi alla richiesta presentata dai
consoli o dal marchese che lo hanno posto al bando, lo allontanino dal loro dominio e territorio e
in seguito non lo accolgano di nuovo, se non quando sarà assolto dal bando dai propri consoli
3. Nessuna persona e nessuna città riscuota dazi o pedaggi nuovi sul proprio territorio […] e
stabilisca qualche patto che sia ostile a questa lega comune e alleanza fra le città.
4. Se il suddetto marchese o qualche città avrà agito contro la lega stabilita fra le città, o si sarà
rifiutata di rendere giustizia a qualche città alleata, tutte le altre città sono tenute ad aiutare
quella che avrà richiesto giustizia o subito il torto, fino a che non si torni in pace e concordia
dopo aver ripristinato la giustizia.
Fonte: MANARESI (a cura di), Gli atti del comune di Milano cit., doc. 64, pp. 93-95.
24 R. Bordone, La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

31
4. Dal comune podestarile al comune popolare
Gli statuti
Successivamente allo scontro con l’impero, i comuni cominciarono a dotarsi di statuti:
elaborarono un proprio modello normativo, promulgando leggi e controllandone
l’applicazione.
Tra XI e XII secolo, infatti, i comuni non si erano dotati di un proprio corpo di leggi,
fatta eccezione per le formule di giuramento dei consoli e dei cittadini.
Dopo la pace di Costanza si ebbe una gran fioritura di statuti comunali: i comuni
avevano ormai acquisito maturità in quanto organismi d’autogoverno. Adesso il comune
stabilisce le proprie norme di diritto privato e di diritto penale e procede – poi – alla
revisione degli stessi statuti, in base ai cambiamenti della vita cittadina. La revisione è
affidata a magistrati e giurisperiti (reformatores, correctores). La cura del diritto statutario
spettava ai giudici comunali, che potevano far ricorso per casi particolari, non previsti dagli
statuti, al diritto comune o alla consuetudine. Lo statuto riuniva in un unico testo legislativo
le norme sulle quali si reggeva la vita del Comune.
L’elaborazione degli statuti diede origine ad un contenzioso con il vescovo che non
voleva rinunciare alle prerogative e ai poteri da tempo acquisiti e rivendicava, anzi, un
ruolo di controllo sul governo comunale. Il comune forte della legittimazione acquisita con
la pace di Costanza, non solo non cedette, ma rivendicò anche il controllo esercitato dal
vescovo su beni, domini e diritti della curia cittadina vescovile, contestandone i privilegi.
L’intensa attività legislativa in collaborazione con i giuristi permise di armonizzare il diritto
statutario cittadino con quello comune.
5. Il comune podestarile
Si è detto che il Comune nacque come sperimentazione di autogoverno. La società
dell’epoca, in continua evoluzione richiese costantemente di adeguare gli istituti esistenti
attraverso prove ed aggiustamenti.
Le frequenti discordie tra i consoli crearono l’esigenza di sostituire al collegio dei
consoli un magistrato unico con il titolo di podestà, concentrando, così, il potere esecutivo
nelle mani del singolo. Ciò permise di prendere decisioni tempestive in condizioni difficili,
mentre i collegi consolari molto ampi spesso non giungevano a decisioni per diversità di

32
vedute al loro interno, oppure impiegavano tempi troppo lunghi. Un governo “individuale”
permetteva di agire senza incertezze e rapidamente.
L'origine dell'ufficio podestarile a Genova (R. Bordone) Le concorrenze di prestigio e di potere all'interno dell'originaria classe di governo –
spesso sfociate nel ricorso consueto alle guerre private – contribuiscono a provocare una
trasformazione istituzionale del sistema: la nomina di un solo ufficiale, il podestà, al quale
sono affidati i compiti che in precedenza spettavano ai consoli. Semplificando il processo,
ma con viva attenzione al clima di violenza che lo accompagna, il cronista genovese
Ottobono Scriba racconta come nella sua città si giunse all'affermazione del regime
podestarile.25 A causa dell'invidia di molti che desideravano smodatamente di ottenere l'ufficio comunale di
console, molte discordie civili e odiose cospirazioni sono sorte nella città [di Genova]. Sicché
accadde che i sapienti e i consiglieri della città si riunirono insieme e convennero di comune
accordo che dall'anno successivo [1190] terminasse il regime consolare e stabilirono quasi
all'unanimità di avere in futuro un solo podestà. A ricoprire tale ufficio fu eletto Manigoldo di
Tetocio, bresciano, e felicemente fu costituito. Ma mentre egli era in città col compito a lui affidato
e concesso dai consoli del comune di esercitare la giustizia criminale e durante una riunione, in
casa dello scriba comunale Ogerio Pane, dei consoli [uscenti] che esaminavano la contabilità del
consolato ormai al termine, ecco che Fulchino e Guglielmo Balbo, figli di Anselmo de Castello,
commettono un gravissimo delitto. Con l'inganno e senza ragione alcuna uccidono infatti
Lanfranco Pepe, persona nobile ed egregio console. Riprendono in seguito a ciò le discordie civili
e le divisioni, ma il giorno seguente al delitto quell'uomo egregio del podestà Manigoldo, toccato
da grave dolore e da vergogna per ciò che era successo, riunisce un parlamento generale e,
indossata la corazza e prese le armi, monta a cavallo, si reca allo splendido palazzo che Fulco
aveva in Castello e lo distrugge per punizione del delitto compiuto, anche se non riesce a
catturare gli assassini che intanto avevano lasciato la città e si erano nascostamente rifugiati a
Piacenza.
I consoli di giustizia continuarono intanto a trattare con onestà le cause dei cittadini, rendendo a
ciascuno giustizia senza contrasti. Fonte: BELGRANO (a cura di), Annali genovesi cit., II, pp. 36-37.
25 R. Bordone, La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

33
Durante lo scontro con l’imperatore, poi, l’aver scelto come magistrato unico
cittadini che godevano di giurisdizioni feudali o inseriti nell’amministrazione vescovile,
aveva consentito di stabilire una sorta di continuità legale tra il passato e il presente.
La figura del podestà (il termine deriva da potestas, sostantivo astratto con il quale
si designava colui che esercitava un potere in nome di una suprema autorità), comincia ad
emergere dalla metà del XII secolo. E’ individuato come una figura preminente, designata
come prior ex consulibus, primus consul, dominus, magister. Compaiono anche i titoli di
dominus civitatis, rector, gubernator, potestas. Titoli tutti, che alludevano al governo
personale del singolo al posto di quello collegiale.
Al podestà facevano capo una somma di Consigli e cariche amministrative con
differenti competenze e, nel nuovo sistema razionalmente elaborato, a lui spettava il
potere esecutivo, mentre quello legislativo era prerogativa del Consiglio.
I primi podestà furono scelti tra i cittadini. Successivamente furono tratti da città
vicine, allo scopo di una maggiore obiettività ed estraneità alle rivalità locali. In seguito si
formò una categoria professionale di podestà. Si trattava di funzionari che per mestiere
governavano delle città temporaneamente, che si spostavano con il loro gruppo di
collaboratori di città in città, per risolvere le questioni che venivano poste loro. Questo
spostarsi favorì la progressiva omogeneizzazione delle leggi e delle istituzioni. Le regioni
finirono per modellarsi su schemi comuni.
I modi di elezione del podestà, come quelli dei consoli, variarono da luogo a luogo.
Solitamente era eletto dagli organi consiliari del comune mediante un meccanismo misto
di elezione e sorteggio. Assumendo la carica egli doveva prestare giuramento.
Viene stabilito che il signor podestà deve prestare giuramento e sotto la sua responsabilità penale
deve restare fedele alla formula di giuramento che segue. Non appena sarà entrato in città, senza
scendere da cavallo se prima non sarà venuto nella piazza del comune, dirà quanto segue di
fronte all’arengo (assemblea popolare): Giuro sui santi Vangeli che reggerò e guiderò la città di
Como e il suo distretto e i loro abitanti per tutto il tempo della mia carica, in buona fede, senza
frode, messo da parte ogni odio, amore e timore, senza tener conto dei compensi o pressioni
indebite e così pure dei danni o vantaggi materiali che io o altri potrebbero trarre, con lo scopo di
accrescere l’utilità e il buono stato del comune di Como e del suo distretto, secondo le sue
consuetudini scritte e, in mancanza di disposizioni negli statuti e nelle consuetudini, secondo il
diritto e l’equità. Mi darò da fare in tutti i modi possibili affinché il comune di Como e tutti i suoi
possessi e privilegi si rafforzino secondo giustizia e, se in qualcosa verrò meno, per quanto posso

34
rimedierò. Non farò e non permetterò che siano fatti furti, danni o rapine contro i beni del comune
e, se ciò accadesse, non appena lo verrò a sapere, provvederò a recuperarli. Consegnerò e farò
consegnare al comune un resoconto mensile su ciò che è stato dato e ricevuto e su ciò che è
rimasto presso i depositi di viveri, fino all’ultimo denaro, debitamente annotato dagli addetti al
controllo dei depositi e dai notai […] . farò leggere questo resoconto ogni mese nel consiglio
generale del comune, convocato secondo l’uso al suono delle campane, fino all’ultimo denaro e
fino all’ultimo carico di granaglie, secondo quanto piacerà al consiglio. 26
Insieme alle modalità di elezione, gli statuti comunali stabilivano la data di inizio
dell’incarico e la sua durata, i collaboratori del podestà, il compenso che gli spettava.
Il mandato durava solitamente un anno (nella seconda metà del XIII secolo sei
mesi) e veniva avviato in un giorno di una festività solenne, per esempio il Natale, la
Pasqua e l’Annunciazione.
Poiché nessuna città può reggersi ordinatamente se non ha magistrati che la governino, e
senza questi sarebbe vano emanare leggi e statuti, volendo provvedere al governo della città,
stabiliamo e ordiniamo che prima del Natale, e precisamente nella festa di Santa Lucia, per ordine
del podestà o dei consoli in carica, al suono della campana e del corno, com’è costume, il popolo
della città di Noli si raccolga nel Palazzo del Comune, dagli anni venti ai settanta, uno per ogni
famiglia. In quel giorno, davanti al popolo, per mezzo del podestà o dei consoli, si proponga se
nell’anno seguente la città di Noli debba essere retta dal podestà oppure dai consoli; a ciascuno
dei presenti all’assemblea si diano due petruzze, una bianca e una nera, e coloro che vorranno
dare risposta affermativa deporranno la petruzza bianca, coloro che vorranno darla negativa, la
nera in un sacchetto o in un bossolo, che lo scrivano comunale terrà nelle mani.
Nel caso sia prevalsa la decisione di eleggere il podestà, entro quindici giorni i consoli e i
consiglieri della città di Noli eleggano il podestà con la seguente procedura: sentita la proposta dei
consoli, colui che otterrà più voti, pronunciati oralmente, sia il podestà in quell’anno; se poi due,
entrambi nominati nel detto consiglio, abbiano pari numero di voti, i loro nomi siano scritti dai
signori consoli in due schede e queste siano deposte in un sacchetto o in un berretto, e colui il cui
nome è scritto nella scheda estratta, sia il podestà ed abbia il governo della città di Noli nell’anno
per il quale è stato eletto. 27
26 Tratto dagli statuti di Como del 1335. In Per lo studio dell’ordinamento giuridico del comune medievale, op. cit., p. 520. 27 Nel momento in cui fu redatto questo statuto del Comune di Noli, risalente al XIII secolo, il governo della città non era ancora affidato in modo permanente al podestà. Da Gli statuti di Noli, a cura di L. Vivaldo, nella riduzione degli autori in Beniamino Proto, Guida alla conoscenza storica, II, APE Mursia, 1988.

35
Una volta terminato il suo mandato, l’operato del podestà veniva sottoposto a
giudizio (sindacato).
Il podestà poteva essere rieletto, ma ciò non si verificò che raramente.
Si richiedeva al podestà di portare con sé, per l’espletamento del suo lavoro, una
squadra di collaboratori di cui si faceva garante. Prima questa era ridotta al minimo,
comprendendo un giudice, un cavaliere ed alcuni uomini armati. In un secondo tempo il
nucleo iniziale essenziale si ampliò e fu composto da giudici, notai, uomini d’arme (fanti e
cavalieri), famigli.
In questo modo le funzioni del podestà cominciarono ad essere distinte: la funzione
giudiziaria spettava allo iudex potestatis , la funzione di polizia urbana al miles potestatis.
Negli statuti del comune sono indicate le funzioni del podestà.
In nome di Dio, amen. Io, che sono rettore della città di Parma, giuro che, in buona fede,
senza inganni, messo da parte ogni odio, amore e timore, o compenso indebito, renderò giustizia
in tutte le cose a tutte le persone del distretto di Parma, sia chierici che laici, di persona o
attraverso un mio funzionario, secondo legge e giustizia, conformemente ai buoni costumi e
consuetudini e agli statuti della città di Parma. Mi occuperò di tutte le controversie portate di fronte
a me e insorte fra le predette persone.28
Il podestà riceveva un onorario per il suo intervento, comprensivo del pagamento
degli ufficiali del suo seguito. Nel corso del XIII secolo questo compenso aumentò sia per il
maggior numero degli accompagnatori, sia perché il podestà era diventato un competente
specialista, che chiedeva, pertanto, compensi adeguati al suo ruolo.
I podestà professionali sono funzionari specializzati che si dedicano, in qualità di
professionisti, all’amministrazione della città. Questa figura professionale si affermò a
partire dalla fine del XII secolo, quando sono presenti governi podestarili con maggiore
frequenza rispetto a quelli consolari.
Al podestà spettava di far funzionare il governo della città. Egli svolgeva il suo ruolo
secondo criteri in modo imparziale, non appartenendo a gruppi e fazioni, né subendone
l’influenza. Doveva garantire l’ordine e l’efficienza dell’amministrazione; scoraggiare l’uso
privato delle istituzioni, la prepotenza dei maggiorenti e i conflitti con le vecchie classi
dirigenti.

36
La sua azione avveniva all’interno degli statuti del comune e rendeva operative le
delibere dei Consigli comunali.
All’interno di questo spazio il podestà, però, godeva di una certa autonomia;
partecipava ai lavori dei Consigli comunali e alle principali decisioni politiche prese in essi;
coordinava gli uffici municipali, emanava decreti con valore di legge.
In quanto giudice massimo amministrava la giustizia. Curava, inoltre, la vita
associata, comandava le milizie militari, manteneva l’ordine pubblico, controllava le
infrastrutture e le opere pubbliche, faceva rispettare le scadenze istituzionali.
L’obiettivo era controllare gli uffici e la cariche, in una parola la giurisdizione
cittadina, di fronte alla complessità di apparati burocratici che, all’estendersi della città, si
era venuta creando.
Questi uomini di governo assommavano nelle proprie mani responsabilità civile e
militare.
Per diventare podestà bisognava possedere attitudini e conoscenze di carattere
teorico e pratico.
28 Gli statuti del comune di Parma del 1255 riordinano diversi documenti istituzionali, risalenti ai decenni precedenti. In Per lo studio dell’ordinamento giuridico del comune medievale, a c. di U. Nicolini, Celuc, Milano 1972, p.485.

37
La transizione al Comune “podestarile” (K. Bosl)
“Nel collegio consolare già da parecchio tempo si era delineato il predominio di un
console. La politica del Barbarossa non aveva fatto altro che incrementare la tendenza
già in atto a sostituire il collegio consolare con un unico funzionario, che proveniva dalla
massa dei cittadini, ma che disponeva di titoli giuridici feudali come pure di importanti
incarichi nell’amministrazione vescovile e che quindi era conforme alla legalità e alla
tradizione del Comune. Questi capi magistrati erano per lo più chiamati potestas,
volendosi esprimere in tal modo la delega dei diritti sovrani e di dominio che veniva
assunta da un’autorità suprema. […]
I primi podestà erano cives e appartenevano alla nobiltà, possedevano pratica di
amministrazione e di strategia militare, possedevano una cultura giuridica e innanzitutto
manifestavano grande energia nel difendere i diritti della città e nel perseguire e imporre
i suoi obiettivi. Questo gruppo di “esperti” spesso non esauriva la propria funzione di
podestà in una sola città, ma inviava i suoi membri in altre città, nelle quali assolvevano
insieme ai loro collaboratori le stesse funzioni. La carica di podestà si trasformò in
carriera professionale aperta ai membri di determinate famiglie.
Il podestà rappresentava il supremo organo esecutivo del Comune ed era presidente
del Consiglio, capitano delle truppe del Comune, giudice supremo. Il gran numero di
competenze che erano riunite nelle sue mani determinò il rafforzamento del controllo
esercitato dal Consiglio maggiore o minore; infatti il rischio di una dittatura era assai
prossimo. […] in questo sistema il potere esecutivo era nelle mani del podestà, quello
legislativo invece era di competenza della totalità dei cittadini. Questo sistema di
governo era assai più avanzato rispetto a tutti i sistemi di governo dell’Europa di quel
tempo”.29

38
6. Le organizzazioni di popolo
Verso la metà del XIII secolo, il popolo medio e minuto, organizzato nelle sue “arti”,
cercò di conquistare più ampie opportunità di rappresentanza politica, conquistando uno
spazio nella vita pubblica cittadina.
In opposizione al “Comune maggiore” si costituì, stato entro lo stato, il “Comune del
popolo”, del quale facevano parte i membri delle corporazioni.
Gli ordinamenti del “Comune del popolo” erano modellati su quelli del “Comune
maggiore”. Alla guida, infatti, troviamo un capitano del popolo di fuori città; accanto a lui
agiva un Consiglio degli anziani e talvolta un Consiglio generale di tutti gli artigiani.
Questa situazione portò nel Duecento quasi tutti i comuni italiani ad uno stato
permanente di guerre interne, che si intrecciava con il conflitto rinnovato tra papato e
impero.
Come già nel XII secolo, si schierarono Guelfi contro Ghibellini, allo scopo di
concentrare il potere nelle mani di una fazione, governare con precisi interessi di parte.
In questa situazione si sentì l’esigenza di un governo forte che dirimesse le
discordie. Per lunghi periodi o a vita, contro i pericoli interni ed esterni, furono concessi
ampi poteri ad una figura unica, un “signore” .
Ormai, pur in presenza delle magistrature comunali, il Comune non esiste più. Con
il Trecento, dal processo di dissoluzione del Comune, sorgerà la Signoria. 30
29 Karl Bosl, L’Europa medioevale, III, trad. M.Keller, in Nuova Storia Universale, Utet 1983, pp. 1748-1749 30 La sintesi è giustificata dal fatto che il “Comune del popolo”, il “governo delle arti” e la “Signorìa” esulano dai limiti cronologici del programma del II anno.

39
7. Il caso di Venezia
Venezia costituisce un caso a sé, nel quadro italiano. Città di fondazione medievale,
non vide una forte presenza feudale nel suo processo di formazione, non conobbe né la
signoria territoriale né la fase del governo del vescovo. Originariamente ebbe una
struttura istituzionale particolare: un ordinamento politico oligarchico, con a capo il doge
(variante veneziana di duca, cioè “condottiero”, dal latino dux).
Il doge era eletto a vita da organi rappresentativi dei ceti dirigenti della città. Era il
primo magistrato. Esercitava il governo sulla città insieme ad un complesso di istituzioni
con cui condivideva il potere.
Ciò che rende particolare la storia veneziana è la collocazione geografica della città.
In quanto laguna, isolata dalle coste venete, non fu mai assoggettata all’Impero, ma fu
lungamente legata a Bisanzio.
Poiché la laguna aveva poche terre, nonostante l’inurbamento di famiglie nobiliari,
la città non ebbe in origine un’aristocrazia terriera molto forte.
Soprattutto veniva sfruttato il sale che si ricavava dalla laguna. Ed è commerciando
sale che i veneziani iniziarono la loro attività mercantile.
Nei secoli dal IX al XI il doge era una specie di monarca dagli illimitati poteri.
Amministrava la giustizia e garantiva i diritti di tutti, nelle vesti di rappresentante unico
della comunità.
Le grandi famiglie operavano unitariamente sotto la guida del doge. Nessuna ebbe
bisogno di rivendicare proprie zone di interesse nelle aree lagunari.
Il doge era scelto tra i membri delle famiglie più illustri; era eletto dall’assemblea
generale (concio), alla quale partecipavano tutti gli uomini liberi della cittadinanza
veneziana.
Al momento dell’assunzione della carica egli si impegnava a rispettare e a
mantenere in vigore le istituzioni sociali cittadine.
Accanto al doge operava, oltre all’assemblea, una corte popolare di giustizia che
accoglieva, a diversi livelli, cittadini di tutti gli ordini (maiores, mediocres, minores).
Verso la fine del secolo XI un élite di famiglie cominciò a distinguersi per ricchezza
e prestigio economico grazie ai traffici con l’Oriente. Desiderosa di far valere la propria
preminenza sociale, diede origine al comune di Venezia (comune Veneciarum), che fu,
quindi, l’espressione del controllo politico-economico da parte delle maggiori famiglie.

40
La stessa elezione del doge non spettò più all’assemblea cittadina, ma ad una
commissione di saggi, provenienti dall’aristocrazia mercantile. Lo stesso doge fu scelto in
questa cerchia.
Chiaramente i suoi poteri cominciarono ad essere limitati.
Dalla metà del XII secolo, infatti, il doge governa assieme ad organi collegiali tra cui
il Maggior Consiglio, in cui sono rappresentati i grandi interessi commerciali della città.
Ad esso spettano i compiti di governare la città e gestire la pubblica
amministrazione, eleggere i magistrati e gli organismi consiliari cittadini (Consigli minori e
commissioni con compiti specifici), emanare leggi e regolamenti, esercitare il controllo
giudiziario e finanziario.
Data la complessità di questa gestione, il Maggior Consiglio dette vita ad una serie
di istituti di supporto.
Nacquero il Consiglio dei Quaranta (o Quarantia) e il Minor Consiglio. Il primo
elaborava linee di politica monetaria e finanziaria, che andavano sottoposte al Maggior
Consiglio per l’approvazione; si occupava anche di amministrare la giustizia.
Il Minor Consiglio, formato da solo sei membri, provenienti dal Maggior Consiglio,
affiancava il doge nella preparazione degli atti di governo, che sarebbero stati sottoposti
all’esame del Maggior Consiglio.
Il doge, eletto da questo organo, godeva di grande prestigio formale, ma non
esercitava poteri reali.
La prima commissione ufficiale per designare il doge risale al 1172, ma la sua
forma più compiuta risale al 1268.
Era eletto con una procedura complessa per evitare sia mire ambiziose, sia rivalità
familiari nell’aspirare alla massima carica dello stato.

41
La complessa procedura per l’elezione del doge di Venezia (Martin da Canal)
I nobili consiglieri fecero riunire quel giorno stesso dopo l’ora di nona il Maggior Consiglio, e
fecero per ogni membro una piccola ballotta (palla) di cera; e dentro trenta di quelle ballotte di
cera stava, in ciascuna un pezzetto di pergamena scritto, che diceva “elettore”; e ciascuno ne
prese una; e i consiglieri e i capi dei Quaranta le rompevano una per una sotto gli occhi di tutti;
e là dove trovavano dentro l’indicazione “elettore”, quegli per il quale essa era stata estratta
andava a sedersi in un posto mentre essi facevano ritirare quegli altri per i quali non trovavano
scritto niente: e si procedette nel modo che vi dico finchè ci furono trenta elettori. […] E quando
essi ebbero giurato davanti al Consiglio, quei trenta nobiluomini rimasero nel Palazzo in una
stanza, e gli altri scesero giù dal Palazzo e se ne andarono. E i trenta uomini che rimasero nel
Palazzo fecero trenta ballotte di cera, e in ciascuna di nove tra esse stava un pezzetto di
pergamena con la dicitura “elettore” , e ciascuno di loro prese la sua, come aveva giurato. E
quelli dentro la ballotta dei quali veniva trovato il pezzetto di pergamena con la dicitura “elettore”
rimasero nel Palazzo, e gli altri andarono via; e sappiate che furono nove gentiluomini […]
Questi nove si riunirono ed elessero quaranta Veneziani ed ebbero podestà di eleggere , con
non meno di sette voti, sia chi faceva parte del Consiglio che tra chi ne era fuori. […] Quando
[…] il vicario del dogado, e i nobili consiglieri e i [tre] capi dei Quaranta conobbero i nomi dei
quaranta uomini che i nove avevano eletto, li fecero subito venire al Palazzo, e fecero quaranta
ballotte di cera, tra le quali ne stavano dodici che contenevano dei pezzetti di pergamena con la
dicitura “elettore”. E quando essi furono riuniti, le quaranta ballotte stavano dentro un cappello,
e c’era là un bimbo di undici anni: e quando uno si faceva avanti per aver la ballotta, si diceva
al bimbo: “Metti una mano nel cappello e prendi una ballotta di cera per questo qua “ e gliene si
faceva il nome. E il bimbo la prendeva e la dava ai consiglieri, ed essi la rompevano alla
presenza di tutti; e se vi trovavano dentro la pergamena con scritto “elettore”, facevano sedere il
designato; e se non vi trovavano scritto niente, quegli se ne tornava indietro; e il bimbo continuò
a dare ballotte finché essi trovarono dodici uomini.[…] Quei dodici nobiluomini, quand’ebbero
fatto il giuramento, si recarono in un stanza, e, secondo il giuramento, elessero venticinque
uomini; e […] li fecero riunire nel Palazzo, ed essi fecero venticinque ballotte, come avevano
fatto gli altri secondo la procedura: e tra quelle venticinque ballotte ce n’erano nove che
contenevano pezzetti di pergamena con la dicitura “elettore”. […] E dovevano eleggere
quarantacinque uomini con non meno di sette voti […] Quando quei quarantacinque furono
riuniti nel Palazzo, fecero quarantacinque ballotte di cera e in undici di esse misero dei pezzetti
di pergamena con la dicitura “elettore”. […] e sappiate che quegli undici dovevano eleggere
quarantun uomini con non meno di nove voti […] e quei quarantuno dovevano eleggere il doge
con non meno di venticinque voti. […] e li fecero giurare davanti al Consiglio di eleggere il doge
secondo la procedura che era stata comunicata al popolo nella chiesa di messer san Marco e

42
che il popolo aveva approvata, giurando ciascuno sulla sua anima di tenere per doge e per
signore quegli che sarebbe stato eletto dai quarantuno, secondo la procedura che era stata
preparata dagli uomini che erano stati eletti dal Gran Consiglio […]31
Il doge, i membri del Minor Consiglio e i tre capi del Consiglio dei Quaranta
costituivano insieme la Signoria, cioè l’organo al vertice che elaborava le proposte da
sottoporre ai Consigli.
Esercitavano, inoltre, funzioni di controllo del rispetto delle norme che garantivano il
buon funzionamento delle istituzioni comunali; prendevano le decisioni nei momenti di
crisi.
Con lo sviluppo mercantile e commerciale si assistette ad un rimescolamento
sociale e all’emergere del ceto popolare. Sotto la pressione di questo ceto, nella metà del
Duecento, si costituì un nuovo Consiglio, quello dei Pregadi o Rogati (detto anche
Senato), dotato di ampi poteri, aperto alla partecipazione anche di membri che non
appartenevano all’antica aristocrazia.
La nascita, nel tempo, di coalizioni e di interessi di parte finì con il dar vita ad un
gruppo oligarchico, che rappresentava gli interessi economici della città. Questa nuova
oligarchia sancì formalmente il proprio monopolio politico attraverso la serrata del Maggior
Consiglio.
Con la quarta crociata Venezia aveva conquistato importanti territori in Oriente: e la
spartizione delle terre tra i vincitori diede luogo alla nascita dell’impero marittimo della
Serenissima, importante potenza commerciale e politica.
Dalla seconda metà del secolo XIII, in politica estera, Venezia mirò a mantenere la
supremazia commerciale in Oriente, a espandersi nell’entroterra veneto, a controllare il
golfo adriatico, da Ravenna a Trieste.
Nonostante l’antagonismo di Genova, a seguito di alterne vicende Venezia riuscì a
mantenere la propria indipendenza, a conservare i suoi possedimenti ed il suo ruolo
economico; si assicurò, inoltre, il controllo delle vie di comunicazione, verso la pianura del
Po e le Alpi e il dominio sul Polesine e sulla Romagna.
Ed era stata proprio l’esigenza di stabilità, necessaria per affrontare così complessi
compiti interni e esterni, ad accelerare tutti i processi politici.
31 La complessa procedura per l’elezione del doge di Venezia, riportata dal cronista Martin da Canal, fu adottata in occasione dell’assunzione della carica da parte di Lorenzo Tiepolo, nel 1268. Martin da Canal, Les estoires de Venice, a.c. di A. Limentani, L. Olschki, Firenze 1972, pp.271-279

43
Le coalizioni e gli interessi di parte,poi, finirono con il dar vita ad un gruppo
oligarchico, che rappresentava gli interessi economici della città. Questa nuova oligarchia
sancì formalmente il proprio monopolio politico attraverso la serrata del Maggior Consiglio.
Nel 1297, durante il conflitto con Genova. Pietro Gradenigo, doge dal 1289 al 1311,
attuò la serrata del Maggior Consiglio. Prima di allora il Maggior Consiglio era composto
da magistrati o ex magistrati, e da membri con incarico annuale.
Attuando la riforma l’accesso al Consiglio fu consentito solo a coloro le cui famiglie
avevano rivestito cariche pubbliche negli ultimi quattro anni.
Poiché, però, il Minor Consiglio era costituito da membri provenienti dal Maggiore, e
ad esso spettava l’elezione dei componenti della Quarantia e l’elezione del Senato, il
controllo sul Maggior Consiglio significava il controllo sulle magistrature cittadine.
In tal modo il governo della città fu consegnato nelle mani di un gruppo chiuso di
famiglie.
Questa oligarchia manterrà il potere sino alla fine del XVIII secolo.

44
8. Le città del Mezzogiorno
Le città del Mezzogiorno seguirono uno sviluppo differente rispetto a quelle
settentrionali. La particolare varietà delle vicende meridionali non rende immediatamente
confrontabili le esperienze municipali realizzatesi al Sud con quelle verificatesi al Nord.
A lungo la tradizione storiografica ha attribuito la responsabilità del mancato
sviluppo dei centri meridionali, soprattutto costieri, che pur alla fine del XI secolo
intessevano rapporti commerciali all’interno del bacino mediterraneo, alla monarchia
normanna. Quest’ultima, trovando il proprio vantaggio economico nell’economia rurale,
avrebbe frenato lo sviluppo delle città.
La successiva formazione di un regno unitario, nel 1130, sotto Ruggero II, che
aveva vasti interessi fondiari, avrebbe accentuato la politica anticittadina. Le città
avrebbero visti ostacolati e soffocati il libero sviluppo delle attività mercantili e il loro
desiderio di autonomia politica.
Attualmente la ricerca storiografica rende necessario chiedersi quanto siano state
effettivamente sentite queste aspirazioni autonomistiche.
Nel Mezzogiorno, infatti, gli interessi dei ceti dominanti risultarono convergenti nel
progetto politico dei signori dominanti.
E’ evidente che non ci furono rivendicazioni autonomistiche al Sud da parte del
comune. Non si sentì l’esigenza di battere moneta, legiferare, disporre di un esercito. Non
si rinnovarono gli ordinamenti e gli istituti municipali, non si crearono quelle alleanze
intercittadine che avevano portato alla difesa delle istituzioni comunali al Nord.
Le città del Mezzogiorno rimasero chiuse ciascuna in se stessa, “nella difesa delle
consuetudini locali, della libertà di scelta, o almeno della facoltà di condizionare la scelta
dei propri amministratori” . 32
In pratica la monarchia normanna non pregiudicò né ostacolo l’organizzazione
comunale delle città nel corso del XII secolo.
I sovrani normanni confermarono tutte le consuetudini vigenti all’interno del Regno,
comprese quelle relative all’ordinamento delle comunità cittadine, se non contrastavano le
norme legislative generali.
Ciò che fece la reale differenza con le città settentrionali fu un gioco di interessi: da
una parte le classi dirigenti locali avevano interesse ad ottenere l’appoggio del potere
regio (sul piano politico, militare, giurisdizionale); dall’altra il potere regio rafforzò il potere
32 G. Galasso, Dal Comune medievale all’Unità. Linee di storia meridionale, Laterza, Bari, 1969, p.65, in Elisa Occhipinti, L’Italia dei Comuni, Secoli XI-XIII, Carocci editore, Roma 2000, p.79.

45
delle famiglie dominanti all’interno della comunità cittadina, assicurandosi in questo modo
il controllo locale dei territori.
L’aver ottenuto un vantaggio reciproco da questo accordo non portò alla collisione
tra l’esigenza di un governo monarchico centralizzato e le abitudini autonomistiche
cittadine.
Il punto di equilibrio fu trovato nella nomina regia di un magistrato scelto dalla
comunità, che garantiva l’esercizio da parte del municipio dei propri poteri amministrativi e
dei diritti consuetudinari.
Questa organizzazione cittadina si mantenne anche durante la crisi del governo
centrale dopo la morte di Enrico VI e nel clima di incertezza dovuto alla minore età di
Federico II.
In questo frangente alcuni città meridionali strinsero accordi con Venezia e
Marsiglia, ma allo scopo di garantire la difesa e la sicurezza cittadina, e non per
conquistare spazi autonomistici.
Questa situazione si mantenne anche durante la prima fase del dominio angioino,
fino cioè al passaggio della Sicilia agli Aragonesi.

46
Parte Terza
UNITA’ DIDATTICA “I COMUNI CITTADINI IN ITALIA (SECC. XI-XIV)”
COLLOCAZIONE DIDATTICA Classe II D dell’I.T.C. “P. Verri” di Milano, indirizzo linguistico, in via Lattanzio. Questa
scuola accoglie ragazzi provenienti da un contesto socio-culturale medio-alto, che hanno
ricevuto numerosi stimoli culturali già in famiglia.
La classe è composta da diciotto studenti: undici maschi e otto femmine. E’ una delle
poche classi dell’istituto in cui non sono presenti alunni stranieri. Il livello è
sostanzialmente omogeneo, sia come estrazione sociale, sia come uniformità sul piano
culturale. I ragazzi sono motivati ad apprendere, interessati e pronti all’ascolto, tranne un
gruppo di quattro alunni, che necessita di guida nell’individuazione e nell’applicazione di
un metodo di studio.
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA La scelta dell’argomento si motiva perché l’Italia ha nel Comune la sua espressione
storicamente più rilevante. E’ un argomento essenziale per comprendere come si sono
formate le nostre istituzioni. Permette, inoltre, di collegarsi al discorso già introdotto della
centralità della città nella storia d’Italia. Può costituire il filo conduttore di una possibile
legittimazione storica dell’Italia unita, al di là dalle differenti realtà e, ugualmente, stare alla
base del programma federalista.
In particolare si è preso in esame “il periodo compreso tra i secoli XI e XIII durante il quale
le città vengono configurandosi come realtà nettamente distinte dal mondo circostante,
con una nuova classe dirigente, con proprie libertates o privilegi o autonomie, la cui
consistenza varia nelle diverse situazioni ed è massima nei comuni italiani […] “
[ G. Pennacchietti, in Il medioevo a scuola, Nuova Secondaria, n.3, 2005, pag.69] Al tempo stesso ci si è preoccupati di presentare gli argomenti in un continuo lavoro
interpretativo e con modalità d’apprendimento partecipativo, sia perché non sembrasse un

47
percorso didattico già confezionato, sia per far emergere la domanda personale degli
studenti verso la storia, in un rapporto dinamico tra presente e passato.
PREREQUISITI
CONOSCENZE
- Conoscere l’organizzazione delle città nell’Italia altomedievale
- Conoscere le vicende relative al conflitto Papato-Impero
- Conoscere la ripresa dopo il Mille
ABILITA’
- Saper collocare i fatti nel tempo e nello spazio
- Individuare i nessi di causa/effetto
- Saper collocare una fonte storica
- Conoscere i termini specifici della disciplina
COMPETENZE
- Saper individuare gli elementi significativi di un testo
- Schematizzare i contenuti dei documenti
- Utilizzare e commentare i dati
OBIETTIVI Al termine del percorso lo studente dovrà essere in grado di:
CONOSCENZE
- Conoscere il ruolo della città e il significato del Comune nella ripresa dopo il Mille
- Conoscere la diffusione e l’intensità del fenomeno comunale in Italia
- Conoscere l’ordinamento sociale e quali classi sociali hanno, all’inizio, un ruolo di
rilievo nel sorgere del Comune

48
- Conoscere la storia interna del Comune: periodo del consolato, podestarile, del
governo delle “arti”
- Conoscere perché e quando la volontà autonomistica dei comuni italiani venne a
conflitto con l’Impero germanico
- Conoscere la conclusione del conflitto tra Federico I e i comuni
- Conoscere la situazione politica, economica e sociale dell’Italia centro-settentrionale e
dell’Italia meridionale
- Conoscere le principali vicende istituzionali del Comune di Milano
- Conoscere il comune oggi
ABILITA’
Saper collocare la fase della storia del Medioevo, che coincide con la nascita e
l’affermazione dei comuni in Italia, nel periodo compreso tra l’XI e il XIV secolo.
Comprendere come la crisi dell’autorità vescovile sulla città, determinò l’apertura di
ampi spazi per la gestione laica dei poteri di controllo, favorendone il passaggio alla
comunità cittadina.
Comprendere come la richiesta di innovazioni politiche e amministrative, fu anche la
risposta a trasformazioni economiche, sociali e ideologiche della collettività cittadina.
Saper collocare e commentare i seguenti documenti che i ragazzi analizzeranno divisi
in piccoli gruppi, ciascuno dei quali affronterà uno degli aspetti considerati durante le
spiegazioni (fase consolare, il governo del podestà, le organizzazioni di popolo):
- Il periodo consolare: “consoli”, “parlamento” e “consiglio” (O. Capitani)
- I primi consoli del comune (R. Bordone)
- Il “Breve della Compagna” del comune di Genova (R. Bordone)
- L’espansione dei comuni maggiori e le lotte tra comune e comune (P. Lamma-R.
Manselli)
- Gli elementi costitutivi del comune ome ente politico (R. Bordone)
- L’origine dell’ufficio podestarile a Genova (R. Bordone)
- La transizione al Comune “podestarile” (K. Bosl)
- Le due tribune del vescovo e dei consoli a Milano nel 1117 (R. Bordone)
- Capitanei, valvassori e popolo nel consolato di Milano (R. Bordone)
- Milano alla fine del Duecento (R. Bordone)
Saper collocare le vicende studiate nel relativo contesto politico e socio-economico

49
COMPETENZE
- Saper analizzare testi di storici diversi, individuando somiglianze e differenze nella
percezione di un medesimo avvenimento
- Confrontare la realtà dei nostri giorni con situazioni ed aspetti del passato per
coglierne l’evoluzione.
CONTENUTI
L’origine del Comune e la sua natura di ente territoriale
Scheda: Il periodo consolare: “consoli” , “parlamento” e “consiglio”
Scheda: I primi consoli del Comune
Il governo dei consoli e gli organi comunali
- Doc.1, dallo Statuto di Genova del 1143
- Doc. 2,dallo Statuto di Pavia del XII secolo
- Doc. 3 dallo statuto dei consoli di Pistoia del XII secolo
Scheda: L’espansione dei comuni maggiori e le lotte tra comune e comune Scheda: Il “Breve della Compagna” del comune di Genova Lo scontro con l’Impero al tempo di Federico I
- Doc. 4, dalle Gesta Friderici
- Doc.5, dalla pace di Costanza Scheda: Gli elementi costitutivi del comune come ente politico Dal comune podestarile al comune popolare
Il comune podestarile - Doc. 6, dagli statuti di Como
- Doc. 7, dagli statuti di Noli

50
- Doc.8, dagli statuti di Parma
Scheda: La transizione al Comune “podestarile” Scheda: L’origine dell’Ufficio podestarile a Genova
Le organizzazioni di popolo
Il caso di Venezia - Doc.9, L’elezione del doge
Le città del Mezzogiorno
Il comune di Milano Scheda: Le due tribune del vescovo e dei consoli a Milano nel 1117 Scheda: Capitanei, valvassori e popolo nel consolato di Milano Scheda: Milano alla fine del Duecento
Il Comune oggi in Italia
SVOLGIMENTO DEL PERCORSO Con il brainstorming l’insegnante avvierà l’argomento. Darà un veloce riepilogo
degli argomenti propedeutici. Richiamerà brevemente la ripresa delle città dopo il
Mille e domanderà agli alunni: “Chi esercitava poteri di controllo sulla città? Si
trattava di un potere “laico”?” Dopo aver richiamato la presenza e la giurisdizione
temporale del vescovo, passerà ad introdurre la nuova forma di autogoverno,
sperimentata dai cittadini, nel loro bisogno di autonomia e di gestione del potere
locale. Per attivare l’interesse degli alunni nei confronti dell’argomento da trattare e
sollecitare una partecipazione attiva, porrà loro la domanda: “ Secondo voi, se una
città decide di rivendicare il governo cittadino, di che organi dovrà dotarsi?” e
ancora “ Sarà un gruppo o l’intera collettività, a sentire quest’esigenza?”
A questo punto il docente introdurrà il primo argomento: la nascita del Comune
come ente territoriale. Presenterà i contenuti, fornendone le principali coordinate e
tracciando alla lavagna degli schemi che servano per gli appunti degli allievi. Non si

51
leggerà in classe il libro di testo in adozione, ma si leggeranno i documenti, alcuni
dei quali ripartiti tra i gruppi, mediante lezione interattiva, con continua
sollecitazione degli alunni, facendo rilevare – ad esempio - il termine consul e
chiedendo: ”Qual era la suprema magistratura della Roma repubblicana? In che
modo interveniva?” e, quindi, facendo emergere somiglianze o differenze. Le fonti
verranno analizzate prendendo in considerazione il tipo di documento, il profilo
cronologico, l’aspetto esteriore, il luogo di produzione, la datazione e l’autore.
Ad ogni lezione successiva, prima di passare alla spiegazione del nuovo
argomento, porrà brevi domande agli alunni (senza attribuzione di voto) per
verificare la conoscenza dei contenuti e la comprensione del libro di testo. Chiarirà
eventuali dubbi, approfondendo alcuni aspetti. Relativamente all’argomento
spiegato saranno assegnati per casa esercizi (vedi verifiche indicate) su documenti
storici o verifiche strutturate, come verifica formativa, da correggere prima della
spiegazione dell’argomento successivo. Questo procedimento sarà seguito per la
presentazione di tutti gli argomenti.
Verifiche utilizzate (allegate):
- Il comune italiano
- Capitoli delle cose che i consoli di Pavia sono tenuti a fare
- Costituzione della pace di Costanza
- Analisi e confronto di documenti
- Confronto tra le caratteristiche del comune medievale e quelle del comune
attuale
Terminata la spiegazione di tutti i contenuti, gli alunni svolgeranno il seguente
lavoro nell’aula multimediale: divisi in piccoli gruppi, di due o tre persone, ciascun
gruppo approfondirà uno degli aspetti considerati durante le spiegazioni (la fase
consolare, il governo del podestà, le organizzazioni di popolo).
Una volta terminati i lavori, trascritti al computer sotto forma di brevi relazioni, ogni
gruppo presenterà il suo elaborato alla classe. Ciò permetterà di approfondire da
parte di tutti la conoscenza dei diversi argomenti e di partecipare con interventi attivi
alla restituzione del lavoro, mediante discussione guidata. Permetterà, inoltre,
all’insegnante di valutare insieme alla forma scritta anche l’esposizione orale.
La presentazione del lavoro svolto in gruppo sarà oggetto di valutazione di profitto
come verifica sommativa.

52
Si è deciso di presentare un approfondimento relativo alle vicende istituzionali del
Comune di Milano, dal momento che l’U.D. è rivolta ad una classe di un ITC del
capoluogo lombardo.
METODOLOGIE DIDATTICHE Brainstorming
Lezione frontale
Lezione dialogata partecipata
Lezione di ricerca in biblioteca e/o nel laboratorio multimediale
Analisi di fonti storiche
Lavoro di gruppo
Discussione guidata
Utilizzo di schemi o mappe concettuali
Il brainstorming sarà utilizzato per il controllo dei prerequisiti; la lezione frontale per la
presentazione di alcuni contenuti informativi necessari allo svolgimento del lavoro; la
lezione dialogata partecipata per il controllo degli esercizi della verifica formativa, per il
coinvolgimento degli alunni nella presentazione dei documenti, e per brevi domande
rivolte agli stessi allo scopo di precisare e sciogliere dubbi prima di proseguire la
lezione; la discussione guidata per la restituzione alla classe del lavoro di gruppo.
Nell’Unità Didattica noi abbiamo privilegiato l’uso delle fonti, convinti che la Storia non
è un insieme di conoscenze da trasmettere dalla mente dell’insegnante a quella degli
studenti, ma va intesa alla stregua di un “viaggio”, in cui i giovani stessi: formulano le
proprie linee di indagine percorrendo la via delle fonti dirette; dibattono le diverse
interpretazioni e rappresentazioni degli eventi; trovano le proprie risposte ad
interrogativi storici di grande interesse. L’idea di base è quella di mettere gli alunni in
condizione di “capire” il lavoro dello storico, di riuscire a far loro comprendere che lo
studio di un periodo è possibile proprio perché – in precedenza – gli storici hanno
potuto studiarlo attraverso l’analisi delle fonti ad esso relative. Per Bloch quello dello
storico è un mestiere che richiede competenze specifiche, che consentano una lettura
consapevole delle fonti. E’ allora opportuno mettere in evidenza che quella delle fonti è
una realtà complessa e come tale impone di capire: in quale contesto sono state
prodotte e con quale modalità, così da poter comprendere il “punto di vista” della fonte
stessa. Occorre inoltre far notare, che le fonti non sono una registrazione

53
dell’accaduto, ma una interpretazione, che – a volte – può costituire una lettura distorta
della realtà.
Gli schemi e le mappe concettuali serviranno per riproporre, in sintesi, idee e concetti
importanti, relativi agli argomenti trattati.
STRUMENTI Libro di testo in adozione per la classe (Clio Dossier, Palazzo-Bergese, La Scuola 2001),
fotocopie di documenti e/o di altri testi, libri della biblioteca scolastica e/o civica, siti web,
lavoro di gruppo in biblioteca e/o nel laboratorio multimediale, schemi e mappe concettuali,
atlante storico.
VERIFICHE E VALUTAZIONE Verifica formativa
Lettura e comprensione di testi e documenti proposti; relativi test strutturati a risposta
chiusa o domande dettate dal docente a risposta aperta.
Verifica sommativa
Elaborato relativo all’approfondimento di alcuni aspetti dei contenuti proposti, realizzato
per tematiche, in piccoli gruppi. Il lavoro sarà presentato da parte dei gruppi alla classe e
ciò permetterà di valutare l’ esposizione orale.
Si terrà conto delle capacità di:
analizzare le fonti ricercate su Internet per trarre informazioni
stabilire una gerarchia
sintetizzare le informazioni in un testo espositivo
utilizzare il lessico specifico della disciplina

54
TEMPI All’Unità Didattica verranno dedicate 12 ore totali, articolate come segue:
- 8 ore per l’esposizione dei contenuti, l’analisi dei documenti e la correzione degli
esercizi
di verifica formativa
- 2 ore per il lavoro di gruppo
- 2 ore per la verifica sommativa