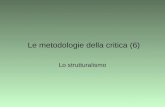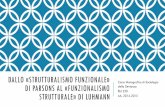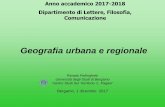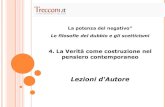Lo Strutturalismo Gestaltico
-
Upload
valeria-isotopia -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of Lo Strutturalismo Gestaltico

7/21/2019 Lo Strutturalismo Gestaltico
http://slidepdf.com/reader/full/lo-strutturalismo-gestaltico 1/15
a cura di
Romeo Galassi
Lorenzo Cigana
Strutturalismo, Strutturalismi
e loro forme
• quaderni del circolo glossematico •

7/21/2019 Lo Strutturalismo Gestaltico
http://slidepdf.com/reader/full/lo-strutturalismo-gestaltico 2/15
65
Rossana De Angelis
Lo Strutturalismo gestaltico*
0. Introduzione
Con l’espressione Strutturalismo gestaltico proponiamo di identificare un ap-
proccio all’analisi del linguaggio, e in particolare del senso, che si sviluppa secon-do più direzioni, tutte convergenti sulla nozione di forma, e in particolare di forma
semantica. Badando a non confonderlo con un approccio alla linguistica generaleintesa come linguistica della forma (Gestalt linguistik), lo Strutturalismo gestaltico risulta dall’incontro fra due paradigmi epistemologici diversi, lo Strutturalismo ela Gestalttheorie, sulla scia delle teorie del linguaggio e della lingua di Ferdinand deSaussure (cf . CLG) e Louis Hjelmslev (cf . FTL).
Rimettendo in questione le relazioni fra linguaggio, percezione ed esperienza,lo Strutturalismo gestaltico trova compimento nella nozione di forma semantica,
situata al crocevia fra prospettive diverse (fenomenologica, linguistica, semiotica,ecc.). Avendo finora ricevuto poca attenzione nella storia delle idee linguistichecontemporanee, ci proponiamo di capire come questo approccio ai fatti linguisticisi sia affermato nelle discipline del linguaggio, specialmente in ambiente francofo-no (Chiss–Puech 1997, 2007; Puech 2003; Moravia 2006).
1. Strutturalismo e Gestalttheorie
1.1. La teoria delle catastrofi
L’incontro fra due paradigmi epistemologici diversi quali lo Strutturalismo, cosìcome si è affermato nelle discipline del linguaggio, e la Gestalttheorie si compie
La presente pubblicazione è cofinanziata con il sostegno della Commissione Europea, Fondo SocialeEuropeo e della Regione Calabria. L’autrice è la sola responsabile di questa pubblicazione e la Com-missione Europea e la Regione Calabria declinano ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fattodelle informazioni in essa contenute.
* Abbreviazioni
CLG Saussure 2003
FTL Hjelmslev 1968

7/21/2019 Lo Strutturalismo Gestaltico
http://slidepdf.com/reader/full/lo-strutturalismo-gestaltico 3/15
66
Rossana De Angelis
intorno al concetto di forma. Secondo i principi fondamentali della Gestaltpsycho-logie, le cose che troviamo nel nostro ambiente rimangono solitamente, e per lamaggior parte dei casi, stabili. Le loro forme sono percepite regolarmente, a menoche non si trasformino per ragioni interne o esterne ad esse stesse (Köhler 2000:
191 sgg.). La prima conseguenza di questo incontro consiste, quindi, nell’assume-re come oggetto di studio non soltanto le modalità di identificazione delle forme,relativamente alla loro capacità di permanenza, ma soprattutto le loro modalità ditrasformazione.
Concentrandosi sulla stabilità e sulla trasformazione delle strutture, René Thom analizza le possibilità e le modalità di successione delle forme, fenomeno iden-tificato come morfogenesi , termine con cui viene definito “ogni processo creatore(o distruttore) di forme” (Thom 1985: 3). In una prospettiva morfogenetica, leforme sono strutture dotate di una certa stabilità: “esse occupano una certa porzio-
ne dello spazio e durano un certo lasso di tempo” (Thom 1980: 3). La possibilitàdi riconoscere una forma in quanto tale, e una certa forma come la stessa forma,dipende dalla possibilità di riconoscere in quella forma una molteplicità di aspettiche ne fanno uno stesso oggetto di analisi. Secondo Thom, questo problema èstato affrontato in maniera adeguata soltanto dagli psicologi della Gestalttheorie che lo “hanno posto da un punto di vista geometrico accessibile all’interpretazionescientifica” (ibid .). La nozione di forma ispirata alla Gestalttheorie si propone, allora,immediatamente, come la nozione centrale in questo approccio scientifico allaconoscenza. “Oggetto di ogni scienza è prevedere questa evoluzione delle forme e,se possibile, spiegarla” (ibid .).
Il concetto di morfogenesi deriva dall’individuazione di una discontinuità nell’a-spetto del sistema, interpretata come un cambiamento della forma, quindi dellastruttura, preesistente. Questo cambiamento si spiega attraverso una teoria dellecatastrofi che procede “dall’esame macroscopico della morfogenesi di un processo, dallo
studio locale o globale delle sue singolarità, […] alla dinamica che lo genera” ( Id .: 11). Icambiamenti di forma vengono chiamati, appunto, catastrofi .
Rispetto all’analisi del linguaggio e delle lingue, Thom sostiene che “le formesoggettivamente identificabili, le forme provviste di una denominazione, rappre-sentate nel linguaggio da un sostantivo, sono necessariamente strutturalmente stabili ”( Id .: 18). Interessandosi al linguaggio e alle lingue ( Id .: 345 sgg.) e, più precisa-mente, addentrandosi nell’analisi della dimensione sintattica al livello della frase,ci si chiede, allora, se, “[d]ato un processo spazio-temporale descrivibile linguisti-camente, esistono criteri formali riguardanti la morfologia intrinseca del processoche permetta di prevederne la decomposizione in frasi” ( Id .: 346). Innanzitutto,secondo Thom, è la struttura attanziale quella che permette di analizzare le frasi e,di conseguenza, i testi:
esistono domini dello spazio-tempo limitati da ipersuperfici di catastrofi aventi unruolo privilegiato: si tratta degli attori del processo, gli esseri o gli oggetti dei quali
il testo descrive le interazioni. Come regola generale, ciascuno degli attori è topo-

7/21/2019 Lo Strutturalismo Gestaltico
http://slidepdf.com/reader/full/lo-strutturalismo-gestaltico 4/15
67
Lo Strutturalismo gestaltico
logicamente una palla (contrattile). Tale è il caso per esempio degli esseri animati(viventi). Ad ogni istante, ogni attore viene contratto in un suo punto e se due attoriinteragiscono, ciò impone che i loro domini entrino in contatto lungo una zona dipunti catastrofici che verrà egualmente contratta in un punto, vertice comune agli
spigoli associati agli attori in contatto mediante la costruzione precedente ( Id .: 347).
Thom propone, dunque, una teoria dell’origine spaziale delle strutture sin-tattiche. I modelli topologici che ne derivano sono, quindi, applicati all’analisilinguistica (Thom 1985: capp. X, XI, XII). Il punto di vista topologico si sviluppamaggiormente, però, nell’opera di Jean Petitot-Cocorda che apre alla morfogenesidel senso, portando la proposta teorica di Thom – su cui non ci soffermeremo ulte-riormente – nell’ambito più specifico dell’analisi semantica.
Come scrive Thom nella prefazione al saggio di Petitot-Cocorda, “nellescienze umane, il metodo catastrofista avrebbe la funzione di costituire l’oggettività
stessa dei fatti studiati” (Petitot-Cocorda 1990: 8), rivelando così la sua portata on-tologica (ibid .). Questa posizione comporta, però, conseguenze teoriche importanti:“come notavano già i fondatori della Gestalttheorie, si tratta in questo caso di unareificazione delle connessioni che, attribuendo all’essere dei termini tutto ciò chepertiene ai valori posizionali, nega a priori l’insieme dei caratteri fenomenologici delle strutture” ( Id .: 15). Non è, quindi, una logica formale che domina in questoapproccio volto alla descrizione oggettiva del senso (Thom 1980, 1985), bensì una“topologia dinamica dei posti e delle relazioni” (Petitot-Cocorda 1990: 8) fondataa sua volta su una “topologia differenziale” (Thom 1985: 4). Sostenendo che l’a
priori dello Strutturalismo (gestaltico) è topologico e non logico, si apre la strada allaproposta teorica di una morfogenesi del senso. Come scrive Thom, infatti,
la topologia è precisamente la disciplina matematica che permette il passaggio dal locale al globale… Spingendo questa tesi alle estreme conseguenze, si potrebbero rapportaretutti i fenomeni vitali alla manifestazione di un essere geometrico che si chiamereb-be il campo vitale (proprio come il campo gravitazionale o il campo elettromagneti-co); gli esseri viventi sarebbero le particelle o le singolarità strutturalmente stabili ditale campo (Thom 1980: 169-170).
Adottando questa prospettiva, il punto di vista da cui condurre l’analisi del sensonon può che essere topologico: la forma semantica è una struttura stabile, complessa, èun fenomeno determinato localmente, in relazione ad altre forme semantiche e allastruttura globale, coerente e stabile, di cui queste forme semantiche fanno parte.
1.2. La morfogenesi del senso
Il progetto teorico di morfogenesi del senso proposto da Petitot-Cocorda partedalla consapevolezza che non esiste un solo Strutturalismo, bensì una pluralità
di strutturalismi diversi. “In particolare, la radice dello strutturalismo moderno,

7/21/2019 Lo Strutturalismo Gestaltico
http://slidepdf.com/reader/full/lo-strutturalismo-gestaltico 5/15
68
Rossana De Angelis
posta all’incrocio del vitalismo biologico, della fenomenologia e della Gestaltthe-orie è stata completamente occultata” (Petitot-Cocorda 1990: 35). L’autore situa,quindi, il suo contributo teorico in questa pluralità di approcci:
i) Lo Strutturalismo dinamico, d’origine biologica e di contenuto vitalista […] è cen-trato sul problema della morfogenesi .ii) Lo Strutturalismo fenomenologico e gestaltista che si è costituito all’inizio diquesto secolo a partire dai lavori di Brentano (Stumpf, Meinong, Ehrenfels 1, Hus-serl, Köhler, Koffka, Wertheimer, ecc.).iii) Lo Strutturalismo linguistico che, nato dalla “frattura epistemologica” saussu-riana, è diventato uno dei paradigmi fondamentali delle scienze umane, in fonologiacon Jakobson, in antropologia con Lévi-Strauss, in linguistica con Tesnière e Ben- veniste, o in semiotica con Hjelmslev e Greimas. Questo strutturalismo si è a sua
volta scisso in due correnti:iii a) quella dello strutturalismo fenomenologico, “realista”, di Jakobson che intrat-tiene stretti rapporti con lo strutturalismo dinamico e con la Gestalttheorie;iii b) quello dello strutturalismo formalista, “metodologico” ed “epistemologico”,di Hjelmslev, Lévi-Strauss, Chomsky e Greimas che concepisce le strutture comedegli oggetti teorici “assiomatizzabili” e risolve la questione della loro realtà onto-logica radicandoli nelle capacità cognitive biologicamente (e quindi geneticamente)determinate.iv) Lo strutturalismo epigenetico e cognitivo di Piaget. v) Lo strutturalismo “catastrofista” sviluppato da Réné Thom. Profonda sintesi tra i
concetti di morfogenesi e di struttura, e dunque tra lo strutturalismo dinamico “vi-talista” e il razionalismo semio-linguistico inaugurato da Saussure, esso è il primo aessere riuscito a matematizzare le strutture in quanto oggetti teorici , superando così lemodalità di un formalismo ingenuo ( Id .: 23-24).
Sullo sfondo di questa pluralità di Strutturalismi – presentati qui sintetica-mente e trascurando la ricostruzione storiografica, per la quale rinviamo diret-tamente al saggio di Petitot-Cocorda (1990) – si colloca, dunque, il progetto diuna morfogenesi del senso. Lo Strutturalismo gestaltico si fonda sull’assunto chenessuna percezione può considerarsi al di fuori di un organismo (biologico) e diun’organizzazione percettiva, giustificando così il comune accordo fra Struttura-
1 “Christian von Ehrenfels, précédé en cela par une observation d’Ernst Mach, attira l’attentiondes psychologues sur le fait que la donnée la plus importante qualitativement du champ sensorielavait, peut-être, été totalement négligée dans les analyses habituelles. On supposait jusqu’alorsqu’une sensation a lieu de façon indépendante, qu’elle était, en d’autres termes, déterminéepar son stimulus local. Ehrenfels introduisit, dans la psychologie scientifique, une notion biencurieuse à propos des qualités de la sensation, à savoir: sa relation à des réseaux de stimuli. Rienqui puisse leur ressembler n’est jamais déterminé par la stimulation per se, à l’échelon strictementlocal. Au contraire, le caractère global – l’ensembléité, pour risquer l’expression – de plusieursprocessus est la condition de ces effets spécifiques à l’intérieur d’un champ sensoriel” (Köhler
2000: 178-179).

7/21/2019 Lo Strutturalismo Gestaltico
http://slidepdf.com/reader/full/lo-strutturalismo-gestaltico 6/15
69
Lo Strutturalismo gestaltico
lismo e Gestalttheorie intorno al concetto di struttura ( Id .: 29-33). Le percezioni sipresentano come delle forme (Gestalten), unità organiche che si individualizzano esi limitano nel campo spaziale e temporale di percezione o di rappresentazione,dipendono da una serie di fattori obiettivi e sono trasponibili, ossia in quanto pro-
prietà si conservano nel cambiamento, presentando un’articolazione interna chedetermina diversi modi di organizzazione del tutto (Guillaume 1979: 23-27). Leforme si presentano come strutture organizzate e complesse, risultanti da un pro-cesso di generazione, i cui elementi costitutivi non possono considerarsi in modoisolato né indipendentemente dal tutto in cui sono compresi.
L’approccio strutturale presupposto nella morfogenesi del senso consiste, dunque,negli aspetti formali che qui riassumiamo brevemente (Petitot-Cocorda 1990: 13-14): 1) riguardo l’organizzazione biologica, la determinazione reciproca delle partisecondo i rispettivi valori posizionali nella struttura; 2) riguardo l’organizzazione
percettiva, l’esistenza di forme (Gestalten) comporta modalità di identificazioneanaloghe; 3) in fonologia, i fonemi si presentano come classi d’equivalenza di al-lofoni definite secondo valori posizionali; 4) in sintassi, le strutture primitive – ilcui modello è rappresentato dalle strutture semio-narrative proposte da Greimas(1966, 1970) – derivano dai valori posizionali assunti reciprocamente dalle struttureattanziali , le cui relazioni semantiche esprimono la forma del contenuto (cf . FTL), ri-manendo indipendenti sia dal lessico sia dai vincoli grammaticali dei termini messiin relazione e costruendo così una sintassi concettuale piuttosto che formale; 5)nell’ambito della semantica strutturale, nella fattispecie generativa, partendo dallestrutture attanziali che emergono nell’analisi delle valenze verbali, individuate al
livello della frase, come proposto da Tesnière (1988), Greimas “concepisce l’artico-lazione semantica secondo il modello fonologico e l’articolazione sintattica in for-ma attanziale” (Petitot-Cocorda 1990: 14), portando l’analisi dal livello della frase aquello del testo e spostando il modello attanziale in una dimensione narrativa.
Le strutture semio-narrative forniscono, dunque, il contributo maggiore alconcetto di morfogenesi del senso: passando da strutture profonde a strutture super-ficiali, attraverso processi di trasformazione di stati, il concetto di morfogenesi siestende in una dimensione narrativa che porta l’analisi da un livello frastico a unlivello transfrastico. Il quadrato semiotico, ad esempio, rappresentando la strutturasemio-narrativa fondamentale che rivela la forma del contenuto, si propone comeuno schema universale di articolazione del senso: considerato da un punto di vistalogico, il quadrato semiotico – secondo Petitot-Cocorda – non ha molto interesse;considerato da un punto di vista topologico, invece, si presenta come una vera e pro-pria struttura organizzata e autoregolata, costituita da elementi che si identificanograzie alle loro relazioni, i cui rapporti di mutua dipendenza definiscono, piuttostoche dei termini precisi, dei valori posizionali in cui i termini si riconoscono per viadelle loro relazioni di reciproca dipendenza. Come sottolinea Petitot-Cocorda,inoltre, le relazioni di opposizione e presupposizione, sulle quali si costruisce ilquadrato semiotico, rimandano alla nozione di posizione che è di natura topologica
piuttosto che logica. Infine, reggendosi su congiunzioni e disgiunzioni, il quadrato

7/21/2019 Lo Strutturalismo Gestaltico
http://slidepdf.com/reader/full/lo-strutturalismo-gestaltico 7/15
70
Rossana De Angelis
semiotico rimanda anche alla nozione di giunzione che è, a sua volta, di natura to-pologica piuttosto che logica. “ L’essere-formale del quadrato semiotico pertiene dunquein ultima istanza a una topologia dinamica di posti e di connessioni e non a una logica
statica di termini e di relazioni ” ( Id .: 51).
Nella prospettiva aperta dalla morfogenesi del senso, ogni forma è, dunque, unsistema strutturalmente stabile e (auto)regolato da connessioni di valori posizionali ed esiste solo in quanto tale. Il concetto chiave nella morfogenesi del senso è, quindi,quello di valore posizionale che presuppone già quello di struttura: poiché è posi-
zionale, topologicamente determinato, il valore si definisce soltanto rispetto a ciòche occupa un posto altro all’interno della struttura che li contiene. Il mutamentodel valore posizionale permette, quindi, di spiegare l’organizzazione, la stabilità eil mutamento delle strutture stesse. La nozione di valore posizionale presuppone,allora, la nozione saussuriana di valore differenziale2 che permette l’identificazione
delle entità linguistiche soltanto grazie alla loro reciproca determinazione rispettoal sistema linguistico di riferimento. Il progetto teorico di morfogenesi del senso mostra, quindi, in maniera esemplare, le conseguenze dell’incontro fra lo Struttu-ralismo linguistico e la Gestalttheorie.
1.3. Verso una teoria delle forme semantiche
La nozione di forma3 proveniente dalla Gestalttheorie rappresenta uno degli at-tributi4 di una gestalt , e su questo attributo si costruisce lo Strutturalismo gestaltico.Questa nozione di forma si specifica poi nella nozione di forma semantica che si de-
clina, a sua volta, secondo accezioni diverse. Una fra queste proviene, ad esempio,dai lavori del gruppo di ricerca Formes symboliques .
2 “Il n’y a dans la langue ni signes [inteso nel senso di signifiants – N.d.A.], ni significations, maisdes différences de signes et des différences de significations: lesquelles 1° n’existent les unes abso-lument que par les autres, (dans les deux sens), et sont donc inséparables et solidaires; mais 2°n’arrivent à se corréspondre directement” (Saussure 2002: 70). Per ciò che riguarda la teoria del
valore, cf. CLG, parte seconda, capp. III, IV.
3 “Aujourd’hui, dans la langue allemande – au moins depuis l’époque de Gœthe – le nom “Ges-talt ” a deux sens: outre la signification de forme, comme attribut des choses, il a celle d’entité
concrète per se qui a, ou peut avoir, une forme comme l’une de ses caractéristiques. Depuisl’époque d’Ehrenfels, l’intérêt s’est déplacé des ses qualités aux faits de l’organisation et donc
vers les problèmes des entités spécifiques dans les champs sensoriels. En conséquence, c’est lasignification de Gestalt , celle qui s’applique à un objet spécifique et à l’organisation, qui est sous-entendue quand nous parlons de la Gestaltpsychologie” (Köhler 2000: 183).
4 Il termine Gestalt dovrebbe essere tradotto come “struttura organizzata”, in contrapposizionead “aggregato”, “mucchio”, “somma”. Nel primo caso viene posto l’accento sul concetto di“organizzazione”, si tratta di un insieme ordinato, regolato da leggi , non-causale; nel secondo casoè implicito che si tratta di un raggruppamento casuale, arbitrario, indifferente. Ma oltre a essereusato per designare il prodotto di un processo di organizzazione, il termine Gestalt viene usatoanche per indicare le proprietà strutturali del processo stesso, cioè per distinguerlo dalla mera
giustapposizione e dalla distribuzione casuale (Kanizsa 1978: 40).

7/21/2019 Lo Strutturalismo Gestaltico
http://slidepdf.com/reader/full/lo-strutturalismo-gestaltico 8/15
71
Lo Strutturalismo gestaltico
Partendo dal presupposto che l’attività di linguaggio possa essere compresa allamaniera della percezione e/o della costruzione di forme, in Cadiot-Visetti 2001 sipropone una teoria delle forme semantiche. Il contributo offerto della Gestalttheorie,dapprima analizzato e discusso nei suoi diversi aspetti (Rosenthal-Visetti 1999), poi
introdotto nello studio del linguaggio (Cadiot-Visetti 2001), consiste nel porre lebasi di una teoria delle forme semantiche che sia immediatamente lessico-gramma-ticale e che non separi sistematicamente strutture e contenuti (Cadiot-Visetti 2001:50), riportando le questioni dell’immaginazione e dello schematismo nelle proble-matiche linguistiche e gettando le basi per lo sviluppo di un approccio microgenetico alle concezioni espressiviste e semiotiche della percezione (Rosenthal-Visetti 2008).Ciò presuppone, innanzitutto, una concezione ampia e complessa della percezio-ne: “ percevoir est une activité sémiotique, qui repose sur la saisie immédiate de qualitéset d’horizons, […] percevoir est toujours esquisser un sens, qui ne se déploie que dans un
parcours, dans une activité de thématisation par laquelle se font et se défont les identités ”(Cadiot-Visetti 2001: 50). I principi fondamentali che derivano dalla teoria delleforme percettive vengono, allora, adattati a una teoria delle forme semantiche ( Id .:54 sgg.). Questi principi, riassunti brevemente, sono i seguenti:
• la reciproca presupposizione fra il tutto e le parti ;• le continue modulazioni interne alla forma, quindi le delimitazioni discontinue
dei campi, percettivi e semantici;• i tempi di costituzione interni alla forma (integrazione, stabilizzazione);• la presenza di un sostrato continuo, uno sfondo su cui diventa possibile la di-
scretizzazione;• l’organizzazione in figure che si distaccano dal fondo;• il carattere trasferibile delle forme, o meglio la possibilità di trasposizione del
rapporto forma/fondo;• l’individuazione di tipi di unità secondo il rapporto schema/istanza, determina-
to dallo scarto fra potenziale e attuale.
La teoria delle forme semantiche integra, inoltre, alla nozione di forma provenien-te dalla Gestalttheorie, un’altra nozione di forma proveniente dalla riflessione feno-menologica, in particolare nella versione proposta da Merleau-Ponty (1942: 147).
Ispirandosi ai modelli dinamici offerti dalla morfogenesi del senso (cf . supra),la teoria delle forme semantiche individua, quindi, tre “regimi semantici” (motivi 5,
profili , temi ), combinando così un approccio gestaltico a un approccio morfogene-tico (Visetti 2004). Passando attraverso l’analisi di fenomeni linguistici particolari
5 Secondo la definizione fornita da Visetti, i motivi linguistici sono principi generici non demanialiche contribuiscono, in primo luogo, piuttosto che al raggruppamento di oggetti o conoscenze,come nelle semantiche referenziali o prototipiche, a quello dei modi di acquisizione o donazione,costitutivi dell’esperienza stessa della parola (Visetti 2004: 16). Questa nozione linguistica dimotivo richiama la nozione percettiva analoga che compare nella Gestaltpsychologie (Köhler 2000:
193 sgg.).

7/21/2019 Lo Strutturalismo Gestaltico
http://slidepdf.com/reader/full/lo-strutturalismo-gestaltico 9/15
72
Rossana De Angelis
(Cadiot-Visetti 2006), l’integrazione fra un punto di vista gestaltico e un puntodi vista morfogenetico conduce, infine, a un approccio microgenetico nell’analisidel senso (Rosenthal-Visetti 2008). Parallelamente, l’integrazione fra un punto di vista strutturale e un punto di vista dinamico conduce a un approccio morfodina-
mico all’analisi del senso (Piotrowski 2010, 2011).
2. Strutturalismo, Gestalttheorie ed ermeneutica
2.1. Un approccio interpretativo
La nozione di forma semantica si sviluppa in una prospettiva interpretativa nellateoria della lingua e del linguaggio proposta da François Rastier. La comprensionedi una sequenza linguistica è essenzialmente un’attività di riconoscimento di forme se-
mantiche, già apprese o costruite nel corso del trattamento del testo (Rastier 1989:9). Nella tradizione retorico-ermeneutica in cui questa teoria del testo (Rastier2009, 1989) si inserisce, la possibilità di riconoscere un oggetto semantico dipendedalle conoscenze acquisite a partire da una pluralità di punti di vista da cui si ana-lizza l’oggetto in questione (Rastier 1998: 100).
La nozione di forma semantica evoca immediatamente quella di forma percettiva:“le langage est un objet de perception: c’est évident pour le signifiant mais aussi pourle signifié, c’est pourquoi j’ai développé le thème de la perception sémantique” (Rastier2009: XIV). Il tema proposto si sviluppa a più riprese nel percorso teorico com-piuto dall’autore. Questa percezione gerarchizza tre tipi di dati: le forme, i fondi ,
nonché lo sfondo delle forme e dei fondi, vale a dire i paradigmi di altri forme efondi concorrenti che collegano la percezione presente al corpus delle esperienzelinguistiche passate.
La relazione tra forme semantiche, fondi e sfondo rievoca il modo in cui la Ge- staltpsychologie spiega i fenomeni di percezione, e in particolare quelli di percezione visiva (Köhler 2000: 188 sgg.). Quando una forma visiva si trova sotto i nostri oc-chi, viene percepita proprio in quanto forma, mentre la seconda – quella che emer-ge per sottrazione della prima – viene assorbita dallo sfondo e la sua forma visivadiventa inesistente. Tuttavia, quando quest’ultima emerge dallo sfondo, la primascompare. La forma visiva che viene in primo piano e quella che viene assorbitadallo sfondo non possono vedersi contemporaneamente: o si percepisce l’una osi percepisce l’altra. L’esistenza di una forma visiva dipende, quindi, da un’unità visiva corrispondente che assume, appunto, questa stessa forma dopo essere stataisolata dal fondo. Parallelamente, una forma semantica implica l’esistenza di un’u-nità semantica. L’unità semantica assume, quindi, quella forma dopo essere stataisolata dal fondo. Essa riposa, quindi, su un fondo semantico in cui si staglianounità semantiche più o meno estese.
Nella semantica interpretativa proposta da Rastier (1989, 2009) la relazione for-ma/fondo dipende dalla distinzione fra semi (unità minime di contenuto) definiti
generici e specifici : i semi generici rappresentano il fondo di una classe lessicale –

7/21/2019 Lo Strutturalismo Gestaltico
http://slidepdf.com/reader/full/lo-strutturalismo-gestaltico 10/15
73
Lo Strutturalismo gestaltico
come di un’isotopia, cf . infra – da cui emergono i semi specifici che identificanoi sememi di quella classe così come le molecole semiche che percorrono il testo. Ciòche si osserva per le forme percettive lo si riscontra, quindi, per le forme semantiche:nel corso dell’interpretazione di un testo, esse emergono dallo sfondo, distinguen-
dosi nello stesso tempo anche dalle altre forme semantiche disseminate nel testo.Secondo la prospettiva proposta da Rastier, il senso di un testo si (ri)costruisce
tracciando una rete di forme semantiche, poggiata su una rete di forme espressive,che indicano il percorso interpretativo del testo. La rete di forme, semantiche edespressive, si presenta come una rete globale che si costituisce a sua volta di retilocali. Nel piano del contenuto queste reti locali sono costituite dalle molecole semi-che i cui nodi sono i semi , entità minime di senso; nel piano dell’espressione, inve-ce, le reti locali sono costituite dalle molecole femiche, i cui nodi sono i femi , entitàminime fonetiche (Rastier 2006). La possibilità di passare continuamente attraver-
so i due piani del testo, contenuto ed espressione, grazie ai percorsi interpretativi (cf . infra) che si delineano nel testo, permette di tener conto degli andirivieni frauna dimensione locale e una dimensione globale del senso, propria non soltanto diun approccio gestaltico al senso, ma anche di un approccio retorico-ermeneuticoal testo6. I testi sono concepiti, dunque, come oggetti complessi e, contempo-raneamente, come corsi di azione, produttiva e interpretativa, che si sviluppanointorno alle forme semantiche intese come punti di orientamento, considerando cosìil percorso stesso da due punti di vista complementari, generativo e interpretativo(Rastier 2006).
2.2. La nozione di percezione semantica
Le sens consiste pour l’essentiel en un réseau de relations entre signifiés au sein du texte– et dans cette perspective, les signifiants peuvent être considerés comme des interprétants qui permettent de construire certaines de ces relations. Elles demeurent de type perceptif:estimation de similarité, reconnaissance de forme, catégorisation (Rastier 2001: 189-190).
Questa definizione del senso rimanda alla nozione di percezione semantica (Rastier 1991: § VIII) che permette di rendere conto dell’individuazione e dellagestione delle forme semantiche nella prospettiva di uno Strutturalismo gestaltico(Rastier 2009).
Come scrive lo stesso Rastier, questa formulazione porta con sé una certa para-dossalità: il termine percezione evoca una dimensione sensibile, mentre l’aggettivo
semantica evoca una dimensione intelligibile. La nozione di percezione semantica rappresenta, quindi, una sintesi del suo punto di vista nell’analisi del senso: agli
6 “La manière la plus simple d’éluder la question consiste à considérer le texte comme un signe.C’est la solution que choisissent Peirce, comme Greimas ou Eco (cf . Eco 1988: 32: “le Messageéquivaut au Signe”). Cette esquive fait évidemment peu de cas de la différence de niveau decomplexité entre le signe et le texte, mais surtout empêche de penser l’incidence du global sur le
local, en l’occurrence du texte sur chacun des signes qui le composent” (Rastier 1997).

7/21/2019 Lo Strutturalismo Gestaltico
http://slidepdf.com/reader/full/lo-strutturalismo-gestaltico 11/15
74
Rossana De Angelis
approcci dominanti nelle ricerche cognitive, in cui si presuppone il significato su-bordinato al concetto e alla composizionalità del senso, viene opposto un approccioche attinge al paradigma strutturale, inizialmente legato alla psicologia della Gestalt (Rastier 2010: 206), consolidatosi in una teoria dei campi semantici, rifiutando sia
la subordinazione del significato al concetto sia la composizionalità del senso, infavore di un approccio insieme gestaltico ed ermeneutico che comporta la deter-minazione del locale attraverso il globale in virtù di una prospettiva interpretativa,presupponendo, quindi, che il trattamento semantico somigli come regola generaleal riconoscimento di forme piuttosto che al calcolo (Rastier 2010: 207).
Secondo Rastier, infatti, gli analoghi dei percetti visivi, uditivi, tattili, ecc.,sono dei simulacri multimodali (Rastier 2010: 207) che devono essere riportati amodalità tanto sensoriali quanto culturali (Rastier 2001: §4). Come dice l’autore,la triade aristotelica di parola / concetto / cosa, nei cui limiti il semantico viene
assimilato al concettuale e il linguistico ridotto al verbale, ha avuto conseguenzeimportanti nell’analisi del senso: dal momento in cui si considera una dimensioneconcettuale che si esprime linguisticamente, si suppone che la codificazione ver-bale si realizzi attraverso l’espressione linguistica, supponendo così un senso pre-linguistico (concettuale) che trova espressione attraverso il significante linguisticoe, di conseguenza, una visione puramente strumentale della lingua che trasmetteun’informazione indipendente dalle forme attraverso cui viene codificata. Rastiersostiene, invece, che le strutture semantiche (dimensione linguistica) pongano dei vincoli alla costruzione di immagini mentali (dimensione concettuale) e defini-scono le condizioni socializzate della produzione di simulacri (Rastier 2010: 211).
Secondo Rastier, infatti,
le système sémantique (si complexe soit-il) contraint aussi bien l’activitè perceptive (créationde signifiés à partir de signifiants) que l’imagérie (création de “concept” à partir de signi- fiés). Ces contrôles ne sont pas unidirectionnels, puisque dans le premier cas on observe descréations de signifiants à partir de signifiés, dans les lapsus, par exemple, et dans le secondune rétroaction des images sur l’interprétation sémantique (cf. le rôle des représentationsdans l’établissement de la cohérence textuelle) (Rastier 2010: 210).
Il carattere differenziale delle unità semantiche, sia sull’asse sintagmatico, siasull’asse paradigmatico, ha a sua volta conseguenze importanti: un principio inter-
pretativo di assimilazione rende conto della modificazione delle immagini mentaliattraverso il contesto, e innanzitutto attraverso il contesto immediato dal momentoin cui l’impressione referenziale, simulacro multimodale di carattere percettivo, che èil prodotto di un’elaborazione psicologica dei significati (Rastier 2010: 211), dipen-de dal contesto, e la costruzione di un’impressione referenziale è una condizione,“necessaria e non sufficiente”, dello stabilirsi della referenza. Il soggetto accoppiaun simulacro multimodale, ossia il risultato di un’elaborazione semantica, quindiculturale; un percetto, ossia un tipo che permette la categorizzazione, intesa come
processo fortemente socializzato; e una struttura percettiva (Rastier 2010: 211).

7/21/2019 Lo Strutturalismo Gestaltico
http://slidepdf.com/reader/full/lo-strutturalismo-gestaltico 12/15
75
Lo Strutturalismo gestaltico
A livello microsemantico, vengono, allora, in primo piano i processi interpre-tativi elementari quali la dissimilazione, l’assimilazione e la presupposizione di isotopia.Nati nell’ambito di una semantica interpretativa, questi principi regolano la com-petenza interpretativa e generativa dei parlanti attraverso la percezione semantica.
La dissimilazione si trova all’opera, ad esempio, nelle tautologie (quelle attributive:“una donna è una donna”, o quelle disgiuntive: “c’è musica e musica”, Rastier2009: § § III, VII) in cui alla ricorrenza di un segno o un sintagma corrisponde,nella dimensione semantica, la ricorrenza di un semèma o una semìa. L’operazionedi dissimilazione può essere già presupposta all’interpretazione e/o alla generazio-ne delle tautologie, può essere già presente nel sistema, o può derivare da inferen-ze pragmatiche. Ciò presuppone che i contenuti possano cambiare di cultura incultura, mentre il principio di dissimilazione operi allo stesso modo e rappresenti,quindi, una regola universale della percezione semantica (Rastier 2001: 216-217). Il
principio di assimilazione, invece, permette di attualizzare tratti semantici afferentiche siano o determinati da certe norme sociali o determinati dal contesto locale.Queste due modalità di assimilazione permettono di interpretare e generare, adesempio, le associazioni e le contraddizioni (Rastier 2009: § § III, VII). Il principiodi assimilazione determina anche la generazione e l’interpretazione di isotopie che,essendo ripetizioni di tratti semantici a tutti i livelli dell’analisi semantica, dallaparola al testo, risultano da operazioni di assimilazione incatenate fra esse. Poi-ché le isotopie sono responsabili della coesione e della coerenza testuali, l’ipotesid’isotopia è un processo che gioca un ruolo eminente nella percezione del sensolessicale in contesto (Rastier 2010: 221).
La teoria saussuriana del valore, attraverso cui viene condotta l’analisi del pianodel contenuto linguistico, si ancora quindi al principio percettivo della dissimila-
zione (Rastier 1991) che, contemporaneamente, sostiene l’idea di una percezione se-mantica e realizza il passaggio verso la nozione di forma semantica. Questo processoporta, quindi, in primo piano i risultati della proposta teorica di uno Strutturalismo
gestaltico. L’ipotesi d’isotopia trova un correlato nella percezione visiva nei principigestaltici di prossimità, similarità e buona continuazione. Più precisamente, l’ipo-tesi d’isotopia è un principio di buona continuazione che presuppone la similaritàdegli elementi vicini (Rastier 2010: 221). Il processo che determina l’ipotesi d’iso-topia, sia nella percezione semantica, sia nella percezione visiva, consiste nell’in-dividuazione di invarianti (di cui il processo di categorizzazione, secondo Rastier,non è che un caso particolare). Ciò giustifica, quindi, la possibilità di intrecciareStrutturalismo e Gestalttheorie.
3. Conclusioni
Lo Strutturalismo gestaltico si sviluppa combinando il concetto di valore (diffe-renziale, posizionale), nozione proveniente dallo Strutturalismo, con quello di for-ma (percettiva, linguistica, semantica), nozione proveniente dalla Gestalttheorie. La
possibilità di identificare una forma, infatti, dipende dalle relazioni reciproche de-

7/21/2019 Lo Strutturalismo Gestaltico
http://slidepdf.com/reader/full/lo-strutturalismo-gestaltico 13/15
76
Rossana De Angelis
gli elementi che la costituiscono in quanto struttura così come dalla sua relazionecon le altre forme dello stesso sistema. Ciò sottintende la continua articolazionefra due dimensioni, locale e globale.
La nozione di forma semantica, invece, rappresenta un crocevia in cui si riuni-
scono i diversi approcci che compongono lo Strutturalismo gestaltico. Questa plura-lità di approcci interni risulta evidente se consideriamo insieme il progetto teoricodi morfogenesi del senso proposto da Petitot-Cocorda, sulla scia della teoria dellecatastrofi di Thom, rispetto alla teoria delle forme semantiche proposta in Cadiot- Visetti (2001), rispetto all’approccio interpretativo di Rastier così come all’approc-cio morfodinamico di Piotrowski (2010, 2011).
Come possiamo osservare, allora, quello che chiamiamo Strutturalismo gestalti-co, lungi dall’essere esaurito, rimane ancora un argomento da approfondire rispet-to alle diversità specifiche degli approcci che in esso si racchiudono. Senza alcuna
pretesa di esaustività, abbiamo, quindi, voluto portare l’attenzione su una unacorrente di quel complesso movimento di pensiero più generalmente chiamiamoStrutturalismo, al singolare, che racchiude in sé più Strutturalismi, alcuni dei qualinon hanno ancora trovato un posto adeguato nella storia delle idee linguistiche efilosofiche contemporanee.

7/21/2019 Lo Strutturalismo Gestaltico
http://slidepdf.com/reader/full/lo-strutturalismo-gestaltico 14/15
77
Lo Strutturalismo gestaltico
C ADIOT , P. – V ISETTI, Y.-M.2001 Pour une théorie des formes sémantiques , Paris,
PUF.2006 Motifs et proverbes: essai de sémantique prover-
biale, Paris, PUF.
CHISS, J.L. – PUECH, C.1997 La linguistique française: le structuralisme in-
trouvable, in Chiss, J. L. – Puech, C., Fon-dations de la linguistique. Etudes d’histoire etd’épistémologie, Louvain-la-Neuve, Duculot:145-205.
2007 Structuralisme linguistique, in Encyclopædia
universalis , Paris, Albin Michel: 793-820.
ECO, U.1988 Sémiotique et philosophie du langage, trad. fr. di
M. Bouzaher, Paris, PUF, 1988.
GREIMAS, A.J.1970 Du Sens , Paris, Seuil.1986 Sémantique structurale, Paris, PUF.
GUILLAUME, P.1979 La Psychologie de la forme, Paris, Flammarion.
H JELMSLEV , L.1968 I fondamenti della teoria del linguaggio, Tori-
no, Einaudi.1971 Essais linguistiques , Paris, Minuit.1985 Nouveaux Essais , Paris, PUF.
K ANIZSA , G.1978 La teoria della Gestalt: distorsioni e fraintendi-
menti , in Kanizsa, G. – Legrenzi, P., (a curadi), Psicologia della Gestalt e psicologia cogniti-vista, Bologna, Il Mulino: 39-61.
K ÖHLER , W.2000 Psychologie de la forme. Introduction à des nouve-
aux concepts en psychologie, Paris, Gallimard.
MERLEAU -PONTY , M.1942 La structure du comportement , Paris, PUF.
MISSIRE, R.2013 Perception sémantique et perception sémiotique
- propositions pour un modèle perceptif du signelinguistique, in J. Lassègue, V. Rosenthal, Y.- M. Visetti (éds.), Le thème perceptif en lingui-
stique, Paris, CNRS.
MORAVIA , S.2006 Lo strutturalismo francese, Firenze, Le Lettere.
PETITOT -COCORDA , J.1990 Morfogenesi del senso: per uno schematismo della
struttura, Milano, Bompiani.
PIOTROWSKI, D.2010 Morphodynamique du signe I: l’architecture fon-
ctionnelle, “Cahiers Ferdinand de Saussure”,63: 185-203.
2011 Morphodynamique du signe II: retour sur quel-ques concepts saussuriens , “Cahiers Ferdinand
de Saussure”, 64: 101-118.
PUECH, C.2003 L’emergere del paradigma semiotico-strutturale
in Francia, in Bettetini, G. (a cura di), Semi-otica II. Configurazione disciplinare e questionicontemporanee, Brescia, La Scuola: 9-50.
R ASTIER , F.1989 Sens et textualité , Paris, Hachette.1998 Le problème épistémologique du contexte et le
problème de l’interprétation dans les sciences du
langage, “Langages”, 129: 97-111.2001 Du signe aux plans du langage, in “CahiersFerdinand de Saussure”, 54: 177-200.
2002 Anthropologie linguistique et sémiotique des cul-tures , in Rastier – Bouquet 2002: 243-267.
2006 Formes sémantiques et textualité , “Langages”,163: 99-114.
2009 Sémantique interprétative, Paris, PUF.2010 Sémantique et recherches cognitives , Paris,
PUF.
R ASTIER , F. – BOUQUET , S. (éds.)2002 Une introduction aux sciences de la culture, Pa-
ris, PUF.
R OSENTHAL, V. – V ISETTI, Y.-M.1999 Sens et temps de la Gestalt , “Intellectica”, 28:
147-227.2008 Modèles et pensées de l’expression: perspectives
microgénétiques , “Intellectica”, 50: 177-252.
S AUSSURE, F. DE 2002 Écrits de linguistique générale, Paris, Galli-
mard.2003 Corso di linguistica generale, Roma-Bari, La-
terza.
bibliografia

7/21/2019 Lo Strutturalismo Gestaltico
http://slidepdf.com/reader/full/lo-strutturalismo-gestaltico 15/15
78
Rossana De Angelis
T ESNIÈRE, L.1988 Eléments de syntaxe structurale, Paris,
Klincksieck.
T HOM, R.
1980 Stabilità strutturale e morfogenesi. Saggio diuna teoria generale dei modelli , Einaudi, To-rino.
1985 Modelli matematici della morfogenesi , Einaudi, Torino.
V ISETTI, J.-M.2004 Le continu en sémantique: une question de for-
mes , “Texto!”, giugno 2004, on line. http:// www.revue-texto.net/Inedits/Visetti/Viset-ti_Continu.html