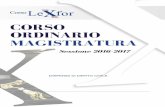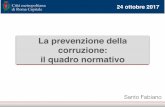L'Illecito
-
Upload
19avantasia87 -
Category
Documents
-
view
74 -
download
0
description
Transcript of L'Illecito
-
LILLECITO
Massimo Franzoni
-
Parte ILILLECITO FONTE DI RESPONSABILIT CIVILE
Titolo IIL FATTO COME ILLECITO CIVILE
Capitolo ILA RESPONSABILIT CIVILE
1. Il concetto di responsabilit civile
La parola responsabilit deriva dal tardo latino respondere ed i giureconsulti di allora la consideravano come una reazione ad un ordine o ad un equilibrio violato. Ora il sostantivo accompagnato da aggettivi che ne precisano il significato e lambito di collocazione nellordinamento giuridico: responsabilit civile, penale, amministrativa, contabile, contrattuale, extracontrattuale, politica, morale.Si tratta di usi eterogenei del termine, spesso neppure riconducibili ad un minimo denominatore comune e neppure riferibili allimpiego terminologico fattone dal legislatore. Questo a causa della povert di linguaggio che ha imposto il medesimo vocabolo per esprimere significati tra loro diversi.
Per indicare il concetto di responsabilit civile bene considerare che elemento caratteristico il collegamento stretto tra il concetto di responsabilit, inteso come fatto produttivo di obbligazione e le conseguenze che si riflettono sul patrimonio di un soggetto: la responsabilit esprime la soggezione del patrimonio di una persona alla soddisfazione di una pretesa altrui.Ci vale tanto per il fatto illecito (Art.2043) quanto per lillecito da inadempimento dellobbligazione (Art.1218); infatti entrambe le norme sul piano degli effetti prevedono che un soggetto tenuto a rispondere con lobbligazione risarcitoria. Ci che le distingue il presupposto: nel primo caso si in presenza di un fatto produttivo di un danno risarcibile che nasce proprio con la responsabilit, nel secondo la responsabilit conseguente ad uninattuazione di un rapporto.Questo collegamento allelemento della patrimonialit tuttavia non ancora sufficiente per definire la responsabilit civile in quanto comune anche alla responsabilit patrimoniale (Art.2740), la cui funzione quella di garantire la soddisfazione del creditore. Qui la responsabilit si qualifica quale mezzo di tutela del diritto del creditore sul patrimonio del debitore; si vincola il patrimonio di un soggetto alle sorti di unobbligazione gi sorta. Nella responsabilit patrimoniale essa si presenta come una situazione autonoma
rispetto al rapporto obbligatorio dalla quale nasce e rispetto al quale non costituisce una fase necessaria ed attuale. Infatti ladempimento, come anche il rimedio dellesecuzione in forma specifica allinadempimento (con il quale il creditore consegue coattivamente la prestazione che forma oggetto dellobbligazione), escludono le conseguenze della responsabilit patrimoniale.Mentre la responsabilit civile connaturata allobbligazione e la qualifica tale sotto un duplice profilo: individua il soggetto responsabile e la rende esistente.
-
*La responsabilit civile sussiste se un certo evento dannoso si possa qualificare danno ingiusto o inadempimento e se questo possa essere imputato ad un soggetto responsabile. Non importa se levento sia derivato da una condotta o da una cosa, se il responsabile non sia lautore materiale del fatto o non sia stato a conoscenza del pregiudizio. Lessenziale che il danno sia ingiusto o che vi sia stato inadempimento e che vi sia un criterio legale per collegarlo ad un obbligato al risarcimento.
Premettendo ci vediamo che la natura/funzione della responsabilit civile consiste in una tecnica per collegare ad un soggetto un evento dannoso con lausilio di un criterio di imputazione (colpevolezza, custodia, propriet), sussistendo il rapporto di causalit. Consta quindi di: criterio di imputazione dellevento, danno ingiusto o inadempimento.
Dallaccertamento della responsabilit nasce il diritto al risarcimento del danno: i due istituiti, pur essendo luno la causa dellaltro (se manca un danno risarcibile viene meno anche lillecito e la responsabilit in quanto questa esiste solo quando sia la causa del risarcimento), conservano una propria autonomia perch rivolti a realizzare finalit diverse- Funzione responsabilit civile : risolvere il problema del se e del come rendere
responsabile un soggetto di un certo fatto dannoso.Se poich occorre valutare quando il danno sia ingiusto e, di norma, astrattamente patrimoniale;come in quanto occorre verificare i requisiti richiesti dal criterio di imputazione applicabile al fatto in questione.
- Funzione risarcimento del danno : risolvere il problema del quanto e del modo in cui compensare il danneggiato.Quanto nel senso che occorre stimare e liquidare lentit del pregiudizio inflitto alla vittima;modo nel senso che la riparazione pu avvenire per equivalente o mediante reintegrazione in forma specifica.
*Alle diverse funzioni si accompagna la diversa struttura dellillecito e del danno!
2. La responsabilit civile e la responsabilit penale
Lunico elemento comune tra responsabilit civile e penale il nome.In origine vi era una perfetta coincidenza tra le due dal momento che la Lex Aquilia ammetteva il risarcimento solo nei casi di condanna ad una pena. La separazione si accentuata con lelaborazione dei concetti di danno e di risarcimento resi autonomi da quelli di reato e di pena criminale, anche se ovviamente permane la comunanza di alcuni termini come quelli di illecito, antigiuridicit, colpa, dolo, rapporto di causalit.
Il sistema della responsabilit civile , destinato a regolare i rapporti tra i privati, autonomo dal sistema di responsabilit penale, destinato ad assolvere una funzione pubblicistica pur potendo riflettersi anche sulle situazioni patrimoniali soggettive dei privati.
-
Cos mentre nellillecito civile il nucleo fondamentale rappresentato dalla clausola generale di ingiustizia del danno; nellillecito penale occorre che vi sia una norma che preveda un certo fatto come reato.
Mentre la funzione della responsabilit civile quella di reagire ad un illecito che vede nel danno ingiusto o nellinadempimento il presupposto per la tutela della vittima, quindi mira a reagire ad una lesione procurata alla sfera del danneggiato; la funzione di quella penale di reagire contro un comportamento contrario alla legge poich in ci risiede lantisocialit da prevenire e reprimere.
Mentre la responsabilit civile causa il risarcimento del danno, che tende a compensare la vittima per la perdita qualificata come danno risarcibile; quella penale importa la condanna ad una pena criminale, che mira a reprimere la condotta illegale punendo e rieducando il reo ed a garantire la tutela della collettivit impersonificata nello stato, rimovendo loffesa ricevuta dal reato. Il danno sempre civile, costituisce sempre una perdita per la vittima che il
risarcimento rimuove; la pena sempre pubblica, costituisce sempre un rimedio che lo stato infligge nellinteresse pubblico!
E diverso il bene tutelato dalle due responsabilit, cos molti reati non hanno rispondenza in alcun illecito civile e viceversa.
Mentre il risarcimento d luogo ad un rapporto tutto interno ai soggetti venuti in contatto per via del fatto illecito o dellobbligazione inadempiuta; la funzione dello stato si limita a controllare le modalit di svolgimento di tale rapporto affinch sia equilibrato lo spostamento patrimoniale oggetto dellobbligazione risarcitoria. La condanna ad una pena fa nascere un rapporto diretto tra stato e reo perch la sua espiazione deve avvenire sotto il diretto controllo dellautorit ed anche perch costituisce esercizio del potere pubblicistico finalizzato a garantire la pacifica convivenza nellinteresse generale.
3. La responsabilit civile, amministrativa e contabile
La responsabilit civile, amministrativa e contabile non hanno nulla in comune, se non gli effetti, in quanto per tutte la conseguenza il risarcimento del danno.La responsabilit amministrativa e quella contabile designano le ipotesi nelle quali il pubblico funzionario chiamato a rispondere per violazione di norme pubblicistiche e della contabilit dello stato, il cui giudizio devoluto alla giurisdizione della Corte dei Conti. sono forme di responsabilit pubblicistiche, analogamente a quella penale, rispetto alle
quali ben delineato lelemento della sanzione per la condotta illecita.Rientrano nella responsabilit interna della pubblica amministrazione che si verifica quando il fatto del funzionario cagiona un danno a terzi cos da impegnare la responsabilit dellente di appartenenza, o quando cagiona un danno patrimoniale allente.Si contrappongono quindi alla responsabilit esterna della pubblica amministrazione, ossia alla sua responsabilit civile
Il presupposto che il danno sia colposamente cagionato allamministrazione, salve le ipotesi nelle quali richiesto il dolo o la colpa grave.
-
4. La responsabilit civile come responsabilit contrattuale ed extracontrattuale
Larea della responsabilit civile si individua nella responsabilit aquiliana o da fatto illecito p extracontrattuale.Dal punto di vista strutturale, come anche sul piano della disciplina la responsabilit extracontrattuale si distingue da quella contrattuale. Infatti - Responsabilit Contrattuale: una conseguenza patologica di un preesistente obbligo
inadempiuto (Art.1218) e limputazione del debitore oggettiva e quindi questa responsabilit pi gravosa.
- Responsabilit Extracontrattuale: nasce con lobbligazione risarcitoria (Art.1173) e limputazione si fonda su diversi criteri tra i quali predomina la colpa.
La responsabilit civile assume il ruolo di concetto di genere rispetto alle due specie, che comunque tendono a soddisfare una medesima funzione: la compensazione della vittima.
5. La responsabilit civile e la responsabilit da illecito concorrenziale
La disciplina tipica della concorrenza sleale stata introdotta con il codice civile del 1942 e diverge da quella della responsabilit civile: gli atti di concorrenza sleale, previsti dallArt.2598, sono giuridicamente fatti illeciti ma tuttavia c una duplice caratteristica che li differenzia dai fatti illeciti in genere previsti dallArt.2043- non occorre perch latto possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale la
prova del dolo o della colpa dellimprenditore che lha commesso- non occorre che latto di concorrenza sleale abbia cagionato un danno allimprenditore
concorrente, essendo sufficiente la mera idoneit dellatto a cagionare danno la differenza dipende dalle qualit dellautore e dalle conseguenze che producono!
Inoltre nella disciplina concorrenziale non si deve indagare circa lelemento della colpevolezza del responsabile, perch si presume.
Inoltre la concorrenza sleale si pone quale autonoma disciplina capace di individuare un bene specifico da tutelare, ossia la reciproca libert di concorrenza degli imprenditori, con due altrettanto specifiche forme, ossia linibitoria ed il risarcimento. lapplicazione della disciplina presuppone la ricorrenza del requisito soggettivo della
qualifica imprenditoriale tra le parti oltre al requisito oggettivo desumibile dalla slealt del fatto.
Che cosa accade se un fatto, oggettivamente qualificabile di concorrenza sleale, non pu esserlo anche soggettivamente per mancanza della qualifica di imprenditore del suo autore?La giurisprudenza ha cos inventato la formula della Sussidiariet Necessaria tra la disciplina dellillecito e quella della concorrenza: una certa condotta ancorch non sia direttamente censurabile con le norme sulla concorrenza sleale costituisce danno ingiusto ossia diviene un fatto illecito agli effetti dellArt.2043. Ed inoltre permette lapplicabilit in via sussidiaria della clausola generale dellingiustizia del danno laddove la concorrenza non sia invocabile per difetto dellelemento soggettivo dellagente.
-
Non si tratta di applicare analogicamente una disciplina in un settore diverso da quello per il quale stata prevista, ma di valutare comparativamente i diversi interessi in conflitto.
In definitiva lillecito concorrenziale tipico, perch produttivo di una responsabilit tipica contrapposta alla responsabilit civile che atipica. Tuttavia non incompatibile con questa: infatti la clausola generale dellingiustizia ben pu essere oggetto di protezione tanto nella forma dellillecito atipico, quanto nella forma dellillecito tipico qualora non ricorrano i requisiti soggettivi.
6. Le fonti della responsabilit civile: la costituzione, il trattato istitutivo dellunione europea e gli altri trattati
Il sistema della responsabilit civile non si risolve nelle norme del Libro IV Titolo IX del codice civile, e ci per due ragioni- la formulazione dellArt.2043 quale clausola generale impone allinterprete di ricercare in
altre norme i valori da tradurre in regole per la soluzione dei singoli conflitti, oltre che nei principi generali dellordinamento giuridico.
- la responsabilit civile, seppur pensata in funzione dellatipicit dellillecito, prevede ipotesi tipiche di illecito rispetto alle quali dato il risarcimento del danno senza dover valutare se levento dannoso costituisca danno ingiusto.
Il sistema delle fonti nella responsabilit civile assolve ad una duplice funzione- consente di attribuire il contenuto ed i limiti della clausola generale- consente di stabilire quando si applichi larticolo e quando invece si applicano altre norme
ugualmente produttive del risarcimento del dannoLe norme costituzionali cui fare riferimento sono quelle espressive dei valori fondamentali dellordinamento giuridicoArt.2 e 3 Cost: per stabilire lambito di protezione delluomo con riferimento al limite della solidariet politica, economica e sociale, da coordinarsi con il principio di uguaglianza in senso formale e sostanzialeArt.41.2 Cost: per affermare che lattivit umana deve essere diretta a realizzare unutilit sociale e non deve recare danno alla sicurezza, libert, dignit umanaArt.21 Cost: per stabilire i limiti della manifestazione del pensiero e constatare quando sia stato leso un diritto della personalit
Proprio il riferimento alle norme costituzionali ha portato uno spostamento di attenzione dai diritti patrimoniali allambito dei diritti non patrimoniali della persona. Ed stato proprio questo riferimento a far nascere la nuova categoria di danno esistenziale.Art.32 Cost: dal quale la giurisprudenza ha desunto lesistenza del diritto alla salute, tutelabile anche nei rapporti tra privati, in quanto espressivo di un valore fondamentale dellordinamento.Il diritto alla salute, quale diritto che comprende in s lintegrit psicofisica nelle sue pi diverse accezioni, ha innovato lambito del danno alla persona, ampliando la sfera degli interessi oggetto di tutela e la nozione di risarcibilit del danno. Sono sempre pi frequenti decisioni dove la tutela aquiliana della persona fatta dipendere dalla sola lesione di un bene o interesse di rilievo costituzionale, senza indugiare oltre sulle conseguenze economiche prodotte da quellillecito.
-
Art.117.1 Cost come modificato: secondo il quale la potest legislativa esercitata dallo stato e dalle regioni nel rispetto della costituzione nonch dei vincoli derivanti dallordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, ha comportato un ampliamento di queste fonti. assumono rilievo quelle di tipo extra statuale, derivanti quindi da trattati
Cos la corte costituzionale ha deciso che la Cedu pur non creando un ordinamento giuridico sopranazionale e non producendo quindi norme direttamente applicabili negli stati contraenti, configurabile come un trattato internazionale multilaterale da cui derivano obblighi per gli stati contraenti. Obblighi, non lincorporazione dellordinamento giuridico italiano in un sistema pi vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti per tutte le autorit interne degli stati membri. Le norme della Cedu non acquistano la forza delle norme costituzionali e non sono
perci immuni dal controllo di legittimit costituzionale della corte.Proprio perch si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale ma rimangono pur sempre ad un livello sub costituzionale, necessario che esse siano conformi alla costituzione.
Non tutti i diritti fondamentali menzionati nella Cedu sono automaticamente diritti inviolabili delluomo, secondo lart.2 cost. I beni/interessi inviolabili della persona devono essere di rilievo costituzionale: seppur tutelati dalla convenzione europea e per questa fondamentali, non hanno il rango di diritti costituzionalmente protetti. la convenzione pur essendo dotata di una natura che la distingue dagli obblighi nascenti
da altri trattati internazionali, non assume, in forza dellart.11 cost, il rango di fonte costituzionale, n pu essere parificata a tali fini allefficacia del diritto comunitario nellordinamento interno.
6.1. Il codice civile
Le norme del codice civile che tutelano diritti o situazioni di fatto possono essere giuridicamente rilevanti. Infatti nelle norme che tutelano i diritti della persona, i diritti reali, il possesso, i diritti della personalit, il contratto, si ritrovano espressi valori fondamentali dellordinamento giuridico, gli stessi valori enunciati nella costituzione e che grazie alla clausola generale di responsabilit dellArt.2043 costituiscono interessi meritevoli di protezione agli effetti della responsabilit civile.
Nonostante la previsione di illeciti autonomi previsti fuori del codice o di sottosistemi introdotti con leggi speciali, non si registrata la perdita di centralit del codice civile. Anzi la maggior parte della legislazione speciale costituisce una specificazione della clausola generale di responsabilit e non tutte le norme speciali prevedono un illecito tipico da porre come alternativo al regime posto dallarticolo 2043.Es. illeciti previsti nel codice della navigazione La deroga si pone solo sul piano del criterio di imputazione diverso dalla colpa o su
quello della delimitazione dellarea del danno risarcibile.
-
6.2. Le leggi speciali
Solo quando la normativa speciale sia idonea a creare una figura tipica, essa diventa compiutamente derogatoria della disciplina ordinaria. Diversamente essa si pone come eccezione ad alcuno soltanto degli elementi dellillecito, ossia come gi detto il criterio di imputazione o il criterio di stima del danno.
La responsabilit civile, a discapito della pluralit delle fonti, resta un sistema unitario costruito intorno alla clausola generale dellArt.2043
6.3. Le direttive ed i principi comunitari
Buona parte del diritto vigente non pi di fonte esclusivamente statuale: i regolamenti e certe direttive comunitarie sono direttamente applicabili senza necessit di alcuna ratifica con legge dello stato. Delleventuale incostituzionalit va investita la Corte di giustizia Europea e non la corte costituzionale, come accadrebbe per qualsiasi legge ordinaria.Lavvento del diritto comunitario assume rilievo sotto un duplice profilo- rappresenta una limitazione del potere sovrano di ogni singolo stato aderente.
In alcuni settori la limitazione pi forte ma non si deve abusare di questo potere: infatti quando sono in questione diritti della personalit uno stato membro pu mantenere le disposizioni nazionali preesistenti che derogano ad una misura di armonizzazione, qualora ritenga che i rischi per la salute siano pi elevati rispetto a quanto calcolato dal legislatore comunitario al momento delladozione della misura di armonizzazione.
- modifica i principi e la cultura giuridica di ogni paese, per consentire luniformit del diritto e dunque un miglior funzionamento delle regole della concorrenza
Le direttive comunitarie sono fonti della responsabilit civile, come il caso della direttiva in tema di responsabilit del produttore di beni di largo consumo.
Una speciale responsabilit dello stato stata delineata nel caso in cui una direttiva non sia recepita e non rientri tra quelle che possono trovare diretta applicazione; a riguardo devono sussistere due requisiti- la prescrizione deve essere incondizionata e sufficientemente precisa: non deve lasciare
margine di discrezionalit agli stati membri nellattuazione e la fattispecie ed il contenuto devono essere determinati con compiutezza in tutti i loro elementi
- lo stato destinatario deve risultare inadempiente per essere inutilmente decorso il termine previsto per dar attuazione alla direttiva medesima.
Ladesione dellItalia allUnione Europea comporta limpegno a conformarsi anche a principi che non necessariamente hanno fonte nellordinamento giuridico nazionale. Gli interessi tutelabili con la clausola generale di ingiustizia devono comprendere anche quelli concorrenziali comunitari. necessario un attento sguardo allEuropa nellelaborare criteri.
La responsabilit civile quale tecnica che comporta lo spostamento di una certa somma da un soggetto ad un altro, deve essere riguardata anche sotto un profilo macro economico, rispetto al quale non per nulla estraneo il profilo dellappartenenza dellItalia allEuropa.
-
In concreto linterprete legittimato ad interpretare la clausola generale di ingiustizia, cos come tutti gli altri elementi dellillecito civile avvalendosi di tecniche e di prassi seguite anche in ordinamenti giuridici diversi dal nostro quando ci sia richiesto dallesigenza di uniformare i diversi sistemi.Naturalmente c un dovere di motivazione dei provvedimenti che non si pu ritenere soddisfatto dal semplice riferimento al diritto vigente in un altro paese.
7. La responsabilit civile ed i principi generali: lalterum non laedere
Il sistema della responsabilit civile costellato di principi comunemente impiegati nelle motivazioni delle sentenze, anche se nelle norme non sempre si trova una loro significativa presenza.Alludo al principio dellalterum non laedere che vuole indicare- una regola di comportamento- il precetto la cui violazione comporta la sanzione della responsabilit civile
ma quale la sua vera funzione, posto che in s nulla aggiunge alla clausola generale di responsabilit? Vi sono tre distinti gruppi di casi- il principio viene impiegato quando il danno deriva dalla lesione di un interesse di cui si
discute la qualificazione giuridica e la tutelabilit nellordinamento.La sua funzione di rafforzare la portata della clausola generale.
- impiego del principio per chiarire la funzione dellArt.2043 attribuendogli la portata di norma secondaria o meramente sanzionatoria: indica che il precetto o la norma violata al di fuori di tale articolo.Il neminem laedere vorrebbe riassumere i doveri di comportamento posti da norme primarie la cui violazione importa la responsabilit ed il risarcimento.*interpretazione dellingiustizia del danno che va contro la costruzione dellarticolo perch la funzione della norma non meramente sanzionatoria in quanto attraverso lingiustizia che la violazione di un diritto diviene fonte di responsabilit civile.
- ricorso al neminem laedere per sostenere che anche la pubblica amministrazione pu rispondere nei confronti dei privati per gli illeciti commessi in loro danno; anche lo stato non pu sottrarsi allobbligo di attenersi alle regole di questo principio, diversamente risponde dei danni cagionati.Assolve quindi il compito di escludere la pubblica amministrazione dal privilegio dellirresponsabilit consentendo eccezionalmente di sindacare anche la discrezionalit amministrativa quando tale uso abbia leso i diritti dei cittadini.*responsabilit esterna dellamministrazione
In definitiva lalterum non laedere non arricchisce mai lArt.2043 e pu pertanto considerarsi sinonimo della clausola generale di responsabilit.
-
Capitolo IIIL FATTO E IL RAPPORTO DI CAUSALITA
Sezione I: Il Fatto
1. Il fatto fonte di responsabilit
Il Titolo IX del Libro IV intitolato dei fatti illeciti, il fatto illecito figura tra le fonti delle obbligazioni allArt.1173, lArt.2043 rubricato risarcimento per fatto illecito e nei termini di concorso del fatto colposo del creditore si esprime lArt.1227.Gran parte della civilistica italiana ha criticato luso legislativo del termine fatto, poich tale non potrebbe essere un accadimento umano cosciente e volontario; questo sostantivo senza altra aggiunta lascia pensare al fatto naturale, non al fatto umano. Questa obiezione riflette unimpostazione teorica costruita sullidea di volont che regge il negozio giuridico: esiste una sequela concettuale che dalla nozione di fatto (meri eventi della natura), attraverso quella di atto (fatti umani prodotti dalla coscienza e volont del soggetto di diritto nei quali gli effetti sono gi predeterminati dalla legge), procede nel spiegare lagire illecito verso quella di negozio giuridico (fatti umani nei quali sono voluti anche gli effetti degli stessi). Non dunque corretto il riferimento al fatto illecito, perch la qualifica di
lecito/illecito sarebbe propria solo dei comportamenti umani volontari. Di qui la preferenza data alla terminologia atto doloso o colposo e di atto illecito.
Ma il linguaggio del legislatore del 1942 non riflette questa impostazione che ha voluto adattare le teorie volontaristiche, funzionali alla costruzione logica del negozio giuridico, alle categorie codicistiche e si mostra a favore della nozione fatto dove il termine illecito non sinonimo di colposo. Questa preferenza perch- non essendo stato codificato il negozio giuridico come categoria generale ed ordinante
dellagire giuridico nel lecito, dubbio che si possa applicarne ugualmente lo strumentario concettuale
- difficile superare la giustificazione linguistica data dal ministro guardasigilli che ritiene pi esatta la denominazione di fatto illecito perch in altra parte del libro delle obbligazioni con la voce atti si sono designati i negozi giuridici
- non tutti gli illeciti fonti di responsabilit, hanno come presupposto un comportamento umano cosciente e volontarioes. nel danno da cose in custodia, da uso di animali la responsabilit non si fonda su una condotta umana antigiuridica o comunque su di un evento verificatosi quale conseguenza di unazione volontaria .Qui la responsabilit mette in relazione un soggetto con una perdita patrimoniale dovuta al fatto della cosa, senza che abbia rilievo la qualit della condotta di colui che deve rispondere
- di un certo fatto fonte di danno si pu rispondere anche non avendo la capacit naturale, dunque in mancanza della volontariet che richiesta dalla teoria del negozio giuridico. Inoltre dallArt.2048 si desume che i minori imputabili rispondono in proprio dei fatti illeciti quantunque siano privi della capacit di agire
- a volte il responsabile tenuto al risarcimento non per il fatto proprio, ma per quello delle persone delle quali deve rispondere per legge.
-
Qui il responsabile non commette alcun illecito, quindi personalmente non compie alcun atto illecito ed il fatto produttivo non pu non essere che un fatto.es. per i padroni ed i committenti
2. Il fatto lesivo, lazione e levento di danno
La responsabilit da fatto illecito si considera solo se pu produrre lobbligazione risarcitoria: la sola azione seppure negligente o addirittura volontariamente compiuta, non produttiva di alcun effetto se non diventa lesiva della posizione soggettiva della vittima e se non sia causa di danno risarcibile.Es. guida di un ubriaco di per s fonte di responsabilit per fini amministrativi ma non costituisce un fatto giuridicamente rilevante fino al momento in cui non diventa causa di un incidente produttivo di un danno risarcibileNelle figure di responsabilit oggettiva spesso manca una vera e propria azione, infatti un certo evento imputato ad un responsabile solo per effetto della relazione che questi ha con la cosa fonte di danno (custode) o in ragione di una particolare situazione soggettiva, a prescindere da una sua azione colposa.Questo dimostra come la nozione di fatto fonte di responsabilit comprenda tanto lazione lesiva, quanto levento dannoso: il fatto coincide con il sinistro, ossia con levento di danno prodottosi.
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno viene fissata la decorrenza dal giorno in cui il fatto si verificato e per giurisprudenza costante viene considerato tale il momento dal quale le conseguenze pregiudizievoli si riflettono nel patrimonio o nella situazione soggettiva della vittima. Se in futuro sopravvengono peggioramenti dalla lesione, questi vanno collegati al fatto originario ed assoggettati alloriginaria decorrenza della prescrizione.Diversamente accade quando la lesione si scopre in un tempo successivo: la prescrizione decorre dal momento in cui vi stata la scoperta della lesione, dando cos per ammesso che il fatto sussiste quando si scopre levento. Prima dellevento, ancorch lazione pu ritenersi antigiuridica a fini penali/amministrativi, la prescrizione civile non incomincia a decorrere: manca il fatto fonte di responsabilit quindi non ancora sorta lobbligazione risarcitoria.
Un evento lesivo indispensabile perch il fatto possa essere aggettivato come illecito.Il fatto quindi non indica lazione lesiva e neppure il danno risarcibile, ma un dato intermedio tra i due ed utile per stabilire se un soggetto sia responsabile e di quali conseguenze deve rispondere con il risarcimento.Gli elementi del fatto possono consistere tanto in unazione quanto in unomissione, purch da queste causalmente si produca un danno ingiusto,ossia un evento lesivo di una situazione protetta.
-
3. Lillecito, antigiuridicit e la colpevolezza
Il termine antigiuridicit privo di un adeguato supporto normativo, infatti non richiama una precisa disciplina; si colloca tra illiceit, ingiustizia e colpevolezza senza assumere mai una posizione certa, avendo in comune a queste la contrariet al diritto. Quindi anzich assumere un valore definitorio e classificatorio di una fattispecie vale quale sinonimo di illiceit della condotta o di ingiustizia del danno.I concetti di illecito ed illiceit vengono tradizionalmente collegati alla condotta umana, ma ci lo affronteremo nel capitolo successivo.
4. La nozione normativa dillecito civile e la tradizione giuridica
Quando si qualifica la illiceit come la difformit di un fatto dal diritto, si impiega il concetto in unaccezione pi ampia di quella qui esaminata. Infatti- La lesione dei diritti della personalit, dei diritti reali sono il risultato di una condotta
illecita, in quanto contraria al diritto, tuttavia non per questo essa produttiva di un illecito fonte di responsabilit civile
- Lazione di nullit, linibitoria poich dirette ad eliminare lillecito mediante la rimozione o la cessazione dei suoi effetti lesivi sul diritto sono rimedi contro lillecito, ma al di fuori della responsabilit civile. Sono misure date per contrastare una condotta lesiva a prescindere dalla verificazione di un danno ingiusto e patrimoniale, dal quale discende la responsabilit civile ed il risarcimento
Quindi in quale significato il termine illiceit stato impiegato nel Titolo IX del Libro IV?La tradizione attribuiva fondamento colposo a tutte le ipotesi di responsabilit, in quanto non era data alcuna responsabilit senza colpa, quindi la colpa diventava sinonimo di illiceit e veniva considerata quale elemento unificante di tutti i fatti per i quali la responsabilit costituiva la giusta reazione.Ora questa concezione trova un duplice ostacolo- la responsabilit la forma di reazione tipica al danno ingiusto, inteso quale lesione di un
interesse meritevole di tutela secondo lordinamento giuridico- la colpa non pi il fondamento esclusivo della responsabilit, sussistendo diversi criteri
di imputazione il baricentro del sistema si spostato dallautore del fatto al soggetto che subisce un
danno ingiusto, pertanto lingiustizia e non la colpa selezione gli interessi la cui lesione determina un evento di danno da risarcire.
Si pu concludere che il significato normativo dellilliceit/illecito non che un concetto di sintesi per indicare una qualit richiesta dalla legge per tutti i fatti produttivi di danno risarcibile:levento deve presentarsi quale danno ingiusto, deve essere riconducibile ad un responsabile secondo uno specifico criterio di imputazione, sussistendo il rapporto di causalit di fatto.Lillecito cos configurato si distingue dal danno che invece attiene alla fase successiva del giudizio di responsabilit, nella quale vengono stimate e liquidate le conseguenze economiche pregiudizievoli dellevento lesivo, ossia il danno risarcibile.
Solo sussistendo lillecito ed un danno patrimoniale pu sorgere la responsabilit, il cui giudizio si conclude con la condanna al risarcimento
-
Laver svincolato la nozione di illecito dalla condotta umana consente di poter accostare al sostantivo laggettivo atipico: pu esserci atipicit dellillecito civile solo se si comprende nella sua nozione lingiustizia del danno.
5. Il fatto illecito permanente
Il fatto illecito pu essere specificato nei termini di fatto istantaneo o di fatto permanente ed in questultima accezione si descrive il fatto attraverso una particolare modalit attuativa della condotta.La natura permanente del fatto consiste in una condotta che non cessa quando si produce la lesione nella sfera della vittima: questa perdura finch lautore non desiste o non compie un ulteriore atto idoneo ad eliminare gli effetti dellazione lesiva.Ci che si rinnova di momento in momento levento di danno prodotto dalla condotta, sicch le conseguenze sono dipendenti dal ripetersi dellevento. Il fatto illecito permanente quando la condotta dalla quale derivano eventi lesivi tra
loro collegati, riconducibili al medesimo autore, continuata.Es. esecuzione costruzione in violazione di norme di edilizia.Per tanto la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non decorre dalla data di realizzazione della costruzione ma da quella di cessazione della permanenza e cio dal momento in cui la costruzione viene demolita.Comunque la qualificazione di un fatto come permanente produce conseguenze in ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento: poich il titolo per il risarcimento sorge con linizio del fatto illecito, possibile che il fatto, al momento in cui proposta la domanda, sia gi prescritto con riguardo al primo evento di danno. Ma poich il danno si rinnova di momento in momento ed frazionabile pro rata temporis in relazione al momento in cui cessata la permanenza o in cui stata proposta la domanda, il quantum va limitato pro rata temporis ossia con riferimento al periodo di prescrizione non ancora decorso.In questo modo si stabilisce quali eventi lesivi siano ricompresi e quali invece estranei e vadano apprezzati autonomamente.
6. Il fatto permanente e il danno permanente
Ogni danno si pu considerare permanente, perch resta fino a che non sia rimosso con il risarcimento.Semmai vi possono essere casi di fatto illecito istantaneo ad effetti permanenti: qui il fatto istantaneo produttivo di conseguenze permanenti non perch il pregiudizio si riproduce continuamente ma perch le conseguenze del fatto sono permanenti nel tempo, una volta verificatosi levento lesivo.La prescrizione inizia a decorrere non dal momento del manifestarsi dellultimo di tali eventi di danno, ma del primo di essi e di cui i successivi costituiscono solo uno sviluppo.Es. illecito da occupazione illegittima quando a questa seguita lirreversibile modificazione della cosa sicch sarebbe impossibile la restituzione in natura dello stesso bene
-
7. Le conseguenze del fatto illecito permanente: il danno plurimo!
La conseguenza del fatto illecito permanente non il danno permanente ma il danno plurimo, ossia quel danno che si rinnova di momento in momento, poich a ripetersi levento lesivo.
8. Il fatto, il danno risarcibile come conseguenza ed il danno patrimoniale
Il fatto illecito fonte di responsabilit richiede un evento lesivo di una situazione protetta (danno ingiusto), riferibile ad un responsabile attraverso un criterio di imputazione e lesistenza di conseguenze pregiudizievoli per la vittima che costituiranno loggetto della obbligazione risarcitoria.La mancanza di una perdita valutabile economicamente o di una disutilit non patrimoniale nella condizione della vittima rende tutto vano: nel concetto di fatto illecito deve sussistere anche un danno certo, nel senso si un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale.Per lungo tempo la prevalenza degli interpreti ha ritenuto che le conseguenze pregiudizievoli per la vittima dovessero riassumersi nel concetto di danno patrimoniale. Il concetto di patrimonialit del danno non enunciato espressamente; al contrario lArt.2059 dispone che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. Questa bipartizione era considerata untile per indicare nel danno patrimoniale quello sempre risarcibile, a differenza di quello non patrimoniale sottoposto ad una tassativa riserva di legge.Allidea di patrimonialit del danno ben si collega la funzione compensativa del risarcimento che deve infatti coprire la perdita causata dal pregiudizio in modo che il patrimonio della vittima sia riportato agli stessi valori che aveva prima del fatto illecito.Ma lemergere di nuove fenomenologie di danno, specie quelle nel settore dei danni alla persona, ha avviato un processo di revisione in quanto quando in questione vi sono lesioni a diritti non patrimoniali non sempre il criterio del patrimonio personale pu essere chiamato in causa per misurare la perdita: questa lesione non necessariamente comporta una perdita misurabile con i valori del patrimonio.Lapprofondimento sul tema della patrimonialit del danno ha inaugurato la terza stagione di studi sulla responsabilit civile, dopo quella inerente alla liberazione dal sistema della colpa e quella che ha qualificato lingiustizia del danno nei termini di clausola generale. Infatti proprio quelle nuove fenomenologie di danno hanno messo in crisi la tradizionale equazione tra la lesione di un interesse patrimoniale e la causazione di un danno patrimoniale, in contrapposizione alla lesione di un interesse non patrimoniale che causerebbe un danno non patrimoniale.
Concludendo: la patrimonialit del danno non una qualit desumibile a priori dalla natura dellinteresse leso, ma dipende dalle conseguenze economiche dellevento lesivo sui beni, sui rapporti del danneggiato, intesi in senso lato. Proprio per questo il criterio della patrimonialit del danno pu essere impiegato per la stima e la liquidazione di lesioni a beni costituenti valori duso o valori che non trovano nel mercato una diretta misurazione in termini di valore. Laddove le conseguenze pregiudizievoli su questi beni/ valori siano valutabili economicamente, secondo un criterio sociale tipico, c un danno patrimoniale, senza che su di questo influisca la natura eventualmente non patrimoniale del diritto o dellinteresse leso.
-
9. Il nuovo danno non patrimoniale
Alle soglie del terzo millennio (dibattito danno alla salute, danno esistenziale) si radicata lidea che la responsabilit civile potesse essere uno strumento per tutelare la persona lesa nei diritti della personalit, a prescindere da ogni riferimento alle capacit della vittima di produrre reddito e a prescindere da una lesione psicofisica medicalmente accertata, dunque oltre il danno biologico.In pi cera lidea che la risarcibilit del danno dellArt.2043 non richiedesse sempre la patrimonialit tra le conseguenze utili nella stima e liquidazione del pregiudizio. Occorreva quindi collegare a quel risarcimento del danno funzioni diverse da quella
compensativa, come quella di assolvere una finalit solidaristico satisfattiva, in precedenza assegnata solo al danno non patrimoniale inteso come danno morale soggettivo.
La rilettura costituzionale dellArt.2059 ha permesso di collocare al suo interno tutte le ipotesi risarcitorie per pregiudizi non patrimoniali conseguenti alla lesione di valori inerenti alla persona di rilievo costituzionale.Tutto ci senza rompere il sistema dellillecito civile retto dallArt.2043 perch ci di cui si tratta riguarda le conseguenze della lesione: se sono di natura patrimoniale restano disciplinate dallArt.2043, mentre se sono di natura non patrimoniale ricadono nellArt.2059 in base alla nuova lettura della norma.
-
Sezione II: Il rapporto di causalit nellillecito
1. Il rapporto di causalit nellillecito civile
Il tema del rapporto di causalit nodale nella ricostruzione del fatto fonte di responsabilit aquiliana; tuttavia il codice civile non d alcuna definizione di causalit. Lunico cenno contenuto nellArt.2043 nellespressione cagiona ad altri un danno ingiusto dove il verbo cagiona qui sinonimo di causa, ma nulla aggiunge su come la causalit debba essere intesa.Inoltre il verbo cagionare predicato del danno ingiusto e non del danno risarcibile: infatti le due nozioni di danno divergono- Danno ingiusto: indica la lesione di un interesse meritevole di tutela secondo
lordinamento giuridico. Quindi inteso come clausola generale di responsabilit- Danno risarcibile: indica le conseguenze economiche pregiudizievoli del fatto, ossia la
patrimonialit del danno o comunque la sua risarcibilitQuestultima fase del giudizio, attinente quindi al danno risarcibile, disciplinata dallArt.1223 ed anche a questa norma attribuito un fondamento causalistico: il criterio per stabilire se una data conseguenza pregiudizievole riferibile ad un fatto illecito, rimanda ad un complesso di regole riassumibili nel concetto di Causalit Giuridica. Impiegata nel giudizio sul risarcimento o sulla riparazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire lentit delle conseguenze pregiudizievoli del fatto, che si traducono nel danno risarcibile.
Concetto differente dalla Causalit del Fatto illecito/materiale : criterio per stabilire se una certa condotta ha cagionato proprio la lesione qualificabile come evento di danno con i caratteri dellingiustizia. Impiegata nel giudizio sullillecito, comprensivo della valutazione sullingiustizia (primo tassello nella costruzione del fatto), al fine di imputare un evento ad un soggetto.
Limpiego della causalit in momenti diversi del giudizio di responsabilit e quindi la sua diversa finalit esclude la possibilit di costruirne una teoria unitaria perch una cosa impiegare la causalit per stimare il danno risarcibile ossia per determinare la rilevanza giuridica delle conseguenze economicamente sfavorevoli dipendenti da quellevento di danno; altra cosa impiegarla al fine di imputare un evento ad un soggetto. (vedi * di seguito)
La giurisprudenza a riguardo si limitata a dettare una serie di formule che vengono adottate per rendere operante la causalit e che possono valere tanto per la causalit giuridica quanto per quella di fatto. Infatti entrambe le causalit hanno in comune la necessit di dover giustificare il collegamento tra un fattore che precede ed uno che segue, a prescindere dalla mera successione temporale.- Regolarit statistica: nellindagine sulla sussistenza della causalit di fatto tra la
condotta e levento, la regolarit della sequela causale pu essere desunta dalla natura pi o meno pericolosa dellattivit fonte del danno
- Probabilit ex ante dellaccadimento secondo una legge dotata di validit scientifica- Verosimiglianza - Rischio specifico della propria attivit
Es. parcheggi lauto in divieto di sosta causando un incidente. Se il cartello era stato posto per evitare incidenti sussiste il rapporto di causalit, se invece aveva un fine di
-
decoro di una zona monumentale il rischio dellattivit non specifico dunque non vale a stabilire il nesso eziologico tra condotta e fatto illecito.
Il rischio e il pericolo pur non essendo categorie normative, possono sorreggere la motivazione che porta ad accertare la causalit di fatto. Sono quindi categorie metagiuridiche di supporto alle regole pratiche, che quindi da sole non valgono a costruire autonomamente una teoria della causalit nellillecito civile.
In tema di responsabilit civile il problema della causalit si presenta sotto un duplice aspetto, infatti il rapporto di causalit va scomposto nelle due fasi corrispondenti al giudizio sullillecito ed al giudizio sul danno da risarcire* attiene al nesso causale tra la condotta del soggetto agente, a lui imputabile a titolo di dolo o colpa e levento (causalit di fatto).
Tale giudizio viene svolto sulla base delle circostanze del caso, con il criterio della regolarit e normalit della sequela ed influenzato dal criterio di imputazione; ci non significa per che la causalit si risolva nel criterio dimputazione.* presupponendo integro in tutti i suoi aspetti lo schema condotta->nesso causale->evento, attiene alla derivazione causale del danno dallevento, danno di cui si pretende il risarcimento.
Qua la regolarit e normalit della sequela delle conseguenze si valutano oggettivamente ossia secondo uno standard assunto a modello astratto di raffronto per tutte le ipotesi analoghe a quella concreta, per consentire unequilibrata ridistribuzione della ricchezza in senso quantitativo.Nella stima del danno non patrimoniale le regole della causalit valgono per determinare quali disagi/disutilit non economiche devono essere riparate, siccome conseguenze della lesione, cos da realizzare la finalit solidaristico- satisfattiva per questo risarcimento.Quando entra in campo il caso fortuito inteso in senso ampio, comprensivo quindi del fatto del terzo o del danneggiato, ci si riferisce a quella fase del giudizio dove viene ricostruito il fatto inteso come condotta-evento: c da accertare se un dato evento di danno imputabile alla condotta del soggetto responsabile. Se il rapporto di causalit tra una certa condotta e levento di danno sussiste vi sar
un danno risarcibile. E la prova del rapporto di causalit spetta al danneggiato, che nel fornirla non sottoposto a particolari limitazioni!Se non sussiste il danno sar una conseguenza remota dellevento prodotto dalla condotta, irrilevante per il diritto.
2. Regole comuni per funzioni diverse
Abbiamo visto che la causalit nel sistema della responsabilit civile assolve una duplice funzione- Causalit di fatto: imputare al responsabile il fatto illecito. Occorre tutte le volte che si
deve esaminare il collegamento tra gli elementi dellillecito- Causalit giuridica: stabilire entit delle conseguenze pregiudizievoli del fatto. Occorre
ogni volta che si debba determinare e misurare il danno risarcibile3. La causalit ed il criterio dimputazione
-
Le regole della causalit non si sovrappongono al criterio di imputazione, dunque non servono neanche per selezionare il novero degli interessi meritevoli di tutela secondo lordinamento giuridico.Infatti nel caso di colpa derivante dalla violazione di leggi/regolamenti, la colpa in re ipsa, nella trasgressione perch la probabilit che da quella violazione possa derivare una lesione gi stata considerata dal legislatore quando ha posto la regola. La inosservanza della norma rende superflua ogni ulteriore indagine sulla negligenza,
imprudenza nel comportamento dellautore
4. Gli usi impropri della causalit
Per lungo tempo vi stato da parte degli interpreti un uso improprio del termine causalit, in quanto la tecnica argomentativa per escludere il risarcimento del danno si era incentrata sulla mancanza del rapporto di causalit giuridica tra fatto e danno. Contrariamente, in tempi pi recenti si messo in luce che la mancanza del danno ingiusto, oltre alla mancanza dellobbligo giuridico di impedire levento, a costituire la sola ratio decidendi.Qualunque uso della causalit estraneo alla funzione di imputare il fatto al responsabile- causalit di fatto o alla determinazione del danno patrimoniale- causalit giuridica, da bandire, poich un modo per risolvere problemi che hanno diversa natura e collocazione.
5. La causalit di fatto nellillecito
Il rapporto di causalit di fatto si compone di un elemento positivo e di uno negativo- Fatto positivo: dato dalla prova che un soggetto abbia posto in essere una condizione
dellevento e cio un antecedente senza del quale levento stesso non si sarebbe verificato.Lonere della prova grava sul danneggiato, questo pi agevole!
- Fatto negativo: dato dal fatto che il risultato non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali.Lonere della prova grava sul danneggiante/convenuto che assolvendolo si libera dalla responsabilit. Infatti in mancanza della prova del fatto impeditivo, ossia di fattori eccezionali, la causalit sussiste e quindi gli elementi o le semplici allegazioni dellattore sono sufficienti per stabilire il rapporto di causalit.
Lonere della prova del danneggiato molto pi agevole perch la prova del fatto positivo pu essere data per presunzioni o addirittura soltanto allegata e perch il principio generale della materia quello dellequivalenza tra tutti i fattori antecedenti alla produzione dellevento di danno. La sua prova si risolve nella dimostrazione della sequela causale alla stregua della teoria della condicio sine qua non (la condotta umana condizione necessaria dellevento se, eliminata mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti, levento non si sarebbe verificato): occorre che gli antecedenti del risultato siano condizionanti levento sul piano fattuale e non siano invece meri antecedenti cronologici di per s senza alcun rilievo concreto. Non difficile raggiungere una siffatta prova perch si fonda sulle regole della regolarit statistica basata sul giudizio di probabilit ex ante da valutarsi in ordine a tutte le circostanze del caso.Il responsabile pu fornire la controprova sul fatto riferendosi sempre alla teoria della condicio sine qua non.
-
Talvolta lo stesso legislatore ad agevolare la vittima: il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno ma se appare verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice pu ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.
6. La causalit ed i diversi impieghi del sostantivodanno
Anche se qualcuno obiettando che la nozione di evento di danno non ha fondamento normativo in quanto non menzionata nel codice civile ritiene che il suo utilizzo rifletta uno schema di ragionamento proprio dellillecito penale, inutile in sede civile, sul piano logico c la necessit di scomporre la nozione di danno in quelle di evento di danno, danno patrimoniale e danno non patrimoniale.Proprio perch il danno risarcibile sempre la conseguenza di una certa lesione, occorre individuare con precisione levento nel quale si satura questa lesione. Questo evento costituisce il momento finale dellindagine sulla sussistenza dellillecito civile (giudizio causalit di fatto) e al contempo il momento iniziale dellindagine sulle perdite da risarcire, quandanche non siano economicamente valutabili. Quindi si pone in soluzione di continuit tra il giudizio sullillecito e quello sul risarcimento. questa sorta di spartiacque concettuale si identifica con levento di danno, ossia con
lingiusta modificazione esteriore, materiale o giuridica, della sfera della vittima per effetto della condotta dellautore, della posizione giuridica che ha un soggetto rispetto alla cosa o del collegamento stabilito dalla legge a carico di un responsabile con il fatto illecito compiuto da altri. Levento di danno delinea la lesione dalla quale origina il pregiudizio ed indica gli effetti materiali di quella stessa lesione; il termine finale della sequela della causalit di fatto.
Levento di danno assume un ruolo centrale perch il presupposto* per accertare se linteresse leso della vittima sia meritevole di tutela* per la determinazione del danno risarcibile con il criterio della causalit giuridica- Evento tipizzato: la funzione della causalit di fatto si limita a collegare levento tipico alla lesione subita dal danneggiato, tutto ci che accade successivamente va catalogato tra le conseguenze da considerarsi secondo la regola della causalit giuridica.- Evento non tipizzato/indicato solo genericamente: la funzione della causalit di fatto di collegare al soggetto responsabile quellevento che gli riferibile secondo la regolarit, la normalit, le regole scientifiche applicabili.Levento di danno non si pu distinguere a priori per i suoi caratteri naturali, ma si pu prefigurare in ragione dei criteri di imputazione della responsabilit.Es.- illecito doloso: levento va identificato con quello voluto dallautore del fatto, quindi
occorre accertare lordinariet della sequela causale dei fatti tenendo conto che lautore si prefigur lesito della sua condotta
- illecito colposo: levento va tendenzialmente identificato con quello che poteva essere prevedibile ed evitabile da parte del responsabile, secondo i criteri impliciti nel canone della diligenza, prudenza e perizia.
-
Questo concetto differisce dal danno evento che identifica un pregiudizio insito nella lesione e che non necessita di alcuna ulteriore dimostrazione per ottenere il risarcimento.
Il termine danno impiegato con diversi significati- Danno ingiusto Art.2043 parte iniziale: lesione di un interesse meritevole di tutela
secondo lordinamento giuridico- Danno patrimoniale Art.2043 parte finale: quando il danno accostato al risarcimento
indica la perdita economica/patrimoniale da stimare e da liquidare secondo le regole della causalit giuridica (Art.1223)
- Danno non patrimoniale Art.2059: conseguenze non valutabili economicamente ma meritevoli di riparazione
- Danno morale soggettivo: da riconoscere alla vittima quando il fatto costituisce reatoLa presenza di tutti questi elementi attribuisce rilevanza giuridica al danno rendendolo risarcibile, perfezione quindi la fattispecie di responsabilit civile dalla quale nasce lobbligazione risarcitoria.
7. Levento di danno, il danno risarcibile ed il danno ingiusto
Il danno ingiusto, quale clausola generale, assolve la funzione di selezionare qualitativamente la circolazione della ricchezza, mediante la cernita degli interessi meritevoli di tutela la cui lesione pu essere foriera di un danno risarcibile.Dal punto di vista fenomenologico il danno ingiusto contiene in s levento di danno, infatti esprime in termini di rilevanza giuridica la lesione degli interessi colpiti. Entrambe le nozioni si riassumono nella clausola di ingiustizia del danno che il primo tassello nella costruzione dellillecito, seguito dal risarcimento: la responsabilit costituisce la reazione al danno ingiusto, mentre il risarcimento la reazione al danno risarcibile.
-
Sezione III: Il concorso di cause
1. Il problema del concorso nellevento di danno
Tra tutti i presupposti di un certo evento, la causalit di fatto deve selezionare solo quelli giuridicamente necessari al suo accadimento.Un certo fatto non mai il risultato di una causa soltanto quindi occorre attribuire alla causalit di fatto una capacit selettiva tra tutte le possibili cause di un risultato quando queste derivano da soggetti diversi: allaccertamento del nesso causale si pu giungere solo attraverso approssimazioni successive.LArt.41 C.p detta in proposito due regole- Equivalenza delle cause : il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute,
anche se indipendenti dallazione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalit tra lazione/omissione e levento.
- Rompe la regola dellequivalenza introducendo il concetto di causa efficiente esclusiva: le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalit quando sono state da sole sufficienti a determinare levento. E se lazione/omissione precedentemente commessa costituisce di per s un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Stabilire se c una sequela causale costante e regolare o se invece essa stata interrotta in presenza di fattori eccezionali di per s capaci di produrre levento, demandato al giudice del merito, il cui giudizio incensurabile in sede di legittimit, sempre che sia sufficientemente motivato ed immune da vizi logici.
2. Le regole di selezione fra le concause
Laccertamento va compiuto ex ante, ossia senza vedere nel risultato finale prodotto da tutte le condotte lelemento di necessaria sintesi di tutti gli antecedenti, ma attribuendo logicamente ad ogni fattore concorrente la propria efficienza. Occorre procedere dal primo evento della serie e risalire fino allevento di danno conclusivo ed appurare se la sequela stata regolare, cio se levento successivo ha rappresentato uno sviluppo normale e non abnorme di quello precedente.Ove cos facendo si giunga ad individuare un evento di danno diverso da quello per il quale il danneggiato agisce in giudizio significa che c una serie concorrente di cause rispetto alla quale tuttavia non si pu ragionare in termini di concorso.
Es. non vi concorso tra il fatto di chi ha continuato ad erogare energia elettrica agli occupanti abusivi di un immobile e la lesione subita dal proprietario per l occupazione abusiva. E si negata la responsabilit dellEnel sebbene quellabuso sia stato agevolato dal contratto di somministrazione di energia elettrica.
Occorre escludere logicamente alcune concause ed interrogarsi sulla possibile verificazione dellevento finale: se questultimo si sarebbe ugualmente verificato significa che le concause in realt sono state solo occasioni e non vere e proprie cause. Dunque si deve escludere coloro che hanno posto in essere le mere occasioni dal giudizio di responsabilit.
-
Il fatto esclusivo dal quale deriva levento non necessariamente deve essere sopravvenuto, pu essere anche contestuale o anteriore ad unulteriore serie causale, purch abbia le caratteristiche della prossimit.
Le serie causali rimangono distinte se sono produttive di eventi lesivi che danno luogo a separati danni patrimoniali.
Es. ferito morto in ospedale per il crollo delle strutture: il responsabile del primo incidente che ha portato al solo ferimento non risponde del danno conseguente allevento morte, ma solo dei danni alle cose riportati in seguito al sinistro
2.1. Segue: casistica sul concorso di cause
Il solo fatto del furto in un appartamento non vale ad esonerare da responsabilit la societ appaltatrice che aveva installato un ponteggio. Occorre valutare se rispetto allaltezza del palazzo ed ad ogni circostanza del caso, la presenza di quel ponteggio abbia costituito il fattore decisivo nella scelta di intraprendere lattivit criminosa. Bisogna valutare in concreto, avendo riguardo alla situazione di fatto e con un giudizio
di prevedibilit compiuto ex ante.Leccezionalit di una certa condotta va accertata in concreto sulla base dellefficienza di ogni serie causale e dellidoneit in concreto a produrre levento di danno, poich solo effettuata questa indagine si pu relegare la precedente sequela al rango di mera occasione.Si tratta si stabilire la misura nella quale il fatto iniziale ha agevolato la commissione del fatto dannoso consequenziale.- Se risulta che, senza lantecedente,lautore materiale del fatto non avrebbe consumato
lillecito, deve ritenersi sussistente lunitariet dellevento dannoso.- Se accertato che lautore avrebbe comunque cagionato il danno ingiusto, lazione
successiva si pone come causa prossima e sopravvenuta, di per s sufficiente ad escludere levento anteriore.
- Se anche il fatto iniziale illecito, ciascun autore risponde separatamente nei confronti del danneggiato per il risultato della propria condotta, perch ogni evento si configurerebbe come un autonomo fatto dannoso.
3. La causalit negli incidenti di massa: una diversa lettura dellart 41 comma 2c.p.
Una causa di per s sufficiente a produrre levento (causa efficiente esclusiva) vale ad assolvere lautore dalla responsabilit derivante dalla precedente serie causale e vale anche ad escludere che il fatto dannoso sia stato prodotto da un fascio di azioni dirette inequivocabilmente verso un obiettivo unitario, cos da determinare la solidariet nellobbligazione risarcitoria.Ma, nel settore degli illeciti di massa, stata proposta uninterpretazione letterale dellArt.41.2 c.p che la rende equiparabile negli effetti allArt.40 c.p: infatti se una causa stata da sola in grado di provocare un evento, significa che non hanno avuto rilevanza altre cause delle quali quindi inutile decretare lininfluenza.
-
3.1. La causalit di fatto e la funzione della responsabilit civile
La funzione della responsabilit civile non quella di punire lautore del fatto, bens quella di reagire contro il danno ingiusto mediante il risarcimento del danno. la posizione centrale nel sistema assunta dalla vittima e non dal responsabile. E
nellinteresse della vittima garantire che levento di danno sia causalmente imputabile a qualcuno, cos da consentirle di ottenere il risarcimento.
Queste decisioni riflettono il favor per la vittima.
4. Dagli incidenti di massa alla diversa regola della causalit nel sistema della responsabilit penale e nel sistema della responsabilit civile
La funzione della responsabilit civile diversa da quella della responsabilit penale, dove centrale la persona del reo; infatti in quella civile centrale la persona della vittima con la conseguenza che anche laccertamento della causalit materiale deve avvenire con criteri diversi, poich il sistema deve privilegiare la riparazione del danno alla vittima e non la punizione del responsabile.Da ci discende che nel sistema penale occorre raggiungere il giudizio di causalit fondandolo sul criterio dellelevato grado di credibilit razionale che prossimo alla certezza, altrimenti si rischierebbe di condannare ingiustamente una persona. Invece nel sistema civilistico sufficiente stabilire una relazione probabilistica concreta tra il comportamento e levento dannoso, secondo il criterio del pi probabile che non.Giudizio che prescinde da ogni valutazione di prevedibilit da parte dellautore (valutazione compiuta ai fini dellaccertamento dellelemento soggettivo) e che si distingue dallindagine diretta allindividuazione delle singole conseguenze dannose, propria della casualit giuridica, finalizzata a determinare i confini della gi accertata responsabilit risarcitoria.( Gli effetti del giudicato penale sul giudizio civile presuppongono lidentit del rapporto di causalit materiale)
5. Il fatto doloso del coautore
La concausa per escludere il nesso eziologico deve presentare i caratteri del caso fortuitoOccorre accertare caso per caso leffettiva incidenza eziologica delle diverse sequele, tenendo conto delle seguenti alternative- Il fatto doloso esercita una sorta di vis actracitva rispetto al fatto colposo, sicch
levento lesivo imputabile in via esclusiva a chi abbia agito con dolo. Ci accade quando la negligenza ha prodotto un evento che seppure autonomo si ponga quale mero strumento nella verificazione dellevento finale.Es. chi volendo uccidere qualcuno sostituisce un medicinale successivamente somministrato allignaro paziente da un medico. Il medico in colpa per aver omesso i dovuti controlli preventivi sulla sostanza, ma tale circostanza irrilevante in quanto
-
questa condotta colposa formava gi oggetto della previsione di chi, avendo agito con dolo, confidava proprio nellimprudenza del medico per realizzare il disegna criminoso
- Il fatto concorre con quello colposo, dando luogo alla responsabilit solidale, ma in sede di regresso risponde dellintero chi abbia agito con dolo. Ci accade in specie con la colpa specifica per violazione di norme che hanno lo scopo di evitare levento oggetto del dolo.Es. chi riesce a trafugare capitali allestero grazie al negligente controllo della documentazione presentata alla banca. Anche la banca risponde solidalmente verso lo stato per colpa specifica, ma in sede di regresso lintero costo del danno sar imputato al trafugatore in dolo
6. Il concorso dovuto ad uno stato di necessit illecitamente causato da un terzo
Il fatto dannoso pu risultare dallattivit di chi ha reagito prefigurandosi uno stato di necessit, che in realt era stato illecitamente causato da un terzo.La circostanza che un terzo illegittimamente determina uno stato di necessit non vale ad interrompere il rapporto di causalit tra chi ha agito e levento di danno che ne seguito.Al soggetto necessitato richiesto lindennizzo e solo il terzo necessitante tenuto al risarcimento dellintero danno. In sede di regresso il necessitato pu agire nei confronti del terzo per ottenere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennit. ipotesi di solidariet con limporto limitato allindennizzo dovuto, per la parte residua
risponde in via esclusiva il terzo colpevole di aver creato lo stato di necessit dal quale derivato il danno.
-
Sezione IV: Il concorso del fatto del danneggiato
1. Il concorso del fatto del danneggiato
Un tipico concorso legislativamente previsto quello del fatto del danneggiato, infatti lArt.1227 prevede due distinte ipotesi per delimitare larea del danno risarcibile- concorso del danneggiato nella produzione dellevento di danno: pone un problema di
causalit di fatto- danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando lordinaria diligenza: pone un
problema di causalit giuridicaEsaminando la prima ipotesi vediamo che lArt.1227.1 dispone che se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento diminuito secondo la gravit della colpa e lentit delle conseguenze che ne sono derivate.N.B: ad una prima lettura pare che la colpa funga da misura per determinare lampiezza del danno, ma non cos perch il termine colpa impiegato in senso atecnico!
2. Lart 1227 comma 1 prima parte c.c
LArt.1227.1 va scomposto in due parti, in quanto detta regole applicabili a momenti diversi del giudizio di responsabilit, sebbene entrambi si concludano con il risarcimento.1 parte: se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno. Indica la modalit per ricostruire il fatto riferendosi al giudizio sullillecito che mira ad accertare e postula lunicit del fatto cagionato in concorso. Unicit da intendersi nel senso che le cause concorrenti devono aver tutte contribuito a determinare levento, in modo che esso non si sarebbe verificato senza lincidenza eziologica di ciascuna di esse. anche il fatto della vittima d luogo ad un concorso di cause il cui effetto va stabilito
con le comuni regole e pu assumere rilievo sebbene sia anteriore, concomitante o successivo alla condotta del danneggiante, purch sia posto come condizione rilevante dellevento finale di danno.Pu assumere rilievo anche il fatto omissivo, se sussisteva lobbligo giuridico di agire.
Il concorso del fatto della vittima pu essere rilevato dufficio dal giudice qualora il danneggiante si sia limitato ad eccepire il difetto della sua responsabilit.La rilevabilit dufficio deve seguire le regole del principio devolutivo del sistema delle impugnazioni: il giudice di primo grado libero di indagare sul concorso sebbene sia mancata unesplicita domanda in proposito; invece il giudice dappello non pu farlo ove sia mancata limpugnazione della parte interessata su quel capo della sentenza, altrimenti si pronuncerebbe su un dictum sul quale si gi formato il giudicato.
2 parte: il risarcimento diminuito secondo la gravit della colpa e lentit delle conseguenze che ne sono derivate. Detta la disciplina per la misura della perdita economica, per meglio dire indica il contenuto del rapporto causale tra il fatto ed il danno risarcibile e fornisce il criterio per delimitare il pregiudizio imputabile al danneggiante.
-
I giudici riducono lentit del risarcimento valutando lincidenza sul piano causale del concorso tra pi fatti imputabili a soggetti diversi, cos da applicare il principio secondo cui il danneggiato deve sopportare il pregiudizio che egli stesso abbia causato.
2.1. Segue: il concorso con il fatto dellincapace
La regola pu essere applicata anche quando il danneggiato sia incapace: lelemento essenziale di accertamento lobiettivo contrasto tra la condotta del danneggiato incapace e la comune prudenza e diligenza.Es. minore che sottraendosi al controllo della madre, viene investito procurandosi lesioniLa non imputabilit dellArt.2046 non viene in considerazione, posto che questa una norma diretta a regolare i risarcimenti dovuti dallincapace ai terzi, ma non quelli che la vittima ha concorso a cagionare a se stessa. Questa non imputabilit idonea ad evitare al responsabile il risarcimento verso i terzi in modo che il terzo dovr quindi sopportare il peso del danno subito, per esigenze socialmente apprezzabili di tutela dellautore, non imputabile, dellillecito.*Al contrario, quando la non imputabilit sia la causa di un danno per il suo autore, le esigenze sociali di tutela non sussistono, dunque quel danno o una sua parte devono essere sopportate dal suo autore non imputabile.
Diversamente accade per il danno subito dallincapace occorso anche per lomessa sorveglianza dei genitori: in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento dovuto da chi tenuto alla sorveglianza dellincapace, salvo che provi di non aver potuto impedire levento. Infatti il genitore che agisce in giudizio per il proprio figlio e non in sua rappresentanza pu vedersi eccepire dal danneggiato il concorso di colpa per non averlo sorvegliato.
2.2. Segue: il concorso nelle ipotesi di responsabilit oggettiva
La nozione di fatto colposo del creditore stata intesa nel senso di evento riconducibile causalmente al suo autore: interessa accertare se la condotta materiale del danneggiato, arricchita dalla qualit eventualmente colposa della sua azione, pu configurarsi quale concausa dellevento. Ratio della 1 parte non quella di una norma nella quale la colpa, in quanto
determinante della responsabilit, influisce anche sullentit del risarcimento; ma quella di una norma che pone a carico del danneggiato il danno che egli stesso ha concorso a cagionare.
Il criterio di imputazione, retto dalla colpa, perde il significato proprio di elemento dellillecito per assumere quello di requisito materiale ed oggettivo dellazione, da affiancare al rapporto di causalit.( Ovviamente quando il fatto del danneggiato sia stato la causa esclusiva dellevento di danno, ovviamente al fatto stesso viene attribuita ancora pi rilevanza)
3. Lart 1227 comma 1 seconda parte c.c.
Bisogna vedere come operano i due criteri legislativi dettati per ridurre il risarcimento: gravit della colpa ed entit delle conseguenze che ne sono derivate.
-
Su questo punto le interpretazioni della dottrina si sono divise, mentre pacifico che questo accertamento di competenza esclusiva del giudice del merito, la cui valutazione non censurabile in cassazione al di fuori delle ipotesi del difetto di motivazione.- chi contrariamente a quanto disposto nella norma ha escluso che la gravit della colpa
possa venire concretamente in rilievo, trattandosi semplicemente di valutare se questa sussista.
- chi sostiene che la colpa va intesa oggettivamente quale violazione della diligenza misurata con riferimento ad un canone generale di condotta, al di fuori di qualsiasi connotato psicologico (volizione-intenzione) e senza alcuna considerazione circa la violazione dellinteresse altrui. Come d'altronde fa la giurisprudenza!
Tuttavia i risultati cui si perviene seguendo le due impostazioni coincidono perch i primi escludono che la colpa abbia un ruolo nel giudizio causale ed i secondi attribuiscono rilevanza alla colpa solo nella prima fase del giudizio ossia in quella relativa alla ricostruzione del fatto.La colpa viene esclusa nella fase successiva che va dal fatto al pregiudizio cagionato, perch in questo momento, dove viene impiegata la tecnica della causalit giuridica, hanno rilievo solo le conseguenza pregiudizievoli che sono derivate. La colpa non pu essere impiegata quale criterio per quantificare il danno
4. La provocazione dellautore come ipotesi di concorso della vittima?
Ai fini del concorso causale, assume rilievo la provocazione effettuata dalla vittima? Un tale comportamento idoneo a ridurre il risarcimento?Molti interpreti negano che assuma rilievo ai fini del concorso colposo del danneggiato, poich ritengono che chi reagisce decide autonomamente e dolosamente la propria condotta sicch la provocazione non pu essere considerata causa del danno e non contribuisce a determinare levento sul piano causale. chi reagisce ad una provocazione risponde per intero del danno cagionato
Ma se la provocazione si protratta a tal punto da ingenerare in chi reagisce la falsa coscienza di uno stato di legittima difesa, diviene di rilievo causale e quindi pu applicarsi lArt.1227.1. Ma leventuale reazione configura comunque un eccesso colposo in legittima difesa che certamente assume rilievo ai fini dellapplicabilit delle regole del concorso.
E diverso il caso in cui la provocazione costituisca un autonomo illecito come nel caso in cui le offese configurino la lesione dellonore, della reputazione o costituiscano diffamazione: di questo la vittima dellulteriore evento di lesioni deve rispondere.
5. La colpa e il rischio nel concorso del fatto del consumatore di un prodotto difettoso (vedi anche il 10.2 del Capitolo seguente)
In tema di Danno da circolazione di prodotti difettosi l Art.10 d.p.r 24 maggio 1998 n.224 , ha disciplinato il concorso nella produzione del danno tra il fatto del danneggiato/consumatore e del produttore.Nellipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato, il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dellart.1227 del codice civile. Il risarcimento non dovuto quando il danneggiato sia stato colpevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne deriva e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
-
viene quindi valorizzata lautoresponsabilit della vittima, volontariamente espostasi al pericolo.
Tali disposizioni, lette congiuntamente allart.9.2 che consente il regresso tra i responsabili nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, importano che al criterio della colpa del danneggiato sul piano della ricostruzione del fatto, si affianca quello del rischio riferibile a ciascuna delle attivit.Infatti, in questi casi, i giudici valutano lincidenza delle rispettive condotte nella verificazione dellevento di danno in funzione del rischio riconducibile a ciascuna di esse. Il comportamento del consumatore diventa rilevante solo per lassunzione del rischio
creato ulteriormente a quello normalmente connaturato alluso del prodotto, il quale resta a carico del produttore.
Proprio al fine di accertare tale rischio ulteriore, occorre indagare se il danneggiato avrebbe dovuto essere consapevole della difettosit del prodotto o se era legittimo che egli ne fosse alloscuro.
Inoltre alla colpa della vittima viene equiparata, allArt.10.3 la colpa del detentore nei confronti del danneggiato, limitatamente al danno delle cose.Es. chi con limprudente utilizzo di un prodotto difettoso, cagiona un danno su una cosa ricevuta in detenzioneAl proprietario della cosa danneggiata il produttore del bene difettoso pu opporre leccezione del concorso, eccezione data nellinteresse del produttore per evitare la solidariet nei confronti del danneggiato.Il danneggiato pu agire separatamente verso il detentore o convenirlo nello stesso giudizio, pur non potendo avvalersi della solidariet. Cos facendo il produttore sollevato dal rischio dellazione di regresso, perch leventuale insolvenza del detentore corresponsabile posta a carico del danneggiato.
6. La volontaria esposizione del consumatore
La funzione dellArt.10.2 quella di armonizzare nel concorso discipline desumibili da contesti nei quali figurano criteri di imputazione diversi in combinazione tra loro: la colpa codicistica e linsicurezza del prodotto dovuta ad un suo difetto.Si oggettivizza nuovamente la colpa in considerazione della particolare posizione assunta dal danneggiato rispetto al bene fonte di danno.Questo articolo infatti riguarda lassunzione del rischio da parte del danneggiato, quindi la sua operativit presuppone che lutente sia stato capace di intendere e di volere al momento del fatto. sussistono la consapevolezza del difetto e la volontariet nellassunzione del rischio
7. I casi discussi di concorso del fatto del danneggiato
Vi sono casi che solo apparentemente si presentano nella forma di concorso del fatto del danneggiato- Seduzione con promessa di matrimonio: pu esserci se loblato (chi la riceve) si trova in colpa nel valutare la seriet e lattendibilit della proposta?
-
In termini di stretto rapporto di causalit anche questo evento dannoso d luogo ad un concorso del fatto del danneggiato, ma se si indaga sul contenuto dellinteresse leso si giunge ad una diversa soluzione: pu essere danno ingiusto la seduzione con promessa di matrimonio, se loblato autonomamente coopera al verificarsi dellevento, al di fuori del raggiro perpetrato in suo danno dal proponente?La giurisprudenza rifiuta il risarcimento ritenendo che non sia configurabile il concorso di colpa del soggetto passivo/oblato, perch la sua condotta colposa dovuta dal difetto della stessa antigiuridicit del comportamento del soggetto attivo.
8. Linsidia o il trabocchetto ed il concorso della vittima: un cambiamento di rotta nella responsabilit della pubblica amministrazione
C un orientamento prevalente secondo il quale la responsabilit della pubblica amministrazione per i danni cagionati dagli utenti delle strade ricondotta alla colpa: la colpa qui desunta da una situazione qualificabile come insidia stradale /trabocchetto, della quale sono stati vittime gli utilizzatori. Ma stato aggiunto che vi sono ragioni di incompatibilit logica tra un possibile concorso di colpa del danneggiato e la stessa nozione di insidia, essendo questa contraddistinta dai caratteri dellimprevedibilit e dellinevitabilit del pericolo. se fosse possibile il concorso di colpa del danneggiato vorrebbe dire che manca
linsidia, dunque la colpa della pubblica amministrazione e che pertanto non potrebbe essere pronunciata alcuna responsabilit a suo carico.
A questa tesi si obiettato che la condizione di insidia deve essere valutata oggettivamente, a prescindere dalla condotta irregolare della vittima: questa condotta di per s non esclude la qualit colposa della condotta negligente dellamministrazione ossia la presenza di uninsidia/trabocchetto.
-
Sezione V: La solidariet quale effetto del concorso di cause
1. Il concorso tra pi agenti e la solidariet nellobbligazione risarcitoria
Il presupposto perch operi la solidariet che il fatto dannoso, inteso come evento di danno, sia imputabile a pi persone: le serie causali logicamente autonome devono tutte necessariamente contribuire a produrre levento finale, indipendentemente dalla loro idoneit a configurare anche altri illeciti previsti dallordinamento.Non richiesta ununit di disegno tra i coautori dellillecito e neppure lidentit o contestualit delle azioni o delle norme violate: anche condotte autonome, tra loro indipendenti, poste in essere in tempi diversi, possono aver dato luogo ad un unico fatto dannoso, quando il loro risultato finale sia unitario.E indifferente che talune condotte siano il risultato di azioni, mentre altre di omissioni o risultino da uno stato di necessit, indifferente che i titoli di responsabilit siano diversi ed infine che le singole condotte avrebbero potuto assumere rilievo quali cause di autonomi illeciti.Occorre solo che il fatto dannoso sia unico e questa unicit deve essere valutata esclusivamente con riferimento alla posizione soggettiva del danneggiato. Comunque tale quel fatto in relazione al quale linteresse della vittima al risarcimento unitario, poich si produce un unico pregiudizio/danno da un unico evento dannoso, pur essendo il fatto illecito plurisoggettivo o pur essendo stati commessi diversi fatti illeciti. il fatto di pi persone imputato con un criterio oggettivo di responsabilit
Il fenomeno del concorso regolato dallArt.2055 (detta la regole dellequivalenza delle cause: solidariet) che tende a favorire il danneggiato, che mediante la regola della solidariet, pu rivolgersi indifferentemente nei confronti di ogni responsabile ed ottenere il pagamento dellintero. Questa scelta si coniuga con lesigenza di tutela del danneggiato contro il rischio di insolvenza di uno dei danneggianti, contro il rischio che uno dei danneggianti resti ignoto o che sia un non imputabile.Questo articolo detta due regole- una che collega un evento dannoso a pi persone mediante il rapporto di causalit di fatto
e da ci fa nascere lobbligo solidale del risarcimento tra i coautori.Presuppone laccertamento di un fatto dannoso unitario e lindividuazione dei responsabili secondo i criteri della causalit di fatto.
- laltra stabilisce il criterio per ripartire il costo del danno tra i corresponsabili.Utile in sede di regresso, esprime il principio secondo il quale ciascuno deve rispondere del fatto proprio e delle conseguenze prodottesi; solo in via residuale, nel dubbio appunto, le singole colpe si presumono uguali.
Differentemente dallArt.1227.1 dove la concausa rimanda al danneggiato e vale a ridurre il risarcimento del danno o ad escluderlo, qui la concausa rinvia ad un coautore terzo e vale a
-
stabilire la regola della solidariet in favore del danneggiato, sul presupposto della riconduzione sul piano causale di un fatto dannoso a pi soggetti.
2. Lorigine e la funzione della solidariet nellillecito civile: lunicit del fatto dannoso
La solidariet svolge una funzione di garanzia, tuttavia il presupposto della sua applicazione non lequit ma proprio lindagine e la ricostruzione del fatto.Compete al giudice del merito stabilire quando un evento dannoso imputabile a pi soggetti e quando invece vi una pluralit di eventi dannosi.
*La solidariet opera anche per il risarcimento del danno non patrimoniale*La solidariet non viene meno per effetto della morte di un condebitore: ciascun erede del defunto rimane obbligato solidalmente con i condebitori originari, ma solo fino alla concorrenza della propria quota ereditaria
LArt.2055 si applica anche al concorso del fatto di una pubblica amministrazione o di pi enti pubblici tra loro: in tal caso la solidariet deriva dalla circostanza che le diverse azioni producono uno stesso fatto dannoso e quindi levento finale unitario.
E solidale anche la responsabilit tra amministratori di societ di capitali e tra amministratori e sindaci.
3. Il rilievo dei singoli apporti ed il concorso della causa naturale
LArt.2055 assolve la funzione di collegare pi soggetti al fatto dannoso, stabilendo leffetto della solidariet nei confronti del danneggiato, sul presupposto dellefficienza causale delle rispettive azioni.Non ha stabilito un principio di causalit parziale, in forza del quale ciascuno risponde del danno nella percentuale che ha concorso a cagionarlo (se lapporto causale di uno dei compartecipi minimo rileva solo in sede di regresso ). Ne consegue che non vi possibilit di concorso tra causa/condotta umana e causa fortuita/fatto
naturale, in quanto questultima per essere produttiva di effetti deve porsi come esclusiva cos da interrompere il nesso eziologico con il soggetto individuabile in base al criterio di imputazione
la partecipazione allevento di danno da parte del fatto del non imputabile, non d luogo a riduzioni
Quando il fatto dannoso non imputabile a pi persone? la regola dellequivalenza delle cause nella produzione dellevento viene superata solo quando ad una di queste possa attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva. E tale quella che si pone al di fuori di ogni normale e prevedibile linea di sviluppo della serie causale dipendente dalla condotta dellagente, e costituisca quindi un fattore abnorme avente una propria autonoma potenzialit.
4. Il fatto di pi persone imputato con un criterio oggettivo di responsabilit
-
Infatti ai fini della solidariet nel risarcimento non rilevante un particolare collegamento psicologico tra le diverse condotte, non richiesto un preventivo accordo tra i coautori e neppure occorre la consapevolezza di cooperare al fatto altrui.Il concorso di cause riguarda tutti gli illeciti, tanto quelli che richiedono la colpa quanto quelli che non la richiedono. Occorre solo che lillecito di ognuno dia luogo ad una responsabilit che potrebbe essere dichiarata qualora questi da solo avesse prodotto levento di danno o che debba essergli imputata in forza della posizione o per la rilevanza di un certo vincolo contrattuale. il criterio di imputazione assume rilievo solo ontologicamente, non per gli effetti che
normalmente produce.
5. La solidariet nel concorso di responsabilit per fatto altrui
La regola dellequivalenza delle cause vale anche per regolare tutte le ipotesi di concorso tra il fatto dellautore materiale dellillecito e quello di chi tenuto parimenti a rispondere del danno in base ad uno status (genitori, tutori), al rapporto di committenza (padroni e committenti) o in base alla particolare posizione giuridica rispetto al bene (proprietario del veicolo).Tutti questi casi costituiscono ipotesi speciali, perch la normalit che ciascuno risponde esclusivamente del fatto proprio; questa specialit comunque non legittima lidea di una deroga al regime della solidariet stabilito allArt.2055.Pertanto preferibile sostenere che larticolo sia espressivo di un principio generale di solidariet, che trova il suo presupposto nellunitariet del fatto dannoso e che prescinde dal titolo o dal criterio di imputazione della responsabilit; anche se nella responsabilit per fatto altrui il concorso una conseguenza del criterio di imputazione della responsabilit. Ma questa non comunque una ragione sufficiente per negare lapplicabilit di un principio generale.Es.- la responsabilit dei genitori solidale con quella del minore capace di intendere e di
volere, salvo che uno dei due non dai la prova della mancanza di coabitazione, quale conseguenza di un provvedimento di separazione personale tra coniugi
- c pari responsabilit da parte di tutti coloro che hanno assunto la veste di committenti del preposto, salvo che non sia accertabile in fatto la preminenza di uno solo.E invece da escludere che dallillecito del preposto minore, possa derivare la responsabilit solidale del committente e dei genitori, perch al genitore non si deve accordare un potere di ingerenza nella direzione dellimpresa, potere che di titolarit esclusiva del padrone.
- la responsabilit del committente per il fatto del preposto pu concorrere con quella del proprietario del veicolo
- sono responsabili in solido i comproprietari di un veicolo per il danno cagionato dal conducente
6. Il concorso derivante da un illecito e da un inadempimento
Pu aversi concorso di cause se i presupposti risiedono in un illecito aquiliano ed in un inadempimento contrattuale.
-
Es. concorso della responsabilit contrattuale del vettore con la responsabilit aquiliana del terzo, che insieme abbiano cagionato lesioni al trasportato.Es. concorso tra la responsabilit dellappaltatore e del progettista
6.1. Il caso dellappaltatore e del progettista
Ipotesi di danno unitariamente considerato anche se causalmente riferibile a diversi inadempimenti: danno cagionato dal fatto dellappaltatore e del progettista nei confronti del medesimo committente.Lappaltatore essendo un tecnico dellarte ed operando in completa autonomia tenuto a verificare il progetto predisposto risponde della rovina, del pericolo di crollo o di altri difetti se non ha constatato gli
errori progettuali o se non li ha prontamente denunciati al committente.Tuttavia il danno subito dal committente deriva dal concorso della condotta del progettista e di quella dellappaltatore: di qui il problema della natura solidale dellobbligazione risarcitoria che vede contrapporsi tre orientamenti- esclusione della solidariet: in quanto c una consumazione separata dei due
inadempimenti a due distinte obbligazioni; ci sul presupposto dellesistenza di obbligazione alternativa e concorrente.Quindi il danneggiato avrebbe potuto agire nei confronti di entrambi chiedendo la condanna per lintero di ciascuno in modo alternativo o di entrambi in relazione alle rispettive responsabilit. Ma in questo modo c il rischio di vedere condannato per intero uno dei responsabili senza possibilit per questo di esercitare il regresso, avendo escluso la natura solidale dellobbligazione.*Si ammetteva invece la solidariet quando vi fosse stata collusione tra appaltatore e progettista.
- ferma la mancanza di solidariet i giudici hanno riconosciuto il diritto di regresso nei confronti del corresponsabile in favore di chi avesse risarcito p