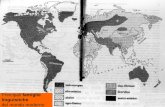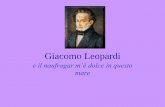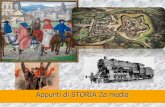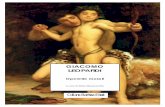Leopardi E Il Mondo Moderno
Transcript of Leopardi E Il Mondo Moderno

FRANC0 FERRUCCI
LEOPARD1 E IL MONDO MODERN0
LA FORTUNA POSTUMA DI LEOPARDI assomiglia per certi versi a quella toccata a Niccolo Machiavelli, un autore da lui molto ammirato (e del quale si servira abbondantemente nella stesura dei Pensieri). L’analogia consiste nella comune difficolta di essere accettati alla lettera. E una sorte curiosa per i due scrittori italiani piu difficilmente interpretabili da un punto di vista allegorico o extra-referenziale, i piu assolutamente onesti e veridici espositori delle proprie idee, i meno portati a una stratifi- cazione di piani semantici e a una pratica di doppia verita (che poi Ma- chiavelli raccomandi quest’ultima a1 suo Principe e un altro discorso). Sono noti i secolari tentativi di far passare Machiavelli come un precet- tore di virtu che finge di incoraggiare il vizio (cosi lo presentano, fra gli altri, sia Rousseau che il Foscolo, e a questo tende in fondo anche Gram- sci nelle sue note sull’autore del Principe). Rassegnarsi alla trasparenza del pensiero machiavellico sembra dover mettere in questione i criteri morali del lettore; cosi come piegarsi alla chiarezza leopardiana pare comportare un’accettazione della sua negativita da parte degli interpreti.
Anche a Leopardi doveva toccare il destino di una lettura “profunda,” la quale ha verosimilmente il suo atto di nascita nel saggio di De Sanctis dal titolo “Schopenhauer e Leopardi,” dove si afferma che e prerogativa del poeta di Recanati ingenerare effetti contrari a quelli da lui perseguiti (l’amor della vita invece della volonta di morte, l’amor di patria invece del rifiuto del patriottismo). Tale indicazione, ancora accettabile nei ter- mini emotivi in cui la pone De Sanctis, ha aperto la strada alla ricorrente ambizione di catturare ‘51 vero significato” del pensiero di Leopardi. Ne 6 seguita una serie di peregrinazioni critiche ispirate dalla volonta di redimere il suo messaggio da un contenuto globalmente negativo.
Cia salutato nel secolo scorso come un precursore del Risorgimento sulla base di una composizione giovanile che 6 stata imposta alla memorizzazione di intere generazioni di studenti, a Leopardi doveva capitare una nuova vicissitudine in questo second0 dopoguerra; quando all’etichetta risorgimentale 6 stata sostituita quella di poeta e di pensatore progressista. Se l’interpretazione patriottica contava soprattutto sulla canzone All’ltalia, quella progressista si 6 appoggiata a una lettura ideologizzata dello Zibaldone. La proposta ha presto acquistato i con- notati di una certezza a priori; e raramente un infortunio critic0 di tale portata e stato preso maggiormente sul serio e per un lasso di tempo cosi
112

Ferrucci SYMPOSIUM 113
considerevole. Per una valutazione di Leopardi come pensatore va anzi- tutto restituito alla sua scrittura un senso rigorosamente letterale.
Ma attraversare le incomprensioni storiche 6 il marchio della grandez- za di un’opera. Che a Leopardi sia riuscito questo attraversamento (al- meno da noi, nei nostri confini, e malgrado lo sfiguramento a cui e stato soggetto) non pare dubbio. Un secolo e mezzo dopo la sua morte non si pub dire che alla sua figura sia venuto meno l’affetto e il sostegno dei let- tori. Pochi scrittori della nostra letteratura sono stati cosi amati e venerati nel ricordo dei posteri.
C’e anche chi ha recepito con esattezza il discorso di Leopardi e pro- prio per questo non l’ha amato. E il caso di Gabriele D’Annunzio. In una nota irosa conservata nella biblioteca del Vittoriale e vergata ai margini di A Sifvia, D’Annunzio rintraccia in questi versi il segno clamoroso dello stato di decadimento a cui era giunta un’intera tradizione letteraria. L’angelismo apocalittico di Leopardi viene risolutamente respinto da colui che vede in se stesso il vero erede di Foscolo e di Carducci, nel solco della tradizione neopagana che attraversa l’intero Ottocento; e Leopardi viene escluso dalla dinastia dei poeti iniziata da Alfieri e prolungatasi fino a1 vate di un’Italia guerriera.
A un dato punto tale insofferenza raggiunge il suo apice. E un passo in cui Leopardi non viene apertamente designato, e questo spiega come la sua presenza sia sfuggita all’attenzione dei critici e dei lettori. Si tratta di un episodio dal libro di Maia, o Laus vitae, un testo assai complesso e ad- dirittura criptico nella sua tessitura di riferimenti. L’ispirazione tematica centrale di Laus vitae e una ripresa dalle Grazie di Foscolo (persino nell’idea di trapiantare la Grecia sulle colline intorno a Firenze, e proprio nello stesso sito scelto da Foscolo, il poggio di Bellosguardo) a cui si ag- giunge la celebrazione di se che aveva trovato uno spavaldo cantore nel Walt Whitman del Song of Mysew. E, come gia Foscolo nelle Grazie, an- che D’Annunzio in Laus vitae si accinge a una ricostruzione della tradi- zione italiana di cui egli vuole essere l’erede legittimo; e la rassegna ter- minera con il saluto al maestro Enotrio, il Carducci, dal quale D’Annun- zio vuol ricevere la simbolica investitura.
Ma fra le figure del passato albergano anche i reprobi e i respinti. A un certo punto, una “delle creature accosciate nell’ombra” tra la folla degli addolorati leva il suo lamento “con voce rimasta per secoli muta-disse l’antica parola: Perche siamo nati?” La reazione del poeta e violenta: “Taci, bestia-da macello e da soma!-(. . . .) Silenzio! Silenzio! (. . . .) Taci tu, casa da mercato, ingombro gemebondo!-E ogni lagno si tac- que,-ogni vil bocca ebbe il bavaglio” (XVII, 497 ss.). Che D’Annunzio si riferisca qui a Leopardi (neppure nominato, tanto e il suo spregio) a me non par dubbio; ed e notevole che in quel “perch6 siamo nati” egli

114 SYMPOSIUM Summer 1993
ritrovi “l’antica paro1a”-certo quella di Giobbe. In cbiave anti- leopardiana va letta anche l’ultima apostrofe del poema, quella diretta alla Natura, “mia Madre immortale,” madre finalmente benigna e non piu malevola o indifferente.
I1 caso di D’Annunzio rimane isolato e, a mod0 suo, abnorme. Anche Carducci professa almeno rispetto per il poeta di Recanati; e Verga fa di Rosso Malpelo un nuovo pastore leopardiano, analfabeta e delirante sot- to il cielo stellato; lo stesso fara Pirandello del suo Ciaula che scopre la h a . Gia Pascoli, mai veramente ammesso a1 trono regale dei suoi maestri, si accinge a peregrinare poeticamente sulle orme del profeta doloroso; e poi Ungaretti, che scrive e riscrive “L’Infinito” lungo tutti i brevi carmi della sua AIIegriu; e poi Montale, il piu coerente prosecutore filosofico dell’eredita leopardiana; per non parlare di Saba, e di Rebora, e di Zanzotto. Dopo Petrarca, non c’era piu stata una presenza cosi per- vasiva e cosi estesa nel tempo. A1 confronto, la stessa eredita di D’An- nunzio e un falo violento e violentemente consumato.
Eppure, a1 di la dell’eredita letteraria, che cosa 2 ora Leopardi per noi; quale retaggio lascia in delega a1 nostro mondo?
Prima ancora di cercare di rispondere, dobbiamo richiamare le due presenze che si sono contese [ie] suo territorio speculativo: ( 1 ) I’idea di un progresso definitivamente inarrestabile; (2) l’idea di una Natura ostile a1 decorso umano. Le due ipotesi sono legate fra di loro: I’ambizione verso un illimitato progresso dovra, secondo Leopardi, fallire a causa della ini- micizia della Natura, la quale non permettera all’uomo di diventare il signore dell’universo. La malvagita di Arimane (0 di chi per h i ) 6 il fon- damento ultimo del pensiero reazionario. Tutto discende dalla convin- zione secondo la quale e impossibile che I’arcana divinita che governa i nostri destini possa uscire sconfitta dal confronto con i suoi suddditi.
Come reggono, entrambe queste idee, dopo un secolo e mezzo di accel- lerazione storica?
La prima annunciazione e stata verificata e consolidata in ogni minimo particolare. Ora che questi ultimi anni hanno definitivamente sanzionato la fine di una serie di tentativi e di varie e tumultuose speranze, possiamo incominciare a delineare un panorama complessivo. I1 “progresso” non solo si 6 mostrato inarrestabile, ma altresi destinato a movimento. All’in- izio di tale process0 Leopardi ironizzava sulla volonta (a suo avviso patetica) di dare un senso ideologico a1 movimento stesso (“le magni- fiche sorti e progressive” di cui egli si burla nella sua Ginestra). In un senso generale la sua previsione si e ampiamente avverata. A partire dalla Rivoluzione francese (che rimane tuttora il propellente dinamico del mondo moderno), il vero dilemma della storia contemporanea non e stato fra reazione e progresso (la quiete e il mot0 della mitologia leopar-

Ferrucci SYMPOSIUM 115
diana), secondo la retorica verbale di questi venti decenni, ma fra: (1) progresso ideologicamente legittimato, e (2) progresso che non ha bisogno di una filosofia della storia per affermare se stesso. Questa e stata la Vera antinomia del mondo moderno; e da tale scontro 6 uscita vincitrice la seconda alternativa, quella che non pone orizzonti filosofici a un movimento di espansione nel futuro.
Sempre piu appare chiaro che l’unica Vera, costante, inesorabile rivoluzione del mondo moderno e quella che fu intrapresa dalla borghesia settecentesca; una rivoluzione opaca, industriosa, silenziosa, devastante di efficacia e di penetrazione. Opporle ideali collettivi e allucinati e stato il tentativo dei totalitarianismi del nostro secolo: nello sforzo di sacraliz- zare il cammino stesso del progresso, incorporandolo a mitologie recuperate dal passato delle nazioni. La democrazia occidentale 6 anche volonta di abbandonare ogni fede tribale-il che e privilegio ma anche la croce di quell’arido vero che, secondo Leopardi, e destinato a impadro- nirsi delle civilta avanzate.
La sconfitta degli autoritarismi fideistici dell’ultimo secolo ha sigillato il trionfo dell’ateismo politico. A chi, come noi, non ha esitato a prendere posizione in favore di quest’ultimo, 6 consentito valutare la portata dell’evento. Certo non siamo stati sconfitti, ma altrettanto certa- mente non ci resta il conforto delle illusioni. La vittoria della democrazia di stampo anglosassone e stato anche il rifiuto della volonta mitologica collettiva, la quale andra confinata nell’orizzonte della creativita in- dividuale, visto che non c’e nulla di piu minaccioso di un fanciullino di massa. Scrivere e capire sono i soli modi di non subire l’aridita della sorte; lo sapeva anche Leopardi, tanto e vero che non smise mai di farlo.
E questo “progresso” davvero destinato a1 fallimento? Ricordiamo che Leopardi vedeva la Natura come un’aguzzina dei propri sudditi in- utilmente rivoltosi. Second0 la sua ipotesi, essa avrebbe finito col ven- dicarsi dell’inquieto animale che pretende di alterare le sue leggi. In realta, si e assistito a un rovesciamento di posizioni che avrebbe sorpreso lo stesso Leopardi. In un lasso di tempo relativamente breve, l’umanita ha preso decisamente il sopravvento in questa lotta, almeno nelle posta- zioni avanzate. La Natura e stata quasi completamente asservita-anzi sconfitta e addirittura umiliata. In questa nuova inimicizia, la quale e stata voluta dall’uomo e non dalla Natura, e possibile vedere un possibile fallimento della civilta “progressiva.” A meno che un colpo a sorpresa non ribalti nuovamente la situazione a favore della Natura, liberandola dal molesto e nocivo occupatore del suo territorio, la Natura stessa ap- pare ovunque in ripiego, una ben malconcia divinita. Su quale base an- dra formulata una previsione del futuro del progresso umano, visto che i termini di riferimento sono stati ribaltati? Sara annichilita la Natura, al

116 SYMPOSIUM Summer 1993
contrario di quanto pensava Leopardi? Oppure il trionfo umano si mostrera illusorio, e alla fine risorgera l’antico e impassibile dominio delle forze naturali, second0 quanto il nostro scrittore non si t stancato di affermare?
Se uno dei due esiti Sara inevitabile, allora il Reazionario avra avuto ragione nella sua piu radicata certezza: quella che afferma che I’uomo non pub governare ne il proprio destino ne quello del mondo, e che ogni mutamento intensifica la corsa verso la fine.
E un teorema di grande chiarezza; ma i suoi teorizzatori abitano all’ interno del teorema stesso e non vedono che nella loro posizione c’k un aspetto paradossale. Perch6 infatti condannare il progress0 in quanto esso affretta la morte-se poi quest’ultima e definita come l’unica via d’uscita dalla contraddizione vitale? Anche il pessimism0 biblico di Leopardi esprime oscuramente un desiderio di soprawivenza: quello che affiora nell’idea della ginestra abbarbicata alla lava-e il poeta che la guarda non sa spiegarsi la propria commozione. Da questo dilemma il pensiero negativo 6 destinato a non uscire.
Ma forse che il suo avversario ideologico, il D’Annunzio di Laus vitae ne 2 a sua volta esente? Una “lode della vita,” che termina con I’affer- mazione che “vivere non 6 necessario,” fa meditare sullo scambio di ruoli che si insegue per tutto il “re0 tempo” della modernita. Chi ha piu inseguito la morte, e chi ha piu servito la vita?
Rutgers University