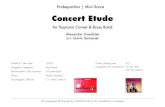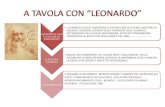LEONARDO - cealex.org Web/PFE_008_W/PFE_008_010_w... · Due furono le attività principali di...
Transcript of LEONARDO - cealex.org Web/PFE_008_W/PFE_008_010_w... · Due furono le attività principali di...
ISTITU'fO ITALIANO DI CULTURA
per la R. A. E. - sez. di Alessandria
L'A'l'ELIER D'ALESSANDRIA
(Gruppo degli artisti e degli scrittori)
LEONARDOlo .olen~la'to
Esposizione di gigantografie di disegrù scientifici di
LEONARDO da codici
e materiale didattico relativo a modelli
e disegni originali
14 - 3i dicembre iDsg
Sale dell'Atelier d'Alessandria
PRESENTAZIONE
Il secolo in cui viviamo, con la sua cultura e soprattutto con il suo progresso tecnologico, ha potuto totalmentevalutare la portata del pensiero scientifico di Leonardo daVinci e giudicare quanto le opere di questo genio abbianocontribuito a fissare le componenti della vita moderna.
Uomo del Rinascimento, cioè di una delle più grandiepoche della storia del libero pensiero umano, Leonardoconfermo' con i suoi studi e con le sue ricerche la validitàdel metodo sperimentale instaurato dal Rinascimento incontrapposizione al metodo filosofico del mondo classico edel Medioevo. Ma attingendo al suo profondo spirito d'artista, Leonardo arrivo' ancora più in là dei suoi contemporanei: rinnovando il mito di Archimede arrivo' a individuareleggi per dare alle soluzioni tecniche da lui inventate unfondamento di razionalità che sta alla base di tutta l'evoluzione tecnico scientifica dei nostri giorni.
In questa antlClpazione, soprattutto, consiste la grandezza del suo genio universale che in solitudine percorse,fuori dal tempo e dallo spazio, il lungo cammino della scienzaadditando luminosi punti d'arrivo.
Per celehrare il V centenario dell'inizio fattivo dellasua attività di scienziato e di inventore di macchine, assolutamente straordinarie per il suo tempo (inizio che coincidecon l'anno del suo arrivo a Milano), sono state allestite diverse mostre che documentano la ricchezza dell'attivitàscientifica di Leonardo.
L'esposizione, che l'Istituto Italiano di Cultura per laR. A. E. è lieto di presentare al pubblico di Alessandria, comprende 19 ingrandimenti fotografici di disegni leonardeschi evarie riproduzioni in offset di disegni e di modelli costruitisu disegni originali. L'insieme da un'idea, sia pure succinta,della vastità della speculazione scientifica dell'esimio artistae la singolare grandezza dei traguardi da lui raggiunti. Ilmateriale raccolto è attinto alla Mostra: "Leonardo ingegnere"
organizzata dal Museo delle Scienze" Leonardo da Vinci"di Milano con qualche apporto di altre che hanno avutoluogo nella stessa città durante l'anno in corso.
L'IstÌfuto Italiano di Cultura ringrazia sentitamente ilMuseo delle Scienze di Milano per la cordiale collaborazionee l'ing. Radames Lackany, presidente dell'Atelier di Alessandria, per aver ospitato tale esposizione nella sede dell' Atelier.
Antonietta DosiDirettrice dell IstitutoItaliano di Cultura perla R. A. E. - sez. di Alessandria
PREMEssA
LEONARDO DA VINCI
E LA SUA OPERA TECNICO-SCIENTIFICA
L'era tecnologica nella quale viviamo e la cultura che da essa
ne è derivata, ha consentito di inquadrare Leonardo nei suoiaspetti di scienziato e di tecnico accanto a Leonardo artista. E'
stato quindi possibile valutare sotto una nuova luce e filtrareattraverso il nostro spirito del XX secolo il suo pensiero e lesue opere che hanno fissato le componenti della vita moderna.
Egli visse durante una delle più grandi epoche della storia dell'umanità, in una società di uomini liberi tesi ad osservare e adindagare su verità imposte dalla dimostrazione e constatabilìdai sensi. Ed è tra questa società di uomini liberi che Leonardoesplicò il suo genio e ne riassunse l'alto pensiero.
Durante la sua vita si svolsero eventi memorabili come la scoperta dell'America che, aprendo l'era delle grandi esplorazioni,diede una nuova e completa dimensione del mondo, avvicinando
popoli nuovi alla civiltà occidentale, e accrescendo la conoscenza
e la cultura generale.
Possiamo ritenere che Leonardo venne a conoscenza delle imprese di esplorazione e della scoperta di nuovi mondi, anche se neisuoi scritti non compaiono specifiche descrizioni sull'argomento.
Indubbiamente ne fu influenzato, e i suoi studi sulla geografiaconfermano tale ipotesi. Soprattutto la concezione da lui già
intuita della sfericità della terra e la distribuzione dei continentisulla superficie del nostro pianeta, sono una testimonianza della
grande genialità intuitiva di Leonardo.
Leonardo fu, in primo luogo, un attento osservatore : ogni cosache la vita quotidiana gli poneva a contatto, era per lui motivo
di studio e di meditazione; trovava qualcosa di nuovo ove altrinon avevano ri levato nulla di importante da osservare e studiare.
Dalle prime timide osservazioni della natura e del mondo che
circondavano il prodigioso fanciullo, egli passò gradualmente dauna materia all'altra in una successione logica e ragionata a manoa mano che in lui si accrescevano l'esperienza e la conoscenza.
Dall'indagine dei fatti e delle cose passava alla precisa annotazione, alla elaborazione e quindi alla sperimentazione ed ideazione.
Annotava le idce e i pensieri che passavano nella sua mente con
l'intento di racccglierli, in successivi momenti, in opere piùorganiche, che la brevità della vita umana gli vietò.
Due furono le attività principali di Leonardo che in realtà ebbero la stessa matrice nel suo profondo spirito di artista.
La prima fu quella di inventore e di costruttore di macchinedove la sua fantasia poteva espandersi e spaziare. La secondafu quella di scienziato proteso nell'individuazione di leggi affinchè le soluzioni tecniche risultassero più razionali nelle varieparti e dimensioni.
Dall'intensa ricerca svolta nell'ideare nuove macchine, Leonardoebbe modo di dare libero corso alla sua innata inclinazione per
i congegni meccanici.
Ma fondamentali rimangono, di queste ricerche, l'introduzioneciel concetto di automazione e di produzione di serie.
Le sua macchine sono automatiche : ciò consente una ridUZlOuedella fatica umana e la ripetizione di oggetti uguali e perfettisenza l'imponderabile dell'errore manuale. Non solo, ma è possibile ottenerè manufatti più rapidamente e più abbondante
mente a buon mercato.
Con Leonardo la macchina entra realmente da protagonista nella storia della civiltà come fattore di progresso tecnologico:non più la macchina imitatrice del lavoro umano, ma la macchina
vera e propria.
Dal risultato di queste indagini tecniche e naturali Leonardointuì che la descrizione di un oggetto, di un fenomeno fisico, è
da considerarsi un elemento scientifico da valutare e analizzare
fino a quando la sua validità può essere da altri intesa in unsolo senso e da altri ripetibile.
TI binomio leonardesco "scienza e tecnica" si amalgama nell'n,rte in quel concetto primario di aggettivazione che è base per" fare di fantasia li effetti della natura", come lui stesso scrisse.'Quindi la ricerca del "vero" era per Leonardo non sola alla
base dell'arte ma anche del pensiero scientifico-tecnico. Per cuila scienza deve passare attraverso l'esperienza e le prove ripe
tute. La sperimentazione è misurazione, e questo pensiero è giàpresente in Leonardo· che afferma: nessuna umana investigarrione si può dimandare vera scienza se non passa per le matematiche dimostrazioni".
In un periodo in cui si avvertono trasformazioni profonde nellacultura tecnico-scientifica, Leonardo già ha additato, con profetica anticipazione, il significato del futuro mondo tecnologico
e scientifico. Ed è proprio in questa anticipazione la grandezzauniversale del genio leonardesco. Tutto ciò che egli inventò fufaticosamente riscoperto e rinventato da un'infinita schiera di
uomini. Egli aveva percorso da solo il suo lungo e faticosocammino, gigantesco e quasi solitario fanta$ma fuori dal tempoe dallo spazio.
Leonardo riassunse e l'lVlSSe, con la sua personalità, tutta l'evoluzione del pensiero tecnico-scientifico che è oggi alla base diogni nostra attività sociale, culturale ed artistica.
ORAZIO CURTI
1452 (15 aprile)
1466
1.482
NOTIZIE BIOGRAFICHE
Leonardo nasce in una casetta (ancora esistente)ad Anchiano, frazione del borgo di Vinci, a dodicichilometri da Empoli. E' figlio illegittimo di SerPietro di Antonio da Vinci e di una certa Caterina,andata in seguito sposa a un tale Antonio di Piero,detto "Achattabriga". Questa nascita illegittima
giustifica in parte il senso di amara e dolorosasolitudine che contrassegnerà la sua vita. Trascor·re la sua adolescenza al contatto della natura nell'agreste bellezza di Anchiano. Prestissimo rivela
la sua vocazione alla pittura. E' celebre l'episodionarrato dal Vasari in cui egli descrive come il fan·ciullo avesse dipinto su una rotella di legno "unmostruoso intreccio di serpi, lucertole, ramarri elocuste" che pare fosse straordinario.
Il padre decide di mandare Leonardo a Firenze adimparare la pittura nella bottega del Verrocchiodove incontra Lorenzo Di Credi, Pietro Perugino,Sandra Botticelli. In pochi anni diviene cosi' bravoda poter già affiancare il Verrocchio nella rifinituradelle tele. E' opera sua il famoso Angelo del "Bat·
tesimo di Cristo" del Verrocchio. La sua attivitàè però assai poco rimunerata, come si deduce daalcune frasi degli scritti di quel periodo. Vi si cela
una scontentezza che aggrava il senso di solitudinedi questo giovane geniale estraniato della famiglia.A ciò si aggiunga l'esodo da Firenze del Verrocchio,
del botticelli e del Perugino, che vanno a Romaa lavorare nella Cappella Sistina insieme a Michelangelo.
Leonardo si reca a Milano con una lettera di presentazione di Lorenzo de Medici, per Lodovico Sforza,
duca di Milano e con uno strumento musicale a
corde da lui esegu'to d. forma di testa di cavalloche Lorenzo gli ha consigliato di porgere in omag-
1483 (25 aprile)
1485
1489
1499 (24 luglio)
gio al duca. Comprendendo però che il signore di
Milanfl, impegnato in continue guerre, ha bisogno
soprattutto di un ingegnere, gli dichiara di saper
costruire edifici, ponti, macchine e gli elenca una
serie di armi che potrebbe realiz7are. Prendono
consistenza in questo lungo soggiorno milanese le
'più famose idee di Leonardo scienziato, macchine
da offesa e da difesa, studi sul volo meccanico esulla nautica, progetti di edilizia e di llrbanistica
per la ricostruzione di Milano, devastata dalla peste.
Leonardo sottoscrive il contratto per il dipinto della
"Vergine delle rocce" che terminerà nel 1484, e per
quello ancora più celebre dell' "Ultima Cena".
Inizia la grande opera del Cenacolo.
E' nominato da Lodovico Sforza "ingegnere e pit
tore ducale". Il duca gli commissi.ona ìl ritratto di
Cecilia Gallerani, che sarà in seguito chiamato
"Donna con ermellino". Gli viene pure ordinato
il monumento di Francesco Sforza che Leonardo
tuttavia non porterà a termine, malgrado i numerosi
studi eseguito.
L'esercito francese di Luigi XII invade il territorio
milanese e il duca fugge. Leonardo lascia allora lacittà e si dirige prima a Mantova, poi a VenezIa
dove gli viene affidata una missione militare col
legata con la minaccia incombente di un' invasione
turca dalla zona del Friuli. Del sua passaggio attra
verso le valli dell'Isonzo e del Viparco per idearvi
uno sbarramento in corrispondenza di Gradisca,
rimane uno schizzo. Poiché la Repubblica veneta
è lenta a prendere decisioni sul progetto da lui
presentato, egli riparte per Firenze. A Firenzeprepara i cartoni raffiguranti sant'Anna con la
Madonna, ma poi, immerso nei suoi studi, non
inizia il quadro.
1502 (18 agosto)
]503 (agosto)
1504
1506
1507
1508
1513
E' chiamato da Cesare Borgia, noto come il Duca
Valentino, in qualità di architetto e ingegnere mili·
tare del nuovo Stato di cui il Duca sta gettando
le basi. Presso di lui Leonardo compie diversi rilievi
planimetrici e studi di idraulica per la bonifica delle
paludi intorno a Piombino. Sovrintende anche l:l.i
lavori per la costruzione del portocanale di Cesena
tico.
Muore il papa Alessandro VI Borgia. Con la sua
morte incomincia la catastrofe del Valentino.
Leonardo ritorna a Firenze dove resterà fino al
1506. A quest'ultimo soggiorno fiorentino risalgono
il dipinto "La battaglia di Anghiari ", andato
perduto, e quello celeberrino della 'Gioconda ",
oggi al Louvre. Successivamente si dedica alla
speculazione scientifica e alla ricerca tecnica e
compie studi di idraulica, metereologia, botanica,anatomia; riprende le ricerche sul volo degli uccel
li e progetta macchine volanti.
Muore il Padre di Leonardo. Il dolore di tale per
dita si aggiunge all'amarezza della sua vita difficile.
Leonardo ritorna a Milano chiamato da Carlo
D'Amboise, Gran Maestro e Maresciallo di Francia, e
governatore del ducato milanese, il quale gli com
missiona un monumento equestre al maresciallo
Trivulzio.
Si reca a FIrenze per regolare le pratiche dell'
eredità paterna.
E' di nuovo a Milano a condurre a termine i suoinumerosi impegni. In tale occasione i Francesi glI
restituiscono la vigna in precedenza confiscata.
Vive a Milano alcuni anni in relativa tranquillità
e in questo clima sereno dipinge la "Leda ",
" Bacco" e "San Giovannino".
Rivolgimenti militari che vedono la cacciata dei
Francesi, riportano a capo del ducato milanese Mas·
similiano, figlio di Lodovico il Moro. Insofferente
1516
151) (2 maggio)
dell'atmosfera che si è creata, Leonardo parte per
Roma, forse su invito di Giuliano de Medici, fratello
del Cardinale Giovanni, che sarà dopo poco tempo
eletto papa con il nome di Leone X. In questi anni
Leonardo si dedica quasi totalmente allo studio
del corpo umano di cui rimangono innumerevoli
disegni assai precisi. Nell'intervallo, e quasi per
distensione, dipinge la "Madonna col Bambino".
Ispeziona le fortezze pontificie e ie Paludi Pontine.
Per risolvere l'annoso problema del loro prosciuga
mento, realizza un progetto assai valido. Nel frat
tempo, in Francia, sale al trono il re Francesco I di
Valois, il quale gli invia un caloroso mvito perché
si rechi presso la sua corte.
Leonardo parte da Roma; si ferma qualche tempo
a Milano, la città mai da lui dimenticata, poi pro
segue per la Francia. Francesco I mette a sua
disposizione una bella dimora a Saint-Cloux. presso
la residenza reale di Amboise. La nuova casa, im
mersa nel verde, non lontano dalla T,oira, piace
molto a Leonardo, anche perché gli ricorda quella
dell'infanzia, a VLrlci. Qui vive, completamente de
dito alle sue ricerche. Rivede e completa il "Trat
tato sulla pittura" e quello della "Voce"; progetta
edi1ìci e città e compone un'infinità di allegorie
misteriose. Una paraliei gli rende inservibile la
mano destra. Ciò nonostante egli trova la forza di
disegnare il suo più famoso autoritratto. Prima
di morire redige il testamento lasciando al suo di
scepolo che lo aveva seguito in Francia, Francesco
Melzi, tutti i suoi libri; al discepolo e amico Salai
la vigna di Milano; ai parenti 400 scudi d'oro e
lasciti ai servi e ai poveri.
Leonardo si spegne serenamente coi conforti reli
giosi e in piena armonia spirituale, dimostrandosi
grande anche in questo ultimo momento della sua
lunga e geniale vita di uomo.
ELENCO DEGU INGRANDIMENTI FOTOGRAFICI E DELLE
RIPRODUZIONI IN OFFSET DA CATALOGO DI MODELLI E DI
DISEGNI ORIGINALI
(Classificazione in base alle discipline)
1) BOTANICA
2) GEOLOGL4.
a) Riproduzione da catalogo del modello costruito su disegno originale:
l i'il1otasgi
(Mns. B 33 a, Paris, Institut de France).
Leonardo da Vinci esegui' osservazioni molto
corrette sulla disposizione delle foglie sui fusti :
cioè sulla fillotassi. A questo scopo studio' la
disposizione di diverse piante, quali l'edera,
l'olmo etc. Della fillotassi diede anche una cor
retta interpretazione sostenendo che la disposizione delle foglie era dovuta al fatto di ricevere
la luce e non l'acqna, come allora si credeva.
b) Ingrandimento fotografico:
Lilium candidum
( f. di Windsor 12418, Windsor, Royal Library )
Fin dall'inizio della sua carriera di pittore,Leonardo da Vinci prese a disegnare e a stu
diare le piante e i fiori. Questi ultimi gli sareb
bero tornati utili per la composizione dei suoiquadri.
a) Riproduzione in ofjset da catalogo del modello costruito su disegno originale:
Trivella a doppio movimento
(Mns. B f a 652, Paris, Institut de France).
La barra superiore fa girare la trivella facen
dola affondare nel terreno. Il movimento della
barra inferiore provoca il ritorno della trivella,senza rotazione, cosi' che quest'ultima portacon sé la terra smossa e raccolta sulle lame.
3) GEOGRAFIA
4) ASTRONOMIA
b) Ingrandimento fotografico:Rocce stratificate con strati piegati ed erosi
( Cod. Windsor 12349, Winclsor, Royal Library )
Leonardo condusse particolari studi sui feno
meni di erosione della superficie terrestre ad
opera degli agenti atmosferici ed in particolare
delle acque. Descrisse la modalità di trasporto
dei materiali erosi e la loro deposizione, intuen·
do il meccanismo di formazione degli strati
rocciosi sulla superficie della terra.
c) RiprDduzione di disegno originale:Vene d'acqua, nel corpo della terra
(Lei 3 v. (Ram. 3 b.) Los Angeles)
Ingrandimento fotografico:
Determinazione del raggio (diametro) ter·
restre
( Cod. Atlantico, f..269 v. a. )
Per misurare in maniera nuova la grandezza
della terra Leonardo propose uno strumento
semplice, costituito da un traguardo verticale
alto quasi cinque metri. Su questo si segna la
posizione assunta da un filo di piombo rispet·
to a un quadrante quando si guarda 'l~w.la
stella polare da due pcsizioni abbast~nza lon·tane : ora il raggio terrestre sta alla hmgh?
del filo a piombo come la distanza fra i .....e
luoghi di osservazione sta alla distanza intercor·
rente tra le due posizioni dell'estremità del filo.
Ingrandimento fotografico:
Studi sulla luna e sui movimenti.
( sinistra: Cod. Atlantico f. 208 v. b )
( destra : Cod. Atlantico f. 104 r)
Leonardo furni' per primo la corretta spiega
zione del lustro della luna, cioè della luce cine·
rea riflessa dalla terra sul disco lunare, affer-
5) CARTOGRAFIA
6) GEOMETRIA
mando anzitutto che, vista dalla luna, la nostra
terra farebbe lo stesso effetto che fa a noi la
luna e apparirebbe altrettanto luminosa.
a) Riproduzione in offset da catalogo del modello costruito su disegno originale:
Odometro.
(Cod. Atlantico f. 1. r. a )
Apparecchio per misurare la distanza sul ter
reno. E' costituito da un meccanismo moltosemplice, simile agli attuali: un contagiri ad
ingranaggio registra ogni giro compiuto dalla
ruota sul terreno.
b) Ingrandimento fotografico:
Planimetria di Imola.
( f. di Windsor 12248, Windsor, Royal Library )
Celebre pianta eseguita da Leonardo nei primianni del Cinquecento, quando era al servizlO
del duca Cesare Borgia detto il Valentino.
Primo esempio di pianta completa rilevata con
l'aiuto della bussola.
Ingrandimento fotografico:Studi suDe lunule.
( cod. Atl8.l1tico f. 167 r. a. b )
Leonardo si dedico' a Milano a ricerche di
geometria manifestando particolare originalità
anche nella trattazione sistematica dei teoremi
sulle lunule e sulle loro quadrature. Egli generalizzo' il teorema di Ippocrate considerando ilcaso di triangoli qualsiasi, anzichè di triangoli
rettangoli isosceli.
a) Ingrandimento fotografico:~Iacchina per la lavorazione degli specchi piani.(cod. Atlantico f. 396 v. f )
La stessa manovella imprime il movimento al·ternativo alla superficie ottica da lavorare t'
nel medesimo tempo il movimento rotatorioalla mola.
b) Riproduzioni di disegni originali:
Sis-tema ottico dell'occhio o i meccanismi della
visione
( Cod. Ambrosiano, 337 a, Milano, Bibl. Ambra·.lana)
Dimostrazione dell'effetto "contorno confuso"(Mns. D 10 V., Paris, Institut de France)
Esperimento di teoria delle ombre
(Cod. Ambrosiano, 227 v. a, Milano, Bibl.Ambrosiana )
Altro esperimento di teoria delle ombre contre sorgenti di luce
(Mus. C 22 r, Paris, Institut de France)
Strumento per lo studio della composizione e
scomposizione delle luci colorate
(Cod. Ambrosiano, 9 v. b, Milano, Bibl. Ambrosiana)
Esperimento sulla teoria dei colori: sovra·pposizioni di luci colorate proiettate in una sfera
(Cod. Ambrosiano, 181 r. a, Milano, Bibl.Ambrosiana )
Schema critico della figura precedente(Disegno di Aurelio Carminati)
Esperimento di teoria delle ombre con duesorgenti di luce di colori diversi(Cod. Ambrosiano, 45 v. a, Milano, Bibl. Am·brosiana)
Esperimento di teoria delle ombre con sovrapposizione di colori
(Cod. Ambrosiano, 241 f. d, Milano, Bibl.Ambrosiana )
8) MATEMATICA
S) CHIMICA
lO) IDRAllLlCA
Disegno di camera ottica con lenti(Mns. F. 28, v. Paris, Institut de France)
Studio di sovrapposizioni di colori(Cod. Ambrosiano 241 v. c, Milano, Bibl.Ambrosiana)
Ingrandimento fotografico:
Compasso parabolico.
( sinistra: cod. Atlantico f. 394 r. a )
( destra: cod. Forster f. 4 r. )
Il compasso parabolico, disegnato nel codice
Atlantico senza aggiunta di commenti esplicativi, doveva servire a tracciare con motocontinuo una parabola.
lngrandimento fotografico:Alambicco di Leonardo o distillatore a refri·gerazione continua.(cod. Atlantico f. 357 r. )
Per ottenere una più costante refrigerazione,
Leonardo propose il dispositivo della doppia
parete, formando una camicia continua diriscaldamento come nel moderno condensatoredi Liebig.
a) Ingrandimento fotografico:Porte a paratoia per conche di canali navigabili.(cod. Atlantico f. 240, r. c)Concepite per la navigazione dei canali di
Milano, queste porte a paratoia (ovvero aportelli mobiii di legno) permettevano di regolare il fiusso delle acque nei canali.
b) Riproduzione in offset da catalogo del modello costruito su disegno originale:
Conca di canale navigabile.(Cod. Atlantico f. 240 r. c )
Progetto di canali sopraelevati per attraversare
un fiume. Fa parte degli studi condotti per ilcanale da Firenze al mare.
Riproduzioni di disegni originali:
Acqua Hl recipienti riscaldati
{ Lei 3 v. (Ham. 3 b) 1.08 Angeles )
Turbina idraulica
(Cod. Ambrosiano 2 r. a, Milano, Bibl Am
brosiana)
Viti di Archimede o pompe per portare l'acqua
ad altezze più elevate.
(Cod. Ambrosiano, 386 r. b, Milano, Bibl.Ambrosiana)
Apparecchio di Leonardo, per misurare la
spinta esercitata dall'acqua contro una parete
verticale.
(Madrid, I, 149 V., Madrid, Bibl. Nacional )
Collegamento di due condotte, per mettere a
contatto due correnti d'acqua o di aria.( Madrid I, 149 v., Madrid, Bibl. Nacional)
Corpi galleggianti e sommersi
a) Madrid I, 145 v., Madrid, Bibl. Nacional)b) Madrid I, 112 r., Madrid, Bibl. Nacional)
Dispositivo manometrico di Leonardo, dove ilpeso agisce come pistone galleggiante
(Madrid, I, 150 v., Madrid, Bibl. Nacional)
Un soffietto caricato con un peso, per produrre
pressione nell'aria e nell'acqua
(Madrid, I, 114 V., Madrid, Bibl. Nacional)
Appareccho per la misurazione di spinte idrostatiche
(Madrid, I, 135 v., Madrid, Bibl. Nacional)
Altro sistema di misurazione della spintaIdrostatica
(Madrid, I, 149 V' l Madrid, Bibl. Nacional)
lI) NAUTICA
Esperimento 8ulia vena deferente effettullto da
Leonardo
(Cod. Ambrosiano, 81 r. a, Miiano, Bibl.Ambrosiana)
Deposito pieno d'acqua provvisto di sfioro su
periore e di tre Qrifizi o differen i:i livelli con
relativi zampilli o cadute d'acqua
(Madrid, I, 134 V., Madrid, BibI. Nacional)
'1) Ingrandimento fotografico:
Motrice nava!e a ruote.
(cod. Atlant.ico, f. 344 v. b )
Il complesso dei ruotismi riceveva il movimento
da una trasmissione a cinghia che attraversava
il ponte di coperta per scendere al disotto di
questo. Si puo' immaginare che all'interno di
una stiva inferior.e si trovi un sistema di manovelle ad energia muscolare umana.
b) Riproduzione in offset da catalogo del modello costruito su disegno originale:
Galleggiante a fondo apribile.
(cod. B - F. 32 v. )
Il galleggiante fu immaginato da Leonardo
come mezzo di ci.~'costanza per l'attraversamento
senza ponte di un ostacolo d'acqua. Egli pre
vedeva una rapida. costruzione in vimini intrec
ciati con rivestimento di cuoio per la tenuta
stagna del galleggiante.
L'elemento più caratteristico era costituito daun fondo apribile per caduta del materialetrasportato, simiL a quello che oggi viene
realizzato nelle bettoline di raccolta dei mate
riali scavati dalle draghe.
c) Riproduzione in offset da catalogo del modello costruito su disegno originale:Circumfolgore.
12) VOLO
COOtplesso formato da canne multiple applicatead una piattaforma girevole. Consentiva una
maggiore celerità di tiri ( da applicare su scafo) .
d) Riproduzione in o;fjset da catalogo del modello costruito su disegno originale:Scafo doppio.(cod. B f. 11 r. )
Non è chiaro se questo progetto riguardasseuna doppia protezione per navi militari oppurela struttura per contenere le cas~e laterali diuna specie di sommergibile. Infatti Leonardonel codice Atlantico lascio' scritti riguardantinavi sommergibili, anche se dichiaro' che nonavrebbe divulgato notizie su questi progettiche avrebbero costituito armi terribili.
a) Riproduzione in offset da catalogo del modello costruito su disegno originale:
rtlacchilla volante con propulsione a molle.
( cod. Atlantico f. 314 r. b)
Con questa macchina Leonardo pensava di poter sostituire l'energia muscolare umana cheegli aveva intuito insufficiente per muovere lemacchine volanti.
b) Ingrandimento fotografico:
Navicella VOlll.&1te con ali battenti e timone.(cod. Athmtico f. 313 v. a e r. a )
E' in scala più grande l'idea della macchinavolante ad ali battenti, caratterizzata da grandi
ali a pipistrello. Leonardo aveva pensato di
muovere le stesse con un sistema misto a levae ruotismi.
c) Riproduzione in offset da catalogo del modello costruito su disegno originale:
Paracadute.(cod. Atlantico f. 381 v. a )
"Se un uomo ha un padiglione di pannolino
13) ARMI
intasato, e sia 12 braccia ed alto 12, potrà get
tarsi d'ogni grande altezza senza danno di sè".Così scriveva Leonardo del suo paracadute, la
cui piramide doveva essere alta 7 metri.
d) Riproduzioni di disegni originali:
Macchina volante
(Mus. B 74 v., Paris, Institut de France)
Collaudatore di ali
(Mus. D 88 v., Paris, Institut de France)
Paracadute
(Cad. Ambrosiano 381 v. a, Milano, Bibl.
Ambrosiana)
Elicottero
(Mns. B 83 v. Paris, Institute de France)
a) Riproduzione in ofJset da catalogo del modello costruito su disegno originale:
Organo a tre canne.
(cod. Atlantico f. 340 r. b )
Questo pezzo di artiglieria leggera consente lo
sparo contemporaneo di tre proiettili.
E' un esempio di artiglieria multipla studiata
da Leonardo per aumentare il volume del fuoco.
h) Ingrandimento fotografico:Proiettili ogivali.
(cod. Atlantico f. 54 r. )
I proiettili di artiglieria, simili ai proiettili mo
derni, vennero studiati da Leonardo per poter
essere impiegati con un miglior rendimento.
c) Riproduzione in ofJset da catalogo del modello costruito su disegno originale:
Catapulta a molle multiple.
(cod. Atlantico f. 54 v. b )
Leonardo progetto' questa catapulta per otte-
14) MAOOH. NL
nere, mediante originali giochi di molle, la mas
sima potenza in modeste dimensioni della mac
china.
,./) Riproduzione in offset da catalogo del modello costruito su disegno originale:
Artiglieria con elevazione regolabile a piolo.
Sì tratta di una "bocca di ferro" in bronzo ad
avancarica montato su affusto a ruote. Gli
spestamenti lungo il sèttore circolare orizzontale
permettono la manovra di puntamento in dire
zione a quelli che si verificano lungo il settore.
e) Riproduzione di disegni originali:
Sbarramento di mortai
(Cod. Windsor 12275, Windsor, Royal Library)
Apparato per misurare l'ascesa verticale di un
proiettile nello spazio
( Madrid I, 59 l'., Madrid, Bibl. Nacional)
Pioli che permettono il puntamento in elevazione.
a) Riproduzione in onset da catalogo del modello costruito su disegno originale:
Macchina per l'hmalzamento delle colonne.
( cod. Atlantico f. 28 v. a )
Si tratta. di un perfezionamento degli apparecchi
già disegnati da Francesco di Giorgio Martini
e da altri architetti precedenti. Questa specie
di argano progettato da Leonardo doveva essere
mobile per il trasporto e l'erezione a mano delle
colonne e degli obelischi.
b) Riproduzione in offset da catalogo del modello costruito su disegno originale:
Argano per soHevamento di artigliere.
(cod. Atlantico f. 27 v. a )
E' un complesso a forma di capra adatto per
il sollevamento di artiglierie pesanti. Il gruppo
pòtenza Ù %stituito dall'accoppiamento di unavite perp--~ua e di una ruota elicoidale chefunge da madre vite che ingralla col vitone disollevamento.
c) Ingrandimento fotografico:
Carro automotore.
(cod. Atlantico f. 296 v. a )
Questo carro rappresentii il coronamento delpensiero di Leonardo nel campo della locomozione terrestre. Il veicolo doveva essere mosso
mediante l'impiego di un sistema di molle, ches<'-aricavano manualmente. La trasmissione eraindipendente ~'m ogni ruota ed era assicuratada un congegno a ruotismi simile al modernodifferenziale.
d) Riproduzione in ofJset da catalogo del modello costruito su disegno originale:
Doppio elevatore ~il'evole.
( cod. B. f. 49 v. Paris. Institut de France)
E' una doppia gru pE:r l'asportazione dei materiali di scava nei canali. L'apparecchio puòvenire trainato per brevi tratti su rulli, mediante un argano orizzontale a vite e madrevite.
e) Ripl'oduzione in olfset da catalogo del modelio costruito su disegno originale:
Trasmissione per carri.( cod. Atlantico f. 366 r. c - cod. Ash. f. 9 r. )
La trasmissione del moto ad una sola ruota.attraverso il rocchetto a lanterna, lascia liberal'altra ruota di girare con velocità diversaa seconda della curvatura della strada.
f) Rivroduzione di disegni originali:
Analisi di nna bilancia a braccio inclinabile(lILfns. E 5H l'., Paris, Institut de France)
15) ARCHtTE'ITIJRA. (1) Riproduzione in offset da catalogo del 11U}-
dello costruito su disegno originale:
Ponte di Galata.(cod. L. f. 66 v. )
Progetto di un ponte ad una sola arcata per
collegare Costantinopoli con Pera, in particolare
col quartiere detto l. Galata ". "Largo 40braccia, alto dalì'acqua braccia 70, lungo 600,
cioè 400 sopra del mare e 200 in terra" - come
scrive Leonarào - il ponte avrebbe dovuto fare
" di sè spalle a sè medesimo" per superare un
tratto di mare di oltre duecento metri.
b) Ingrandimento fotografico:Ponre girevole a lll'ofilo parabolico.
( cod. Atlantico f. 312 r. a )
Progetto di ponte campale di grande portata
e di rapido allestimento, costruito con travi
armate reticolari e profilo superiore parabolico.
Gli argani consentono di far girare il ponte
sopra un apposito perno.
CI Ingrandimento fotografico:
Chiesa a pianta centrale (sormontata da otto
cnpole secondarie).
(cod. B. f. 17 v. )
E' UI10 dei progetti più interessanti di Leonardo
relativi a chiese a pianta centrale.
d) Riproduzione di disegni originali:
Decorazione scenografica: schizzi allegorici sul
tema dd Giglio (Iris FIorentina)
(Cod. Windsor 12700 l', Windsor, Royal Library)
l6) ARCHITETfURA
MILITARE
a) Riproduzione in offset da catalogo del mo
dello costruito su disegno originale:
Castello di Milano.
( Cod. B. f. 69170)
Si tratta dell'organizzazione della bombardiern
in un torrione tradizionale del castello cl.; llllll.
no, per il miglior fiancheggiamento delle cortint
adiacenti.
b) Ingrandimento fotografico:
Progetto di fortezza.(Cod. Atlantico f. 4 v. b )
Il progetto in questione è stato concepito da
Leonardo per un terreno montano.
c) Riproduzione di disegni originali:
Studi per fortezza
Sezione di un forte Con mastio ~entrale cilin
drico e altri studi
(Mns. B 52 l'., Paris, Institut de France )
Studi per un torrione angolare, sezione dicortina a scala doppia elicoidale
(Mns. L. 43 V., Paris, Institut de France)Studi per una torre e per fossato di rocca inmontagna e disegni vari.
(Mns. B 60 l'., Paris, Institut de France)
Fronte d'una fortezza con rivellino antipasto
di forma triangolare ed altri studi.(Mns. B 24 v., Paris, Institut de France)
Disegni di fortezze romboidali e studi vari inpianta e alzato.
(Cod. Ambrosiano, 763 V., Milano Bibl.Ambrosiana) .
Bastione di fieno e paglia e bastione "dove li
colpi mudano", con altri studi.
(Cod. Ash. II, 4 v., Paris, Institut de France)
Studio per spalto fortificato.
(riprodotto specularmente, Milano BibI.
Trivulziana )
Studi di '« pallocta" e grafici relativi all' inci
denza dei proietti sulle murature.(Mns. L. 43 v., Paris, Institut de France)
Studi di sproni smussati su scarpa fortementeinclinata.
(Mns. L. 50 V., Paris, Institut de France)
Studi di c<lperture convesse e carenate.(Cod. Ambrosiano, 120 r., Milano, BibI. Am
brosiana)
Cintura difensiva ad andamento spezzato epuntoni smussati e carenati su scarpa.
(Mus. L. 39 V., Paris, Institut de France)
Disegni sulla forma delle feritoie tra sproni e
studi vari.(Cod. Ambrosiano, 982 r., Milano, BibI. Am
brosiana)
Studi sulla forma delle feritoie con indicazionidel tiro fra note e disegni vari d'architettura.
(Cod. Ambrosiano, 121 r., :Milano, BibI. Am
brosiana)
Studi vari per sprcni appuntiti.
( Cod. Magliabechiano II, I, 141, 238 r., Firenze,Bib!. Magliabechiana)
Studio per cortina con coperture convesse.
(Cod. Magliabechiano, II, I, 141, 217 r., Firen
ze, Bib!. Magliabechiana)
Sezione di cortilla difensiva con coperturaconvessa prospiciente un fossato.
(Madrid, TI, 6 v., Madrid, BibI. Nacional)
Studi per fortezze a pianta circolare con
mastio centrale e con altri disegni di fortezze.
(Cod. Ambrosiano, 133 l'., Milano, BibI. Am
brosiana)
Utilizzo dei principi leonardeschi :
Giovanni Antonio DOSIO: pianta di fortezzacentralizzata con bastioni sporgenti e mastiocircolare interno (f. 3877 A. l'., Firenze, Bibi.
Magliabechiana )
17) ARTE MUSICALE
18) ANATOML\
Giovanni Antonio DOSIÒ: spacccato verticale
di fortezza ·di 'Hnpianto centralizzato con mastio
centrale in cui si evidenziano i corpi di fabbrica
digradanti in altezza.
(f. 3877 A v., F.'irenze, BibI. Magliabechiana)
forre clinidrica con rivellini .'tUa base fra note
varie e dieegno d'architettura militare.
(Madrid, II, 93 r., Madrid, BibI. Nacional)
Anhmio DA SANGALLO, il Giovane: disegno
per un torrione poligonale con rivellini appuntiti
alla base.
(f. 813 A. V., Firenze, Bibi. Magliabechiana).
Ingrandimento fotografico.'
Tamburo meccanico.
( Cod. Atlantico f. 335 r. c )
Questo tambUTo aveva le bacchette mosse siste
maticamente da un sistema di ingranaggi colle·
gati alle ruote motrici e comandate da tamouri
che porta,vano dei nottolini. La strumento do
veva essere probabilmente utilizzato in occasione
di cerimonie o parate.
a) Riproduzione in ofJset da catalogo del modello costruito su disegno originale.'
Cranio.Muscoli del braccio e del collo.
Muscoli del tronco e delle gambe.
Sistema venoso e arterioso.
b) Ingrandimento fotografico:
Studi sull'apparato cardio-ch'colatorio.
( Anatomia, f. B F 32 v. )
Negli studi dell'apparato cardio-circolatorio,
Leonardo segue i concetti di Galeno e, come lui
crede, che i due ventricoli comunichino fra di
toro attraverso il setto. Come si vede dal dise·gno, egli interpreta Però con esattezza la struttura muscolare del cuore cui dedica, come dei
resto anche all'intero sistema vascolare, nume·
rosi disegni.
c) Riproduzione di disegni originali:
Vedute prospettiche degli occhi e dei nerviottici.
(Cod. Windsor 12603, V., Wlridsor, Royal
Library )
La posiziooe del senso comune all'intern<; delcranio(Cod. WindsC'l' 19057, l'., Windsor, RoyalLtbrary )
I ventricoli cel'ebrali dopo iniezioni di cera(Cod. Windsor 19127 l'., Windsor, Royal
Library )
Propagazione circolare deHe onde di percussione
(Mns. A. 61 l'., Paris, Institut de France)
Studi del movimento dell'uomo che sale uno
lcalino
(Cod. Windsor 19038 V" Windsor, RoyalLibrary )
Misurazione della potenza dei movimetni d~l
corpo(Mns. H 43 v., Paris Institut de France)
Scoperta dell'azione del muscolo bicipite sulgomito
(Cod. Windsor 199 V' o Windsor, Royal
Library )
Muscoli del tronco dissezionati dalla superficiE:
(Cod. Windsor 19014 V., Windsor, RoyalLibrary )
I muscoli della gamlYd rappresentati da fili di
rame
(Cod. Windsor 12169 l'., Wìndsol', ll.oyal
Library )
Andamento dei vortici nell'aorta
(Cod. Windsor 19117 V., Windsol', Royal
Library )
Modelli del bulbo dell'aorta e modalità di chiusI.>
ra della valvola
(Coà. Wind90r 19031 l'., Windsor, Royal
Libral'Y)
Schema dell'intestino con i reni e l'ingresso
dell'urina nella vescica
(Cod. Windsor 19062 l'., Windsor, Royal
Library )
Cuore: scoperta, degli atri o "ventriculi su
periori ".
(Cod. Windsor 19062 l'., Windsor, Royal
Library )
n feto all'ill~rno dell'utero.
(Cod. Windsol' 19102 r., Windsor, Royal
Library )
Complesso li.i1gua-farillge.trachea-tiroide-esofa~(I
e studio dei muscoli della gamba
(A 3 r., Windsor, Royal Library )
Studio sull'ingrossamento della tiroide
(Mns. F 274 fui. 23, Milano, Bibl. Ambrosiana)
Dettaglio dell'albero bronchiale
( Q a II 1. l'., Windsor, Royal Library )
~,~~. or( Jl:!..v ~ , .J"-'~~ , ,'\" V .J.J-'.)-~~ .:l§.)
~JJ~' J ~4.t~n 4iS:~
Jl:!-,.J~ , .J.J-'~", ~ ,'\" V .J.J-'~" .:l§.)
fi~' JllJ ~JJ~' J:'~I 4J-o [.i".i( Jl:!~.J ~ , .J.J-'~-' ' ' '\. i' .J~"""'~", .:l.§. )
~)'JJ:~~J
( Jl:!~.J ~ , .J.J-'~" , ,'\. "\ ~ .J"_..J~' .:l§.)
~~1 ~, ù1~' : ~,
( Jl:!~.) ~ , .J..Y-'~" ; ''\ •• ~ J,.......~" .:l§.)
~)'~b
Jl:!~.) ~ l , ,'\,. ~ .J..r-'~)
.wl,~~, .u.A1, _..,;,;-:t1 ~A"'" ~ ..~J J~ J~ ._~
( Jl:".) ~~ ~ .)r-'~~ )
,)~' ~J~ 'i.-'~
Mns. F. 274 nif. 23 ~l~j".;~-4l ~ , ,,;~
~'".s' ~, ~ ~~Q a 11 1. r. I Jl:~.) ~ , .).J-'~" )
~,
~)'Jt'~'~.~, ~: ...,,~u. J '-~
~'~'J OJ;i'J'Jl . ""II .(':11 (.......).ryyo- ~
~,.»' o;jJl'J ~, ~ ~';J
F. B F 32 v. - e::ruJ.),)~~ ~"...l.ll o,)J.l..lIJ yWl J47 4....-..1,).) ,y
, ~.J.-:u " ,L Il .,.l1.:Uu .) ~ ,I .\.S 1.1-. ~ I,,) .J,)Y.;'I,,) J
ù:!fi:J1 .)~J ~ r-')l J l.S~ l.oS -A-l:Jl 0~
.~~l
4..J"••:;YI uL.. )" "" (~)• ,J-J v" I,)"'"' ,l •...~I' ., "',, ...~" .l:.là.ou~ ~ rJ Ur.:- ,J-
( J..:!J,)~ , ,),J-J~J ' \ n . '" ,)j.....~J .)~ )
~n
( J..:!J,)~ , ,)~J ' \ '\ \ W ,),J-J~J .)~ )
Q~~ ~;'J f>";JJ ~
Mns. A. 61 r. ~,)~ - L..;,;-i 4'4
~, 4P~~j1' J-i;f' ~~ l.Jlo Q\.,w,;,)
( J..:!J,)~ , ,),J-J~J ' \ '\ • '"A ,),J-J~J .)~ )
~'~~o,....a
Mns. H 43 v. ..,.........)~ _ Lu...... ~
tp1' ~ J.QaJ' ~ ~,( ~J,) ~ , ,)".....~J ' \ '\ li. ,)J-'~J .)Y. )
t~'~
( J.:!J,)~ , ,)".....~J ' \ '\. \ t ,)J-'~J .)~ )
lS~l uI~ <Y- uL.\j~
~i"J ~.l:>. .. ~1 d........l.)~
- ~~jJhj ~:;~ - yJl:..Cod. Ambroziano 120 r.
t~~ r\~ <Y- ul~ .. l.)..:.
Mns. L. 39 v. -..r':).~ - l-.U.;-i ~uL.\..:. . .......;,,~ iJ'-' .,L.....:.:i, JL;'; \. uL.. ..........) J ""'- '" v . U""'" ..01..1.
• ~';"1
- ~~jJ.,,~l ~ - y:4.Cod. Ambroziano 982 r.
<Y- lS~l uL..r-'.)J 0~ i".~""';; uh .::..L...... l.)..:.
• 4.:';"-""J I o).-o..J I
Cod. Ambroziano 121 r. ~l~jJ';7-01 ~ _ y~
~.l.o ~wo(~ <Y- lS~1 -::..L.I..)..:.
Cod. Magliabechiano L;l:S:~l~JL.. 4..;~.. _ l...,';.)~
~\J <~ .,;...... <Y- d........l.)~
L;l&UL..~ _ l...,,; -I,. ... .)~
Cod. Magliabechiano II. l,Hl, 217 r.
lSi" <~ ~1.,J\ ji-JI r..:.iMadrid, II, 6 V., Madrid 4.~"J1 4..;:&S:ll , ~.).l.o
0."..d lS~1 -::..L..r-'.)J 0~ <y- 4.......1..),)
- L,;l:jJr.i ~.s... - y~Cod. Ambrosiano 133 r.
: J..:..)L;~ ~L.l r1.b.:i......1
lS:f.j4~ 1"1.:01 Y--'J') ~."c.b1 ~~~(F. 3877 A. r., Firenza _ L......,,;.)~
lS:f.j4 ..:;..d ~1.) ~ : Y--'J..l j~~l ~~~
• O§...)-O ~l~(F. 3877 A V., Firenze _ L..."';..)~
LS'"'J4l\ r-')\ .)..;1 o.)~W~ ~1..sLl (1~1
lS.;LaJ1
~Yl ~~\ , ~).l.o , '\ i , " ~.).l.o
o~ ..,.u\~ li (~ ~.) : ~4-~L. b ..s~yl
( W.)"li - A' i .w.) O..l>.W~
jl~jiy ~
~~~~F 335 r. c. _ ( ~)l:;1 ..:.§ )
JI~ji~ ~ (.:;-)
o~l~~~~~~
B. F. 17 v. .::.~
V"'w! J.1)..,;~ 41 ~}."":-'ll ~1 ~ (JA YbJ
• ~lAJ~
~Yl ":"4.".....)1 ~ jo.; (.::.)( L.....i..:w .1, ... \ ) ~ ..
• ..Jy--' ~.J. ~.J
J~J.J ~~ , 'rv . .JJ-'~J .1~
1"lA1\ (.i.".J~ -.r>wl (~~1 ~ ~J''1~ J~ (I)
• ~1 r-'.J uh~.riA
Cod. B. F. 69170
..i~ .. " j...L.;.;J\ .~ .. t:·:. 1~''11 ;;.Lu...J . ~ 1.>. V r---: ~ I..::.J
. ~;rJ\ ~\~.1 .i. ~..Jl ·<·JI (y)L>.r".; ~
( ~l,bll ) 0~1 t.J~~
Cod. Atlantico F. 4 v. b. ~)l:;1
~) ~ J.1}";~ ;U..>"'~ ~ ~:.; .J"s.i1 1 tJ~1 ,:;I.~
~'11 ":"4.".....)1 ~ j::..; (.:;-)
0~1 0J- c.Jt....al;~
Mns. B. 52 r. ~.J~ _ l......;~ ~
[J.1r ~""""J ;;":,,I;~ ~) ,y ..::.oL.....l.J.1
Mns. B. 69 r. \.J"""'...J~ - L......i~ ~
~ J).: .J;......JI p" [~ (..'"" ;;" .....1.J.1
Mns. B. 60 l'. \.J"""'...J~ - L......i~ ~
~~.:;-IJ
Mns. B. 24 V. ~.J~ - L......i~ ~
~~ ùL.....I.J.1J:i..:~ t..r.1~ ":,,4.,,......,J
Cod. 763 r. (l.;~j"r.l~ .. ' y~ )~?1 ..:..L......J.1J ' ~l ~ ~
Cod. Ash. 11, 4 V. ~.J~ - L......i~ ~
~ j.:;>oL:.. .y. :i.......1.J.1(L;L)'''~ .~). .Y':,j'. Y.
( ~"J~ .y. ) :i.......1.J'::'
Mns. L. 43 V. I,)""':.J~ - L......i~ ~
.4 jJ~ _ 'i
~~~
~~ ..::..ulS:j ..l:J~ t;iji ;;'~..)",J\ w';L~j ~..;)q .::.'J~1
d~~\ <\.:-.;';:; ~~ ~~~ ..::..ulS:}~ ~I .:r.~~l
~l:All (.i,:...,.Jl. I,,)""~I (~~1 ,;-. (.:........:.i.j"1~ J~ (.,)). ~I r-'.) uk
[~jo e-a';Cod. B. F. 49 v. -r:.)~ - L...;.;-ò ~
wl j~.ll ~~j dj..wJi ..)~J ~j 0~ .)7" ~j
• J;jJJl:J\..: ~I }~ :i.L1y' ~~.c 1"\.:41 1 J:.,)J...JJ (4J~1 0~ '::'-'-<j'~l~ ~ (Jb)
~I tj,r...J--Aj ~\~~ J-ii
F. 366 r. c. - cedo Ash. F. 9 r. - ( .-p;;:;';)l.:j1 .,).-p )
.)p....Jl p. '~\~I ~..J\ d.i ~.r--l' 0-<> ...\:i..J1
;i,~~ .::.\...c.~ u.l.ll j ;;.r \.5,j..':{1 ~..J\ -.:lji:)
. J.;hJ l :ut.:J~
~....:>'~I d.~j .....)1 0-<> J~ (.J)
~ J.!~ tlj~ Ù1j.:'4 4.-w1;,)Mns. E. 58 r. J-':)~ - l-....i~ ~
;4L:J.l (.i.,...Jl.: I,,)""~I C.~liSJ\ c:....., ,::,_...uj'':il~ J_..:A.4 (I) ~;~ 4i 'hl> _ \0
, ~I r-'.) uk
« ti~~ )} 4.S~~
Cod. L. F. 66 v.
~~ "'~;~h;h ..JI ~) ~\j l.l~~ I.S.J.....~ tj.r4-0t \.).i ~. ~.)~ l:;'JI-,;,- li:>'~ l+b~) 1")""_:.,,.'1 I u·\..c j lJ~
~1 Jy ~ ~., J~ tl.).i V. <UI .:r cf'.)..
0\.S: 1.Sy'~1 - j.,)).';.;-:J ~~ W; - ",,~..!·':il uk r"'I.S~I y..., r .. o..)~ J.;~ ~1 ~I ~ wl ~
jl~ ii.;.i.J\ .r.01' (~)
ii;\.)~ JW~ <.5.;1,3 4.S~~
F. 312 r. a. -; .A.W)l.:j1 .,).-p )
'~1 uh ~l4j ;;~~ d.i I.S~~ t)~
• 0'.))~ ~ L... ')b~ $..:ì uk w.......
ùjl~l~t~
F. 54 v. b. - ( J's.::u~1 .)~ )
~~ ù.i:i ~ J~J t)l:Jl li..<b .5.).>L;~ t~l
.. 4JSU 4Ji........ uLA.l...: ;; y
~l:Al' t~"....;J1..: ~wl (JJL:i5:.l1 (;-Q w....J.ÒJ·~1.: J~ (.)).. uL:-' r-''> uh
~~ t~J~ ~J.o
4......~•.1I j ~J~I ~ « I.P:-'.:>. r>" )) ..r~ ·Yl
\S'"1) l ~.,.w l t Lb.:A.J l -.La..;-: u)l~ uh yS......
.. l.>:!~
I.Sl:iJ~ I.SJ ji.i.~lJ\~
~ J\.:".J ~s:'" , '>J-""~J ' 'nvo .>J~...J~J .)~ )
~l:All (~~I.: ~L:JI (.,JL:i5:.l1 ..r u ...uJ"J1.: Jy..;.. (1)
.. uL:-'
f...J.> uho~)tl ~) 411
F. 28 v. a. _ ( ~)l:il .)~ )
4-.---.> ~L-,J I ;;~)U (f.-~ J.L...a..:i~ .!'""il
~.J'-- ù:-'.);+lJ u~}'" ';~.)~ ~.) y-~\~
.. ~..r ~';"1
0§:. 0'~~ 0~ J.).;L;~ ~L-ul vJI oj67"Jl oi..<b J
.. u;L.lIJ ;.)~.~\ lr...::J .i.S~
r-''> uh ~L:JI (~~ (.,Jl:i5Jl 0-. w..-....;.j"Jl: jl; (y)
: uL:-'
~Jl~ ()'3U eAfi j\i~F. 27 v. a. _ ( jS::~)!) .)j5. )
.l;,JJJU: ' 4..l:..:Aill 4.;:\'Ù..)~ l C:.>: ~G.. yS.;", ~ J
.. ~)J ~J
.• \ . •. .<., (.:>.)~.ry~ ~ .
J~.sl~ ~~F. 296 v. a. _ ( ~)l:ii .)~ )
J4 j J.).;L;~ .J~1 ~jU J-~ ~~I oi..<b J
~\ ~ 4~ j..P..):i j.).J\..;~ ùlS:j , d...:..~~
•. JL,~ ~J L.C:".J . .~
l'Wl (.i.,...J~ -.r-W \ (.,J~l (r u'~j"J~ J~ (~)
. u-L' f'"'.J uh~ "'1 Wl~J.
(F. 381) _ l. ~)b' .)~ )
~,l ~ tL..i.:i) ~ J.I....-o '4 J7.J ~~ ùlS: l.il~ I~ \ .\ . .) "LA:; I ,cl . ~ ,l., j .J,r:> vj \.. .J "" V'O . ~
.Jl:i...' ~..... ~Jl.4i) I.}~ u:;J l 4.:J1... Ù-O j').J'L.;y-J
cJ.-.:.'), \ 1"'-') \ (r~
., ...." ~nv.r.-\,.r..:u~ - l~~ ~
( ~,...:il}.~l ) milll. Li~jJr.' ~ , y~ , i A' Y~jjr.' .)~ )
~~
1..r:!.J~ - ~~ ~
("Wl (.i"...;Jl: vaW1 (.,JliS:.I1 (r u ........j·)'~ Jy..;... ('). u-L1 f'"'.J uh
~L..à~jA ~ j aU..... j ç~
F. 34 r. b. _ ( ~)bi .)~ )
,r:>W\ J)lb':I \~~ ~~.ll1 0 .. :\.....b:J1 o.u,~~ ;;"""'j.J.ll1 L~L... )U )L.. u.Jl>j ~\~ ò)w
·1 :1\ Jla..:i.-;:;I ;.)\.J) .) \..;--\vr- .. j.J~
J''';j:;~1 e ' (1.:-')
~1'»
F. 54 r. _ I ~)bl .).:{" )
;j !'!hl1 ~I~l ~ u:Jl L:uU~ll ~l..i... 0'J~~I 0-0~ j~)";~ 4;i...... I.J.)~ I"W ~~1
.(~':I\~1~1
{"Ull (.i.,...J~ ~WI (.,J~I (r u.......;,-'')'~ Jy..;... (Jb)
. u-L' f'"'.J uh
....ji ---"..' ....1 _ ".,
-(
'"la
ç.
Lo
-'c:-
li'~
If.
t.' n... ç,S'
r.~
laC
a,
~ ·11(.'l ì \ E.... E
~
Lo --
.1~
ftt'
..L
f:, ..~
'~.:r
g'b.
.t.
..-.!
..[
1:'1
ft:
.t·t
i~r.
r~
rL
~A0
'.C
'"•
G.,
-\.
!2'-L
,~
1t'
lO.~,
Go,:;
\:
E~
o~t
t.re.
'I:-
,..
'Ir..
E~
ì.,.
rn
Il'
o'
r-t
1:0-
-r.-
'e...
1.I.,
'e...
V\
~oG
o,-
Coç
Ii\g
1::.L
~~.
~~
\-Co
--
cL
t,..
C'
'rC
'[,·.[.~-o
.1
~.1
Efl
[f
[:1.
rf[.l
i'.~
rr\:
-c~
oC
f.-
f-
S:f;[
'i--~
ole
,C
',.
,-
~~
l.L
.l~~
lo
Ct·
rl
'\1~....
Lo
't,
LC
-rv-.~~"",
C-r~l
E•
~.
,.Lo
•I
'--
~I
1;'t.
.~
'lo
.~
't.\-
ll
lai-
\-
-
~ -1..
f ~ ~
t..
~'..
g~
r-tE
-t,..
t:~'
t-\~
e-t
,f:-z..
~:;',
't~
.t:E
Co,-
.G
..t
,-.'I
-e.-
'%J
V\
'%J
-n
~~
,"~c..
'e...
,.:....
1,.
Co...
.k
ç~
w-
~t
~o
',-
,·tF
~'-'
t--
1:l
1."ç.
.t>~
I~
.li'
f'~
"".{.
{~~-
fl~
r'.V
"t
~ln
\"At
~L
1:..
t.'I
_~
~.~
.1:-
1::.
t::'o
<;.:.
...:-
~...
:-
-....
.'~I
1;l
oC
c;-
'"~,
-_
L(.
't-
'1-.~
.Lo
t,.
C-
l-,~
r:~
1:.f
o
~~
\-l-
e;..
_.i
:'-
-la
_
\ - ....
( ..,...~, ..,....,1)~". .bi~ Lj~Jji
C':~jJ.J7"' ~,~ I. 2 r. a) .s~l~jJ.J70' J j:)
~L,' ul' 041' J.:J .:.~ J' ~~;I ,;~ ~
'~.J'"
~jJ~l ~ , ".~ (386 r. b) "'~jJ/...1 J j:
jJ;liJ:!l ii~'"p".~ yj\..:- uh <Ul .k...;, V'L::D
( ~"Jl ~~, , ~J.l.o ),
. ~,~~~
oL:-.lJ ~..P,>-o J:--ayJ( ~"Jl ~l '.l.I-I.4 (I, 149 v.) ~J.l..,)
~~'-J ~~.~~ fl~1( ~"Jl ~I , .l:!.;.4 , \ ~ o l J~.;.4 O( ~"JI ~l , .l.I-I.4 , \ \ t I ,):.;.l.., (y
~J\iJ~ ~J.iA tL..i»JI( ~"Jl ~l '.l.I-I.4 (150 a) ~.;.l..,)
~~~~
~UIJ ~I*I uh !.SiA .hà.....o
( ~"Jl ~I '.l.A-I.l.., (114 a) ~.;.l..,)
:l\1.bW11 ~LA1 ii~'~ u _ JV7
( ~.~1I ~l '.l:!.;.l.., (135 a) ~.;.l..,)
~1 1i.a..QJl ~~ ,;.;:r.' J..<h
( ~"JI ~l '.l.A-I.l.., (149 a'l ~.;.l..,)
~;\i~ ~1 ii~JJ:l\ ~ ":-lJ~
.,Jl:!jJ~l~ , ".~ , A\ , Y~jj.J70' J.f.
~U~~~~,~
( ~"J\ ~l '.l.I-I.l.., (134 a ì ~,).l..,)
,;~ jj~
F 344 v. b _ ( ~Jl:il J~ )
"",:.i__,,~1 _"
·1·1~ ~L 11.:.11 4l.I.:.: ~ ..~~ . . u- ...J- .~
C,';~jJ.)~'~ 'y~ 241 f. d Y~jjr.'.)..s~)
~1 I)'~ ~~~1 o..~.:..~;F. 28, v. (L..u..;-A~ , v~.J~ ,
0',1:1
',).r. L..,.,1;J
'''''~jJr.' :i~ ,yJl:.. (241 v. c) Y~jjr.'.)jS)
jl . ... .<':Y'yy. ~
o)IJ u...a.i J~~F 394 1'. a §W)l;'.)Y. : .J~~ \
F. 4 r. ;':"'-'.J>'..)y.: ~l
~)l;'JI j>-o.J j 1".,.....)1 o)b w....,ojJl ~.7. 0\
j l''~ 0' '-:-L7'~ 0~ 4.S~ ~ 4;.wt 0j~
. ~r.)
jl ... ...; .CY'Y__ ~
JJ;uJ!:ll.SJ ~~,F 357 r. _: ~)l;' .)y. )
y.;1~\ ~ j.))';~ [.;:0\ .;:S, ~jfi uh J~JWl Yb ~ )~~ ~L. 4..;~ L.;:f.... ~j.))l
cc ~ )) J ~~I ~\ j
jl,;iyy ~ (') u-l'L..ll JaWl _ 1.
~1 ~1;~ ":'Ù'Jo:' ~~(y~jJ~' ~'y~ F. 240 r. c. j;~jjr.'.)y.1
y1y''Jl O~j y)l~ ~~I ul,;..ll j ~JlJ.l .lA.q
iJ oyl .)J,;..~ '.' '~l\ 0'> .......ly.~ ~
. u\~1
l'Wl (~~L.: ...,...L:JI (."J~l 0'> u ....,..j·'1~ Jy..ò.o (y)
. .)-o' r'.J uh~ J.&l1 ~\l1 l.SP,11 ..;i~
F. 240 r. c. - ( 5~)l;' .)y. )uL-..l.J~1 0'> ~.,p. j~'JI .J~1 u\j;.:;Jl tj~
• ~I ull L..;.J".l.o ~ u...j1l ~jJl j ~
~L..,;YI u4.,.....) l ~ ~ (~)
~'-' ..;i~i J J~
jl~jiy ~
4,.~~jU' ~ L.w';.)F. 167 r. a. b _ ( ~:;:u)l:il .:l~ )
:L...~l .:r~ y~ j ~ .s.:l)';~ u-'.f.
~~L....JI JJ ul:-4J~1 j v~'~l w-h.s \Y'U~
c.1.f.y'::'1 ~j;; ~ .l:.iJ ~IJ)\ w.l' d:!);.j1 :i..,j;,;ll
~~ ~ c..jLS ~1 uUJ:.l \ dJL::.. ulc l..l_:u.....
• ~JL:,IJ u~
jl~y.s" r,).:.' (1)
~, ~L 11 1.~ ~':I;..J ~
F. 396 v.f _ ( ~~~1 .:l~)
4L..... I. 4...,bLJ l 4.s ,Il I.. 4-W )llù 'Lllu- ". r-' ~ .. j-J
uh w1.)J.lll 4.s.J"" ..::....A.sJl u-'.o..; jj~ u~~\
. tr)\
~YI d ...."....,) I ()-4 J:o.; (~)
~l ~~ Jl~ ~l~~n ~~;b
( Y~jJ.r.ol ~ , ".;~... j riV , yl-:jjy) .:l~ )
~'JjJl1 J~ ~J-7:i
IJ"'-!...J~ - L..;..;-' ~
Mus. D lO, Paris J.b11 ~~ ~~
( Y4jJ.r.o'~ , ".;~.. , j;~jj.r.o' .:l,s )
tla..:il jA~ ~ ~ Jb!' ~l:!P ~ J~I ~J~
Mns. C. 22 r. Paris i.T'-:.)~ - L......;.;i .l+'4
~"l1 ~1,rQ~1 ~J ~) ~IJ~ j~
( ".\'-:jJ.r.o'~ '".;JI-:.. (B 9) j;~jj..t:..l.:l~ )
.bL.all ~jlll ~~ ..p : ~1"s~1 ~~,;li,j 4.J" ~~oj1J j
(y~jJY.""'~ ,y~.. (181 r. a) j;l~jJy..l.:l~)
~U\ JLilllS..ll.A:ijl r'.)
( -.;L:.::-4.)LS ~.)J'~ r''; )
~~1 ~1';)U 4~-U11~ J!ill d:I;.!l,,i ~~
(YI.:!JJ~1 ~ 'y~ (45 v. a ) "'~jJ.r.ol .:l§.)
L '\lW _"\
4 ·"h'l _ V
v/a;'JI lJb~ J ol~ 4SJ~
<.r~1 <.r."J
.•1 .i. .. ..;. .<'~ -' y.; .J::7'"'
. 'lI .L:"1~IJ4J .;r- ..
Cod. Atlantico f. 269 v, a ~)l:;1
, ~.;'11 J.f. ~~.1.;J I ~)J~ -r\.:lJ l ~ (,,&.:i:J..;.. o ~~ .)~~ ~~ jlp (ji11 ".)..JL;~
1.J""'l-)1 ~ ~ jS:)1 .).l:>, J"..WI I,i,a, uh". .L'II -,:1\ I::: L.. .
0:~~J~~ r.-~ ~J~..J"'-:
~L-.l1 ~~ ~Jl11 <J~ 0::-: :UL..,.l1 (,5';
• éU-Jl ~4J ~~I ~
jl/yy. ~
~~J ~1 4JS- ~1~F. 208 v. B AfU)l:;l Jy. : (,5.r:Jl ~l
F. 104 r ~)l:;1.)y.: ~I ~I
~..J'jl ~JJ ~y..lJ J,,)tl (~I .".)..)L;~ r..l.-O..<. L.;...:. 1 Il '1I:-l;...L.· 1.lS: • ,\I ~L,
1",).'1"'::. ..) lJ' ~.; vo ".. ~. ,• ,1\ <Lo - ".ill J .. :ll .'~ . r~ I,,;> J"""'4 ~
l'w. l ~.i"..J~ V"'~1 ~.,.J~I ~ U-.J.,,'J~ J~ (1)
. ~..,1 ~..)uh
J).4jJJIF. 1. r. a _ ( ,,<.:'j;)l:;l .)~ )
~~ ~ 0y.... ~J"11 ;(cUI -r\.:lJ .;4J:.-.:i -rJ'; ~J 4l~ .)7:'.,..Jj <Lo-i:i 1-'7 4.h~
.' 'lI I, ~l" .... :uJ Js:I.J"'"J lJ""' , . ~
jl/yyJl ~\ (y)
~~1 4SJ ~~
( Jl:!J..J~ , ..Jr-'~'" , \ ntA ~..) JJ-'~J)
F. Windsor N, 12248
JJ'fl ùI.,.o.....Jl j J.)..)L;~ 0.i:.~ l''l.:i. ..J~ r..J
~W\ ~~ j 0Ls: L...w ? u'JL,J\ 0?1 ~I l' J ,. . .. ')WL, .....J.I L..:. \. .....r-'.>' 1,,)-'4 J ~ . l.f<' •• :JY. ..)~
• ~,,-;Jl ~~~ ~ ('\.:A ~Ls:
~,~ -(
~J I..r'.)~ u""..,.aJ I 1-41 \~J I..r'\.:i#J l ~ J
~, •• .,.t'JIJ I.)~~'il : ~\ JI.)J'J\
uL'J\ r)~ ~))I (.,J1.:Q1 -r 4Jy..;l\ (1)
\:i .1.':'..r ~Mns. G 33 a ~.J~ - L...;~ ~
Jl.)J·~\ ~ ~ u~JL. .i.i~~ ?\~ J~.)L.;~
.. , '" \~~ \ ... <-ili \.:iJ....i.~Ju I.r' - ~. I..r' J_ ,y.
,-~J .~l 0-' ~\ wl}~ 0~ Jl.)J·Yl
.l:.Wo.~ 0~ w: •Ul
jly jiy.J I ~\ (~)
~j.l.~~~ ~,...~
( J~J.) ~ , .)r-'~J ' I ~ ~ lA ~.J .)"......~J )
~J: ~b j~.).,;~ 0~ r.......)J ~., ~l~ ~
~ 4J 0~ ;;~'J\ O~j .)."b)l j uL.~.Jl u-'.)~J
• <t:.b..,J J.-.-.t. l.\
roL:Jl (.)"...J~ U""'L:JI (.,JI.:QI (,.--. w .......J·Y~ J~ (1)
. ~, r'.) uh~j.lj4 <\S:~ j.i~
Mus. B f 652 \.r..:u~ _ L...;~ ~
~r~ u"".)"il ~J ~I .>:!~ ~'~l .)~Wl 0\
01.)J~ 0J~ ..,..:cl I ;;~JJ: ~ jA.....'Jl ~~Wl
JJ ;, 011
l. J~J.) ~ , .)"'-'~j , '~i ~ \ ~.) .).}-'~j )
~L..ll .)~l ybl"J;. uh 4.-...1.)~1 j~.)L.;~ 1"L:i1
LÀ...AjJ • oL,ll ~~l uhJ ~~llj ~.)'J'
41j4 ~jj ù1 j .:.":/l ~ U""'L:Jl (i"...Jl
.~;~\ ~L.....)J: ~;.~\ ~l (;7.~~~\
o~ JJ o~.lJJ1 4..l4.&.1 ~~ ol~ y~ J \S~1 orj
~JolLa ù'l".,~ u:J1 rP1 o),~ ù~~I4..lolLc1 ~~'JI
<J.l.A> J dy..-, O.l-c y~ J -rLcJ • <t.,;-4 ù~~1
•«~l.òJ7 ùL....,' j>~' lJ.;l)) r-'J ~\Sol\;+Jl ~I \.iJb JJ
lSol Yy.- 0-0 o~ol u.k ~~ ~J L..JJ u-l1 .,ol),j~ ~y
I \, .l.<L.l ~\ ' l'.ill 'lo"..:>. Jl,;"ol,l.S..l\ , •• :. . I •• .l...à~., V ls'J.. , .J ~~.
o.l.ll o.iJb ~~1 Jol}';~ \.J""./;' J.:;j r LJ1 ~y'j ~J ~~
• ~ol uL..""""'J o~ .l7J é.o~ ùL....;)'1 ~ 4......,IJ~
~ J:JJ « J.;1Jl ~ l..ijolUI » r.......7. r\.;; ~~'jl o.iJb JJ
(,y ~~'jl Jj rU c:'J,r:.... ..i~ Jol)'';.".;J r\.;; ~JI AoLcol \S..iJ\ 1.,Jl.ò \Sol JJ'j\ ~"":"';l~ » cllll L-..;~ J
• ~l..::..J J <t.,;~ oJl..::.. o~~
~.l.ll y~ J .::.u.,J1 ~ J1J ~JJ Ù'" JolJl.;.".;J ~t......
cllll ~J ~J • L-..;~ u-l l J,..:,J ~ uL......i u:J1
J -l~ ùl...... J ~ L.&...... 4..ò.r<>'-' u.:..:; ~I~
I~ .r=J L......oI J J.;ll 1.iJb ÙlSJ )J-;-o~ ~I ~I
<L:J~ .fi~ ùlS ~ JolJl.;.".;J ~1 J.:;j ).,JJl -*' 0-0
~~1 ~ 4.......IJol J <I..:i1.J l......,;S'.... -rLc éll.iJb., •~ J~L~~l U,r....j {( ~~l )) J {( ("'-')1 .:.r O.l.JbWl ))
• ~Jll ~l 0-0 ~ uJ1J ù.l.l\J
o_., 1I.l..:.. .l.l.O clJ..i ' l' .. 11 O.lJ' jl..:iJL. I....U....<>1 .lAY'"' • J ~J v~ . .., ," J
~) ~J J~ u~ ù1 ~J . ~I ~J r--)..:l ".lA - .': \ •(' .. .::1 ' l.......; •• .s.........:.; .l'..iJ l
~jJJ~~~~"',v
{ •• ., <ÙA>1 u-l l., y~ 0-0 rfl1 oJL"'::'j J~)I u-l l ~• <1;Wlj r~ 4Sji ~..i ~
\D.V
l DH'
101"\
~ • «.~ ~)~l » r-'.)) HAt r~ J ~\ 1$l! \. ~' .,J~ylS.J1 ~ I~
..\...-:0) ~L:.J.l 1oL..)) l ........~ L. .)~J....... §";')j.,J~ ~~
j~ ~~ ~I ~1.r.l~~r~ ~Wl ~
ri)~ ~l~\ <,)4 jj)..i~ ~ 15.iJl ~) ù~l.ijJ
. ~ r1.:o u:JI oJ~.wl ..:...L..).ll\ 0-t
~I) j~ ~~ ~WI u-"~."J J~ J ~.;-JI ~l r\.2
~y) ~.ll.l jJ}.i):l ~ rii) • ~G.JI '-:-'Y") )~J4..
4....~ ..:(, L,.. ~ ò...:>. ~:o..l.i..J l 1\ ~ li .' 1\ ':/ T...r-- ..))-<l • '" V"' t' y.'-4 V"' )
15 j1 ) J o.)jjO J)l; uly.;-'JI ;c;~ )~ t..f>.ii ~~ ~
.:.l~ J L,.;.)."J-ò ul l dE ~ "'-7..5':; r.'; .?.)~l::-Jlj 15.;~':/1
~I ~ L.;jJUI t"" \..;1 li.iU JL1\Ùyfll jl.ll~ rl:à
• )j~1 J~ l~ r-lj ~l.)j j
4..,;~ _:.::\~ .<:L:,., J~.. .:i,"; 6,~ ,I~...;; J..:o ....... ',u".~ r J.J ... .JJ . ..;..I.. • ""- '0,.1,;--
(J".) l.S.iJl 0~~1 4Jj.ll~ ~..r u-"j";~j 15}·....4 u-'~
oj.)~ r>-,.) o~ ~ jj.)l.i~ rl_:o ..l1) ~WI l.v-,..L....1
i~~ J~ 15j."J~ ~l_.a..l .)U\ .b~.:J1 L_"'\.)JJ
. \S:.i~~ "l.i~ JL,.<:L rl.:oj O,ll;~';-o>-,
;;,;:;}~ d~ <l:.iliy,j • L.7.)y, ,..,.•.& ........JI .)_\.iL.1 ~~1 jy
I"~ ~ ~ ~ l~.))o ul l )J}.i..zJ jlc • y~Jlò
15 j l_:1~ ':I ) r.) ~ o~Yl 4..-,u':l\ oia. "L.;.';l j \ o. iL:lG. ojJ-7';-llj oft...:.JI (( 1~~Y--7' )) r.)j «( 15.)~1
~I ~ J rh-J1 JJl;..:;....':/~ v ....f. ~ />....lJ1~
..:...~l) ~~~l d~1 r-hj Al.1 k....:. J ~I.)j J~l-,
0 1.e-b <y òL.,,,../11 ul l Jl~ ~ ul1yJl ~ C~,r.:J1J
• o)l.bJ1 ..:...':l'Yl ..:...lc),r"j .J~1
j o))l j ùj--::JI .)l.'il ~ ":"'pj jJ.)l.i~ .lll" ..:...L.
.~I<l:.i~
(~l)\o.r
\ o. (
10.i
~.;J ~l:J1 ~~l J ( bF.'~ JI).. )~ J )..l)"~.l.l.,
ifr .r.l0:1Y'»' ~';7"\ 0-- \~# H ~ ulc~L..":jjl.S ii Y..l.t\)~ (,rq ~3.b.;1 ($..l )ji::.: / ~
l:iL..::.l )) ["-"\.: wijyJl j~:~ ($..l ~3.b.;1 y.l11 ~ u::::-)5'
~\ ...;..... ~ ...~ ~1 ifr J1 .r.i. ..l)) \ I.i~) .. « 4-:~
.. J.::.<>j'1 u:J\ 4.1j.li o~~lJ
~ ~.r~) • « y~1 )) J4:;>j 4."'7,.J> C..:"" <\.~l~ ~ .ll.l)
($)).. J---ilJl ~...c. <I....<:U L.. ,,)S.,9 .. (".....)\ ~l 4.. (j
o~~ uh r.J .....WJl ,,) wi.f. wi_.o)~ I.;~
t ..lLi......;Jl '~1 ~l......:.::.. 4..J.-i:". , W~' ')(J" ), .. )~ . ...,..
. ~u, L........; vl.S) ..l1.r.J1,.,
!""'""') l ~ L..,.,;.;.,.L; ~ \ .ul..-.) )..l.;\..;~ .l.ll) .JjA ..l.ll,.,
,k ' ($..l:.f. ($..l j ......·~..u.sJ ~\.:,; òf" ~).r..i J-.,:.... J. ~;;:;y. j';~j k.,~
~\y. vi )..l.JY:J vl.5:..1J ~1 ~ wI~ .Jjr ~J
r)1 #1 (,rq) ";;Wl\ uh (",....)1 ...,..~....::u J ~j.r..i
..,..\.a.:;1 uh J=:.: VLS) « ~1l ~~ )) .y- ~'1 o.;~I
J J.::.Lb~ ~ ~ ~~ élE ~ l..S .bL..:;.;.y- ~
. ~, clb
0-0 ~y ..,..\.1.;. <Lo....,9 y)L,.. ~I é.U.i ~ j..l.;L,) ~,
.<:il.:.. , ... , 'C"'o..lJ Il J-.. ..... ..l-o,t'..l '.\r Y.;~:re. .;.; iJ" r ~ \,;> ~.;y
~ ("\.:,; )::.)":1'1 d.i ~~ <\.JT L..:.;J <Lo...j y~
~b~ v\ ~.;) ~ ($.iJ\ v~ V""1.J JL'; uh~l.:>. J Y)L,.. ~ v1 ~ vLS Ll j r'~1 4.JJL:J ~~($.;~l., u-'41' 4.-.\,:,;\ wi~ <W~ o~1 ~ V""~ ~l
.. 4~ .:.f.-<>: ~.......''1\ ..:..~ ~~) u'{))l-,
~L;.....o~ ("1.:0 ..u.o y~ 4J: j .bJI <\.:;...,l:o\ ~L;~1 j..l}~~ vl.S U'"Jr-W1 :i......1.J~ ("lò ..l-'é) ~~..l ($ ...~1) ;;"~.r u':H
~ ".;~ A~ ii..lLs.'1 ~~J\ 6;ljj) 4.~~I) ~LS:l1
u~ ..l:o u~LS u:Jl ~i11 c:.\1:; 4J ":':"""':'yU u:J' ..,...,.rJ'« LS))l~..l ~.;Al\ )) r)..l.:>..J' )..l}";~ e?.,..l:o.i vY~
( J!~lllo) '(o,l
Hii
c:J'l-u~' ~~ ~1 J....oyçl\~j~L,yjl w..;\S <\:i'jT ,).,
~1 V. ~1 ~ • lS,,~l J-J\ ....Lb,.;.\ )l\1-; ~\.~_~L... :;ll ;\=......:.\1\ )~ C:'
•~.... ~j O.J&:j ~ J""'"': ~j..>.:! J~l ulc- J."..-=Jl
(O:!~ J-laS ~.u' ~....li j w'jT U-.-h.:l j.))';~ t:::---j• u7'~~1
,.~ ~ ~j -,.,)).,;~ ~ ~.h.ll-, ~I ~l '-41 4?.(iij
• ~.,Jl olia..., .u # ~ ).~'j
~, w,~t:; wl).~~'jl -:rJl j L..~I j.)).';~ ~ rh 0'.,,").JLi~ ~~ 0\S ~.4:>JI .y. ~lo 0.i1 • élJ.i .,.,)....Li~ ~ ~
<:~Il'~ <':<':11 L 'I ~JI L..:ul L,.; \ . :\1 L....l.h:iu; .. \~ .,~ u- ./.. ..., V"-' V" ~3
~~~ 0'~~ 'j <\,.j~ ~1! lS.ill j.)....Li.5t:!J lS..).\ .,)~~ ."..
~' ....)l J o~ w~..).aJ ~ ~ 0..,j J., ~...a~)\ ~'.r.l~ ~ ~ 0'.1_11 _1·:<':11 LII . L,~ ~T ~ •.,) Li··\ ·lo :i........Wl 4..W..llU- J u7'y~ r--' U"""4 . '"' .... r. Ve. ..
• ~..,.wl~* ~ ~l élJ.i Jj
O~." ....Ls .:6., ~'J' ul1 u1.l: ~T O.,).;~ o~Tj oU~1 L, ~• ~TL, h h ;u.L o .4r-' u=- ..y=' ~ u
\S~, u-Ja-l'~I ~I wl ....~ t~7 4';J o':" "i: ~1 ..)J. .,.,)....Li~
-L..Z.]' .~~'j1 \.à"W:.,; .; l.ìJt> L4 .~ .1.l-:l.i ~ .; <I..J 'j J1.;~ ."....,.... I..:> ~'-' \,.;> • .".......
. ~'j
n\.,.
r~
~:c:
~~
~1
\.,.~
S:c:
ir:li\
.r,r
-·l
c.
'l[:
l~
fC;.
.r-
.r.t-
C-.
""
l..
'i==
__IL
~,
t-l
:l-
f;.t
[.~.
ç
'f::~.
't,.,
""-t-
f.r
_
~;~f
'f~f:t r
f~
~~~
.1.!
~t
!ff[;
f1
[f.:
.."",
[r
t'~
'r.-
[lA
Le·
ft.
•I
_t
L;"~.,
(..r-
.,[
'f
I~
..
't,i
.E~
l'&
J~
~'t
hJ
p.
"'='l
RCi.
-~-
tG
.,1:
L~
L.r
-C.
.p~
__
Ly.-
l'-E
1~
~~.
J=~.
""-
...~
~...
t.:~:
'-
\.,.'I:
...'I:
...11
•L
Co(".
Cl
I..
•L.
~.L
>t·
or.-I:.
:..b.
b,.t.
ff~'
1:!!:~
:\'r-:~
~f:~
-.l
<tt.i
~.~
li\li\
rtf
",,-h
~~
~c.
-:G
..fo
.,_
.~-r
."".
.,
G..
t·
f'ç..
.[r
L..
I""
""
,_
t;.
Cl"C
LL
"t
l['
,(.L
t::'
l-;
1~
-LO
t.'1
(li'
t:r~:,;
~:_
~~
rif.~'>
-=1-
~1tr~
'1L~
Eig>
f':
c·~
[\.,.
li.
r:..~
J;-L.
t.~,
I--\.,.
".r
-_
'~,.,1
1~~
<f;r:
f.L
-1>
:Ì
~IL
..
~y
o~.I
~~::~
'",,
-~,
,G
..f
J<f;
,.~
ol
t·[:
-'b
J."~I.
'b~
[t:.-
k-
•.
!'L
t.~
b1:
L..
,•
•
~"":1=
Cl.
.""
fc.':.
1f
t""
",,'
,r1"~
r[c.
,l'
C:..f~
,0
'""
,tb:
f·..
.c~
.[
r]o
'I:...
L.
""I·lì
rl.
_~
Lle.
..l-v·
"".
_L
,\.,
.t\"'-
,..(.
\U>
.L
-"-
le,\'
.Lo
'lfi\
-L
-t
-\.~
~L
IrC:
..,I
-'r
'p't
<f;t
bt
""~.
~~
""~
b.1l
.r-
t,-
c1-
l.f·
t'L
l.li:
''.
G..
'I:...
...cl
[.-
•,
.L",,
'C
-O
'•
_L
t:..
'•
.,L~
b-t0.
-:':
~'~
-:~~
:~-:.
.~\~
c~'
&.~.
[')'{-
'et,
h&
--[
c-J.
~.r-
.[t
Li\Ll
1,~.
cJ:
-r.\
t.t~
.t1r
t't
[C
o~
CorC
o~E,
L'L-
';,
E1-:
HV
\l'
~1-:
.!:::
I.'.
'-.-
lAli\
-li\
\-E.
V\L~
t..-
\o'
illì
1::~
G..
\,p~
0.:
•C:
-J"=
r,:b:-
""""
It""!.
a.
_-
l.'I:
...L
""'"
l,""
'I:...~
,~.-
f''I
:.~
ft.(.
(.I:'t'
,I:'p\
\o.
tg
\Fr.
~~
:~f
11-
t..~
~~
~~~
I•Cf;
.t'r
t't.
'"1
f.c;
r.['
.f-'
o....
f-.t
' l'ç
O'
Lt'f
l]'O
'So
f}
"L.
C'"
('~
t:::
.t.-l-
oIl
-.
'),
'-L.
f..
L.ç
'".·t
~[
c~.
,~,
1:~),
E.r::
.t'i'
.f·,~
_eT
~~.
-ç,.
l.~
~:IL
t~
1.l.
"ç.,
..~
'".f~
6Go
..t
7~.
~G
.,~
~~
o'"'
-~
1-1~
:;)L.
.t.f:'
1'!
=~
rL
{flL
~.~
}\.
[~
.t't.
.~,~
"',~~
..t
'f
l~
'"{~
",'[t
bç
~-Go
,lr,~
-:
o~
f-Y
,'"
LI
.L.~
.,
-le
..I::
:-
IL