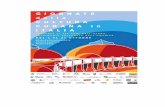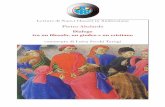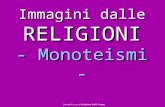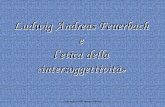L’arbitro Abelardo così affrontò la contesa tra i monoteismi
Transcript of L’arbitro Abelardo così affrontò la contesa tra i monoteismi

8/7/2019 L’arbitro Abelardo così affrontò la contesa tra i monoteismi
http://slidepdf.com/reader/full/larbitro-abelardo-cosi-affronto-la-contesa-tra-i-monoteismi 1/1
L’arbitro Abelardo così affrontò la contesa tra i monoteismi
di Luigi Accattoli
in “Corriere della Sera” del 2 marzo 2011
All’inizio di luglio del 1141 Pietro Abelardo, in cammino verso Roma, giunge in Borgogna, nella
grande Abbazia di Cluny. A Sens un concilio dei vescovi di Francia l’ha condannato come eretico
ed egli si è appellato al Papa e per questo sta viaggiando verso l’Italia. Mentre sosta nell’Abbazia
gli arriva la notizia che il papa Innocenzo II ha ratificato la condanna di Sens, l’ha scomunicato e gli
ha imposto l’obbligo di «tacere per sempre». Abelardo rinuncia al viaggio a Roma e muore a Cluny
nove mesi più tardi, il 21 aprile 1142, di scabbia o di leucemia, riammesso in extremis nella
comunione cattolica. Nei mesi passati a Cluny osserva il silenzio che gli è stato imposto, ma la sua
intenzione non è quella del «perpetuo silenzio», perché viene componendo l’ultima sua opera, la più
matura e sinfonica, conciliante filosofia e teologia, Grecia, Gerusalemme e Roma: Dialogus inter
Philosophum, Judeum et Christianum, ripubblicato ora dal «Corriere» nei «Classici del Pensiero
Libero», con il titolo Dialogo tra un filosofo, un giudeo e un cristiano e la prefazione di MariateresaFumagalli Beonio Brocchieri. Dialogo immaginario, protagonisti che egli aveva dentro di sé e
riusciva a far parlare con pari dignità. Opera incompiuta Abelardo muore che la sta ancora
dettando essa è come un battello affidato un giorno al mare aperto e che ancora viene tracciando
la sua rotta, nella mente di chi lo legge. «In una visione notturna vidi tre uomini che arrivavano per
sentieri diversi»: è l’incipit affabulante del Dialogo. I tre si presentano ad Abelardo e l’informano
che dopo aver «discusso a lungo» sulle rispettive fedi hanno deciso di ricorrere al suo «giudizio».
Qui dunque il maestro assume un ruolo super partes. Per nulla in dubbio sulla validità della propria
dottrina, egli insedia se stesso come arbitro nel conflitto delle fedi e fa dire al filosofo del Dialogo:
«Sappiamo che tu conosci bene sia la forza delle argomentazioni filosofiche, sia i fondamenti di
entrambe le leggi». Sempre quel filosofo più avanti afferma che a fare di Abelardo un arbitro «in
grado di risolvere questa nostra contesa» sono tutti i titoli e la fama conquistati sul campo e c’è per ultima «quella tua mirabile opera di teologia che l’invidia non potè sopportare». Allude al trattato
Theologia Christiana, scritto nel 1132-34, dal quale gli avversari avevano tratto le proposizioni per
le quali era stato scomunicato. Egli non riconosce valida la condanna. Non solo perché il suo ultimo
protettore, l’ecumenico Pietro di Cluny, detto «il Venerabile», gli ha aperto le porte dell’Abbazia e
si è adoperato per la cancellazione della scomunica presso il Papa. Non la riconosce valida perché
ritiene di non essere stato capito ed è sicuro che sarà riabilitato dai posteri, come infatti è stato.
Orgoglioso e a volte temerario, Pietro Abelardo si segnala per una disposizione naturale alla disputa
ed è tra i primi a istruire il metodo scolastico del vaglio di ogni opinione in campo prima di dare
soluzione a una quaestio disputata (questione discussa). Antesignano in questo di Tommaso
d’Aquino e del suo grandioso impegno a fare della teologia una scienza con un pieno statuto
metodologico. Anticipatore di Tommaso egli è anche per il rapporto equilibrato che propone tra
filosofia e teologia, in dialettica con la tendenza dei teologi mistici guidati da Bernardo di
Chiaravalle, che fu il suo avversario. Di che apertura alare fosse capace il raziocinio di Abelardo lo
si intuisce dalle pagine in cui mette in bocca all’ebreo nel Dialogo un’appassionata difesa della
propria stirpe: «Non si sa di nessun altro popolo che abbia sopportato tante prove in nome di Dio
quante noi ne sopportiamo continuamente». Morto Abelardo a Cluny, Pietro il Venerabile ne manda
il corpo a Eloisa, che ora è monaca ma che era stata sua allieva, amante e sposa e gli aveva dato un
figlio di nome Astrolabio. Per l’audacia di quell’amore, Abelardo era stato evirato da tre sicari
inviati dallo zio di lei Fulberto. Morta anche lei due decenni più tardi i due vengono uniti
nella stessa tomba, che è anche oggi visibile nel cimitero del Père Lachaise a Parigi.