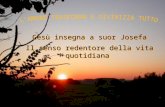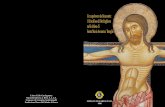La vita quotidiana a Siena nel Duecento.
Transcript of La vita quotidiana a Siena nel Duecento.

Storia di Siena
Dalla nascita della Repubblica fino alla prima metà del Duecento.
La Repubblica di Siena nacque nel 1125, anno in cui venne deposto il Vescovo,allora a capo della città e del contado attorno ad essa. Fu nominato un governoconsolare per amministrare lo Stato nel suo primo periodo: nel 1125 la caricadi Consul Saenensis fu attribuita a Manco.
Dal 1147 in poi si hanno notizie di regolari elezioni di Consoli; nel 1179 ilComune di Siena era compiutamente costituito.
Convenzionalmente è indicato il 1186 come l'anno del riconoscimento ufficialedel nuovo Stato da parte del Sacro Romano Impero, anno in cui l'ImperatoreFederico Barbarossa concesse la possibilità di battere moneta e di eleggereliberamente i consoli.
L’espansione di Siena fuori dalle mura (con la spinta verso il castello di Staggia,le miniere d’argento di Pontieri, Poggibonsi – chiamata Poggio Bonizio – e laVal d’Elsa) provocò il primo scontro con Firenze (1141). Nel 1197, i Senesiaiutarono i Fiorentini nella presa di Semifonte (1202), ma per contestazioni diconfini le due città entrarono di nuovo in conflitto.
Al governo dei consoli, rappresentanti delle famiglie nobili, dal 1199 si sostituìil podestà (il primo fu Malapresa da Lucca).
Sconfitti dai Fiorentini a Montalto della Berardenga (1207), i Senesi dovetterorinunciare a Montepulciano e Montalcino, allargandosi però in Maremma; nel1224 fu conquistata Grosseto.
Nel 1228 S. entrò nuovamente in guerra con Firenze, fino all’intervento di papaGregorio IX nel 1234.
A moderare l’autorità del podestà e delle grandi famiglie, nel 1236 fu istituitoun consiglio, detto Eccelso Concistoro, al potere fino al XV secolo.
Nel 1252 fu creato il capitano del popolo, che aveva il compito di vigilare inobili, amministrare la giustizia criminale e dirigere le compagnie militari deiterzieri della città; al podestà rimasero solo l’autorità giudiziaria e il comandodegli eserciti in guerra.

Vita quotidiana a Siena nel Duecento
(testo rielaborato e adattato a partire dal libro di Lodovico Zdekauer, La vitaprivata e pubblica dei senesi nel Dugento, Arnaldo Forni Editore)
INTRODUZIONEPer descrivervi la vita d'ogni giorno di questi antichi, bisognerebbe chedisegnassi anzi tutto la cornice, in cui si incastra il quadro: le strade strette,fiancheggiate da altissime case, qua e là torri minacciose e superbe, e fondacie botteghe oscure e chiese e cappelle; e intorno le mura del piccolo recinto,merlate e fortificate; e sotto ad esse i fossati e le carbonaie. Si comprende chei Signori feudali non volessero cambiare i loro castelli, posti in vetta alla collina,con questa città che sorgeva, sudicia, con le strade anguste e buie, colle goreaperte, piena di lezzo, affollata d' artigiani, di contadini; ove mancava quel cheera la loro vita: aria e luce; ove incontravano per strada il loro villano, appenariscattato, e già prepotente. Le loro superbe cavalcate attraversavano solo diquando in quando la città; e la loro vita non era quella di cittadini. Essiavevano per occupazione principale i bagordi, i tornei, le feste; lor primipensieri gli onori, la guerra, le donne, la caccia, i grassi mangiari, i cavalli, icani — ecco i loro piaceri di ogni giorno.
I popolani, siano essi agiati mercanti o poveri artigiani, sono costretti apassare tutta la loro vita dentro quelle mura cittadine, e vivono per altro scopoben differente che non la gloria e le apparenze: vivono per sostentar la vita,per la loro arte, per i figli, e soprattutto per la patria, che devono difenderecontro quegli stessi signori feudali, non ancora del tutto debellati. E ciò valetanto per i banchieri e artigiani e mercanti ricchi — popolo grasso — quantoper i semplici fanti e operai salariati e poveri: il popolo magro — come si èvoluto chiamarlo con un nome terribilmente espressivo.
IRA E POVERTÀL' ira è il grande vizio del secolo; e la ragione ne è chiara. Troppa gente sitrovava forzatamente unita in uno spazio ristrettissimo, in contatto continuo, ecercava naturalmente di affibbiare la responsabilità dei propri guai al caroprossimo.
Certamente non avrà contribuito alla mitezza dei costumi il vedere ogni tantopunire per le strade qualche donna ladra, o veder bruciare in piazza qualcheeretico o falso monetario. La povertà del basso popolo contribuiva a renderloinsensibile a queste scene, che anzi per esso erano come spettacoli. Frequentisono quei piccoli furti, che danno segno della miseria più grave: i furti d' untreppiede, d' una gonnella, d' un fuso. Il rubare in grande non si usava ancora;ma il cavare al prossimo quel tanto che fa comodo e che pareva avesse in più,era non meno usato d'ora. I contadini entravano nei boschi e nelle culturealtrui, per fare legna o per cavarsi il gusto delle frutta padronali; in città invecee nelle Masse i ghiotti tiravano sui piccioni e rubavano di notte i pesci dai vivai,

che pare allora non fossero rari nelle vigne e nelle culture entro le mura. Tuttoquesto certo non è segno di ricchezza.
LE STRADEI popolani soddisfacevano i loro bisogni per strada, con preferenza verso lachiesa dei Frati Predicatori e in Piazza del Campo; abitudine questa, della qualeriferisce ancora il Constituto del 1262, condannandola anche se in manierapoco convinta. Tutto si fa per strada. Tengono per strada il legname davendere; caricano per strada i muli; stendono per strada le cuoia da asciugare;scuotono per strada le vesti e le pelli. Anche i porci girano per le strade, manon in Siena soltanto.
Il turpiloquio poi può dirsi una specialità del Duecento; le donne soprattuttobestemmiano volentieri e sanno trovare certe ingiurie che pungono a sangue.Una vera passione è quella di gettare dalla finestra i cocci ed altre immondizie.Le fruttivendole e i pescatori del Lago vendono per strada la loro merce: frutta,cacio, uova, polli, starne, oche, piccioni; pesci preferiti sono lasche e anguille.
LE ABITAZIONISull'abitazione e sulle vesti dei popolani sono rimaste poche notizie. Noisappiamo quel che non avevano; ma di quel che avevano, sappiamo poco oniente. Cosi è certo, che andassero a letto senza camicia; e che vi dormisseroin due e più.
Sappiamo anche che la mobilia, nelle case anche ricche, consisteva appunto inun letto immenso e assai basso, con una predella e con le cortine moltoantiigieniche; mentre una tavola a tre piedi, uno scrigno, una panca e uncassone ferrato o dipinto completavano l'interno. Ma come fossero fatte questepoche cose, quali le particolari forme e l'arredamento, non si sa.
Molta parte delle case doveva essere di legno; di lì i frequenti incendi, e lafacilità di abbattere tettoie e ballatoi per la venuta di qualche grandepersonaggio. Gli incendi sono una delle preoccupazioni maggiori del Comune. Imagistri de lignamine e lapidis formavano un vero corpo di pompieri; ed ilComune si rendeva garante dei danni e persino della salvezza degli edifici.
Non giurerei che fosse molto diffuso l'uso delle finestre di vetro. Le finestreerano chiuse colle impannate e colle pelli di pecora, rese trasparenti con olio diseme di lino. Inoltre potevano serrarsi per mezzo di sportelli, fatti d'un pezzosolo, e che difendevano non tanto dal sole, quanto dai sassi e da altriavvertimenti amichevoli. I fornaciari ed i bicchierai, che costituivano un seriopericolo d'incendio per la città, furono banditi fuori del recinto delle mura.
LA SATIRA E LO SCHERNOQuel che forse maggiormente dava gaiezza all'ambiente era la satira, alla qualela gente senese mostrò allora una particolare inclinazione. Il poeta CeccoAngiolieri è il rappresentante più caratteristico del genere satirico popolare

del Duecento. Fu certo in vista di poeti come lui, che lo Statuto cittadino proibìle canzoni ingiuriose sotto pena di dieci lire.
Ma la satira non si limitava alla parola; essa si serviva pure del pennello peresprimere arditamente il suo pensiero. Nel 1264 il Capitano del popolocondannò alla forte pena di ventocinque lire un pittore, un tale VenturaGualtieri, del popolo di S. Egidio, per avere dipinto una lupa (emblema delComune) che feriva con la zampa un leone (emblema del Popolo) nella faccia,in modo che gli si vedeva uscire il sangue dal muso: satira politica delle più evidenti e che disegna mirabilmente l'indole dei tempi.
LA NOTTEDopo l'ora terza di notte tutti si ritiravano; né era permesso di girare per lestrade (ove regnava sovrano un buio profondo), a rischio di esser presi dallaronda. Quando nel 1255 si riformò il servizio dei Custodi di notte, siobbligarono i bottegai ad accendere qua e là qualche lampada a loro spese; main tutto non sono più di cinque o sei. Solo in Biccherna ed innanzi al Carroccioardevano a spese del Comune lampade eterne. Ma anche questi Custodi dinotte, giacché nessuno custodiva loro, non facevano sempre il loro servizio conmolto zelo; e nel 1233 una bella notte si addormentarono in sette, per cuifurono condannati tutti alla multa di dodici danari a testa. Quanto si fossegelosi di questa custodia di notte lo prova il divieto di mettere alcun fiorentinotra i custodi.
I privati provvidero in certo modo all'illuminazione, accendendo in strada,innanzi alle immagini della Madonna, le piccole lampade a olio, che alzavano edabbassavano prudentemente dall'interno della casa, come ancora oggi si vedefare in un certo cantone di San Pietro alle Scale. Accesa la lampada allaMadonna, neir interno della casa tutti certo si riunivano intorno al focolare, ementre fuori imperversava il tramontano, al lume fioco di una candela di sego,la nonna raccontava ai nipoti le leggende dell' origine di Siena e della stregaDiana, che gli antichi avevano adorato come una dea, e di quel San Galgano,che fu di certo un patrono di gente forte, quando fissò la spada nella rocciaviva, come narra la sua leggenda.
Finalmente dopo Terza era permesso di gettare dalla finestra tutto ciò chepareva e piaceva; purché si usasse la precauzione di avvertire con un «Ohe!»
LA SALUTENon credo poi che la salute di quelle generazioni fosse straordinariamentebuona. La mortalità era grande e le epidemie facevano strage. La grandeignoranza in fatto di medicina e di fisica contribuiva molto a questo stato dicose. Basta pensare che i malati, cacciati durante tutto l'anno dalla città, vierano riamessi appunto nei giorni della maggiore affluenza di gente: nellaSettimana santa.
Ad onore sommo di Siena però bisogna dire che assai presto si provvide a

queste necessità della vita colla fondazione dell'Ospedale e con la istituzione dimedici condotti. Sino dal 1250 il Comune stanziava tra le uscite fisse lo stipendio di un maestroche insegnasse allo Studio generale Arte medica; e non invano, giacché i feritiche tornavano dalla battaglia di Montaperti furono curati a spese del Comune.Una apposita Rubrica del Constituto provvide al caso non infrequente che ilchirurgo facesse difficoltà di ammettere il medico curante, dando ragione aquest'ultimo, almeno riguardo al consulto.
LA FESTALa loro allegria, rumorosa e schietta, prende tutti ad un colpo; e allora la festaviene da sé. Una leggenda antica, che vorrebbe dare un'idea della profondaconcentrazione intellettuale di Dante, racconta che egli, passando per lapiazza di Siena, entrasse in una bottega, e lì, aperto un codice, rimanessetalmente immerso nella lettura, da non accorgersi della festa che rumoreggiavain piazza.
Dunque le feste senesi erano celebri per il movimento e la vivacità della folla.Il Palio è stato descritto da molti, per cui, senza discorrerne, aggiungerò soloche lo Statuto del 1262 disponeva che nella festa della Madonna di Agosto lagente di città dovesse andare al Duomo, contrada per contrada, coi ceri accesi:tutti, anche quelli di fuori, ed eccettuati solo i poveri, i malati e quelli cheavessero inimicizie mortali. E veniva concessa l'impunità per le offese e feritearrecate dai fantini e da altri in questi giochi.
Per tre giorni prima e tre giorni dopo si teneva anche mercato in città: ed ilPotestà era obbligato a farlo bandire il primo sabato del mese di Agosto. IlPalio poi non era l'unico spettacolo per questa gente: il gioco della battaglia fuproibito fino dal 1262, ma si ripristinò malgrado il Constituto.
Non avevano teatri, seppure non avessero di già (in Duomo o in Piazza) iMisteri religiosi; ma avevano invece i giullari, ed il giuoco della pugna, e lefeste giorgiane, e ogni tanto un duello giudiziario in piazza. IL MATRIMONIOSeguiremo ora il percorso di due sposi novelli, che si preparano a scendere inpiazza, ove il notaro li attende per stendere il contratto matrimoniale. Giacchéanche questo, certo il più solenne atto della vita, si compiva in piazza, appuntoper dargli maggiore pubblicità.
Il corteo partiva da due punti differenti: lo sposo da casa sua, la sposa dallacasa di suo padre o del suo tutore, accompagnati, ognuno dei due, da non piùdi sette amici, più il giudice ed il notaro; in tutto quindi una ventina di per-sone. Cosi almeno voleva lo Statuto: ma pare che spesso qualchedunoinciampasse volentieri in una multa per aver oltrepassato quel numero sacraledi testimoni. In capo al corteo non mancava la musica; e per straforo siprestavano a questo servizio anche i trombettieri ed i suonatori di nacchere del

Comune, che vedeva di mal occhio questa infrazione alla sua dignità.
Si invitavano di regola anche i giullari. Essi non recitavano solo delle poesie,ma facevan anche dei giochi e delle burle, spesso arrischiate: per cui, chi intale occasione avesse bastonato un giullare, andava immune da pena. Il chedel resto non impediva ai giullari di fare i loro giochi talvolta ancora in chiesa edi sedere a tavola con i chierici.
Vediamo ora quel che succede in piazza. La sosta in piazza non è lunga, perchèil notaro ha già preparato da giorni il contratto e lo legge in fretta, alla brigataimpaziente. Dalla Piazza i due cortei, ormai riuniti, si muovono verso la casadello sposo. Un pregiudizio popolare antichissimo voleva che la sposa uscissedalla casa dei genitori mettendo il piede destro avanti, e cosi anche entrasse incasa dello sposo. Lì finalmente gli sposi possono ricevere gli amici ed icongiunti e chi altro lor piaccia, senza temere che alcun venga a contare ilnumero degli invitati, per denunciarli, a buon conto, ai Pretori ed al giudice delPotestà. Qui riceveranno i doni e le felicitazioni degli amici mentre i giullari e legiullaresse rallegreranno le brigate coi loro scherzi, in attesa dell'ora delpranzo; e qui li lasceremo tutti, augurando loro una buona digestione delcavolo col latte di capra, della gru e del pavone ripieno.
http://latestabenfatta.wordpress.com