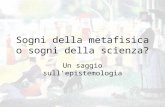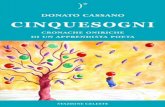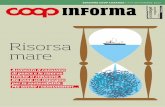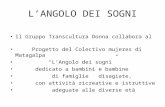COME CONSIDERARE UNA RISORSA UMANA UNA VERA RISORSA Padova, 27 giugno 2006.
La guerra dei sogni? L'immaginario come risorsa di genere
-
Upload
oliver-binetti -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of La guerra dei sogni? L'immaginario come risorsa di genere
-
7/31/2019 La guerra dei sogni? L'immaginario come risorsa di genere
1/10
1
Laguerradeisogni?LimmaginariocomerisorsadigenereAnnaLisaTota
Iodisegnosempre,anchequandononstodisegnandoperchstoscrivendooppuremiconcentroanonfarenulla[...].Lascritturaabolisceiltempo,comprimendoloodilatandolo.Neldisegnositrovalespressione pi concisa. [...]Spesso le rappresentazioni graDiche sono poesiedisegnate; e moltepoesiedescrivonocontorni,digradanoitonidelchiaroscuro.[...]LoperagraDicapiprecisa.Nonsifa ingannare dal suono delle parole. Il verso, rispetto allunivocit della linea, maggiormenteminacciatodallachiaccheradellepossibiliinterpretazioni.
GnterGrassdescriveilcomplessorapportotraparolaedisegno,ildelicatointrecciotratestoscrittoeimmagine.Perloscrittoresitrattadidimensioniespressivequasicomplementari,fortementeinterrelateereciprocamenteinDluenzate,checonservanotuttaviapeculiaritspeciDiche.Ildisegnoevocailpotereplastico dellimmagine con cui il testo scritto non in grado di competere. I disegni, cos come le
immaginipiingenerale,rimandanoa modalitpercettivee cognitiveche fannoappelloallestruttureemotivedellarappresentazionepiuttostocheaquellerazionali.PerquestosonocosefDicacineiprocessidilegittimazionesociale.Lintentodiquestoarticoloproprioquellodianalizzareilpoteresocialedellimmaginario,ilsuoruolospeciDicocomearenaincuicompetereperaffermaredifferentiinsiemidivalori,comeluogoespazioincuicostruire socialmente le soggettivite le identitcollettive. Tale prospettiva rimanda a contributiassai diversi, comela storiasocialedellimmaginario (LeGoff,1988; Gruzinski,1991), leriDlessioni dipsicologia fenomenologica sullimmaginazione (Sartre, 1948), lanalisi DilosoDica del rapporto traesistenza e simbolico da Cassirer (1961) a Lacan (1974)1, il contributo dellantropologia dellasurmodernit(Aug,1997a),glistudidiculturalstudies (Hebdige,1979;Agger,1992).La guerra dei sogni, o guerra delle immagini, rappresenta un terreno di riDlessione su cui si sonocimentati patrimoni disciplinari e categorie analitichemolto diversifra loro checondividonotuttavia,pur nella estrema variet delle prospettive, unattenzione comune alle forme generali di mediazioneattraversocuigliattorisocialidanno letteralmente forma alle loroWeltanschauungen ,ailorouniversipercettivi e discorsivi. Le immagini diventano letteralmente risorse attraverso cui negoziare ladeDinizionedel reale,spazioentrocuicompetereperdareformaallapropriasoggettivit. InfatticomesottolineaCrespi(1978,p.33),riprendendolanozionetecnicadisimbolicopropostadaCassirer,lamediazione simbolica ha anche sempre una dimensione costitutiva del soggetto. In tal sensolimmaginario ci che istituisce lordine del possibile e quello del probabile, strutturandomaterialmenteiconDinidicichesiamoo nonsiamoingradodipensare.Senzaimmaginiliononpupensare se stesso. Ogni forma di diseguaglianza sociale richiede repertori di immagini consolidatiattraverso cui legittimarsi. a questo punto di vista immagini impari non possono che descrivereopportunitdiseguali.1.Aicon4inidelmondo:antropologiadellimmaginarioeformesimboliche
Leimmaginirappresentanounodeiterrenifondamentalisucuicompeterepercostruiresocialmenteleidentit. A questo proposito Aug (1997a, p. 11) in La guerra dei sogni introduce la nozione dicolonizzazione dellimmaginario, descrivendo come lo scontro fra popoli si sia spesso accompagnatoallurtofraimmaginari:
1Sulla concezione lacaniana di immaginario e sul rapporto tra immaginario e simbolico si veda Lalli (1995).
-
7/31/2019 La guerra dei sogni? L'immaginario come risorsa di genere
2/10
2
Lantropologia si interessata allimmaginario individuale, alla sua negoziazione perpetua con leimmaginicollettiveeancheallafabbricazionedelleimmaginiopiuttostodeglioggetti(chiamatiavoltefeticci)chesipresentavanoallostessotempocomeproduttoridiimmaginiedilegamesociale.Gliantropologi,inoltre,hannoavutooccasione(...)diosservare,attraversosituazionidettepudicamentedicontatto culturale, come lo scontro fra immaginari accompagnasse (...) le conquiste e lecolonizzazioni,comeleresistenze,iripiegamenti,lesperanzeprendesseroformanellimmaginariodeivintiperaltrodurevolmenteintaccatoe,insensostretto,impressionatodaquellodeivincitori.
SecondoAugunaculturavivasoltantonellamisuraincui,incontrandosioscontrandosiconlalterit,riesce a trasformarsi, a mettere in gioco i suoi processi di simbolizzazionee istituzionalizzazione. Laculturainfattiserveanchearendereiprocessidiproduzionedelsensopensabili(attraversoilricorsoasimboliche laculturastessa mette a disposizione) e gestibili (attraverso leistituzioni).Lanalisidellasurmodernit, cuigranparte dellavorodellantropologo francese rimanda,concerneprincipalmente imomenti di contatto culturale,quando linsieme delle forme simboliche e degli immaginari di popolidiversisiincontrano.Talimomentirappresentanofasicrucialiedelicateincuisiridisegnanoleidentitelealteritdiunpopoloodiungrupposociale,incuisimettonoanudolerelazionitrasognoepotere,traimmaginaridominantieimmaginaricolonizzati.Gruzinski(1991)analizzailconDlittoditipocolonialechevedecontrapporsinelMessicodel XVIsecoloigesuitiegliamerindi.UntrattocaratteristicoditaleconDlittoconcernelaconversionedegliindiosalle
immaginicristianeadoperaprimadegliordinimendicantiesuccessivamentedellaCompagniadelGes,chescatenaunaveraepropriaoffensivacontrolesperienzavisionariadegliindios.Lerappresentazionidellimmaginario cristiano estirpano a poco a poco tutta liconograDia locale. Sono alloperacontemporaneamentesquadronidipittori,discultori,diteologiediinquisitori(ivi,p.189).Lealternevicendedellacolonizzazionesonoripercorseattraversolanalisidellacontrapposizionetradueimmaginimariane:NostraSignoradi GuadalupeelaVerginedeLosRemedios.LostudiodiGruzinski,coscomequello di Le Goff (1988) sullimmaginario medioevale, documentano la centralit del ruolo degliimmaginarinellariproduzionesocialedelleculture:neivaricontestistoricosocialisonoalloperavereepropriepolitichedellimmaginazione,piomenoarticolate,piomenonormate.Senelpassatoilmonopoliodellimmaginario statogestitosoprattuttodallaChiesache,attraversolecommittenzeartistiche,ha inqualchemodotesoa conservareun controllosullemodalitsocialidellarappresentazione, nella societ contemporanea lo scenario diviene pi complesso. Tale funzione di
controllopassaattraversoimassmediacheDinisconoperagirecomecassedirisonanzadelleesigenzedimercato.AprezzodiunadrasticasempliDicazione,sipotrebbedirecheconlavventodeimassmediaelaloroprogressivadiffusioneilmonopoliodellimmaginariopassadalleistituzionipoliticheereligiosealmercato. Ovviamente non si intende misconoscere il ruolo attivo di altri fonti di rielaborazione eproduzionedellimmaginariosocialecomplessivo,masoltantofocalizzarelattenzionesulladiscontinuitche i media hanno introdotto nelle forme simboliche di mediazione. Tale passaggio infatti profondamenteinDluenzatodallelogichesottesealletecnologiedellacomunicazione.AquestopropositoThompson (1995, trad. it. 1998, p. 54), riDlettendo sulla mediazione delle forme simboliche nellamodernit,afferma:
OltreadaveremodiDicatoilnostrosensodelpassato,imezzidicomunicazionehannoanchecreatoquellochepotremmodeDinireunmondomediato:leformesimbolichemediateplasmanosemprepisia la nostra conoscenza delluniverso che si trova al di l della sfera di ci che sperimentiamo
personalmente,sialenostreideesulleposizionicheoccupiamoinesso.OltrequindiariDletteresullacentralitdellimmaginariocomerisorsadicoesionee/odiscontrosociale,la chiave di lettura qui proposta si interroga sulle trasformazioni che caratterizzano i processi diproduzione simbolica nella societ dei media, sottolineando come queste ultime abbiano un impattodecisivo sulle modalit attraverso cui gli attori sociali possono concepire le loro soggettivit e fareesperienzadelmondo.Coscomenelle situazioni di contatto culturale lo scontro frapopoli si accompagna alla guerra deisogni,analogamentesipusostenerecheancheloscontro/incontrofraigenerinonpuchegiocarsi
-
7/31/2019 La guerra dei sogni? L'immaginario come risorsa di genere
3/10
3
anche sul terreno delle immagini. In tale prospettiva infatti, limmaginario appare come magazzinosimbolicoacui attingereper daresensoalle identit,per elaborarele rappresentazionisocialicon cuimisurarcinellaquotidianit.Imutamenticheinvestonotalesfera,lungidallessereaccessoriomarginali,sonodestinatiadavereripercussioniprofondesullassettocomplessivodiundatocontestosociale.Seplausibile che lordine del possibile sia scandito dalle sequenze delle immagini a disposizione perpensarlo,altrettantoplausibileguardareallastoriadellediscriminazionietniche,digenereediclasse
comestoriadelleimmaginimancate.Lametaforapiappropriataperproseguirequestaesplorazionedeimarginiquelladellimmaginerubata.2.Nomadismoculturale,homelessness eimmaginaricolonizzati
Ripartiranno per visitare altri castelli, ascoltare altre guide; acchiappare frammenti di leggenda eframmenti di storia.Sanno che lessenziale nel movimento,che bisogna girare intondo per darsilimpressionediavanzare,poich,dopotutto,laTerrarotondaedsulbordodellastrada,allasvoltadelcammino,nonimportadove,nonimportaquando,persinonelmezzodiunviaggioorganizzatocheabbiamo tutti una possibilit dincontrare il Graal, la principessa o il principe azzurro. Siamo tuttidiscendentidiParsifalediWaltisney(Aug,1997b,trad.it.1999,p.678).
ComesiconDiguralimmaginarionellamodernit?E,soprattutto,comedialogaconlenostresoggettivit
senzadimora(Berger,1992),conilnomadismopostmoderno(Braidotti,1994)?Questisonoalcunidegliinterrogativi che attraversano la presente riDlessione, nella consapevolezza di rappresentare perlopidomandeurgenti,masenzarisposta.Intalsensolachiavediletturaquipropostacollegalanalisidellanatura dellesperienza prodotta dalle quasiinterazioni mediali (Thompson, 1995, trad. it. 1998, p.290)allhomelessness eaisoggettinomadi,cercandodimostrarecomesitrattididueprocessispeculari,strettamenteconnessieinterrelatitraloro.Nellamodernitinfattiassistiamoaldiffondersidinuoveformediesperienzadelquotidiano:
Viviamoinunmondo,oggi,incuilacapacitdifareesperienzesiseparatadallincontro.Ilsequestrodellesperienza dai luoghi spaziotemporali della nostra vita quotidiana va di pari passo con ladiffusionediesperienzemediate,conilmescolarsidiesperienzechelamaggioranzadinoivivediradoinprimapersona(ivi,p.291).
Questo tipo di quasiesperienze mediali attinge ad universi di enunciazione che sono sempre piomologati, sempre pi globali e sempre pi distanti dalle nostre esperienze reali. O meglio, gliimmaginaripropostidaimediasonotantomenoattinentiallanostraquotidianitquantopisonofruttodiprocessidicolonizzazione.InBeverlyHillslostereotipodimadrerappresentatodaunavvenentesignoradivorziatache,dopoalcunetraversiedovuteallabusodicocaina,incontraDinalmenteunnuovogrande amore e decide di risposarsi.Lo scollamento radicaleche comespettatori televisivi possiamoavvertirerispetto aquestotipodirappresentazionedella Diguramaterna seriferitoallarealtitalianaderivaappuntodalfattochesiamoinpresenzadiprocessidicolonizzazionedelleimmaginiche,nelcasospeciDico, derivanodalla produzione televisiva e Dilmica statunitense. Ci che vale la pena comunquesottolineareconcerneilcarattereomologantediquestotipodirappresentazioni:sonolontanissimedainostristereotipi,ciparlanodimadrichenonconosciamoechedubitiamodiincontrareaspassoperlenostrecitt etuttaviaci paionointime,normali,quasinaturali. proprioilprocessodicolonizzazione
checipermettedisostituireildisagioculturalechedovrebbederivaredalladiscrepanzatraglistereotipimessi in scena e quelli che ci sono propri, con una sensazione di naturalezza e aproblematicit. Ilprocessodicolonizzazione tantopiriuscitoinfattiquantopi ingradodi occultarelo scontrofraimmaginari in atto. Come ricorda Aug, la guerra dei sogni cessa quando le vittime subiscono einteriorizzanolafascinazionedellimmaginariodeilorooppressori.Lesperienzadellaculturafraduemiti, di cuiparla Aug, datain ultima analisidallincontro/scontro trale mammediBeverlyHills equellenapoletane,unpopinostrane,di Unpostoalsole .La tendenza allomologazione progressiva degli stereotipi sociali messi in scena dai media tuttaviacontrobilanciata da una tendenza di segno opposto: quella relativa alla proliferazione e pluralit dei
-
7/31/2019 La guerra dei sogni? L'immaginario come risorsa di genere
4/10
4
messaggi mediali che ampliDicano in modo esponenziale le immagini disponibili. Come osservaThompson(1995,trad.it.1998,p.295)infatti:
Aprendoilsanuoveformediconoscenzanonlocaleeadaltritipidimaterialisimbolicimediati,losviluppodeimediaarricchisceeaccentualasuaorganizzazioneriDlessiva.Laarricchiscenelsensoche,accedendoaformedicomunicazionemediata,gliindividuipossonocostruireillorosutilizzandoun
insieme di risorse simboliche sempre pi abbondante. Come i materiali simbolici scambiati nelleinterazioni faccia a faccia, anche quelli mediati possono essere incorporati nel processo diautoformazione; il s si trasforma dunque in un progetto riDlessivo nel corso del quale lindividuoincorporamaterialimediati(tralealtrecose)eliinserisceinunraccontoautobiograDicocoerenteecontinuamenterivisto.Manonsolo:cichelosviluppodeimediafaancheapprofondireeaccentuarelorganizzazioneriDlessivadels:infatti,viaviachelerisorsesimbolicheadisposizionedelprocessodiautoformazione aumentano, gli individui scoprono nuove possibilit, allargano i loro orizzonti ecambianoiloropuntidiriferimentosimbolici.
Ne deriva quindi una tendenza allomologazione crescente che tuttavia non mai compiutamenterealizzata.Sedalpuntodivistadellaproduzionecidovutoalproliferaredeimessaggidisponibiliche,datalanumerosit,difDicilmentepotrebberoesseretuttiuguali,dalpuntodivistadellaricezionecisidevealruoloattivodeiprocessididecodiDica.Aquestaomologazioneprogressivadeglistereotipisociali
messiinscenadaimezzidicomunicazionedimassagliutentimediali,infatti,rispondonotuttaltrochepassivamente,comehannodocumentatolericerchediMorley(1986)nelDilonedella receptiontheoryequellidiMoores(1993)inrelazionealletnograDiadelconsumomediale.propriointalsensochepossiamoleggereilnomadismoculturalecomelaltrafacciadellimmaginariocolonizzato.Lepratichedegliintervalli,delleinterfacceedegliinterstizi,dicuiciparlaRosiBraidotti(1995,p.9),rappresentanorispettoallomologazionelaltrafacciadellamedaglia:nelleserciziodellamarginalit,nellafrequentazionedelleareeditransito,nellacollocazioneaiconDinidelmondochesisovverte lordine omologante degli stereotipi mediali. In tale prospettiva lio senza dimora sembrarisponderealladelocalizzazionedellesperienzaprodottadaimediaconladelocalizzazioneconsapevoleeriDlessivadeisuoistessiconDini.innanziadunimmaginariocheciapparesemprepicolonizzatolepratichediresistenzapiefDicaciconsistononelcollocarsiaimargini,nellaframmentazionedeirepertoridisensopreDigurati,nellafrequentazioneconsapevoledialtriimmaginaripossibili.3.Soggettivit,interpellanzaetecnologiedigenere Come si declinano immaginario colonizzato e nomadismo culturale rispetto alle questioni poste dalgeneredellutentemediale?Opiprecisamente,cosacomportainambitomedialeilriconoscimentodellanaturasessuatadellinguaggio?Lateoriapoststrutturalista,partendodaunacriticaradicaledellaneutralitdel linguaggio, lo deDinisce come arena conDlittuale e antagonistica dove si producono e si legittimano leidentit.Ilgenere,intaleprospettiva,rappresentasoltantounafraleareedellesperienzasociale,chenonesaurisceovviamentetuttigliaspettidellasoggettivit.Gliattorisocialisonocostituitidalledifferentipratichesocialiedaidifferentilinguaggicheutilizzano.ComesottolineadeLauretis(1996,p.120)infatti:
il soggetto si costituisce nel linguaggio (...) ma non soltanto attraverso le differenze sessuali, bensattraversoledifferentipratichediscorsiveelediverserappresentazionisociali;(...)unsoggettoquindi
nonunivocomamultiplo,enontantodivisoquantopiuttostoindinamicacontraddizione.TalenozionedisoggettivitrielaboratadavanZoonen(1994),chedeDinisceilgenerecomecollezionedirappresentazioni culturali concorrenti e talora contraddittorie e di signiDicati simbolici antagonistici, tutticonnessi allelaborazione sociale della differenza sessuale. In questa prospettiva, il genere diviene partecostitutiva di una cultura, un set di pratiche sociali e discorsive a cui gli attori sociali sono socializzati econtinuamenterisocializzatidurantetuttelefasidellalorovita.Inquestosenso,lanozionepiappropriataquelladel lifelonglearning (Balbo,1995):lidentitdigenere,seconcettualizzatacomecostruttolinguisticodiscorsivochesirealizzaattraversopratichesocialielinguistiche,frammentataedinamica;unprocessoin
-
7/31/2019 La guerra dei sogni? L'immaginario come risorsa di genere
5/10
5
Dieriincuigliattorisocialisonoimpegnatiintuttelefasidellavita.GuardareaimediacometecnologiedigeneresigniDicainprimoluogoanalizzarelalorofunzionediagenziedisocializzazione.Nonsitrattatantodistudiarecosaimediafannoallepersonequantopiuttostocosalepersonefannoconimedia.Unavoltamessiinconnessionetesticulturaliemodidipensarelasoggettivit,unavoltaesplicitatiinessichearticolanoeleganoleidentitconglioggetticulturaliemediali,imediaeleistituzioniculturaliriacquistanolalororilevanzacomeistanzeingradodiinDluenzareattivamenteleissuesfondamentalideldiscorsopubblico.
Le pratichedella produzionee del consumo culturale diventano concretamente luoghi in cui progettare ilcambiamento sociale, spazi a cui ancorare la riDlessione sul possibile, inteso come ambito in cuilimmaginazionesocialeesercitasestessa.Adunapubblicaletturadellesue poesieallaStanfordUniversityAudreLordeesordpio menoconquesteparole:sonounafemminista,nera,lesbica,guerriera,poetessa,madre,chefailsuolavoro(...)evoichisieteechecosafate?2.UnappellocheemblematicodiunpercorsodiriDlessionesullateoriafemministaesullesuepossibili implicazioniper lanalisidei testiculturalie mediali.A partireda unattodi negazione e dirivoltarispettoadunaculturadeDinitadal patriarcatodegliuomini,ledonneinizianoa riappropriarsi deglioggetticulturaliemedialisecondounotticanuova.Eallora,comediceLynnePearce,cisonoquadrichenonvorrestepossedereealtrichevorrestesbeffeggiare,perchcontinuanoaparlareillinguaggiodelladiscriminazione.Eancora, ci sono soap opera che propongono protagoniste cos emancipate da non piacere al pubblicofemminilechenonriesceariconoscersi(comedocumentanoalcunericerchesullafruizionedelletelenovelasinBrasile)ealtrechecontinuanoinveceaproporreimmaginidigenerestereotipate.
Il decostruzionismo femminista si riappropriato in vari modi di una cultura declinata al maschile,decostruendoqueicanonichetradizionalmente hannoesclusotutte ledonne, oalmenola maggiorpartediloro,trasformandoiltalentodiartiste,poetesse,scrittriciescienziateinquellodimutemuseispiratrici.Tuttesorelle,madriemoglidiShakespeare,perriprendereunesempiocaroaVirginiaWoolf,chesiispirallatristevicendadellagiovaneJudithShakespeare,mortadipartosenzapassaremaiaiposteri.Intaleprospettiva,larte e la cultura funzionano al pari di altri media come tecnologie di genere, come possibile luogo distrutturazione delle nostre identit femminili e maschili. etto altrimenti, i media, larte e la cultura ciappaionosessuatisianellepoeticheconcuisonoprodottieallestiti,sianellemodalitconcuisonoconsumati(Tota,1999a;1999b).VolendodeDinireildecostruzionismofemminista,sipotrebbedirecheunacorrenteintellettualeepoliticacheanalizzalerappresentazionitestualidellidentitedelcorpopropostedalcinema,dairomanzi,daimediae da tutti gli artefatti culturali, a cui gli attori sociali femminili e maschili devono poi, pi o menoconsapevolmente,attingereperpensareenominaresestessi.Laprospettivaincuilaquestionesideclina,
propone nuove chiavi di lettura, in grado di permettere alle minoranze culturali e sociali di negoziare lapropriaidentitconlaculturadominante.bellhooks,adesempio,uninterpretemoltooriginaledellaculturacherappresenta:ilsuointentosvelareimeccanismiideologiciattraversocuiiprodottiartisticieculturalivengonoacquisitiinconsapevolmentedagliattorisociali,dandoluogoaveriepropriprocessidiacquiescenzaeacculturazione.Leimmaginidigenereequelledietniasonoproblematizzatedallautriceattraversolanalisidellerappresentazionimedialidelcorponudodiunadonnanera.Lariappropriazionesimbolicaditalecorpopassaancheattraversola contestazionedi unimmaginariotuttobianco, eterosessualee maschile. bell, chescrive provocatoriamente il suo nome in minuscolo, unoriginalissima intellettuale nera che rappresentalarea radicale della cultura progressista newyorkese. In reel to real, un libro del 1996, propone ladecostruzionefemministadellerappresentazionidelcorpofemminileneroattraversolanalisideitestiDilmici.Lideasottostantecheilconsumodiprodotticulturalicostituiscaunadelleareeprivilegiateacuigliattorisociali attingono per lelaborazione della loro soggettivit. In tale prospettiva veicolare nuove pratiche diconsumo e nuovi signiDicati assume una valenza quasi sovversiva rispetto allideologia consolidata,riprendendoincialcunedelleimplicazionipirilevantidellapprocciodeiculturalstudies.In generale, i livelli a cuipossiamo guardare per analizzare il contributo deldecostruzionismo femministasonoalmenotre:illivellodellarappresentazioneacuiprincipalmentesisitualanalisidellaculturaedeitestimedialicometecnologiedigenere,illivellodellaproduzioneculturaleeartistica(nelduplicesensodiungeniotuttodeclinatoalmaschileedelleffettivaesclusionedelledonnedaivariambitidiproduzioneartisticoculturale)e, inDine, illivellodellaricezione, ciodelconsumoeffettivo dapartedelledonnedi prodottiche
2cit. in Teresa De Lauretis (1996, p. 34).
-
7/31/2019 La guerra dei sogni? L'immaginario come risorsa di genere
6/10
6
parlano soltanto al maschile. Ripercorrere tutto lintreccio che ha collegato nei vari approcci disciplinari igender studies allanalisi della cultura esula evidentemente dagli intenti di questo contributo; pilimitatamente possibile delineare alcune delle questioni fondamentali che tali metodologie sollevanorispettoallanalisideitesticulturaliemediali.UnanozionecertamentecentraleinquestotipodiriDlessionesideve a Teresa e Lauretis che, rielaborando criticamente la nozione di tecnologia del sesso proposta daFoucault,introducelanozioneditecnologiadelgenere:
SipotrebbeiniziareapensarealgenereprendendospuntodaMichelFoucault,dallasuateoriadellasessualitcometecnologiadelsesso,perproporrecheancheilgenere,siacomerappresentazionesiacomeautorappresentazione,vengaconsideratoilprodottodivarietecnologiesociali,comeilcinema,edidiscorsiistituzionali,epistemologieepratichecritiche,nonchdipratichedellavitaquotidiana.(eLauretis1996,p.133)
La costruzione del genere, in tale prospettiva, ha luogo non soltanto negli apparati ideologici di stato pitradizionali (come la scuola e la famiglia), ma anche nellincontro con i messaggi mediali, con i prodotticulturali,conleoperedarteepersino,ricordalautrice,conlariDlessionefemminista.Selideologiacostruiscegliindividuiinquantosoggetti,ilgenerehalafunzione(...)dicostituireindividuiconcretiinquantouominiedonne(ivi,p.137).RiferendosisiaallavorodiAlthussersiaaquellodiFoucault,TeresaeLauretis(ivi,p.14153)partedalpressuppostoche:
la rappresentazione sociale del genere incida sulla sua costruzione soggettiva e che, viceversa, larappresentazionesoggettivadelgenere(oautorappresentazione)incidasullasuacostruzionesociale(...).Lacostruzionedelgenereprosegueoggitramitelevarietecnologiedelgenere(comeilcinema)eidiversidiscorsiistituzionali(comelateoria),ehailpoteredicontrollareilcampodelsigniDicatosocialeequindidiprodurre,promuoveree impiantarelerappresentazionidelgenere.Ma esistonoancheiterminiperunadiversacostruzionedelgenere,aimarginideidiscorsiegemoni.Anchetalitermini,provenienti dallesterno del contratto sociale eterosessuale e iscritti nelle pratiche micropolitiche,possono avere unruolonellacostruzionedelgenere, incidendo soprattuttoal livellodelle resistenzelocali,nellasoggettivitenellautorappresentazione.
Sicreanocosipresuppostielecondizionieffettiveperunospazioincuiarticolarelantagonismo,siintravedeuno spazio pubblico per dar voce al silenzio delle donne, per avviare un progetto culturale e politico di
riappropriazione di un immaginario culturale e simbolico che parli e ascolti al femminile. Gran parte dellavoro deifeminist cultural studies, deifeminist media studies e della reception-theory va proprio in taledirezione.Unavoltapropostalanozioneditecnologiadelgeneresiapronotuttaviaunaseriediinterrogativicruciali, per comprendere processualmente la costruzione del genere. Se si adotta infatti la nozionealthusserianadiinterpellanzaintesacomeilprocessoattraversoilqualeilsoggettointeriorizzaefapropriaunadatarappresentazionesociale,cheacquisisceperciconsistenzareale,anchesedifattoimmaginariarestadachiarirecomeincidanoinquestoprocessoledifferentitecnologiedigenere(ilcinemaversuslateoriafemminista, per intenderci) ed inoltre resta da spiegare perch dinnanzi a differenti e contradditorierappresentazioni di genere circolanti in societ il soggetto(femminile,ad esempio) si appropri proprio diquella.Ponendosilucidamentetaliinterrogativi,TeresaeLauretis(1996,p.147)proponeditornareallateoria dellapparatocinematograDicoe diesplorare ilrapporto spettatorialedal punto divistafemminile:imodiincui ilDilmsirivolge aognisingolospettatore,i modiincui lasuaidentiDicazionevienesollecitataestrutturatanelsingoloDilm,sonointimamenteeintenzionalmente,anchesenonesplicitamente,connessialgeneredellospettatore..La questione del perch un certo soggetto, in particolare quello femminile, si appropri di una certarappresentazionesocialeenondiunaltrarimaneparzialmenteirrisolta,anchefacendoriferimentoallateoriadiWendyHollwaychedeDinisceilpoterecomecichespiegherebbelinvestimentodelsoggettoinunacertaposizionediscorsiva.Siprecisaanchechetaleinvestimentononnecessariamenteconscioorazionale.Larealt tuttavia un po diversa: si tratta quasi sempre di un investimento tacito, inconscio e perlopiirrazionale che pu avvenire sia, ad esempio, nella direzione di una rappresentazione mediale altamentesessista della donna sia nella sua rappresentazione nei termini della teoria femminista. Il vero problema,ancora una volta, ha a che fare con il concetto di probabilit: quante sono le rappresentazioni sociali
-
7/31/2019 La guerra dei sogni? L'immaginario come risorsa di genere
7/10
7
disponibilie dichetiposono?Non dettoche ilsingolosoggettofemminileinvestanecessariamenteinunacerta posizione discorsiva,se essa maggiormentediffusanellimmaginario complessivo o neldiscorso sulgenerecircolanteinsociet,maleprobabilitchelofacciaaumentano.Seragioniamointerminidiprobabilit,ci precludiamo forse di comprendere lesperienza di interpellanza del singolo soggetto, ma possiamocomprendere meglio il trend complessivo, cio lesperienza media. Si potrebbe obiettare che lesperienzamedianon esiste se non nella percezione dei sociologi, dei matematici e degli statistici.Tuttavia le medie
continuanoarappresentareunutilestrumentodicomprensionedellarealtsociale.A partire dalla nozione di tecnologia di genere, elaborata compiutamente gi nel 1987, si sono avviateriDlessioni e ricerche nei vari ambiti della produzione culturale e mediale, al Dine di documentareempiricamente lintreccio tra rappresentazioni sociali di genere e rappresentazioni soggettive (oautorappresentazioni).Ilcontributofemministaintaledirezionesipropostocomenuovoparadigma(vanZoonen,1994),ingradodiconvincereledonne(eanchegliuomini)adinvestireinposizionidiscorsivenonegemoniche.Intalsensounfattochequestiapprocci,piomenoesplicitamente,hannomessoinagendaladiffusionedinuoverappresentazionisocialidelgenere,partendodallaconsapevolezzachelastessateoriafemministafunzionadatecnologiadigenere.In particolare, i feminist cultural studies hanno promosso una vera e propria rivoluzione nella coscienzafemminileattraversounametodologiachesi ispirainparteallepratichedi autocoscienza.In questocasositrattadipromuoverelautocoscienzarispettoatesticulturali.Intaleprospettivasiipotizzato,avvicinandosialla posizione poststrutturalista, che lidentit di genere fosse un testo fra gli altri, formato mediante
lintersezione,lunioneo lapartizionecon altritesti chepossonoessereartistici(unromanzoo unquadro),relazionali(lasessualit,lamicizia),istituzionali(lascuola,luniversit).Immaginarequestodialogo\scontrofratestiunametaforautilepergettareunadiversalucesuiprocessiingioco,apattotuttaviadinonperderedivistailfattocheledinamicheeffettivehannopoia chefareconlasoggettivitenonsonocertoriducibiliallanozioneditesto.AtalDineunutileespedienteretoricoquellodiricorrerealconcettodipraticatestuale:questadeDinizionemipareparticolarmentefelice,perchmetteinsiemeidueterminidellaquestione.Sedaunapartesi riferisce chiaramenteai soggetti cheattivanoe interpretanotalipratiche,dallaltrarimanda alfattochetalipratichesonopredeDinitedalleistituzionientrocuihannoluogo..Pensieridisegualiperdiseguaglianzereali:lastrati4icazionesocialedelsimbolicoSe i media funzionano davvero come tecnologie di genere, fornendo alcune delle risorse simbolichecrucialiperlaproduzionedeisigniDicatiattribuitialledifferenze,occorreriDletteresullenuoveformedidiseguaglianza espressiva e simbolica che caratterizzano la societ contemporanea. In tal senso unadimensioneanaliticaefDicaceconcernelinsiemedirepertoriconsolidaticheiprodottimediali,culturalieartisticimettonocontinuamenteadisposizionedegliattorisocialiperpensarelarealtelasoggettivit.Ilfocusquindiquellodelrapportotrarisorseidentitarie,dicuigliattorisocialidispongonoallinternodiunadataculturapercostruireleimmaginidigenere,eidentitsocialiattualizzate.Atalepropositoutiletenerecontodegliampigradidilibertentrocuigliattorisocialiinterpretanoitesti.Ladistinzionetra risorse identitarie e identit attualizzate rende conto a livello analitico proprio di questo scarto:nessunaidentitdifattomairiducibileaduninsiemeditesti.Occorresempreunattoresocialecheattualizzitalitesti,liinterpreti,licomponga,licolleghifraloroproducendoneisigniDicati.Sarebbedeltutto fuorviante pensare che, rispetto al genere, le immagini prodotte, ad esempio, dal cinemastatunitenseodallaletteraturarosasianoassunteindiscriminatamente:inprimoluogo,gliattorisocialidispongonoanchedimoltealtrerisorseperindividuarsiquellemesseloroadisposizionedeglialtri
apparatiideologicidistatoe,secondariamente,sonoingradodiprodurreelaborazioneassolutamentesoggettivenei loroprocessidi signiDicazione,conun numero Dinito,maassaiampio digradidi libert,comehannobendocumentatomoltericerchenelDilonedeiculturalstudies(Agger,1992).Questotipodiimpostazionihapermessodiprendereledistanzedaconcettualizzazionivoltearidurreisoggettiapassivicontenitoridimessaggiculturaliemediali(pensoacerteposizionivicineallascuoladiFrancoforte),mainalcunicasihaapertolastradaadipotesialtrettantofuorvianti:comeadesempiolipotesisecondocuiiconsumatoriditestimedialisonosempreutentiiperattivi,capacididecodiDicareimessaggisecondopercorsidisensonecessariamenteinnovativieinusitati.Verieproprisuperutentimediali,immunidaogniformadimassiDicazione.Gliapproccipirecentinellecomunicazionidimassa
-
7/31/2019 La guerra dei sogni? L'immaginario come risorsa di genere
8/10
8
hanno segnalato i rischi impliciti in entrambe le concezioni. Se da una parte gli approcci pluralistitendonoaconsiderarecomeneutralelimpattodeimediasullavitapubblicaedemocraticadegliattorisociali sottovalutandone di fatto le inDluenze speciDiche, dallaltra gli approcci critici tendono adenfatizzarelinDluenzanegativadeimediache,intaleprospettiva,rappresenterebberoesclusivamentegliinteressidominantiascapitodellavitademocraticadeicittadini.Rispettoallanalisidellerisorseidentitarieevidentecheilmodoincuisidecidedirappresentareil
rapportotramediaeconDigurazionidellospaziopubblicogiocaunruolocruciale.Lapprocciopluralistaallanalisidellecomunicazionidimassa(Sigal,1973;Gans,1979)sembraaverampiamentesottovalutatolapotenzialedistorsionecheimediapossonoarticolareallinternodellospaziopubblico;daltraparteicontributipirecentidelDilonepostmodernista(Ang,1985;Fiske,1989)sedaunapartehannobendocumentato il cosiddetto potere semiotico dei soggetti, dallaltra hanno anche adombrato unadeDinizionediutentemedialenoncorrispondenteallarealt:inalcuneversionipiradicalidelDilonepostmodernistasimetteinscenaunutenteidealizzato,pienodispiritocritico,capacedidecodiDicareinmaniera innovativa qualsiasi messaggio. Il limite ovvio non sta tanto nellattribuzione di tali qualitallutentemedialequantonellageneralizzazionechesenepropone:lanozionediteleutenteinformato,criticoeinnovativodescriveunatendenza,untipodiutentecheprogressivamentesivadelineando,nonsi riferisce al tipo medio. Sarebbe fuorviante ipotizzare che questo tipo di utente sia egualmenterappresentativodituttelecategoriesocialidellapopolazione.Lafrequentaredeimargininonpuancoraconsiderarsicometendenzadiffusaeconsolidata.NeldibattitosulrapportotramediaesferapubblicauntentativodimediazionefralapprocciopluralistaealcunederivedelDilonepostmodernistasideveaKeane(1991)cheaffrontalaquestionecercandodiradicare i media nella societ civile, non enfatizzando n il ruolo dei media come manipolatori delconsensonquellodegliutenticomesupereroidelprocessointerpretativo.Inaltri termini, sedaunaparteirragionevoleimmaginarechelinDluenzadeimediasianeutralizzatadallascopertadellinDinitopotere semiotico dellutente, dallaltra sarebbe altrettanto fuorviante ipotizzare che la capacit dielaborazione individuale sia egualmente allocata fra gli attori sociali e che pertanto lesistenza e ladiffusione di repertori diimmaginisessisti,accompagnata dalla mancanzadi unestesa circolazionedicontroimmagini altrettanto efDicaci, non abbia alcune implicazioni sociali, sulle quali valga la penariDlettereinundibattitosulleformedidiseguaglianzaediesclusionesocialecaratteristichedellapostmodernit.In talsenso unimportante riDlessioneinvesteglistatutistessi dellaproduzionemediale:sitratta di interrogarsi sulla legittimit di una produzione che pu continuare a proporre immagini di
genere (ma anche di etnia) discriminanti, avvalendosi deldiritto\dovere di riproduzionedello statusquo.Restadachiedersiinprimoluogosecisiaunsaldopositivoonegativotraleimmaginidigeneremesse a disposizione degli attori sociali e le modalit in cui essi costruiscono le loro soggettivit e,secondariamente,quantotaledivariosiasostenibileallinternodelledemocraziecontemporanee.5.Immaginariosocialeeimmaginariomediale:qualcheri4lessionesulcasoitaliano
Proprio partendo da queste riDlessioni, diviene importante provare a ragionare sullimmaginario digenereinItaliaesullemodalitconcuisitrasformatonegliultimidecenni.Occorreinterrogarsisucome sono cambiate le immagini e le rappresentazioni mediali di genere cui attingiamo nella vitaquotidiana. Perpensarsi,nominarsi ed individuarsi, gliattori socialidi quali materiali dispongono?Ecertamente vero che i repertori di immagini a disposizione sono mutati profondamente negli ultimi
decenni, ma forse sono cambiati meno di quanto ci aspetteremmo. innanzi ad un panoramacomplessivo cos ricco di stimoli e innovazioni come quello italiano, limmaginario disponibile nellasocietsembrarimanereancoratoavecchiclich,chenonsonopiingradonemmenolontanamentedirappresentare la realt. Permane una sorta di scarto tra le rappresentazioni dei ruoli femminili emaschili offerte da gran parte della pubblicit, della;iction e di molti altri ambiti della produzionemedialee culturalee laquotidianitdicuidonnee uominifannoesperienza.Tuttiquesticambiamentipositivi,chehannosegnatocosprofondamentelavitaquotidianadelledonneedegliuomininegliultimidecenni, sembrano aver avuto soltanto uneco sbiadita nelle immagini di genere che continuano acircolare nella societ italiana. Non a caso, ogni volta che un prodotto mediale (penso alle recenti
-
7/31/2019 La guerra dei sogni? L'immaginario come risorsa di genere
9/10
-
7/31/2019 La guerra dei sogni? L'immaginario come risorsa di genere
10/10
10
BergerP.L.(1992),RobertMusileilsalvataggiodas,trad.it.acuradiP.Jedlowski,Rubbettino,SoveriaMannelli.
BraidottiR.(1995),Soggettonomade.Femminismoecrisidellamodernit ,onzelli,Roma.CassirerE.(1961),Filoso;iadelleformesimboliche ,LaNuovaItalia,Firenze.CrespiF.(1978),Esistenzaesimbolico.Prospettiveperunaculturaalternativa ,Feltrinelli,Milano.eLauretisT.(1996),Suigeneri.Scrittiditeoriafemminista,Feltrinelli,Milano.
FiskeJ.(1989),ReadingthePopular,UnwinandHyman,Boston,Ma.GansH.J.(1979),DecidingWhatsNews ,VintageBooks,NewYork.GruzinskiS.(1991),Laguerradelleimmagini.DaCristoforoColomboaBladeRunner ,Sugarco,Milano.Hebdige.(1979),Subculture.TheMeaningofStyle,Methuen,London,trad.it.Sottocultura.Ilfascinodi
unostileinnaturale ,Costa&Nolan,Genova1983.hooksb.(1996),reeltoreal.race,sexandclassatthemovies ,Routledge,NewYork.KeaneJ.(1991),TheMediaandDemocracy,PolityPress,Oxford.LacanJ(1974),Scritti,vol.II,Einaudi,Torino.LalliP.(1995),Immaginario,Rassegnaitalianadisociologia,2,pp.27992.LeGoffJ.(1988),Limmaginariomedievale ,Laterza,Bari.Morley.(1986),FamilyTelevision ,Comedia,London.MooresS.(1993),InterpretingAudiences.TheEthnographyofMediaConsumption ,Sage,London.SartreJ.P.(1948),LImaginaire.Psychologiephnomnologiquedelimagination ,Gallimard,Paris.SigalL.V.(1973),ReportersandOf;icial,LexingtonBooks,Lexington,MA.ThompsonJ.B.(1995),TheMediaandModernity.ASocialTheoryoftheMedia ,PolityPress,Cambridge,trad.it.
Mezzidicomunicazioneemodernit.Unateoriasocialedeimedia ,ilMulino,Bologna1998.TotaA.L.(1999a),Sociologiedellarte.Dalmuseotradizionaleallartemultimediale,Carocci,Roma.(1999b),Arteescienzainpubblico:ilruolodeimusei,Rassegnaitalianadisociologia,3,pp.46186.ZoonenL.van(1994),FeministMediaStudies,Sage,London.