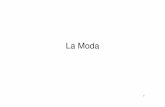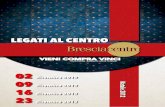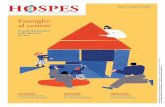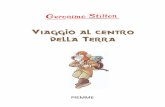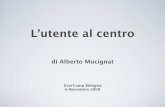La Comunicazione al Centro
Transcript of La Comunicazione al Centro





5
Prefazione
di Carlo Sorrentino1
La ricerca che vi accingete a leggere presenta vari motivi d’interesse sia scientifi co, sia più specifi camente operativi.Sotto il profi lo della teoria comunicativa, Gaia Peruzzi e il suo nutrito gruppo di ricerca aderisce senza indugio a quella che è ormai un paradigma affermato negli studi: la comunicazione non ha prioritaria-mente funzioni promozionali e persuasorie – anch’esse ovviamente rilevanti – ma risponde soprattutto a esigenze di tipo identitario e or-ganizzativo.Questa consapevolezza permette agli autori di ben inquadrare l’inte-ro impianto della loro ricerca sul ruolo occupato dalla comunicazione nella costituzione e poi nell’implementazione della rete formata dai Centri di Servizio per il Volontariato. Tale approccio isterilisce subito una delle rifl essioni che ancora si sente fare intorno alla comunicazione nel volontariato, cioè la sua marginalità perché il volontariato non ha niente da vendere, oppure non ha nessuno da convincere attraverso le chiacchiere, dovendolo, potendolo e sapendolo fare attraverso l’azione quotidiana e meritoria dei volontari. Affermazioni ideologiche e ingenue che, però, accom-pagnano ancora il complesso mondo del volontariato, rendendo più ardua la strada di quanti cercano di muoversi nel volontariato secon-do criteri innovativi e, soprattutto, confi dando di sviluppare organiz-zazioni effi cienti nel raggiungimento dei loro obiettivi.È questo retropensiero che da sempre porta alla riduzione degli in-vestimenti in comunicazione non appena le risorse scarseggiano, quando bisogna individuare voci di bilancio da tagliare, come ancora emerge in alcune delle interviste effettuate fra i professionisti della co-municazione dei Centri di Servizio, che fanno trapelare le perduranti diffi coltà di muoversi in un ambiente ancora scettico e diffi dente nei
1 Carlo Sorrentino è professore straordinario di Sociologia dei processi culturali presso l’Università di Firenze.

6
confronti delle attività di comunicazione.Ebbene, proprio questi diffi denti dovrebbero essere i primi lettori della ricerca; capirebbero come la comunicazione obblighi ogni or-ganizzazione a rifl ettere su se stessa e a muoversi di conseguenza; obblighi – in altri termini – a pensarsi strategicamente e, poi, a orga-nizzarsi ponendo al centro la relazione, con quanti sono all’interno dell’organizzazione e, poi, con i tanti e differenti portatori d’interesse con cui s’interagisce.Qual è la principale caratteristica della funzione strategica della co-municazione? Lo spiega bene la Peruzzi nel secondo capitolo, quan-do descrive come i Centri di Servizio di Volontariato si raccontino. Raccontarsi serve anche a capirsi meglio. Oggi il sito web di un’organizzazione è un ottimo contenitore per tali racconti. Per questo motivo, analizzare un sito signifi ca rintracciare i modi in cui l’organizzazione vuole presentarsi ai suoi interlocutori. Da tale presentazione si capisce quasi sempre quanta sia la consapevo-lezza sul proprio ruolo, quali le priorità operative individuate, quanta la rilevanza attribuita alla relazione con i vari portatori d’interesse. Ma si ha contezza anche di quanta sia fl uida e quindi effi cace la comuni-cazione all’interno dell’organizzazione. Perché soltanto un’organizza-zione che funziona, in cui le varie parti riescono a entrare facilmente in contatto fra loro, a lavorare insieme, sa poi raccontarsi, sa fare del sito un momento fondamentale della propria vita organizzativa, scon-giurando il pericolo – sempre incombente – del sito vetrina, che rac-conta una realtà inesistente, ma che si scopre dopo la prima patina di lucido, oppure del sito burocratico, dove i vari comparti dell’organiz-zazione rovesciano in modo disordinato e con linguaggi incomprensi-bili le diffi coltà della vita relazionale interna all’organizzazione.La risposta che viene dai Centri di Servizio è abbastanza incorag-giante. Certo non mancano ritardi e, soprattutto, situazioni eteroge-nee, ma in linea di massima ciò che emerge è un quadro di crescente consapevolezza circa l’importanza della dimensione strategica e or-ganizzativa della comunicazione. Certo questa consapevolezza non sempre è accompagnata da adeguati investimenti e, soprattutto, da azioni comunicativamente coerenti. Navigando sui siti analizzati si ri-

7
scontrano ancora linguaggi disomogenei, tendenze autoreferenziali, vezzi burocratici. Ma – come sembrano affermare anche i ricercatori – sono inerzie culturali da attribuire anche all’enorme varietà del mon-do del volontariato, in cui la buona consapevolezza dei tanti profes-sionisti della comunicazione – rilevata attraverso le interviste a loro effettuate – deve fare i conti, mediare e, talvolta, rallentare davanti alle richieste provenienti da quanti – nelle organizzazioni studiate – sono ancora portatori di visioni esornative e limitative della comunicazione, in cui casomai si preferisce l’autocelebrazione o la retorica alla rela-zione.Insomma, dalla ricerca emerge una comunicazione professionalmen-te avvertita, che conferma le conclusioni a cui giunge Peruzzi quando esplicita come la comunicazione del volontariato sia un campo che offre competenze specifi che e c’invita ad abbandonare la perdurante visione di una realtà fatta soprattutto di buona volontà, qualche vellei-tarismo e troppo dilettantismo.Non siamo più davanti a fughe in avanti, che però lasciano immanca-bilmente dietro tanti ritardatari, incapaci di seguire. Infatti, i dati ripor-tati ci dicono di una quasi totalità di Centri che si sono dotati di pro-fessionisti della comunicazione, spesso con studi specifi ci alle spalle e talvolta con esperienze professionali signifi cative già compiute.Insomma, si va strutturando una rete comunicativa che favorisce – ed è un altro elemento ben sottolineato nella ricerca – il raggiungimento di due importanti risultati:
– rendere più facili, fl uidi ed effi caci i rapporti fra i vari Centri, riuscendo a far nascere una coerenza fra loro non soltanto co-municativa, ma anche operativa;
– utilizzare la comunicazione per un altro importante scopo, an-cora più rilevante per chi si occupa di volontariato: assicurare maggiori livelli di trasparenza.
Il primo risultato è ovviamente favorito dalle nuove tecnologie, che consentono una migliore circolazione delle informazioni in tempo re-ale, garantendo quella partecipazione da molti descritta come vero plus della rete. Questo contatto più stretto favorisce anche la maggio-re identifi cazione delle professionalità presenti nel settore comunica-

8
tivo. Il confronto, infatti, non serve soltanto a misurarsi sulle scelte, a consigliarsi e a rivedere processi già effettuati, ma anche a far circo-lare fra le varie strutture le esigenze e le priorità che la comunicazione impone all’organizzazione, facendole diventare con più robustezza temi e problemi condivisi da ciascun Centro e permettendo di familia-rizzare con le logiche e i linguaggi della comunicazione. Il secondo risultato consiste nel riuscire a rispondere a quella richie-sta di trasparenza che ormai ciascuno di noi rivolge a ogni organizza-zione, pubblica o privata, profi t o non profi t che sia.Le pretese di conoscenza, le istanze informative ormai albergano nell’opinione pubblica ed è un’evidente conseguenza di una sfera pubblica abitata da un maggior numero di soggetti sociali, ciascuno portatore di propri interessi e visioni, ma soprattutto di legittime prete-se di raggiungere quel livello di conoscenza sulle cose che permette di farsi una propria idea, d’esprimere un proprio parere. Troppo a lungo nel mondo del volontariato è prevalsa l’errata convinzione che il carattere di gratuità della propria azione garantisse di per sé. Al contrario, la scarsa attenzione nel rendere conto all’opinione pubblica ha prodotto come involontaria conseguenza un’immagine d’opacità, di poca chiarezza che – soprattutto fra chi conosce poco il mondo del volontariato – rischia di degenerare in diffi denza.Ancora una volta pensarsi strategicamente come organizzazione tesa a comunicare facilita una maggiore circolazione dei tanti volti del vo-lontariato, della complessa realtà di un mondo che è più interessante proprio nella misura in cui riesce a far superare gli stereotipi – anche quelli positivi – che la circondano.La ricerca, infi ne, conferma come anche nel campo del volontariato non si riesca a cogliere del tutto le potenzialità offerte dal cosiddetto web 2.0, cioè l’implementazione delle forme di dialogo e di condivisio-ne delle azioni rese possibili dai social media. Anche in questo caso, ci troviamo allo stesso stadio riscontrabile in tutta la comunicazione pubblica, ancora ferma ad una visione residuale, talvolta quasi ludica o modaiola, di un nuovo schema comunicativo fra emittenti, contesti e riceventi che l’interattività in tempo reale potrebbe garantire. Fra i professionisti intervistati c’è cognizione di questo ritardo, ma

9
anche la lucida quanto giusta determinazione a superarlo soltanto quando sarà chiaro che l’interazione continua richiesta dai social me-dia necessita di una ulteriore e nuova consapevolezza nella ridefi ni-zione dei processi d’interazione dell’intera organizzazione che se si apre al dialogo, che esige ancora maggiore disponibilità ad accele-rare l’intensità e la densità di risposta. È apprezzabile l’insistenza con cui gli intervistati sottolineino come si produca una ridefi nizione del contesto comunicativo, un ulteriore assottigliamento della distinzione fra dimensione pubblica e dimensione privata che richiede ancora maggiore chiarezza identitaria ed effi cacia organizzativa.Insomma, il lavoro di Peruzzi e dei suoi collaboratori è completo e in-teressante, ci fornisce tante informazioni e, soprattutto, consente agli addetti ai lavori d’avere una conoscenza di fondo utile per pensare la comunicazione in modo professionale e consapevole.

10
Premessa
Marco Granelli, Stefano Tabò2
Per sostenere il volontariato è indispensabile conoscerlo: lo sanno bene i Centri di Servizio per il Volontariato (Csv) che, dal giorno stes-so della loro istituzione, ne sono divenuti un naturale nonché perma-nente osservatorio. Ciò vale anche per Csvnet che, in quanto Coordi-namento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, necessita una piena cognizione del proprio network. Non può, cioè, rinunciare a possedere un profi lo progressivamente sempre più dettagliato dei modi e delle forme con cui i singoli Centri declinano la loro attività. Se comune è la fi nalità perseguita tra i Csv, infatti, diverse sono le loro espressioni operative.Ad un Coordinamento nazionale che intende svolgere con incisivi-tà la propria funzione di stimolo e di supporto non può sfuggire la centralità e l’importanza del tema della comunicazione. Proprio su questo argomento si concentra la ricerca qui presentata, realizzata da un team di giovani ricercatori coordinato da Gaia Peruzzi, docente in Sociologia dei processi culturali e della comunicazione presso la Sapienza Università di Roma, in collaborazione con l’Area Comunica-zione di Csvnet.La ricerca, partita nella seconda metà del 2010, nasce dunque dall’esigenza di disegnare un quadro aggiornato della comunicazio-ne dei Centri di Servizio per il Volontariato e delle connesse dinami-che identitarie e relazionali che i Csv costruiscono con il mondo del volontariato e con gli altri interlocutori.Il campo di indagine è stato preliminarmente individuato nella comu-nicazione online dei Csv, sulla base dell’evidenza che internet e le tecnologie digitali sono divenuti strumenti imprescindibili per qual-siasi organizzazione, anche nel mondo del non profi t. Comunicare in maniera effi cace signifi ca, oggi, utilizzare anche gli strumenti del web.
2 Marco Granelli, già presidente Csvnet; Stefano Tabò attuale presidente Csvnet.

11
In senso ampio, non sfugga che internet racchiude ricche potenzia-lità per il mondo del volontariato, perché è in grado di veicolarne e amplifi carne i messaggi, riuscendo a limitare l’impatto della diffusa carenza di risorse economiche e professionali.La ricerca, per come è stata impostata nell’analisi e negli esiti, resti-tuisce elementi polifunzionali, da comprendere e sfruttare nelle loro conseguenze. Le pagine che seguono costituiscono una fonte di arricchimento in-formativo e valutativo per gli stessi Csv che hanno l’opportunità di valutare la propria esperienza, di trarre suggerimenti dalle scelte di altri, di avviare confronti e collaborazioni. Il tutto verso la valorizzazio-ne delle buone prassi già registrate e, perché no, nella direzione di ambire a nuovi traguardi. Gli esiti delle osservazioni che ci vengono offerte dal presente studio interessano, poi, un’ulteriore sfera. La pubblicazione di questo volu-me contribuisce a diffondere una maggiore conoscenza dei Centri di Servizio per il Volontariato tra tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati a comprenderne e verifi carne l’attività. Nella sua peculia-rità, pertanto, l’apporto di questa ricerca si inserisce a pieno diritto nel virtuoso percorso di rendicontazione che, da tempo, Csvnet sta perseguendo e ne rappresenta un originale e qualifi cante tassello.A Gaia Peruzzi e a tutto il suo staff va quindi il nostro più sincero rin-graziamento per il prezioso contributo.


Parte prima
La comunicazioneal centro


15
Capitolo 1Una ricerca sui Centri di Servizio per il Volontariato aderenti a Csvnet
di Gaia Peruzzi
1. La comunicazione al centro Il titolo di questo capitolo, e dell’intero libro, è un titolo programmati-co. In nuce infatti esso contiene tutte le ragioni di questo lavoro. Se lo “esplodiamo” e giochiamo un po’ con i suoi due sostantivi principali, esso è in grado di rivelarci tutte le strade che il gruppo di ricerca ha seguito nel realizzare il progetto, dall’ideazione dell’indagine sino a questo risultato.In che senso, dunque, la comunicazione al centro?Sono almeno tre i signifi cati cui il titolo fa riferimento: primo, la comu-nicazione è il tema centrale di questa indagine; secondo, lo studio in questione si occupa della comunicazione di quelle organizzazioni, uniche in Italia che in Europa, che sono i Centri di Servizio per il Vo-lontariato; da ultimo, i processi e le attività di questi enti sono osservati dal centro di una rete, quella del Csvnet, il Coordinamento nazionale dei suddetti enti. Proviamo a sviluppare un po’ più estesamente ciascuna di queste tre affermazioni.
1.1. La comunicazione indagata come tema centrale Che la comunicazione sia una chiave, una porta di accesso privile-giata per capire l’identità, la vita e le trasformazioni di un’organizza-zione e del mondo che essa rappresenta, è un concetto ormai diffuso e condiviso nella letteratura sociologica.La comunicazione sociale, cioè quella branca della comunicazione in cui il mondo del volontariato e del non profi t giocano un ruolo da protagonisti, è un terreno interessante per la realizzazione di tale tipo di studi.Il Terzo settore e la società civile costituiscono una sfera vitale per le democrazie contemporanee, che proprio nella funzione espressiva

16
(dei bisogni, dei diritti, delle aspettative e delle volontà dei cittadini) ha uno dei suoi tratti identitari più importanti. Questo mondo è caratte-rizzato però anche da confi ni e identità continuamente cangianti, che sarebbe bene monitorare con attenzione in una fase storica, come è quella in cui stiamo vivendo, in cui le concezioni e le forme della solidarietà e della partecipazione alla vita collettiva si evolvono in ma-niera rapida e continua.Inoltre, benché negli ultimi anni la letteratura sul settore sia cresciuta, le ricerche empiriche sulla comunicazione dei soggetti che lo abitano sono ancora scarse. Gli studi di caso che abbiano ottenuto visibili-tà sulla scena pubblica nazionale sono pochi, e ancora meno quel-li realizzati in un’ottica comparativa. Il territorio si presenta dunque, per larghe zone, agli occhi dei ricercatori, ancora sostanzialmente inesplorato (Peruzzi 2011). Considerando che il non profi t è una re-altà molto eterogenea, e che i suoi abitanti lamentano spesso una visibilità inadeguata sulla sfera pubblica, si intuisce facilmente come cercare di comprendere i processi, le dinamiche e gli effetti delle co-municazioni realizzate in questo ambito rappresenti una sfi da attuale e interessante.Il volume che presentiamo accoglie in pieno questa istanza: esso na-sce infatti dalla convinzione che analizzare le dinamiche e i signifi cati della comunicazione prodotta da un’organizzazione importante del mondo del volontariato signifi chi creare un’occasione per compren-dere qualcosa della vita, della storia e dei cambiamenti in corso nella società civile. La comunicazione dunque come luogo, pretesto di in-dagine del ruolo di un’istituzione e, attraverso le relazioni da questa ambite e intrecciate nei territorio fi sici e in quelli digitali, delle evolu-zioni di un’intera sfera sociale.Per realizzare tali obiettivi, si è scelto di concentrarci sull’immagine comunicata dai soggetti del nostro campione attraverso il medium che, nei contesti organizzativi contemporanei, ci è parso più idoneo a rilevarne l’identità a tutto tondo: il sito. Questo strumento, infatti, mettendo in vetrina tutte le attività, i progetti e i servizi offerti da un’or-ganizzazione, e rendendo accessibile almeno parte della struttura or-ganizzativa, “consente una visione di insieme delle strategie comuni-

17
cative” (Solito 2010, 65). Dunque, una conoscenza globale dei Centri e del loro Coordinamento.
1.2. La comunicazione realizzata dai Centri di Servizio per il Volontariato
I Centri di Servizio sono un caso di studio signifi cativo per almeno due ragioni: si tratta di una realtà unica a livello internazionale, e ancora non studiata, almeno dal punto di vista e con i metodi qui proposti. La seconda delle due ragioni è presto spiegata: se si eccettuano i rapporti interni realizzati dal Coordinamento, non esistono ad oggi studi sistematici rilevanti sulla fi gura e sul ruolo dei Centri di Servizio, né tantomeno sulla loro comunicazione, o a partire dalla medesima.Torniamo invece sul primo motivo, e proviamo a illustrare in che sen-so questi enti possono essere considerati sociologicamente rilevanti. Nel panorama della società civile non solo italiano, ma anche interna-zionale, i Centri di Servizio per il Volontariato rappresentano un’espe-rienza, si è detto, unica. Essi devono la vita a un provvedimento politico, la Legge quadro n. 266 del 1991. Riconoscendo l’importanza del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, essa ne di-sciplinava anche gli organismi. Nel far ciò, oltre a classifi care in una tipologia defi nita gli enti esistenti, fondava una nuova fi gura nel pa-norama del non profi t nazionale: i Centri di Servizio per il Volontariato, appunto. L’articolo 15 prevedeva infatti che, per il tramite degli enti locali e con il fi nanziamento delle fondazioni di origine bancaria, che avrebbero destinato ogni anno a queste nuove strutture un quindice-simo dei propri profi tti, nel nostro paese fossero istituiti dei Centri, a disposizione delle associazioni di volontariato e da queste gestiti, con la funzione esclusiva di sostenerne e qualifi carne l’attività. Qualche anno più tardi, il Decreto ministeriale dell’8 ottobre 1997 sta-biliva nei dettagli le modalità per la costituzione e il mantenimento presso le Regioni dei Fondi speciali per il volontariato: i fi nanziamenti sono assegnati e controllati a livello regionale dai Comitati di gestio-ne, composti dai rappresentanti delle fondazioni, delle organizzazioni di volontariato e delle istituzioni (Ministero del Lavoro, della salute e

18
delle formazioni sociali, Regioni, enti locali).Lo stesso Decreto specifi cava poi le attività che i nuovi Centri erano chiamati a svolgere. I Centri di Servizio hanno lo scopo di sostenere e di qualifi care le attività di volontariato. A tal fi ne essi erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazio-ni di volontariato, sia che queste risultino iscritte o meno nei registri regionali. In particolare: forniscono strumenti e iniziative per la cre-scita della cultura della solidarietà e per la promozione di iniziative di volontariato; offrono consulenza e assistenza qualifi cata, sostegno e strumenti per la progettazione e la realizzazione di attività; promuo-vono iniziative di formazione e di qualifi cazione destinate ai volontari; infi ne, producono e diffondono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.Negli anni a venire, cominciano a fi orire i nuovi Centri, disegnati dall’alto ma promossi dal basso, ovvero localmente per iniziativa del-le associazioni dei singoli territori, prima nelle regioni del Nord e del Centro, poi fi nalmente nel Sud e nelle isole. Oggi i Centri di Servizio per il Volontariato sono 78, coprono tutto il territorio nazionale e, come vedremo meglio nel prossimo paragrafo, dal 2003 75 si sono raccolti in una rete di Coordinamento nazionale.Il report 2008-2009 del Coordinamento è la relazione più aggiornata sul funzionamento reale di queste strutture. Essa ci informa che la stragrande maggioranza dei Centri di Servizio per il Volontariato è costituita da un’associazione di associazioni, in prevalenza di volon-tariato. Pochissimi (solo 4, in percentuale poco più del 5%), i Centri fondati da un unico ente.Ancora, le organizzazioni di volontariato che, direttamente o median-te l’adesione a un’associazione di secondo livello, partecipano alla gestione dei Centri, sono oltre 41mila. Nel complesso, la base associativa dei Centri aderenti a Csvnet risul-ta composta per tre quarti da organizzazioni di volontariato iscritte ai registri. Sommando quelle non iscritte, si sale a quota 90%. Il restante 10% dei soci è formato per metà da associazioni di promozione so-ciale, e per il resto da un insieme eterogeneo di cooperative e altri enti non profi t. Gli enti pubblici rappresentano una fetta piccolissima,

19
inferiore all’1%. Una composizione sociale così affollata di strutture diverse è un tipico esempio di rappresentanza dal basso.Anche la vita organizzativa dei Centri è gestita da una molteplicità di fi gure: assemblee, consigli direttivi, giunte esecutive, collegi dei sindaci revisori, garanti e probiviri. Una governance così articolata confi gura i soggetti del nostro campione come una palestra di parte-cipazione e democrazia. Passando ad esaminare il funzionamento concreto dei Centri, sap-piamo che essi erogano servizi mirati e qualifi cati alle associazioni aderenti. Fra i più diffusi risultano quelli logistici, relativi alla fornitura di spazi e attrezzature. Per quanto riguarda le consulenze, i servizi più numerosi concernono i campi della progettazione, della comuni-cazione e della ricerca di volontari. Un settore che negli ultimi anni ha conosciuto un grande sviluppo, sempre stando alle informazioni dei Report generali, è quello della formazione, in seno al quale è stata rilevata l’erogazione continua e massiccia, in tutte le regioni, di corsi strutturati e di seminari, molti dei quali organizzati insieme alle stes-se associazioni. Infi ne, nell’ambito dell’orientamento e dell’accompa-gnamento, le iniziative più ricorrenti sono quelle relative ai bandi del servizio civile e del servizio volontario europeo, realizzate spesso in collaborazione con le scuole. Due terzi dei fruitori dei servizi appena elencati (sempre facendo rife-rimento al Report, che prescindeva dalla vita online dei Centri) sono costituiti da associazioni di volontariato; seguono associazioni di di-verso tipo, altri enti non profi t e, di nuovo in coda, enti pubblici. Ad oggi, i Centri di Servizio per il Volontariato rappresentano dunque un sistema diffuso e consolidato a sostegno del non profi t. Per le fun-zioni di coordinamento e di rappresentanza e per le caratteristiche che abbiamo illustrato, essi possono essere considerati uno dei volti istituzionali del volontariato italiano.
1.3. La comunicazione osservata dal centro di una rete La ricerca che stiamo presentando è anche uno studio sulla comu-nicazione di una rete. La rete è il Csvnet, il Coordinamento nazionale

20
cui aderiscono 75 dei 78 Centri di Servizio per il Volontariato italiani.Il Csvnet è nato a inizio del 2003 per raccogliere e rafforzare l’espe-rienza del collegamento nazionale dei Centri di Servizio, che si era costituito quattro anni prima per rispondere alle prime istanze di rap-presentanza e di alcuni interventi comuni a livello nazionale. Oggi tutte le regioni della penisola vi sono rappresentate.Il Coordinamento lavora per incrementare la collaborazione e lo scam-bio di esperienze, di competenze e di servizi fra i Centri, così che, nel rispetto delle singole autonomie, essi possano comunque mirare e partecipare a iniziative di più ampio respiro. A tal fi ne, esso fornisce servizi di formazione, consulenza, sostegno e accompagnamento a tutti i Centri soci.Il Coordinamento si confi gura dunque come un rappresentante e un interlocutore dei propri associati di fronte alle istituzioni della politica e della società civile, sia a livello nazionale che internazionale.Csvnet è socio del Cev - Centro europeo per il volontariato (con sede a Bruxelles), di Euricse - European Research Institute on Co-operative and Social Enterprises (una fondazione di ricerca creata per rilanciare la rifl essione scientifi ca e la formazione sulla coopera-zione, sull’impresa sociale e sul volontariato) e dell’Iid - Istituto ita-liano della donazione. Inoltre, fa parte da diversi anni delle Associa-zioni Osservatrici del Forum Terzo Settore, ed è stato tra i promotori della Fondazione per il Sud, l’organismo nato nel 2006 dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del Terzo settore e del volontariato per promuovere l’infrastrutturazione sociale del Mezzo-giorno.Csvnet è una rete nata dal basso, caratterizzata da un potere diffuso tra “nodi” (i Centri) giuridicamente ed economicamente indipendenti, e ben radicate sul territorio: deve dunque la propria autorevolezza esclusivamente alle proprie capacità di rappresentanza e di coordi-namento.La nostra indagine nasce anche con lo scopo di comprendere l’iden-tità e il grado di effettiva coesione di questo network. Avviandosi ver-so il compimento dei primi dieci anni di vita, Csvnet ha colto infatti l’occasione di un partenariato con l’Università per una valutazione

21
globale dell’effettiva capacità dei propri Centri di fare sistema, fra sé e con il territorio.Dall’incontro tra questa esigenza “politica” di autovalutazione e l’inte-resse degli studiosi di esplorare terreni della comunicazione sociale ancora vergini, discendono gli obiettivi e il disegno della ricerca illu-strati nei paragrafi successivi.
2. Il disegno della ricerca La comunicazione online dei Centri di Servizio per il Volontariato come porta, strategia di penetrazione delle dinamiche identitarie, organiz-zative, relazionali e promozionali dei Centri e del Coordinamento che essi costituiscono: questa è l’idea che sta alla base dell’indagine qui presentata1. Come illustrato poco sopra, il sito, vetrina di presenta-zione di tutte le attività di un’organizzazione, è stato individuato come il luogo e insieme il canale che consente di approcciare, e che può restituire, una visione globale dell’identità di ciascun soggetto e, nel complesso, della rete.Operativamente, tali obiettivi sono stati declinati in una serie di do-mande-guida per la costruzione delle strategie e degli strumenti di indagine, organizzate intorno a cinque aree tematiche principali: l’im-magine comunicata e i servizi erogati dai singoli Centri attraverso il sito (I siti dei Centri di Servizio sono professionali? Sono, cioè, acces-sibili, attraenti, funzionali ed effi caci? Sono dei siti vetrina o funziona-no anche come media di servizio? E, in caso, che cosa offrono agli utenti? Cosa comunicano i siti del Csvnet? Quali realtà del volonta-
1 La ricerca raccontata in questo volume è stata ideata e realizzata da un team mi-sto di ricercatori e collaboratori del Coris - Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza Università di Roma, e di Csvnet - Coordinamento nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato. Il gruppo di lavoro era così composto: direzione scientifi ca Gaia Peruzzi (Sapienza Università di Roma); coordinamento Maria Teresa Rosito (Csvnet) e Manuela Bartolotta (Sapienza Università di Roma), Stefania Carulli (Sapienza Università di Roma), Clara Capponi (Csvnet); ricercatori Lorenzo Boscato, Alessia Ciccotti, Annalisa Critelli, Claudio Fratini, Sandra Fratticci, Maria Ida Maroni e Laura Viviani (tutti giovani laureandi e laureati in comunicazione della Sapienza Università di Roma); assistenti alle procedure tecnico-informatiche Maria Paola Faggiano (Sapienza Università di Roma) e Luca Bracchi (Csvnet).

22
riato raccontano? A chi si rivolgono? Riescono a proporsi come una fonte di informazione interessante per gli utenti esperti – giornalisti, ricercatori, amministratori – non appartenenti al mondo del non profi t? Esistono tra i siti delle differenze rilevanti riconducibili alla collocazio-ne territoriale dei Centri o alle loro dimensioni?); le reti tra i Centri, con il Coordinamento, sul territorio (I siti raccontano l’appartenenza dei Centri a un coordinamento comune? Quanto e cosa degli input ero-gati da Csvnet fi ltra nella comunicazione dei singoli membri? I Centri “parlano” l’uno dell’altro? Fanno rete con altri soggetti del territorio?); i bisogni e le competenze di comunicazione dei Centri di Servizio (Qual è il profi lo dei comunicatori che lavorano nei Centri? Quali com-petenze possiedono? Quali bisogni di comunicazione rilevano per le proprie strutture? In quali attività sono impegnati quotidianamente? Quali ostacoli incontrano?); la comunicazione organizzativa (In che modo la diffusione della comunicazione sul/nel web cambia la vita organizzativa dei Centri? Come cambiano la natura e il concetto di servizio nell’era della comunicazione digitale? Quale ruolo attribui-scono alla comunicazione i suoi addetti? Esiste una pianifi cazione delle attività di comunicazione?); l’utilizzo dei social network e dei me-dia digitali (I Centri sfruttano le opportunità del web 2.0? Quali sono i social network più usati? Per quali funzioni sono utilizzati? Nei siti ci sono spazi vivi di dialogo fra l’organizzazione e i volontari?). Per esplorare i campi appena tracciati, si è deciso di procedere pa-rallelamente lungo due piste principali: un monitoraggio di valutazio-ne dei siti dei Centri di Servizio per il Volontariato e una survey sul la-voro quotidiano dei loro uffi ci di comunicazione, affi dando a un terzo step di interviste mirate a testimoni privilegiati il compito di sciogliere i nodi eventualmente emersi durante la sintesi dei risultati. Come sug-geriscono gli studiosi dei media digitali (Hine 2005; Lievrouw e Li-vingstone 2007), il disegno complessivo della ricerca integra metodi quantitativi e qualitativi, on e offl ine.
2.1. Il monitoraggio dei siti La prima azione della ricerca è stata quella di effettuare una valuta-zione globale e approfondita di ognuno dei siti della rete. A tal fi ne,

23
è stata costruita una scheda di rilevazione (Appendice 1) sulla base della quale i ricercatori hanno osservato, studiato, interagito con i siti del Coordinamento nazionale, rilevando per ciascuno oltre cento item, relativi a cinque aspetti: il possesso dei requisiti minimi che rendono professionale il sito di un’organizzazione; la presentazione del Centro di Servizi (delle sue origini, della sua mission e delle sue funzioni); i servizi (di informazione, formazione, consulenza e promozione della cultura della solidarietà) offerti dal sito ai volontari e a tutti gli altri pos-sibili utenti; le reti del Centro con il Coordinamento, con gli altri Centri e con soggetti diversi del territorio; l’uso dei social network e delle nuove tecnologie digitali. Le rilevazioni sono state effettuate nella seconda metà di settembre 2010. Sono stati monitorati 71 siti2 soci del Coordinamento. Il monito-raggio ha restituito un corpus ingente di dati3 concernenti le strategie, le attività e la qualità della comunicazione dei Centri del Coordina-mento, dal quale è stato possibile ricostruire un quadro approfondito dell’identità, dell’immagine comunicata e delle relazioni di queste or-ganizzazioni.
2.2. La websurvey sugli uffici e le risorse di comunicazioneIl secondo intervento consisteva in una mappatura degli uffi ci di co-municazione dei Centri di Servizio aderenti al Coordinamento, per rilevarne: dimensioni e caratteristiche principali, bisogni e competen-ze, strategie e attività. La rilevazione è stata effettuata questa volta mediante una websurvey. Dei 71 Centri contattati, hanno risposto in 61.
2 Quando sono state effettuate le rilevazioni, i Centri di Servizio aderenti al Coordi-namento erano 72, 3 in meno rispetto ad oggi. Inoltre, un sito risultava indisponibile. Desideriamo ringraziare tutti i Centri che hanno partecipato alla ricerca, perchè senza la loro collaborazione questa pubblicazione non sarebbe stata possibile.3 Data l’entità del campione, inferiore a 100, le statistiche utilizzate per illustrare i ri-sultati del monitoraggio riportano i valori assoluti delle frequenze: laddove però si è ritenuto che la narrazione potesse guadagnarne in effi cacia espositiva, si è lasciato che qualche percentuale affi ancasse il dato intero. Ancora: quando, nelle fi gure o nei commenti, il totale dei casi è inferiore a 71, signifi ca che la specifi ca funzione per alcuni siti non era rilevabile.

24
Il questionario, che si rivolgeva ai responsabili dell’uffi cio comuni-cazione, e, in alternativa, ai “semplici” addetti (Appendice 2), era strutturato nelle seguenti sezioni: il profi lo socio-demografi co e occu-pazionale dei comunicatori che operano nei Centri di Servizio per il Volontariato; l’uffi cio comunicazione (dimensioni, ruolo ideale, funzioni concretamente svolte); i rapporti della struttura con il Coordinamento centrale e con gli altri nodi della rete, e quelli del Centro con il suo territorio. Sia la somministrazione che la compilazione dello strumento sono state gestite attraverso un’apposita piattaforma online. Le rispo-ste fornite dai responsabili della comunicazione hanno consentito di confrontare i dati sull’immagine comunicata dai Centri all’esterno con le percezioni diffuse all’interno tra gli abitanti di quel mondo.
2.3. Le interviste ai testimoni privilegiati L’ultima fase della ricerca prevedeva la realizzazione di interviste te-lefoniche a un campione selezionato di testimoni privilegiati, sui nodi – argomenti particolarmente signifi cativi, e contraddizioni – emersi durante l’esame del corpus. La traccia di intervista è riportata nell’Ap-pendice 3, insieme all’elenco dei dodici intervistati. Questi ultimi sono stati selezionati sulla base delle indicazioni fornite dall’uffi cio comuni-cazione del Csvnet.Le affermazioni raccolte sono state utilizzate, ovviamente, non con valore rappresentativo, ma come stimoli e suggestioni per integrare e illuminare le analisi dei dati raccolti nelle due azioni precedenti.
2.4. Il valore aggiunto della ricerca: gli strumenti per l’auto-valutazione
Una piccola nota a mo’ di chiusura alla presentazione del lavoro. Questa ricerca è nata, ed è stata realizzata, da una collaborazione non formale tra i due enti promotori, l’Università e il Csvnet. Ciò ha fatto sì che, da una parte, i ricercatori mantenessero sempre viva l’attenzione a spiegare le implicazioni concrete degli obiettivi e dei risultati del proprio lavoro; dall’altra, che i collaboratori del Csvnet e dei Centri coinvolti nelle attività del progetto (in qualità di ricercatori o di testimoni) potessero sperimentare sul campo le potenzialità eu-

25
ristiche, a fi ni conoscitivi e valutativi, di un’indagine di ben più ampio respiro rispetto alle rilevazioni di matrice tecnicistica e aziendalistica diffuse in questo settore. Una testimonianza emblematica della fertilità di questa modalità di lavoro compartecipata è costituita dal primo strumento di indagine. Il questionario per la valutazione dei siti (allegato in Appendice 1) è sta-to costruito tenendo in mente due esigenze: quella di predisporre un dispositivo suffi cientemente articolato e sofi sticato da poter risponde-re ai numerosi interrogativi in cui sono declinati gli obiettivi del proget-to, ma anche quella di fornire al personale dei Centri uno strumento di auto-valutazione dei propri siti chiaro e agile nell’uso.Con i suoi 116 item “tagliati su misura” per i soggetti che costituisco-no il campione, e articolati, come si è visto, in sezioni, il questionario costituisce dunque una risorsa originale, accessibile e già testata, a disposizione di tutti i Centri di Servizio per il Volontariato (ma, con qualche ritocco, anche di altri enti non profi t) per cominciare a va-lutare, in maniera autonoma, la qualità del sito e delle strategie di comunicazione con cui queste organizzazioni vivono e lavorano nel cyberspazio.


Parte seconda
Il volontariatosul web


29
Capitolo 2I Centri di Servizio per il Volontariato (si) raccontano
di Gaia Peruzzi e Sandra Fratticci1
1. I siti del Coordinamento alla prova dei requisiti minimi di qualità
Questo paragrafo costituisce una sorta di premessa all’esposizione dei risultati narrata nei successivi capitoli. Prima di addentrarci nella valutazione dei servizi e dei processi della comunicazione online dei siti dei Centri di Servizio aderenti al Coordinamento nazionale si è pensato infatti di effettuare una panoramica introduttiva per valutare se tali strumenti possano essere considerati professionali.Si è analizzata dunque la presenza, all’interno di ciascun sito web della nostra rete, di quei requisiti tecnici e funzionali indispensabili a distinguere un sito come professionale, adeguato alle esigenze co-municative fondamentali di un’organizzazione lavorativa. In particola-re, ci si è concentrati in questa fase su alcuni dei criteri fondamentali che defi niscono l’accessibilità, l’usabilità e la qualità dei siti web, da intendersi come presupposti minimi di professionalità nella comuni-cazione digitale.Il primo requisito basilare che abbiamo valutato è la velocità di carica-mento delle pagine. Da questo punto di vista i siti dei Centri di Servizio per il Volontariato garantiscono buone performance, risultando, in 64 casi su un totale di 71 (90%), ‘molto’ o ‘abbastanza’ veloci. Si tratta, come si diceva, di un fattore determinante nel decretare l’effi cienza di un sito. Nell’era del web 2.0 infatti tempi di attesa dilatati non sono più accettabili per gli utenti, abituati ormai ad una navigazione rapida, anche frenetica, che salta da una risorsa all’altra, potendo usufruire di un’offerta amplissima, spesso caratterizzata da prestazioni elevate (Nielsen e Loranger 2006). Per tali ragioni il tempo di risposta mas-
1 Sandra Fratticci è autrice del paragrafo 1, Gaia Peruzzi del paragrafo 2.

30
simo consigliato per la homepage di un sito è di 10 secondi, ma per una usabilità ottimale le pagine dovrebbero caricarsi in meno di un secondo (Nielsen e Tahir 2002).Altro presupposto irrinunciabile per un sito che intenda presentarsi come autorevole è il corretto funzionamento dei link inseriti. La presen-za di collegamenti che non aprono nuove pagine è infatti un sintomo di sciatteria che non può che incidere negativamente sulla credibilità del sito. Dal monitoraggio effettuato emerge che in 47 siti dei Centri di Servizio per il Volontariato tutti i link funzionano correttamente e in 21 siti la maggior parte dei collegamenti risulta attiva. Soltanto in 3 casi si riscontra una presenza elevata di link inutilizzabili.Tra le caratteristiche che concorrono a defi nire la qualità di un sito web va inoltre considerata l’immediata riconoscibilità del soggetto promotore e degli scopi del sito. La ragione è presto detta: i tem-pi di permanenza all’interno dei siti sono, in genere, piuttosto bassi. L’utente dà una rapida scorsa all’homepage e, se non trova nulla che lo interessa, abbandona il sito. Per questo è necessario fornire dei riferimenti chiari che consentano di capire, a colpo d’occhio, di cosa si occupa il sito, che cosa offre (Polillo 2004). Nel monitoraggio sono stati presi in considerazione due elementi pri-mari nel garantire l’immediata identifi cazione del sito come apparte-nente ad un Centro di Servizio per il Volontariato, ossia la presenza del logo del Centro e l’utilizzo di Url, indirizzi web pertinenti rispetto al nome dell’ente. Per quanto riguarda il primo profi lo, si rileva un utilizzo generalizzato del logo come fattore di riconoscibilità del sito: in 70 siti su un totale di 71 questo è infatti presente in tutte le pagine ed è sempre collocato nella stessa posizione2.Nella scelta dei nomi di dominio, ossia dei nomi che identifi cano i siti, emerge invece una maggiore variabilità, e un trend negativo. Se, infatti, in 33 casi il nome del sito richiama quello dell’ente, in ben 38 esso non risulta pertinente rispetto a quello del Centro.
2 Oltre a rappresentare un elemento fondamentale di riconoscibilità del sito, il logo è anche un riferimento importante per la navigazione, perché consente all’utente di sapere, in qualunque istante, su quale sito sta navigando.

31
Oltre al logo e al nome risulta centrale, per un’organizzazione che intenda offrire dei servizi, pubblicare i propri recapiti. 52 dei 71 siti analizzati presentano, ben visibile in homepage, un link ad una se-zione ‘contatti’. In 29 casi tale sezione è dettagliata ed include i nomi dello staff, fotografi e, o altre informazioni sull’organizzazione e sul suo personale. In 23 siti la sezione ‘contatti’ presenta un indirizzo di posta completo, ma non fornisce alcuna ulteriore informazione sulle per-sone che operano all’interno del Centro. In altri casi i contatti sono incompleti o poco visibili (15 siti) oppure assenti (4 siti).Anche l’utilizzo di fotografi e contribuisce ad infl uenzare la percezione che il navigatore ha del sito. Poiché, infatti, una delle caratteristiche connaturate al web è la multimedialità, la pubblicazione di immagi-ni a corredo dei contenuti dovrebbe essere considerata un requisito centrale, soprattutto nei siti che hanno come obiettivo l’offerta di in-formazioni e servizi, purché naturalmente le immagini inserite siano di qualità. Tale prerogativa non è particolarmente diffusa all’interno dei siti dei Centri di Servizio per il Volontariato. Sono soltanto 26, infatti, i siti che offrono ai propri navigatori fotografi e di livello professionale, mentre in 45 siti le fotografi e sono state valutate dai ricercatori di scar-sa qualità, oppure erano assenti.La disponibilità dei contenuti in versione multilingua può essere in-vece considerata un requisito ‘accessorio’ che, laddove presente, attesta la volontà e la capacità del sito di rivolgersi ad un’utenza più ampia. Nei siti dei Centri di Servizio per il Volontariato tale qualità si ritrova in un numero ristretto di casi: 6 siti su un totale di 71.Il monitoraggio ha poi incluso, come accennato, alcuni dei criteri che concorrono a garantire l’usabilità di un sito web. Quest’ultima può essere defi nita come la capacità di un sito
di soddisfare i bisogni informativi dell’utente fi nale che lo sta visitando e interrogando, fornendogli facilità di accesso e di na-vigabilità e consentendo un adeguato livello di comprensione dei contenuti (Visciola 2006, 39).
Anche in questo caso sono stati considerati soltanto quei requisiti che, dato il livello di sviluppo del web, è ormai usuale aspettarsi da un sito concepito in chiave professionale. Tra questi, la presenza di stru-

32
menti di orientamento della navigazione. In 68 siti (il 96% del totale) al logo del Centro di Servizio per il Volontariato3 si aggiunge l’utilizzo di menù di navigazione e 46 siti (64%) hanno menù di navigazione sia globali, sia locali. I pulsanti di navigazione globale, presenti su tutte le pagine, consentono all’utente di accedere alle sezioni di primo livello da qualunque pagina del sito, senza bisogno di passare per la ho-mepage. Attraverso la navigazione locale, l’utente ha la possibilità di muoversi agevolmente tra le pagine di secondo livello che apparten-gono ad una stessa sezione. L’impiego di entrambi questi strumenti semplifi ca dunque notevolmente la navigazione all’interno del sito. Assai diffusa, inoltre, è la tendenza ad includere nei siti dei Centri di Servizio per il Volontariato una sezione di ricerca, collocata in una posizione ben visibile agli utenti. Sono infatti 58 i siti che presentano questo tool, tuttavia in 8 casi lo strumento di ricerca non funziona correttamente. Fatto salvo il caso di siti ‘elementari’, composti da po-chissime pagine, lo sviluppo di un motore di ricerca interno dovrebbe essere previsto in ogni sito, poiché, dopo la navigazione, la ricerca è il modo più diffuso con cui le persone trovano ciò che cercano in un sito (Nielsen e Loranger 2006). Discorso analogo può essere fatto per la mappa di navigazione, che non dovrebbe mai mancare nei siti che presentano un minimo di articolazione dei contenuti, consenten-do agli utenti un accesso diretto alle sezioni di interesse. Da questo punto di vista i siti dei Centri di Servizio per il Volontariato risultano piuttosto carenti. Soltanto 21 siti presentano mappe funzionanti, men-tre in 4 siti la mappa di navigazione non funziona e in 46 siti è addirit-tura assente. Più accurate sono invece la scelta dei font e l’allineamento dei testi. 64 siti su un totale di 71 (il 90%) utilizzano un font omogeneo in tutte le pagine del sito e adottano caratteri bastoni. In 39 siti (55%) il testo è sempre allineato a sinistra. L’importanza della coerenza dei caratteri è abbastanza intuitiva: la discordanza dei font genera una situazione
3 Oltre a rappresentare, come detto, un elemento di riconoscibilità immediata, il logo consente anche di contestualizzare la navigazione, permettendo all’utente che accede alle pagine interne del sito di sapere, in ogni momento, su quale sito sta navigando.

33
di confusione e fornisce l’impressione di una mancanza di attenzione (Grasso 2002). L’utilizzo di caratteri sans serif, ossia privi di grazie, è necessario invece per garantire una maggiore leggibilità dei testi su video, poiché la risoluzione dei monitor, più bassa rispetto alla carta stampata, non consente di riprodurre adeguatamente le gra-zie (Postai 2004). L’impaginazione a bandiera, infi ne, è fondamentale perché disegnando sul margine destro una linea irregolare, offre dei punti di “ancoraggio ottico”, rendendo la lettura più agevole. Il testo giustifi cato è solo apparentemente più elegante. Infatti sul web capi-ta spesso che il rendering dei browser crei una spaziatura notevole tra le parole, modifi cando e interrompendo il ritmo di lettura (Postai 2004).L’accessibilità dei siti web, ossia la loro fruibilità anche da parte di utenti diversamente abili, rappresenta in Italia un preciso obbligo per i siti delle Pubbliche Amministrazioni4, ma il buon senso dovrebbe suggerirne l’applicazione in qualsiasi sito. Il riferimento primario, in questo senso, è rappresentato dalle linee guida defi nite dal World Wide Web Consortium attraverso la Web Accessibility Initiative5.Le Wcag 2.0, rilasciate nel 2008, comprendono 12 recommendation riferibili a quattro principi cardine: fruibilità delle informazioni e dell’in-terfaccia utente attraverso differenti canali sensoriali (il sito deve es-sere percepibile); possibilità di utilizzo dell’interfaccia senza ingiu-stifi cati disagi o vincoli per l’utente (il sito deve essere utilizzabile); intuitività delle modalità di funzionamento dell’interfaccia e delle azio-ni in essa contenute, necessarie per ottenere servizi e informazioni (il sito deve essere comprensibile); compatibilità dei contenuti con una vasta gamma di programmi, comprese le tecnologie assistive (il sito deve essere robusto) (Harper e Yesilada 2008).Nel monitoraggio dei siti dei Centri di Servizio per il Volontariato sono stati considerati i requisiti relativi al contrasto cromatico, al layout adattabile ed alle descrizioni alternative per elementi non testuali. Tali criteri non esauriscono, chiaramente, la gamma dei requisiti cui
4 Si veda a tal proposito la Legge del 9 gennaio 2004, n. 4.5 Le linee guida possono essere scaricare all’indirizzo <http://www.w3.org/WAI/>.

34
un sito dovrebbe conformarsi per risultare fruibile anche da parte di utenti diversamente abili, ma possono fornire una prima indicazione dell’attenzione che i siti del Coordinamento nazionale riservano all’ac-cessibilità. Per quanto riguarda il contrasto cromatico, per consentire la fruizione del sito anche da parte di chi soffre di defi cit nella visione dei colori, è necessario utilizzare combinazioni di colori che assicu-rino un contrasto suffi ciente a distinguere il primo piano dallo sfondo (Diodati 2007). Nei siti dei Centri di Servizio per il Volontariato predo-mina l’utilizzo di caratteri scuri su sfondi chiari, presente in 67 casi su 71 e, in particolare, 31 siti utilizzano testo di colore nero su sfondo bianco. Per layout adattabile si intende la possibilità di variare le di-mensioni della fi nestra del browser (anche attraverso il ridimensiona-mento, ingrandimento o riduzione dell’area di visualizzazione o dei caratteri) senza che si verifi chino sovrapposizioni degli oggetti pre-senti o perdita di informazioni tali da rendere incomprensibile il con-tenuto (Polillo 2006). Questa proprietà è presente in 43 siti dei Centri di Servizio per il Volontariato, mentre 12 siti mantengono soltanto in parte la struttura e le informazioni e 15 siti non risultano adattabili. Le descrizioni alternative, infi ne, sono un riferimento fondamentale per i non vedenti, operando come sostituto degli elementi non testuali, come immagini e video (Boscarol 2003). Soltanto in 12 casi i siti dei Centri associano sempre una descrizione alternativa ad elementi non testuali, mentre in 29 casi emerge un utilizzo parziale di questo stru-mento e in 30 casi non se ne fa uso.All’analisi dei fattori fi nora menzionati è stato aggiunto un giudizio sog-gettivo dei ricercatori sulla professionalità dei siti, basato sull’impatto visivo immediato dei siti che analizzavano. Stando alle impressioni dei ricercatori del team, 34 siti trasmettono già a prima vista l’impres-sione di siti realizzati da professionisti. 22 siti appaiono complessiva-mente di qualità professionale, anche se alcuni particolari potrebbero essere curati meglio. I restanti siti, invece, si presentano con un’or-ganizzazione dei contenuti poco chiara ed effi cace (9 casi); con testi ricchi di animazioni in Flash (2 siti); con immagini poco nitide e/o il testo scarsamente leggibile (4 casi). Tirando le somme dell’analisi che abbiamo illustrato in questo primo

35
paragrafo, possiamo affermare che i siti dei Centri di Servizio per il Volontariato rispondono positivamente nel complesso ai requisiti fondamentali di qualità, usabilità ed accessibilità, anche se rispetto ad alcune dimensioni la situazione si presenta eterogenea. Quella che analizzeremo più in dettaglio nei capitoli successivi è dunque una rete di comunicazione professionale, anche se alcuni nodi hanno margini rilevanti di miglioramento.
2. Vetrine istituzionali: i Centri di Servizio per il Volontariato online
Abbiamo visto nel paragrafo precedente come i siti dei Centri che formano il Coordinamento si presentino, nella struttura e nell’aspetto editoriale, come delle vetrine di qualità. Si tratta di una premessa im-portante, che ci consente di affermare che la nostra analisi riguarda organizzazioni consapevoli e attente nello svolgimento di un’attività pubblica secondo criteri formalmente professionali. Adesso dobbia-mo entrare nel cuore dell’analisi e valutare la capacità dei nostri siti di svolgere le funzioni per cui sono deputati, cioè quelle di comunicare l’esistenza, le funzioni e i servizi dei Centri di Servizio per il Volontaria-to, tanto nei territori della conoscenza e dell’esperienza online che in quelli offl ine. Per fare questo, dobbiamo addentrarci nella valutazione dei contenuti dei testi che costituiscono i siti. Questo primo paragrafo si concentra sugli elementi che dovrebbero raccontare l’identità dei Centri, sia agli abitanti del mondo del non profi t che a eventuali navigatori meno esperti: dunque, come si pre-sentano i nostri Centri nel cyberspazio? I siti sono in grado di spiega-re che cosa sono, come funzionano e cosa fanno queste organizza-zioni? Sono in grado di raccontare mission, storia e valori dei Centri di Servizio per il Volontariato?Vediamo cosa ci dicono in proposito i dati del nostro monitoraggio.La quasi totalità dei siti (68, pari al 96% di quelli analizzati) ha una pagina dedicata alla presentazione dell’ente Centro di Servizio per il Volontariato, visibile, e dunque raggiungibile, dalla home. Esattamente in tre quarti dei casi i ricercatori hanno rilevato la pre-senza di una pagina di presentazione della struttura completa degli

36
elenchi dei relativi organi e incarichi. Ben 69 fanno riferimento alla normativa che ha istituito i Centri di Ser-vizio per il Volontariato a inizi degli anni Novanta. Di questi, 39 (cioè il 55%) includono addirittura ulteriori aggiornamenti sull’argomento. Nel complesso dunque, la maggior parte dei siti sembrano curare la presentazione delle proprie strutture, almeno per quello che riguarda gli aspetti fondamentali. Le asticelle dei punteggi però si abbassano sensibilmente quando si passano a valutare dimensioni più comples-se dell’identità, legate alle origini e alla memoria storica del volontaria-to. Per esempio, i siti che fanno un qualche tipo di riferimento ai valori del volontariato sono solo 42; e in ogni caso si tratta di accenni che sono stati classifi cati dai rilevatori come generici e/o poco effi caci. Neppure la metà (29, il 40%) sono poi quelli che hanno dedicato qualche frase alle origini storiche del Centro e al rapporto di questo con il suo territorio. Si scende addirittura a quota 15 (pari al 21% del campione) per avere il numero dei siti che si esprimono in maniera un po’ più dettagliata sui valori fondativi del volontariato, menzionando termini quali: solidarietà, democrazia, pluralismo. Infi ne, un dato tanto secco quanto eloquente: i Centri che possono vantare sul proprio sito informazioni approfondite sulla propria storia e sulle persone che ne sono state protagoniste sono solo 4 (che equivalgono al 6%). L’esame dei contenuti fornisce informazioni non solo sui temi della co-municazione, ma anche sui suoi destinatari. A chi si rivolgono dunque i siti del Coordinamento nazionale?Se 28 siti propongono percorsi di navigazione che, per la specifi cità del vocabolario e delle questioni, sembrano riferirsi in maniera pre-valente alle associazioni, oltre la metà (37) parlano invece a tutti gli utenti. La maggior parte di questi però lo fa in maniera generica e indifferenziata, e sono pochi quelli che cercano esplicitamente l’at-tenzione di pubblici diversi, offrendo percorsi di navigazione mirati: per esempio, 5 siti particolarmente accorti propongono, accanto alle sezioni per le associazioni, contenuti confezionati per esperti del set-tore e altri interlocutori. Una criticità importante emerge riguardo all’uso delle immagini, che viene giudicato, anche in risposta ad item diversi, poco effi cace. Ben

37
34 siti, cioè quasi la metà, pubblicano immagini in numero ridotto e poco defi nite… alcuni di questi addirittura hanno intere pagine senza foto! Ancora, 37 siti, quasi il 55% del campione, non usano immagini a corredo delle news. 20 usano immagini di buona qualità, ma di con-tenuto generico. In 18 casi addirittura i ricercatori hanno riscontrato immagini di scarsa qualità (a bassa defi nizione, o comunque prodot-te da dilettanti). Senza volerne in alcun modo attenuare la gravità, non possiamo comunque non tenere conto che questi dati hanno un’inevi-tabile attenuante in una situazione purtroppo diffusa della comunica-zione sociale (Peruzzi 2011).Tentando un bilancio di questo primo step della valutazione, concer-nente la presentazione sul web dei Centri, possiamo affermare che i siti del Coordinamento superano senza dubbio l’esame. Essi presen-tano quasi sempre in maniera corretta e formalmente ineccepibile la propria struttura, spiegandone ruolo e funzioni principali. Non riesco-no però a restituire che poco o nulla della sua storia, della missione e dei valori del volontariato. Insomma, essi parlano “alla testa, più che al cuore”, dei visitatori.Nei capitoli che seguono approfondiremo la qualità di tutti gli altri ser-vizi e attività che essi svolgono.




41
Capitolo 3I servizi online del volontariato
di Stefania Carulli
1. La cultura del servizio Centro di Servizio per il Volontariato (Csv): è il nome stesso a indicarci gli obiettivi per cui il genere di struttura che studiamo lavora, ossia supportare le attività delle associazioni di volontariato di un territorio mettendo a disposizione un saper fare avanzato e concreto. In altre parole, servizi. Il sito web è uno strumento fondamentale per dare corpo e visibilità a tale offerta di contenuti e, in linea con la mission di un Centro di Servizio per il Volontariato, dovrebbe adempiere a due principali funzioni: la prima è quella di offrire informazioni e assisten-za alle associazioni del territorio; la seconda consiste nel diffondere notizie e percorsi utili alla promozione della cultura del volontariato. Quindi, in questo senso, la sezione relativa ai servizi presente sul sito web di un Centro diventa un indicatore utile per avere una visione d’insieme su alcune questioni sostanziali: quali servizi offre il Centro di Servizio per il Volontariato alla propria utenza e in che misura sup-porta le attività a sostegno del volontariato? Quali rapporti emergono con i soggetti impegnati sul territorio?Nei prossimi paragrafi , partendo dai dati emersi durante la ricerca, proveremo a dare conto di quanto il concetto di servizio sia legato ai contenuti presenti sui siti web dei Centri e di come esso sia declinato secondo le quattro principali categorie in cui sono organizzati i servizi offerti: informazione, formazione, rendicontazione e, infi ne, promo-zione della cultura del volontariato.Prima di procedere con i risultati dell’analisi, è opportuno rifl ettere un attimo sul concetto di servizio, che in questo caso si fa concetto-guida per aiutarci a individuare e a comprendere lo spazio relativo agli elementi che caratterizzano la mission di un Centro di Servizio per il Volontariato.Il concetto di servizio può essere descritto attraverso molteplici acce-zioni: a seconda del settore, del prodotto e del contesto in cui viene

42
fornito. Tale concetto, al centro di un dibattito ancora in corso, è stato variamente defi nito da studiosi di numerose discipline, ma ha cono-sciuto le prime e più compiute teorizzazioni nell’ambito economico e di marketing. Più di recente, la crescita delle tecnologie dell’infor-mazione e della comunicazione ha reso indispensabile studiare tale concetto attraverso un approccio multidisciplinare, capace di unire la base socio-economica con le discipline tecniche e scientifi che (Mez-zanzanica 2010, 15; Olivetti Manoukian 1998) e di dare più ampio respiro alla scienza dei servizi. Secondo un’ottica prevalentemente economica, le caratteristiche distintive dei servizi messe in luce dagli studiosi nel corso del tempo sono: l’intangibilità, l’eterogeneità (come effetto della personalizzazione delle prestazioni fornite) e il ruolo atti-vo del ricevente che, riponendo fi ducia in un soggetto erogatore, ne accetta i servizi e ne valuta l’operato (Mezzanzanica, 2010). Sul versante del settore pubblico, la concezione di servizio si carica di ulteriori valenze economiche oltre che giuridiche e, pur legando-si ad una valutazione espressa dal soggetto pubblico, implica delle prerogative comuni: la trasversalità dell’azione a prescindere dal-la condizione socio-economica degli utenti e il soddisfacimento di un bisogno considerato primario e utile alla collettività nel rispetto dei diritti della persona. Entrambe queste letture ci aiutano a chiari-re l’importanza che assume il concetto di servizio nell’ambito di una struttura come un Centro di Servizio per il Volontariato. Infatti, in tale contesto, i servizi offerti si pongono a metà strada rispetto alle inter-pretazioni che abbiamo appena considerato e ne raccolgono i tratti positivi, aspirando però ad una fi sionomia più ampia. Un Centro forni-sce gratuitamente servizi alle associazioni – i soggetti che potremmo considerare “i clienti diretti” di queste prestazioni – nel campo della consulenza, della formazione come in quello della comunicazione. Allo stesso tempo dovrebbe offrire a cittadini, istituzioni e organi di informazione contenuti e notizie volti alla promozione della cultura del volontariato: entrambi gli aspetti evidenziano il contributo dei Centri di Servizio per il Volontariato al pieno rispetto di quelle norme, in partico-

43
lare il dettato costituzionale1, che vedono nell’iniziativa dei cittadini e delle associazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale uno strumento fi nalizzato allo sviluppo della persona e della parteci-pazione dell’individuo alla vita sociale del paese.
2. I servizi di informazione: il cuore della comunicazione in Rete
Un Centro di Servizio per il Volontariato nasce con la funzione di so-stenere e di qualifi care l’attività delle organizzazioni di volontariato. L’informazione quindi è il primo servizio offerto dai centri di servizio. Il web che nasce come luogo di presentazione di un soggetto (Lie-vrouw e Livingstone 2007; Jenkins 2007; Castells 2001), in questo senso è una cartina al tornasole attraverso cui testare gli elementi maggiormente rappresentativi in cui si sostanzia la comunicazione di un Centro di Servizio per il Volontariato. Quindi è lecito chiedersi: il sito web di un Centro quali servizi di informazione offre? E qual è la qualità delle informazioni pubblicate?Per rispondere alla prima domanda abbiamo suddiviso i servizi pro-posti in quattro categorie: le news; la rassegna stampa; gli studi e le ricerche sul volontariato; la newsletter. Nel primo gruppo rientrano quelle notizie che ci aspettavamo di trovare nella homepage del sito, contenuti generalmente posti in evidenza per la loro rilevanza e/o at-tualità. Infatti è possibile trovare notizie che si riferiscono al lavoro delle associazioni, agli aggiornamenti sulle iniziative attuate dai Cen-tri oppure la segnalazione di incontri ed eventi promossi dai Centri di Servizio per il Volontariato o dalle associazioni. La maggior parte dei siti dedicano un rilievo particolare alle notizie di natura amministrati-va, con riferimento a bandi di fi nanziamento o alle procedure in corso sulle agevolazioni fi scali disponibili. Trattandosi in questo caso di una
1 Si vedano a questo proposito l’articolo 18 e 118 della Costituzione della Repub-blica Italiana. Nel primo viene sancito il diritto per i cittadini italiani di associarsi liberamente mentre il secondo articolo, dopo le revisioni apportate dall’art. 4 della legge costituzionale numero 3 del 2001, garantisce il principio di sussidiarietà che intercorre tra gli organi pubblici e le iniziative dei cittadini per lo svolgimento di at-tività di interesse generale.

44
quantità di contenuti in costante evoluzione, diventava essenziale analizzare la frequenza di aggiornamento delle news.
All’ultima settimanaAd oggiAll’ultimo meseA ieriNon ci sono news sul sito
Figura n.1 – La frequenza di aggiornamento delle news – Anno 2010
3 (5%)
6 (9%)
7 (11%)
16 (25%)
32 (50%)
A quando risale l’ultima news in homepage?
Totale dei casi 64
Fonte: nostre elaborazioni
La metà dei siti del Coordinamento nazionale aggiorna le news con cadenza settimanale, mentre 22 siti (pari al 34% dei casi studiati) propongono un aggiornamento giornaliero delle notizie o ogni due giorni. Solo in una percentuale residuale (7 siti, pari all’11%) si ri-scontra l’aggiornamento mensile delle news e in casi ancora minori la totale assenza di notizie sul sito. L’attenzione diffusa alla dimensione delle news e all’aggiornamento dei contenuti denota la vocazione “informativa” dei Centri che, attraverso lo strumento del sito web, co-stituisce il primo servizio offerto alla propria utenza. Da notare come lo stile usato si adatti bene alle peculiarità del mezzo. I testi proposti sono sintetici, effi caci e completi: aspetti questi che denotano una particolare attenzione alla presentazione della notizia, in linea con una vena quasi giornalistica, insieme ad una capacità di proporre notizie brevi, adatta alla lettura più veloce e meno impegnata tipica del web. A corredo di questo ultimo dato è da segnalare la presenza di link di approfondimento e la possibilità di per documenti ulteriori sugli argomenti trattati.Se la gestione dei contenuti testuali rispetta quelle che sono le ca-ratteristiche da seguire per una corretta presentazione delle notizie su un sito, il discorso è differente per quanto riguarda l’uso di foto

45
e immagini. Negli ultimi anni si è andata affermando una crescente presenza iconografi ca sul web, comprovata dai siti dei principali quo-tidiani nazionali, come all’esplosione di immagini e scatti dei maggiori social network, fi no ad arrivare all’uso ‘tattile’ delle immagini grazie ai dispositivi touchscreen: una tendenza che conferma la capacità fortemente evocativa delle immagini sul web, oltre che di sintesi – soprattutto se di accompagnamento ad un testo – e che attraverso l’evoluzione dei nuovi supporti tecnologici porta necessariamente a riconsiderare, e a rivalutarne, la portata. Nel nostro caso sono invece solo 20 (il 30%) i siti che utilizzano regolarmente immagini a com-pletamento delle notizie; 11 siti (16%) pubblicano immagini saltua-riamente, mentre 37 Centri di Servizio (54%) non pubblicano mai o quasi mai foto o immagini nei loro siti web. Laddove invece si dà la presenza di foto a supporto del testo, troviamo quasi sempre delle im-magini tecnicamente di buona qualità (in alta risoluzione e con buoni tempi di caricamento) ma senza un contenuto coerente ed esplicati-vo a supporto delle notizie: un elemento questo che provoca l’effetto anonimo creato da immagini fuori contesto e che si accompagna, in alcuni casi, ad un uso parsimonioso di foto e immagini nell’ambito dell’intero sito.Per quanto riguarda il secondo gruppo di contenuti, i dati ci dicono che la rassegna stampa è presente nella maggioranza dei casi e libe-ramente accessibile all’utenza. I temi trattati riguardano sia il mondo del volontariato e del terzo settore che i temi del sociale: una prospet-tiva, quest’ultima, che denota un approccio culturale di ampio respiro verso gli argomenti tipici del settore. In più la frequenza di aggiorna-mento è quotidiana o settimanale. A tale proposito è da segnalare un elemento altrettanto positivo e indicativo dell’interesse dei Centri verso l’approfondimento sui temi del Terzo settore.Ricerche e pubblicazioni sul volontariato, il terzo gruppo all’interno del quale abbiamo classifi cato i contenuti da analizzare, sono una presenza costante nelle pagine dei siti web, declinate in modi e stili molteplici. Anche nei casi in cui mancano delle sezioni appositamen-te dedicate troviamo in differenti aree del sito rimandi a ricerche o ad altri approfondimenti. Possiamo defi nirla come una sintesi della

46
vocazione al servizio rappresentata dal Centro di Servizio per il Vo-lontariato. L’attenzione verso l’informazione è confermata inoltre dalla possibilità in molti siti di consultare o scaricare liberamente i materiali a disposizione, offrendo solo in alcuni casi un’anteprima dei contenuti che precede la richiesta del testo cartaceo.Discorso a parte merita invece la newsletter. Il servizio offerto è stato analizzato a seconda di due caratteristiche differenti ma complemen-tari: la fi nalità informativa, ed è quella di cui ci occuperemo in questo paragrafo, e l’interattività, di cui si parlerà nel quinto capitolo. Riguar-do al primo aspetto, a fronte di una diffusa disponibilità alla condi-visione di materiale e allo scambio di informazioni che si riscontra all’interno dei siti, l’uso e la gestione delle newsletter risulta ancora disomogeneo.
Sì, con una periodicitàsettimanale/quindicinaleSì, ma non ha una periodicità precisaNo, non c’è nessuna newsletterSì, con una periodicità tra il mensile el’annuale
Figura n.2 – Possibilità di iscriversi/consultare una newsletter – Anno 2010
2 (3%)
15 (24%)
17 (28%)
28 (45%)
È possibile iscriversi/consultare una newsletter?
Totale dei casi 62
Fonte: nostre elaborazioni
Troviamo infatti 28 siti (45%) che offrono la possibilità di iscriversi e di consultare una newsletter con una periodicità settimanale o quindici-nale, ma oltre questo dato positivo si registra l’assenza di una periodi-cità precisa per 17 Centri, mentre in altri 15 casi assistiamo alla totale assenza di comunicazioni da parte dei Centri tramite una newsletter. Dove incontriamo questo servizio esiste spesso un archivio delle co-municazioni inviate (19 siti, il 34%): ma su 6 siti (l’11%) questa ‘me-moria’ non è aggiornata, e in ben 30 Centri, pari al 55% dei casi è del tutto assente. I contenuti inviati tramite newsletter molto spesso sono

47
ripresi dalle notizie del sito, mentre sono ancora una percentuale mi-noritaria le newsletter redatte con materiale originale appositamente creato per gli utenti registrati. I dati raccolti ci suggeriscono che l’in-serimento di contenuti inediti in futuro potrebbe costituire un’occa-sione utile, fi no ad ora non pienamente sfruttata, per attrarre nuovi utenti al servizio e per offrire ulteriori contenuti agli utenti già iscritti, implementando in questo modo la vocazione informativa che si pone come primo – e basilare – requisito delle attività dei Centri.
3. L’attenzione alla formazione: dal sapere al saper fare servizio
La crescente rilevanza del volontariato come parte integrante della società civile e come catalizzatore della partecipazione sociale ha reso la formazione un elemento strategico nello sviluppo del settore non profit. Innanzitutto, l’acquisizione di competenze specifiche rende le organizzazioni di volontariato autonome e affidabili su mol-teplici fronti di intervento e le conoscenze acquisite costituiscono un momento privilegiato di apprendimento e di creazione di competen-ze chiave sia per i volontari che per la cittadinanza. Come afferma Daniele Baggiani (2011, 23-24), autore di un volume incentrato sulle competenze e i fabbisogni formativi del volontariato:
le conoscenze e le competenze oggetto delle azioni formative che coinvolgono i volontari e le associazioni sono di un genere particolare: servono a porre in atto in modo corretto e costruttivo azioni di mutuo-aiuto volte a far crescere le persone e a conso-lidare il legame sociale, promuovendo le risorse relazionali di fi ducia e della cura reciproca. Questo suo scopo primario ne fa un momento prezioso di educazione degli adulti alla relazione, alla reciprocità, alla solidarietà, alla civiltà, intesa come diffu-sione, attraverso la gratuità e il dono, del senso civico e delle obbligazioni che ne discendono.
Negli ultimi anni, dunque, il tema della formazione dei volontari delle associazioni nazionali e gli organismi rappresentativi è diventato un nodo centrale nelle rifl essioni sulla cultura del volontariato, soprattutto per ciò che riguarda i contenuti, le modalità di erogazione di percorsi formativi e come questi elementi incidano sulla qualità del servizio

48
offerto dalle associazioni. Il tema della formazione, come abbiamo avuto modo di vedere in tempi recenti anche in occasione del terre-moto in Abruzzo, è approdato oltre il settore del non profi t, nell’ambito di una rifl essione teorica più ampia su questo tema (Martelli 2009; Rossi e Boccacin 2006). Quando si opera di fronte all’opinione pub-blica, soprattutto in occasione di grandi emergenze, le competenze dei volontari diventano il biglietto da visita, il tratto costitutivo e distin-tivo della natura stessa dell’attività di volontariato, ed evidenziano la necessità di una preparazione mirata che, al di là del senso di solida-rietà, sia uno strumento di apprendimento e di rifl essione “per capire meglio il senso del proprio impegno rispetto al contesto sociale di riferimento” (Rossi 2005, 73).Quindi occorre disporre di un sapere che sia condizione necessaria e preliminare del fare, o meglio, di un “saper fare”, che sia motore delle azioni che guidano i volontari, in cui “fare e pensare” non possono essere intesi come momenti uno successivo all’altro (Ciotti 2002, 5), ma diventano spazi inscindibili dove la cultura e l’approfondimento vadano di pari passo con l’azione. I Centri di Servizio per il Volontaria-to svolgono un ruolo “catalizzatore” per lo sviluppo di questi processi di formazione perché pubblicano e pubblicizzano i corsi organizzati dalle associazioni o da enti esterni e organizzano (in via esclusiva o in partnership) percorsi di formazione diretti alle associazioni. Dai dati raccolti arriva una prima conferma dell’attenzione dei Centri per la formazione: 65 siti su 71 (il 92%, con una distribuzione omoge-nea in tutte le aree geografi che del Paese) presentano una sezione dedicata alla formazione. Da una parte, troviamo notizia di attività e corsi di formazione tradizionali realizzati dalle associazioni in 55 siti (l’81% dei casi), mentre dall’altra non si registra ancora un interesse rilevante verso la formazione a distanza (Fad), al momento proposta solo da 7 siti (il 7%) che pubblicizzano corsi gestiti da associazioni del territorio. Le proposte di corsi tradizionali o a distanza si arricchiscono inoltre di altri appuntamenti, come ci dicono i 59 siti (l’86%) che pubblicano informazioni relative ad attività formative ed eventi episodici con una valenza formativa organizzati sia dalle associazioni che dal coordina-

49
mento nazionale. Non mancano gli spunti che arrivano dalle attività formative organizzate da soggetti differenti dal volontariato. Benché siano solo 25 (il 37%) i siti di Centri di Servizio per il Volontariato che promuovono iniziative adottate da centri di studio, enti pubblici o pri-vati, il dato rileva una tendenza interessante di apertura e di sinergia con soggetti differenti da quelli operanti nel settore specifi co del vo-lontariato, o quantomeno, dell’associazionismo. In aggiunta a questo dato, è interessante notare la promozione di percorsi espressamente dedicati alla progettazione di interventi formativi, in pratica “una for-mazione per fare formazione”: praticamente la metà dei Centri pos-siedono una sezione visibile e aggiornata interamente dedicata alla segnalazione di bandi di fi nanziamento e 17 siti (un quarto) danno un pacchetto minimo di informazioni in tal senso all’interno delle news. Ma a chi sono rivolti questi percorsi? Un’informazione interessante arriva proprio dalla tipologia di utenza. Si tratta, in 38 casi (56%), di attività formative offerte ai volontari nel senso più ampio del termine, iscritti e non, alle associazioni di volontariato; a seguire, troviamo in-vece 20 siti (30%) che dedicano questo tipo di notizie a chiunque sia interessato ai temi proposti. Così anche se le proposte sono diret-te prevalentemente ai volontari, l’ultimo dato denota un’attenzione al coinvolgimento di fasce più ampie della popolazione, in linea con uno dei principali obiettivi dei Centri, ossia la promozione della cultura del volontariato da parte di almeno un gruppo di enti.Il capitolo giovani. La maggioranza dei Centri di Servizio per il Volon-tariato dedica un’attenzione particolare a percorsi formativi dedicati alle nuove generazioni, nello specifi co al mondo scolastico. Infatti, in 42 dei siti analizzati (il 62% del totale) presenta attività o progetti in cui sono coinvolte le istituzioni scolastiche e il 59% offre notizie e aggiornamenti relativi a progetti extrascolastici dedicati ai giovani. Nell’ambito di questo fi lone si inseriscono, ad esempio, le informa-zioni attinenti al servizio civile di cui è possibile operare una doppia lettura: le sezioni relative al servizio civile svolgono sia una funzione formativa, in quanto primo passo per un percorso formativo nel cam-po del volontariato, che di supporto alla promozione della cultura del volontariato, come vedremo più avanti. Nel primo caso, il 79% dei

50
siti offre una serie di informazioni e di approfondimenti sui progetti a disposizione nello stesso Centro o in altre associazioni di volontariato, e il fatto di dedicare una sezione specifi ca a questo tema dimostra la crescente visibilità che tale opportunità sta assumendo nella forma-zione dei giovani al volontariato.Di fronte ad un così variegato elenco di percorsi e incontri formativi promossi da differenti soggetti, è da segnalare la presenza marginale di percorsi formativi fi nalizzati alla comunicazione. Nel periodo da noi monitorato solo 8 Centri di Servizio per il Volontariato (12%) hanno proposto, attraverso le pagine web del sito, incontri, corsi di forma-zione o concorsi per la realizzazione di campagne di comunicazione (un requisito che sta diventando indispensabile per le associazioni, per quelle grandi come per le piccole realtà). E l’esigenza di un ap-profondimento sulla materia arriva anche dalla parole degli operatori della comunicazione dei Centri (di cui si parlerà più analiticamente nella seconda parte del libro). Un segno questo che conferma la for-mazione come parte del Dna dei Centri di Servizio per il Volontariato, sia come percorso di apprendimento continuo per le associazioni al fi ne di incrementare conoscenze già acquisite o da apprendere, sia come occasione di empowering delle risorse interne.Per concludere, possiamo dire che si ritrova manifesto nei siti dei Centri di Servizio per il Volontariato analizzati l’interesse a suppor-tare e organizzare percorsi formativi a vari livelli, tra un sapere che sviluppa la capacità di progettazione e di gestione di tali percorsi a una conoscenza che sia in grado di farsi “valore civico” per le nuove generazioni. In questo senso, l’interesse dei Centri nei confronti della formazione, quello che abbiamo defi nito come il Dna dei Centri di Servizio per il Volontariato, trova la propria cifra identitaria nella ric-chezza delle proprie proposte formative, che coniuga il ‘fare’ ad una dimensione più ampia e collettiva della propria azione. Una forma-zione dunque i cui effetti ricadono, come già rilevato anche da Laura Solito e Carlo Sorrentino in una recente ricerca sulle immagini e le percezioni del volontariato, “sulla più generale crescita culturale del volontariato, sull’acquisizione di competenze specifi che e di profes-sionalità” (2011, 57).

51
4. Bilanci pubblici: le nuove tecnologie a servizio della trasparenza
Un altro settore in cui esaminare la vocazione informativa dei Centri di Servizio per il Volontariato è quello delle notizie inerenti alle questioni amministrative. La dimensione online in questo senso può giocare un ruolo strategico per due motivi. Innanzitutto, il sito può mettere a disposizione un archivio di documenti e materiali agevolmente fruibile che costituisce una sorta di desk professionale per quanti operano in questo settore. In secondo luogo, la necessità di offrire dei servizi in materia di rendicontazione e di fund raising ad associazioni e volon-tari può costituire per gli stessi Centri un segno di responsabilità su questioni che richiedono un’assoluta trasparenza e comprensione.Per questa area abbiamo rilevato la presenza di quattro oggetti: ban-di di fi nanziamento; cinque per mille; fund raising; bilancio sociale. 34 siti dei Centri di Servizio per il Volontariato dedicano un’apposita sezione, ben visibile e aggiornata, alle iniziative dedicate al fi nanzia-mento di percorsi formativi, e 17 (quasi un quarto del totale) inserisco-no tra le news almeno la segnalazione di questo tipo di progetti. Le tipologie dei bandi pubblicati in 47 casi (71%) possono contenere un mix di informazioni che vanno dalle notizie di bandi di livello comuni-tario e locale; 7 siti web, pari all’11%, offrono bandi esclusivamente a carattere nazionale, mentre 12 (18%) danno informazioni unicamente riguardo a bandi locali. Si tratta in particolare di concorsi che consen-tono l’accesso a fi nanziamenti pubblici.Per quanto concerne il cinque per mille, 16 siti (23%) dedicano all’ar-gomento un link ben visibile sin dalla homepage, 39 (54%) inserisco-no almeno un richiamo all’interno del sito, mentre 16 siti (23%) non pubblicano alcuna informazione in proposito. Queste percentuali, che da una parte denotano dei progressi, ma dall’altra denunciano una si-tuazione di disomogeneità, rifl ettono l’andamento incerto che sconta questo tema, soprattutto a causa alle controversie politiche che cicli-camente si verifi cano in occasione della pubblicazione dell’annuale legge fi nanziaria (Carulli 2011).Discorso a parte merita invece il fund raising. Le informazioni e i ser-vizi utili per organizzare le attività mirate alla raccolta fondi, laddove

52
presenti, non hanno una collocazione riconoscibile all’interno dell’ar-chitettura informativa del sito, e nella maggioranza dei casi non è possibile reperire informazioni in proposito. Infatti 36 siti, pari al 51%, non offrono alcun contenuto sul tema: 28 (39%) forniscono materiali e informazioni sulle iniziative ma li spalmano in modo confuso nell’in-tero sito, in assenza di un’apposita sezione che organizzi eventuali percorsi tematici; 7 (appena il 10%) dedicano una sezione al fund raising.Considerate queste prime tre categorie di contenuti possiamo dire che l’attenzione dei Centri nei confronti delle attività relative al fund raising è di tipo “istituzionale”. Emerge, infatti, una grande attenzione verso il cinque per mille, sia per le sue implicazioni “politiche” sia per gli adempimenti pratici a cui le associazioni devono sottoporsi per usufruire di questa possibilità (ad esempio sono pubblicate informa-zioni per la presentazione della domanda oppure la modulistica). An-che per gli approfondimenti inerenti le agevolazioni e i contributi pub-blici spettanti alle onlus troviamo informazioni precise e dettagliate. Al contrario, però, più del 50% dei Centri non pubblica informazioni o materiali di alcun tipo per l’organizzazione di una raccolta fondi e per supportare la gestione di tali attività. Il discorso si può estendere an-che all’esiguità di percorsi formativi centrati sull’acquisizione di com-petenze comunicative spendibili nel fund raising. Infatti da questi dati emerge che il reperimento delle risorse al di fuori dell’ambito ammini-strativo è collocabile in una dimensione quasi “privata” delle associa-zioni, caratterizzata da differenti pratiche di reperimento dei fondi a totale discrezione delle singole realtà non profi t. Questa discrezionali-tà nella ricerca delle risorse, non contribuendo a dare forma compiuta a linee guida condivise in grado di valorizzare i contributi provenienti dai singoli centri, evidenzia la carenza di termini di confronto tra le esperienze, perlomeno a livello delle attività online. Considerata la crescente importanza delle pratiche di socializzazione su cui lavora il web, la Rete potrebbe invece costituire un valido spazio di supporto e riscontro su questo tema.Se i primi tre tipi di informazioni a carattere gestionale concorrono a vario titolo al reperimento delle risorse, lo strumento del bilancio

53
sociale si discosta da questo genere di contenuti per via della sua natura ambivalente. La pubblicazione del bilancio sociale infatti non solo risponde all’esigenza di rendere manifesta l’attività di un’orga-nizzazione, e quindi di dare conto dei processi che sottintendono i suoi risultati, ma soprattutto rende conto della necessità di mantenere sempre attivo il dialogo con i soggetti coinvolti in tale attività. Secondo Luca Bagnoli (2007), autore di una guida pratica per la realizzazione del bilancio sociale per le organizzazioni di volontariato, tre sono le fi nalità alla base della costruzione di un bilancio sociale. La prima è l’esigenza di rendicontare le attività svolte: ossia informare gli stake-holder e l’utenza sugli obiettivi dell’ente e sui percorsi intrapresi per raggiungerli, ed evidenziare quali sono i risultati raggiunti in relazione ai soggetti coinvolti. La seconda consiste nella necessità di comuni-care, attivando un canale di scambio, sia con gli interlocutori esterni che interni, con l’obiettivo di raccogliere suggerimenti e osservazioni in merito ai risultati presentati. La terza fi nalità è la possibilità di realiz-zare forme di controllo della gestione sociale attraverso la valutazione della corrispondenza tra le attività svolte e la mission su cui si fonda l’operato di un’organizzazione. Nel nostro caso, si riscontra un interesse diffuso, ma non in modo omogeneo, su questo tema. Un terzo dei Centri (24) pubblica sul sito una sezione dedicata, con informazioni pratiche sulla redazione del bilancio e con la segnalazione di iniziative – esterne o organizzate dallo stesso Centro di Servizio per il Volontariato – mirate alla costru-zione di competenze spendibili nell’ambito della rendicontazione. In 20 casi, il 28%, in assenza di una sezione apposita, troviamo infor-mazioni in vari spazi del sito su materiali, corsi e iniziative. Restano ancora, a fronte di un interesse più o meno specifi co sull’argomento, una carenza di informazioni sul tema in un numero signifi cativo di siti. Questa organizzazione a macchia di leopardo delle informazioni sul bilancio sociale fornite alle associazioni trova un riscontro più netto per quanto riguarda la pubblicazione del bilancio da parte degli stes-si Centri: 31 siti (44%) pubblicano un documento di rendicontazione ma sono 38 (54%), un numero ancora consistente, i Centri che non presentano alcun feedback al riguardo.

54
5. La promozione a servizio della cultura del volontariatoCome abbiamo visto nei paragrafi precedenti, un Centro di Servizio per il Volontariato ha come obiettivo quello di offrire servizi alle asso-ciazioni di volontariato, sostenendone e qualifi candone l’attività. Ma negli spazi online, aperti ad una utenza potenzialmente illimitata e con molteplici profi li, i servizi offerti si rivolgono esclusivamente alle asso-ciazioni? O la portata del proprio mandato a sostegno del volontariato abbraccia ben altre categorie di soggetti interessati a questo tema? I contenuti sono tarati unicamente sulle esigenze di chi già possie-de un bagaglio di esperienze coerente con gli argomenti affrontati o sono adeguati anche per chi non possiede conoscenze pregresse in questo campo? Queste domande nascono in considerazione del ruo-lo di promozione del volontariato e della solidarietà che è il fi ne ultimo, implicito, di questi centri.Abbiamo analizzato dunque i progetti con fi ni promozionali presentati sui siti del campione. Tra questi, 15 siti (21%) dedicano una sezione al servizio civile, corredata da testi dettagliati che illustrano le oppor-tunità offerte dai progetti promossi dalle associazioni di volontariato. Un numero rilevante di siti, ben 28 siti, pari al 39%, offre testi generici sulle possibilità di prestare servizio nel mondo del volontariato, a cui seguono 15 Centri (il 21%) che non pubblicano alcuna informazione in merito. 13 siti (il 18%), invece, contengono una sezione con infor-mazioni relative ad un progetto del Centro. In defi nitiva si conferma un atteggiamento positivo verso la promozione di questo genere di opportunità, soprattutto se consideriamo il servizio civile come primo passo per avvicinare la fasce giovanili della popolazione ad un’espe-rienza di volontariato, nonostante le diffi coltà che spesso accompa-gnano lo stanziamento dei fondi per i progetti. Un ulteriore dato si accompagna alle percentuali relative alle informa-zioni sul servizio civile. Per approfondire la conoscenza del sociale e del volontariato 28 siti dei Centri (il 39%) dedicano una o più pagine con link che rimandano ad altre strutture (enti non profi t e pubblici, biblioteche, centri di ricerca), in 27 (il 38%) troviamo link o riferimenti sporadici a soggetti differenti rispetto al Centro o al Coordinamento nazionale; invece per quanto riguarda 16 siti (23%) non ci sono ri-

55
mandi a soggetti esterni ma solo a informazioni più autoreferenziali relative ai soggetti del circuito dei Centri di Servizio. In un’ottica più ampia, la presenza sui siti di segnalazioni di eventi culturali, recensioni e approfondimenti su pubblicazioni non promos-se da un Centro di Servizio per il Volontariato o dal Coordinamento nazionale trova una collocazione variegata. Il mondo del sociale che emerge dalle pagine di 36 siti (la metà del campione) è composto uni-camente dalle associazioni e da organizzazioni di volontariato. Solo 19 Centri (27%) propongono diversi riferimenti ad altri soggetti mentre 15 siti (il 21%) offrono ancora poche informazioni al riguardo. Quindi, in sintesi, abbiamo meno del 40% dei Centri presi in esame che pre-senta pagine con riferimenti a soggetti esterni per approfondire i temi relativi al volontariato, evidenziando un interesse all’approfondimento del volontariato, anche se è demandato a strutture esterne. Mentre una percentuale ancora più bassa pubblica recensioni di pubblica-zioni o eventi culturali legati al volontariato provenienti da soggetti al di fuori del circuito dei Centri di Servizio per il Volontariato, facendo emergere l’assenza di uno spazio pubblico di rifl essione culturale sui temi legati alla promozione del volontariato.In conclusione, i Centri di Servizio per il Volontariato, operando su più livelli organizzativi e su molteplici fronti di intervento sociale, atti-vano quelle relazioni solidali, quelle “trame di relazioni signifi cative e solidali” (Mazza e Morcellini 2008, 76), e promotrici della cultura del volontariato che sono distintive degli attori che operano nella comu-nicazione sociale. Attraverso l’informazione e i servizi danno forma e sostanza a questo mandato, in una prospettiva di continua valorizza-zione dei soggetti con cui lavorano – nel rapporto con le associazioni del territorio e all’interno di un coordinamento nazionale: ma l’aper-tura a soggetti differenti, “altri” rispetto al Coordinamento nazionale, potrebbe creare uno spazio di confronto e rifl essione sui temi del vo-lontariato in grado di dare concretezza ad una “cultura del servizio” verso la cittadinanza che è già nel Dna dei Centri.




59
Capitolo 4Le reti del volontariato. Fra i Centri, con il Coordinamento, sul territorio
di Alessia Ciccotti
1. I Centri di Servizio per il Volontariato e la cultura di rete: le opportunità offerte dal web
Nel presente capitolo si affronterà il tema della rete, o meglio delle reti, in cui il sistema dei Centri di Servizio per il Volontariato si organiz-za. La parte della ricerca qui illustrata si sofferma infatti sul tentativo di valutare se e con quali strumenti della comunicazione online i Cen-tri si impegnano nella promozione della cultura di rete e della rete di Csvnet, e se esistono collaborazioni con soggetti della società civile del territorio di riferimento. Da un punto di vista operativo, al fi ne di rispondere a tali interrogativi, i ricercatori nel lavoro di monitoraggio dei siti web hanno utilizzato tre punti di osservazione. Il primo riguarda la capacità dei Centri di Servizio per il Volontariato di fare rete, attraverso le attività e i servizi offerti, ma soprattutto attraver-so la comunicazione, in particolare quella online, tra le loro strutture, diverse per dimensioni, per specifi cità del territorio in cui nascono ed operano e per tipo di associazioni che vi aderiscono. Il secondo punto di vista è volto alla valutazione dei rapporti esistenti tra i Centri e il Coordinamento nazionale, nell’intento di verifi care da un lato il grado di corrispondenza e somiglianza delle identità visive dei siti internet, vale a dire la capacità dei singoli Centri di mostrarsi online in maniera coordinata al sito di Csvnet, dall’altro il livello e le modalità di utilizzo della comunicazione erogata dal Coordinamento nazionale da parte dei singoli Centri, attraverso gli strumenti offerti dal web. Infi ne ci si è soffermati sullo studio delle relazioni, degli scambi e delle sinergie che i Centri riescono ad instaurare sul proprio territorio di riferimento, sia con le associazioni aderenti sia con altri enti locali, quali le istituzioni o le imprese, cercando di valutare quanto (e cosa)

60
di tali rapporti emerge o viene favorito dal mezzo internet. Il tema delle reti del volontariato è stato affrontato anche attraverso il questionario sottoposto ai responsabili della comunicazione dei vari Centri, chiamati a rispondere in maniera più diretta ed esplicita sulle interazioni e sugli scambi comunicativi con il Csvnet, nonché sull’uti-lizzo, da parte dei Centri di Servizio per il Volontariato, dei materiali provenienti dal Coordinamento nazionale. I referenti sono stati inol-tre interrogati sui rapporti dei rispettivi Centri con le realtà associati-ve, istituzionali e imprenditoriali locali, sulla visibilità e la presenza di queste strutture nei territori di riferimento. L’analisi dei dati emersi dal monitoraggio è stata quindi integrata con le spiegazioni e gli spunti offerti da alcuni operatori. Le tre dimensioni di rete indagate nel corso della ricerca (la rete dei Centri di Servizio per il Volontariato, quella con il Coordinamento nazionale e quella sul territorio) verranno illu-strate separatamente: a ciascuna di esse, anche per facilitare la lettu-ra e la comprensione per il lettore, è stato infatti dedicato un apposito paragrafo.La diffusione di internet, la Rete per eccellenza, ha contribuito alla diffusione di un paradigma della rete e della relazionalità nelle scien-ze sociali e organizzative. Questo capitolo nasce proprio con l’idea di indagare i processi e gli effetti di tale paradigma nel mondo del non profi t: capire cioè se il web può rappresentare un mezzo, un luogo, un modo alternativo di partecipare e di impegnarsi. Inoltre, la capacità di creare reti e legami tra le persone è proprio una delle caratteristiche distintive del volontariato e del non profi t; sviluppare relazioni signifi -cative, rapporti sociali fondati sul sostegno, l’ascolto e la cooperazio-ne reciproca è una delle ragioni principali che spingono le persone a praticare attività di volontariato (Ranci 2006, 64). Tra i due mondi qui indagati sembrano dunque intercorrere profonde analogie. Caratteristiche principali del web sono, ad esempio, la possibilità di interazione, la gratuità di molti servizi o prodotti a disposizione di chiunque, la possibilità di condividere e scambiare materiali, docu-menti, foto, ma anche pensieri e idee.
Per via delle dinamiche sociali che animano la produzione e la distribuzione dei contenuti, associate a una diffusione ormai su vasta scala della rete di comunicazione, gli strumenti del web

61
2.0 sono chiamati anche social media, media sociali (Maistrello 2010, 31).
Negli ultimissimi anni ai media sociali si è riconosciuto un ruolo rile-vante non solo nella nascita e nella diffusione di fenomeni e eventi culturali organizzati online, ma anche in proteste partite da gruppi di Facebook, fl ash mob, movimenti politici come quello dei ‘grillini’, per non parlare della primavera araba. Seppur diverso, il volontariato è anch’esso animato da azioni che partono dal basso. Il volontariato è condivisione, scambio, interazione, offerta gratuita di sé e delle pro-prie capacità. Il volontariato produce partecipazione sociale e coin-volgimento collettivo, perché spinge le persone ad associarsi insieme e a contribuire al benessere della società. In fondo, sebbene i volon-tari non scendano in piazza (Ranci 2006, 77- 87) un bisogno almeno accomuna la decisione di diventare un volontario e quella di creare un blog: la voglia di esprimersi, la voglia di esserci, di partecipare e di condividere obiettivi o opinioni comuni con altre persone, per quanto simili o diverse da noi, per quanto vicine o lontane possano trovarsi.
2. La rete tra i CentriLa parte di ricerca qui presentata indaga quanto e cosa della dimen-sione di rete che il sistema dei Centri di Servizio per il Volontariato è riuscito a costruire sul territorio, se c’è riuscito, viene rappresentato, veicolato e stimolato anche attraverso il web. In particolare lo studio si è concentrato sulla visibilità che i Centri ri-cevono e al tempo stesso offrono sui propri siti internet agli altri enti che costituiscono la struttura qui indagata; sui rapporti che questi instaurano fra di loro e sugli elementi che più rappresentano, laddove presenti, la percezione dei Centri di appartenere ad una rete.Come già detto nei capitoli precedenti, i Centri di Servizio per il Vo-lontariato nascono all’inizio degli anni Novanta per costruire delle reti tra le associazioni di volontariato, favorendo scambi, collaborazioni e sinergie. Tuttavia i Centri costituiscono, o dovrebbero costituire, una struttura ramifi cata e disseminata sul territorio nazionale allo scopo di sostenere e stimolare il volontariato italiano, ma anche di osservarne le trasformazioni, valorizzandone i pregi, smussandone i difetti, rile-vandone in anticipo problematiche e necessità. Proprio tali fi nalità e

62
una struttura così estesa ed eterogenea al suo interno per dimensio-ni, campo d’azione, orientamenti politico-ideologici delle associazioni dimostra l’alto grado di rappresentatività del volontariato italiano da parte del sistema dei Centri. Perciò queste strutture si rivelano dei soggetti particolarmente interessanti per lo studio della dimensione di rete in generale; una dimensione che negli ultimi anni sta acqui-stando una rilevanza sempre maggiore per la vita delle associazioni, per la gestione dei territori o per l’organizzazione e l’erogazione dei servizi. Per quanto riguarda questo aspetto, gli esiti della ricerca han-no evidenziato che i Centri non dedicano troppo spazio, sul proprio sito, ai propri simili. I numeri parlano di soli 27 siti, sui 71 analizzati, che riportano nella homepage, in qualsiasi punto di essa, il nome di un altro Centro di Servizio per il Volontariato. Osservando le sezioni dedicate alle notizie e all’informazione su attività e servizi, è emerso inoltre che solo 7 sono i siti in cui si trova un riferimento ad un altro Centro nei titoli delle ultime 5 notizie. Accade più di frequente, invece, di leggere il nome di un altro Centro di Servizio per il Volontariato nei testi delle 5 notizie più recenti presenti in homepage.
Figura n. 1 – I soggetti “esterni” presenti sulle homepage dei sito dei Csv - Anno 2010
Nella homepage del sito c’è almeno un riferimento a...
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Un altro Csv Un ente pubblico
Un personaggio politico locale
Un’impresa
NoSì
2768 66
3 5
44
33
38
Fonte: nostre elaborazioni

63
Nel complesso i Centri sembrano invece sfruttare, anche se non pie-namente, la possibilità che internet offre di aprirsi all’esterno. Apprez-zabile, sebbene con ampi margini di miglioramento, appare l’attività di linking, una delle azioni precipue del web, che permette il continuo rimando da una pagina all’altra, da un sito all’altro, a documenti, im-magini o video, attraverso i collegamenti ipertestuali. 39 siti su 71 (pari al 57%) offrono link di approfondimento e materiali scaricabili. In altri 22 (il 32%), invece, vengono utilizzati solo alcune volte. L’importanza dei link sta nel fatto che trasformano un testo chiuso in un ‘ipertesto’, vale a dire in un contenuto aperto che può esplode-re in più direzioni ed avere molteplici prospettive, differenti modalità di fruizione e comprensione, a seconda degli interessi e dei bisogni informativi dell’utente/navigatore. Se ben utilizzati, dunque, essi of-frono l’opportunità di una conoscenza più specifi ca, approfondita e completa; opportunità ancor più interessante per enti come i Centri di Servizio per il Volontariato, e il Terzo Settore in generale, che faticano a far quadrare i conti, a trovare risorse economiche o professionalità e che, inoltre, si propongono di diffondere e promuovere temi e idee che riescono di rado a conquistare il ‘gatekeeper’ (Sorice 2001, 63-64). Proprio per questo non andrebbe mai sprecata la possibilità di bypassare l’intermediazione dei mass media e puntare direttamente al pubblico diventando fonte primaria di informazione e conoscenza (Binotto 2006, 134-140).Ma il vantaggio di utilizzare gli strumenti del web riguarda anche l’op-portunità di conoscersi e farsi conoscere, la possibilità di essere co-stantemente informati su cosa accade negli altri Centri, sulle attività, gli obiettivi pratici e politici, le problematiche e le possibili soluzio-ni. Gli stessi referenti della comunicazione, almeno secondo quanto emerso dalle interviste in profondità, sembrano avvertire questa esi-genza e in particolare la necessità di avere più occasioni di incontro nel corso dell’anno.È stato poi osservato come questa volontà di conoscersi, condividere opinioni, consigli e prospettive può rafforzare l’identità di gruppo, la rete dei Centri appunto, cioè la consapevolezza di far parte di un in-sieme, di partecipare ad una comune dimensione relazionale, mirata

64
a creare legami, scambi e socialità (Volterrani 2006, 107-108).Ma quali sono questi strumenti in grado di accrescere il livello di co-noscenza reciproca dei Centri di Servizio per il Volontariato? Nella parte della ricerca realizzata con l’aiuto dei responsabili si chiedeva loro proprio di indicare fra: telefono, fax, email, circolari, periodici, newsletter, sito, social network o altro, quelli più utilizzati nelle loro atti-vità di comunicazione. Praticamente tutti i Centri riconoscono la new-sletter, il sito web e la posta elettronica come gli strumenti più adatti e più utili al loro lavoro. In particolare dei 61 referenti intervistati, 57 (pari al 93%) hanno risposto di utilizzare maggiormente email e newsletter; sebbene con una differente, a volte indefi nita, periodicità, sono 47 gli uffi ci di comunicazione dei Centri che producono una newsletter; 60 infi ne (il 98%) sono gli operatori che mettono tra gli strumenti più utili alla propria attività anche il sito internet. Risulta evidente, quindi, il peso e la rilevanza attribuiti dagli uffi ci di comunicazione di questi enti alle nuove tecnologie. Quelli citati sono infatti tutti strumenti in grado di facilitare la comunicazione, e quindi l’informazione e la conoscen-za, sia all’interno del singolo Centro sia con gli altri, rendendola più immediata, veloce, comoda, diretta, ed economica. Tuttavia, abbia-mo riscontrato anche segnali di scarsa apertura all’esterno o ai ‘non addetti ai lavori’. Il primo è emerso dalle interviste in profondità: alcuni operatori hanno segnalato una carenza di contatti, rapporti o collabo-razioni con i Centri di altre province o regioni. Dal monitoraggio dei siti, invece, è risultato che nel 42% dei casi non c’è alcuna informa-zione rivolta agli utenti per farli avvicinare al mondo del volontariato; mentre in un quarto dei casi c’è un testo ma con informazioni del tutto generiche.Decisamente scarso è poi l’utilizzo dei social network che, in teoria, dovrebbero essere di facile utilizzo, anche più di un sito web, e fornire allo stesso tempo ottime opportunità in termini di visibilità, interazione, scambio e comunicazione, ancora una volta a costo zero. Di questo si parlerà però più in profondità nel prossimo capitolo; basti dire per ora che la potenziale utilità dei vari Facebook e Twitter è nettamente avvertita dagli addetti ai lavori, così come però è forte la convinzio-ne che per utilizzare al meglio i social network ci sia bisogno di una

65
fi gura appositamente dedicata, che al momento nei Centri è diffi cile individuare.
3. Il Coordinamento in ReteDal lavoro di monitoraggio dei siti internet dei Centri di Servizio per il Volontariato è emerso che un utente che casualmente si imbatta in uno dei siti del Coordinamento avrà meno del 5% di probabilità di co-gliere a colpo d’occhio l’esistenza della rete nazionale. E, anche nel caso in cui egli prolunghi un po’ la permanenza, avrà solo 2 possibili-tà su 3 di riuscire a percepire l’esistenza della rete nazionale. Al fi ne di analizzare la capacità dei Centri di alimentare la comuni-cazione tra centro e periferia, sfruttando le potenzialità del web per favorire la creazione di una cultura di rete, la ricerca si è soffermata sull’identità visiva dei siti, sul loro grado di somiglianza e corrispon-denza con quello del Csvnet; è stato inoltre osservato quanto e cosa degli input provenienti dal Coordinamento nazionale fi ltra nella comu-nicazione online dei Centri.Il dato fornito in apertura di paragrafo non lascia ben sperare. Ma andiamo ad illustrare quali sono i fattori principali che lo hanno deter-minato.Il primo di questi riguarda la presenza del logo del Csvnet, un ele-mento signifi cativo che dovrebbe richiamare in maniera rapida e l’esi-stenza della sovrastruttura nazionale. Dall’analisi dei 71 siti è risultato che ben 38 di questi (il 54%!), non riportano né il logo del Csvnet, né un link al suo sito. Dei restanti 33, solamente 3 presentano il logo, e gli altri solo un link.Il layout dei siti è un altro elemento che, se costruito sulla base di caratteristiche comuni ai Centri, potrebbe far percepire all’utente l’esistenza di una rete più grande; favorirebbe inoltre la distinzione e la riconoscibilità di questa rete rispetto ad altre. L’impatto e l’imme-diatezza che un’immagine complessiva può avere sull’utente è infatti molto forte. Tuttavia solo un Centro presenta un sito internet grafi -camente, esteticamente coordinato con quello del Csvnet; 14 inve-ce presentano solo alcune somiglianze nei colori o nel layout. Ma la maggior parte, 56 siti, pari all’80% del totale, non ha alcun riferimento

66
visivo al sito del Coordinamento nazionale. Spunti molto interessan-ti provengono dall’analisi degli aspetti fi gurativi. Innanzitutto i colori. Abbiamo rilevato i due colori principali che fanno da sfondo ai layout di ogni sito. Dalla classifi ca cromatica è emerso che i due più diffusi sono proprio quelli che fanno da sfondo al sito di Csvnet: il verde e l’arancio. Ma la loro supremazia rimane solo relativa. Essa è incalzata fortemente dall’accoppiata blu-celeste. Seguono poi il grigio, il mar-rone, il rosa.Un richiamo al Coordinamento potrebbe però essere suscitato dai ‘volti’ che i Centri hanno scelto di darsi, vale a dire i loro loghi. No-nostante anche in questo quadro la fantasia la faccia da padrona, fra i simboli di molti Centri si possono rintracciare delle analogie. In-nanzitutto, fi ori, alberi e cerchi sono le fi gure che, in varie declinazio-ni, forme e misure, più di frequente ricorrono. In una recente opera sull’immagine del volontariato toscano comunicata e percepita attra-verso il web, le prime due in particolare sono state associate ai valori dell’autenticità e della trasparenza (Solito e Sorrentino 2011). Su scala nazionale, sono presenti anche altri elementi naturali: un melograno, la margherita, l’erba, l’onda. Il cerchio, oltre ad essere presente come fi gura geometrica autonoma, dà forma, più o meno esplicitamente, a molte altre fi gure: alcuni soli, girotondi, la già citata margherita, un mappamondo. Si tratta evidentemente di richiami alla dimensione della rete, del mettersi insieme, del fare corpo con l’unione.
Figura n.2 – I colori predominanti nei siti dei Csv del Coordinamento nazionale - Anno 2010
Totale dei casi 71 Fonte: nostre elaborazioni

67
Per quanto riguarda invece l’analisi dei contenuti, il Csvnet non risulta tra i protagonisti principali. Sono 6 infatti i siti internet dei Csv che hanno un richiamo alla pagina di presentazione del Coordinamento nazionale; 27 gli dedicano un testo specifi co, che però non è facil-mente visibile o rintracciabile; più della metà invece, 38 su 71, non hanno alcuna informazione o forniscono al massimo un link di pre-sentazione. Tutti i Centri di Servizio per il Volontariato soci ricevono regolarmente da parte del Csvnet numerosi materiali, come la new-sletter, la circolare interna, le email e i comunicati stampa, attraverso i quali la struttura centrale informa e comunica con quelle locali. A tal proposito la ricerca ha voluto verifi care se i siti internet dei Centri riportano traccia di queste informazioni. Sebbene i materiali diffusi dal Coordinamento nazionale vengano utilizzati molto o abbastanza dall’82% dei referenti della comunicazione (in particolare dei 61 inter-vistati 38 hanno risposto di utilizzarli abbastanza e 12 molto), i risultati del monitoraggio hanno evidenziato che nel 60% dei siti (43 su 71) non è possibile distinguere le notizie provenienti dal Csvnet da quelle di altre fonti; 17 citano il Coordinamento nazionale quale fonte delle informazioni e solo 11 ne danno un’effi cace segnalazione. Più nel dettaglio, le risposte degli operatori della comunicazione han-no evidenziato quella che in fondo è la funzione e la ‘preoccupazione’ principale dei Centri, vale a dire il sostegno alle associazioni di volon-tariato che operano sui territori.Essi hanno infatti risposto che i materiali più utilizzati fra quelli pro-venienti dal Csvnet sono le notizie sul mondo del volontariato e quel-le relativa ai bandi o ad altre informazioni utili alla progettazione. Le prime sono state indicate dal 67% degli intervistati, cioè 41 su 61; le seconde invece dal 69%, cioè 42 su 61. Abbastanza equilibrato è poi il dato sugli strumenti che più di altri possono indicare l’immagine e la visibilità dei singoli Centri all’esterno; è emerso infatti che la rassegna stampa quotidianamente fornita dall’uffi cio stampa di Csvnet e i co-municati vengono utilizzati entrambi dal 49% dei referenti, vale a dire 30 su 61, praticamente la metà; infi ne le notizie sul mondo del sociale vengono riprese dal 48% e le informazioni fornite tramite il servizio Infocontinua dal 38%.

68
4. Le reti con il territorio Come già anticipato in apertura di capitolo, la dimensione di rete è stata analizzata anche dal punto di vista del territorio fi sico. La ricerca ha infatti indagato la capacità dei Centri di creare attraverso il web relazioni e scambi con altri soggetti del territorio. In particolare, si è concentrata sui loro rapporti da un lato con le associazioni aderenti, e dall’altro con le istituzioni, gli enti locali e il mondo imprenditoriale.Per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato, i dati più signi-fi cativi emersi dalla ricerca ci parlano di un rapporto sostanzialmente positivo tra queste e i Centri a cui aderiscono. A tal proposito, è sta-to rilevato che l’87% dei siti monitorati ha delle sezioni dedicate alla presentazione delle associazioni aderenti; il 42% di questi, inoltre, le descrive in maniera molto approfondita.La maggior parte (62%) dei referenti della comunicazione intervistati affermano di aver instaurato un buon rapporto con le associazioni cui si rivolgono, le quali risultano accedere con regolarità ai servizi che vengono loro offerti. In 19 casi, sui 61 considerati, questa relazio-ne risulta addirittura ottima, con una percezione di continua crescita nell’attenzione e nella fi ducia delle associazioni verso i Centri di Servi-zio per il Volontariato. Nessuno degli intervistati ha dichiarato di avere scarsi rapporti con le organizzazioni.Un’ulteriore conferma di questo legame è arrivata anche dalle inter-viste in profondità agli operatori della comunicazione, molti dei quali hanno sostenuto di avere numerosi e positivi feedback riguardo alla conoscenza e all’apprezzamento della struttura dalle associazioni lo-cali.Facendo ancora riferimento ai dati, relativamente al mondo istituzio-nale e degli enti pubblici, questi risultano essere gli interlocutori terri-toriali cui viene riservato il più alto grado di attenzione e visibilità sui siti web dei Centri presi in esame. In 33 siti (46%) dei siti monitorati, infatti, si trova almeno un rimando ad un ente pubblico nella homepa-ge e nel titolo. Sono addirittura 51 poi (72%) i siti che fanno riferimento a un ente pubblico nel testo di una delle ultime 5 notizie pubblicate. Questa attenzione ha trovato sostanziale conferma anche nelle rispo-ste dei referenti degli uffi ci comunicazione intervistati, la maggior par-

69
te dei quali, (40 su 61) afferma di mantenere un buon rapporto con le istituzioni e gli enti pubblici, e sostiene che c’è un continuo scambio di informazioni, nonostante l’inesistenza di qualsiasi tipo di tavoli di concertazione, permanenti o temporanei che siano.Molto scarsi, invece, gli spazi dedicati ad imprese e personaggi po-litici locali, di cui si rileva solo qualche cenno nelle notizie ma mai nei titoli o nella pagina principale dei siti.Infi ne, ci si è soffermati su cosa e quanto emerge dallo spazio web dei Centri relativamente alle loro relazioni con le fondazioni di origine bancaria e con i Coge, i Comitati di gestione dei fondi speciali per il volontariato; entrambi infatti rappresentano la linfa vitale e una fonte imprescindibile di sostentamento per i Centri. È stata proprio la legge istitutiva di queste strutture di coordinamento (266/1991) a stabilire che siano le fondazioni e i Coge, costituiti in ogni regione e nelle pro-vince autonome di Trento e Bolzano, ad erogare, gestire e distribuire fondi e fi nanziamenti al volontariato, tramite l’azione dei Centri.Non vanno, dunque, assolutamente trascurate l’incertezza e la de-bolezza di cui ancora soffre la versione online delle relazioni con il mondo fi nanziario e anche imprenditoriale. A tal proposito, l’indagine ha evidenziato come solo la metà dei siti analizzati, per la precisione 36, fanno menzione di banche e/o fondazioni. Di questi solamente 9 riportano almeno un link ad un’istituzione bancaria; sugli altri 34 inve-ce non ve n’è traccia alcuna.Lo stesso vale per i Coge: 42 siti, pari al 59% dei casi, non riportano nessun riferimento a questi enti; 15 presentano un semplice link al Coge del proprio territorio; solo 14 ne danno una descrizione appro-fondita.Appare poi sostanzialmente confermata dalle testimonianze degli operatori la debolezza delle relazioni con il mondo profi t nelle attività di promozione del volontariato sul territorio: il 36% degli intervistati ha risposto infatti di provare spesso a richiedere l’appoggio di imprese e/o sponsor, ma senza grandi risultati; il 30% ha addirittura risposto di non averci mai nemmeno pensato; il 26% infi ne trovano che il coin-volgimento e la collaborazione di aziende in attività di volontariato richieda tempo e risorse che il Centro non ha a disposizione! Solo

70
5 degli intervistati hanno risposto di cercare sempre il sostegno di sponsor e imprese private e di incitare anche le associazioni aderenti a fare lo stesso.Ai responsabili della comunicazione è stato anche chiesto di indicare il grado di visibilità che essi percepiscono per i propri Centri, sia sul territorio sia sui media locali, ed è emerso che, a parer loro, tali strut-ture hanno acquisito nel tempo una buona visibilità e nel mondo del volontariato locale e presso la cittadinanza. Intervistati in profondità, alcuni testimoni privilegiati hanno insistito proprio su questo fattore, sull’opportunità cioè di promuovere il rapporto fra i Centri e i cittadini del territorio.A tal proposito dai dati risulta che il livello di visibilità viene giudicato discreto (41% dei casi) o buono (27% dei casi) dalla maggior par-te dei referenti. Tuttavia gli stessi operatori della comunicazione non nascondono la diffi coltà nel portare avanti un rapporto con i giornali e i giornalisti. Infatti, per quanto riguarda le principali diffi coltà incon-trate nel lavoro di uffi cio stampa, sebbene la maggior parte dei refe-renti intervistati, 30% dei casi, sostenga di non incontrare particolari diffi coltà, un altro 28% ritiene che giornalisti e media locali abbiano diffi coltà a comprendere il mondo del volontariato; il 25% riconosce la necessità di un maggior impiego di mezzi e risorse da parte della propria struttura e per il restante 17% c’è uno scarso interesse per il settore non profi t da parte dei mezzi di comunicazione. Infi ne, il rapporto con i media locali anche dalle interviste in profon-dità non risulta propriamente idilliaco, bensì condizionato secondo gli intervistati da tre fattori in particolare: la scarsa competenza dei redattori, che in molti casi si trovano ad occuparsi solo saltuariamen-te di sociale, senza un adeguato background di conoscenze; il poco interesse verso queste tematiche, per mancanza di tempo o di spazio sui giornali; ed infi ne la consapevolezza che, per ottenere risultati quantitativamente, ma soprattutto qualitativamente migliori siano ne-cessarie maggiori risorse in termini sia di tempo che di professiona-lità.

71
Non ci sono grandi diffi coltà, il rapportoè soddisfacente
I giornalisti e i media locali hannodiffi coltà a comprendere il nostro mondo
Noi dovremmo dedicare più tempo e/orisorse al lavoro di uffi cio stampaI giornalisti e i media locali sonoscarsamente interessati al volontariato ealle nostre attività
Figura n. 3 – I problemi degli uffi ci stampa dei Csv – Anno 2010
11 (18%)
15 (25%) 17 (28%)
18 (29%)
Qual è la principale diffi coltà che incontra la sua organizzazione nel lavoro di uffi cio stampa?
Totale dei casi 61
Fonte: nostre elaborazioni




75
Capitolo 5Coordinamento 2.0. Primi approdi dei Centri di Servizio per il Volontariato sui social media
di Manuela Bartolotta
1. I Centri tra partecipazione, condivisione e personalizzazione
Il presente capitolo approfondisce la parte dell’indagine che ha esa-minato l’uso degli strumenti web 2.0 all’interno delle attività di co-municazione dei Centri di Servizio per il Volontariato e del loro Co-ordinamento. L’obiettivo fondamentale di questa sezione è cercare di comprendere quanto tali strumenti siano utilizzati e quanto siano effettivamente utili alle strategie comunicative e alle attività realizzate da questo tipo di organizzazioni. Per conoscere la portata e lo svilup-po delle nuove tecnologie, ma soprattutto le forme di comunicazione online attive nella rete dei Centri, si è scelto di partire da alcuni inter-rogativi-guida: i Centri di Servizio per il Volontariato utilizzano i social network? In che modo gli strumenti del web 2.0 incidono sull’identità dei Centri? Quali forme e codici espressivi caratterizzano la loro co-municazione online? L’interattività offerta dai social media è percepita come una risorsa dagli operatori della comunicazione che si occupa-no di volontariato?Innanzitutto, è opportuno precisare che l’espressione web 2.0 è utiliz-zata per indicare uno stato di evoluzione del web e, pur non avendo una defi nizione univoca e compatta, può essere meglio compresa in una piattaforma di nuove applicazioni online che incoraggiano la par-tecipazione degli utenti attraverso il rilascio di contenuti e feedback (O’Reilly 2005; Simonin 2007; Mayfi eld 2008). Il contributo diretto dei navigatori, dunque, rappresenta il fulcro di questa innovazione. Il suc-cesso di questi strumenti risiede, infatti, nella capacità di mettere al centro le relazioni e con esse gli individui, consentendo alle persone di entrare facilmente in contatto tra loro e di scambiarsi informazioni. Rispetto al web 1.0, cambiano le possibilità offerte agli utenti con il passaggio da “un’interazione basata sulla semplice consultazione,

76
alla possibilità di inserire contenuti propri e contribuire all’arricchi-mento della rete” (Cavallo e Spadoni 2010, 49). Partecipazione e condivisione sono, dunque, le parole-chiave su cui fanno leva il funzionamento e il successo dei social media; ma, oltre a queste, c’è anche un altro aspetto che non può essere certamente trascurato: la personalizzazione. Con questo termine si indica non solo la capacità di questi media di ampliare le modalità di interazione tra gli utenti, ma anche quella di offrire un numero sempre crescen-te di opportunità all’individuo per soddisfare i suoi bisogni (Wellman 2007). Un buon modo per comprendere il successo di questi stru-menti si può cogliere citando le parole di Mayfi eld (2008, 7):
a good way to think about social media is that all of this is actual-ly just about being human beings. Sharing ideas, cooperating and collaborating to create art, thinking and commerce, vigo-rous debate and discourse, fi nding people who might be good friends, allies and lovers – it’s what our species has built several civilisations on. That’s why it is spreading so quickly, not becau-se it’s great shiny, whizzy new technology, but because it lets us be ourselves – only more so1.
Comprendere la portata di questa innovazione presuppone, dunque, considerare i social media come un’opportunità per realizzare le no-stre identità e vocazioni. I social network, su cui si concentra in par-ticolare questa sezione d’indagine, appartengono alla categoria dei social media e possono essere meglio descritti come “piattaforme che consentono di articolare, attualizzare e gestire relazioni sociali” (Comunello 2010, 122); nello specifi co, si fa riferimento a “strumenti che abbracciano tutte le forme di comunicazione supportate dal web, come testi, video, audio o immagini, con l’opportunità di scambiare opinioni e interagire sulla base di tali contenuti” (Cavallo e Spadoni
1 Un buon modo per rifl ettere sui social media è che tutto questo è in realtà solo essere esseri umani. Condividere idee, collaborare e cooperare per creare arte, pensiero e commercio, per creare un dibattito vigoroso e un discorso, trovare per-sone che potrebbero essere buoni amici, alleati e amanti – è ciò su cui la nostra specie ha costruito civiltà diverse. Ecco perché si sta diffondendo così rapidamen-te, non perché sia una grande e brillante nuova tecnologia, ma perché ci permette di essere noi stessi – solo di più [traduzione dell’autrice].

77
2010, 54)2. Costruire facilmente ‘comunità’ virtuali e condividere in-teressi comuni, attraverso la creazione di un profi lo pubblico e l’uso di differenti forme di comunicazione, sono gli aspetti caratteristici di questa nuova tecnologia. Sulla base delle peculiarità fi nora descritte, l’ambiente comunicativo online sembra essere molto più favorevole alle attività delle associazioni non profi t di quanto lo siano mai stati i media tradizionali. Come spiega Stefano Martelli (2006), attraverso le novità introdotte dagli strumenti tecnologici a costi bassissimi, si pos-sono realizzare forme originali di comunicazione autoprodotta e “dal vivo”, ossia in tempo reale e raggiungere alcuni dei più importanti scopi associativi, come la creazione di luoghi virtuali di discussione pubblica, lo sviluppo di collegamenti stabili con organizzazioni dello stesso settore, l’aggiornamento e la promozione tempestiva delle pro-prie attività. Inoltre, integrando nella propria attività di comunicazione modalità di partecipazione mediata, tramite l’uso di forum, chat, Istant messaging, sms o blog, è possibile sviluppare forme inedite di comu-nicazione a distanza e sperimentare modelli sociali innovativi per la costruzione o il rafforzamento dell’identità associativa. È questo che fanno i Centri di Servizio per il Volontariato?La lettura dei dati che seguirà nel corso di questo paragrafo è il frutto dell’integrazione dei risultati ottenuti dalle prime due azioni di ricerca realizzate dal gruppo di lavoro. L’analisi procederà dunque attraverso una lettura comparata e integrativa dei dati provenienti sia dalla web-survey, cui hanno risposto 61 responsabili della comunicazione, sia dal monitoraggio di 71 siti dei Centri di Servizio per il Volontariato.Partendo dalla lettura dei dati relativi alla websurvey, emerge chia-ramente che gli strumenti del web sono presi in considerazione dai Centri di Servizio per il Volontariato e sono loro utili. L’enfasi per l’am-biente online si registra nella lettura dei dati sulle attività prevalenti svolte dai 61 Centri di Servizio per il Volontariato: per 56 (oltre il 90%)
2 Per ovvie ragioni di spazio, in questo paragrafo si è deciso di non entrare nell’ac-ceso e ampio dibattito esistente in letteratura sul tema delle classifi cazioni applica-bili a questi ambienti (ad es. online social network, social networking, social network sites, online social networking), però per chi desiderasse approfondire si rimanda a Comunello (2010).

78
operatori della comunicazione, la gestione del sito è una delle attività prioritarie nel lavoro quotidiano svolto dagli uffi ci e, in ordine di rile-vanza, è collocata subito dopo le attività di redazione testi (comuni-cati stampa, notizie, materiale informativo, ecc.) e di uffi cio stampa. Spostando invece lo sguardo sui dati relativi alla gestione dei social network, si evidenzia come tale attività sia considerata prevalente solo da poco più della metà (58%) dei Centri di Servizio per il Volontariato intervistati – 35 su 61 – e, sulla base delle differenze territoriali, risulta particolarmente diffusa nel Nord Ovest e al Sud3. Un ulteriore slancio a favore del web è dato dall’insieme di quei 28 (46%) operatori su 61 rispondenti che ritiene utile l’acquisizione o il perfezionamento di competenze nell’area della comunicazione legata allo sviluppo del web e dei social network. Nell’esprimere una preferenza tra le diver-se attività di comunicazione indicate nella survey, quest’area risulta tra le più segnalate ed è seconda solamente alla “Progettazione di campagne ed iniziative di comunicazione sociale”, suggerita invece da 30, di fatto la metà dei responsabili. Questo dato è certamente un segnale importante, perché lascia ipotizzare lo sviluppo futuro di competenze legate all’apprendimento degli strumenti del web e, di conseguenza, prefi gura un’apertura sempre maggiore per le poten-zialità offerte dalla Rete. Inoltre, i Centri di Servizio per il Volontariato più interessati a questo sviluppo sono di nuovo quelli situati nelle re-gioni del Nord Ovest e del Nord Est.La tendenze mostrate in questi primi dati sono confermate da un’ana-lisi più approfondita sugli strumenti maggiormente utilizzati dai Centri di Servizio per il Volontariato nell’attività di comunicazione. Dall’inda-gine emerge che il sito web è lo strumento più impiegato nell’attività di comunicazione di 60 uffi ci; seguono l’utilizzo della newsletter e della email con 57 segnalazioni, mentre i social network sono utilizzati sola-
3 I 35 casi sono così ripartiti: 15 Csv sono situati nelle regioni del Nord Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta); 11 Csv si trovano nel Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia); 4 Csv appartengono al Nord Est (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto); 3 Csv sono del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria); 2 Csv sono situati nelle Isole.

79
mente da 28 uffi ci4. Per tutti e tre gli strumenti indicati in precedenza, le aree territoriali in cui risultano particolarmente diffusi sono le mede-sime e afferiscono alle regioni del Nord Ovest e del Sud. Nell’analisi dei dati non si possono certamente sottovalutare gli uffi ci che, tra gli strumenti più utilizzati, hanno dichiarato di servirsi del telefono in 40 casi e dei periodici in 29 casi. A questi si aggiungono 11 casi in cui l’attività di comunicazione è pianifi cata tenendo conto di ulteriori stru-menti, come quotidiani, radio, tv, sms, agenda mensile e sportelli5.Da una prima osservazione emerge chiaramente come il web sia un ambiente fondamentale per lo sviluppo della comunicazione dei Cen-tri di Servizio per il Volontariato. Tutte le prime postazioni, infatti, sono occupate da strumenti e prodotti online. Internet ha ormai preso piede nell’attività di comunicazione, ma appare maggiormente legato all’uti-lizzo di strumenti online più tradizionali, come l’email e la newsletter, che a quelli più caratteristici del web 2.0 e, quindi, più interattivi. La Rete si è senza dubbio affermata come ambiente indispensabile per la circolazione e lo scambio di informazioni tra le organizzazioni che fanno parte del Coordinamento, ma l’ampio e variegato mix di mezzi e strumenti che offre per dialogare con gli utenti non sembra essere pienamente sfruttato. Nel caso in questione, la partecipazione attiva e la collaborazione degli utenti, che sono alla base della logica di fun-zionamento dei social media, non sembrano essere così incoraggiate. Le forme della comunicazione online appaiono ancora sbilanciate su modelli di “sito vetrina” o “sito banca dati”, anziché presentarsi come siti interattivi in grado di sviluppare soluzioni per una comunicazione bidirezionale e sembrano riprodurre la scarsa attitudine 2.0 delle am-ministrazioni pubbliche descritta ampiamente da Giancarlo Fornari (2004). Appaiono assenti, dunque, spazi adeguati per lo sviluppo di forme di aggregazione in Rete.L’analisi dei dati che derivano dal monitoraggio del campione dei 71 siti dei Centri di Servizio per il Volontariato non si discosta molto
4 Questo tema è approfondito nel capitolo 7.5 Nello specifi co: quotidiani, radio e tv (9 casi), sms (3 casi), agenda mensile (1 caso), sportelli (1 caso).

80
dagli aspetti fi nora segnalati. Gli strumenti della comunicazione on-line tramite i quali un navigatore-utente può interagire con i Centri di Servizio per il Volontariato consistono principalmente nell’indirizzo di posta elettronica (67 casi) e nella newsletter (55 casi). Solo 23 siti (32 %), invece, consentono al navigatore di interagire collegandosi ad un profi lo sui social network: il più utilizzato è Facebook, che sorpassa tutti gli altri ambienti di social networking. Solamente in 5 siti, infatti, è possibile accedere ad un profi lo su Twitter, in 2 siti su Myspace, in 1 sito su LinkedIn. In un solo caso sono presenti riferimenti ad altre piattaforme di web publishing come Flickr o YouTube. Analizzando la presenza di ulteriori strumenti 2.0 all’interno dei siti, è emerso che solamente 7 hanno creato un forum e 5 un blog. Con il primo termine si fa riferimento a “bacheche virtuali”, solitamente divise per argomenti, su cui gli utenti condividono informazioni e idee; con il secondo, vengono prese in considerazione quelle forme di comuni-cazione di tipo grafi co che consentono di pubblicare online, in tempo reale, notizie o informazioni, dando la possibilità ai visitatori di lascia-re commenti6. Abbiamo esaminato i temi trattati nei forum presenti: riguardano prevalentemente la vita organizzativa delle associazioni e il loro rapporto con i Centri di Servizio per il Volontariato; a scrivere sui blog, invece, sono in prevalenza i volontari delle associazioni e le tematiche trattate ne rispecchiano l’inclinazione, ovvero guardano in generale al mondo del volontariato. Ugualmente limitato, all’interno dei siti, è il ricorso all’uso di messaggi testuali o post con funzione di opinione o commento ai contenuti pubblicati dai Centri, che abbiamo registrato solamente in 8 casi. Appaiono modeste anche le possibilità di partecipare a sondaggi, all’infuori di 7 siti e di accedere a sistemi di messaggistica istantanea o Instant messaging7, fatta eccezione per
6 Per un approfondimento su questi temi si vedano anche: Roversi (2004), Granieri (2005) e Di Fraia (2007). 7 I sistemi di messaggistica istantanea o Istant messaging si basano sull’installa-zione, da parte dell’utente, di un particolare programma che consente lo scambio di messaggi in tempo reale. La discussione può avere inizio quando si è connessi ad internet e si è verifi cata la presenza in linea di altri utenti. Tra i più noti sistemi di questo tipo si possono citare Skype e Windows Live Messenger.

81
2 casi del Sud. Da segnalare, invece, la diffusione tra i siti del campione di uno stru-mento innovativo, che consente di tenersi aggiornati in tempo reale sulle notizie pubblicate nelle pagine web. Si tratta della tecnologia Rss, acronimo di Real simple syndication, utilizzata da 28 (39%) Cen-tri di Servizio per il Volontariato. Le funzionalità relative a questo stru-mento sono segnalate proprio dal sito del Coordinamento nazionale che, all’interno di una sezione dedicata, ne descrive le modalità di accesso e di utilizzo. La tecnologia Rss consente “a tutti gli utenti di Csvnet di accedere in tempo reale alle news che vengono pubblicate quotidianamente” sul sito e, “ai Centri di Servizio per il Volontariato che dispongono di un sito, di inserire in modo semplice le notizie” all’interno delle loro pagine web, così da tenere le informazioni sem-pre e automaticamente aggiornate8. A fare uso di tali strumenti sono in prevalenza i Centri di Servizio per il Volontariato che si trovano nelle regioni del Nord Ovest. L’utilizzo di tale tecnologia, che rappresen-ta un tipo di “sistema decentrato di approvvigionamento individuale dell’informazione” (Lovari 2008, 47), consente di concentrare in un unico spazio le notizie provenienti da diversi siti e può considerarsi un signifi cativo passo in avanti, da parte Centri di Servizio per il Volonta-riato, verso l’appropriazione coordinata di soluzioni e dinamiche 2.0.Per riassumere, dalla lettura dei dati provenienti dalla websurvey e dal monitoraggio dei siti emerge che tra le modalità di comunicazio-ne mediata dal computer sono privilegiate solamente due forme di comunicazione testuale di tipo asincrono: l’email e la newsletter. Non sono prese suffi cientemente in considerazione, invece, le altre due modalità di comunicazione asincrona, come i forum e i blog. Le forme di comunicazione mediata dal computer di tipo sincrono, invece, mo-strano ancora più diffi coltà a trovare spazio all’interno delle strategie di comunicazione dei Centri di Servizio per il Volontariato. Sistemi di Istant messaging o di Internet relay chat, che consentono un dialogo interattivo e immediato con utenti anche ignoti, sembrano essere stru-menti non adeguati per le attività svolte dal Coordinamento nazionale
8 Testi tratti da www.csvnet.it

82
e dai Centri di Servizio per il Volontariato. Meritano una considerazione a parte i social network, intesi come piattaforme online che implementano entrambe le tipologie di comu-nicazione. L’intuizione di tali strumenti, infatti, è proprio quella di far convergere diverse forme di comunicazione mediata dal computer in un unico servizio online, ma sembra non attecchire pienamente nelle logiche del Coordinamento e della sua rete. Questo signifi ca rinun-ciare a una “convergenza comunicativa” di media dapprima pensati singolarmente e, a livello di comunicazione, non esaurire le tipologie di media possibili sulla Rete. Aumentare tali tipologie consentirebbe di andare incontro a più esigenze e preferenze di comunicazione e, di conseguenza, permetterebbe di estendere le modalità di erogazione dei servizi a diverse tipologie di utenza. Tali strumenti, inoltre, potreb-bero rappresentare una modalità innovativa per affi nare le tecniche di profi lazione dell’utenza.Sulla base dei dati analizzati fi nora, il Coordinamento e i Centri di Servizio per il Volontariato sembrano far fatica ad accogliere la natura sociale del web 2.0 e, di conseguenza, non sfruttano pienamente le possibilità offerte da questi strumenti. Questi risultati non sorprendo-no. Le funzioni di coordinamento e rappresentanza del volontariato svolte da questi Centri li rendono infatti assimilabili, per certi aspetti, a delle pubbliche amministrazioni e sappiamo che questi enti mostrano spesso diffi coltà nell’adottare nuovi strumenti, soprattutto se lontani da logiche formali. Ad un primo sguardo, i nostri Centri sembrano tendere a preservare forme e codici espressivi meno fl essibili, che rendono diffi cile l’adozione di logiche e modelli di azione 2.0. Pur prendendo parte alla realtà digitale, i Centri di Servizio per il Volonta-riato non aderiscono in maniera convinta alle caratteristiche fondanti la logica di rete, come l’interattività e la condivisione. I social network, ma più in generale i social media, non sembrano dunque incidere molto, per adesso, nei processi di costruzione identitaria dei Centri di Servizio per il Volontariato e del Coordinamento. Eppure, i dati sulla percezione degli strumenti ritenuti più effi caci per l’attività di comu-nicazione esterna ci dicono che: da 30 (49%) Centri di Servizio per il Volontariato i social network sono considerati uno degli strumenti

83
più effi caci nella comunicazione esterna. In cifre, si situano dopo le attività di gestione del sito, dell’email e della newsletter e superano gli strumenti della comunicazione offl ine9. Questo suggerisce che lo sviluppo dei social network sia un dato ancora molto fl essibile o co-munque “in costruzione” e lascia immaginare prospettive di crescita. Ancora una volta l’impulso più forte sembra provenire dalle regioni del Nord Ovest e del Sud. A cosa è dovuto, allora, lo scollamento tra la percezione positiva di questi strumenti e il loro scarso utilizzo?
2. La percezione dei social media: vincoli e opportunitàCome mostrano i valori riportati nel grafi co a torta, il modesto utilizzo dei social media, e nello specifi co dei social network, sembra essere collegato ad una mancanza di risorse in termini di tempo e di perso-nale disponibile – almeno per 17 responsabili della comunicazione, il 28% dei rispondenti – piuttosto che al mancato riconoscimento di questi strumenti e delle possibilità che essi offrono.
Molta: ci stiamo organizzando per imple-mentarne l’usoAbbastanza: sappiamo che sarebbe utile dedicarvi maggiori risorse, ma ci richiede un impegno termini di tempo e risorse umane che non possiamo permetterci
Poca: è una funzione secondaria rispetto atutte le altre attività di comunicazione
Nessuna importanza
Figura n.1 – La percezione dei social network negli uffi ci comunicazione dei Csv – Anno 2010
8 (13%)
16 (26%)17 (28%)
20 (33%)
Quanta importanza attribuisce all’uso dei social network?
Totale dei casi 61
Fonte: nostre elaborazioni
I dati lasciano ipotizzare un futuro in cui l’uso di tali strumenti pos-
9 Un estratto dei dati della web survey condotta su 61 responsabili della comu-nicazione dei Centri di Servizio per il Volontariato. Gli strumenti ritenuti più effi caci per l’attività di comunicazione esterna: sito (55 casi), newsletter (52 casi), mail (41 casi), social network (30 casi), telefono (24 casi), periodici (21 casi), fax (4 casi).

84
sa essere maggiormente valorizzato all’interno della rete dei Centri di Servizio per il Volontariato: 20 responsabili della comunicazione, cioè un terzo, prospettano infatti la possibilità di un’implementazione più estesa di tali strumenti; solamente 16 (26%) invece considerano l’utilizzo dei social network una funzione secondaria rispetto alle altre attività di comunicazione e ancor meno – 8 (13%) – sono gli operatori che non attribuiscono a questi strumenti alcuna importanza. Nella lettura dei dati delle interviste in profondità emergono ulteriori elementi di spiegazione sui vincoli e le opportunità legati all’uso di queste tecnologie. Sulla base del grafi co appena mostrato, abbiamo chiesto ad alcuni responsabili della comunicazione i motivi di una scarsa presenza dei Centri di Servizio per il Volontariato sui principali social network. Gli spunti suggeriti sono stati diversi: questi allargano il campo della rifl essione precedente che, ricordiamo, si basava sui dati statistici di due diverse rilevazioni. Le impressioni e le percezioni di alcuni testimoni privilegiati, che saranno trattati in questo paragra-fo, non hanno invece un valore rappresentativo, bensì solo di stimolo su un tema così nuovo. I responsabili della comunicazione intervistati hanno confermato che il problema fondamentale di un modesto uti-lizzo di tali strumenti può essere collegato spesso ad una mancanza di personale disponibile. Natahalie Grange, responsabile dell’area comunicazione del Centro di Servizio per il Volontariato Valle d’Aosta, ha spiegato:
i social network richiedono lavoro. Abitare questo spazio richie-de lavoro, disponibilità ad allacciare e mantenere relazioni. Non basta esserci, occorre alimentare questo spazio. Certo è una parte interessante dal punto di vista comunicativo, ma poi il la-voro sul campo è un altro.
Il problema delle risorse, dunque, potrebbe essere una delle cause principali della scarsa considerazione di questi strumenti all’interno delle strategie comunicative dei Centri di Servizio per il Volontariato. Le parole di Michela De Falco, responsabile dell’area comunicazione del Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna, riba-discono questa ipotesi:
una rifl essione che abbiamo fatto legata all’interattività è stata

85
sulla possibilità di inserire dei forum sul nostro sito; non l’abbia-mo mai fatto perché signifi cherebbe avere una persona dedica-ta in grado di gestire le richieste degli utenti in modo diretto.
La vita virtuale è dunque faticosa, perché richiede di impegnare ul-teriori risorse per la comunicazione. Come sottolinea Gaia Peruzzi (2010, 8), “il salto nel web 2.0 si traduce sovente all’interno dell’orga-nizzazione in una spinta all’incremento e alla professionalizzazione delle risorse dedicate alle comunicazione”. Un ulteriore ostacolo all’utilizzo informale di questi strumenti sembra essere collegato allo specifi co bacino d’utenza dei Centri di Servizio per il Volontariato. Spiega chiaramente, ancora una volta, Michela De Falco:
la gradualità con cui i Centri di Servizio per il Volontariato ap-procciano allo strumento è a mio parere dovuta al profi lo del target delle associazioni che hanno un ritardo di consapevolez-za di questo tipo di strumenti e comunicazione; questi prodotti attualmente non incontrano i loro bisogni.
Marilena De Nigris, responsabile dell’area comunicazione del Centro di Servizio per il Volontariato San Nicola, specifi ca ancor meglio le caratteristiche dei volontari che rallenterebbero il processo:
probabilmente utilizziamo ancora altri strumenti per quella che è la tipologia dei nostri utenti, che hanno un’età medio-alta e non fanno un grande utilizzo dei social network.
Molti dei progetti ideati dagli uffi ci comunicazione dei Centri fi nisco-no così per non ricevere un corretto sostegno al loro sviluppo, come spiega Marta Moroni del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Milano:
abbiamo aperto un blog legato al progetto di rete per l’orien-tamento al volontariato; lo strumento è coordinato da un colla-boratore che anima lo spazio e coinvolge le associazioni che fanno parte di questa rete, in modo che diventi una specie di diario collettivo. Devo dire che sta avendo grandissime diffi col-tà, perché le organizzazioni che fanno parte della rete non sono abituate e non sono interessate ad utilizzare questo strumento di partecipazione web per incontrarsi e frequentarsi.

86
Le parole dei responsabili suggeriscono elementi d’analisi interes-santi. Infatti, per lo sviluppo di una corretta ed effi cace strategia di comunicazione, è fondamentale non trascurare le fasce di popolazio-ne che non sono ancora nelle condizioni di utilizzare le tecnologie e il web. Nella relazione con l’utenza non si deve cadere nell’errore di assumere una visione “internet centrica”, che enfatizzi l’erogazione dei servizi attraverso l’uso esclusivo dei media digitali e porti a sotto-valutare la varietà degli strumenti comunicativi che si hanno a dispo-sizione, comprese le potenzialità offerte da una relazione diretta. È necessario, dunque, scegliere le tecnologie sulla base dei “compor-tamenti di fruizione e i bisogni comunicativi dell’utenza e sulla base delle competenze di coloro che lavorano all’interno dell’ente” (Lovari 2008, 31). La scelta dei mezzi, quindi, dovrebbe ricadere sulla giusta combinazione tra le competenze che si hanno a disposizione nell’or-ganizzazione e il tipo di approccio che gli utenti ricercano. Un ulteriore vincolo che può spiegare il modesto utilizzo dei social network da parte dei Centri di Servizio per il Volontariato sembra rin-tracciarsi nella diffi coltà da parte degli uffi ci a gestire correttamente lo strumento. In particolare, i responsabili hanno dichiarato tre tipi di problemi legati alla gestione del mezzo. Il primo attiene alla capacità di rispondere in maniera adeguata ai feedback rilasciati dagli utenti. Lo illustra bene Irene Troia dell’area comunicazione del Centro Servizi per il Volontariato del Lazio (Spes):
avere una pagina Facebook per noi Centri di Servizio per il Vo-lontariato è un impegno, non solo nel cercare di mantenere viva la pagina, che potrebbe anche essere semplice se si riprende l’aggiornamento del nostro portale. È un impegno perché signi-fi ca avere noi le capacità e le possibilità di rispondere alla ri-chiesta. La diffi coltà è dare la risposta adeguata e chi gestisce il social network si può trovare in questa diffi coltà. La diffi coltà, per esempio, è nel mettere a disposizione dei documenti, anche se potrebbe essere una cosa utile. È chiaro che stiamo parlando di un impegno maggiore.
Il secondo ostacolo si rintraccia, invece, nella grande velocità del mezzo, che molto spesso non si combina con le competenze interne dell’organizzazione. Spiega Chiara Castri dell’ufficio stampa del

87
Centro Servizi per il Volontariato Lazio (Cesv):
Facebook è uno strumento velocissimo e quindi quando fai il conto fra la gestione dello strumento e le risorse, sicuramente ne risentiamo, perché le risorse a disposizione non sono adatte alla velocità che lo strumento richiederebbe.
Il terzo problema nella gestione dei social network è legato al lin-guaggio del web e, nello specifi co, all’informalità della comunicazio-ne che il mezzo comporta. Cristina Galasso dell’area comunicazione del Centro di Servizi per il Volontariato Toscana, ha spiegato:
a livello di immaginario lo strumento viene considerato un mez-zo di comunicazione informale, che uno sviluppa anche come privato cittadino; di conseguenza, si tende a replicare questa informalità, che il mezzo stesso sollecita, nell’uso professionale e istituzionale che se ne fa. Lo strumento, però, è ingannevole: ti fa pensare che è informale, che puoi comunicare di tutto, ma in realtà è uno strumento di comunicazione e come tale va saputo gestire e governare.
Queste parole sollevano un problema ampiamente discusso nella let-teratura sui media digitali, che mette in luce come le diffi coltà nell’uti-lizzo delle nuove tecnologie non derivino esclusivamente dall’esisten-za di barriere di tipo tecnologico, ma soprattutto da ostacoli linguistici e culturali. Un ulteriore vincolo all’utilizzo del mezzo è dato dalla diffi coltà a va-lutare l’impatto di queste di tecnologie. Anche questo tema è stato suggerito da Cristina Galasso:
è necessario sapere qual è il rimando attraverso Facebook, per-ché con un comunicato lo sai subito se ti pubblicano. Su Face-book, invece, la comunicazione prende la sua strada, la perdi e poi te la ritrovi sul sito ‘x’ e non sai ricondurla a quel post che hai diffuso su Facebook. È una comunicazione poco quantifi cabile e anche investirci risorse umane ed economiche non è sempli-ce, perché il ritorno non è facilmente percepibile e misurabile.
La fl essibilità e il decentramento dell’informazione che tali strumenti consentono, in alcuni casi, possono frenare lo sviluppo delle tecno-logie, anziché favorirlo. Se da una parte tali strumenti ampliano le capacità di intervento dell’organizzazione, dall’altra producono una

88
conseguente perdita di controllo dell’informazione, alla quale i Centri di Servizio per il Volontariato, organizzazioni con una responsabilità pubblica di coordinamento e rendicontazione, non sembrano ancora voler rinunciare. Tutti i vincoli e le problematicità fi nora sollevate possono essere ricon-dotti alla mancata acquisizione di una requisito fondamentale da parte dei Centri: competenze diffuse e consolidate all’uso dei social media. Come riconoscono gli stessi esperti della comunicazione, “non sono ancora maturate delle consapevolezze e delle professionalità ad hoc” per farne un uso suffi cientemente adeguato. Il web 2.0 da solo non basta e non è sinonimo di partecipazione. Ha bisogno di professio-nalità in grado di far comprendere, ad esempio, come si veicolano e si creano i contenuti nel nuovo web e, più in generale, come si può garantire un posizionamento effi cace e duraturo all’interno di queste nuove realtà. Sarà, dunque, compito dei vertici istituzionali sceglie-re, in futuro, se investire nel mercato professionale per implementare nuove competenze e, di conseguenza, per attivare nuove strategie. Gestire effi cacemente queste dinamiche signifi ca, da un lato as-sorbire competenze legate alle logiche editoriali del web, dall’altro acquisire aspetti più propriamente tecnologici. In questo scenario, aumentano per i Centri di Servizio per il Volontariato le possibilità di interagire con il proprio pubblico, ma si estende la complessità della comunicazione che devono saper gestire. Lo riconosce Gianluca Ca-poraso, responsabile dell’area comunicazione del Centro di Servizio per il Volontariato Basilicata, quando afferma:
se alcuni strumenti non sono integrati ad altri – per esempio il sito web e la pagina Facebook – ne condivido la rinuncia. Anche a fronte di una minore ricchezza comunicativa, si evita il rischio di creare dimensioni comunicative fuori sincrono.
Lo spunto appena citato sofferma l’attenzione su una condizione indi-spensabile per affermare la propria riconoscibilità all’esterno, ovvero il rispetto dell’immagine coordinata dell’ente, che richiede alle orga-nizzazioni di saper “gestire strategicamente tempi, format e contenuti delle loro produzioni comunicative” (Lovari 2008, 37). I responsabili della comunicazione intervistati, dunque, mostrano di

89
saper riconoscere adeguatamente sia le opportunità che i vincoli le-gati all’uso dell’ambiente 2.0. La comprensione della portata comu-nicativa dei social media emerge in ulteriori spiegazioni in cui, ad esempio, viene messa in luce la capacità dei nuovi media di porsi come “tecnologie di relazione” (Marinelli 2004, 199) in grado di svi-luppare un processo bidirezionale, come sottolinea Chiara Castri:
di strumenti ne abbiamo molti, ma sono tutti strumenti del Centro che parla agli altri. Con Facebook, invece, l’idea era di creare una piazza, inserirsi in una situazione che consentisse di parlare non solo alle associazioni, ma anche ai cittadini comuni.
Ciò che manca allo sviluppo dei social media si può dunque attribuire ad un mancato investimento in termini economici e, ancora prima, culturali. Non si tratta, infatti, di implementare l’uso di tecnologie in-formatiche, ma di contribuire ad un processo di rinnovamento che metta al centro la partecipazione attiva degli utenti come “creatori di valore”. Il web 2.0 si basa su aspetti culturali e organizzativi, piuttosto che su scelte puramente tecnologiche.Le organizzazioni devono essere in grado di stare al passo con i bi-sogni informativi e relazionali degli utenti; esser capaci di sperimen-tare linguaggi e formati innovativi, ma soprattutto nuove modalità di ascolto e di relazione. Il principale cambiamento culturale risiede nel riuscire a valorizzare le nuove tecnologie in un’ottica di integrazione con media differenti a seconda degli obiettivi che si devono raggiun-gere. È inoltre indispensabile una visione strategica di lungo periodo, che porti ad una valorizzazione del ruolo del comunicatore e, di con-seguenza, di tutta l’attività comunicativa.Come ha effi cacemente spiegato Gianluca Caporaso, responsabile dell’area comunicazione del Centro di Servizio per il Volontariato Ba-silicata:
gli strumenti spesso diventano l’unico livello di valutazione del-la comunicazione. Invece, gli strumenti, in quanto tali, proprio perché consentono di mettere in relazione e in comunicazione, devono rispondere ad una questione più importante: a chi co-munico e cosa devo comunicare. È in questo senso che acqui-stano rilevanza strategica e tattica.

90
L’obiettivo e il signifi cato della relazione restano il motore principale di qualunque azione comunicativa. Nonostante le diffi coltà fi nora de-scritte, l’interesse per tali strumenti è piuttosto vivo e lascia intravede-re, come suggerisce Irene Troia, prospettive di sviluppo concrete:
ci siamo interrogati molto sui social network, perché siamo con-sapevolissimi di essere manchevoli sull’aspetto dell’interattività. Abbiamo una email, ma pochi momenti d’incontro a livello in-formatico con i nostri utenti. Ora abbiamo capito l’importanza e cercheremo di implementare la nostra presenza sui social net-work.

Parte terza
La comunicazioneraccontata dai
comunicatori


93
Capitolo 6Gli uffici di comunicazione dei Centri di Servizio per il Volontariato
di Lorenzo Boscato e Sandra Fratticci1
1. Le struttureQuesta parte della ricerca si propone di analizzare la comunicazione promossa dai Centri di Servizio per il Volontariato da un punto di vista strutturale ed organizzativo. Le dimensioni indagate sono dunque: le strutture deputate a promuo-vere attività di comunicazione, le risorse utilizzate, il profi lo occupa-zionale e socio-demografi co del personale impegnato nella comuni-cazione, le attività svolte. Si tratta di indicatori che complessivamente possono offrire un primo quadro del livello di sviluppo e di maturità della comunicazione realizzata dal network. Dai risultati della websurvey emerge che su 61 Centri di Servizio per il Volontariato ben 51 (84%) hanno un uffi cio deputato specifi camen-te alla comunicazione. Con riferimento alla distribuzione territoriale, hanno indicato la presenza di strutture dedicate alla comunicazione tutti gli intervistati delle aree Centro (5) e Isole (3), 21 intervistati del Nord Ovest (su un totale di 23), 8 intervistati del Nord Est (su un to-tale di 11) e 14 intervistati del Sud (su un totale di 19). Non sembra, dunque, che vi siano differenze apprezzabili tra le diverse aree del paese, così come non si registrano signifi cativi scostamenti in base alle dimensioni dell’ente. Strutture dedicate alla comunicazione sono state infatti istituite in 2 Centri interprovinciali (su un totale di 2), 42 Centri provinciali (su un totale di 50) e 7 Centri regionali (su un totale di 9). La scelta di istituire uffi ci ad hoc sembra indicare un’elevata consapevolezza del ruolo della comunicazione, divenuta una realtà diffusa per la quale sono previste risorse mirate ed un impegno non occasionale.
1 Sandra Fratticci è autrice del paragrafo1, Lorenzo Boscato del paragrafo 2.

94
Figura n. 1 – La presenza degli uffi ci di comunicazione nei Csv del territorio nazionale – Anno 2010
I Csv che hanno un uffi cio deputato alla comunicazione
Centro Nord Est
Nord Ovest
IsoleSud
NoSì0
5
10
15
20
25
58
314
21
2
5
3
Totale dei casi: 61
Fonte: nostre elaborazioni
E anche l’assenza di strutture apposite non sembra comportare un’au-tomatica rinuncia a svolgere attività di informazione e comunicazione, perché pare che si cerchi comunque di garantire un investimento in queste aree, assicurando nella maggior parte dei casi una presenza costante. Nei Centri in cui non c’è una struttura apposita (10 in tutto) le attività di comunicazione sono infatti affi date a uno o più dipendenti o collabo-ratori esterni. In 6 casi tali attività sono curate con regolarità, mentre in 3 casi l’impegno su questo fronte è più saltuario. Da segnalare, infi ne, che un intervistato, alla domanda “Generalmente chi svolge le attività di comunicazione?” ha selezionato l’opzione di risposta ‘Altro’. Sulla base delle impressioni suggerite da un’analisi complessiva dei materiali della ricerca (quindi tenendo conto anche di dati analizzati più in dettaglio in altri paragrafi ), l’ipotesi di chi scrive è che l’entità degli investimenti in questo settore sia legata, oltre che alle disponi-bilità di budget, anche al livello di diffusione della cultura della comu-nicazione tra i vertici delle strutture. Gli operatori infatti sono sempre sembrati consapevoli del ruolo strategico della comunicazione, ma in taluni casi denunciano una mancanza di risorse adeguate.

95
Il riconoscimento del carattere strategico della comunicazione sem-bra trovare conferma, all’interno dei Centri di Servizio per il Volontaria-to, non soltanto nella scelta di dedicare specifi che risorse e strutture a tali attività, ma anche nella stessa denominazione degli uffi ci chiamati a gestirle. In 41 casi, infatti, il nome dell’uffi cio include espressamen-te il termine ‘comunicazione’: “Area comunicazione” (27 casi), “Area comunicazione e informazione” (5 casi), “Area comunicazione e pro-mozione” (4 casi), “Area sviluppo e comunicazione” (2 casi), “Uffi cio stampa e comunicazione” (2 casi), “Area comunicazione e pubbliche relazioni” (1 caso). In 9 casi è comunque presente un riferimento ad attività di informazione: “Uffi cio stampa” (4 casi), “Area informazione” (4 casi), “Media” (1 caso). Soltanto in un caso il nome dell’uffi cio non è immediatamente ricollegabile all’area della comunicazione e dell’in-formazione. Nella maggior parte dei casi si registra dunque uno stretto legame tra denominazione e funzione degli uffi ci. In particolare il riferimento esplicito al termine ‘comunicazione’ sembra indicare il raggiungimen-to di una fase matura, in cui la comunicazione ha ormai guadagna-to una precisa identità e collocazione all’interno dell’organizzazione, chiaramente percepibile sin dal nome. Al tempo stesso l’utilizzo di questo termine, spesso preferito ad altri più specifi ci (come “uffi cio stampa”) suggerisce una concezione allargata delle relative attività, che sembra trovare riscontro nelle competenze degli uffi ci.Tra le funzioni svolte dalle strutture deputate alla comunicazione, in-fatti, gli intervistati hanno indicato, nell’ordine: attività di uffi cio stampa (50 casi su un totale di 51), redazione di testi (50 casi), gestione del sito web (49 casi), progettazione di campagne (40 casi), gestione dei social network (33 casi), comunicazione interna (32 casi), organizza-zione di eventi (30 casi), relazioni pubbliche (27 casi).Nei Centri di Servizio per il Volontariato che non hanno strutture dedi-cate emerge un impegno analogo in attività di uffi cio stampa (indicate da 8 intervistati su 10), redazione di testi (8 casi), gestione del sito web (7 casi) e, in parte, nell’organizzazione di eventi (5 casi). Più con-tenuta, invece, l’iniziativa nei settori delle relazioni pubbliche (4 casi su 10), della progettazione di campagne (3 casi), della comunicazio-

96
ne interna (2 casi), della gestione dei social network (2 casi).Soltanto in 4 Centri, infi ne, è annoverata tra le attività di carattere co-municativo la gestione del fund raising e si tratta dei soli casi in cui è presente una struttura specifi ca per la promozione della comunica-zione.Complessivamente i dati fi nora riportati descrivono sviluppi che ap-paiono in linea con la più generale evoluzione della comunicazione, intesa come risorsa organizzativa (Invernizzi 2000). Se nelle realtà d’impresa si assiste all’avvento di aziende custumer oriented, aperte ai pubblici di riferimento (De Vincentiis 1999); se nella pubblica am-ministrazione si fa gradualmente strada la volontà di entrare in rela-zione con i cittadini (Rovinetti 2007); anche nel Terzo settore, con il passaggio ad organizzazioni non profi t evolute, ispirate a modelli di “professionalità sociale” (Ranci 2006, 34), si afferma la consapevo-lezza che: “non basta ‘fare’, occorre anche farsi conoscere presso il proprio pubblico” (Gadotti 2005, 71). L’impegno dei Centri di Servizio per il Volontariato sul versante comunicativo può essere dunque let-to come una scelta ‘naturale’, a fronte di una comunicazione che è, sempre più, risorsa strategica, funzione complessa che comprende e integra tutti i processi comunicazionali necessari alla vita e allo svi-luppo di un’organizzazione.Passando alla considerazione del personale impegnato in attività di comunicazione, nei Centri di Servizio per il Volontariato provvisti di uffi ci dedicati, questi possono contare, in 33 casi (65%), su 1 o 2 di-pendenti o collaboratori stabili, in 7 casi (14%) il numero di unità sale a 3, in 5 casi (9%) a 4, in 5 casi (10%) oscilla tra le 5 e le 10 unità. Piuttosto contenuto è il ricorso, da parte di tali strutture, a personale non dipendente, ossia volontari, operatori del servizio civile, stagisti. Sono infatti solo 18 (35%) i Centri che ricorrono a questo tipo di colla-borazioni, a fronte di 33 Centri (65%) che affi dano le attività di comu-nicazione esclusivamente a dipendenti e collaboratori stabili. Nei Centri di Servizio per il Volontariato privi di uffi ci comunicazione la gestione delle relative attività è demandata in 4 casi a dipendenti dell’organizzazione e in 5 casi a collaboratori esterni. La scelta di assumere personale, o, laddove ciò non sia possibile,

97
di instaurare rapporti di collaborazione, anziché ricorrere a strumenti quali stage, progetti di servizio civile, o prestazioni volontarie, sembra rafforzare l’ipotesi che la comunicazione rappresenti per i Centri di Servizio per il Volontariato una realtà strategica in cui investire, attra-verso l’apporto di specifi che professionalità.In tal senso risulta interessante anche il profi lo professionale dei sog-getti intervistati. 42 rispondenti su un totale di 61 si qualifi cano come responsabili o referenti della comunicazione, 8 come responsabili dell’uffi cio stampa. Per 55 intervistati (il 90% del totale) la collabo-razione all’interno del Centro ha una durata superiore ai 2 anni. In particolare 25 intervistati (il 41%) lavorano per il Centro da oltre 5 anni. Da un lato, dunque, si riconferma la volontà di riservare alla comunicazione risorse e competenze specifi che e dedicate. Dall’al-tro emerge una continuità che fa pensare a prospettive di impiego nell’organizzazione di lungo termine. Siamo legittimati a pensare che i Centri di Servizio per il Volontariato credono nella comunicazione ed investono nelle relative attività, assumendo personale cui affi darle in modo stabile, o, comunque, puntano a rafforzare l’impegno su questo versante, cercando di garantire una presenza costante delle risorse chiamate a gestirle.
2. Professionisti della comunicazioneCome anticipato all’inizio del capitolo, una parte della nostra ricerca mirava a tracciare il profi lo dei comunicatori dei Centri di Servizio per il Volontariato, per valutare quali competenze siano messe in campo e come siano distribuite sul territorio da quella rete che, si è detto, rappresenta uno dei volti istituzionali più importanti per il volontariato italiano.Di seguito presenteremo i principali risultati, confrontandoli con i bi-sogni percepiti da chi si occupa di comunicazione in queste strutture e con le principali tendenze diffuse in altri settori della comunicazione pubblica.Le risposte sulla formazione di base degli addetti alla comunicazione mostrano una maggioranza di laureati (38 su 61, 62% del totale) di-stribuiti in modo abbastanza uniforme negli uffi ci comunicazione dei

98
Centri di tutto il territorio italiano. A questi possiamo “accorpare” gli 8 (13%) che hanno conseguito un dottorato. Sono solo 13 (21 %), inve-ce, i responsabili con un diploma di scuola superiore e 2 quelli che si sono fermati alla scuola media inferiore. Il bacino di competenze cui attingono i Centri Servizio per il Volontariato per le loro attività di co-municazione è dunque notevole: il 75% circa degli intervistati hanno il livello di formazione più alto.Guardando poi al dettaglio del tipo di laurea, i percorsi prevalenti sono di tipo umanistico (21 su 46, quasi la metà dei casi), con una presenza signifi cativa e specifi ca di laureati in comunicazione (13 su 46, 28%); seguono economia e giurisprudenza (6 su 46, 13%) e una serie di altre aree disciplinari, con quote individuali non rilevanti.Gli addetti alla comunicazione dei Centri di Servizio per il Volontariato provengono dunque da percorsi diversi, abbracciando prevalente-mente le diverse aree umanistiche (lettere, sociologia, scienze politi-che, ma anche psicologia e scienze della formazione) se non il per-corso interdisciplinare per eccellenza, ancora relativamente recente in Italia, che è quello di scienze della comunicazione.Le professioni della comunicazione richiedono, almeno idealmente, percorsi formativi transdisciplinari, date la molteplicità delle pratiche agite, e la diversità degli attori con cui è necessario relazionarsi (Ro-vinetti 2000).Proprio nella consapevolezza che al lavoro di comunicazione si può arrivare da differenti percorsi, la nostra ricerca è andata a indagare se gli addetti alla comunicazione avessero seguito dei corsi anche più brevi di comunicazione oltre o indipendentemente dai percorsi uni-versitari mirati. Abbiamo valutato, quindi, le esperienze di formazione specialistiche, rilevando che nella grande maggioranza di 53 casi (87% del totale) gli addetti alla comunicazione hanno svolto corsi di formazione specifi ci in comunicazione.La specializzazione degli operatori indica quindi un investimento nell’acquisizione di competenze che prescinde dal livello iniziale di formazione. Anche laddove le competenze iniziali non siano mirate, la formazione successiva sembra “recuperare” con una specializza-zione.

99
Particolarmente interessante, ancora, è la tipologia dei corsi seguiti (che in diversi casi possono essere anche più di uno) per la “specia-lizzazione” in comunicazione: abbiamo una minoranza di master uni-versitari (9 su 53) distribuiti, ancora una volta, principalmente al Sud, una buona metà di corsi proposti direttamente dai Centri di Servizio per il Volontariato (27 su 53) con una distribuzione uniforme nel terri-torio e una maggioranza di corsi presso organizzazioni esterne (41 su 53), concentrati prevalentemente tra Nord Est e Nord Ovest.Possiamo supporre, quindi, che la rete dei Centri di Servizio per il Volontariato abbia un effetto omogeneizzante sul territorio, per quanto riguarda le opportunità di formazione dei propri comunicatori. Per altri tipi di esperienze formative, invece, si rilevano diseguaglianze territo-riali che siamo abituati a osservare in diversi settori socio-economici del nostro Paese.L’omogeneità del dato sulla penisola, ancora, è rilevante soprattutto allargando il punto di vista, e in considerazione del fatto che le op-portunità formative organizzate dai Centri di Servizio per il Volonta-riato raggiungono un numero di utenti generali in costante aumento nel tempo. Passiamo, infatti, dalle 29mila unità circa del 2006 alle 35 mila del 2007, e dalle 68mila del 2008 alle 73mila del 2009 (CSVnet 2010).Completa il quadro che stiamo costruendo il dato che ci informa che 3/4 degli intervistati (46 su 61) abbia avuto esperienze lavorative nel settore della comunicazione già prima di collaborare con i Centri di Servizio per il Volontariato.Trattandosi di attività di comunicazione, a maggior ragione, il dato è importante, perché le esperienze lavorative precedenti costituiscono uno dei fondamenti per la competenza professionale degli addetti, costruendo anche le basi per quelle competenze relazionali indispen-sabili alla comunicazione.Pensiamo, in questo senso, al rapporto con i media: tutte quelle at-tività considerate, comunemente, di “uffi cio stampa”. È quest’ultimo, in effetti, che “organizza le informazioni da diffondere nei media e interpreta a sua volta i segnali che provengono da essi” (Lo Savio e Lorenzetti 2008, 27) con compiti che, nello specifi co, spaziano dall’in-

100
dividuazione delle notizie nelle attività della propria struttura all’elabo-razione dei messaggi che dovranno veicolarle, dalla gestione di un sistema continuo di relazione con i giornalisti, alla conoscenza delle modalità operative delle diverse testate.Ma le competenze relazionali, a ben vedere, contribuiscono in modo determinante anche a quella “crescita della cultura della solidarietà” che queste strutture sono chiamate a promuovere e formare. Fare rete, per chi si occupa di comunicazione nei Centri di Servizio per il volontariato, signifi ca facilitare lo sviluppo di relazionalità nel territorio: dalla condivisione di competenze sulle pratiche di lavoro alla diffusio-ne di conoscenze sui valori della solidarietà e del volontariato; dalle attività che riguardano il rapporto diretto con il proprio pubblico (dai singoli utenti alle organizzazioni di volontariato) e con le istituzioni, ad esempio, alle operazioni di pubblicità sociale (Gadotti 2001), per concorrere al mantenimento e alla tutela dell’immagine della struttura presso il pubblico.Se fi no a qui abbiamo fornito una lettura di dati descrittivi della realtà, adesso passiamo ai dati sui bisogni percepiti dagli addetti alla comu-nicazione. Rileviamo anzitutto una forte intenzione di seguire in futuro corsi di formazione: sono 54 su 61 (89% del totale) gli intervistati che rispondono positivamente alla domanda. Da un lato la percentuale può suggerirci che in talune aree la formazione conseguita sia con-siderata suffi ciente dagli intervistati, d’altronde, come abbiamo visto (cfr. infra), i percorsi formativi non sono molto dissimili. Il dato, d’altro canto, è signifi cativo del fatto che le professionalità della comunica-zione richiedono un aggiornamento e una formazione continui. Gli strumenti di comunicazione, infatti, sono in continua evoluzione, pen-siamo, ad esempio, all’impatto della tecnologia nella professione (cfr. infra cap.5).Siamo in grado, infi ne, di specifi care gli ambiti di competenze che gli addetti alla comunicazione ritengono di dover acquisire per consoli-dare il proprio profi lo professionale.

101
Figura n.2 – I bisogni di competenze dichiarati dagli addetti alla comunicazione dei Csv – Anno 2010
Gli ambiti della comunicazione in cui si ritiene di dover acquisire competenze
Progett
azion
e
di campag
ne
Web e
social
network
NoSì
Totale dei casi: 54
0
10
20
30
40
50
60
30
24 26
2821
33
19
3538
1610 6 5
4448
49
Fund ra
ising e
public rel
ation
s
Comunica
zione i
nterna
Organizz
azion
e even
ti
Gestion
e Uffi c
io sta
mpa
Redazi
one t
esti
Informati
ca
Fonte: nostre elaborazioni
Il bisogno maggiore è quello di formazione sulla progettazione di campagne di comunicazione: più della metà di preferenze si sono espresse infatti in questo senso (30 su 54). Seguono le richieste di maggiori competenze su: web e social network (28 su 54) e a seguire fund raising e pubbliche relazioni (21 su 54), comunicazione interna (19 su 54) e organizzazione di eventi (16 su 54). In misura marginale, invece, gli operatori hanno risposto gestione dell’uffi cio stampa (10 su 54), redazione testi (6 su 54) e conoscenze di informatica in gene-rale (5 su 54). I bisogni più sentiti riguardano quindi competenze che riguardano in primo luogo attività di comunicazione esterna: segno che la comunicazione sociale, per linguaggi e temi, richiede cono-scenze specifi che. In secondo luogo, emerge il bisogno di prepararsi al confronto con i continui cambiamenti dovuti di una rivoluzione del web che provoca un incessante cambiamento di luoghi e linguaggi della comunicazione.

102
Dagli intervistati, abbiamo l’ennesima conferma della complessità delle pratiche cui sono deputate le strutture di comunicazione dei Centri Servizio per il Volontariato. Ma anche dell’intenzione di con-frontarsi con questa.Tentando una sintesi degli stimoli forniti in questo paragrafo, possia-mo affermare che l’addetto alla comunicazione dei Centri di Servizio per il Volontariato è un comunicatore di alto profi lo. A una elevata, anche se non sempre mirata, formazione di base, si somma infatti spesso una solida esperienza professionale; inoltre, è molto diffusa la percezione dell’importanza dei corsi di aggiornamento.Nell’ambito del volontariato, professionalità e specializzazione sono alla base di una comunicazione di relazione che può penetrare nel territorio: come non identifi care queste caratteristiche con i lineamenti e il percorso specifi co che gli operatori della comunicazione sociale devono avere?Il denominatore comune delle diverse attività considerate, in effetti, risulta quello di mettere in circolo quel capitale sociale che facilita l’azione coordinata di singoli che condividono bisogni e valori comuni (Mazza 2006). Se la comunicazione sociale è una disciplina dai line-amenti ancora incerti nella teoria (Peruzzi 2011), il comunicatore so-ciale ci appare una fi gura ben più strutturata dalle molte esperienze che nel Terzo settore è possibile osservare.



105
Capitolo 7Le strategie e le attività di comunicazione dei Centri di Servizio per il Volontariato
di Maria Ida Maroni e Laura Viviani1
1. La comunicazione internaLe strategie e le attività di comunicazione che descriviamo in questo capitolo riguardano la comunicazione interna ed esterna dei Centri di Servizio per il Volontariato. Nelle risposte al nostro questionario strutturato – che, ricordiamo, è mirato sostanzialmente alla comunicazione esterna – ma soprattutto nelle dichiarazioni dei testimoni privilegiati intervistati, abbiamo cer-cato informazioni concernenti, anche indirettamente, la comunicazio-ne interna, e tentato qualche approfondimento, senza la pretesa di una sintesi complessiva della stessa2. Oggi, infatti, la comunicazione di qualsiasi organizzazione non può più essere considerata sepa-ratamente nelle sue dimensioni interna o esterna: si parla invece di comunicazione organizzativa, come insieme di strategie politiche e obiettivi di condivisione che servono al funzionamento e allo svilup-po dell’organizzazione nel suo complesso (Invernizzi 2000). Dunque, essendo il focus della ricerca sulla comunicazione come strategia identitaria, per dare un’immagine il più possibile globale dell’attività comunicativa, abbiamo ritenuto necessario affrontare anche la comu-nicazione interna dei Centri di Servizio per il Volontariato. In generale, le fi nalità principali della comunicazione interna sono quelle di garantire identità all’organizzazione, ascoltare in modo at-tivo le attese e i bisogni dei differenti gruppi interni e raccogliere e gestire i contributi dei dipendenti per il miglioramento organizzativo, attraverso modalità di lavoro più coinvolgenti (Auteri 2008). In parti-
1 Maria Ida Maroni è autrice dei paragrafi 1 e 2, Laura Viviani dei paragrafi 3 e 4.2 Un’indagine sulla comunicazione interna, quindi sui meccanismi di funziona-mento dell’organizzazione, avrebbe richiesto metodi di indagine diversi da quelli da noi utilizzati, come indagini qualitative o sul campo.

106
colare, quando si ha a che fare con associazioni senza fi ne di lucro è necessario sottolineare l’importanza della mission, perché essa ri-chiede un grande impegno da parte di tutti gli associati per realizzar-ne gli obiettivi. Quindi nel non profi t l’attività di comunicazione interna può essere più complicata rispetto alle istituzioni di tipo privato (Da-mascelli e Bosotti 2007). I Centri di Servizio per il Volontariato, però, sono associazioni diverse dalle altre del Terzo Settore: sono infatti organizzazioni di secondo livello, con funzioni di rappresentanza e di servizio, che le rendono simili piuttosto a enti pubblici. Ciò rende particolare, e dunque più complesso, il loro lavoro di comunicazione interna ed esterna. Per quanto riguarda i dati in nostro possesso, solo la metà degli ope-ratori della comunicazione interpellati per la nostra survey (32 casi su 61) ha dichiarato che nei Centri di Servizio per il Volontariato nei quali lavorano si svolgono attività di comunicazione interna riconosciuta come tale. Inoltre, le informazioni raccolte attraverso le interviste a te-stimoni privilegiati, suggeriscono che sarebbero davvero pochi i Cen-tri che hanno una struttura di comunicazione interna così chiamata e dedicata. Infatti, gli intervistati mettono in evidenza che in molti Centri la comunicazione interna non è strutturata e non viene gestita da un settore specifi co ma, all’occorrenza, è quello addetto alla comuni-cazione esterna che se ne occupa. In alcuni casi, hanno addirittura parlato di una totale assenza di attività e/o strategie di comunicazio-ne interna. Ciò può essere dovuto al fatto che i Centri sono struttu-re medio-piccole, le quali potrebbero non avere come priorità quella di un uffi cio di comunicazione interna specializzato; oppure, un’altra spiegazione che ci siamo immaginati è che tali Centri potrebbero non riconoscere sotto questo nome settori affi ni come quelli delle risorse umane o del personale. Riteniamo possibile, quindi, che molti Centri di Servizio per il Volontariato siano di dimensioni tali da non sentire il bisogno di utilizzare strategie di comunicazione interna strutturate; al-tri, invece, pare ne sentano l’esigenza e ne comprendano l’importan-za, ma si rendono conto di non avere a disposizione risorse (econo-miche e umane) per creare una struttura effi cace dedicata a questo specifi co ramo della comunicazione organizzativa.

107
I Centri che dichiarano di usufruire di un sistema di comunicazione interna strutturato usano per la maggior parte lo strumento della new-sletter. Altri mezzi utilizzati sono l’intranet del sito dell’organizzazione, le email e delle piattaforme web di comunicazione interna alle quali possono accedere solo gli operatori del Centro: tutti strumenti digitali. Il massiccio utilizzo di tali tecnologie ai fi ni della comunicazione in-terna sembra essere una pratica confermata anche dalla letteratura: infatti, la comunicazione interna delle organizzazioni pubbliche e pri-vate è sempre più caratterizzata dalla cosiddetta information techno-logy. Essa, in via trasversale e con modalità sempre più integrate con gli aspetti istituzionali della comunicazione interna, si sta sostituendo alle tradizionali modalità comunicative (Auteri 2008). In realtà, alcuni testimoni intervistati sostengono che sia una prassi di diversi Centri riunirsi periodicamente per pianifi care il lavoro o per confrontarsi sulle attività svolte, ma lo si fa in modo per lo più informale, senza che si pensi a tali incontri come a forme di comunicazione interna strutturata. Tirando le somme, sembrerebbe che alcuni Centri non si rendano conto dell’importanza che potrebbe avere disporre di un sistema di comunicazione interna che sia strutturato. Infatti, analizzando le in-formazioni a disposizione, abbiamo riscontrato una diffi coltà a distin-guere il semplice scambio di informazioni quotidiano o periodico tra gli operatori da un vero e proprio sistema strutturato di comunicazio-ne interna.
2. La comunicazione esternaLa comunicazione esterna rappresenta la punta dell’iceberg della co-municazione organizzativa di ogni Centro di Servizio per il Volontaria-to. Così è in tutti i tipi di organizzazione profi t e non profi t, ma ancor di più in organismi di rappresentanza come quelli oggetto di studio.Dalla nostra ricerca risulta evidente che la comunicazione non è an-cora percepita come un’attività strategica, nonostante siano ben 51 i Centri di Servizio per il Volontariato che dispongono di un uffi cio dedicato alla comunicazione. I dati sulla percezione parlano chiaro: per quasi due terzi dei Centri (39 casi su 61 rispondenti) la comuni-cazione è considerata “abbastanza importante”, mentre sono solo 2 i

108
Centri nei quali la comunicazione è percepita come “molto importan-te”. Sembrerebbe che, non essendo la comunicazione un settore che fornisce risultati concreti e tangibili nel breve periodo, ma i cui effetti, come quelli dei processi identitari profondi, hanno bisogno di tempi più lunghi, i Centri fatichino a percepirne appieno l’importanza: sono pochi, infatti, i Centri nei quali se ne è compresa l’importanza reale e dove, di conseguenza, si investe molto in comunicazione, sia da un punto di vista umano sia economico. Quindi, nonostante la maggio-ranza dei Centri di Servizio per il Volontariato formalmente abbia un uffi cio deputato alla comunicazione, non sempre gli operatori che vi lavorano dichiarano una percezione dell’importanza del lavoro di co-municazione adeguata.L’immagine che ci suggeriscono i dati della nostra websurvey e del-le interviste per descrivere gli uffi ci dedicati alla comunicazione dei Centri di Servizio per il Volontariato è quella di uffi ci stampa allargati: uffi ci cioè nei quali si scrivono testi, si gestisce la comunicazione con i mezzi di informazione, si seleziona, si fi ltra e si sintonizza il fl usso di informazioni provenienti dall’interno dell’ente in funzione delle esigen-ze degli organi di informazione e, contemporaneamente, si interpre-tano le informazioni dei mass media a seconda della natura e delle esigenze – tutte le attività, insomma, caratteristiche di un qualsiasi uf-fi cio stampa – ma all’interno dei quali si fanno anche tante altre cose. Per esempio, ci si occupa della gestione del sito web e dei social net-work, della progettazione di campagne, dell’organizzazione di even-ti, delle relazioni pubbliche, del fund raising e della comunicazione interna. Tra le funzioni svolte dagli uffi ci deputati alla comunicazione gli intervistati hanno indicato, infatti, nell’ordine di frequenza3: attività di uffi cio stampa (50 risposte positive su un totale di 51), redazione di testi (idem), gestione del sito web (49), progettazione di campagne (40), gestione dei social network (33), comunicazione interna (32), organizzazione di eventi (30) relazioni pubbliche (27).Il lavoro quotidiano di comunicazione dei Centri di Servizio per il Vo-
3 Per ciascuna delle attività elencate, ogni rispondente doveva indicare se il suo uffi cio svolge o no quel tipo di lavoro.

109
lontariato risulta dunque caratterizzato da molteplici attività: lettura dei giornali locali, rassegna stampa, scrittura e invio di comunicati stampa, preparazione della newsletter, organizzazione di eventi e/o conferenze stampa, progettazione di campagne, aggiornamento del sito e, in misura che sappiamo inferiore, da attività concernenti i so-cial network.In alcuni di questi Centri, inoltre, sappiamo che gli operatori della co-municazione organizzano periodicamente riunioni per condividere gli obiettivi lavorativi anche con altre aree del Centro e per pianifi care il lavoro: nella maggioranza (43 casi) è proprio la struttura interna che si occupa direttamente della pianifi cazione e progettazione della co-municazione, riducendo al minimo le consulenze esterne.Per quanto riguarda gli obiettivi che i Centri si pongono al momento della pianifi cazione del lavoro, la maggioranza (un totale di 39 casi su 61) progetta periodicamente il proprio lavoro: nello specifi co sono 3 i Centri nei quali gli operatori della comunicazione si pongono obiettivi a lungo termine, 10 quelli nei quali gli addetti alla comunicazione si pongono obiettivi a breve termine e 26 i Centri nei quali si lavora con obiettivi a medio termine. Ci sono invece Centri nei quali non risulta esserci affatto una pianifi cazione strategica della comunicazione (22 casi).I dati sulla pianifi cazione del lavoro sono indicativi del fatto che la comunicazione è spesso fi nalizzata ad obiettivi a breve/medio ter-mine, ma è interessante evidenziare anche il fatto che questo lavoro di pianifi cazione della comunicazione si è sviluppato nei vari Centri a macchia di leopardo, con da una parte Centri eccellenti nei quali avviene una pianifi cazione minuziosa ed effi cace delle attività e altri dove la pianifi cazione non esiste affatto.Gli strumenti più utilizzati per portare avanti le attività dell’uffi cio de-dicato alla comunicazione sono nell’ordine: sito internet (utilizzato da 60 Centri), newsletter e email (entrambi da 57), telefono (40), periodi-ci (29), social network (28), fax (12) e circolari (8).Va evidenziato, però, che secondo la nostra websurvey, i dati relativi agli strumenti utilizzati e quelli ritenuti più effi caci non corrispondono perfettamente. Due strumenti, in particolare, sono utilizzati molto ma

110
considerati proporzionalmente meno effi caci dagli stessi interlocutori: l'email e il telefono. Al contrario, i social network risultano ancora poco utilizzati ma vengono valutati strumenti importanti di comunicazione.Partendo dal presupposto che non esistono strumenti che, in quanto tali, risultano capaci di eliminare diffi coltà o rendere più interessanti i fatti o gli avvenimenti di cui l’uffi cio stampa dà notizia (Rovinetti 2007), ciò che è rilevante ai fi ni della ricerca è stato analizzare quello che i Centri di Servizio per il Volontariato con tali strumenti possono ‘costru-ire’: dagli spazi sui quotidiani locali alle rubriche in radio, dall’ideazio-ne e realizzazione di progetti con enti e istituzioni all’organizzazione di eventi e convegni, dal contatto con il singolo giornalista all’organiz-zazione di conferenze stampa.
3. Un problema quotidiano: il gap irrisolto tra l’importanza e il costo della comunicazione
In questo paragrafo concentreremo le nostre considerazioni sulla di-stanza tra l’importanza attribuita alla comunicazione dai nostri Centri di Servizio per il Volontariato e le principali diffi coltà che essi invece incontrano nel realizzarla. In particolar modo analizzeremo una parte delle risposte ricavate dalla websurvey e ci affi deremo alle osserva-zioni di alcuni dei responsabili della comunicazione dei Centri tratte dalle interviste telefoniche ai testimoni privilegiati.Attraverso la survey abbiamo indagato come l’attività di comunicazio-ne venga percepita dai Centri di Servizio per il Volontariato. Da sot-tolineare come nessuna delle strutture consideri questa attività come marginale. Per i due terzi dei Centri di Servizio analizzati (39 casi su 61) la comunicazione è ritenuta abbastanza importante all’inter-no della propria struttura. Le strutture che indicano la comunicazione come “molto importante, perché le si dedicano ingenti risorse” sono invece 20. Detto ciò, è sicuramente un dato molto positivo il fatto che siano solo due i Centri che dichiarano che la comunicazione non rap-presenta affatto una loro priorità.Nella nostra analisi dell’attività di comunicazione svolta dai Centri di Servizio per il Volontariato abbiamo ritenuto indispensabile indagare quali fossero le principali problematiche che ostacolano il lavoro quo-

111
tidiano. La scarsità di investimenti economici è indicata come una criticità da 23 Centri. Oltre a ciò, si riscontra una diffi coltà di coordi-namento interno (20 casi), vale a dire una assenza di sinergia con le altre attività operative del Centri di Servizio per il Volontariato. Un’altra diffi coltà percepita nel corso del lavoro operativo dei vari uffi ci comu-nicazione è legata al numero di risorse umane impiegatevi, conside-rato non adeguato in 16 Centri. Un risultato considerevole invece è che ben un terzo dei responsabili (21 su 61) abbia risposto che non c’è nessun ostacolo all’attività di comunicazione.Ciò lascia intendere che buona parte dell’area comunicazione dei Centri di Servizio per il Volontariato ritenga di operare in un contesto di lavoro ottimale, un presupposto che dovrebbe facilitare l’effi cacia dello sforzo comunicativo. Risultati più che positivi si riscontrano con le altre tre risposte multiple suggerite dal questionario. Solo 6 Cen-tri di Servizio per il Volontariato hanno dichiarato di risentire di una mancanza di competenze mirate, dato in linea con le considerazioni esposte nel capitolo sesto. Lo stesso esiguo numero ha lamentato una scarsa importanza attribuita alla comunicazione da parte dei vertici del Centro di Servizio per il Volontariato: un risultato che, comparato con il livello di percezione dell’importanza delle attività di comunica-zione, dimostra quanto la comunicazione occupi un posto di rilievo all’interno della struttura, anche a livello di dirigenza. Infi ne, rispetto ai 61 responsabili della comunicazione interrogati, solo 2 hanno lamen-tato una mancanza di strumentazione: un ottimo risultato, probabil-mente legato anche allo sviluppo tecnologico degli strumenti neces-sari all’attività di comunicazione, sempre più integrati e cross mediali, e soprattutto facilmente accessibili anche a livello economico (Baldi e Zarriello 2007).Il numero di responsabili che percepiscono la comunicazione della loro struttura come abbastanza importante (39), equivale a quello dei responsabili che pensano che gli investimenti economici rivolti alla loro area non sia suffi ciente (38). Sembra dunque che in alcuni casi si venga a delineare uno scollamento tra i risultati che mostrano la cen-tralità della comunicazione, vale a dire la consapevolezza della sua importanza e l’esistenza di personale qualifi cato, e la pratica quo-

112
tidiana, dove si riscontra un investimento di fondi che non sempre, ai responsabili, appare adeguato. Naturalmente non va sottovalutato quanto la scelta di personale qualifi cato sia già di per sé un sostan-ziale investimento economico. Come sottolineano alcuni dei respon-sabili intervistati come testimoni privilegiati, scegliere di investire nella comunicazione è complesso soprattutto quando si riscontra una pro-blematicità generale a livello di risorse economiche per tutte le attività dei Centri di Servizio per il Volontariato. Il percorso metodologico impostato con la nostra ricerca ci porta d’al-tro canto a indagare le ragioni interne ai Centri, piuttosto che quelle esterne relative alle diffuse ristrettezze fi nanziarie. È qui che si anno-da un’altra delle rifl essioni suggerite dalle interviste ai responsabili: la poca consapevolezza a livello di dirigenza dei Centri di Servizio per il Volontariato. Quest’ultima non considererebbe l’attività comunicativa con il giusto peso per due ragioni principali. La prima motivazione si rintraccia nella scarsa, tradizionale propensione del Terzo settore e del volontariato di investire nella comunicazione, argomento su cui la letteratura è già intervenuta più volte (Volterrani 2006; Binotto 2006; Ranci 2006; Springhetti 2008). La seconda potrebbe essere legata ad un gap generazionale. I dirigenti dei Centri di Servizio per il Volon-tariato, a cui va il merito di aver fatto emergere il substrato del volon-tariato in Italia, sono spesso persone che hanno vissuto l’esperienza della solidarietà quando mancava quasi del tutto una organizzazione formale e istituzionale, di fatto quando gli stessi Centri ancora non esistevano. Può dunque risultare più complesso per costoro riuscire a capire l’essenzialità di un’attività considerata a lungo come acces-soria. Come spiega Cristina Galasso, addetta alla comunicazione del Cesvot:
si crede che il volontariato non abbia questo gran bisogno di comunicare, i volontari fanno e quello che fanno si vede, non c’è bisogno di comunicarlo. Negli ultimi anni, anche grazie al lavoro dei Centri di Servizio per il Volontariato, anche nelle associazioni di volontariato questa idea sta cambiando e quindi si sta cer-cando di impiegare risorse nella comunicazione.

113
Resta da segnalare infi ne un motivo suggerito da alcuni intervistati riguardo l’utilizzo delle risorse economiche. Un maggior investimento di risorse economiche non si traduce necessariamente in una svolta vincente in campo comunicativo. Questo perché spesso il problema non risiede tanto nella mancanza di strumenti, quanto nella capacità o meno di utilizzarli in modo consapevole e strategico. Un esempio può essere quello di cercare nuove collaborazioni con i media locali per dare visibilità alla associazioni. Dopo aver illustrato la percezione dell’attività di comunicazione nella struttura Centro di Servizio per il Volontariato, abbiamo ritenuto ne-cessario comprendere quale dovrebbe essere la sua comunicazione ideale. I risultati della websurvey dimostrano che per i responsabili lo sforzo comunicativo dovrebbe concentrarsi sulla promozione della cultura del volontariato e sullo stimolo del dibattito sui temi sociali. Ben 43 Centri su 61 hanno scelto questa risposta, ritenendola prioritaria rispetto all’accrescere la visibilità dei Centri di Servizio per il Volonta-riato (10) e al pubblicizzare i servizi dei Centri presso le associazioni (8). Solo un responsabile ha ritenuto che la comunicazione dei Centri dovrebbe vertere innanzitutto sul reclutamento di nuovi volontari per le associazioni.Ancora, è interessante capire se c’è una corrispondenza tra la prati-ca quotidiana di lavoro delle aree comunicazione dei Centri e la loro visione ideale di come dovrebbe svolgersi questo lavoro. Se a livel-lo ideale i responsabili a privilegiare la promozione della cultura del volontariato erano 42, nella pratica di lavoro quotidiana il numero si assesta a 36. Gli sforzi comunicativi realizzati nella pratica operativa dei Centri vertono più sulla pubblicizzazione dei suoi servizi per le as-sociazioni, 14 contro 8. Risultato quasi identico per l’incremento della visibilità dei Centri di Servizio per il Volontariato, con una sola struttura in più che sceglie questo obiettivo. L’attività che mira a reclutare nuovi volontari per le associazioni non viene invece praticata da nessun Centro. L’idea che i responsabili della comunicazione hanno di que-sta attività corrisponde quasi in toto all’effettivo impegno svolto dai Centri di Servizio per il Volontariato. Questo risultato è positivo perché mostra come la volontà dei responsabili sia sulla stessa lunghezza

114
d’onda di quella dei dirigenti dei Centri. Lavorare in un contesto in cui le scelte di fondo, relative agli obiettivi e alle strategie, sono condivise dai diversi livelli del personale è senza dubbio un’ottima premessa per una comunicazione effi cace.
Promuovere la cultura del volontariato eil dibattito sui temi sociali
Accrescere la visibilità del CSV, perraggiungere nuovi interlocutori istituzionaliPubblicizzare presso le proprie associazioni quanti e quali servizi il CSV offre
Reclutare nuovi volontari per le associazioni
Figura n. 1 – Il lavoro ideale degli addetti alla comunicazione dei Csv – Anno 2010
8 (13%)
10 (16%)42 (69%)
La comunicazione ideale di un Csv dovrebbe occuparsi di... Totale dei casi 611 (2%)
Fonte: nostre elaborazioni
Promuovere la cultura del volontariatoe il dibattito sui temi sociali
Accrescere la visibilità del CSV, perraggiungere nuovi interlocutori istituzionali
Pubblicizzare presso le proprie associazioni quanti e quali servizi il CSV offre
Reclutare nuovi volontari per le associazioni
Figura n.2 – Il lavoro quotidiano degli addetti alla comunicazione dei Csv – Anno 2010
11 (18%)
14 (23%)36 (59%)
Come gli addetti alla comunicazione trascorrono la maggior parte del tempo
Totale dei casi 61
Fonte: nostre elaborazioni

115
4. I Centri di Servizio per il Volontariato pensano al futuro? Le strategie di comunicazione
Come tutte le attività organizzative, anche la comunicazione si dimo-stra più effi cace se strutturata attraverso una attività di pianifi cazione. Altrettanto importate è una pianifi cazione della comunicazione che si ponga degli obiettivi e che li ordini secondo un criterio tempora-le (Rovinetti 2006). A questo proposito abbiamo indagato se nella comunicazione dei Centri di Servizio per il Volontariato sia prevista una pianifi cazione delle attività e quanto questa progettazione rispet-ti obiettivi di medio, lungo o breve termine. Dalla nostra websurvey notiamo che 39 uffi ci comunicazione organizzano le loro attività se-guendo una pianifi cazione strategica. In 26 uffi ci il tipo di pianifi cazio-ne effettuata prevede prevalentemente obiettivi di medio termine. Le aree comunicazione che perseguono obiettivi di lungo termine invece sono solo 3, mentre quelle che optano per progetti di breve termine sono 10. Alla pianifi cazione si lega una solida organizzazione e clas-sifi cazione delle attività svolte e da svolgere. In questo senso non si può non sottolineare l’importanza di essere dotati dello strumento che permette questa organizzazione e classifi cazione: l’archivio delle attività (Rovinetti 2006; Veneziani 2007; Lo Savio e Lorenzetti, 2008). Le strutture che si occupano della comunicazione che hanno questo archivio sono 54 su 61, anche se tra queste ce ne sono 4 che non lo aggiornano in modo sistematico. Sei uffi ci, invece, non sono ancora dotati di database delle attività, anche se ne è prevista la messa a punto. Rimane infi ne un solo uffi cio che non ne prevede la creazione.In 43 strutture che si dedicano alla comunicazione dei Centri, l’idea-zione e progettazione dei prodotti e delle strategie comunicative ven-gono sviluppate direttamente dall’uffi cio interno. Le restanti 18 aree comunicazione si affi dano invece a consulenti esterni o agenzie di comunicazione. A rivolgersi a professionisti esterni sono per la mag-gior parte i Centri di Servizio per il Volontariato del Nord Est (7 su 11). Solo 2 Centri di Servizio per il Volontariato del Nord Ovest scelgono di rivolgersi solo ad esperti della comunicazione non profi t, mentre 7 strutture scelgono di rivolgersi ad un soggetto esterno sulla base del costo di questa consulenza. Se la scelta di prediligere esperti della

116
comunicazione non profi t si ferma solo a quota 2 Centri, è probabile che ciò sia imputabile al fatto che, nonostante sia cresciuta, e vada sempre più specializzandosi, ad oggi non si sia ancora affermata una vera e propria fi gura del professionista della comunicazione so-ciale (Volterrani 2006; Binotto 2006; Ranci 2006; Springhetti 2008).



119
Conclusioni
di Gaia Peruzzi
La ricerca che abbiamo illustrato in questo volume costituisce il primo studio sociologico dedicato a quell’istituzione, unica nel panorama del non profi t italiano e internazionale, che è la rete italiana dei Centri di Servizio per il Volontariato. Queste organizzazioni, istituite per leg-ge venti anni fa, con lo scopo di sostenere la diffusione e la crescita del volontariato e della cultura della solidarietà, si sono diffuse nel de-cennio successivo in tutte le regioni della penisola, e hanno svolto, e svolgono, funzioni di coordinamento, di supporto e di rappresentanza delle associazioni locali, mediante l’erogazione di molteplici servizi (di informazione, formazione, consulenza e promozione) alle organiz-zazioni di volontariato e del Terzo settore. Il Csvnet, il Coordinamento nazionale che dal 2003 raccoglie quasi tutti i Centri della penisola, si adopera per organizzare in un’unica voce le esigenze e le posizioni dei membri della rete di fronte agli attori della vita pubblica e politi-ca nazionale e internazionale, e per costruire esperienze condivise e qualifi cate di rifl essione e di intervento. Il progetto all’origine di questo lavoro costituisce per l’appunto un esempio di questo tipo di azione: esso è stato ideato e promosso dal Coordinamento nazionale, che si è adoperato per costruire la partnership con l’Università, e realizzato con la partecipazione attiva dei singoli Centri.Gli obiettivi su cui è stato plasmato il disegno della ricerca miravano sia a fornire delle conoscenze utili al soggetto indagato che a colmare un gap conoscitivo della ricerca sociologica in tema di comunicazio-ne e di cultura della solidarietà. Infatti, se i risultati di questa indagine rappresentano un’occasione importante di auto-rifl essione per i tutti i Centri indagati (e gli strumenti lasciati a disposizione in appendice sono addirittura degli utensili pratici con cui essi possono sperimen-tarsi in percorsi di auto-valutazione), i medesimi dati contribuiscono a gettare qualche sprazzo di luce anche sui campi della letteratura pertinente. Proviamo dunque a organizzare in una rifl essione sintetica le principali evidenze emerse dalle analisi effettuate.

120
La prima è una nota di natura metodologica. La comunicazione come chiave di accesso alla comprensione dell’identità e della vita di un’or-ganizzazione si è confermata una strada molto fertile. Altrettanto può dirsi di un approccio integrato, che esplora insieme i territori fi sici dell’esperienza e quelli del cyberspazio, utilizzando strategie sia on-line che offl ine. Studiare l’immagine comunicata dal sito, e i servizi e le relazioni gestite sul web, e integrare questi dati con le spiegazioni e i dettagli suggeriti dagli abitanti dei relativi uffi ci, si è rivelata infatti un’azione in grado di restituire informazioni ricche, coerenti e origina-li. Queste hanno permesso di “colorare”, di rendere più spesse e vive le fi gure dei Centri di Servizio per il Volontariato, che fi nora erano sta-te tratteggiate esclusivamente dai report autoprodotti e diffusi dalle strutture medesime, e di porre qualche nuovo mattoncino nella cono-scenza di quel mondo eterogeneo e complicato che è il non profi t.Chi sono, dunque, e come funzionano, i Centri di Servizio per il Volon-tariato raccontati dai propri siti e social network uffi ciali, e dalle testi-monianze degli operatori e dei responsabili della comunicazione? I nostri Centri sono organizzazioni tutte professionali e molto attive, in grado di costruirsi presentazioni adeguate sui territori digitali, e che regolarmente erogano informazioni e servizi di buona, se non elevata, qualità, in misura spesso copiosa. La scarsa signifi catività, nell’analisi della maggior parte delle risposte registrate nel monitoraggio dei siti, della variabile “territorio di appartenenza” suggerisce che l’istituzione di questi enti possa aver innescato degli effetti omogeneizzanti, al-meno a livello di organizzazione e di formalizzazione, del volontariato italiano. Sempre dallo studio delle vetrine e degli ambienti digitali sono emer-se alcune costanti che consentono di mettere a fuoco altri particolari dell’identità di questa rete. Si è detto a inizio di questo lavoro che i compiti formalmente attribuiti, per nascita, ai Centri di Servizio, li confi gurano come uno dei volti istituzionali del volontariato nazionale. L’esame della comunicazione conferma che la fusione tra un’anima “istituzionale” e una “sociale” è un lineamento che caratterizza tan-to la loro immagine quanto la loro vita organizzativa. Se i siti sono formalmente quasi impeccabili nel presentare le relative strutture,

121
come richiede una buona comunicazione istituzionale, e nel com-plesso superano brillantemente la prova dei servizi, in ciò mostran-do di adempiere concretamente a una delle funzioni distintive della comunicazione sociale, di entrambi i due generi di comunicazione essi riproducono però anche i più classici difetti. I siti dei Centri di Servizio per il Volontariato parlano infatti più alla testa che al cuore dei propri pubblici: quanto sono diligenti nello specifi care le leggi e i compiti cui sono deputati, tanto sono sbrigativi e formali nei riferimenti alle origini storiche e ai principi valoriali su cui si fondano il volontaria-to e la cittadinanza attiva. Sicuramente essi incarnano bene lo spirito di formalità indispensabile a garantire credibilità e autorevolezza alla propria mission; non riescono però a evitare del tutto quell’impressio-ne di freddezza che è tipica delle organizzazioni burocratiche. Non è un caso che, fra tutti i servizi erogati, quelli che i nostri Centri evi-dentemente faticano a implementare sono l’uso dei social network e le pratiche di dialogo e di interattività con i cittadini: criticità, come è noto, diffuse nella comunicazione della pubblica amministrazione. La diffi coltà ad aprirsi, ad attrarre e a coinvolgere pubblici altri rispetto ai destinatari tradizionali (le associazioni di volontariato e di promozione sociale), evoca invece uno dei problemi classici della comunicazio-ne sociale: l’autoreferenzialità. Sintomo di una malattia del medesimo ceppo sono senza dubbio poi le mancanze che sono state rilevate riguardo alla comunicazione dell’identità di rete: molti siti non comuni-cano in maniera chiara e adeguata la propria appartenenza al Coor-dinamento nazionale. Un po’ più forte sembra invece, nel complesso, la disponibilità dei Centri a creare relazioni e ponti con i propri pari e con alcuni enti pubblici del territorio. In proposito, c’è da segnalare però che il web sembra offrire delle opportunità interessanti a quelle organizzazioni che manifestino un po’ di attenzione a investire tempo e risorse nella promozione del vo-lontariato sul cyberspazio. Alcuni Centri che hanno previsto sui propri siti percorsi mirati di navigazione, magari insieme a qualche servizio di informazione online particolarmente curato, sono riusciti a intercet-tare, in quei territori fl uidi ed eterogenei che sono gli spazi della Rete, pubblici nuovi e diversi. In particolare, sono stati identifi cati come

122
ulteriori target raggiunti dal/sul web studiosi, ricercatori ed esperti di temi e problemi del Terzo settore.Il nostro caso-studio dunque, dandosi come un esempio particolare di contaminazione tra comunicazione sociale e comunicazione isti-tuzionale, ci suggerisce che la sfera delle comunicazioni pubbliche sia più densa e complessa di confi gurazioni di quanto la letteratura ancora non abbia avuto modo di raccontare. Questo esempio, infi -ne, ci esorta anche a rivedere l’immagine dei comunicatori sociali. Nel mercato della formazione professionale e dell’occupazione gli addetti alla comunicazione sociale sono considerati e trattati come fi gure marginali. Invece, la mappatura degli uffi ci di comunicazione dei Centri appartenenti alla rete ha portato alla luce un bacino di com-petenze notevole, e bisogni e attività di comunicazione così densi e articolati, da far cominciare a pensare che la comunicazione sociale possa confi gurarsi come un settore di nicchia sì, ma non perché resi-duale, bensì perché specializzato.



125
Bibliografia
AUTERI ENRICO 2008 — Management delle risorse umane, Milano, Guerini.
BAGGIANI DANIELE 2011 — Le competenze del volontariato. Un modello di analisi dei fabbisogni formativi, Cesvot, “I Quaderni”, n. 51, < http://www.cesvot.it/usr_view.php/ID=52 >.
BAGNOLI LUCA
2007 — Il bilancio sociale delle organizzazioni di volontariato. Guida pratica, Cesvot, “I Quaderni”, n. 34 < http://www.cesvot.it/usr_view.php/ID=52 >.
BALDI CARLO, ZARRIELLO ROBERTO
2007 — Penne digitali 2.0. Fare informazione online nell’era dei blog e del giornalismo diffuso, Roma, Centro di documentazione giornali-stica.
BARBETTA GIAN PAOLO, MAGGIO FRANCESCO
2008 — Nonprofi t. Il nuovo volto della società civile, Bologna, il Mu-lino.
BERTOLO CARLA 2008 — Comunicazioni sociali. Ambiguità, nodi e prospettive, Pado-va, Cluep.
BINOTTO MARCO
2006 — “Volontari nella rete”, in Andrea VOLTERRANI (a cura di), Raccontare il volontariato, op. cit., 134-140.2010 Comunicazione sociale 2.0, Roma, Nuova Cultura.
BOSCAROL MAURIZIO
2003 — Ecologia dei siti Web, Milano, Tecniche Nuove.

126
BOSOTTI GIANCARLA, DAMASCELLI NINO
2007 — Comunicazione e Management. Introduzione alla comunica-zione organizzativa, Milano, FrancoAngeli.
CARULLI STEFANIA
2011 — “Il non profi t in Rete tra riduzioni e tagli”, Comunicazionepun-todoc, n. 4, Roma, Lupetti, 305-316.
CASTELLS MANUEL 2002 — Galassia internet, Milano, Feltrinelli.
CAVALLO MARINO, SPADONI FEDERICO 2010 — I social network. Come internet cambia la comunicazione, Milano, FrancoAngeli.
CAVENAGO DARIO, MEZZANZANICA MARIO (a cura di)
2010 — Scienza dei servizi. Un percorso tra metodologie e applica-zioni, Milano, Springer.
CIOTTI LUIGI (a cura di)
2002 — Il volontariato nelle Marche anno 2002, Ancona, Centro di Servizio per il Volontariato delle Marche.
COMUNELLO FRANCESCA 2010 — Networked sociability. Rifl essioni e analisi sulle relazioni so-ciali (anche) mediate dalle tecnologie, Milano, Guerini.
CSVNET
2010 — Report 2008-2009. Resoconto delle attività 2008-2009 dei Centri di Servizio per il Volontariato; < http://www.csvnet.it/usr_view.php/ID=1536 >.
CUCCO ENZO, PAGANI ROSARIA, PASQUALI MAURA (a cura di)
2005 — Primo rapporto sulla comunicazione sociale in Italia, Roma, Rai-Eri.

127
CUCCO ENZO, PAGANI ROSARIA, PASQUALI MAURA, SOGGIA ANTONIO
(a cura di)
2011 — Primo rapporto sulla comunicazione sociale in Italia, Roma, Carocci.
DE VINCENTIIS MAURO
1999 — L’Uffi cio Stampa, Milano, Lupetti.
DI FRAIA GUIDO
2007 — Blog-grafi e: identità narrative in rete, Milano, Guerini.
DIODATI MICHELE
2007 — Accessibilità. Guida completa, Milano, Apogeo.
FACCIOLI FRANCA (a cura di)
2000 — Comunicazione pubblica e cultura del servizio, Roma, Ca-rocci.
FAUSTINI GIANNI (a cura di)
Le tecniche del linguaggio giornalistico, Roma, Carocci.
FORNARI GIANCARLO
2004 — La nuova comunicazione pubblica. Strategie e tecnologie per avvicinare le istituzioni ai cittadini, Milano, Il Sole 24 Ore.
GADOTTI GIOVANNA
2001 — La comunicazione sociale. Soggetti, strumenti e linguaggi, Milano, Arcipelago.2005 — “Gli attori e i temi della comunicazione sociale”, in Enzo CUC-CO, Rosaria PAGANI e Mauro PASQUALI (a cura di), op. cit., 47-98.
GAZZOLA ELISABETTA (a cura di)
2008 — La raccolta fondi per le organizzazioni di volontariato. Idee, suggerimenti e strumenti, Approfondimenti, n. 2, Milano, Coordinamen-to Regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia.

128
GIORGINO FRANCESCO
2004 — Dietro le notizie, Milano, Mursia.
GRANIERI GIUSEPPE
2005 — Blog generation, Roma, Laterza.
GRASSO MARIO
2002 — Scrivere per il Web. Annotazioni, considerazioni e suggestio-ni per quanti intendono conoscere la scrittura online, Milano, Franco-Angeli.
HARPER SIMON, YESILADA YELIZ
2008 — Web Accessibility: A Foundation for Research, Londra, Springer.
HINE CHRISTINE (a cura di)
2005 — Virtual methods. Issues in Social Reseach on the Internet, New York, Berg.
INVERNIZZI EMANUELE 2000 — La comunicazione organizzativa: teorie, modelli e metodi, Milano, Giuffrè.
JENKINS HENRY 2007 — Cultura convergente, Milano, Apogeo (ediz. orig. Conver-gence Culture, New York, New York University Press, 2006).
LEPRI SERGIO
1991 — Professione giornalista, Milano, Etas.
LIEVROUW LEAH, LIVINGSTONE SONIA (a cura di)
2007 — Capire i new media, Milano, Hoepli (ediz. orig. The Hand-book of New Media, Londra, Sage, 2006).

129
LO SAVIO FABIO, LORENZETTI LUCA
2008 — Comunicare ai media. L’uffi cio stampa nell’era del Web 2.0, Roma, Eurilink.
LOVARI ALESSANDRO, MASINI MAURIZIO
2008 — Comunicazione pubblica 2.0. Tecnologie, linguaggi, formati, Milano, FrancoAngeli.
LUNARIA 2001 — L’ABC del Terzo Settore. Lavoro, progettazione, fi nanziamen-ti, leggi, comunicazione, Roma, Edizioni Lavoro.
MAISTRELLO SERGIO
2010 — Giornalismo e nuovi media. L’informazione al tempo del citi-zen journalism, Milano, Apogeo.
MANCINI PAOLO
2004 — Manuale di comunicazione pubblica, Roma, Laterza.
MARINELLI ALBERTO
2004 — Connessioni. Nuovi media, nuove relazioni sociali, Milano, Guerini.
MARTELLI STEFANO
2006 — La comunicazione del Terzo settore nel Mezzogiorno, Milano, FrancoAngeli.2009 — La comunicazione al servizio del volontariato, Milano, Fran-coAngeli.
STEFANO MARTELLI, SALVATORE GAGLIO (a cura di)
2004 — Immagini della emergente società in rete, Milano, Franco An-geli.
MATACENA ANTONIO
1999 — Scenari e strumenti per il Terzo Settore, Milano, Egea.

130
MAYFIELD ANTONY
2008 — What is social media?, iCrossing, V1.4 updated 01.08.08; http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_So-cial_Media_iCrossing_ebook.pdf.
MAZZA BARBARA
2006 — Alla ricerca della relazionalità diffusa. Quali spazi fra capitale sociale, competenze relazionali e comunicazione sociale, in Andrea VOLTERRANI (a cura di), op. cit., 275-282.
MORCELLINI MARIO, ABRUZZESE ALBERTO (a cura di)
1995 — La comunicazione, Viterbo, Stampa Alternativa.
MORCELLINI MARIO, FATELLI GIOVANBATTISTA
2007 — Le scienze della comunicazione. Modelli e percorsi discipli-nari, Roma, Carocci.
MORCELLINI MARIO, LALLI PINA, STELLA RENATO (a cura di)
2008 — Spazi comunicativi contemporanei, Roma, Editori Riuniti.
MORCELLINI MARIO, MAZZA BARBARA (a cura di)
2008 — Oltre l’individualismo. Comunicazione, nuovi diritti e capitale sociale, Milano, FrancoAngeli.
NIELSEN JACOB, LORANGER HOA
2006 — Web Usability 2.0. L’usabilità che conta, Milano, Apogeo (ed. orig. Prioritizing Web Usability, Berkeley, New Riders, 2006).
NIELSEN JACOB, TAHIR MARIE 2002 — Homepage Usability. 50 siti Web analizzati, Milano, Apogeo (ed. orig. Homepage usability: 50 Websites Deconstructed, Indianapolis, New Riders, 2002).

131
O’REILLY TIM
2005 — What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software; <http://www.oreillynet.com/pub/a/or-eilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html?page=1>.
OLIVETTI MANOUKIAN FRANCA
1998 — Produrre servizi. Lavorare con oggetti immateriali, Bologna, il Mulino.
PERUZZI GAIA
2010 — “S.O.S CULTURA. I nuovi media salveranno il teatro e le arti dal vivo?”, Studi culturali, n. 3, 451-465.2011 — Fondamenti di comunicazione sociale. Diritti, media, solida-rietà, Roma, Carocci, in corso di stampa.
PERUZZI GAIA, VOLTERRANI ANDREA
2010 — “Daily Life of Non Profi t Organizations Inhabiting the Web”, Journal of Sociocybernetics, vol. 7, 107-120; < http://www.unizar.es/sociocybernetics/Journal/index.html >.
PEVERINI PAOLO, SPALLETTA MARICA
2009 — Unconventional: valori, testi, pratiche della pubblicità socia-le, Roma, Meltemi.
POGGIALI VIERI
2005 — Uffi cio stampa: dottrina e tecnica della comunicazione “tim-brata” di aziende, enti, istituzioni, Roma, Centro di documentazione giornalistica.
POLILLO ROBERTO
2004 — Il check-up dei siti Web. Valutare la qualità per migliorarla, Milano, Apogeo.2006 — Plasmare il Web. Road map per siti di qualità, Milano, Apo-geo.

132
POSTAI SOFIA 2004 — Siti che funzionano 2.0. Quando web design non signifi ca disegni sul Web, Milano, Tecniche Nuove.
RANCI COSTANZO 2006 — Il volontariato, Bologna, Il Mulino.
ROMA ANGELO
2005 — Informare. Tecniche di scrittura per la comunicazione interna, Milano, FrancoAngeli.
ROMANO DARIO, FELICIOLI RICCARDO
1999 — Comunicazione interna e processo organizzativo. Al di là del marketing interno, verso sistemi di comunicazione orientati allo svi-luppo dell’impresa, Milano, Raffaello Cortina.
ROSSI ROSSANA ADELE
2005 — Formazione e nuova cittadinanza. Le prospettive della demo-crazia, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino.
ROSSI GIOVANNA, BOCCACIN LUCIA
2007 — Il capitale sociale in un’organizzazione multilivello di terzo settore, Milano, FrancoAngeli.
ROVERSI ANTONIO
2004 — Introduzione alla comunicazione mediata dal computer, Bo-logna, il Mulino.
ROVINETTI ALESSANDRO 2000 — I comunicatori pubblici: profi li possibili, in Franca FRACIOLI (a cura di), op. cit., 211-233.2007 — Comunicazione pubblica. Sapere & fare, Milano, Il Sole 24 Ore.

133
SARTI MAURO
2007 — Il giornalismo sociale, Roma, Carocci.
SIMONIN DANIELE
2007 — Il Web 2.0, Revisione: 3 (15 Settembre 2007), Creative Com-mons BY-NC-ND; <http://projects.melodycode.com/Web20/>.
SOLITO LAURA 2010 — Cogito ergo sum. Idee e fatti sulla comunicazione, Firenze, Le Lettere Università.
SOLITO LAURA, SORRENTINO CARLO (a cura di)
2011 — Il volontariato. Immagini, percezioni e stereotipi, Cesvot, “I Quaderni”, n. 50.
SORICE MICHELE
2001 — Dall’evento al testo, in Gianni FAUSTINI (a cura di), Le tecni-che del linguaggio giornalistico, op. cit., 63-64.
SORRENTINO CARLO
2002 — Il giornalismo. Che cos’è e come funziona, Roma, Carocci.
SPRINGHETTI PAOLA
2008 — Solidarietà indifesa. L’informazione nel sociale, Bologna, Emi.
STAGLIANÒ RICCARDO
2002 — Giornalismo 2.0. Fare informazione al tempo di Internet, Roma, Carocci.
VENEZIANI SERGIO
2007 — Organizzare l’uffi cio stampa, Milano, Il Sole 24 Ore.
VISCIOLA MICHELE
2006 — Usabilità dei siti Web. Curare l’esperienza d’uso in Internet, Milano, Apogeo.

134
VOLTERRANI ANDREA (a cura di)
2006 — Raccontare il volontariato, Cesvot, “I Quaderni”, n. 29; < http://www.cesvot.it/usr_view.php/ID=52 >.
VOLTERRANI ANDREA, TOLA PAOLA, BILOTTI ANDREA
2009 — Il gusto del volontariato. Tra etica, valutazione partecipata e innovazione sociale, Roma, Exòrma.
WELLMAN BARRY
2007 — “The network is personal: introduction to a special issue of Social Networks”, Social Networks, n. 29, Issue 3, 349-356.



137
Appendice
1. Il questionario per la valutazione dei siti
Il questionario pubblicato in questa appendice è lo strumento sul-la base del quale sono stati analizzati e valutati i siti dei Centri di Servizio per il Volontariato aderenti al Coordinamento nazionale. Per la precisione, al momento della rilevazione erano disponibili, e sono stati monitorati, 71 siti.
Elenco dei Centri di Servizio monitoratiCsv di AlessandriaCsv dell’AquilaCsv di AstiCsv di AvellinoCsv di BariCsv della BasilicataCsv di BellunoCsv di BeneventoCsv di BergamoCsv di BiellaCsv di BolognaCsv di BresciaCsv di BrindisiCsv di CampobassoCsv di CasertaCsv di CataniaCsv di CatanzaroCsv di ChietiCsv di ComoCsv di CosenzaCsv di CremonaCsv di CrotoneCsv del Friuli Venezia GiuliaCsv di Imperia

138
Csv di Foggia (Cesevoca)Csv di Foggia (Daunia)Csv di GenovaCsv di IserniaCsv di LarinoCsv del Lazio (Cesv)Csv del Lazio (Spes)Csv di LecceCsv di LeccoCsv di LodiCsv di MantovaCsv delle MarcheCsv di MessinaCsv di MilanoCsv di ModenaCsv di Monza e BrianzaCsv di NapoliCsv di NovaraCsv di ParmaCsv di PiacenzaCsv di PalermoCsv di PaviaCsv di PerugiaCsv di PescaraCsv di PiacenzaCsv di RavennaCsv di Reggio CalabriaCsv di Reggio EmiliaCsv di RiminiCsv di RovigoCsv di SalernoCsv della SardegnaCsv di SavonaCsv di SondrioCsv di Taranto

139
Csv di TeramoCsv di TerniCsv di Torino (Idea Solidale)Csv della Toscana (Cesvot)Csv di TrentoCsv di TrevisoCsv di VareseCsv di VeneziaCsv di VeronaCsv di VercelliCsv di VicenzaCsv della Valle D’Aosta
Sezione 0.I requisiti minimi per un sito professionale
Il livello del sito è adeguato alle esigenze di una struttura professionale?
Si valuta la presenza di quei requisiti tecnici indispensabili a distin-guere un sito come professionale, adeguato alle esigenze comunica-tive fondamentali di un’organizzazione lavorativa.Il sito offre i requisiti minimi di navigabilità indipendentemente dal tipo di hardware o software utilizzato (codice corretto, testi chiari e leggi-bili, testi alternativi, disposizione coerente dei contenuti)?Il sito è effi cace? Ovvero: i contenuti sono organizzati e presentati in maniera chiara? Sono ben indicizzati? Presentano tutte le informazio-ni necessarie? Il sito offre la possibilità ai soggetti con differenti abilità di accedere ai contenuti offerti (tecnologie assistive e uso di confi gu-razioni particolari)?
0.1) Il caricamento delle pagine del sito avviene in tempi rapidi?1. Molto2. Abbastanza3. Poco4. Per niente

140
0.2) L’Url del sito è pertinente con il nome dell’ente (ad es. www.csv.marche.it)?1. Sì2. No
0.3) A prima vista il sito dà l’impressione di essere un sito professionale?1. Sì, senza dubbio l’impatto visivo è quello di un sito fatto da
professionisti2. Nel complesso sì, anche se alcuni particolari potrebbero
essere curati meglio3. No, perché i contenuti appaiono organizzati in maniera poco
chiara/effi cace4. No, perché i testi sono ricchi di animazioni in Flash5. No, il sito sembra “fatto in casa” (le immagini non sono niti-
de, e/o il testo è poco leggibile, etc.)
0.4) Il tipo di carattere utilizzato è lo stesso in tutte le pagine?1. Sì, ed è sempre un carattere bastoni/senza grazie2. Sì, ma è un carattere con le grazie/non bastoni3. No, si cambia spesso carattere
0.5) Il testo è allineato a sinistra?1. Sì, sempre2. A volte sì, altre no3. In genere no
0.6) Nei testi predomina l’utilizzo di caratteri scuri su sfondi chiari?1. Sì, il testo è sempre nero su sfondo bianco2. Sì, c’è sempre testo scuro su sfondo chiaro, anche se i co-
lori non sono proprio bianco e nero3. No, la modalità scuro su chiaro non è ricorrente

141
0.7) Quali sono i colori predominanti? (oltre allo sfondo bianco e al nero dei caratteri)1. (Specifi care fi no a 3 colori)
0.8) Il logo del Csv:1. È presente in tutte le pagine (compresa la home page),
sempre nella stessa posizione2. È presente in tutte le pagine, ma in posizioni diverse3. È presente solo in alcune pagine, fra cui la home4. Non è presente neppure nella home page
0.9) I link presenti all’interno del sito funzionano correttamente?1. Sì, tutti2. La maggior parte3. Solo alcuni4. Nessuno
0.10) Nella home page del sito c’è ben visibile una sezione “cerca”?1. Sì, e funziona correttamente2. Sì, ma non funzione bene3. No, non c’è
0.11) Esiste una mappa del sito?1. Sì, e funziona correttamente2. Sì, ma non funzione bene3. No, non c’è
0.12) Si utilizzano menù orizzontali e verticali per favorire la navigazione del sito?1. Sì, sia verticali che orizzontali2. Solo verticali3. Solo orizzontali4. No, né verticali né orizzontali

142
0.13) C’è una struttura fissa (logo+menù) che permetta all’utente di sapere sempre su quale sito si trova?1. Sì, su tutte le pagine2. No, solo su alcune pagine3. No, su nessuna pagina
0.14) C’è in home page una sezione “Contatti” del Csv?1. Sì, ben visibile e dettagliata (nomi dello staff, e/o foto, etc.)2. Sì: fornisce un indirizzo di posta completo ma anonimo3. Sì, ma non è completa e/o non è ben visibile nella home
page4. No, non c’è
0.15) Sul sito sono pubblicate delle foto?1. Sì, ce ne sono parecchie, sulla home e all’interno, tutte di
livello professionale 2. Non ce ne sono molte, ma sono tutte di livello professiona-
le3. Ce ne sono parecchie, ma non sono immagini curate/ben
defi nite4. Non ce ne sono/Ce ne sono poche, e poco curate
0.16) Il sito è disponibile anche in altre lingue? 1. Sì2. No
0.17) Le pagine possono essere navigate per tabulazioni?1. Sì2. No
0.18) Aumentando la grandezza del font sono mantenute le informazioni e la loro struttura?1. Sì2. Solo in parte3. No

143
0.19) Eliminando le immagini dalla home page, sono fornite descrizioni di testo alternative per utenti diversamente abili?1. Sì, sempre2. Sì, ma solo in qualche caso3. No
Aggiungere eventuali segnalazioni
Sezione 1.La presentazione del Csv
Il sito spiega adeguatamente cos’ è un Csv e cosa fa il Csv in questione?
Si valuta se il sito fornisce in maniera adeguata le informazioni essen-ziali per far comprendere anche a un non esperto cos’ è e cosa fa un Csv.Perché nascono e cosa fanno i Csv? Come si presenta il Csv in que-stione?
1.1) L’acronimo Csv è:1. Chiaramente spiegato nel logo e nei passaggi chiave del
testo, così che la natura dell’ente è immediatamente com-prensibile anche a un non esperto del settore
2. È spiegato sono nel logo, e nel testo non lo si “scioglie” qua-si mai
3. Non è spiegato neppure nel logo!
1.2) Il logo del Csv è composto di:1. 1. Solo testo vai a domanda 1.42. Figura e testo
1.3) Di quale figura si tratta?1. (Specifi care)

144
1.4) Sul sito c’è una pagina dedicata alla presentazione del Csv (cos’è un Csv, cosa fa un Csv?)1. Sì, ed è chiaramente linkabile dalla home page2. Sì, ma non è facile da trovare3. Una pagina intera non c’è, c’è solo un paragrafo in un te-
sto3. 4. No, non c’è né un testo né un riferimento mirato vai a
domanda 1.6
1.5) Il testo di presentazione del Csv:1. È chiaro e ricco di informazioni, che rendono facile anche a
un non esperto capire cos’è e cosa fa un Csv2. Ci sono le informazioni indispensabili per la presentazione
di un Csv3. Ci sono molte informazioni sul Csv in questione, ma un non
esperto del settore avrebbe diffi coltà a comprendere che cosa sono e cosa fanno in generale i Csv
4. Ci sono solo poche informazioni sul Csv in questione
1.6) La normativa sui Csv:1. Fa riferimento solamente alla legge che li ha istituiti.2. Oltre alla legge istitutiva dei Csv, è completa di ulteriori ag-
giornamenti3. Non è mai nominata
1.7) Riguardo alla storia del Csv in questione:1. Non ci sono altri riferimenti oltre a quelli della legge che ha
istituito i Csv in Italia2. C’è un riferimento breve (di carattere storico, legislativo,
etc.) alle sue origini specifi che, al rapporto con il territorio3. Ci sono informazioni interessanti sulle origini, sui protagoni-
sti e la storia di questa struttura
1.8) È presente l’elenco delle associazioni aderenti al Csv?1. Sì, sono indicati i nomi delle associazioni corredati da link ai

145
siti delle associazioni e dall’indicazione dell’area in cui ope-rano oppure da una sintetica descrizione delle loro attività
2. Sì, sono indicati i nomi delle associazioni corredati da link ai rispettivi siti
3. Sì, sono indicati i nomi delle associazioni, senza link4. No, c’è un generico riferimento alle associazioni del territo-
rio/No, non c’è alcun riferimento alle associazioni del territo-ri
1.9) Nelle sezioni di presentazione del Csv si riporta l’organico del Csv?1. Sì, viene presentata la struttura del Csv con i relativi organi
e incarichi e sono indicati anche i nomi delle persone che ricoprono i vari ruoli
2. Sì, viene presentata la struttura del Csv con i relativi organi e incarichi
3. No, l’organico non è presente sul sito
1.10) Nelle sezioni relative all’identità del Csv, si fa riferimento ai valori sociali fondanti l’attività di volontariato?1. Sì, sono ripetutamente citati diversi valori (solidarietà, de-
mocrazia, pluralismo, etc.)2. Sì, ma il riferimento ai valori è anonimo/generico/poco effi -
cace3. No, non si fa mai riferimento ai valori
1.11) La maggior parte delle foto pubblicate sul sito:1. Ritraggono uffi ci e ambienti di lavoro, con effetto complessi-
vo professionale ma abbastanza anonimo2. Raccontano la vita del Csv, delle sue organizzazioni e del
volontariato3. Evocano temi e categorie del sociale, in maniera professio-
nale ma anonima4. Ritraggono/evocano temi e categorie del sociale, in manie-
ra molto originale

146
1.12) Sono presenti percorsi di navigazione rivolti a categorie mirate di utenti?1. Sì, ci sono dei percorsi/settori riservati/espressamente rivolti
alle associazioni2. Sì: oltre a sezioni e percorsi mirati alle associazioni, il sito
cerca di interessare anche esperti e interlocutori privilegiati3. No, il sito parla in maniera indistinta a qualunque utente
Aggiungere eventuali segnalazioni
Sezione 2.I servizi offerti dal sito
Quali servizi e informazioni di servizio offre il sito?Si valutano la tipologia e la qualità dei servizi offerti dal sito alle as-sociazioni e agli utenti nei seguenti settori: informazione, promozione della cultura del volontariato (anche presso i cittadini e i mass media), formazione e amministrazione.Quali servizi di informazione offre il sito del Csv? Qual è la qualità del-le informazioni pubblicate?Oltre alle informazioni di servizio, il sito fornisce notizie/informazioni/percorsi utili a far conoscere e a promuovere la cultura del volontaria-to? A chi si rivolgono questi servizi: persone già esperte? giornalisti ed esperti di comunicazione? semplici navigatori?Il sito offre servizi o informazioni utili alle associazioni per progettare e organizzare azioni formative (formali e informali, in presenza o a distanza)? Si dà notizia sul sito di iniziative con valenza formativa, tipo incontri, tavole rotonde, seminari, organizzati anche da altri sog-getti?Il sito offre informazioni e servizi utili per la raccolta fondi e per le attività di gestione e rendicontazione dei progetti? Il sito offre informa-zioni sulle possibilità di donazione alle associazioni, anche on line? E su eventi e campagne legati alla raccolta fondi? Il sito dà informazio-ne dei risultati raggiunti dal Csv o dalle associazioni con iniziative in materia?

147
2.1) A quando risale l’ultimo aggiornamento delle news?1. Ad oggi2. A ieri3. All’ultima settimana4. All’ultimo mese5. A più di un mese fa6. Non ci sono news sul sito vai a domanda 2.8
2.2) Negli ultimi 10 giorni quante notizie sono state pubblicate dal Csv?1. Nessuna2. Da 1 a 103. Più di 10
2.3) Qual è lo stile prevalentemente adottato nella stesura delle notizie?1. Testi effi caci, sintetici e completi2. Testi poco effi caci, perché troppo poveri3. Testi poco effi caci, perché lunghi e dispersivi
2.4) Le notizie sono corredate da link di approfondimento e/o dalla possibilità di scaricare materiali?1. Sempre/Quasi sempre2. Solo alcune volte3. Mai/Quasi mai
2.5) Le notizie sono corredate da immagini?1. Sempre/Quasi sempre2. Solo alcune volte3. Mai/Quasi mai
2.6) Le immagini poste a corredo delle notizie sono prevalentemente:1. Immagini di bassa qualità2. Immagini anche ben fatte, ma dall’effetto generico/anoni-

148
mo, che non trasmettono all’utente ulteriori informazioni o emozioni rispetto a quelle del testo scritto
3. Immagini originali e interessanti, che arricchiscono il testo con evocazioni e suggestioni importanti
2.7) Le news pubblicate:1. Riguardano esclusivamente iniziative del Csv e delle sue
associazioni2. Riguardano il mondo del Terzo Settore in senso ampio: quin-
di informazioni sulla vita delle associazioni, ma anche su ini-ziative politiche e legislative che coinvolgono il sociale
3. Hanno un respiro molto ampio, e trattano i temi del sociale e del terzo settore da punti diversi: culturale, politico, eco-nomico; le iniziative delle associazioni sono solo una parte/uno spunto per trattare questi temi
2.8) Il sito offre la possibilità di iscriversi a/consultare una newsletter?1. Sì, che ha una periodicità settimanale/quindicinale2. Sì, che ha una periodicità tra il mensile e l’annuale3. Sì, ma questa non ha una periodicità precisa1. 4. No, non c’è nessuna newsletter vai a domanda 2.12
2.9) La newsletter ha una grafica:1. Coordinata con la grafi ca del sito del Csvnet2. Coordinata con la grafi ca del sito del Csv3. Non coordinata con quella di altri prodotti
2.10) L’ultima newsletter contiene almeno un contenuto originale, non presente sul sito?1. Sì2. No
2.11) Esiste un archivio delle newsletter?1. Sì, ed è aggiornato

149
2. Sì, ma non è aggiornato3. Non esiste
2.12) Sul sito esiste una rassegna stampa?1. Sì, ed è consultabile da chiunque2. Sì, ma è necessario iscriversi per poterla visionare2. 3. No, non c’è vai a domanda 2.16
2.13) I temi della rassegna stampa:1. Riguardano strettamente il Csv e il Csvnet2. Riguardano in generale il mondo del volontariato e il Terzo
Settore3. Trattano i temi del sociale con un taglio culturale di ampio
respiro
2.14) Che testate recensisce la rassegna stampa?1. Solo locali2. Locali e nazionali3. Nazionali e internazionali
2.15) La rassegna stampa è aggiornata?1. A oggi2. All’ultima settimana3. Non è aggiornata
2.16) Quali altri servizi di informazione offre il sito?a. Calendario degli eventi delle associazioni
1. Sì2. No
b. Feed Rss1. Sì2. No
c. Calendario dei bandi aperti/in corso1. Sì2. No

150
d. Archivio dei bandi scaduti1. Sì2. No
e. Calendario dei Progetti in corso1. Sì2. No
f. Archivio dei bandi scaduti1. Sì2. No
2.17) Sul sito esiste una sezione dedicata a ricerche e/o pubblicazioni sul/del volontariato?1. Sì, ci sono una o più sezioni del sito mirate, e ricche di ma-
teriali 2. Non ci sono sezioni dedicate, ma in diverse aree del sito ci
sono comunque riferimenti ad iniziative di ricerca ed edito-riali
3. No, in tutto il sito non si trovano riferimenti ad iniziative edi-toriali o di ricerca vai a domanda 2.21
2.18) Da chi sono realizzati in prevalenza questi materiali?1. Dal Csvnet, anche in collaborazione con soggetti esterni2. Dal Csv in questione, anche in collaborazione con soggetti
esterni3. Dalle associazioni, anche in collaborazione con soggetti
esterni4. Da una collaborazione tra Csv e associazioni, anche in col-
laborazione con soggetti esterni5. Da una collaborazione tra Csv e Csvnet, anche in collabora-
zione con soggetti esterni6. Da esterni, su commissione del Csv7. Da soggetti esterni, senza rapporti diretti con il Csv

151
2.19) Questi materiali si possono consultare o scaricare dal sito del Csv?1. Sì, sono interamente scaricabili dal sito2. Il sito fornisce una preview; poi si può richiedere gratuita-
mente il testo alla redazione3. Qualunque servizio di consultazione e/o acquisizione è a
pagamento4. Non ci sono indicazioni per approfondimenti di alcun tipo
per il lettore
2.20) La pubblicazione dell’ultimo di questi materiali risale:1. Agli ultimi due mesi2. All’ultimo anno3. A più di un anno fa
2.21) C’è un luogo del sito in cui si forniscono informazioni per avvicinare nuove persone al volontariato?1. Sì, c’è un testo dettagliato, che addirittura illustra le opportu-
nità del volontariato per categorie diverse di persone (don-ne, anziani, giovani, etc.)
2. Sì, c’è un testo dettagliato, con tutti i recapiti delle sedi più vicine al nuovo possibile volontario
3. Sì, c’è un testo con informazioni generiche per chiunque intenda avvicinarsi al mondo del volontariato
4. No, non è presente alcun segnale di richiamo
2.22) C’è un luogo del sito dedicato al servizio civile?1. Sì, c’è un testo molto dettagliato e accattivante, in cui si
spiegano tutte le opportunità offerte ai giovani da un proget-to presso un’associazione del mondo del volontariato
2. Sì, c’è un testo molto dettagliato e accattivante, in cui si spiegano tutte le opportunità offerte ai giovani da un proget-to di servizio civile presso il Csv
3. Sì, c’è un testo con informazioni generiche sulla possibilità di effettuare il servizio civile nel mondo del volontariato
4. No, non è presente alcun segnale di richiamo

152
2.23) Si trovano sul sito segnalazioni di eventi culturali o recensioni di libri non promossi dal Csv o dalle sue associazioni?1. Sì, si trovano diversi riferimenti ad attività realizzate da altri
soggetti, che denotano un’attenzione del Csv a promuovere in senso ampio la cultura del volontariato e i temi del socia-le
2. Sì, ma sono poche le informazioni su attività promosse da soggetti altri rispetto al Csv o al volontariato
3. No, il mondo del sociale che emerge dal sito è fatto solo di associazioni e volontari
2.24) Sul sito ci sono riferimenti ad altri luoghi/soggetti utili per approfondire la conoscenza del volontariato e del sociale?1. Sì, c’è una pagina/ci sono pagine dedicate ai link ad altre
strutture (associazioni ed enti non profi t, enti pubblici, bi-blioteche, centri di ricerca, etc.), la cui conoscenza è ritenu-ta utili per approfondire i temi in questione
2. Sì, in alcune pagine si trovano riferimenti/link sporadici a soggetti altri rispetto alle associazioni, al Csv, al Csvnet
3. No, il sito non rimanda mai direttamente a soggetti altri ri-spetto alle associazioni, al Csv o al coordinamento
2.25) Sul sito esiste una sezione dedicata alla formazione?1. Sì2. No, non c’è neppure una sezione dedicata
2.26) Quali di queste attività formative vengono presentate sul sito?a. Corsi tradizionali di formazione realizzati dalle associazioni
1. Sì2. No
b. Corsi FAD realizzati dalle associazioni1. Sì

153
2. Noc. Eventi episodici con valenza anche formativa organizzati
dalle associazioni/dal coordinamento (incontri, tavole roton-de, seminari, etc.)1. Sì2. No
d. Corsi ed eventi con valenza anche formativa realizzati da soggetti diversi dal volontariato1. Sì2. No
e. Progetti rivolti al mondo scolastico1. Sì2. No
f. Progetti extrascolastici rivolti ai giovani1. Sì2. No
g. Concorsi per la realizzazione di campagne di comunicazione1. Sì2. No
2.27) Il sito offre informazioni sui bandi utili alle associazioni per progettare la propria attività di formazione?1. Sì, c’è una sezione del sito interamente dedicata ai bandi di
fi nanziamento, ben visibile e ben aggiornata2. Sì, tra le news si trovano anche segnalazioni di bandi3. No, non ci sono informazioni utili in questo senso
2.28) Su che tipo di bandi fornisce informazioni il sito?1. Su molti tipi di bandi, dai comunitari ai ministeriali, fi no ai
bandi regionali e locali2. Solo sui bandi nazionali3. Solo sui bandi locali
2.29) A chi sono rivolte le attività formative presentate sul sito?1. Esclusivamente ai volontari delle associazioni della rete

154
2. Ai volontari in senso ampio: iscritti e non alle associazioni del coordinamento
3. A chiunque sia interessato ai temi proposti
2.30) Sul sito è disponibile un archivio delle attività di formazione?1. Sì, ed organizzato in corsi attivi e edizioni ormai concluse2. Sì, ma non si distinguono immediatamente i corsi attivi da
quelli già conclusi3. No, non è disponibile
2.31) Le attività formative presentate sul sito offrono la possibilità di ottenere attestati/certificazioni?1. Sì, sempre2. Sì, qualche volta3. No/Non ci sono informazioni a riguardo
2.32) Il sito fornisce informazioni/servizi utili alle associazioni per organizzare attività di fund raising?1. Sì, c’è addirittura una sezione dedicata al fund raising per le
associazioni2. Sì: anche se non c’è una sezione apposita, in vari luoghi si
forniscono informazioni su materiali e iniziative al riguardo3. No, non si parla quasi mai di questo tema
2.33) Il sito presenta informazioni sul 5 per mille?1. Sì, c’è un richiamo a queste attività ben visibile in prima pagina2. Sì, c’è un richiamo al 5 per mille all’interno del sito3. No, non ci sono informazioni in proposito
2.34) È possibile effettuare donazioni al Csv o alle associazioni direttamente tramite il sito?1. Sì, e la procedura è chiara e agevole2. Il servizio ci sarebbe, ma il funzionamento non è immediato3. No, non si possono effettuare donazioni online

155
2.35) Sul sito sono presenti informazioni o servizi sul bilancio sociale?1. Sì, c’è addirittura una sezione dedicata al tema2. Sì: anche se non c’è una sezione apposita, in vari luoghi si
informa su materiali, corsi e iniziative al riguardo3. No, non si parla mai di questo tema
2.36) Sul sito è pubblicato il bilancio sociale del Csv?1. Sì2. No
Aggiungere eventuali segnalazioni
Sezione 3.La rete di Csvnet
Il sito è uno strumento di networking?Si valuta se e attraverso quali strumenti della comunicazione online il Csv promuove: la cultura di rete, la rete di Csvnet, la collaborazione con soggetti diversi del territorio.L’identità visiva del sito è coordinata con quella di Csvnet?Quanto e cosa degli input e della comunicazione erogata da Csvnet fi ltra nella comunicazione online dei Csv?Esistono attività/servizi di networking tra i Csv?Il sito promuove la creazione e il consolidamento di reti tra le associa-zioni del proprio territorio?Il sito promuove la creazione di sinergie e collaborazioni con altri enti del territorio?
3.1) Nella home del sito c’è un link/rimando diretto a quello di Csvnet?1. Sì, c’è un link al sito di Csvnet2. Sì, c’è il logo di Csvnet3. No, non ci sono né logo né link

156
3.2) L’immagine del sito è coordinata in qualche modo con quella di Csvnet, a parte il logo?1. Sì, il layout del sito è evidentemente coordinato con quello
di Csvnet2. Sì, sulla home del sito ci sono dei richiami ai colori di Csvnet
(giallo e verde)/al logo di Csvnet/al layout di Csvnet3. No, nella home non c’è alcun riferimento visivo alla rete del
coordinamento e il sito sembra completamente autonomo
3.3) Il sito del Csv fornisce delle informazioni su Csvnet?1. Sì, e il richiamo a questo testo è ben visibile in prima pagina2. Sì, ma i testi su Csvnet sono all’interno del sito, non facil-
mente visibili3. No, non c’è alcuna informazione/L’unica informazione è il
link al sito di Csvnet
3.4) Le notizie fornite dal Csvnet si distinguono dalle altre?1. Sì, esse sono raccolte in una sezione a parte/evidenziate in
maniera effi cace2. Si può sempre leggere la fonte all’interno di una news, sia
che si tratti di Csvnet che di altre fonti3. No, non c’è alcuna possibilità di distinguere l’origine di
un’informazione
3.5) Esiste una parte del sito riservata a utenti con username e password?1. Sì, può accedere solo personale qualifi cato delle associa-
zioni2. Sì, può accedere chiunque si qualifi chi3. Non c’è nessuna parte riservata
3.6) Nella home del sito c’è almeno un riferimento a:a. Un altro Csv
1. Sì2. No

157
b. Un ente pubblico1. Sì2. No
c. Un personaggio politico del territorio1. Sì2. No
d. Un’impresa1. Sì2. No
3.7) Nei titoli delle ultime 5 news c’è almeno un riferimento a:a. Un altro Csv
1. Sì2. No
b. Un ente pubblico1. Sì2. No
c. Un personaggio politico del territorio1. Sì2. No
d. Un’impresa1. Sì2. No
3.8) Nel testo delle ultime 5 news c’è almeno un riferimento a:a. Un altro Csv
1. Sì2. No
b. Un ente pubblico1. Sì2. No
c. Un personaggio politico del territorio1. Sì2. No
d. Un’impresa

158
1. Sì2. No
3.9) A vostro parere, che percezione del coordinamento può avere un utente qualsiasi che navighi sul sito?1. Nessuna2. Potrà percepire l’esistenza del Csvnet solo se capiterà in
alcune pagine specifi che del sito3. È facile che se ne renda conto navigando solo in qualche
pagina4. È impossibile che non percepisca il rapporto con il Csvnet!
Solo per il sito del Csvnet
3.10) Il sito del Csvnet fornisce informazioni sui singoli Csv?1. Sì, li nomina e fornisce i link di ciascuno2. Sì, li nomina ma non fornisce alcun link3. No, non li nomina nemmeno
3.11) Nel sito del Csvnet esiste un forum o un altro spazio di discussione riservato ai Csv?1. Sì2. No
3.12) Sul sito del Csvnet sono fornite indicazioni relative alle modalità di realizzazione dei siti dei Csv?1. Sì, e anche dettagliate2. Sì, ma sono molto generiche3. No, non ce ne sono
Aggiungere eventuali segnalazioni

159
Sezione 4.Social network e interattività
Il sito del Csv interagisce con i nuovi strumenti della comunicazione online?
Si valuta la possibilità per i navigatori del sito di interagire con il Csv attraverso l’utilizzo di strumenti web personalizzati.Il sito del Csv rimanda a dei social network? Per quali attività?La comunicazione del sito e quella dei social network sono coordina-te?Quali altre forme di interattività si promuovono?
4.1) Sul sito ci sono dei contenuti commentabili dai navigatori?1. Sì, e sono attivi2. Ci sarebbero, ma non ci sono commenti3. No, non ci sono
4.2) Attraverso quali strumenti della comunicazione online il navigatore può interagire con il Csv?a. Newsletter
1. Sì2. No
b. E-mail1. Sì2. No
c. Sistemi di instant messaging1. Sì2. No
d. Social network1. Sì2. No
e. Sondaggi1. Sì2. No

160
f. Post1. Sì2. No
4.3) Il sito del Csv rimanda ad un profilo sui social network?a. Facebook
1. Sì2. No
b. Twitter1. Sì2. No
c. Linkedin1. Sì2. No
d. Flickr1. Sì2. No
e. Myspace1. Sì2. No
f. Altro (specifi care)1. Sì2. No
4.4) La comunicazione del sito e quella dei social network sono coordinate?1. Sì, per tutti i social network2. Solo quella di alcuni social network3. No
4.5) C’è un forum?1. Sì, aggiornato ad oggi2. Sì, aggiornato a ieri3. Sì, aggiornato ad una settimana fa4. Sì, aggiornato a più di una settimana5. No, non c’è

161
4.6) Qual è il livello di utilizzo del forum?Argomenti:1. 0-22. 3-53. Più di 5
4.7) Quali sono gli argomenti trattati sul forum?(è possibile più di una risposta)1. In prevalenza, argomenti che riguardano la vita organizzati-
va delle associazioni2. In prevalenza, argomenti che riguardano il rapporto tra le
associazioni ed il Csv3. In generale, tematiche relative al mondo del volontariato e
del sociale4. Problemi concreti per i quali si cerca aiuto5. Altro
4.8) Esiste un blog del Csv?1. Sì2. No
4.9) Chi scrive sul blog:1. Associazioni2. Volontari3. Esperti4. Navigatori generici
4.10) Quali sono gli argomenti trattati sul blog1. Argomenti che riguardano la vita organizzativa delle asso-
ciazioni2. Argomenti che riguardano il rapporto tra le associazioni ed
il Csv3. Tematiche relative al mondo del volontariato in generale4. Problemi concreti per i quali si cerca aiuto5. Altro

162
4.11) A quando risale l’ultimo post del blog?1. Ad una settimana2. Ad un mese3. A più di un mese
4.12) Sono presenti sondaggi? 1. Sì,2. No
Aggiungere eventuali segnalazioni

163
2. Il questionario per la websurvey
Il questionario pubblicato in questa appendice è stato sottoposto agli addetti alla comunicazione di 71 Centri di Servizio per il Volontaria-to aderenti al Coordinamento nazionale. Hanno risposto in 61. Sia la somministrazione che la compilazione erano gestite attraverso un’ap-posita piattaforma online.
Profi lo del Csv di appartenenza1) Il suo Csv è1:
1. Provinciale2. Interprovinciale3. Regionale
2) Il suo Csv si trova:1. Nel Nord Est (Emilia-Romagna, Friuli, Trentino Alto Adige,
Veneto)2. Nel Nord Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Ao-
sta)3. Nel Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria)4. Nel Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia)5. Nelle isole (Sardegna, Sicilia)
Specifi care qual è il Csv di appartenenza
L’intervistato3) Età
4) Genere
5) Che titolo di studio ha conseguito?
1 Laddove non sia diversamente specifi cato, l’intervistato può selezionare una sola risposta per ciascuna domanda.

164
1. Diploma scuola media2. Diploma scuola superiore3. Laurea triennale (da specifi care)4. Laurea specialistica o quinquennale (da specifi care)5. Dottorato/altri titoli post lauream6. Nessuno
6) Specifi care la laurea conseguita
7) Qual è l’area prevalente del suo percorso universitario?Rispondi solo se le seguenti condizioni sono rispettate:È stato risposto ‘Dottorato/altri titoli post lauream’ o ‘Laurea speciali-stica o quinquennale (da specifi care)’ o ‘Laurea triennale (da specifi -care)’ alla domanda “Che titolo di studio ha conseguito?”
1. Comunicazione2. Scienze politiche, Sociologia, Servizio sociale3. Giurisprudenza, Economia4. Psicologia5. Lettere, Lingue, Storia, Filosofi a, Dams6. Informatica7. Matematica, Fisica, Scienze naturali8. Ingegneria9. Medicina, Scienze infermieristiche10. Architettura, Design11. Altro
8) Che ruolo ricopre all’interno della struttura?1. Responsabile/Referente della comunicazione2. Collaboratore uffi cio comunicazione3. Responsabile uffi cio stampa4. Collaboratore uffi cio stampa5. Addetto alla segreteria6. Web master7. Altro

165
9) Da quanto tempo lei lavora per la struttura (indipendente-mente dal ruolo ricoperto)?1. Da meno di un anno2. Da 1 a 2 anni3. Da 2 a 5 anni4. Da più di 5 anni
10) Qual è attualmente la sua posizione all’interno della strut-tura?1. Dipendente Csv2. Collaboratore a progetto3. Collaboratore occasionale4. Operatore del Servizio Civile5. Volontario6. Consulente esterno7. Stagista
11) Ha mai seguito corsi di formazione in comunicazione?1. Sì2. No
12) Di che tipo?Rispondi solo se le seguenti condizioni sono rispettate:È stato risposto ‘Sì’ alla domanda “Ha mai seguito corsi di formazione in comunicazione?”
1. Master universitario2. Corso di formazione organizzato dal Csv3. Corso di formazione organizzato da altro soggetto
13) Prima di collaborare con il Csv, ha mai lavorato nel settore della comunicazione?1. Sì2. No

166
14) Sarebbe interessato seguire un corso di formazione nell’ambito della comunicazione?1. Sì2. No
15) In particolare, in quali ambiti della comunicazione le sareb-be più utile acquisire/perfezionare competenze?
Rispondi solo se le seguenti condizioni sono rispettate:È stato risposto ‘Sì’ alla domanda “Sarebbe interessato seguire un corso di formazione nell’ambito della comunicazione?”
1. Scrittura e redazione testi2. Organizzazione e gestione di uffi cio stampa3. Progettazione di campagne o altre iniziative di comunica-
zione sociale4. Organizzazione eventi5. Fund raising e Public Relations6. Web e social network7. Informatica8. Comunicazione interna e organizzativa
16) Potrebbe indicarci le ragioni del suo disinteresse?Rispondi solo se le seguenti condizioni sono rispettate:È stato risposto ‘No’ alla domanda “Sarebbe interessato seguire un corso di formazione nell’ambito della comunicazione?”
1. Credo di possedere tutte le competenze che mi servono per il mio lavoro
2. Mi piacerebbe ma non ho tempo3. Ritengo che nella mia struttura ci siano problemi ben più
urgenti della comunicazione4. La comunicazione non mi interessa5. Altro
L’ufficio comunicazione del suo Csv17) Nel suo Csv c’è un uffi cio deputato specifi camente alla co-
municazione?

167
1. Sì2. No
18) Con quale denominazione è indicato?Rispondi solo se le seguenti condizioni sono rispettate:È stato risposto ‘Sì’ alla domanda “Nel suo Csv c’è un uffi cio deputato specifi camente alla comunicazione?”
19) Quanti dipendenti o collaboratori stabili (con altri contratti professionali) fanno parte di questo uffi cio?
Rispondi solo se le seguenti condizioni sono rispettate:È stato risposto ‘Sì’ alla domanda “Nel suo Csv c’è un uffi cio deputato specifi camente alla comunicazione?”
20) Quante persone non dipendenti (volontari/operatori del servizio civile/stagisti, etc.) collaborano al momento con questo uffi cio?
Rispondi solo se le seguenti condizioni sono rispettate:È stato risposto ‘Sì’ alla domanda “Nel suo Csv c’è un uffi cio deputato specifi camente alla comunicazione?”
21) Quali attività svolge quest’uffi cio?Rispondi solo se le seguenti condizioni sono rispettate:È stato risposto ‘Sì’ alla domanda “Nel suo Csv c’è un uffi cio deputato specifi camente alla comunicazione?”Scegli tutte le corrispondenti:
1. Redazione testi (comunicati stampa, newsletter, notizie, ma-teriale informativo, etc.)
2. Uffi cio stampa e relazioni con i media3. Relazioni pubbliche4. Organizzazione di eventi5. Progettazione e/o coordinamento campagne di comunica-
zione6. Comunicazione interna7. Fund raising

168
8. Gestione sito web9. Gestione social network
22) Generalmente chi svolge le attività di comunicazione?Rispondi solo se le seguenti condizioni sono rispettate:È stato risposto ‘No’ alla domanda “Nel suo Csv c’è un uffi cio deputa-to specifi camente alla comunicazione?”
1. Se ne occupano regolarmente uno o più dipendenti di un altro uffi cio
2. Se ne occupano saltuariamente dipendenti di più uffi ci in base alle esigenze del momento
3. Se ne occupa uno stagista4. Se ne occupano regolarmente uno o più collaboratori ester-
ni5. Se ne occupano saltuariamente uno o più collaboratori
esterni6. Altro
23) Quali sono le attività prevalenti svolte da queste persone?Rispondi solo se le seguenti condizioni sono rispettate:È stato risposto ‘No’ alla domanda “Nel suo Csv c’è un uffi cio deputa-to specifi camente alla comunicazione?”Scegli tutte le corrispondenti:
1. Redazione testi (comunicati stampa, newsletter, notizie, ma-teriale informativo, etc.)
2. Uffi cio stampa e relazioni con i media3. Relazioni pubbliche4. Organizzazione di eventi5. Progettazione e/o coordinamento campagne di comunica-
zione6. Comunicazione interna7. Fund raising8. Gestione sito web9. Gestione social network

169
24) A suo avviso, all’interno del suo Csv, l’attività di comunica-zione è percepita come:1. Molto importante, perché le si dedicano ingenti risorse2. Abbastanza importante, anche se non le si dedicano molte
risorse3. Poco importante: infatti non è mai considerata una priorità,
si lavora sempre sull’emergenza e le sono dedicate scarse risorse
4. Un’attività del tutto marginale/Poco importante, non le si de-dicano risorse
25) A suo avviso, quali sono i principali ostacoli all’attività di comunicazione all’interno del suo Csv?
Scegli tutte le corrispondenti:1. Scarsa importanza attribuitale dai vertici del Csv2. Diffi coltà di coordinamento interno (assenza di una sinergia
con le altre attività operative del Csv)3. Scarsità di competenze mirate4. Scarsità di investimenti economici5. Mancanza di strumentazione6. Scarsità di personale7. Nessuno
26) Secondo lei, la comunicazione ideale di un Csv dovrebbe occuparsi innanzitutto di:1. Pubblicizzare presso le proprie associazioni quanti e quali
servizi il Csv offre loro2. Accrescere la visibilità del Csv, per raggiungere nuovi inter-
locutori istituzionali e politici3. Promuovere la cultura del volontariato e il dibattito sui temi
sociali4. Reclutare nuovi volontari per le associazioni
27) Di fatto, lei trascorre la maggior parte del suo tempo a lavo-rare per:

170
1. Pubblicizzare presso le proprie associazioni quanti e quali servizi il Csv offre loro
2. Accrescere la visibilità del Csv, per raggiungere nuovi inter-locutori istituzionali e politici
3. Promuovere la cultura del volontariato e il dibattito sui temi sociali
4. Reclutare nuovi volontari per le associazioni
28) Quali di questi strumenti sono più utilizzati nell’attività di comunicazione del suo Csv?
Scegli tutte le corrispondenti:1. Telefono2. Fax3. Mail4. Circolari5. Periodici6. Newsletter7. Sito8. Social network9. Altro
29) A suo avviso, quali sono gli strumenti più effi caci per le attività di comunicazione esterna del suo Csv?
Scegli tutte le corrispondenti:1. Telefono2. Fax3. Mail4. Periodici5. Newsletter6. Sito7. Social network
30) Quando è stato attivato il sito del suo Csv?1. Non posso dirlo con esattezza, esisteva già prima che arri-
vassi

171
2. Meno di un anno fa3. 1-3 anni fa4. 3-5 anni fa5. 5-10 anni fa
31) Potrebbe indicare chi si occupa generalmente dell’idea-zione e della progettazione di prodotti di comunicazione e campagne sociali?1. Se ne occupa direttamente la mia struttura2. Se ne occupano le associazioni della nostra rete3. Cerchiamo un consulente/un’agenzia sulla base della bud-
get disponibile4. Cia affi diamo a un consulente/un’agenzia con cui lavoriamo
spesso5. Ci rivolgiamo quasi esclusivamente a esperti/agenzie spe-
cializzati in comunicazione per il non profi t
32) A suo avviso, quanta importanza attribuisce la sua struttu-ra all’uso dei social network?1. Molta: ci stiamo organizzando per implementarne l’uso2. Abbastanza: sappiamo che sarebbe utile dedicarvi mag-
giori risorse, ma ci richiede un impegno in termini di tempo e risorse umane che non possiamo permetterci
3. Poca: è una funzione secondaria rispetto a tutte le altre atti-vità di comunicazione
4. Nessuna importanza
33) Nel vostro uffi cio si fa una pianifi cazione strategica della comunicazione?1. Sì2. No
34) La scansione temporale di questa pianifi cazione è legata:Rispondi solo se le seguenti condizioni sono rispettate:È stato risposto ‘Sì’ alla domanda “Nel vostro uffi cio si fa una pianifi -cazione strategica della comunicazione?”

172
1. Ad obiettivi di breve termine2. Ad obiettivi di medio termine3. Ad obiettivi di lungo termine
35) Avete un archivio delle vostre attività?1. Sì ed è aggiornato2. Sì, ma non è aggiornato3. No, ma ne è prevista la creazione4. No, e non ne è prevista la creazione
La rete del suo Csv36) Come defi nirebbe i rapporti tra il suo Csv e il Csvnet?
1. Ottimi: tra il nostro Csv e il Csvnet i rapporti sono molto stret-ti...in pratica siamo la stessa cosa
2. Buoni: collaboriamo su diverse attività3. Abbastanza buoni: collaboriamo per certe attività, ma sicu-
ramente si potrebbe fare di più4. Scarsi: interagiamo ogni tanto5. Non ci sono rapporti, solo comunicazioni formali
37) Come defi nirebbe i rapporti tra il Csvnet e gli altri Csv?1. Ottimi: la rete non potrebbe funzionare meglio2. Buoni: ci sono collaborazione e partecipazione reciproca3. Abbastanza buoni, ma potrebbero essere decisamente mi-
gliori4. Scarsi/Molto problematici5. Inesistenti/Solo formali
38) Quanto utilizzate i materiali (info, rassegne stampa, etc.) che vi invia il Csvnet?1. Molto2. Abbastanza3. Poco4. Per niente

173
39) Tra i materiali che ricevete dal Csvnet quali sono quelli che più spesso vi capita di utilizzare?
Scegli tutte le corrispondenti:1. News sul mondo del volontariato2. News e informazioni sul mondo del sociale3. Rassegna stampa4. Comunicati stampa di Csvnet5. Pubblicazioni del Csvnet o di altri Csv6. Bandi o altre informazioni utili alla progettazione7. Informazioni tecniche sul e per il volontariato segnalate e
predisposte con il servizio Infocontinua di Csvnet8. Altro:
40) In che modo utilizzate questi materiali?Scegli tutte le corrispondenti:
1. Pubblichiamo sul sito tutte le informazioni che il CsvNet ci invia e le utilizziamo per le nostre newsletter
2. Pubblichiamo sul sito solo alcune delle informazioni che il Csvnet ci invia, selezionando quelle che ci interessano maggiormente
3. Utilizziamo i materiali di Csvnet per elaborare materiali e/o comunicazioni per il volontariato del nostro territorio, citan-do la fonte
4. Non pubblichiamo nessuna delle informazione che ricevia-mo dal CsvNet, ma le diffondiamo all’interno dell’organizza-zione
41) Secondo lei, gli altri operatori che lavorano nel suo Csv leggono le notizie che pubblicate sul sito?1. Spesso2. A volte3. Mai
42) Le circolari che vi invia il Csvnet:1. Sono uno strumento decisamente utile, ormai indispensabi-

174
le al nostro lavoro2. Sono uno strumento di comunicazione abbastanza utile, ma
non riusciamo a pubblicarle tutte3. Sono uno strumento utile anche se dovrebbero essere cura-
te/organizzate diversamente nei contenuti4. Sono uno strumento inutile e poco effi cace
Il suo Csv sul territorio43) Come defi nirebbe il rapporto fra il suo Csv e le associazio-
ni del territorio?1. Ottimo: percepiamo una crescita di attenzione e fi ducia da
parte delle associazioni nei nostri confronti2. Buono: le associazioni accedono regolarmente ai nostri ser-
vizi3. Suffi ciente: le associazioni ci conoscono, ma ci consultano
soltanto per poche attività4. Scarso: molte associazioni non ci conoscono o preferiscono
operare in maniera autonoma
44) Come defi nirebbe la visibilità del suo Csv sul territorio?1. Ottima: si rivolgono a noi direttamente anche cittadini ed
esperti, senza la mediazione delle associazioni2. Buona: siamo abbastanza conosciuti anche presso la citta-
dinanza3. Discreta: al di fuori dei contatti con le associazioni, non ab-
biamo alcun riscontro da parte dei cittadini4. Insuffi ciente: abbiamo problemi di riconoscimento e rela-
zione con le associazioni, e nessun riscontro dal resto del territorio
45) Come defi nirebbe la visibilità del suo Csv sui media locali?1. Ottima2. Discreta3. Buona4. Mediocre

175
46) Quali sono gli strumenti che più garantiscono la visibilità della sua associazione sul territorio?
Selezionare da 1 a 3 risposte:1. Gli sportelli operativi territoriali a disposizione delle organiz-
zazioni e dei cittadini2. L’invio regolare di materiale informativo sulle attività del Csv
ad enti pubblici, soggetti non profi t o privati3. Iniziative varie di sensibilizzazione sul non profi t promosse a
livello territoriale (campagne, incontri, pubblicazioni)4. La presenza costante sui mass media5. I tavoli di concertazione con le organizzazioni di volontaria-
to e gli enti pubblici6. La presenza continua dell’associazione in azioni di sensibi-
lizzazione e di denuncia su tematiche di disagio del territo-rio
7. Altro:
47) Qual è la principale diffi coltà che incontra la sua organizza-zione nel lavoro di uffi cio stampa?1. I giornalisti e i media locali sono scarsamente interessati al
volontariato e alle nostre attività2. I giornalisti e i media locali hanno diffi coltà a comprendere
il nostro mondo3. Noi dovremmo dedicare più tempo e/o risorse al lavoro di
uffi cio stampa4. Non ci sono grandi diffi coltà, il rapporto è soddisfacente
48) Lei come giudica i rapporti del suo Csv con le istituzioni e gli enti pubblici?1. Ottimi: partecipiamo periodicamente a tavoli di concertazione2. Buoni: anche se non ci sono tavoli di concertazione, esiste
uno scambio continuo di informazioni3. Mediocri: interagiamo saltuariamente4. Inesistenti
49) Secondo lei, perché i rapporti del suo Csv con le istituzioni

176
e gli enti pubblici sono saltuari/inesistenti?Rispondi solo se le seguenti condizioni sono rispettate:È stato risposto ‘Mediocri: interagiamo saltuariamente’ o ‘Inesistenti’ alla domanda “Lei come giudica i rapporti del suo Csv con le istitu-zioni e gli enti pubblici?”
1. Gli enti pubblici mostrano poco interesse verso le attività del Csv
2. Nonostante l’interesse manca un reale sostegno alle attività del Csv
3. Le risorse messe a disposizione dagli enti pubblici non ri-sultano adeguate al lavoro del Csv
4. Altro
50) Relativamente alle attività di comunicazione, avete rapporti di collaborazione con qualche Università?1. Sì, abbiamo molti contatti e ci capita spesso di lavorare in-
sieme2. Sì, ma saltuari3. No, anche se ci piacerebbe. Il problema è che l’Università è
un mondo diffi cile da raggiungere4. No, non ci abbiamo mai pensato5. No, non ci interessa
51) Nelle vostre attività di promozione del volontariato sul ter-ritorio cercate mai il sostegno di sponsor e imprese priva-te?1. Sì, noi lo facciamo sempre e incitiamo anche le nostre asso-
ciazioni a farlo2. Ci proviamo spesso, anche se è molto diffi cile ottenere at-
tenzione e aiuto dai privati3. Ci piacerebbe, ma è un’attività che richiede tempo e risorse
che non abbiamo4. No, non ci abbiamo mai pensato/No, non ci interessa

177
3. I testimoni privilegiati e la traccia di intervista
In questa appendice sono elencati i 12 testimoni privilegiati seleziona-ti e intervistati per approfondire alcuni aspetti della vita comunicativa dei centri di servizio emersi durante le prime due fasi precedenti della ricerca, e la traccia che ha fatto da canovaccio ai colloqui telefonici.
I referenti intervistatiGianluca CAPORASO, area comunicazione, Centro di Servizio per il Volontariato Basilicata.Chiara CASTRI, uffi cio stampa, Cesv - Centro di Servizio per il Volon-tariato Lazio.Monica CERIONI, area comunicazione, Centro di Servizio per il Vo-lontariato Marche.Michela DE FALCO, area comunicazione, Centro di Servizio per il Vo-lontariato della provincia di Bologna.Marilena DE NIGRIS, area comunicazione, Centro di Servizio per il Volontariato San Nicola (Bari).Cristina GALASSO, area comunicazione, Centro di Servizio per il Vo-lontariato Toscana.Natahalie GRANGE, area comunicazione, Centro di Servizio per il Vo-lontariato Valle d’Aosta.Piergiorgio GRECO, area comunicazione, Centro di Servizio per il Vo-lontariato della provincia di Pescara.Marta MORONI, area comunicazione, Centro di Servizio per il Volon-tariato della provincia di Milano.Marco OLIVIERI, area comunicazione, Centro di Servizio per il Volon-tariato di Messina.Irene TROIA, area comunicazione, Spes - Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio.Viviana VELTRE, uffi cio stampa, Centro di Servizio per il Volontariato di Monza e Brianza.

178
La traccia di intervista
1) La percezione della comunicazione. In riferimento al coordina-mento tra i singoli Centri di Servizio per il Volontariato e il Csvnet, quali potrebbero essere a suo avviso gli ambiti da migliorare a livello di co-municazione? E facendo riferimento alla sua percezione personale, cosa signifi ca per lei far parte di un coordinamento?
2) Attività degli Uffi ci. Può descriverci una sua giornata lavorativa tipo?
3) L’identità del Csv. Dal nostro monitoraggio, risulta che nei siti del Coordinamento siano spesso carenti le sezioni relative alla storia dei Centri di Servizio per il Volontariato: secondo lei a cosa è dovuta que-sta carenza?
4) Interattività e social network. Secondo i dati emersi dalla nostra survey, molti operatori considerano i social network strumenti impor-tanti o comunque meritevoli di maggiori risorse; ma, a fronte di queste dichiarazioni, dall’analisi dei siti non emerge una presenza strutturata dei Csv sui principali social network. Perché secondo lei i social net-work vengono gestiti in maniera così informale?
5) La rete dei Csv. Può raccontarci un’esperienza profi cua tra il suo Centro di Servizio per il Volontariato e un altro Csv del Coordinamento?
6) Le risorse per la comunicazione. L’83,5% dei Centri di Servizio per il Volontariato ha un uffi cio deputato alla comunicazione, e il livello professionale degli operatori è elevato. Nonostante ciò, il 63,9% degli addetti alla comunicazione che hanno riposto al questionario pensa che alla comunicazione, pur essendo un elemento importante, non vengano attribuite molte risorse. Secondo lei a cosa è dovuto questo scollamento tra i numeri e le percezioni relative alla pratica quotidiana?
7) Il rapporto con i media locali. Quali sono le diffi coltà maggiori che lei riscontra nei rapporti con i media locali?

179
8) La promozione della cultura del volontariato. La promozione della cultura del volontariato viene considerata un’attività prevalente, sia nelle intenzioni che nella pratica quotidiana, ma dal monitoraggio dei siti risulta uno scarso investimento nei servizi online che potreb-bero fare da richiamo ai valori della solidarietà. Secondo lei a cosa è da imputarsi questo gap? Ha qualche suggerimento su interventi che potrebbero aiutare a risolverlo?
9) Comunicazione interna. Nel suo centro di servizio sono previste strategie di comunicazione interna e attività specifi che saltuarie o abi-tuali per mantenerla?
10) I saperi dei Centri di Servizio per il Volontariato. Il suo Csv è utilizzato, che lei sappia, come una fonte da ricercatori, studiosi e giornalisti? Se sì, ha la sensazione che il Csv si renda conto di essere una fonte potenziale per tali referenti specializzati, e/o si stia attrez-zando per diventarlo?
11) Le attività prevalenti svolte dall’uffi cio comunicazione. Stan-do alle nostre statistiche, soltanto in 4 Csv l’uffi cio comunicazione si occupa del fund raising. Secondo lei, negli altri casi chi cura queste attività e come vengono gestite?
12) La comunicazione esterna. Quali sono gli strumenti specifi ci che il Centro di Servizio per il Volontariato utilizza per garantire la comunicazione esterna (comunicati stampa - conferenze stampa - newsletter - organizzazione eventi)?
13) Le strategie di comunicazione. Come vengono organizzate le strategie di comunicazione nella sua struttura? Ci può descrivere come il suo Csv ha gestito la comunicazione di un vostro servizio/evento?
14) Il rapporto con i cittadini. Ritiene che il Centro di Servizio per il Volontariato sia abbastanza conosciuto dai cittadini? Può dirci su cosa basa questa impressione?




183
Gli autori
Gaia PERUZZI è docente di Comunicazione dei diritti e della cittadi-nanza attiva e di Uffi ci relazione con il pubblico e uffi ci stampa presso il corso di laurea specialistica in Comunicazione e pubblicità per pub-bliche amministrazioni e non profi t della facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della Sapienza, Università di Roma. Sui temi pertinenti alla ricerca di recente ha scritto: Fondamenti di co-municazione sociale. Diritti, media, solidarietà (Carocci, in corso di stampa).
Manuela BARTOLOTTA è dottoranda in Scienze della Comunicazio-ne della Scuola di Dottorato Mediatrends della Sapienza, Universi-tà di Roma. Sui temi della comunicazione sociale ha collaborato ai seguenti progetti di ricerca: Mediaemergenza terremoto e Identità e comunicazione nelle Pubbliche Assistenze (entrambi della ex-Facoltà di Scienze della Comunicazione della Sapienza).
Lorenzo BOSCATO è laureato in Editoria multimediale e nuove pro-fessioni dell’informazione presso la Facoltà di Scienze della Comuni-cazione della Sapienza, Università di Roma. Ha lavorato come capo-redattore web per il settimanale Romac’è, ha svolto attività di uffi cio stampa per diverse associazioni di volontariato romane e attualmente collabora all’organizzazione di eventi artistici con il laboratorio Mana cultura.
Stefania CARULLI è dottoranda in Scienze della Comunicazione della Scuola di Dottorato Mediatrends della Sapienza, Università di Roma. Presso il medesimo ateneo è coordinatrice organizzativa del Master in Comunicazione Pubblica e Istituzionale Publi.Com. Dal 2008 collabora con la cooperativa Qubica sui temi della valutazione e della progettazione sociale.
Alessia CICCOTTI è laureanda in Editoria multimediale e nuove pro-fessioni dell’informazione, presso la Facoltà di Scienze della Comuni-

184
cazione della Sapienza, Università di Roma. È giornalista pubblicista, iscritta presso l’Ordine regionale del Lazio; scrive per il quotidiano online Abitare a Roma e per Strafoglio, il mensile online dell’associa-zione Pair. Attualmente collabora come stagista presso l’uffi cio stam-pa di Csvnet.
Sandra FRATTICCI è laureata in Professioni dell’informazione e uf-fi ci stampa presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione della Sapienza, Università di Roma. Attualmente svolge attività di supporto web presso il Data Center della Croce Rossa Italiana e collabora con il settimanale on-line Più Culture.
Maria Ida MARONI è laureata in Editoria, comunicazione multimedia-le e giornalismo presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione della Sapienza, Università di Roma. Attualmente lavora presso l’uffi -cio stampa Public Affairs di Sky Italia. È giornalista pubblicista, iscrit-ta all’Ordine regionale dei giornalisti delle Marche.
Laura VIVIANI è laureata in Editoria multimediale e nuove professioni dell’informazione presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione della Sapienza, Università di Roma, con una tesi sul giornalismo so-ciale. Collabora con il sito di eventi LesFlaneurs.it e con la testata online ilcambiamento.it. Attualmente svolge uno stage presso l’uffi cio stampa di Wind Telecomunicazioni Spa.



187
Indice
Prefazionedi Carlo Sorrentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 5
Premessadi Marco Granelli, Stefano Tabò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10
Parte prima.LA COMUNICAZIONE AL CENTRO
Capitolo 1Una ricerca sui Centri di Servizio per il Volontariato aderenti a Csvnetdi Gaia Peruzzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15 1. La comunicazione al centro . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15 1.1. La comunicazione indagata come tema centrale 15 1.2. La comunicazione realizzata dai Centri di Servizio per il Volontariato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 17 1.3. La comunicazione osservata dal centro di una rete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 19 2. Il disegno della ricerca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 21 2.1. Il monitoraggio dei siti . . . . . . . . . . . . . . . . . » 22 2.2 La websurvey sugli uffici e le risorse di comunicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 23 2.3. Le interviste ai testimoni privilegiati . . . . . . » 24 2.4. Il valore aggiunto della ricerca: gli strumenti per l’auto-valutazione . . . . . . . . . . . . . . . . . » 24
Parte seconda.IL VOLONTARIATO SUL WEB
Capitolo 2I Centri di Servizio per il Volontariato (si) raccontanodi Gaia Peruzzi e Sandra Fratticci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 29

188
1. I siti del Coordinamento alla prova dei requisiti minimi di qualità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 29 2. Vetrine istituzionali: i Centri di Servizio per il Volontariato online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 35
Capitolo 3I servizi online del volontariatodi Stefania Carulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 41 1. La cultura del servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 41 2. I servizi di informazione: il cuore della comunicazione in Rete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 43 3. L’attenzione alla formazione: dal sapere al saper fare servizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 47 4. Bilanci pubblici: le nuove tecnologie a servizio della trasparenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 51 5. La promozione a servizio della cultura del volontariato 54
Capitolo 4Le reti del volontariato. Fra i Centri, con il Coordinamento,sul territoriodi Alessia Ciccotti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 59 1. I Centri di Servizio per il Volontariato e la cultura di rete: le opportunità offerte dal web . . . . . . . . . » 59 2. La rete tra i Centri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 61 3. Il Coordinamento in Rete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 65 4. Le reti con il territorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 68
Capitolo 5Coordinamento 2.0. Primi approdi dei Centri di Servizio per il Volontariato sui social media di Manuela Bartolotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 75 1. I Centri tra partecipazione, condivisione e personalizzazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 75 2. La percezione dei social media: vincoli e opportunità 83

189
Parte terza.LA COMUNICAZIONE RACCONTATA
DAI COMUNICATORICapitolo 6Gli uffici di comunicazione dei Centri di Servizio per il Volontariatodi Lorenzo Boscato e Sandra Fratticci . . . . . . . . . . . . . . . p. 93 1. Le strutture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 93 2. Professionisti della comunicazione . . . . . . . . . . . » 97
Capitolo 7Le strategie e le attività di comunicazione dei Centri di Servizio per il Volontariatodi Maria Ida Maroni e Laura Viviani . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 105 1. La comunicazione interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 105 2. La comunicazione esterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 107 3. Un problema quotidiano: il gap irrisolto tra l’importanza e il costo della comunicazione. . . . . . . . . . . . . . . » 110 4. I Centri di Servizio per il Volontariato pensano al futuro? Le strategie di comunicazione . . . . . . . . . . . . . . . » 115
Conclusionidi Gaia Peruzzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 119
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 125
Appendice 1. Il questionario per la valutazione dei siti . . . . . . . » 137 2. Il questionario per la websurvey . . . . . . . . . . . . . » 162 3. I testimoni privilegiati e la traccia d’intervista . . . » 176
Gli autori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 183




193
1Lo stato di attuazione del D.M. 21/11/91 e successive modifi cheRelazione assemblea del seminario
2Volontari e politiche sociali: la Legge regionale 72/97Atti del Convegno
3Gli strumenti della programmazione nella raccolta del sangue e del plasmaCristiana Guccinelli, Regina Podestà
4Terzo settore, Europa e nuova legislazione italiana sulle OnlusCristiana Guccinelli, Regina Podestà
5Privacy e volontariatoRegina Podestà
6La comunicazione per il volontariatoAndrea Volterrani
7Identità e bisogni del volontariato in ToscanaAndrea Salvini
8Le domande e i dubbi delle organizzazioni di volontariatoGisella Seghettini
9La popolazione anziana: servizi e bisogni. La realtà aretinaRoberto Barbieri, Marco La Mastra
10Raccolta normativa commentata. Leggi fi scali e volontariatoStefano Ragghianti
11Oltre il disagio. Identità territoriale e condizione giovanile in ValderaGiovanni Bechelloni, Felicita Gabellieri
12Dare credito all’economia sociale. Strumenti del credito per i soggetti non profi tAtti del convegno
13Volontariato e Beni CulturaliAtti Conferenza Regionale
14I centri di documentazione in area sociale, sanitaria e sociosanitaria: storia, identità, caratteristiche, prospettive di sviluppoC entro Nazionale del volontariato, Fondazione Istituto Andrea Devoto
15L’uso responsabile del denaro. Le organizzazioni pubbliche e private nella promozione dell’economia civile in toscanaAtti del convegno
16Raccolta normativa commentata. Leggi fi scali e volontariatoStefano Ragghianti
“I Quaderni” del Cesvot

194
17Le domande e i dubbi delle organizzazioni di volontariatoStefano Ragghianti, Gisella Seghettini
18Accessibilità dell’informazione. Abbattere le barriere fi siche e virtuali nelle biblioteche e nei centri di documentazioneFrancesca Giovagnoli
19Servizi alla persona e volontariato nell’Europa sociale in costruzioneMauro Pellegrino
20Le dichiarazioni fi scali degli Enti non Profi tStefano Ragghianti
21Le buone prassi di bilancio sociale nel volontariatoMaurizio Catalano
22Raccolta fondi per le Associazioni di Volontariato. Criteri ed opportunitàSabrina Lemmetti
23Le opportunità “fi nanziare e reali” per le associazioni di volontariato toscaneRiccardo Bemi
24Il cittadino e l’Amministrazione di sostegno. Un nuovo diritto per i malati di mente (e non solo)Gemma Brandi
25Viaggio nella sostenibilità locale: concetti, metodi, progetti realizzati in ToscanaMarina Marengo
26Raccolta normativa commentata. Leggi fi scali e volontariatoStefano Ragghianti
27Le trasformazioni del volontariato in Toscana. 2° rapporto di indagineAndrea Salvini, Dania Cordaz
28La tutela dei minori: esperienza e ricercaFondazione Il Forteto onlus - Nicola Casanova, Luigi Goffredi
29Raccontare il volontariatoAndrea Volterrani
30Cose da ragazzi. Percorso innovativo di Peer EducationLuca Napoli, Evelina Marallo
31L’arcobaleno della partecipazione. Immigrati e associazionismo in ToscanaEttore Recchi
32Non ti scordar di te. Catalogo dei fondi documentari del volontariato toscanoBarbara Anglani
33Buone prassi di fund raising nel volontariato toscanoSabrina Lemmetti

195
34Il bilancio sociale delle organizzazioni di volontariatoLuca Bagnoli
35Le responsabilità degli organi amministrativi delle associazioni di volontariatoStefano Ragghianti, Rachele Settesoldi
36Storie minori - Percorsi di accoglienza e di esclusione dei minori stranieri non accompagnatiMonia Giovannetti
37Ultime notizie! La rappresentazione del volontariato nella stampa toscanaCarlo Sorrentino
38Contributi e fi nanziamenti per le associazioni di volontariatoGuida praticaRiccardo Bemi
39Le domande e i dubbi delle associazioni di volontariatoRiccardo Bemi, Stefano Ragghianti
40Cittadinanze sospese. Per una sociologia del welfare multiculturale in ToscanaCarlo Colloca
41Un mondo in classe. Multietnicità e socialità nelle scuole medie toscaneEttore Recchi, Emiliana Baldoni, Letizia Mencarini
42Altre visioni. Le donne non vedenti in ToscanaAndrea Salvini
43La valutazione di impatto sociale dei progetti del volontariato toscanoAndrea Bilotti, Lorenzo Nasi, Paola Tola, Andrea Volterrani
44Le donazioni al volontariato.Agevolazioni fi scali per i cittadini e le impreseSabrina Lemmetti, Riccardo Bemi
45Una promessa mantenuta.Volontariato servizi pubblici, cittadinanza in ToscanaRiccardo Guidi (2 voll.)
46Atlante del volontariato della protezione civile in ToscanaRiccardo Pensa
47La mediazione linguistico-culturale. Stato dell'arte e potenzialitàValentina Albertini, Giulia Capitani
48Contributi e fi nanziamenti per le assocciazioni di volontariato.Aggiornamento 2009Riccardo Bemi
49Volontariato e formazione a distanzaGiorgio Sordelli

196
50Il volontariato. Immagini, percezioni e stereotipiLaura Solito, Carlo Sorrentino
51Le competenze del volontariato.Un modello di analisi dei fabbisogni formativiDaniele Baggiani
52Le nuove dipendenze.Analisi e pratiche di interventoValentina Albertini, Francesca Gori
53Atlante sociale sulla trattaInterventi e servizi in ToscanaMarta Bonetti, Arianna Mencaroni, Francesca Nicodemi
54L'accoglienza dei volontari nelTerzo SettoreTecniche di comunicazionee suggerimenti praticiStefano Martello, Sergio Zicari
55Il lavoro nelle associazioni di volontariatoa cura di Sabrina Lemmetti




Stampato in Italiada La Grafi ca Pisana - Bientina (Pisa)
Dicembre 2011