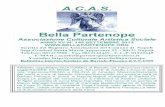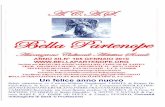La Canzone Napoletana. Tra Memoria e Inn
-
Upload
anonymous-wi852rtwpn -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of La Canzone Napoletana. Tra Memoria e Inn
-
8/20/2019 La Canzone Napoletana. Tra Memoria e Inn
1/13
I motivi di un progetto
di MARIALUISA STAZIO
Questo volume riunisce i contributi di quanti sono intervenuti durante quattro
giornate di lavoro del Gruppo di studio sulla Canzone Napoletana (Napoli, 28 e 29
novembre 2011, Biblioteca BRAU, Polo di Scienze Umane e Sociali, Università di
Napoli Federico II; Napoli, 7 e 8 giugno 2012, Dipartimento di Sociologia “Gino
Germani”, Università di Napoli Federico II).
Inizialmente concepita da Anita Pesce e da chi scrive, l’idea di promuovere questo
gruppo di studio multidisciplinare sulla canzone napoletana parte da un paio di
constatazioni.
La prima è che le canzoni napoletane fine ottocentesche hanno rappresentato un
unicum, per estensione della diffusione e per profondità e persistenza nella memoria e
nell’immaginario collettivi.
Quella immediatamente successiva è che oggi, quando al pari dell’opera buffa e del
melodramma, esse sono ormai “fuori produzione” – e fanno quindi parte dell’heritage –
cultura e politiche della cultura non hanno ancora sviluppato strumenti per
comprenderle e gestirle: musicalmente, “mitologicamente”, produttivamente.
Nel paradosso (almeno apparente) di un’espressione musicale che metonimicamente
“significa” e rappresenta una città, quando non l’intero Paese, e della sua insignificanzaa livello di ricerca e di iniziative istituzionali per la salvaguardia e valorizzazione del
suo patrimonio materiale e immateriale, si collocano “vuoti” di conoscenza che hanno,
ovviamente, a che vedere con i processi produttivi della conoscenza stessa. Ed è, infatti,
proprio su questi “processi produttivi” che l'iniziativa di riunire, non episodicamente,
studiosi di provenienza diversa su quest’oggetto, intende incidere.
Il progetto ha immediatamente trovato la calda accoglienza da parte dell’Istituto di
Storia delle Società del Mediterraneo dell’Istituto Nazionale delle Ricerche, nelle
-
8/20/2019 La Canzone Napoletana. Tra Memoria e Inn
2/13
Marialuisa Stazio
persone del direttore, Paolo Malanima e della dirigente di ricerca Paola Avallone che
qui, ancora una volta, sentitamente ringrazio.
Le giornate di studio hanno trovato ospitalità e patrocinio da parte dell’Università di
Napoli “Federico II”, nelle persone del Preside della Facoltà di Lettere, prof. Arturo De
Vivo; del Direttore del Dipartimento di Sociologia, prof. Enrica Amaturo; del Polo di
Scienze Umane e Sociali e dei suoi direttore, prof. Mario Rusciano, e vice direttore,
prof. Stefano Consiglio. E sono state realizzate grazie alla collaborazione scientifica con
Enrico Careri e Raffaele Savonardo, che che non solo hanno partecipato attivamente
alla loro organizzazione ma, soprattutto, le hanno arricchite di contenuti, di ospiti, di
originali spunti di riflessione.
A tutti voglio ribadire qui la gratitudine mia personale, quella di Anita Pesce e di tuttii partecipanti.
Durante le quattro, intensissime, giornate si sono declinati molti temi importanti.
Uno di questi – centrale per lo studio di tutti i fenomeni ascrivibili alla produzione
culturale (industriale e non) – è quello della stretta interrelazione fra le modalità
produttivo/distributive e le particolarità linguistico/formali.
Una delle cose che è apparsa immediatamente evidente, infatti, è che per quanto
riguarda la canzone napoletana sono accomunate sotto una stessa dizione formeespressive prodotte in momenti diversi e in modalità produttive differenti, tanto
relativamente ai mezzi utilizzati, quanto in riferimento alle logiche, ai mezzi e alle
modalità di distribuzione, alle organizzazioni industriali e alle loro logiche
economico/sociali. E diverse soprattutto – ma qui le differenze diventano più sfumate,
maggiormente bisognose di analisi in dettaglio – nelle caratteristiche
linguistico/musicali.
Nell’arco di tempo che va dal 1824 al 1970, nel campo finora ricompreso nellacomune denominazione di canzone napoletana, si avvicendano, infatti, diverse forme e
diverse fasi produttivo/distributive: dai “fogli volanti”, alle “raccolte”, all’editoria
musicale con le sue “canzoni d’autore”, fino al “sorpasso” della riproduzione sonora
rispetto alla stampa come medium di diffusione, e alla centralità ̀ dei media di
teletrasmissione nel sistema complesso dell’industria culturale.
Nelle giornate di studio abbiamo posto il problema – se non di “ri-nominare” i
diversi oggetti canzone – quanto meno di evidenziare fattori che permettano
12
-
8/20/2019 La Canzone Napoletana. Tra Memoria e Inn
3/13
I motivi di un progetto
legittimamente di accomunarli e di distinguerli. E, a quell’aggregazione quasi
“naturale” delle diverse forme espressive secondo il “periodo” di produzione, abbiamo
cominciato a sostituire una differenziazione operata attraverso il filtro dei media di
comunicazione (oralità, stampa, riproduzione sonora, telecomunicazione) e dei processi
e delle logiche produttive dei diversi apparati industriali di produzione culturale.
Abbiamo, inoltre, cominciato a porre il problema di evidenziare e classificare fattori e
caratteristiche linguistico/musicali che permettano di operare distinzioni fra oggetti
tanto diversi.
Un’altra peculiarità dell’oggetto di studio sta nel suo costruirsi, sin dalla prima metà
del XIX secolo, attraverso percorsi intertestuali tra parola scritta, musica
dell’illustrazione: nelle raccolte, negli spartiti e poi negli Album di Piedigrotta, nelleriviste, nei quotidiani, nei fogli d’album. Com’è noto, inoltre, alla fine del XIX secolo,
numerosi comparti dell’industria della cultura “fanno sistema” intorno alla canzone.
Essa diviene, così, un mezzo attraverso il quale esplorare il funzionamento sinergico
dei diversi comparti e apparati produttivi dell’industria culturale napoletana:
dall’editoria, all’informazione, dalla pubblicità, al teatro, alla riproduzione sonora. E,
naturalmente, il cinema, con il quale la essa inaugura – ancor prima del sonoro –
proficue sinergie.Il che introduce ad ancor più complessi percorsi transmediali. Giochi e rimandi
intertestuali e transmediali che si complessificano nel secondo dopoguerra, quando al
cinema sono affidati gli intrecci fra nostalgia e memoria, e la radio e la televisione
introducono elementi di modernità e contaminazione. E quando, contemporaneamente,
si completa il processo di delocalizzazione, iniziato già con il cinema nel ventennio
mussoliniano, dei centri e degli apparati produttivi di prodotti che continuano ad essere
“marchiati” come napoletani.Osservare come già “sulla carta”, e già nel XIX secolo, l’“oggetto canzone” si
costruisca attraverso la capacità del lettore/interprete di connettere parole e musiche con
testi giornalistici e illustrazioni, sposta immediatamente l’attenzione sul fatto che la
parte più importante, più imponente, della “creazione di prodotto” e del suo valore, sia
avvenuta principalmente nei processi del consumo e della circolazione culturale. Da una
parte, grazie alla capacità dei comparti di produzione culturale di innervarsi nelle
culture, nelle reti e nei rituali mondani e sociali, di entrare nel quotidiano e di sfruttare i
13
-
8/20/2019 La Canzone Napoletana. Tra Memoria e Inn
4/13
Marialuisa Stazio
miliardi di ordinarie interazioni comunicative che vi avvengono ma, ancor più –
dall’altra – grazie alle capacità e alle competenze del pubblico.
In omaggio soprattutto alla prospettiva operativa della maggior parte degli interventi
che seguono, vorrei ora dedicarmi a evidenziare i motivi per quali il fenomeno canzone
napoletana dovrebbe essere considerato interessante, e per i quali il progetto del
Gruppo di studio merita di continuare.
Cominciamo, anche qui, da una constatazione. Le canzoni napoletane sono
globalmente conosciutissime. Probabilmente la notorietà attuale può essere
parzialmente attribuita a un massiccio e corretto uso dei media di riproduzione e
trasmissione. Ma questi prodotti – e in particolare gli “esemplari” più famosi – nascono
molto prima dei mezzi tecnici di riproduzione e trasmissione del suono. E sonouniversalmente conosciuti già “prima” di essere ripresi e ulteriormente diffusi dai mezzi
tecnici. In breve, per trovare evergreen paragonabili – per profondità e persistenza nella
memoria e nell’immaginario collettivi – a Funiculì Funiculà, Santa Lucia, ’O sole mio,
dobbiamo attendere gli anni ‘40-50 del Novecento, spostarci geograficamente negli
Stati Uniti, e invocare la convergenza fra tecnologie di riproduzione e trasmissione del
suono e l’operare congiunto degli studios hollywoodiani, delle major discografiche,
delle radio.In altre parole, con la canzone napoletana riscontriamo un fenomeno di grande
diffusione e di penetrazione profonda e geograficamente estesa di prodotti musicali
concepiti per un largo pubblico, seppure in assenza di mezzi tecnici di riproduzione e
trasmissione del suono e grazie a un unico medium: la stampa. Che è un medium
selettivo (per accedervi bisogna essere alfabetizzati) e tipico di un’industria, quella
editoriale, che vende i suoi prodotti a prezzi più o meno accessibili.
Ma noi sappiamo – così ci dice la storiografia – che tutto questo avviene in unterritorio fortemente segnato dall’analfabetismo, dove l’economia domestica della
maggior parte delle famiglie è al di sotto della pura sussistenza.
Posto che il verificarsi di un fenomeno di diffusione e penetrazione di un prodotto
culturale presuppone l’esistenza di apparati produttivi e distributivi, evidentemente nella
Napoli del XIX secolo esisteva un’imprenditoria editoriale musicale in grado di
produrre e diffondere prodotti con caratteristiche adatte a incontrare un pubblico vasto,
internazionale, interclassista e multiculturale e di elaborare e combinare, in sinergia con
14
-
8/20/2019 La Canzone Napoletana. Tra Memoria e Inn
5/13
I motivi di un progetto
la stampa d’informazione e con le organizzazioni dello spettacolo dal vivo, modalità di
diffusione straordinariamente efficaci. Esisteva, insomma, un sistema d’industria
culturale, anche se con una “dotazione” mediale decisamente scarna, e in un territorio e
in un’epoca lontani (almeno secondo la storiografia più accreditata) anche
dall’industrializzazione tout court .
Si delineano, quindi, i primi due ambiti per i quali la ricerca sul fenomeno canzone
napoletana può essere considerata importante e opportuna.
Uno è quello che mi vede disciplinarmente maggiormente coinvolta, e che riguarda
la “revisione” della “modellistica” in dotazione ai sociologi della comunicazione,
specialmente di quella che enfatizza la centralità dei media ed affida la possibilità di
penetrazione sociale dei prodotti culturali alla “potenza” o alle caratteristiche dei mezzitecnici. In fin dei conti, una delle questioni sollevate dalla canzone napoletana
ottocentesca è proprio quella del media power : come mai constatiamo “effetti” profondi
in assenza di un “media potente”?
Il secondo riguarda prettamente la storia economica – ed è in esso che risiede
principalmente l’interesse dell’ISSM-CNR al fenomeno – poiché evidentemente
l’esistenza di un’industria culturale e, comunque, di numerose fiorenti attività legate
agli ambiti della produzione culturale e dei servizi, in un territorio consideratocomunemente economicamente depresso e “sottosviluppato”, è cosa che merita di
essere indagata.
Un terzo motivo d’interesse – sovente, da più parti, richiamato ma, in definitiva, mai
veramente affrontato – sta nel fatto che la canzone napoletana rimane un “fattore
distintivo” dell’immagine locale, dal quale sarebbe lecito aspettarsi ricadute nelle
strategie di differenziazione del prodotto turistico napoletano e dei prodotti napoletani
sui mercati globali.Il che era piuttosto evidente già nel XIX secolo, quando appaiono in primissimo
piano le alleanze strategiche fra diversi settori economici e, in particolare, le sinergie fra
diversi settori di produzione culturale e fra produzione culturale e segmenti economico-
produttivi come il commercio e il turismo.
Posto che, allora, il patrimonio musicale della canzone possa entrare a far parte di un
“vantaggio competitivo” del territorio, bisognerebbe individuare (e magari predisporre)
i presupposti necessari alla sua valorizzazione.
15
-
8/20/2019 La Canzone Napoletana. Tra Memoria e Inn
6/13
Marialuisa Stazio
La canzone napoletana può essere considerata un bene culturale, in quanto
“testimonianza di civiltà” e componente dell’heritage. O, almeno, così è abbastanza
comunemente percepita, tanto che c’è chi ha pensato di richiedere all’Unesco il suo
inserimento tra i patrimoni culturali dell’umanità.
La valorizzazione dei beni culturali (essendo di solito questi beni – non importa se
materiali o immateriali – legati a uno specifico territorio) è comunemente connessa con
la creazione di quello che è chiamato “prodotto turistico” e rappresenta, di solito, un
fattore di differenziazione in un’offerta globale, che si rivolge a una domanda –
anch’essa globale – interessata ai fattori, insieme culturali e d’intrattenimento, distintivi
di un territorio complessivamente considerato.
E allora – e non è strano in un Paese come il nostro, che detiene gran parte dei primati positivi e negativi nell’ambito dei beni culturali (l’heritage più ricco, la spesa
pubblica più povera) – ci troviamo, grazie alla canzone, ancora una volta al centro delle
problematiche cruciali della conservazione e della valorizzazione, e divisi fra la
consapevolezza delle enormi potenzialità di creazione di valore connesse al nostro
“patrimonio” e lo sgomento per l’incuria in cui è tenuto.
Il caso di specie, poi, è particolarmente utile per esemplificare i rapporti che
sarebbero “desiderabili” (o, meglio, indispensabili) fra conservazione, ricerca,formazione e valorizzazione.
È chiaro, infatti, che se vogliamo considerare il “bene culturale” canzone napoletana
nella sua funzione di “attrattore turistico”, dobbiamo ipotizzare un sistema di spettacolo
dal vivo, che la leghi al territorio non solo nella denominazione.
Nel far questo, dobbiamo tener le effettive qualità della domanda turistica – che
cerca esperienze “autentiche”, non paccotiglia folkloristica – ed anche che la canzone è,
anche e direi soprattutto, un prodotto culturale destinato all’intrattenimento. Tutto questo, unito alla rilevanza che l’esecuzione dal vivo – nella crisi del mercato
della riproduzione – ha assunto nei fatturati complessivi nel settore musica, mette in
primo piano l’esigenza (e l’inesistenza) di un circuito produttivo di offerta e domanda di
canzone napoletana (o, come forse sarebbe meglio dire: di popular music di matrice
napoletana), dotato di una sua vitalità e “verità”. Che, com’è ovvio, non può prescindere
dal rapporto con gli apparati di produzione e distribuzione che costituiscono il sistema
dello spettacolo e della comunicazione: circuiti di produzione e messa in scena e di
16
-
8/20/2019 La Canzone Napoletana. Tra Memoria e Inn
7/13
I motivi di un progetto
distribuzione teatrali e musicali; industrie editoriali, discografiche, radiofoniche,
televisive nelle loro varie e reciproche connessioni e sinergie, e nell’interazione con i
grandi canali di distribuzione dei prodotti e delle informazioni loro connesse, web
compreso.
E non può prescindere nemmeno da un maggiore impegno, organicità, continuità
nell’inserire e praticare questa forma “storica” nella formazione e nella ricerca
musicale.
Ma, la domanda di un prodotto culturale destinato all’intrattenimento non è – non
può essere – solo turistica.
La popular music napoletana – quell’oggetto, cioè, che comprende la canzone
napoletana e che con essa si confronta (ed è confrontata) consciamente, inconsciamenteo subliminalmente ma, comunque, senza posa – può e deve aspirare a pubblici davvero
più ampi, segmentati e articolati in relazione a interessi che riguardano il prodotto
culturale in sé, ma anche il genere cui appartiene, il canale tramite il quale è distribuito,
l’esperienza di fruizione che tale canale favorisce.
E, se ci inoltriamo in quest’ambito, non possiamo ignorare il radicale cambiamento
del mercato della musica: il digitale e le nuove forme di distribuzione hanno ridotto le
barriere di accesso alla musica e ai contenuti musicali, così come i costi di riproduzione,distribuzione, stoccaggio, e hanno aperto alla possibilità di sfruttare su scala globale la
“coda lunga” dei mercati di nicchia, dove si generano volumi economici addirittura
maggiori che nella grande distribuzione delle hit, mentre le modalità virali del
“passaparola” consentono di bypassare gli apparati promozionali e gli accordi
radiotelevisivi delle major .
Cambiamenti che hanno, ovviamente, investito anche la canzone napoletana.
Grazie a You Tube, in rete si trova veramente ogni cosa. Da Funiculì Funiculà “riarrangiata” da Rimsky-Korsakov, a rare registrazioni d’epoca (come, ad esempio,
Viviani in edizione Phonotype), ai video “promozionali” per il mercato dei
“matrimoni”. Nel 2011, iTunes ha inaugurato una Sezione speciale “Musica
Napoletana”.
Nel frattempo si affacciano nuovi servizi freemium – come Spotify e Pandora, nelle
due versioni: gratuita, limitata nell'uso e finanziata dalla pubblicità, la prima; a
pagamento completa, con funzioni aggiuntive e senza pubblicità, la seconda. I servizi di
17
-
8/20/2019 La Canzone Napoletana. Tra Memoria e Inn
8/13
Marialuisa Stazio
subscription hanno compiuto passi cruciali verso il raggiungimento di un mercato di
massa: principalmente attraverso l’integrazione con Facebook che ha spinto la musica in
abbonamento entro l’ambiente dei social network. Cosa che consente ad artisti e fan di
condividere canzoni legalmente e di scoprire nuova musica con sempre maggiore
facilità.
I nuovi modelli offrono ad artisti e case discografiche uno schema diverso di ritorno
dell’investimento.
Nel contesto del download à-la-carte (es: iTunes) ogni singola canzone o album
viene scaricato e pagato una volta sola. Con il sistema dello streaming , invece, una
canzone o un album possono essere ascoltati centinaia di volte, ognuna delle quali
genera un pagamento ai detentori dei diritti. Per quanto la somma pagata per un singolo stream sia di entità più ridotta di quella prodotta da un download , nel lungo periodo la
quantità di denaro generata dall’ascolto ripetuto di un album o di una canzone può
risultare maggiore. Ciò vale anche per mercati di nicchia, come ad esempio quello della
musica classica. Ad esempio, Abeille Musique, etichetta indipendente francese di
classica, ha abbracciato le nuove tecnologie entrando nel mercato digitale con un
servizio di streaming (Qobuz). Attualmente (2012), ricava circa il 12% del suo fatturato
dai canali di vendita digitali e pronostica una crescita fino all’85% nell’arco dei prossimi cinque anni1.
Così si delineano ulteriori possibilità di valorizzazione dei repertori di nicchia, per
sfruttare le quali diventa opportuno concentrare l’attenzione sui nuovi modelli di
business e sui relativi accordi per la corresponsione dei diritti d’autore e di
riproduzione. Ma occorre anche intervenire sui contenuti e la loro conservazione e
archiviazione e sulle opportunità per renderli fruibili in modi e forme adeguati tanto alle
nuove sensibilità musicali, quanto ai nuovi servizi e dispositivi.Ciò ci riporta, quasi automaticamente, a un altro problema che la canzone napoletana
condivide con i “beni culturali: quello della conservazione, che è fra quelli (con la
formazione e la ricerca) che passano più facilmente in subordine, quanto meno nei
bilanci dello Stato.
1 Digital Music Report 201. Expanding Choice, Going Global, IFPI 2012, Ifpi.org.
18
http://www.ifpi.org/content/library/dmr2012.pdfhttp://www.ifpi.org/http://www.ifpi.org/http://www.ifpi.org/content/library/dmr2012.pdf
-
8/20/2019 La Canzone Napoletana. Tra Memoria e Inn
9/13
I motivi di un progetto
Se parliamo di possibilità di sfruttare la “coda lunga” degli appassionati della musica
napoletana, parliamo infatti di rimettere in gioco i “cataloghi”, non importa quanto
antichi, purché conservati (e ben conservati), vuoi con la pura e semplice messa in rete
delle registrazioni sonore per lo streaming , vuoi con la ripresa di vecchi spartiti o
vecchie registrazioni per studiarli e riproporli. Il che, ovviamente, non può prescindere
dall’esistenza di archivi e biblioteche (anche se quest’affermazione non pare affatto
confermata dai bilanci dello Stato, guardando i quali la sopravvivenza di queste
istituzioni non appare affatto ovvia). Il processo di digitalizzazione dei materiali sonori
e cartacei (di tutti i materiali e quindi anche di quelli della canzone napoletana) è ormai
ad uno stadio avanzato e il sistema di conservazione e tutela dei materiali archivistici e
bibliografici ha acquisito una presenza in rete abbastanza forte.Cosa che, d’altra parte, molte biblioteche già fanno: dalla “nostra” Biblioteca
Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III”, con il suo catalogo di dischi “napoletani”
della Pathé in streaming o in download, al “National Juke Box” della Library of
Congress con i suoi dischi Victor, ascoltabili a richiesta. Il problema è, allora, anche
agire sulla domanda che, in questi casi, è rappresentata soltanto da un pubblico ristretto
di amatori e cultori della materia.
Il che apre a possibilità di mettere a frutto gli sforzi di ricerca e la capacità diorganizzazione dei contenuti (e, quindi, di creazione di valore aggiunto) che archivi e
biblioteche indubbiamente dimostrano, predisponendo possibilità di download o di
streaming on demand (gratuiti o a pagamento).
Cosa che, d’altra parte, molte biblioteche già fanno – dalla “nostra” Biblioteca
Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III”, con il suo catalogo di dischi “napoletani”
della Pathé in streaming o in download , al “National Juke Box” della Library of
Congress con i suoi dischi Victor, ascoltabili a richiesta –, raggiungendo, però, solo un pubblico ristretto di amatori e cultori della materia.
Un ulteriore esempio del legame fra lavoro di conservazione, archiviazione e
digitalizzazione e nuove modalità di fruizione potrebbe essere rappresentato da WR7, la
Web radio collegata all’ Archivio Sonoro della Canzone Napoletana.
Questo esperimento nasce in ambito RAI, e non è quindi esemplificativo delle
problematiche in cui sono immersi gli archivi e le biblioteche del MIBAC. Ma
rappresenta, oltre che un buon inizio, anche la testimonianza del fatto che – se pur
19
-
8/20/2019 La Canzone Napoletana. Tra Memoria e Inn
10/13
Marialuisa Stazio
complicato e difficile, per evidenti problemi legati ai diritti d’autore, per molta parte del
repertorio ancora attivi – v’è un possibile sbocco (se non di mercato quanto meno di
distribuzione e di visibilità) per tutte le forme di conservazione dei materiali stampati e
sonori della canzone napoletana.
Il che pone ancora una volta l’accento tematiche capitali per i beni culturali in Italia,
Paese in cui non pare ancora chiaro (almeno ai decisori politici ed economici) che per la
valorizzazione non è sufficiente che un bene esista.
Al contrario, perché un bene possa rappresentare un valore – in tutta la pienezza dei
sensi che questa parola assume – occorre un grande lavoro collettivo di conservazione,
tutela, studio, ricerca, e un’attenzione altrettanto ferma sulla trasmissione, diffusione,
disseminazione della cultura: in breve sulla crescita della conoscenza tacita dei pubblicie, quindi, sul sistema educativo d’istruzione e formazione. Poiché il “bene” – che può
essere fisicamente uno spartito consultato online da uno studente del Conservatorio, o
un file di ’O sole mio venduto su i-Tunes; un’area archeologica o un dipinto –
acquisisce (e può acquisire) valore sono nello scambio. E, dunque, solo se c’è un
pubblico che ha non solo la possibilità ma, soprattutto, la capacità di usarlo: di
comprenderlo, apprezzarlo, goderlo.
Nel caso di specie, può essere forse necessaria una conoscenza tacita relativamentelimitata per ascoltare una canzone (anche se la rete di riferimenti intertestuali ed
extratestuali necessari alla piena comprensione di testi come le canzoni napoletane,
caricati di senso dall’ascolto appassionato e partecipativo di un paio di generazioni è,
ormai, di tutto rispetto). Sicuramente, però, occorrono bagagli di saperi e competenze
per compiere operazioni complesse come connettere ricerca e ascolto, uso dei servizi e
creazione di playlist personali e, soprattutto, per abbandonare il mainstream del “flusso”
ed acquisire il gusto – quasi “collezionistico” – di inseguire, nel mare magnum del web,un particolare genere, autore, prodotto.
Nel frattempo, Napoli continua ad apparire come un laboratorio a cielo aperto sui
fenomeni di resistenza e ibridazione culturale fra materiali della tradizione, prodotti
delle industrie culturali e forme di espressione marginali, dove s’intrecciano produzioni,
culture, “paesaggi” sonori e musicali. Ci sono diversi momenti e occasioni in cui tutto
ciò è evidente, direi quasi esibito. Ad esempio, ogni anno, tutte le domeniche, dalla
metà di gennaio fino a Pasqua, le paranze – gruppi di fedeli che si preparano al
20
-
8/20/2019 La Canzone Napoletana. Tra Memoria e Inn
11/13
I motivi di un progetto
pellegrinaggio alla Madonna dell’Arco, che si svolge lunedì in albis – fanno la “cerca”,
vale a dire che raccolgono offerte in denaro “per la Madonna”.
Nei vicoli – ma anche nella centralissima via Toledo – risuona ancora la “voce” Chi
è devoto, fra esecuzioni bandistiche della Leggenda del Piave di E. A. Mario (1918) e di
Caruso di Lucio Dalla (1986), e diversi arrangiamenti dal pop mainstream. I fujenti –
nella vita quotidiana, spesso assai discordante con il loro “servizio” religioso –
ascoltano musica con i loro iPod, smartphone o iPhone. Ma si avvistano ancora ibride
versioni digitali dell’antico pianino, che del vecchio strumento a rulli mantengono la
sagoma esterna, nascondendo nell’anima un lettore CD, dal quale si diffondono melodie
più o meno neo – ma talvolta anche antichi evergreen – al fine di commercializzare
supporti di rigorosa provenienza “clandestina”. Le strade echeggiano, è vero, di produzioni neomelodiche, talvolta inframmezzate dalle “vecchie” canzoni del Festival
di Napoli, ma anche di musiche etniche di diversa provenienza, secondo i Paesi di
origine degli extracomunitari che ormai prevalentemente abitano i vecchi “bassi”. E che
a questo movimento di differenziazione e omogeneizzazione, di destrutturazione e
ristrutturazione culturale, partecipano attivamente: pare che, nel 2010, alcune centinaia
di cingalesi abbiano partecipato al pellegrinaggio alla Madonna dell’Arco e ai relativi
riti2
.È ovvio che a comporre le culture urbane partecipino sempre diversi livelli e
“stratificazioni” culturali.
Il caso napoletano pare, però, presentarsi ricco di peculiarità soprattutto per la
presenza – costante dal XIX secolo – di una produzione musicale dalla forte valenza
identitaria. E che a sua volta affonda le radici in processi di interpenetrazione fra
materiali eterogenei (canti contadini, frammenti operistici, estrapolazioni dalla
letteratura di colportage, cultura musicale tradizionale cittadina, ecc.) in cui trovavanoespressione fenomeni come la ininterrotta immigrazione a Napoli da altre province del
Regno e il continuo, quotidiano, pendolarismo dei cafoni fra la città e le campagne
circostanti. Questo “laboratorio”, dunque, ha cominciato a funzionare molto tempo fa, e
possiede una vitalità che pare inesauribile.
2 Vedi Link .
21
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/notizie/cronaca/2010/5-aprile-2010/festa-madonna-arco-anche-cingalesi-fanno-fujenti-1602778563713.shtmlhttp://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/notizie/cronaca/2010/5-aprile-2010/festa-madonna-arco-anche-cingalesi-fanno-fujenti-1602778563713.shtml
-
8/20/2019 La Canzone Napoletana. Tra Memoria e Inn
12/13
Marialuisa Stazio
L’universo neomelodico rappresenta oggi, allora, probabilmente, solo l’aspetto
“emerso” di processi molto più profondi e sfuggenti. E, pur nella sua grande risonanza
mediatica, nella sua apparente evidenza, ci mette di fronte a fenomeni che paiono
resistere all’analisi, così come a ogni possibilità di tenere insieme la faccia notturna e
quella diurna del simbolo/canzone: il neomelodico pare essere un’espressione diabolica,
che rifiuta gli scenari d’integrazione dell’armonia perduta della napoletanità almeno
quanto la canzone classica ne è stata, per decenni, l’espressione simbolica. Le
organizzazioni produttive, le reti di distribuzione e promozione, le occasioni di
esibizione dal vivo, il pubblico, tracciano, infatti, una mappa cittadina frastagliata da
fratture radicate in una povertà relativa, in una decisa alterità culturale, in una contiguità
con la microdelinquenza e la malavita organizzata, che autori e interpreti, lungi dalnascondere, esaltano nei comportamenti e nelle produzioni canore.
Anche questo è un campo di studio che andrebbe più e meglio praticato dalla
sociologia, dall’antropologia, dall’etnomusicologia – cosa che il coinvolgimento del
Dipartimento di Sociologia dell’università di Napoli, Federico II , promette di fare –
proprio in quanto forma espressiva di culture urbane che possiamo sommariamente
definire come “marginali” (ovviamente in relazione a ciò che viene descritto come
mainstream nei media e nelle culture “ufficiali”: politiche, accademiche, ecc.).Come probabilmente ogni forma culturale contemporanea, queste culture urbane
partecipano di diversi livelli e “strati” simbolici, di diversi “tempi della storia”. In esse
sembrano, infatti, convivere e contaminarsi uno strato arcaico, uno “congiunturale” ed
uno “evenementiel”, e ancora – e nel medesimo universo simbolico-culturale – prodotti,
culturali e non, appartenenti all’universo mainstream (con i loro usi sociali, questi sì
tutti culturali) e produzione simbolica autonoma e “autogestita”. L’universo
neomelodico – come l’osservazione delle cerimonie, degli interni domestici, della produzione/consumo di prodotti culturali di altro tipo – può rappresentare una strada e
un mezzo per avvicinarci a qualcosa che ci è tanto vicino quanto poco conosciuto.
Attraverso l’osservazione del sistema di produzione/consumo di questi prodotti
musicali – dove probabilmente acquistano evidenza tanto le stratificazioni dei
riferimenti e degli universi culturali (forme musicali urbane, canzone napoletana
classica, canzone melodica italiana, pop music, ecc.), tanto l’eco della
22
-
8/20/2019 La Canzone Napoletana. Tra Memoria e Inn
13/13
I motivi di un progetto
23
concorrenza/antagonismo con la produzione mainstream – potremmo almeno
cominciare a formulare delle ipotesi sul “funzionamento” di queste culture.
In conclusione, mi pare che avere organizzato quattro giornate di studio sulla
canzone napoletana non sia stata fatica sprecata. E che il progetto – che mira a portare
su questi temi l’attenzione di comunità scientifiche diverse e di cercare di assicurare
strutturazione, controllo scientifico e permanenza allo scambio fra enti, studiosi ed
operatori che, nelle Università, nei Conservatori, negli Enti di ricerca – meriti di essere
portato avanti.
Come già in questo volume appare chiaro, il nostro oggetto può offrirsi a diverse
discipline come un campo – definito e dalla complessità ancora piuttosto “dominabile”
– sul quale elaborare ipotesi interpretative, punti di vista e modelli di ricerca, e grazie alquale trovare punti di incontro e di lavoro multidisciplinare e interdisciplinare.
La formazione (e, soprattutto, la permanenza) di una rete di studiosi e di discipline,
avrebbe molteplici vantaggi tanto per la conservazione, trasmissione, studio e
valorizzazione di un patrimonio che connota profondamente l’italianità nel mondo,
quanto – a livello metodologico e interpretativo – per una migliore comprensione dei
fenomeni e dei processi culturali in età industriale e “post-industriale” in ambito urbano,
o per rileggere e ri-declinare “umanisticamente”, in maniera adeguata alla particolaresituazione italiana, i dettami e le regole dell’economia della cultura e dell’informazione.