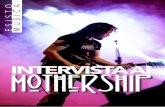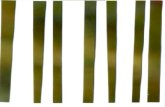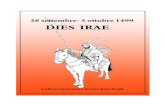Intervista a Pier Luigi Ferro sul "Verso libero" di Lucini
description
Transcript of Intervista a Pier Luigi Ferro sul "Verso libero" di Lucini

1
Pier Luigi Ferro LE REVOLVERATE CRITICHE DI GIAN PIETRO LUCINI Un secolo dopo la sua pubblicazione presso le edizioni di ‘Poesia’ del futurista Marinetti, riappare in anastatica “Il Verso Libero”, un debordante saggio polimorfo di settecento pagine dell’eterodosso autore lombardo che dichiarava: ‘Filosofia, Lirica, Storia, Sentimento, Metodo, Grammatica ed Anarchia; tutto si avvicenda in questi fogli’. Ne parliamo con l’appassionato curatore del libro, che vede nello stile sovversivo, antiborghese, radical-aristocratico dello scrittore lariano una chiave di paternità della modernità letteraria italiana e, insieme, una irriducibile dimensione oppositiva alla modernità stessa.
******
di Mario Lunetta Nel novembre 1908, dopo una bella serie di traversìe, difficoltà economiche, ripensamenti e angosce d’autore, esce finalmente presso le Edizioni di “Poesia” di Marinetti Il Verso Libero di Gian Pietro Lucini: un saggio polimorfo, di estensione pressoché irrefrenabile (circa 700 pagg.), che lo stesso autore definì come un “corpo collerico, isterico, disordinato”. Nell’Invio al “duce” dei Futuristi, dal quale poco dopo lo dividerà un insanabile contrasto ideologico, Lucini parla con ironia del suo opus magnum come di un “volumetto” che definisce interrogativamente come Storia, Filologia, Critica, Autobiografia, Polemica, Estetica pura, concludendo, contro prevedibili addebiti di oscurità, confusione, astrusità, che “Sì, potete aver ragione; ma l’oscurità di un autore è in ragione diretta della personalità inedita de’ suoi concetti”. E aggiunge, orgogliosamente: “Filosofia, Lirica, Storia, Sentimento, Metodo, Grammatica ed Anarchia; tutto si avvicenda in questi fogli. Io mi confido alla capacità del lettore, che tutto legga e sappia leggere; gli procuro un nuovo piacere. Come la vita. Bisogna saperla vivere; trascegliere, accettare o rifiutare; la vita è una sintesi; chi l’esercita bene, la scompone e ne estrae quelli elementi che gli sono utili, belli, piacevoli. Così si vive filosoficamente; così si legge intelligentemente. Non credo opportuno di preporre un piccolo trattato: Sul come si deve leggere, necessario, forse, ma ingombrante”. Quella di Lucini è un’anarchia in cerca di sintesi, appunto – e un’antiestetismo assoluto. Il Verso Libero è una recherche magmatica, un’indagine ipotetica e multistratica che attraversa l’enigma Letteratura per decifrare il geroglifico della Vita Presente, nelle contraddizioni leggibili dei suoi orrori: il patriottismo, il militarismo, l’egolatria, l’oppressione dei forti contro i deboli, insomma tutto ciò che appena poco più di un decennio dopo si chiamerà fascismo. Ecco perché al libertario raffinatissimo che è Gian Pietro Lucini finiscono per diventare insopportabili personaggi iconici emblematicamente ingombranti come Marinetti e D’Annunzio. Se per lo Stendhal di Vie de Rossini “Il patriottismo d’anticamera è la grande malattia morale degli italiani”, in nome della Tradizione contro la Consuetudine, quindi nell’orizzonte dell’Avanguardia, Lucini – proprio per “salvare la Poesia dalla Prudenza” – dedica pagine sprezzanti al “pastore e zampognaro Titiro d’Abruzzi” alias Gabriele D’Annunzio, qualche tempo prima di massacrarne immagine e ruolo con D’Annunzio al vaglio dell’Humorismo. Un’opera straordinaria, quindi, Il Verso Libero, che alla sua uscita riscosse qualche attenzione da alcuni circoli letterari assai ristretti, per essere poi confinata – per motivi più “politici” che estetici – nel limbo dei libri bizzarri e un poco fastidiosi. Dell’edizione di “Poesia” si vendettero alcune decine di copie, poi il silenzio. Un “sonno” editoriale durato un secolo. Un libro a suo modo

2
“dannato”, che attraversa la letteratura e la storia italiane senza bave diplomatiche e reticenze di comodo, anarchicamente, coraggiosamente. D’altronde, è l’intera opera luciniana che ha subito una rimozione pesantemente vendicativa; e ci sono voluti gli interventi acutissimi di Glauco Viazzi e di Edoardo Sanguineti a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, per rimetterne degnamente in gioco i valori alla nostra Borsa Letteraria, per truccata che fosse. Oggi, per le cure meritorie e intelligenti di un italianista poeta come Pier Luigi Ferro, ecco apparire in anastatica Il Verso Libero (interlinea ed., 2008, pp. XXXVIII+710, € 30,00). A lui abbiamo rivolto alcune domande: La figura di Lucini è ricca e complessa, la sua opera è piena di stimoli e di proposte innovative, ma la cultura italiana l’ha sostanzialmente ignorata. Quali ragioni ci sono, al fondo di questa rimozione? Leopardi scrisse che “obblio / preme chi troppo all’età propria troppo increbbe” e certo la posizione polemica di Lucini da una parte contro il dannunzianesimo trionfante, dall’altra, dopo un primo avvicinamento, contro il nascente futurismo, lo resero ben presto, come ha scritto Sanguineti, oggetto di culto da “religione solitaria per eruditi ambrosiani”. Il suo linguaggio inattuale e ad amplissimo spettro stilistico, ricchissimo di acri umori così come di erudizione raffinata e di preziose distillazioni, non è fatto per blandire il pubblico che gia c’è, ma cerca un proprio pubblico “non dozzinale”. È, il suo, uno stile sovversivo, antiborghese, in una duplice direzione, improntato com’è di anarchismo aristocratico, che tende a “sorpassare la consuetudine”, ma che non appare disposto a rinunciare tout-court ad una concezione gentilizia della letteratura. Nulla di più distante e di più indigeribile per l’udienza cui si rivolgeva la nascente industria editoriale, alla quale Lucini non ammannisce neppure le narcotiche blandizie dell’estetismo e quindi l’illusione della praticabilità di un bello, di un sublime sapientemente confezionato per le moderne folle, destinato a precipitare per sua natura con ferma logica verso il Kitsch. Insomma, si può davvero parlare, a proposito di questo padre della modernità letteraria italiana, di una irriducibile e contraddittoria disposizione alla modernità stessa. A ciò è dovuto, a mio parere, gran parte del suo fascino e della sua importanza come rappresentante di alcuni dei nodi più intricati nella cultura italiana a cavaliere tra l’Ottocento e il Novecento. E quando dico questo, intendo non solo riferirmi a quell’attitudine alla contraddizione come “piacere particolare” cui Lucini scrittore volentieri si concede come ad un portato vitale, come ad una caratteristica non “di chi descrive”, ma della “cosa descritta”, da una posizione di fenomenalismo critico. Intendo soprattutto riferirmi ad un “dire contro”, ad un rapporto sfaccettato e crudele, tutto sommato inesauribile, con la realtà ma anche con il lettore. Quali indicazioni di lettura suggeriresti, per una buona fruizione odierna del Lucini autore creativo e del Lucini teorico? Intanto diciamo che, a parte naturalmente il Verso Libero, non mancano oggi recenti strumenti per avvicinare anche il Lucini più impervio, quello prima maniera, legato alla poetica del Simbolismo francese. Penso alla recente edizione critica del Libro delle Figurazioni Ideali curata davvero con grande scrupolo e acume da Manuela Manfredini per la Salerno, che offre molti strumenti interpretativi e di apparato, completi e aggiornati. Recentemente è stato poi ristampato addirittura in una collana come gli “Oscar” di Mondadori l’ultimo scritto polemico, lasciato in bozze nel 1914 e mai uscito: Antimilitarismo, a cura di Simone Nicotra. Il più recente profilo critico monografico su Lucini, non privo di riserve, è nel volume di Paolo Giovannetti, edito da Palumbo nel 2000; ma non dimenticherei le pagine importanti che gli dedica Alberto Bertoni nel saggio Dai simbolisti al Novecento. Le origini del verso libero italiano, edito da Il Mulino una decina di anni fa. Si possono poi segnalare le recenti ristampe dei Monologhi curati da Marcello Carlino e Francesco Muzzioli per Empiria, o le riproposte in anastatica, purtroppo prive di commento critico, di Antidannunziana, dei Filosofi ultimi, dei Monologhi di Pierrot e, soprattutto, de L’ora topica di Carlo Dossi, che

3
insieme al Verso Libero mi pare il vertice della critica luciniana. Questo tralasciando gli studi dedicati a Lucini e apparsi su riviste specialistiche. Personalmente, a parte quanto già detto sulle scritture critiche e teoriche, il Lucini che mi pare oggi più interessante per il lettore è quello satirico: penso alle Revolverate e Nuove Revolverate curate da Sanguineti nel 1975, e alla Solita Canzone del Melibeo, che attende ancora di essere ristampata e di cui non mi dispiacerebbe occuparmi. Lucini continua ad essere assente dalle antologie scolastiche, e non solo. Sembra una vera damnatio memoriae. Dall’accoglienza che la ristampa anastatica del Verso Libero da te così appassionatamente e rigorosamente curata ha avuto, c’è da sperare che lo straordinario autore lombardo possa finalmente avere il posto di prima fila che gli spetta nella nostra letteratura tra fine Ottocento e primo Novecento? Il discorso sull’editoria scolastica è piuttosto complesso e meriterebbe di essere sviluppato; ma non è possibile affrontarlo in questa sede. Ricordo solo che la migliore, probabilmente, tra le antologie scolastiche uscite negli ultimi anni, curata da Cesare Segre e Clelia Martignoni, uno spazio al Lucini delle Revolverate lo riservava. Piccolo, ma c’era. Ora credo non sia più in catalogo. Purtroppo la politica dell’editoria scolastica va in un certo modo… È comunque vero quanto dici, generalmente Lucini non ha spazio in queste compilazioni. Quanto alle antologie non scolastiche, a parte quella ormai classica curata da Sanguineti quarant’anni fa e più volte ristampata, cui va il merito, come tutti sanno, dell’inserimento di Lucini nel canone del Novecento, non bisogna dimenticare che un posto di qualche riguardo vien riservato al nostro autore nell’opera curata da Carlo Ossola e Cesare Segre, diffusa anche in veste economica come supplemento a “La Repubblica” nel 2004 e dunque arrivata, si può dire, al grande pubblico. Io penso tuttavia che occorra ancora fare qualcosa per attribuire a Lucini il posto che ormai gli compete e, a tal fine, io e la Manfredini stiamo lavorando per mettere a punto un progetto editoriale complessivo ormai non più rimandabile. Nella tua densa Presentazione tu osservi che a pochi mesi dalla comparsa “l’opera più ambiziosa di Lucini era già avviata a divenire un libro certamente più citato per sentito dire che letto”. Ti chiedo: è sufficiente l’irriducibilità ideologica dello scrittore lariano a spiegare la sua emarginazione? Ci potremmo abbandonare a qualche considerazione dettata del momento, pensare che in questi tempi ogni traccia della cultura politica che, per via più o meno diretta, discende dal sovversivismo antiborghese del primo Novecento, di cui Lucini fece parte, è stata cancellata dal nostro Parlamento, grazie ad una legge elettorale che, tra l’altro, non ha permesso agli elettori di scegliere i propri rappresentanti. Tutto questo per dar vita ad una sorta di autoritarismo morbido a tutela degli interessi di un blocco sociale che ha i suoi rappresentanti, con varie trascurabili sfumature, ormai nell’intero emiciclo. Si è annunciata, con vari accenti di soddisfazione, la fine delle ideologie: in realtà ciò che è stato spento è il pensiero critico, le ideologie che si opponevano a quella dei gruppi dominanti. In molti, non solo da destra intendo dire, hanno contribuito a questo risultato. Quindi mi verrebbe da dire che sì, l’irriducibilità ideologica sia una qualità alla lunga poco spendibile in una società come la nostra, allora come oggi, e forse in essa risiede la ragione prima dell’ostracismo di cui il poeta lariano è stato condannato. Però non si può ignorare che, se è pur vero che Lucini è certamente uno scrittore capace di riservare non poche pagine gustosissime e memorabili, di un virtuosismo mai fine a se stesso, non è meno evidente come la sua appaia una scrittura tutt’altro che semplice: essa pretende piuttosto di essere attivamente, costantemente interrogata. E non molti durano questa fatica, preferiscono chiedere altre cose al libro: di essere sedotti, convinti, rassicurati, magari di essere confermati in una comune indignazione. Rispetto a questi orizzonti di attese Lucini sa essere perfino superbamente irritante, e non ha mancato di irritare, infatti. Non a caso nella Autologia, premessa alle Revolverate ma scritta

4
mentre componeva il Verso Libero, dichiarando di sdegnare “le pigre bugie cotidiane”, confessa “il Bene e il Male abburatto e distillo; / più che amicizia eleggo odio palese”. Lucini, autore d’avanguardia, si trova ben presto in rotta di collisione con Marinetti e il Futurismo da una parte, e dall’altra con D’Annunzio e il dannunzianesimo nazionalista e patriottardo, nutrito di mistica piccoloborghese. Ricorda Sanguineti come Lucini si sia seccamente rivolto ai Futuristi: “con questa gibigianna instaurate il dispotismo”, a riprova che nella sua visione agisce una coincidenza di ragioni letterarie e di ragioni civili. Parlaci di come si è sviluppata la tua ricerca, partendo dalla prima fase del tuo interesse per Lucini. Sono diventato lettore del poeta lariano al tempo dell’Università, quando mi procurai le edizioni di Viazzi stampate da Guanda e l’antologia della Ghidetti, che ormai erano finite sugli scaffali di un remainder che si trovava in una specie di scantinato del Palazzo Ducale di Genova; ma soprattutto lessi le Revolverate e Nuove Revolverate edite da Einaudi. In quegli anni riuscii a procurarmi dagli antiquari anche molte edizioni originali, che allora avevano un prezzo accessibile anche ad uno studente di non floridisime condizioni quale ero. Il mio interesse per Lucini nasce però mediato, non mi sembra il caso di sottacerlo, dalla grande ammirazione per il lavoro critico e poetico di Sanguineti. Dieci anni fa, sulle pagine di Alias, lessi un suo articolo, in cui invitava a rendere finalmente disponibile alla lettura un’opera capitale come Il Verso Libero: dal momento che nessuno nel frattempo aveva colto tale autorevole e opportuno invito, mi è sembrato indispensabile farlo in occasione del centenario della sua prima edizione in tiratura assai limitata, tanto che il volume era ormai quasi introvabile. Decisa l’impresa, mi son posto naturalmente il problema di come condurre il lavoro critico e di ricerca. Ho esaminato i manoscritti, tutto il materiale originale e inedito a disposizione sull’opera, presente nel Fondo Lucini a Como. La mole del testo, tra l’altro dotato di per sé di un apparato di note assai consistente, mi ha fatto scartare l’idea di darne un’edizione critica e chiosata, perché ne sarebbe scaturito un volume di dimensioni impressionanti e la prima urgenza mi è parsa quella di rendere il saggio accessibile. Ho preferito seguire la strada di un’edizione anastatica dotata di una premessa critica che ricostruisse puntualmente la storia del testo, assai interessante peraltro, a partire dai suoi rapporti con l’Inchiesta marinettiana sul verso libero lanciata dalle pagine di “Poesia”, fino al primo tentativo di ristampa integrale nel 1913, non andato a buon fine, da parte di Ugo Tommei, un giovane intellettuale fiorentino di formazione anarco-repubblicana e fervente ammiratore di Lucini, che tradì le sue posizioni iniziali, finendo nell’area di “Lacerba”. Dalle complesse vicende di gestazione, composizione e stampa del Verso Libero, dall’analisi delle lettere di Marinetti, di Tommei, dei documenti, mai studiati prima, è scaturita una vicenda che mi pare esemplare anche del clima di involuzione culturale e politica nel primo scorcio del Novecento, in quegli anni di modernizzazione senza industria che portarono alla Grande Guerra e alla catastrofe fascista. Fare emergere ciò, tra l’altro, mi è sembrato più utile che perdermi nel tentativo inane di descrivere l’impianto teorico del testo, soprattutto perché il Verso Libero è un libro fondamentalmente anarchico, che si nega programmaticamente ad una riduzione sistematica, per un suo irriducibile besoin de totalisme. È sempre difficile fare paragoni, i contesti storici non son mai identici, però penso si possa trarre qualche utile spunto di riflessione anche riferito all’ Italia contemporanea: un Paese ancora oggi di agili “saltatori”, che sembra procedere con un suo “passo del gambero” e che forse, chissà?, meriterà presto chi gli imponga nuovamente quello dell’oca. In fondo il fascismo non ce l’hanno regalato gli Iksos, come sostenne Croce: è stato un fenomeno assai complesso, che ha espresso delle pulsioni profonde nell’identità nazionale e che è stato poi rimosso, per necessità, dalla superficie della coscienza collettiva, senza essere mai stato realmente estinto.

5
Nel corso delle tue indagini hai trovato testi luciniani inediti di qualche interesse? Cosa pensi eventualmente di farne? Sì, anche se ovviamente le mie ricerche erano orientate sul Verso Libero, e si trattava di non esiguo materiale, non ho resistito alla tentazione di fare qualche sondaggio che ha dato risultati che a me paiono interessanti. In particolare, sono riuscito a scovare il Diario Besson e vari altri documenti collegati, con cui Lucini aveva intenzione di costruire un libello polemico “di poche pagine e pronta vendita”, come lui stesso dichiara in una nota, un po’ alla Umberto Notari, un giornalista molto vicino a Marinetti. Notari è uno di quei letterati che ad inizio secolo ben comprendono la valenza pubblicitaria dello scandalo, in un momento cioè in cui l’editoria era ormai diventata un’industria culturale ed il pubblico del libro stava diventando sempre più vasto. I due si erano conosciuti in occasione della stesura, da parte di Notari, di un violento pamphlet anticlericale, dal titolo invero poco reticente: Il maiale nero. A Varazze, sulla Riviera del ponente genovese, dove Lucini trascorreva gli inverni per scampare al clima rigido di Breglia, nell’estate del 1907 era scoppiato un grosso scandalo che coinvolse il collegio dei Salesiani, accusati da un convittore, Alessandro Besson, appunto, di aver indotto gli studenti ad atti poco edificanti. Lucini si dedicò con molto impegno a “rinfocolare” lo scandalo, come scriverà nell’Antidannunziana, che peraltro aveva già avuto spazio sulla stampa nazionale. Coinvolse Cesare Lombroso e vari psichiatri, tra cui Enrico Morselli, cui chiese pareri sulla vicenda. Gli sviluppi di tale vicenda arrivarono a turbare l’ordine pubblico, ci furono manifestazioni di piazza contro i Salesiani dapprima, contro il poeta poi, scontri, attestazioni di solidarietà, anche curiose, come quelle nelle lettere di due anarchici varazzesi emigrati negli Stati Uniti, che scrivono a Lucini raccontandogli la loro vita oltre oceano. Ho raccolto e ordinato molto materiale su questa storia veramente fuori dal comune, attraverso cui emerge ancora uno straordinario spaccato, per certi aspetti anche divertente, dell’Italia di allora. Lucini non riuscì a completare il suo libello: ne annuncia come imminente la pubblicazione ancora cinque anni dopo. È mia intenzione pubblicare il Diario e i documenti collegati di maggior interesse in un libro di non molte pagine che ricostruisca l’accaduto. Non solo per aggiungere un importante tassello alla conoscenza di questo scrittore; ma, confesso, perché la vicenda mi pare ancora ricca di spunti significativi rispetto al clima politico che stiamo vivendo.