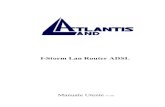INFORMATICAB Ingegneria+Elettrica+ · 2015-06-04 · Fisico Rete Data Link Fisico Applicazione...
-
Upload
nguyendieu -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of INFORMATICAB Ingegneria+Elettrica+ · 2015-06-04 · Fisico Rete Data Link Fisico Applicazione...
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOIGNEGNERIA
INFORMATICA B Ingegneria Elettrica
Architetture dei sistemi informatici e reti di calcolatori
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Sistema informatico distribuito
• I programmi scritti finora sono “monolitici”, ogni componente necessaria all’elaborazione è eseguita da uno stesso processo che viene eseguito da un unico calcolatore (con un’unica CPU…) ed eventualmente accedono ad una base di dati locale
• E’ possibile sfruttare più calcolatori in parallelo ed organizzare meglio la struttura di un’applicazione in più programmi che cooperano tra di loro
Sistema distribuito
2
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Sistema informatico distribuito
• Sistema informatico distribuito se (almeno una delle condizioni è verificata): § Le applicazioni (fra loro cooperanti) risiedono su più nodi elaborativi
(Elaborazione distribuita) § Il patrimonio informativo (unitario) è ospitato su più nodi elaborativi
(Basi di dati distribuita)
• Per analizzare i sistemi distribuiti bisogna analizzare: § I mezzi e le tecniche di trasmissione dei dati attraverso un canale di
comunicazione § L’organizzazione dei calcolatori in una rete di calcolatori § L’organizzazione delle applicazioni che sono eseguite sulla rete di
calcolatori e che interagiscono tra di loro (cioè il sistema distribuito)
3
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
4
La comunicazione dei dati
• Trasmettitore: converte il messaggio per renderlo trasmissibile in modo efficiente
• Ricevitore: riceve il segnale dal canale e lo converte in un messaggio comprensibile dal destinatario
sorgente
trasmettitore ricevitore (segnale) canale di trasmissione
(messaggio)
destinatario
(messaggio)
sistema di trasmissione
distorsioni
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Mezzi e tecniche di trasmissione dati
• La trasmissione dati consente di collegare dal punto di vista fisico tra di loro calcolatori e periferiche
• I principali mezzi per la trasmissione dei dati sono § I cavi di rame § Le fibre ottiche § Le onde elettromagnetiche
• I parametri più significativi per caratterizzare la trasmissione dati sono: § La velocità di trasmissione (in bit-‐per-‐second, bps) § La distanza di trasmissione (da poche decine di metri a migliaia di
chilometri)
5
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Cavi in rame
• Coassiale § Simile a quello della
televisione § Primo cavo transatlantico nel
1956 (36 telefonate in parallelo)
§ Resistente alle interferenze elettromagnetiche
§ Poco flessibile • Si usura facilmente • Difficile da installare
• Doppino § Simile a quello utilizzato per il
telefono § Meno costoso § Più flessibile e facile da
installare § Più soggetto ad interferenze
esterne
6
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Fibre ottiche
• La fibra ottica è costituita da materiale vetroso e impiega un segnale luminoso per la trasmissione di informazioni
• Rappresenta un mezzo di comunicazione ideale, diffusione limitata dagli alti costi di produzione
• Oggi ampiamente utilizzata sia per le reti locali che metropolitane e geografiche principali
• Il primo cavo transatlantico nel 1988 (40000 telefonate contemporanee)
• Vantaggi: § Bassa attenuazione del segnale § Grande capacità di trasporto delle informazioni § Immunità alle interferenze elettromagnetiche
• Svantaggi: § Minore flessibilità rispetto ai conduttori in rame § Costi di produzione e soprattutto di installazione maggiori
8
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Fibre ottiche
• Nelle fibre ottiche, il raggio luminoso viaggia attraverso continue riflessioni
• Il segnale può viaggiare lungo distanze di decine di chilometri senza bisogno di essere rigenerato
• Velocità di trasmissione ordine delle decine di Gb/s • I cavo è composto da due strati:
§ Il core è un mezzo trasparente che trasporta il segnale laser § Il cladding è uno strato esterno che costringe l’onda a seguire il percorso del
cavo
9
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Onde radio e sistemi wireless
• Per comunicazioni wireless si intende un’ampia gamma di tecnologie che fanno uso di onde elettromagnetiche per la trasmissione dati
10
Tecnologia Frequenza Note
Onde radio < 3GHz • Tecnologia più diffusa • Può coprire ambienti eterogenei
Microonde 3GHz – 300GHz • Fasci direzionali senza dispersione • Collegamento di edifici vicini
Infrarossi 300GHz – 428GHz
• Collegano dispositivi «visibili» • Tecnologia lenta ed in disuso
Luce visibile (laser)
428GHz – 749GHz
• Fasci direzionali senza dispersione • Sensibile agli effetti atmosferici
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Tecnologie radio nei sistemi wireless
• Wifi § Raggio di azione di circa 100 metri § Velocità fino a 54Mbps
• WiMAX § Raggio di azione di 50Km (copre un’area metropolitana) § Velocità fino a 70Mbps
• Rete cellulare (GSM, GPRS, UMTS) § Velocità fino a 14.4Kbps (GSM), 57.6kbps (GPRS), 3Mbps (UMTS)
• Rete satellitare § Utilizzano satelliti geostazionari § Velocità di parecchi Gbps § Connessioni sia monodirezionali
che bidirezionali § Utilizzate nel campo della telefonia,
televisione e navigazione marittima
11
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Modulazione e demodulazione del segnale
• Le reti di telecomunicazione trasmettono onde elettromagnetiche (o luminose) cioè segnali analogici
• Per trasmettere informazioni digitali è necessario quindi trasformare le sequenze di bit in onde elettromagnetiche e viceversa
• Il modem trasforma segnali digitali in analogici (modulazione) e viceversa (demodulazione)
12
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Modulazione e demodulazione del segnale
• La modulazione di un segnale può avvenire in frequenza, fase o ampiezza • Modulazione in frequenza sulla linea telefonica tradizionale:
§ In assenza di trasmissione dati, il segnale portante è una sinusoide con una data frequenza (1700Hz)
§ Se si vuole trasmettere un 1, si usa una frequenza più alta (2100Hz) § Se si vuole trasmettere un 1, si usa una frequenza più bassa (1300Hz)
• Velocità massima di trasmissione: 56Kbps • Evoluzione: tecnologia DSL
13
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Rete di calcolatori
• Una rete permette di collegare più calcolatori (detti anche nodi o host) con l’obiettivo di: § Condividere applicazioni § Consultare archivi comuni § Trasmettere dati tra sistemi
• Una rete è composta da nodi eterogenei sia per quanto riguarda il software che l’hardware
• Le reti hanno dimensioni di vario tipi: § LAN (Local Area Network) o rete locale
• Collega calcolatori nella stessa stanza o edificio § MAN (Metropolitan Area Network)
• Copre un’area metropolitana § WAN (Wide Area Network) o rete geografica
• Collega citta diverse o nazioni diverse • Internet è la più estesa tra le rete geografiche
14
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Rete di calcolatori
• Le reti hanno una struttura gerarchica
15
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Rete di calcolatori
• Si è assistito ad una convergenza tecnologica tra reti di calcolatori (WAN e MAN) e reti di telecomunicazione § Le telecomunicazioni si appoggiano sempre più sulla trasmissione
digitale e sui protocolli tipici delle reti di calcolatori § Le reti di calcolatori usano spesso le infrastrutture create per le reti di
telecomunicazioni
16
La rete di dorsale La rete d’accesso
Point of Presence
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Rete di calcolatori
• La rete di dorsale (una WAN o MAN) è la parte centrale di una rete di telecomunicazioni. È la rete gestita da Internet Service Provider
• La rete d’accesso permette l’accesso alla rete dorsale. Possibili esempi sono ADSL e UMTS
17
Rete d’accesso Rete di dorsale
Molti collegamenti Pochi collegamenti
Bassa velocità (Mbit/s) Alta velocità (Gbit/s)
Brevi distanze (<50km) Lunghe distanze (>50km)
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Struttura dei messaggi
• La comunicazione tra due nodi avviene tramite invio di messaggi • I messaggi sono divisi in pacchetti, ciascuno dei quali spedito
individualmente • I pacchetto sono
sequenze di bit in genere di ugual lunghezza
• L’header e il footer contengono una serie di informazioni di controllo
18
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Struttura dei messaggi
• I pacchetti sono spediti individualmente • L’instradamento (routing) di ciascun pacchetto viene
effettuato tramite le informazioni nei bit di controllo § Il routing può essere deciso staticamente o dinamicamente
19
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Protocolli di comunicazione
• Protocollo di comunicazione: un insieme di regole che devono essere seguite da due interlocutori per la mutua comprensione in una comunicazione § Regole di formato, regole temporali, ecc...
• L’elevato livello di cooperazione in una comunicazione nelle reti di calcolatori pone condizioni molteplici, gestibili tramite insiemi di protocolli § Ogni protocollo è dedicato ad un particolare aspetto della
comunicazione • I protocolli utilizzati dai calcolatori sono organizzati secondo
una gerarchia di livelli § Ogni protocollo fornisce servizi al protocollo immediatamente
superiore e si appoggia a sua volta su di un protocollo a livello inferiore
20
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Lo standard ISO-‐OSI
• L’Open System Interconnection definito dall’International Standard Organization propone una pila di protocolli per la comunicazione
21
Servizi telematici
Conversione dei formati
Apertura/chiusura dialogo
Segmentazione del messaggio in pacchetti
Routing
Controllo di correttezza
Aspetti HW/SW legati ai dispositivi di comunicazione
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Lo standard ISO-‐OSI
• In un nodo ciascun livello è una sorta di macchina virtuale che comunica con la macchina virtuale equivalente dell’altro nodo
22
Protocolli end-‐to-‐end, principalmente utilizzati dai due capi estremi di una comunicazione per elaborare le informazioni scambiate
Protocolli di accesso, alla rete regolano la comunicazione dei nodi intermedi per permettere lo scambio dei messaggi e dei pacchetti
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Lo standard ISO-‐OSI
23
Ogni livello aggiunge proprie informazioni di controllo che saranno considerate come dati dal livello sottostante
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Lo standard ISO-‐OSI
• Esempio di invio di un file
24
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Apparati di rete
• Le reti possono contenere altri elementi oltre ai calcolatori per migliorare l’efficienza e l’organizzazione della rete
• Hub (livello 1): ripetitore di segnale § Replica i bit in ingresso su tutte le interfacce in uscita § Collegamento tra segmenti di cavo
• Bridge/switch (livello 2): ripete i bit verso un’interfaccia § Bridge connette due reti § Switch collega un numero maggiore di reti § Esamina i dati inoltrando solo quelli che devono raggiungere l’altro cavo § Esegue modifiche sui dati trasmessi
• Router (livello 3): connette reti con tecnologie diverse • Proxy (livello 4): può analizzare i dati in transito
§ Esempio: antivirus, sistemi di autenticazione • Gateway (livello 7): interfaccia tra protocolli diversi
§ Collegamento tra reti dissimili § Esempio: la Webmail (legge i dati tramite IMAP e li visualizza tramite HTTP)
25
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Apparati di rete
26
26
WAN WAN
G
GG
G G
G
LAN B LAN LAN
B LAN
B LAN LAN
LAN-LAN WAN-LAN WAN-WAN LAN-WAN-LAN
Bridge (B): connessione tra reti locali
Gateway (G): connessione tra reti geografiche con caratteristiche
diverse
Host: macchine destinate all’esecuzione dei programmi
utente
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Apparati di rete
27
Applicazione
Presentazione
Sessione
Trasporto
Rete
Data Link
Fisico
Rete
Data Link
Fisico
Rete
Data Link
Fisico
Applicazione
Presentazione
Sessione
Trasporto
Rete
Data Link
Fisico
Nodo A Router Router Nodo B
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Sistema distribuito
• Il sistema distribuito è basato su una rete di calcolatori • Il sistema distribuito è dotato di un infrastruttura software
detta middleware che permette di coordinare le attività delle varie applicazioni e condividere le risorse § Implementa la pila di protocolli di comunicazione
• Il sistema distribuito esegue una serie di applicazioni logicamente indipendenti che cooperano per adempiere un obiettivo comune
28
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Paradigma client/server
• Il paradigma client/server è un modello di interazione tra processi che si suddividono in § Client
• Processo (attivo) che richiede l’esecuzione di servizi
§ Server: • Processo (passivo) che offre i servizi • Rimane in attesa delle richieste dei client
• Ogni server potrebbe aver richieste da più client
• Il server può agire a sua volta come client in un’interazione con un altro nodo e viceversa un client può agire da server
29
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Paradigma peer-‐to-‐peer
• Nel paradigma peer-‐to-‐peer non esiste una gerarchia precisa nella rete
• Tutti i calcolatori hanno lo stesso ruolo (possono agire sia da client che da server) e possono condividere le risorse software ed hardware
• Il vantaggio del paradigma peer-‐to-‐peer è la possibilità di distribuire il carico di lavoro
• Lo svantaggio è la complessità nella coordinazione tra le macchine
30
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Le componenti logiche di un’applicazione
• Un’applicazione (distribuita) è composta in genera da tre elementi (layer): § Presentazione: gestisce l’interazione con l’utente (front-‐end
dell’applicazione) § Logica applicativa: manipola i dati o gli input forniti dall’utente § Gestione dei dati: gestisce la persistenza dei dati, l’accesso, ecc.
31
Presentazione Logica applicativa Gestione dei dati
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Architetture 3-‐tiered
• Tier: Livello hardware (una macchina) su cui sono installati gli
strati software • Nel modello ideale il componente intermedio contiene tutta
la logica dell’applicazione (nei casi reali parte della logica applicativa può risiedere sul front-‐end e sul back-‐end)
• Vantaggi: flessibilità e scalabilità
32
Presentazione Logica applicativa
Gestione dei dati
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Server Farm
• Una server farm è un insieme di elaboratori sullo stesso livello del paradigma Client/Server, che condividono il carico elaborativo, le applicazioni e, eventualmente, i dati
• La server farm è gestita dagli altri livelli come un’unica risorsa
33
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Internet
• Internet è la più grande rete geografica che utilizza il protocollo TCP/IP § È una “rete di reti” § È composto da un grandissimo numero di risorse eterogenee
interconnesse sparse in tutto il mondo (calcolatori, reti, applicazioni, dati) che si basano sulla stessa pila di protocolli
§ Non è solo un collegamento fisico tra calcolatori, ma è anche un insieme di servizi
§ Il World Wide Web è solo uno di essi
• Intranet: le tecnologie e i servizi Internet sono utilizzate anche per la rete locale
• Extranet: connessione fra reti locali di diverse aziende
34
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Storia di internet
• Anni 70 – ARPANET § Una rete informatica del DARPA (Defence Advanced Research Project
Agency) dedicata a progetti di ricerca § Prima rete basata su scambio di pacchetti (50kbps) § Applicazioni: scambio file, terminale remoto § Una dozzina di nodi (connetteva principalmente università)
• Primi anni 80 – nascono alcune sotto-‐reti § MILNET: dedicata ad applicazioni militari § CSNET: dedicata a ricerche in ambito informatico – collega tutte le
facoltà universitarie in USA § Altre reti dedicate alla ricerca: HEPNET (fisica delle alte energie) e NSI
(NASA) • Fine anni 80
§ CSNET diventa Internet estendendosi ad applicazioni commerciali § Reti private: CompuServe e MCI
35
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Il protocollo TCP/IP
• TCP/IP è un insieme di protocolli usati per connettere calcolatori e reti fisiche diverse § Indipendenza dalla realizzazione fisica della rete § Nasconde i dettagli delle reti fisiche, gestendo il formato degli
indirizzi, il formato dei messaggi scambiati e le tecniche di trasferimento
• Il TCP/IP è nato prima dello ISO-‐OSI § I due standard sono leggermente diversi § TCP/IP ha due livelli § ISO-‐OSI ha sette livelli
36
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Confronto tra TCP/IP e ISO-‐OSI
37
I primi due livelli non sono definiti
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Livello di rete (IP)
• Internet Protocol (IP) opera a livello di rete • Consegna i pacchetti tra sorgente e destinazione • È connection-‐less
§ Non garantisce la corretta consegna dei pacchetti § Se necessario i livelli superiori rendono affidabile la consegna
• Due funzionalità principali: § Individuare quale è il calcolatore di destinazione § Instradare i pacchetti al nodo di destinazione attraverso nodi
intermedi
38
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Livello di trasporto (TCP e UDP)
• Questi protocolli (utilizzati uno in alternativa all’altro) creano un canale virtuale diretto tra due applicazioni nascondendo tutta la gestione in pacchetti della trasmissione dei dati
• Transmission Control Protocol (TCP) § Garantisce che i dati arriveranno a destinazione senza errori § Ritrasmette i pacchetti che sono stati persi
• User Data Protocol (UDP) § Meno affidabile del TCP: non ritrasmette i pacchetti persi § Offre prestazioni migliori
39
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Livello applicativo
40
World Wide Web
Invio messaggi di posta elettronica
Ricezione messaggi di posta elettronica
Trasmissione di video su Internet
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Indirizzi IP
• È una sequenza di cifre binarie che identifica un calcolatore in una rete § Analogo ai numeri di telefono § Per poter comunicare con un
calcolatore è necessario conoscere il suo indirizzo IP
• Gli indirizzi IP si suddividono in § Pubblici: quelli che identificano
un calcolatore su Internet § Privati: quelli che identificano un
calcolatore in una Intranet
41
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Nomi dei domini
• In indirizzo IP può essere associato ad un nome solitamente composto da 3 parti § Dominio di primo livello: identifica in genere la nazione § Dominio di secondo livello: identifica la società o l’ente § Nome host: il nome della macchina § Esempio: www.polimi.it
• I nomi dei domini sono organizzati in modo gerarchico • ICANN è l’ente che regola l’assegnamento
degli IP pubblici e dei domini di primo livello • Esiste un protocollo applicativo (DNS)
che permette risolvere l’indirizzo IP partendo dal nome del dominio
42
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
World Wide Web
• Nel 1989 Tim Berners-‐Lee, fisico del CERN di Ginevra, popone il progetto di un’interfaccia grafica ipertestuale denominata World Wide Web (WWW)
• Nel 1993 un gruppo di studenti del NCSA (National Center for Supercomputing Applications) dell’Università dell’Illinois realizza il primo browser Mosaic
• Nel 1994 Nasce la Netscape Comunications Coorp. che rilascia il primo browser commerciale Navigator. Solo nel 1996 Microsoft rilascia Internet Explorer
• Il World Wide Web è oggi un enorme deposito di informazioni accessibili attraverso Internet
• Per consultarle gli utenti necessitano di programmi di navigazione (browser), che utilizzano un’interfaccia di tipo point and click
• Le informazioni visualizzate dai browser sono ipertesti multimediali
43
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
World Wide Web
• Il Web utilizza tre meccanismi per realizzare la condivisione di materiale su Internet § URL (Uniform Resource Locator): permette di identificare in modo
univoco un documento su Internet § HTTP (Hyper Text Transfer Protocol): protocollo applicativo client/
server usato per accedere ai documenti § HTML (Hyper Text Markup Language): linguaggio per realizzare
ipertesti • Collegamenti tra le pagine • Modalità di visualizzazione del testo contenuto nella pagina
44
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Ipertesti
• Insieme di pagine Web (non necessariamente residenti sullo stesso server)
• Le pagine hanno una struttura ad albero • La pagina iniziale è detta homepage
45
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Architettura del Web
• Due attori: § Web browser: permette agli utenti di visualizzare le pagine Web § Web server: gestisce le pagine Web da mostrare agli utenti
• Due tipi di pagine: § Statiche: memorizzate nel file system del server § Dinamiche: costruite dinamicamente in base alle richieste dell’utente
e alle informazioni lette da un database ed eventualmente elaborate
46
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
URL
• Lo URL identifica in modo univoco una pagina Web § Schema: protocollo utilizzato per interagire con il server
(generalmente HTTP) § Host: Nome del computer su cui risiede la pagina § Percorso: identifica il percorso ed il nome della pagina all’interno del
computer
47
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Interazione tra browser e web server
1. L’utente inserisce l’URL della pagina da visualizzare 2. Il browser invia la richiesta HTTP al server 3. Il server invia la pagina richiesta al browser e chiude la
sessione HTTP 4. Il browser riceve la pagina HTML e la visualizza
48