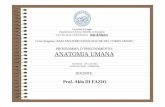Il Sistema Uditivo
-
Upload
matteo-cozzi -
Category
Documents
-
view
218 -
download
2
description
Transcript of Il Sistema Uditivo
Il sistema visivoIl sistema visivo il sistema che permette alluomo di percepire coscientemente gli stimoli luminosi. Lorgano di senso della vista locchio, che sul fondo ha la retina, una membrana cosparsa di fotorecettori che trasformano il segnale luminoso in impulso bioelettrico. Gli assoni di queste cellule formano il nervo ottico, il secondo nervo cranico, che ha una decussazione parziale a livello del chiasma ottico (vengono cio incrociate le fibre nervose provenienti delle emiretine nasali), e prosegue nel tratto ottico fino a raggiungere il corpo genicolato laterale e da l andare nella corteccia visiva primaria.Integrazione visuomotoria e percezione dei gestiCi sono numerosi studi in letteratura che dimostrano come alcuni stimoli visivi possano indurre unattivazione delle aree premotorie della corteccia umana.Ad esempio gi nello studio di Martin e collaboratori del 1996, utilizzando la PET, hanno notato come limmaginazione di movimenti della mano attivava il giro temporale medio di sinistra (area MT), attivato anche nella generazione di parole che implicano azioni. Uno studio pi recente di Kourtzi e Kanwisher (2000) ha usato la fMRI per vedere quali aree cerebrali sono attivate durante la visione di immagini che implicano un movimento, e ha trovato che viene attivata larea MT. Questi esempi ci dicono che le regioni coinvolte nellanalisi del movimento sono attive anche nel processamento di immagini statiche che solo implicitamente contengono un movimento. Altri studi presenti in letteratura riportano attivazioni anche in altre aree deputate ad una integrazione visuomotoria. il caso di Iacoboni, che nel suo articolo del 2003 utilizzando un paradigma di target ridondante con la fMRI trova che il solco intraparietale di destra unarea di cruciale importanza nella facilitazione della risposta durante un processamento parallelo dellinformazione visuomotoria. In questo studio i soggetti dovevano premere un tasto (in alcune sequenze con la mano destra e in altre con la sinistra) non appena vedevano un flash di luce, che poteva essere a sinistra, a destra oppure bilaterale (costituendo un target ridondante appunto). IMMAGINE SPL DA DESKTOPNello studio del 2006, Glover et al hanno chiesto ai soggetti di afferrare il cilindro illuminato dei due (di misure diverse) che avevano davanti. Mentre svolgevano questo compito veniva usata una TMS a impulsi ripetuti sul solco intraparietale di destra, per perturbare questarea. In alcuni casi il cilindro illuminato veniva cambiato, per indurre aggiustamenti rispetto ad un movimento gi iniziato. Quando la perturbazione veniva fatta entro un tempo breve dallinizio del movimento di apertura della mano (entro i 350ms) veniva perturbato il movimento di aggiustamento da target piccolo a quello grande, ma non viceversa; quando invece la perturbazione TMS veniva fatta pi tardi (intorno ai 450ms) si aveva una situazione invertita, cio era perturbato laggiustamento dal target grande a quello piccolo e non viceversa. Questo esperimento ci suggerisce che questarea ha anche un ruolo di controllo durante lesecuzione del movimento, con feedback continui tra il sistema visivo e il sistema motorio per aggiustare la posizione del nostro corpo nello spazio.Un articolo di Johnson-Frey et al del 2005 composto da due studi fMRI per esplorare le regioni coinvolte nella pianificazione dei gesti rispetto a quelle coinvolte nellesecuzione degli stessi, utilizzando in una condizione la mano dominante ed in unaltra la mano non dominante. I risultati ci indicano come una complessa rete nellemisfero sinistro, composta dal solco temporale posteriore, la corteccia premotoria frontale e ventrale, il giro sopramarginale, il giro angolare e la corteccia prefrontale dorsolaterale costituiscono un network attivo nei compiti di pianificazione dei gesti. Per lesecuzione le aree sono le medesime a parte la corteccia prefrontale dorsolaterale. Queste aree a sinistra sono sempre attivate a prescindere dalla mano che viene mossa.
Altri studi che hanno usato tecniche e metodologie diverse (Dijkerman, 2007; N. Oosterhof, 2010) giungono alle medesime conclusioni.Lo studio di Colzato (2006), che presenta una sorta di paradigma di Posner mediata da immagini connotate da emozioni positive o negative, ci dimostra che lestrazione di caratteristiche visive riguardanti la forma dello stimolo mediata dalle emozioni, mentre le emozioni non giocano nessun ruolo in risposta alla posizione o al colore degli stimoli. In particolare la visione di unimmagine con unemozione negativa aumentava i tempi di reazione sia nella condizione di posizione ripetuta che di posizione alternata, mentre le immagini connotate da unemozione positiva riducevano i tempi di reazione dei soggetti anche qui in entrambe le condizioni.
Andando a vedere le evidenze neuroscientifiche per lanalisi del gesto un imponente studio di Hermsdrfer del 2001 ci da molte risposte. Utilizzando la PET e chiedendo ai soggetti di dire se due immagini di persone che compivano gesti senza senso fossero uguali tra loro o no Hermsdrfer ha notato che lattivit cerebrale durante questo compito era fortemente lateralizzata a sinistra, con un picco sullarea parietale inferiore.La discriminazione dei gesti delle dita attiva un pattern di aree pi bilaterale, che comprende il solco intraparietale di destra e le aree di Broadmann 18 e 19, aree visive associative. Questi dati, in accordo con la neuropsicologia, ci dimostrano che lemisfero destro importante per la codifica dei gesti senza un significato, mentre lanalisi della posizione delle dita richiede in aggiunta unanalisi visiva pi precisa, resa possibile dallattivit delle aree sopracitate dellemisfero destro.IMMAGINE FINGER GESTURE VS CONTROLSLo studio di Kellenbach del 2003, compiuto mediante lutilizzo della PET, ci fa vedere quali aree cerebrali si attivano durante luso di oggetti conosciuti (come un martello) rispetto alle aree attivate verso artefatti umani non manipolabili (ad esempio le luci del traffico). Notiamo come si attivi una vasta rete lateralizzata a sinistra, che comprende la parte ventrale della corteccia premotoria, la parte posteriore del giro temporale medio, e il solco intraparietale (AIP).Un recentissimo studio di Weaver (2015) sui macachi getta luce sulla specifica funzione del solco intraparietale: combinando una microstimulazione elettrica e utilizzando una fMRI la Weaver ha trovato che la parte posteriore del solco intraparietale di importanza cruciale per la convergenza della via dorsale e ventrale della visione, deputate rispettivamente nella localizzazione della posizione e nellidentificazione degli oggetti. Stimolando la parte anteriore del solco intraparietale porta ad un aumento nellattivit neurale nella rete di aree somatosensoriali e motorie impegnate nel compito di presa, mentre una stimolazione posteriore del solco intraparietale aumenta lattivit nelle aree cerebrali deputate al riconoscimento degli oggetti. Probabilmente quindi linformazione passa dalla parte posteriore dellAIP verso la parte anteriore e da l verso le aree somatosensoriali e motorie.Altri studi sulla scimmia hanno avanzato lipotesi che un deficit dellarea omologa per luomo dellAIP nei macachi sia coinvolta nellaprassia, cio nella difficolt o nellincapacit di compiere in maniera corretta movimenti volontari in assenza di disordini neurologici di altro tipo (ad esempio motori o sensitivi). Nello studio di Gallese et al del 1997 gli scienziati hanno osservato che i macachi avevano deficit motori che esitavano in grande difficolt nel comportamento di grasping dopo aver subito delle iniezioni di anestetico nellAIP. Un altro studio di Binkofski del 1998 ha studiato 3 pazienti con una lesione focale nella parte anteriore del solco intraparietale, che avevano deficit specifici nella coordinazione dei movimenti delle dita durante la prensione degli oggetti. Binkofski ha fatto replicare il medesimo movimento in 5 soggetti sani, e la scansione tramite una fMRI ha mostrato una forte attivazione della stessa area, che evidentemente responsabile del controllo del movimento fine delle dita. Questo studio suggerisce che la parte pi anteriore e laterale del solco intraparietale costituisce lomologo dellarea intraparietale anteriore implicata nellintegraione sensomotoria nei macachi.
Il sistema uditivoQuello uditivo un sistema che capace di produrre una sensazione cosciente per lindividuo dei suoni che arrivano alle nostre orecchie e l vengono trasformato in segnali bioelettrici che raggiungono il cervello. Il trattamento delle informazioni uditive per complesso, e si verifica su pi livelli. Il primo stadio rappresentato dalla coclea, un canale a spirale riempito di fluido presente nellorecchio interno, che a sua volta divisa in tre distinte strutture, denominate scale: la scala vestibolare, quella media e quella timpanica. Queste strutture sono separate da 3 membrane: lelicotrema tra la scala vestibolare e quella timpanica, mentre la membrana di Reissner e la membrana basilare fanno da pareti alla scala media. La pi importante per noi in questa sede la membrana basilare, su cui poso lorgano del Corti, che lorgano deputato alla trasduzione dellimpulso vibrazionale in impulso bioelettrico. LOrgano del Corti composto da una serie di cellule ciliate (che sono in grado di causare una depolarizzazione della loro struttura alla loro flessione) sono disposte lungo tutta la lunghezza della coclea, la cui struttura a spirale fa s che le onde sonore complesse vengano naturalmente divise nelle loro costituenti fondamentali (come si fa in ingegneria applicando la Trasformata di Fourier). Per un processo di tipo fisico quindi nella parte iniziale di questo tubicino si infrangono le onde semplici di frequenza alta (fino ai 20000Hz), mentre nella parte finale i suoni con frequenza pi bassa (fino ai 20Hz). I segnali vengono poi convogliati nella parte cocleare nel nervo vestibolococleare, lottavo nervo cranico, per poi andare nelloliva superiore (stazione binaurale che serve per rilevare le differenze di tempo tra i suoni uditi dalle due orecchie, conseguenza quindi della posizione del suono), al lemnisco laterale, al collicolo inferiore, al talamo e poi alla corteccia uditiva primaria, localizzata nella circonvoluzione temporale superiore posteriore di sinistra (BA 41, 42 e 22).Integrazione audiomotoriaIl sistema uditivo non un sistema chiuso: ci sono studi in letteratura che ci dimostrano come uno stimolo uditivo possa elicitare unattivazione motoria. Ad esempio Hauk (2006) ci presenta un interessante esperimento nel quale ha indagato questo processo: partendo dallidea che stimoli sonori ad alta frequenza duso potessero elicitare unattivazione motoria corticale ha creato un set di stimoli utilizzando schiocchi di dita e di lingua, ed un altro set di stimoli bilanciati per caratteristiche fisiche ma che non erano riconducibili ad alcuna azione. Utilizzando la tecnica degli ERP in un paradigma di Mismatch Negativity ha osservato (tra le altre cose) che la localizzazione della MMN elicitata dagli schiocchi di dita e di lingua era diversa da quella degli altri suoni. In particolare Hauk e i suoi collaboratori hanno notato andando a fare una modellizzazione del dipolo (con la sottrazione della condizione Suoni umani-controlli) che gli schiocchi di dita andavano ad attivare larea motoria della mano nellemisfero associato alla mano dominante del soggetto, mentre gli schiocchi di lingua attivavano una porzione pi inferiore dellarea motoria, proprio in corrispondenza dellarea deputata al movimento della lingua. In un altro studio Aziz-Zahed (2004) ha indagato usando la TMS come lascolto di suoni associati ad azioni (come piegare o strappare un foglio di carta, oppure camminare) modulassero leccitabilit della corteccia motoria rispetto a suoni neutri (un tuono). I risultati sono stati che hanno ottenuto contrazioni muscolari pi intense nellarea motoria primaria della mano mentre i soggetti ascoltavano i suoni legati alluso di quellarto. In uno studio del 2005 Pizzamiglio e i suoi collaboratori hanno messo a punto un paradigma ERP per vedere se i suoni che potessero essere prodotti dallascoltatore potessero attivare aree cerebrali diverse rispetto ai suoni che lascoltatore non potrebbe riprodurre utilizzando un paradigma di priming semantico e sfruttando la repetition suppression. La parola prime veniva presentata sullo schermo (ma solo per 33ms, in modo da non avere una percezione cosciente), e poteva essere semanticamente congruente col suono che la seguiva o incongruente. Ai soggetti veniva chiesto di premere un tasto se il suono poteva essere prodotto da un essere umano (come quello del battito di mani) oppure un secondo tasto se il suono non poteva avere origine umana (come quello dellacqua che bolle).La localizzazione dei dipoli ci fa vedere come per i suoni non umani le aree attivate sono prevalentemente la punta del lobo temporale bilaterale, i suoni che si possono emettere con le mani attivano un dipolo nel solco temporale superiore dellemisfero sinistro e un secondo dipolo nella corteccia premotoria di sinistra ed i suoni che si possono emettere con la bocca attivano sempre il STS di sinistra e la corteccia premotoria di sinistra, in una posizione pi inferiore, compatibile con la posizione della bocca nellorganizzazione somatotopica della corteccia motoria.Questi studi ci fanno vedere come il sistema mirror ha un ruolo importante nellidentificazione delle categorie di suoni che attivano una rappresentazione di unazione necessaria a produrli. Questo dato in accordo con quanto trovato da Kohler con Gallese e Rizzolatti nel 2002 in uno studio sui macachi. Il team ha trovato un gruppo di neuroni nella corteccia premotoria della scimmia che si attiva quando lanimale esegue unazione, sente il suono ad essa correlato oppure osserva la stessa azione.
BibliografiaGallese V., Fadiga L., Fogassi L., Luppino G., Murata A., A parietal-frontal circuit for hand grasping movements in the monkey: evidence from reversible inactivation experiments. In: Their P. Karnath Ho editors. Parietal lobe contributions to orientation in 3D space. Berlin: Springer; 1997. P.255-70