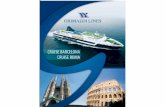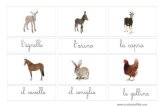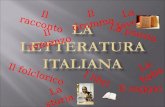Il semipresidenzialismo
Transcript of Il semipresidenzialismo

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 1/29
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMOFACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
CORSO DI LAUREA IN RELAZIONI E POLITICHE INTERNAZIONALI
IL SEMIPRESIDENZIALISMO
La v° repubblica francese, le altre esperienze europee e un tentativo di analisicritica
Docente Studenteprof.CLAUDIO RIOLO NICOLA PALILLA
ANNO ACCADEMICO 2003-2004

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 2/29
I RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Ogni qualvolta abbiamo menzionato Ceccanti, Massari e Pasquino ci siamo riferiti a“Semipresidenzialismo”, il Mulino, 1996.Quando abbiamo menzionato Fabbrini e Vassallo ci siamo riferiti a “ Il governo, gli esecutivi
nelle democrazie contemporanee”, Editori Laterza, 1999.Quando ci siamo richiamati al solo Fabbrini abbiamo tratto da “ Le regole dellademocrazia.Guida alle riforme”, Editori Laterza, 1997.A proposito di Sartori abbiamo consultato “ Ingegneria costituzionale comparata”, il Mulino,1998.Per quanto riguarda la citazione di Pitruzzella “ Forme di governo e trasformazione della
politica”, il Mulino, 1996.

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 3/29
Introduzione
Da anni in Italia si fa un gran parlare di riforme istituzionali per risolvere il cronico problema
dell’instabilità ministeriale: nella complessa società odierna, infatti, il frequente ricambio di
governo è visto negativamente, da cui il termine spregiativo instabilità, perché tale fenomeno non
consente un’adeguata programmazione e attuazione di politiche di lungo respiro, generando così
ritardi ed inefficienze. Instabilità è, ancora, sinonimo di deriva assembleare, vale a dire di
prevalenza non tanto dell’organo legislativo su quello esecutivo, su cui c’è poco da dire, quanto di
partitocrazia, di istituzioni, cioè, in balia dei capricci, della logica spartitoria e delle strategiche
incoerenze delle fazioni politiche organizzate, cosicché il governo si configura più come un osso
da spolpare – consentiteci l’espressione – piuttosto che un mezzo di organizzazione democratica e
funzionale delle risorse. È proprio per far fronte a tale problema, che ha prodotto cinquantasei
governi e ventiquattro presidenti del consiglio in cinquantotto anni di repubblica, che il dibattito
sulle forme di governo nel nostro paese si richiama alle felici esperienze straniere. Anche se la
gran parte degli attori politici nostrani appare oggi maggiormente incline a sostenere una forma di
governo parlamentare ben razionalizzata, quando non addirittura neo-parlamentare, il modello
della V° repubblica francese miete ancora molti consensi non solo presso alcuni gruppi politici, ma
pure tra parecchi autorevoli studiosi della politica. Nel primo caso si tratta del suggestivo richiamo
esercitato dall’elezione diretta di un capo dello stato ben munito in quanto a prerogative e capace
di incarnare il popolo che lo ha eletto a proprio leader incontrastato; nel secondo, invece, della
notevole stabilità e continuità governativa conseguita a partire da condizioni di frammentazione
estrema. Bene, il semipresidenzialismo è davvero un modello da seguire? Con il nostro lavoro
cercheremo di spiegare perché la risposta alla domanda potrebbe essere positiva con l’illustrazione
delle virtù e dei meriti di questa forma di governo e perché, invece, è anche passibile di un’analisi
critica.

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 4/29
Il semi-presidenzialismo
Il semi-presidenzialismo è quella forma di governo che solitamente viene definita la via di mezzo
fra il parlamentarismo ed il presidenzialismo, giacché è imperniata su di un presidente della
repubblica, eletto direttamente o come se direttamente (usando un’espressione di Giovanni Sartori)
dai cittadini, a cui sono devoluti consistenti prerogative, attutite, tuttavia, dalla presenza di una
figura tipica dei regimi parlamentari e assente in quelli presidenziali: il primo ministro.
A voler essere schematici per motivi di semplificazione, potremmo elencare i maggiori poteri del
presidente della repubblica nel modo seguente, anche se l’elenco non è comprensivo di tutte le
esperienze:
• nomina il primo ministro e, su proposta di questi, i ministri;
• presiede il consiglio dei ministri;
• può licenziare il primo ministro e tutto il governo;
• può sciogliere il parlamento;
• ha una notevole influenza in politica estera e militare;
• è capo delle forze armate;
• può assumere poteri eccezionali.
Dall’elenco proposto si ricava che il presidente di una repubblica semipresidenziale gode di tutti i poteri di un suo omologo parlamentare, ma ha in più la capacità di influire fortemente sulla
composizione e sull’azione del governo, nonché, ma questo non si evince dall’elenco, di sciogliere
con una maggiore discrezionalità il parlamento. A tutto ciò si aggiunga che l’elezione a suffragio
universale attribuisce al presidente un surplus di legittimità davvero considerevole.
In una repubblica semipresidenziale, quindi, il presidente è il capo dello stato ma non
simultaneamente capo del governo, in quanto vige l’obbligo di condividere il governo con un
primo ministro posto alla guida del governo stesso.
La figura del primo ministro condiziona inevitabilmente lo stesso capo dello stato, poiché se è
praticamente certo, lo dimostra l’esperienza francese, che il presidente prevale sul premier quando
dispone di una maggioranza in parlamento a suo favore, la stessa cosa non può dirsi se l’assemblea
elettiva esprime un orientamento avverso a quello presidenziale: in questi contesti, infatti, il
presidente è costretto alla coabitazione, cioè a rinunciare all’esercizio di molti dei suoi poteri
costituzionalmente sanciti. Tutto ciò ha indotto gli studiosi a parlare di una struttura dell’esecutivo
flessibile costituito da due teste (Duverger lo definì simbolicamente un’aquila a due teste) in cui la
primazia è determinata dalle combinazioni maggioritarie (Sartori), vale a dire da chi consegue la

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 5/29
maggioranza dei seggi all’assemblea legislativa. L’esecutivo semipresidenziale è, dunque, una
sorta di diarchia.
In cosa consiste precisamente la coabitazione? Consiste nel fatto che il presidente della repubblica,
avendo perduto la sua maggioranza in parlamento, si vede costretto a nominare come suo primo
ministro il suo (suo altrettanto) più diretto avversario: in Francia questa eventualità si è verificata
tre volte negli ultimi vent’anni. La prima volta avvenne nel 1986, quando la maldestra riforma
elettorale in senso proporzionalista voluta dal presidente François Mitterrand non impedì ai neo-
gollisti di Jacques Chirac di ottenere la maggioranza assoluta dei seggi all’Assemblea Nazionale, e
si concluse nel 1988; la seconda avvenne tra il 1993 e il 1995 e vide protagonisti nuovamente
Mitterrand con il gollista Balladur; la terza, la più lunga, dal 1997 al 2002, ha trovato Chirac
stavolta nei panni del presidente e il socialista Jospin quale primo ministro .
La coabitazione risolve il problema del governo diviso tipico dei regimi presidenziali, visto che
esiste sempre un governo stabile in grado prima di prendere decisioni e poi di applicarle a dovere
grazie al sostegno della sua maggioranza parlamentare.
Se è sicuramente vero che i rapporti tra presidente e primo ministro non sono idilliaci quando c’è
coabitazione, è comunque possibile osservare l’innesco di un meccanismo spontaneo di
autolimitazione delle parti che consente ai due di convivere, visto che nessuno dei due vuole
apparire distruttivo all’opinione pubblica, fondamentalmente, per lo stesso scopo: il presidente
aspira alla rielezione, il premier alla successione .
In questo calcolo tutt’altro che disinteressato, infine, a guadagnarci è il sistema, che continua a
funzionare in modo efficiente e a garantire una solida leadership e la stabilità al paese .
In ogni modo, le competenze tra i due protagonisti appaiono ben marcate, sì da ridurre al minimo il
rischio di paralisi del sistema: il premier dirige l’azione di governo specie in materia di politica
interna ed economica, mentre il presidente gode di un domaine reservé sulle questioni inerenti la
difesa e gli affari esteri.
La flessibilità del semipresidenzialismo alimenta un grande dibattito a cui partecipano, tra gli altri,
oltre che Sartori, anche Duverger da un lato e Shugart e Carey dall’altro.
Per il primo, il semipresidenzialismo non sarebbe una sintesi tra sistema parlamentare e sistema
presidenziale, ma un avvicendamento tra fasi presidenziali e fasi parlamentari: il potere di governo
passerebbe, quindi, dal presidente al primo ministro sulla base di chi vince le elezioni
parlamentari.
Questa posizione è contrastata da Sartori perché le due fasi suddette non si verificano mai se è vero
che il presidente non governa mai senza primo ministro e che, in ogni caso, conserva sempre dei

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 6/29
poteri maggiori rispetto ad un suo collega europeo. Inoltre, l’idea del trasloco dei poteri fa venire
meno la stessa nozione di sistema.
Per i secondi esistono due tipologie di semipresidenzialismo, quello a regime premier-
presidenziale e quello a regime presidenziale-parlamentare, nei quali, rispettivamente, il primo
ministro prevale sul presidente e, inversamente, il presidente supera il primo ministro. Sartori
giustamente osserva che i paesi in cui il premier prevale sul presidente sono da considerarsi
parlamentari a prescindere dall’elezione diretta del secondo.
Prima di procedere ad un’analisi specifica del più importante caso di semipresidenzialismo, quello
francese, buona cosa ci sembra fornire una sintetica definizione di cosa s’intende per
semipresidenzialismo ricorrendo, in qualche modo, a Giovanni Sartori (per l’ennesima volta): si
tratta di una forma di governo in cui il presidente della repubblica viene eletto direttamente, o
come se direttamente, dal popolo per un periodo prestabilito e senza che vi sia la possibilità di
procedere ad una sua sostituzione in corsa e in cui, seppur disponendo di rilevanti poteri, il
presidente non può governare senza un primo ministro, da lui autonomo nella misura in cui questi
è legato al parlamento.
Tutto ciò ci fornisce, lo ribadiamo, l’idea di una diarchia.

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 7/29
Il modello francese
Facendo un rapido paragone con le passate costituzioni francesi di tipo parlamentare, è facile
accorgersi che nel testo della V° repubblica l’ordine in cui le istituzioni vengono presentate risulta
capovolto, poiché si affrontano subito le prerogative del capo dello stato con il titolo II, formato da
quindici articoli (5-19); si passa poi a trattare del governo in soli quattro articoli (20-21-22-23)
raggruppati nel titolo III; mentre solo in seguito, è il titolo IV, si tratta del parlamento a cui la
Costituzione dedica dieci articoli (24-33). Importantissimo appare, inoltre, il titolo V sui rapporti
tra parlamento e governo in cui su tutti affiora l’articolo 49 sulla responsabilità del governo.
Per portare a termine la nostra analisi ci sembra opportuno soffermare la nostra attenzione su
alcuni articoli costituzionali.
Secondo l’articolo 8 il presidente nomina senza consultazioni il primo ministro e, su proposta di
questi, gli altri ministri, per cui se egli è il leader della maggioranza all’Assemblea Nazionale,
unica camera elettiva, nominerà una persona fidata che, politicamente parlando, sia di “secondo
piano” in modo da potervi esercitare un certo ascendente. In questi casi, l’esperienza lo dimostra,
si ritiene che il capo dello stato abbia anche il potere di licenziare il primo ministro, nonostante
non sembri che questo potere gli sia stato riconosciuto dal testo costituzionale. Nel caso in cui,
invece, il presidente sia costretto a coabitare, nulla egli può contro un premier di colore politico
opposto nominato perché non c’era altra scelta: stavolta il primo ministro è il leader espresso
(implicitamente) dall’Assemblea Nazionale e il presidente non può chiedere di lui le dimissioni (e
nessun potere ha il presidente per rimuoverlo, tranne l’articolo 16), così come non può attivare il
potere di scioglimento e quello di indire referendum legiferando parallelamente al governo.
Tuttavia, è il successivo articolo, il nono, ad assegnare allo stesso presidente della repubblica il
compito di presiedere il consiglio dei ministri: inutile dire che questo potere lo colloca al di sopra
di un qualunque presidente parlamentare, perché presiedere un’assemblea implica il potere di
stabilire l’ordine del giorno, l’ordine degli interventi, le priorità. In poche parole, al presidente è
attribuito il potere d’agenda.
L’articolo 11 è relativo al referendum che il presidente può convocare per le riforme inerenti
l’organizzazione dei poteri pubblici. De Gaulle fece frequentemente uso di tale articolo, per
esempio per l’autonomia dell’Algeria, e a volte anche ai limiti della legalità costituzionale, come
per introdurre l’elezione diretta del capo dello stato (una riforma costituzionale), ma egli stesso finì
poi vittima del suo più amato strumento costituzionale. Il referendum francese non è abrogativo,
anzi, se usato diligentemente, è la più genuina manifestazione della sovranità popolare. Si tratta di
un potere talmente importante e su cui non si osa discutere molto, che la riforma costituzionaleapprovata in congresso da deputati e senatori nel 1995 a Versailles, con cui si estendono i poteri

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 8/29
referendari del presidente anche a materie attinenti temi economici e sociali, è stata approvata con
674 voti favorevoli e 178 contrari (la grande maggioranza gollista conquistata alle elezioni del
1993 all’Assemblea Nazionale non giustifica da sola il successo della proposta). Il moderato
ricorso a tale strumento dopo la presidenza De Gaulle è forse più dovuta alla paura dei partiti del
dissenso popolare (ricordando le conseguenze che tale dissenso provocò in De Gaulle) che alla
tendenziale parlamentarizzazione del sistema (di questo si parlerà meglio in seguito).
L’articolo 12 tratta del potere di scioglimento dell’Assemblea Nazionale, potere riconosciuto
esclusivamente al capo dello stato senza controfirma alcuna e con l’unico, labile, limite di una
consultazione del primo ministro e dei presidenti delle camere; vige anche il divieto di dissolvere
un’assemblea prima che sia trascorso un anno dalla sua elezione. Quando il presidente è il leader
della maggioranza parlamentare, la decisione di attivare detto potere è puramente discrezionale,
rispondendo alla necessità strategica di anticipare le elezioni in un momento favorevole al
governo. In circostanze diverse, invece, lo scioglimento ha lo scopo di stabilizzare un parlamento
frammentato, per il quale a volte è sufficiente la sola minaccia della dissoluzione; infine, in caso di
coabitazione l’articolo 12 è attivabile solo nel caso (assai improbabile e mai accaduto) in cui si
verificasse una crisi di governo oppure ancora (e questa è l’eventualità che ricorre) all’indomani
della rielezione del presidente.
L’articolo 16 consente al presidente di assumere poteri speciali di consistenza indefinita e di durata
praticamente illimitata. Questa prerogativa, dettata all’epoca in cui la Costituzione fu scritta dalla
crisi algerina, consegna al capo dello stato un potere senza uguali nel mondo intero, anche perché
frutto di una decisione, ponderata sì, ma pur sempre relativa esclusivamente alla sua sfera
discrezionale. Infatti, il presidente deve solo consultare il primo ministro e i presidenti delle
camere, oltre che informare la nazione della sua decisione, non essendo richiesta, nemmeno questa
volta, la controfirma ministeriale.
Un altro importante articolo è il 52 che, insieme al 53, assegna al capo dello stato notevoli poteri in
materia di politica estera, avendo egli il potere non solo di ratificare i trattati internazionali, ma
addirittura di negoziarli. Infine, l’articolo 89 consente al presidente di partecipare al processo di
revisione costituzionale in modo attivo.
Fin qui ci siamo occupati degli articoli attinenti alle competenze del capo dello stato; cosa buona
appare concentrarsi su quelli relativi al gouvernement. Come ci insegna Stefano Ceccanti, se il
titolo II è il risultato delle idee di De Gaulle, il fondatore della V° repubblica, i titoli successivi,
soprattutto il III ed il V, sono opera di Michel Debré, il capo della commissione che redasse la
Costituzione. Fu proprio Debré, infatti, guardando al parlamentarismo maggioritario, a voler specificare all’articolo 20 che è il governo a determinare e guidare la politica della nazione,

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 9/29
potendo disporre dell’amministrazione e delle forze armate, e con il 21 che è il primo ministro a
dirigere il governo. L’esecutivo, ancora, alla lettera dell’articolo 34, nei limiti cioè dei principi
generali stabiliti della legge, e secondo il disposto dell’articolo 37, vale a dire nel dominio non
riservato dalla Costituzione alla legge, può emanare regolamenti, il cui contenuto è quindi sottratto
dal controllo parlamentare dei partiti; l’articolo 38 consente al governo di emanare ordinanze (una
sorta di decreto-legge italiano).
Gli articoli 42 e 48 attribuiscono al governo il potere di incidere profondamente sull’agenda delle
camere ed il 44 limita la capacità di emendamento dei disegni di legge governativi al solo
dibattimento in aula.
In conclusione, gli articoli 44 e 49. Il primo istituisce il cosiddetto “voto bloccato” che consente al
governo di chiedere l’approvazione di una legge senza le parti controverse o munita solo degli
emendamenti accolti o proposti dal governo stesso; il secondo disciplina il modo in cui far valere
la responsabilità governativa di fronte all’Assemblea Nazionale: una mozione di sfiducia deve
dapprima essere sostenuta da almeno un decimo dei suoi membri; è necessario che essa venga
approvata non prima delle quarant’otto ore successive alla presentazione; infine, deve essere
approvata dalla maggioranza assoluta dei seggi dell’assemblea. Su deliberazione del consiglio dei
ministri, il primo ministro può engager la responsabilità del governo su di un particolare testo,
cioè chiedere una sorta di “fiducia negativa” per cui, se nelle successive quarant’otto l’Assemblea
Nazionale non vota a favore di una mozione di sfiducia, il provvedimento in questione si considera
approvato (questa è la famosa ghigliottina).

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 10/29
Origine della V° repubblica francese e sua evoluzione
La Costituzione della V° repubblica francese nasce in un contesto storico del tutto eccezionale.
Dopo aver perduto la guerra d’Indocina, la Francia, seppur dolorosamente, decise di smembrare il
suo impero coloniale; nondimeno, l’Algeria, ormai divenuta una specie di grande regione francese
in terra d’Africa, costituiva un serio problema.
L’Algeria, infatti, era stata la prima pietra dell’impero coloniale francese, il secondo al mondo
dopo quello inglese, essendo stata occupata a partire dal 1830; ospitando, ormai, circa un milione
di francesi che da generazioni lì vivevano e producevano ricchezza, quella terra non era più
considerata come una semplice colonia: anche l’Algeria era Francia, per i francesi. Ad aggravare
lo stato delle cose ci pensava, tra le altre cose, la recente scoperta di ingenti risorse di gas naturali.
Per l’opinione collettiva l’Algeria era divenuta Francia e abbandonarla avrebbe significato
disgregare la Patria stessa: la Storia, tuttavia, aveva preso la sua decisione.
Le istituzioni della IV° repubblica erano ancora più deboli di quelle della III°; i governi erano
ancora più instabili ed impotenti, i partiti più divisi ed incompatibili.
Inoltre, la IV° repubblica era nata senza gloria (al referendum che ne approvò la costituzione
parteciparono solo x milioni di elettori), ma era destinata a finire peggio, perché aveva perduto
l’Indocina e si apprestava a perdere anche l’Algeria.
La crisi d’identità e di programmi che colpì le potenze europee vincitrici della seconda guerra
mondiale pose la Francia in bilico tra chi sosteneva la necessità di conservare l’impero secondo
un’idea che, ormai, appariva antistorica e chi ne auspicava l’ordinata dissoluzione in nome della
nuova aspirazione alla libertà di tutti i popoli. Questa crisi rese ancora più fragili i governi che
cambiavano, praticamente, ogni tre mesi sotto la violenza terroristica del FLN (Fronte di
liberazione nazionale).
La situazione precipitò ad un punto di non ritorno quando, in seguito all’uccisione di tre soldati
francesi in servizio in quella terra, i militari reagirono organizzando un Comitato di Salute
Pubblica alla testa del quale si pose il generale Massu al grido di: Vive De Gaulle! (De Gaulle era
il carismatico generale che aveva condotto la resistenza contro i nazisti).
I militari pensavano, infatti, che il Generale, fuori da anni dalla vita pubblica, avrebbe potuto
instaurare un governo-regime in grado di affrontare con energica decisione la questione d’Algeria,
assecondando, così, le aspettative dei militari.
Il grido di Massu fu così forte che a Parigi il Presidente René Còty (temendo il colpo di stato) fu di
fatto costretto a chiamare al governo proprio Charles De Gaulle in occasione dell’ennesima crisi di
governo (si trattava del governo Pflimlin).

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 11/29
De Gaulle accettò, ma presidente e parlamento dovettero accettare le sue condizioni: che fosse
costituita una commissione per la scrittura di una nuova costituzione e modificato il processo di
revisione costituzionale; che fossero sciolte le camere; che gli fossero concessi pieni poteri per sei
mesi.
Comunque, anche il Generale dovette accogliere le condizioni di presidente e parlamento, tra le
quali il rispetto del principio della separazione dei poteri e la responsabilità del governo davanti
alle Camere .
Il governo di De Gaulle fu, per così dire, un governo costituente: solo Napoleone aveva osato
tanto!
La costituzione che da lì a poco verrà approvata per referendum è quella di cui abbiamo già scritto:
allora, perché questo richiamo alla storia? La costituzione della V° repubblica, soprattutto negli
anni settanta e ottanta, è stata al centro di numerosi studi, giacché essa appariva di non facile
comprensione ed interpretazione: chi la considerava una sorta di dittatura elettiva e chi la
considerava una repubblica parlamentare usurpata. Come risolvere tale dubbio? Non possiamo non
ricorrere alla storia perché: “le forme di governo sono dei modelli (…) i quali evidenziano alcuni
elementi ritenuti caratterizzanti il tipo e ne definiscono la logica intima e le implicazioni che per coerenza
devono ricavarsi da esso. I modelli sono delle astrazioni che in nessun caso possono aderire alle specifiche
fattispecie storiche in cui essi si trovano realizzati. La forma di governo storicamente presente in un
determinato Stato è infinitamente più ricca del modello ed il suo concreto assetto dipende” da uncomplesso di variabili tra le quali la cultura politica, il sistema politico, le teorie costituzionali
dominanti, la rappresentanza politica, i caratteri del popolo (Pitruzzella).
Questa citazione di Pitruzzella ci permette di capire che vi è sempre una tendenza alla
differenziazione tra quanto scritto su di una costituzione (e la teoria a cui i costituenti si ispirarono)
e ciò che realmente si verifica per effetto della sua applicazione e dei condizionamenti provenienti
dal mondo esterno: le variabili suddette possono nei fatti rendere una forma di governo idealtipica
in qualcos’altro. L’imprevedibilità di alcune realtà, il malfunzionamento di altre e le difficoltà neldefinirne altre ancora è spiegabile, allora, solo dall’osservazione delle dinamiche reali di un
sistema di governo, piuttosto che dalla sola analisi dei testi e delle forme di governo: è proprio da
questa considerazione che dobbiamo partire per comprendere la V° repubblica.
La flessibilità della costituzione francese del ’58, infine, non va considerata solo in termini di
relazione presidente-premier, ma anche sulla base di come essa è stata interpretata ed usata dai vari
attori politici che fino ad ora ne hanno perpetuato l’esistenza.
A tal fine Stefano Ceccanti ha distinto cinque periodi nella vita della quinta repubblica. Il primo ècompreso tra il 1962 e il 1974: il ’62 è l’anno dell’introduzione dell’elezione diretta del presidente
della repubblica, il ’74 quello della morte del successore di De Gaulle, George Pompidou. Se

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 12/29
l’elezione diretta del presidente della repubblica ha modificato non poco la portata dei poteri
costituzionali del capo dello stato, la scomparsa di Pompidou non è meno significativa, visto che
da quel momento in poi i gollisti, ed i loro toni pressoché apocalittici e sicuramente compassati,
saranno esclusi dalla presidenza fino alla vittoria nel ’95 di Jacques Chirac. In questo primo
periodo la Costituzione viene interpretata in modo “imperiale” nel senso che si assume come
elezione principale non già quella parlamentare, quanto la presidenziale, ed è proprio il presidente
la figura che spicca su tutte, essendo il primo ministro una sorta di suo segretario; soprattutto, è
l’assenza di un formato partitico organizzato a favorire il frequente ricorso ai licenziamenti dei
governi, alle dissoluzioni dell’Assemblea Nazionale e al referendum.
Il secondo periodo va dal 1974 al 1981: è la presidenza del liberale Valery Giscard D’Estaing.
Giscard, avendo deciso di non sciogliere il parlamento subito dopo la sua elezione, si ritrovò in
un’Assemblea Nazionale in cui non poté disporre della maggioranza, nel senso che non poteva
domarla agevolmente. Quello fu, infatti, il periodo in cui i partiti presero a riorganizzarsi (primo
fra tutti quello socialista di Mitterrand) avendo imparato la logica del doppio turno, e ciò comportò
dei gravi problemi a Giscard, costretto a nominare primo ministro un noto gollista, Chirac, con cui
di fatti si instaurò una sorta di coabitazione. Il presidente Giscard in seguitò sostituì il primo
ministro con una personalità meno politicizzata, Raymond Barre, ma questo non poté impedirgli di
prendere atto che il testo costituzionale nulla gli attribuiva per arginare l’avanzata dei partiti:
insomma, gli fu chiaro che le presidenze precedenti non fecero altro che giovarsi della transizione.
Il terzo periodo coincide con il primo mandato del socialista François Mitterrand (1981-1988).
Mitterrand, avendo portato alla vittoria anche il suo partito, si trovò nelle condizioni ideali per
reinterpretare la costituzione gollista in senso gollista, nonostante egli stesso ne avesse contestato
la cosa proprio al Generale fin quando questi visse. Il paradosso era di semplice spiegazione se si
pensa che Mitterrand, contrariamente a Giscard D’Estaing, aveva beneficiato della cosiddetta
“quadriglia bipolare”, il nuovo sistema dei partiti francesi che si articolava su quattro gruppi
raccolti in due coalizioni. Mitterrand si trovò nella situazione di considerare il primo ministro un
suo semplice collaboratore, ma, trovatosi a circa metà mandato in minoranza nell’Assemblea
Nazionale, fu costretto a rivedere drasticamente il proprio uso della costituzione. Nominato, infatti,
Chirac alla carica di primo ministro, Mitterrand si trovò a dare battaglia al governo gollista,
potendo continuare a presiederlo, dall’interno, rendendone più lenta la capacità decisionale e
rivendicando un dominio riservato in materia di politica estera e militare. La soluzione della
coabitazione non si trova nella Costituzione e ciò spiega perché questo ritaglio delle competenze è
più frutto di una convenzione che altro. La cosa che sorprende è che a questo punto, onde

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 13/29
difendere la propria posizione di primo ministro, è un esponente gollista a rivendicare la
parlamentarizzazione del sistema.
Il quarto periodo è il secondo mandato di Mitterrand, anch’esso connotato da una prima fase di
governo presidenziale e da una seconda di coabitazione. Quello che va fatto notare di questo
periodo è proprio la coabitazione tra il presidente socialista ed il gollista Balladur. Questa
coabitazione fu piuttosto pacifica e per la maggiore disponibilità del primo ministro nei confronti
del vecchio presidente e per il sostanziale atteggiamento arreso del presidente, senza ambizione di
rielezione e conscio della grave crisi in cui la sinistra cadde dopo la caduta del muro di Berlino.
Il quinto periodo è la prima presidenza Chirac, anch’essa caratterizzata da un governo “amico”
(premier Alain Juppé) e da una lunga coabitazione con Jospin. Potremmo aggiungere un sesto
periodo: il governo Chirac-Raffarin.
Alla fine di questa (forse noiosa) rassegna storica, possiamo pervenire ad una importante
conclusione: l’assestamento del sistema dei partiti ha realizzato una stabilizzazione parlamentare
del governo francese. Esso è sempre duale, visto il doppio rapporto di fiducia che lega il primo
ministro tanto al presidente quanto all’Assemblea Nazionale, ma, nonostante la forte figura del
presidente, è chiaro che solo se la presidenza è ricoperta da un vero leader di partito maggioritario
il sistema può funzionare secondo dinamiche marcatamente presidenzialiste.

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 14/29
Le altre esperienze europee
La descrizione sin qui fatta del semipresidenzialismo ci consente di maturare un’opinione positiva
del modello e di definire, attraverso le peculiarità che dal sistema di governo francese si evincono,
una categoria politologica distinta tanto dal presidenzialismo quanto dal parlamentarismo.
Tuttavia, al momento di riempire tale categoria gli studiosi si trovano di fronte al problema, non
piccolo, di individuare i paesi che dovrebbero farne parte. In realtà, tra i politologi non solo non vi
è alcuna definizione condivisa di semipresidenzialismo, come abbiamo avuto modo di vedere, ma
non vi è neppure accordo su quali siano i paesi a regime semipresidenziale. Questa cosa
inquietante è stata fatta presente non solo da Sartori, ma anche da Oreste Massari.
Abbiamo già rilevato come l’elemento fondamentale del semipresidenzialismo sia la cosiddetta
“diarchia”, costituita dai due reggitori della repubblica, il presidente ed il primo ministro, e non già
l’elezione a suffragio universale del capo dello stato, elemento, questo, non essenziale (tanto che
originariamente in Francia il presidente veniva eletto da un ampio collegio).
L’Austria, l’Irlanda e l’Islanda non possono essere, dunque, definiti regimi semipresidenziali
nonostante l’elezione popolare del presidente, perché il “sistema” di questi paesi segue
completamente la logica di funzionamento di un qualsiasi governo parlamentare.
Per quanto riguarda nel dettaglio l’Irlanda e l’Islanda sembra che non vi siano dubbi sul fatto che
la tesi del semipresidenzialismo non sussista e ciò per affermazione non solo di Sartori, ma anche,
tra gli altri di Fabbrini e Vassallo, i quali, tenendo conto sia dell’elezione diretta del presidente
della repubblica che della mancanza della fiducia iniziale al governo unitamente al funzionamento
praticamente parlamentare dei loro sistemi di governo, preferiscono collocare in una specie di
zona dubbia, tra il semipresidenzialismo ed il parlamentarismo, questi due paesi. Infatti,
rispolverando anche le idee di Shugart e Carey, sia l’Irlanda che l’Islanda concentrano il potere di
direzione dell’esecutivo nelle mani del primo ministro e non in quelle del presidente, che è eletto
popolarmente, ma non dispone di alcuna delle maggiori prerogative del collega francese; mentre
se questi poteri gli sono stati devoluti, la tradizione che vuole la personalità di spicco di ciascun
partito candidarsi alla carica di primo ministro, piuttosto che a quella di capo dello stato, fa in
modo che tali poteri siano ormai cristallizzati.
In particolare, il caso irlandese è significativo nel senso che le funzioni del presidente ricalcano
quelle del sovrano inglese cosicché, dalla semplice osservazione di come quest’ultimo si
“comporta”, è possibile ricavare informazioni sul primo: se il re d’Inghilterra non governa, allora
non lo fa nemmeno il presidente irlandese. Infine, nella terra degli Irishmen non c’è dualismo
perché il governo si regge unicamente sulla non-sfiducia parlamentare e non anche su quella presidenziale.

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 15/29
Anche quello austriaco è un caso interessante e anche questa volta il dubbio regna sovrano: è
tuttavia riconosciuto che pure questo è un caso solo apparente di semipresidendezialismo.
Che il semipresidenzialismo non esista? Gli esempi su cui riflettere per trovare un’adeguata
risposta alla domanda postaci da noi stessi sono la I° repubblica tedesca, la repubblica finlandese,
la costituzione portoghese del 1976 e quella della Polonia post-comunista: tanto Massari quanto
Fabbrini ritengono che questi siano i casi non contestabili di semipresidenzialismo; Sartori riduce
l’aria della certezza assoluta, invece, alla sola V° repubblica francese.
Per quanto riguarda la repubblica di Weimar, c’è da dire che non la si potrà mai capire senza aver
guardato un po’ nella situazione storica tedesca del primo dopoguerra, situazione da cui essa fu
fatalmente condizionata. Quando i tedeschi, cacciato l’imperatore, fondarono la loro I° repubblica,
la desolatamente nota Repubblica di Weimar, ebbero davanti agli occhi un esempio da non copiare:
la III° repubblica francese. Francesi e tedeschi, in verità, hanno sempre avuto il piacere a prendersi
reciprocamente le distanze, ma questa volta la scelta germanica non fu dettata da una sorta di
odium theologicum per i francesi, quanto dalla necessità di evitare la deriva assembleare. E’ chiaro
che la paura per l’instabilità ministeriale, dovuta alle “virtuose” logiche del gioco dei partiti,
indussero i costituenti tedeschi a razionalizzare fino all’ossessione il loro parlamentarismo, finendo
così per riconoscere al presidente della repubblica alcuni davvero forti poteri, tra i quali:
• nominare e licenziare il cancelliere senza richiedere per il nuovo governo la fiducia
parlamentare;
• sciogliere motu proprio il parlamento;
• sottoporre a referendum le leggi su cui tra le camere fosse sorto conflitto;
• governare per decreto in accordo con il cancelliere;
• proclamare lo stato d’assedio in situazione di pericolo per l’ordine pubblico.
Questi poteri erano, per lo più, di natura straordinaria e indirizzati a rimettere sulla giusta via un
governo deviato dalla voracità e litigiosità dei partiti. Possiamo, allora, affermare che tali poteri
non furono previsti per creare il governo arbitrario di un solo uomo, ma come deterrenti contro la
razionale irrazionalità dei partiti: la costituzione tedesca fu, dunque, profondamente innovativa
sotto plurimi aspetti, anzi, come ebbe a dire Sartori, particolarmente ingegnosa sia da un punto di
vista squisitamente tecnico che da quello della democrazia che essa aspirava a creare. Infatti, fino
al 1930 (la repubblica fu fondata nel 1919) il presidente si comportò in modo tale da non mettere
in discussione l’aspetto parlamentare del governo e in tale contesto i poteri razionalizzanti che la
costituzione gli aveva attribuito non furono mai usati in modo significativo con il risultato che,
dopo la frantumazione della coalizione tra socialdemocratici, liberali e cristiani, l’instabilità
ministeriale tanto deprecata colpì anche Weimar, i cui governi sopravvissero in media sette mesi.

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 16/29
Il problema vero di Weimar, però, fu la devastante crisi economica del 1929. Quella crisi, avendo
ingenerato forti tensioni e spaccature sociali, mise a dura prova l’impianto istituzionale della I°
repubblica tedesca e, infine, furono proprio quei fattori costituzionali “iperdemocratici”, come a
scritto Massari, ad affossarla definitivamente, perché quando dei poteri concepiti per gestire
l’eccezione si trasformano nella quotidiana normalità, non possono che essere all’ordine del giorno
gli scioglimenti anticipati e violenti del parlamento e la formazione di governi ad hoc per
sostenere dei provvedimenti presidenziali, essendo a quel punto solo il presidente la figura
legittimata dal voto popolare. In pratica, solo a partire del 1930 si può parlare di un governo
presidenziale.
Cosa fu, quindi, Weimar? Un sistema con inequivocabili somiglianze con la Francia della quinta
repubblica, ma soprattutto, un regime che troppo poco è vissuto e in circostanze assai eccezionali
per poter consentire un vero giudizio agli studiosi posteri.
Anche la Finlandia, almeno fino alle riforme del 1992, è stata considerata una repubblica
semipresidenziale, anche se questo caso, da più parti, è ritenuto una versione debole del modello.
Secondo quanto ci è parso evidente dalla lettura sia di Massari che di Sartori, il momento di
collegamento tra Francia e Finlandia è stato costituito dal dominio riservato in materia di politica
estera: almeno fino alle modifiche costituzionale suddette, infatti, il presidente finlandese
presiedeva il consiglio dei ministri solo quando all’ordine del giorno vi erano le relazioni del paese
con l’estero, mentre in tutti gli altri casi la sua presenza non era nemmeno ammessa. Il governo
finlandese era, dunque, parlamentare ? In realtà il discorso è un po’ più complesso, perché il
presidente aveva una non indifferente discrezionalità nella scelta del primo ministro (il che senza
pregiudicare il parlamento) e nella determinazione della coalizione di governo, dimostrando di
poter disporre di un numero maggiore di prerogative rispetto ad un suo omologo continentale.
Anche gli studiosi si pongono la domanda se la Finlandia sia da considerarsi un esempio di
semipresidenzialismo ovvero una repubblica parlamentare che riconnette forti poteri al presidente?
Una cosa è senz’altro certa: l’elemento fondamentale del semipresidenzialismo francese, la
diarchia, è qui praticamente inesistente non essendo il presidente un uomo di governo – per cui
non c’è nemmeno la più remota possibilità di coabitazione nel caso che il premier sia
politicamente avverso – bensì il garante dell’unità nazionale, anzi, il “tutore” tanto
dell’indipendenza faticosamente raggiunta dalla Russia nel 1919 quanto della pace scaturita in
quegli stessi anni tra le fazioni che fin lì avevano dato vita ad una cruenta guerra civile.
Per circa settant’anni, infatti, la Finlandia si è trovata in bilico tra due mondi, quello occidentale e
quello comunista, con la voglia di andare verso il primo, ma la paura di subire il ritorno dei russi,che zaristi o comunisti, non hanno mai sopito le loro tendenze imperialiste; inoltre, durante lo

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 17/29
stesso arco di tempo (ma all’oggi la situazione non è di molto cambiata) una notevole
frammentazione del sistema partitico ha impedito la creazione di governi stabili e coesi: ecco,
allora, la necessità di avere sempre “il presidente giusto” al momento giusto. Il motivo per il quale
il primo cittadino finlandese presiede il consiglio dei ministri solo se sul tavolo vi sono le relazioni
con l’estero risiede nel fatto che nessuno ha la sua stessa autorità morale, prima che politica, per
occuparsene. Per comprendere ciò, sufficiente appare considerare il sistema d’elezione del
presidente. Per lungo tempo questo fu indiretto nel senso che i cittadini eleggevano un collegio su
base partitica e solo all’interno di esso aveva luogo la vera scelta e selezione dei candidati; il
popolo aveva, comunque, la possibilità di influire sulla decisione attraverso il voto per eleggere
tale assemblea. Quando fu introdotta, invece, l’elezione diretta, essa fu limitata ad un turno unico
per cui, in mancanza di un candidato vincente con la maggioranza assoluta dei suffragi, la scelta
sarebbe ricaduta sul collegio: per consuetudine, però, questo investe sempre il candidato più votato
dagli elettori.
Insomma, il presidente finlandese è forse più un forte presidente parlamentare che una figura
simile a quella del capo di stato francese; in fondo, è lo stesso Sartori ad ammettere di aver
catalogato la Finlandia tra i regimi semipresidenziali per scopi propri, per “dotare il
presidenzialismo di una valvola di sicurezza”, la cui traduzione: “se escludessi la Finlandia dal
novero dei paesi semipresidenziali, non potrei più consigliare ai presidenzialismi di scegliersi in
secondo grado il presidente per sfuggire alla video-politica”. Non potendosi, comunque, trascurare
la grande importanza del capo di stato nella determinazione della coalizione di governo, nemmeno
tanto azzardato appare collocare il sistema di governo finlandese nella famiglia dei
semipresidenzialismi.
Accenneremo adesso agli esempi portoghese e polacco per mostrare come, a dispetto delle
norme costituzionali, le vicende politiche e gli equilibri di sistema definiscono la forma di governo
in modo determinante.
La costituzione portoghese a cui ci si riferisce è quella scritta all’indomani della Rivoluzione dei
garofani, nel 1976. Quella rivoluzione, che restaurò la democrazia in Portogallo e che fu guidata
dalle frange socialiste e comuniste delle forze armate, generò delle istituzioni decisamente
presidenziali, poiché era obiettivo dei militari creare una forte presidenza (e non poteva essere
diversamente) che fosse appannaggio della “classe militare” stessa. Non a caso il primo presidente
della rinata democrazia portoghese fu Ramalho Eanes, un militare. La Costituzione attribuiva al
presidenti i poteri di nominare discrezionalmente il primo ministro e di licenziarlo, di non emanare
atti legislativi a lui non graditi senza possibilità di reazione per il parlamento, sciogliere il parlamento, assumere poteri speciali. Tuttavia, già nel ’82 la Costituzione venne profondamente

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 18/29
rivista, cosicché oggi il presidente nomina il primo ministro tenendo conto dei risultati elettorali e
previa consultazione; nomina i ministri su proposta del primo ministro stesso; non ha potere di
veto assoluto (anche se ne conserva uno molto forte in materia di politica estera e militare) sulla
legislazione approvata dal parlamento (monocamerale); non può dimissionare il primo ministro se
non in caso di rara urgenza; la dissoluzione del parlamento è tipica; infine, proclama lo stato
d’emergenza ma non assume poteri speciali, conferiti, invece, al governo e al parlamento. Come
già prima del ’76, il presidente non presiede il consiglio dei ministri.
Come si arrivò alle riforme del 1982 ? Vi si arrivò per la necessità di ufficializzare le dinamiche
sistematiche che fin dall’inizio avevano contraddistinto il regime democratico del paese. Infatti, il
presidente Eanes non ebbe mai la possibilità di esercitare i suoi poteri così come l’impianto teorico
del sistema faceva pensare e questo per via della mancanza di una maggioranza parlamentare a lui
favorevole. Insomma, il baricentro del sistema si spostò presto dalla parte del primo ministro e a
quel punto giunti non restava che innalzare quella spontanea evoluzione a norma costituzionale,
onde evitare sgraditi ritorni di autoritarismo.
La convergenza politica tra il presidente Jorge Sampaio e la maggioranza socialista nel periodo
1996-2000 non ha provocato il ritorno a forme presidenziali di gestione del potere così come alcun
conflitto per la prevalenza tra lo stesso Sampaio ed il primo ministro Antonio Guterress. Altresì, la
recente vittoria del centro-destra, che ha portato al governo Barroso, in costanza della presidenza
socialista, non ha originato il fenomeno della coabitazione.
Il caso polacco, infine, è degno di nota tanto per l’evoluzione fin qui avuta dello stesso che per
alcuni passaggi del dettato costituzionale. In particolare sono da sottolineare l’articolo che assegna
il potere esecutivo al presidente e al consiglio dei ministri e quei meccanismi che di fatto
realizzano una meccanica alternativamente presidenziale o parlamentare nella scelta del primo
ministro. Il presidente nomina il primo ministro, ma questi deve ricevere la fiducia della camera;
qualora la fiducia non fosse votata, toccherà al parlamento eleggere il primo ministro. La cosa
singolare di questa costituzione è che se anche il parlamento dovesse fallire, la palla tornerebbe
nuovamente al presidente e poi di nuovo al parlamento. Solo a questo punto il capo dello stato
potrà indire nuove elezioni o nominare un governo provvisorio in carica per pochi mesi. In breve,
la “ piccola costituzione” polacca congiunge la nomina presidenziale del premier con la possibilità
del parlamento di esperire una sorta di sfiducia costruttiva.
Ora, le vicende della Polonia post-comunista ci inducono a pensare che, seppur concepita con
decisi tratti presidenziali durante la fase militare del generale Jaruzelski, la sua forma di governo si
sia stabilizzata in senso parlamentare grazie alla formazione di un ordinato sistema di partiti (di cui

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 19/29
il merito è tutto di una buona legge elettorale) che ha tagliato le “mani” ad un personaggio politico
come Lech Walesa, fermo sostenitore delle prerogative presidenziali (in quanto presidente).
In fine, anche in Polonia, come in Portogallo, la medesima origine politica del presidente e del
premier non ha causato conflitti di attribuzioni, tanto meno la leadership liberale del governo
Buzek – insediatosi a sorpresa nel ’97 – ha generato problemi di coabitazione con il presidente
socialista Kwasniewski.

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 20/29
Un tentativo di analisi critica
Fino ad ora ci siamo attenuti all’esposizione della teoria del semipresidenzialismo come definita
dai suoi sostenitori per illustrare del modello semipresidenziale le innegabili qualità e la
sorprendente capacità d’adattamento ai contesti “difficili”. Adesso, invece, ci proponiamo di
sviluppare alcune considerazioni critiche di natura personale, onde spiegare perché il sistema
semipresidenziale potrebbe essere considerato esclusivamente come una categoria del pensiero
politologico, piuttosto che una descrizione oggettiva e precisa delle dinamiche politico-istituzionali
di taluni paesi. Queste considerazioni finali nascono, soprattutto, per capire il motivo per il quale
arduo appare alla Scienza individuare e classificare i regimi semipresidenziali: la nostra proposta,
se possiamo permetterci, consiste nell’inserire la Francia tra le repubbliche presidenziali e tutte le
altre esperienze di semipresidenzialismo (su cui sono più forti i dubbi che le certezze) tra i regimi
parlamentari.
Argomenteremo la nostra proposta a partire dalla distinzione tra costituzione formale e
costituzione materiale (la cui origine è già stata da noi trattata con la citazione di Pitruzzella a pag.
9). Parlando del semipresidenzialismo francese la dicotomia formalità-materialità riguarda
soprattutto le prerogative del presidente della repubblica: per farla breve, alcuni autori come
Deverger e Sartori sembrano sostenere l’ipotesi che buona parte dei poteri di cui il capo dello stato
dispone siano il risultato di un’usurpazione consumata a danno del governo e, ancor di più, del
primo ministro. Quello che apprendiamo dall’esperienza polacca può aiutarci a comprendere bene
questa tesi e l’affermazione che vuole la figura del presidente della repubblica francese
maggiormente definita dalle interpretazioni individualistiche dei presidenti maggioritari piuttosto
che dal dettato costituzionale. Noi ci permettiamo di mettere in dubbio tutto ciò.
È proprio vero che il presidente abbia usurpato la costituzione assumendo il potere di licenziare
il primo ministro? Secondo noi non è vi è conflitto alcuno tra formalità e materialità giacché, se
presidente e premier hanno difficoltà a convivere, vista la maggior legittimazione della carica
presidenziale, l’unico a potere e dovere tirare i remi in barca è il secondo dei due: ciò spiega
bene il motivo per cui il presidente nulla può contro un premier di colore politico opposto dato
che, molto semplicemente, è logico che vi sia conflitto tra i due, ma in questo caso il primo
ministro non si dimette perché, anche se il presidente glielo chiedesse, nessun sentimento di
lealtà politica potrebbe indurre il premier a sentirsi obbligato a rassegnare le dimissioni (e
nessun potere ha il presidente per rimuoverlo). Insomma, il presidente può “invitare” il primo
ministro a dimettersi, ma non può usurpare niente e nessuno visto che non si è arrogato alcun
atto potestativo, essendo Parigi ben diversa da Weimar. Pasquino fa notare come la decisione disostituire il premier sia dettata dalla necessità di ridar fiato e slancio alla maggioranza

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 21/29
parlamentare, cambiare linea politica, rispondere ad esigenze meramente politiche, scaricare
responsabilità personali del presidente; e ancora, a sostegno di quanto da noi scritto in
precedenza, come il licenziamento del governo passi attraverso un mero sollecito.
È il presidente della repubblica il vero capo del governo? Certo, osservando le dinamiche della
coabitazione la risposta che vien da dare è sicuramente negativa; pensare che la V° repubblica
disegni un sistema di trasferimento dei poteri dal presidente al primo ministro a seconda dei
casi, è già stato scritto, non appare altresì soddisfacente. Le possibili risposte sono, allora, due:
o il presidente ha assunto un ruolo che non gli spetta oppure la coabitazione non è nella
fisiologia della repubblica gollista. Nel primo caso dovremmo parlare della Francia come di una
repubblica parlamentare a cui il generale De Gaulle ha voluto, quasi arbitrariamente, imprimere
una logica presidenziale, ma la cosa non ci appare chiara dato che è la stessa costituzione ad
attribuire al capo dello stato la presidenza del consiglio dei ministri; nel secondo, invece,
dovremmo parlare di una repubblica a decisi tratti presidenziali che talvolta – la causa risiede
nella diversa lunghezza dei mandati presidenziale e parlamentare – si inceppa. In fondo, è stato
Mitterrand a dire che “ Il primo ministro ed i ministri debbono eseguire la politica definita dal
presidente della repubblica, dal momento che il presidente della repubblica ha come dovere
quello di applicare il programma sul quale ha stabilito un contratto con il paese”.(Citazione da
Ceccanti)
Dalla lettura degli articoli 12 e 16, sullo scioglimento e sullo stato d’emergenza, si apprende
che il presidente può attivare questi poteri senza che se ne debbano controfirmare gli atti
relativi: esiste qualcosa di simile nelle repubbliche parlamentari? Come ci insegna Ceccanti, il
titolo II della Costituzione, quello che comprende i due articoli, appartiene allo strato delle idee
di De Gaulle ed è proprio a quest’ultimo che dobbiamo riferirci se vogliamo intendere il
significato di un termine che ricorre nei due articoli: consultation. C’è differenza tra una
consultazione (art.12) ed una consultazione officielle (art.16) e, se si, qual è? La differenza
esiste e consiste, probabilmente, nel sottolineare che la decisione di sciogliere l’Assemblea
Nazionale non può non essere esclusiva del presidente, perché lo scioglimento serve a mettere
ordine nel caos dei partiti, tanto odiati dal generale, e non potrebbe non essere affermato che da
colui che si dispone al di sopra dei partiti (il presidente, appunto). La consultazione di cui
all’articolo 16 è, invece, più severa e formale così da avere una certa ricaduta sulla decisione
del presidente, poiché l’applicazione di detto articolo ha delle conseguenze di maggiore gravità,
potendo il presidente assumere poteri speciali senza che la Costituzione ne definisca la
consistenza e la durata. In ogni modo, la decisione finale è rimessa unicamente al capo dellostato, visto che il relativo atto non necessita di controfirma.

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 22/29
Esiste davvero il dominio riservato in materia di politica estera a favore del presidente? La
migliore domanda che ci viene da porre è: perché poteri quali il referendum e lo scioglimento
sono considerati usurpati nonostante che non vogliano la controfirma, mentre, allo stesso modo,
non si ritiene il cosiddetto “dominio riservato in politica estera” un’usurpazione della
Costituzione, dato che, a differenza che nei primi due casi, nel terzo è richiesta la controfirma
(questa sì che potrebbe essere una chiara usurpazione del testo costituzionale) ?
Infine, qualche considerazione sul primo ministro. L’articolo 20 sancisce che il governo è
responsabile della politica della Nazione e che a dirigerlo è il primo ministro. Questo punto è
fondamentale, visto che è proprio su questo articolo che si fonda l’idea dell’esecutivo diarchico.
La diarchia implica che due persone abbiano tali poteri da “comandare” insieme: il presidente
ed il primo ministro francesi “comandano” davvero insieme? La domanda è d’obbligo nel
momento in cui, leggendo l’articolo 20, ci accorgiamo che il premier francese non è tanto
dissimile dal presidente del consiglio italiano, rinomatamene debole, è nemmeno lontanamente
somigliante ai suoi colleghi britannico e tedesco. Il potere di direzione del governo si potrebbe
riferire, allora, alla semplice implementazione di decisioni già prese dal governo, in cui la voce
predominante è, in condizioni di normalità, il presidente. Contro il governo è possibile votare
una mozione di sfiducia, ma tale atto fa cadere la testa che non comanda veramente. Il semi-
presidenzialismo potrebbe, allora, essere un’ingegnosa trovata del Generale per non derogare al
principio della responsabilità dell’esecutivo di fronte l’Assemblea, principio impostogli nel ’58,
senza far venire meno la leadership.
Infine, in nessun regime parlamentare il presidente propone riforme istituzionali ed interviene
attivamente nel processo di revisione costituzionale come in Francia (art.89).
Queste argomentazioni ci portano a concludere che esiste davvero una frattura tra “costituzione
formale” e “costituzione materiale”, ma questa potrebbe non consistere in ciò che si legge nei
tradizionali manuali di scienza politica: lì, infatti, si legge che la prima delinea i tratti di un regime
non presidenziale, tratti che al contrario caratterizzano la seconda; la nostra opinione è che il
regime fu fatto fondamentalmente presidenziale e che abbia in seguito assunto dinamiche vieppiù
parlamentari come conseguenza dello sviluppo del sistema dei partiti.
Come Massari, Ceccanti e Pasquino pongono in evidenza, i fattori che hanno profondamente
condizionato l’evoluzione della V° repubblica sono stati due: l’introduzione dell’elezione diretta
del capo dello stato e l’adozione della formula uninominale a doppio turno per la selezione dei
membri dell’Assemblea Nazionale. Il sistema elettorale suddetto ha permesso la comparsa del
“fait majoritaire” dopo anni di sperimentazione: poiché al secondo turno accedono soltanto icandidati che hanno superato una certa soglia (attualmente il 12,5% degli iscritti al voto in ciascun

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 23/29
collegio) i partiti hanno imparato ad adottare comportamenti strategici – l’accordo pre-elettorale o
la desistenza – così che ogni elezione favorisce la formazione di una chiara distinzione tra
maggioranza ed opposizione. Il majority, che la Francia aveva già usato durante la III° repubblica
con pessimi risultati e che De Gaulle aveva voluto proprio per mantenere frammentato il
parlamento e fare così il rassemblement , col tempo ha invece ridotto il numero dei partiti e ne ha
reso il sistema stabile e convergente al centro. Il doppio turno ha, dunque, sempre permesso la
formazione di stabili maggioranze parlamentari a sostegno o del presidente o del primo ministro.
Si ritiene, tuttavia, che quest’effetto non sarebbe stato raggiunto senza la bipolarizzazione politica
indotta dal doppio turno presidenziale e in effetti ciò non può essere negato. Paradossalmente,
piuttosto che rinforzare la presidenza, queste due leggi hanno rivitalizzato il sistema dei partiti: 1)
perché la forza di un presidente è ormai determinata dai meccanismi di lealtà e solidarietà politica
tipici della leadership di partito; 2) perché tali leggi hanno prodotto la “de-presidenzializzazione”
del governo. Potrebbe essere proprio questo, allora, ad aver usurpato la V° repubblica, originando
in questo modo la divisione ed il contrasto tra “costituzione formale” e “costituzione materiale” e
la nozione stessa (di dubbia verifica empirica) di semipresidenzialismo. Stando così le cose, la
nostra proposta è che il normale governo francese deve essere di emanazione presidenziale, mentre
la coabitazione deve essere considerata solo un fenomeno temporaneo e, comunque, patologico
dovuto dalla ricostruzione in senso bipolare del sistema dei partiti. Dunque, potrebbero non
esistere delle convenzioni “usurpatrici” che hanno permesso al capo dello stato di
“presidenzializzare” il sistema, bensì delle condizioni oggettive non presenti in partenza e delle
prassi elaborate dagli attori politici che hanno “parlamentarizzato” il governo per dirimere la
questione spinosa della coabitazione. La verità è che De Gaulle cercò, al di là delle retoriche
rassicurazioni dei suoi tattici discorsi, di dar vita ad una repubblica presidenziale avendo insistito
sull’elezione diretta del presidente, sulla divisione dei poteri (incompatibilità tra incarichi
parlamentari e ministeriali; impossibilità per il legislativo, alias i partiti, di rovesciare la prima
testa nell’esecutivo) e sulla frantumazione della rappresentanza politica, ma tale repubblica ideale
fu cambiata nel corso degli anni dall’inattesa comparsa del fatto maggioritario. In conclusione,
trattare l’argomento alla luce dell’ipotesi dell’usurpazione, nonostante i suoi autorevoli portavoce,
ci appare una perdita di tempo, perché i poteri che il presidente ha esercitato ed esercita sono tutti
nella Costituzione e nella sua logica di funzionamento; l’equivoco, tuttavia, nasce perché in un
sistema in cui il baricentro si è decisamente spostato a favore del parlamento – perché è qui che si
decide chi governa – è la figura di un presidente forte ad apparire una nota stonata, un’incoerenza,
un’intrusione non opportuna nei processi decisionali. È come se la scelta adottata nel ’58 di un

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 24/29
potente capo di stato, motivata dalla cronica instabilità del formato partitico, fosse ormai scaduta
dato che l’Assemblea da sola è in grado di istituire e sostenere proprie compagini ministeriali.
L’infondatezza della tesi dell’usurpazione ci spinge a verificare la possibilità di inserire la Francia
tra i regimi presidenziali, nondimeno un elemento critico in tal senso rema contro questa idea: il
primo ministro, essendo in un regime presidenziale la persone del capo dello stato fusa con quella
del capo del governo.
Abbiamo già visto come gli stessi presidenti francesi abbiano definito i loro rapporti col primo
ministro con diverso entusiasmo a seconda che fossero o meno maggioritari in parlamento.
Giscard ha dovuto tristemente dichiarare, temendo una vittoria socialista alle politiche del 1978,
che la Costituzione non gli attribuiva alcun potere per ostacolare un eventuale governo delle
sinistre; Mitterrand ha prima detto che il governo deve realizzare il programma del presidente e poi
che la Costituzione conferisce al presidente il potere di impedire le decisioni ma non di prenderle
(citazione da Sartori). Perché è così problematico capire come presidente e primo ministro
debbono relazionarsi? Il problema è la legittimità a governare. Quando in Francia si elegge un
nuovo presidente della repubblica, la campagna elettorale è centrata su questioni politiche e non
personali, giacché in quei giorni gli elettori francesi non sono chiamati ad eleggere una personalità
rassicurante e/o autorevole e basta, ma ad approvare un vero e proprio programma di governo per
gli anni successivi, esattamente come accade nei paesi a regime presidenziale e a differenza di
quelli in cui l’elezione del presidente è solo simbolica, se tale espressione può passare. È ovvio che
la simpatia che un candidato può esercitare sulle persone conta notevolmente, ma ciò non è più
determinante della leadership che si può esercitare su di un partito o di una colazione sulla base di
un programma condiviso. Quando un candidato vince le presidenziali è tutto il partito a vincerle,
non il solo candidato e ciò spiga il motivo per cui, all’indomani dell’avvenuta vittoria, il presidente
francese scioglie l’Assemblea Nazionale, mentre quello portoghese e quello polacco non lo fanno
e non ci pensano nemmeno. La decisione di andare ad elezioni anticipate, nominare un premier
amico a dispetto della maggioranza attuale (basta pensare alla nomina di Raffarin ad opera di
Chirac nel 2002 nonostante l’Assemblea sarebbe stata rinnovata solo tre mesi dopo), sospendere
l’applicazione di leggi proposte dal governo precedente (la legge sulle 35 ore) sono solo alcuni
degli atti che un presidente appena eletto può adottare in piena legittimità. In quanto premiere
femme del momento il presidente è colui che realmente comanda, mentre il primo ministro fa solo
funzionare la macchina governativa, come a dire che il primo è l’ispiratore ed il secondo il
realizzatore. Diversa è la situazione in cui il presidente ha perso la maggioranza in parlamento,
perché in questo caso è chiaro che gli elettori hanno scelto un nuovo programma di governo,scontenti di quello precedente: cioè, se in luogo delle politiche si fossero fatte le presidenziali, il

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 25/29
capo del governo (quello vero) le avrebbe perdute a favore dello sfidante. Il presidente è
assolutamente delegittimato e questo spiega perché egli non faccia ripetere le elezioni, come
facevano i sovrani del 19° secolo quando non le vincevano, e perché non sciolga il parlamento
all’improvviso nella speranza di sorprendere il primo ministro ed il suo partito. Dell’impossibilità
di chiedere le dimissioni del governo abbiamo già riferito. Ora, quando perde le politiche e con
esse una buona sostanza (di fatto) delle sue prerogative, il presidente della repubblica viene
mortificato nella sua figura istituzionale, apparendo al popolo che lo ha eletto non solo inutile, ma
addirittura fastidioso: un ostacolo per il primo ministro, una zavorra per il governo, un noioso e
superfluo oratore. Non sarebbe il caso di rassegnare le dimissioni? La dimissione eviterebbe la
distorsione della meccanica del sistema e le secche della coabitazione: insomma, eviterebbe
equivoci circa il ruolo del presidente. L’alternativa sarebbe accordarsi per la definitiva e formale
parlamenterizzazione del regime, cioè, decidere di tagliare i rami alla presidenza, ma la recente
riforma costituzionale, votata per referendum, che ha ridotto il mandato presidenziale da sette a
cinque anni va nella direzione opposta. Equiparare la durata del mandati del presidente e
dell’Assemblea Nazionale, infatti, produce l’effetto di ripresidenzializzare il sistema, giacché il
diminuito rischio di coabitazione produrrà dei notevoli effetti sui poteri del presidente nei
confronti del parlamento. In primo luogo, lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale, seppur
ancora possibile, non sarà più realizzato perché il presidente non avrà alcun interesse ad anticipare
le elezioni rischiando di perdere la maggioranza; essendo sicuramente il capo dello schieramento
maggioritario in aula, egli potrà sostituire il primo ministro con una notevole facilità (come fecero
De Gaulle, Pompidou e Mitterrand); la sua presidenza del Consiglio non sarà solo di forma, ma di
sostanza; la sua autonomia in politica estera sarà incrementata. Questo presidenzialismo non
corrisponderà evidentemente alla teoria pura, tuttavia, se un sistema di governo va valutato anche
per come funziona e non solo per quello che si è scritto sulla costituzione, basterà osservare che il
presidente non scioglie (anche se solo di fatto) il parlamento, è il leader incontrastato del governo
estesamente inteso potendone licenziare i membri non più fidati, e che dirige la politica estera e
militare. In fondo, se i paesi del centro e del sud America sono considerati senza dubbio paesi a
regime presidenziale nonostante la loro diversità molto pronunciata rispetto al modello teorico,
perché la Francia non può rientrare nella stessa categoria? Se in Francia non si fosse verificato il
fenomeno della coabitazione, avremmo sollevato dubbi sul carattere presidenziale delle sue
istituzioni? Allora, il problema è stabilire se dualismo coincide con dualità della struttura di
governo. Ci sembra che la risposta sia negativa. Dicendo “struttura duale dell’esecutivo”, infatti, ci
riferiamo a ciò che Sartori definì “diarchia” o “esecutivo bicefalo” per sottolineare che esistonodue teste che comandano insieme, una in quanto fonte d’autorità autonoma dal parlamento, l’altra

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 26/29
in quanto legittimata da due fonti d’autorità distinte, il presidente ed il parlamento. Ma come
sostenere a lungo questa idea se – lo hanno dichiarato gli stessi presidenti francesi, non noi –
quando governa il presidente il primo ministro è il suo più stretto uomo di fiducia, mentre quando
governa il primo ministro il presidente “abdica” in suo favore? Se comanda l’uno, insomma, l’altro
non lo fa: esiste davvero la guida duale del governo? Probabilmente, la V° repubblica francese, in
condizioni di normalità, è più simile alla monarchia costituzionale che non a quella parlamentare:
la presenza del primo ministro non impedisce, cioè, che la corona abbia posto per una sola testa. Il
concetto di “dualismo”, invece, è relativo alla duplice “fiducia” di cui il governo deve disporre, la
fiducia del capo dello stato e quella del parlamento, per cui entrambe possono distintamente
licenziare l’esecutivo, come realmente accadeva nella prima metà dell’ottocento. Dunque, la
V°repubblica riscopre in Europa il dualismo, ma non sembra creare un governo a struttura duale. È
ovvio che, se la nostra comprensione dei termini non è corretta, la conclusione può essere opposta.
Comunque, la nostra analisi, per nostro difetto di scienza, non è adeguata e ancor più perché priva
di riferimenti a ciò che significa “esecutivo monocratico”: infatti, è proprio in questa espressione
che risiede la grande differenza tra USA e Francia. E questa è una differenza di non poco conto.
La costituzione americana è costituita da soli sette articoli e in nessuno d essi si parla di ministri o
di consiglio dei ministri: il governo, in pratica, è formato solamente dal presidente. Ideata nel
momento più alto della speculazione politica illuminista, la costituzione americana si ispirava
profondamente alla teoria della separazione dei poteri, in base alla quale il potere decisionale
spettava esclusivamente al legislativo, che rappresentava la Nazione, mentre all’esecutivo sarebbe
toccata la semplice applicazione delle leggi: non è un caso che negli Stati Uniti il termine
anglosassone governement venga sostituito da administration. A lungo, dunque, si parlò di
“ governo del Congresso” e solo l’evoluzione storica comune a tutti gli esecutivi moderni ha reso
quello americano sempre meno una administration e sempre più un governement . Tuttavia, proprio
perché pensato come un’amministrazione, il governo americano non è formato da un gruppo di
politici, ma è un’organizzazione gerarchia che fa capo al presidente e che a lui soltanto risponde
direttamente. Il presidente dispone (non per costituzione, ma per legge) di due uffici: il White
House Office ed il Executive Office of the President , che costituiscono la cosiddetta presidenza
personale. In particolare, il secondo potrebbe essere in qualche modo paragonata ad una
presidenza del consiglio (comunque la si voglia chiamare) di tipo europeo, mentre il primo, pur
essendo in realtà parte del primo, è una sorta di ufficio personale con cui il presidente tiene i
rapporti col Congresso, colla stampa, con l’opinione pubblica. Il secondo strato della presidenza è
quella detta dipartimentale, costituita da quattordici dipartimenti guidati da segretari e non daministri. Cosa comporta ciò? L’inesistenza di un cabinet , di un luogo in cui, cioè, più persone si

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 27/29
riuniscono per assumere collegialmente le decisioni necessarie. Essi sono propriamente dei
delegati del presidente. Infine, abbiamo la presidenza amministrativa, costituita da una serie di
agenzie indipendenti (Fabbrini, Vassalo). MA quello che ci interessa è sottolineare l’inesistenza di
un gabinetto, cosicché non tutti i dipartimenti sono ugualmente importanti, valorizzati e
considerati; inoltre, la riunione plenaria della presidenza dipartimentale è occasionale e rimessa
alla volontà del presidente, essendo essa non necessaria, poiché ciascun segretario prende ordini
dal capo o risponde personalmente dei suoi comportamenti successivamente ma sempre presso il
presidente (che in questo modo ne legittima l’operato ex post ). Infine, il presidente è l’unico a
rispondere personalmente di fronte al corpo elettorale. In Francia tutto questo non c’è e per la
presenza di un cabinet e per l’esistenza di una struttura specifica che fa testa al presidente della
repubblica (circa 700 persone) e di una, invece, si riferisce al primo ministro. Come scrivono
Fabbrini e Vassallo, il capo dello stato si è appoggiato fortemente sulla prima per appropriarsi
della direzione del governo, facendo sì che al primo ministro fosse rimessa la guida
dell’esecuzione delle politiche. Nondimeno, sono sempre gli stessi autori a far notare come
l’ufficio del primo ministro sia stato organizzato principalmente con lo scopo di “ coordinare e
supervisionare l’azione del governo”, e che successivamente, con la coabitazione, esso si sia
attrezzato per anche dirigere il governo stesso. Oggi il governo francese ha a sua disposizione
un’organizzazione che può competere fondamentalmente alla pari con la presidenza della
repubblica.
Un ultima considerazione: anche le istituzioni nordamericane sono dualiste, ma nel senso che esse
sono “istituzioni separate che condividono il potere”, vale a dire istituzioni poste orizzontalmente,
su di un piano di parità cosicché esse sono dotate di autorità equivalente sotto la Costituzione, al
contrario dell’Europa dove vige una relazione verticale tra legislativo ed esecutivo (tanto che il
governo francese risponde anche davanti alla camera elettiva) ed il parlamento, in quanto sede
unica della sovranità, è al di sopra della stessa costituzione. Questo fa in modo che in Europa “ la
decisione di governo è rimessa dal parlamento al suo esecutivo” contrariamente a quanto accade
oltre oceano perché lì il legislativo partecipa direttamente alla decisione governativa
“indipendentemente dall’esecutivo, anche se insieme ad esso”.
27

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 28/29
Conclusioni
La conclusione di questo lavoro in realtà è poco concludente, nel senso che al punto in cui siamo
giunti abbiamo maturato la convinzione che il problema relativo all’individuazione dei regimi,
cosiddetti, semipresidenziali sia stato tutt’altro che risolto. Nelle nostre carte avevamo avanzato
una proposta che abbiamo cercato di motivare e di rendere accettabile e che consisteva nel
catalogare la Francia della V° repubblica tra i paesi a regime presidenziale e tutti gli altri esempi di
semipresidenzialismo citati dagli esperti tra i regimi parlamentari, ma alla fine ci siamo dovuti
arrendere all’evidenza che, se è praticamente incontestabile il fatto che la repubblica gollista non
possa rientrare tra le forme di governo parlamentari, è altrettanto incontestabile l’utilità di creare
un modello teorico nuovo e diverso da quelli tradizionali, essendo le differenze tra il governo della
V°repubblica ed un governo monocratico assai evidenti. Tuttavia, è nostra profonda convinzione, e
ci sembra di aver trovato tracce della stessa anche negli autori da noi consultati fatta eccezione per
i chiari intendi partigiani, che uno degli elementi caratterizzanti del semipresidenzialismo, la
possibilità che la direzione del governo oscilli come un pendolo tra il presidente ed il primo
ministro, sia un eventualità poco desiderabile. Lo stesso Fabbrini in altro suo scritto avverte delle
difficoltà che dalla seconda metà degli anni ottanta flagellano la V° repubblica proprio a causa
della logorante logica della coabitazione che, lungi dall’essere un virtuoso meccanismo che
concilia due opposti, è quasi una pratica consociativa che impedisce agli elettori di attribuire chiare
responsabilità. L’esito delle ultime elezioni presidenziali dell’aprile 2002, che videro al primo
turno i seguenti risultati: Chirac a circa il 20%, Le Pen al 17%, Jospin al 16% e almeno altri
quattro candidati minori sopra il 5% dei suffragi, dimostrano la nostra affermazione (anzi, sono
questi dati ad aver formato la nostra convinzione).
Ha scritto Sergio Romano sul Corriere della Sera il giorno dopo il primo turno delle ultime
presidenziali:
(…) all’origine della crisi vi sono almeno due ragioni strettamente collegate . La prima è la
coabitazione . La sconfitta subita alle elezioni presidenziali del 1997 ha costretto Chirac a convivere
per cinque anni con un governo di sinistr . Questo nuovo “regime” (le precedenti coabitazioni erano
state più brevi) ha privato il Paese di una reale dialettica politica. Egualmente interessati ad evitare
una crisi costituzionale, i leader della destra e della sinistra hanno dovuto rinunziare al diritto di
confrontarsi da posizioni contrapposte ( …) Non è sorprendente che i francesi abbiano
progressivamente perduto il senso della differenza tra i due schieramenti. (la seconda ragione di cui
parla Romano è di carattere economico e non ci riguarda).
La riduzione del mandato presidenziale da sette a cinque anni farà in modo da allineare le elezioni
per l’Assemblea Nazionale con quelle per il Presidente della Repubblica onde evitare per il futuro

5/10/2018 Il semipresidenzialismo - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/il-semipresidenzialismo 29/29
il fenomeno della coabitazione, la cui eliminazione farà che il presidente eletto dal popolo non sarà
più messo nelle condizioni di essere un’impotenza sostenuta (da un voto passato). Ciò nonostante,
l’aver compreso l’eccezionalità delle situazioni in cui De Gaulle e Pompidou agirono ci permette
di valutare l’impatto della transizione sull’interpretazione dei poteri presidenziali e, più in
generale, della Costituzione stessa: non si può negare, infatti, che in quella fase le prerogative del
presidente crebbero, in qualche modo, più di quanto fosse lecito attendersi. È possibile, quindi,
attendersi una decisa “svolta” parlamentare senza dar vita ad una VI°repubblica, come qualcuno ha
sostenuto durante i giorni di gloria di Le Pen, anche in considerazione della sempre più artificiale,
perché costruita con la sfida a due del turno di ballottaggio, legittimazione presidenziale, non
essendo quest’esito estraneo alle possibilità offerte dalla dimostrata flessibilità del sistema.
La nostra opinione, però, è già stata espressa e volge verso equilibri favorevoli al presidente anche
perché, alla luce delle conseguenze ipotizzate in seguito alla riduzione del mandato presidenziale,
questo ci sembra lo scenario futuro obbiettivamente più realistico