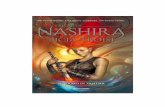“Guarda il cielo” 5 esempio la “movida” della notte, o l’happy hour o l’aperitivo della...
-
Upload
nguyenngoc -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of “Guarda il cielo” 5 esempio la “movida” della notte, o l’happy hour o l’aperitivo della...
LIBERA UNIVERSITÀ
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA
- LUMSA -
“Guarda il cielo” L’uomo, il cosmo e l’interiorità
Massimo Marelli
Silvia Fanfani Schiavoni
Roma - A.A. 2017-2018
Ad uso degli studenti
Introduzione
«Era una notte incantevole, una di quelle notti che ci sono solo se si è
giovani, gentile lettore. Il cielo era stellato, sfavillante, tanto che, dopo
averlo contemplato, ci si chiedeva involontariamente se sotto un cielo
così potessero vivere uomini irascibili e capricciosi. Anche questa
domanda è da giovani, caro lettore, proprio da giovani, ma che Dio la
faccia sorgere più spesso nell’anima tua! ... A proposito di persone
irascibili e ostinate, non posso non ricordare come mi comportai bene
durante tutta quella giornata. Una certa angoscia aveva iniziato a
tormentarmi fin dal mattino. A un tratto mi era sembrato che tutti mi
lasciassero solo, che tutti mi abbandonassero».1
L’apertura del romanzo breve di Dostoevskij, Le notti bianche, è forse uno degli incipit più
belli che sia stato mai scritto. Egli elabora questo libro - che porta come sottotitolo «memorie di un
sognatore» - a 27 anni.
La memoria evocata, richiama qualcosa che afferisce al sacro, perché è ciò che viene custodito
nel più intimo di se stessi. Non è semplicemente memoria psicologica di qualcosa che non è più,
sebbene abbia un effetto ancora sul soggetto, capace di produrre emozioni. Qui Dostoevskij sta
affermando l’essenza stessa dell’uomo: il suo essere memoria (ri-cordo) e presenza del sacro.
L’uomo, pertanto, non è profano anche se le sue azioni lo possono rendere tale.
L’essere sognatori, poi, rievoca la speranza: infatti, il disilluso non sogna più, non sa più
prendere le distanze dall’asprezza della realtà, non la sa vedere con occhi nuovi, limpidi… sognatori
appunto.
Per questo sognare appartiene alla giovinezza dell’anima, perché con la senilità si possono
anche perdere i sogni, per trattenere nelle mani solo la polvere delle proprie delusioni.
Protagonista o co-protagonista di questo inizio narrativo è la notte. Una notte che il sognatore
non teme, perché il silenzio dell’oscurità lo porta naturalmente a volgere lo sguardo verso l’alto, a
elevarsi dalle inquietudini dell’animo, per incontrare il cielo trapunto di stelle.
La notte, che ha suscitato i sogni di molte generazioni, paradossalmente oggi, nelle nostre città,
viene esorcizzata, avendola resa luminosa come il giorno2 in modo artificiale, tanto che non si è più
capaci di vedere le stelle.
L’inquinamento luminoso delle nostre metropoli ci impedisce di riconoscere le costellazioni
dell’universo, di percepirci immersi in un grande silenzio e in una profondissima quiete.
La notte un tempo silenziosa - ma non vuota di suono - è oggi riempita di rumori, spesso
assordanti, che impediscono all’animo di riconoscere l’alterità e di lasciarla emergere all’orizzonte.
Siamo in un mondo sempre più globalizzato, eppure siamo sempre più soli e abitati da paure che
tentiamo continuamente di scongiurare con “rituali” notturni che ne ottundano la coscienza, quali per 1 F. DOSTOEVSKIJ, Le notti bianche, Einaudi, Torino 2014, p. 3. 2 Nella Veglia pasquale si canta che «la notte splenderà come il giorno, e sarà fonte di luce per la mia delizia». Qui, però,
la luce non è un artificio perché è l’uomo stesso, in Cristo luce del mondo, a essere divenuto tutto luminoso. La notte del
peccato è infatti senza stelle perché, lontani da Dio e dal suo sguardo che è salvezza, si perdono tutti i punti di riferimento
e l’orientamento della propria vita. La luce pasquale è prima di tutto la luce di uno sguardo misericordioso e pietoso che
si volge sulla creatura amata per salvarla. La luce pasquale da cui l’uomo viene tutto illuminato fino a diventare esso
stesso luce è l’amore, che dalla croce, luogo di massima lontananza da Dio, si riverbera su tutta l’umanità e su tutta la
creazione perché ogni cosa sia com-presa in essa.
Introduzione
5
esempio la “movida” della notte, o l’happy hour o l’aperitivo della sera... Si cerca lo “sballo” come
soluzione per superare la caligine del vivere e l’angoscia del vuoto, perché il bisogno di luce è insito
nell’uomo che è fatto per la Luce che è Dio.3
Ma, già nel 1848, la solitudine è la paura che abita il cuore di questo sognatore innamorato e lo
tormenta: «Una certa angoscia aveva iniziato a tormentarmi fin dal mattino. A un tratto4 mi era
sembrato che tutti mi lasciassero solo, che tutti mi abbandonassero».
Pure abitato da questi fantasmi notturni, il giovane sognatore sa ancora alzare lo sguardo verso
il cielo per ammirarvi le stelle e cercarvi un orientamento, ed esse gli appaiono come una realtà
(dimensione) fondamentale per la vita dell’uomo.
In latino stella si dice “sidus”, e alle stelle sono legate molte parole della nostra lingua e della
nostra esperienza: con-siderare, per esempio, indica la capacità di esaminare con attenzione una realtà
in tutti i suoi aspetti, e deduce il suo significato proprio dall’esperienza di guardare insieme, in un
solo colpo d’occhio, le stelle del cielo. Oppure, il verbo de-siderare e il suo sostantivo desiderio che
indica un moto dell’anima, la cui particella intensiva de- li fa derivare entrambi dalla capacità di
fissare profondamente le stelle per scorgervi il significato divino delle cose.
Di fronte al miracolo del cielo stellato, il giovane sognatore cerca così il senso della propria
vita a partire dai desideri che muovono il suo intimo.
Davanti alle stelle sorgono le grandi domande sul senso e il fondamento della propria vita. Così
alle stelle si affida l’orientamento dell’esistenza per non perdere la bussola del proprio vagare nel
mondo. Da queste domande inizia un cammino tormentato che porterà il protagonista a scoprire
l’amore…a scoprirsi amato.
Le stelle sono fondamentali per l’uomo simbolico: Dante vi costruisce tutto l’impianto della
Divina Commedia come un cammino verso la Vita.
Inferno, Purgatorio e Paradiso non sono possibili condizioni che attendono l’uomo alla fine
della sua esperienza terrena, ma realtà che egli esperisce già mentre entra nella selva oscura
dell’esistenza e compie il suo tragitto per uscir fuori (nascere) a riveder le stelle.
Dante delinea così attraverso i tre mondi della Commedia delle qualità del cuore: solo
affrontando le proprie paure e il male che è dentro di sé, l’uomo può riemergere alla realtà, non
disilluso ma ancora sognatore, ossia capace di futuro… trovando questo futuro in Dio (Paradiso),
dopo aver purificato i propri desideri (Purgatorio).
E la domanda esistenziale del sognatore di Dostoevskij, appunto, nasce dallo stupore che sotto
un cielo così meraviglioso possa esistere il male (ira e ostinazione), una realtà che non è fuori di lui
ma in lui!
Tuttavia, a partire da questa constatazione dolorosa che accende il tormento dell’anima e la
percezione dell’essere lasciato solo nel suo male (de-solato) si avvia il suo processo di purificazione
e di liberazione e le stelle rimarranno per lui la memoria sacra del suo essere sognatore, cioè del suo
essere giovane nell’anima, del suo essere vivo.
La letteratura è uno dei luoghi privilegiati per l’espressione dell’esperienza simbolica
dell’uomo: nelle pagine che seguono il lettore troverà spunti, suggerimenti, elementi di riflessione
sull’eterna attualità di questa esperienza, declinata in funzione degli elementi cosmici. Esperienze del
cielo (dell’aria) dunque, ma anche della terra, del fuoco e dell’acqua.
3 Il sacramento del Battesimo era definito dai Padri della Chiesa come illuminazione, ossia come un venire alla luce della
grazia e della comunione con Dio, fino a esserne luminosa trasparenza. Anche l’episodio evangelico della Trasfigurazione
annuncia questo mistero di luce che è l’uomo. Infatti, il Signore trasfigurato non manifesta tanto qualcosa di Dio ma la
bellezza dell’uomo, ovvero il suo essere luce nella comunione Trinitaria, fonte di ogni chiarità. 4 Dostoevskij fa un costante uso nelle sue opere dell’avverbio russo vdrug che in italiano è stato reso con «a un tratto» o
«all’improvviso». Come è stato osservato dagli studiosi, può essere considerato come un nuovo tipo di cronotopo
(rappresentazione letteraria del rapporto tempo/spazio). Sebbene lo scrittore lo usi quasi in maniera inconscia e noi
inconsciamente lo recepiamo, esso traduce in realtà il Kairòs biblico, il momento in cui cielo e terra si uniscono, così
come tempo ed eternità. L’angoscia della solitudine diventa il momento favorevole, improvviso, in cui fare vera esperienza
del Sacro, ossia del Santo… un’esperienza di consolazione e di comunione (Cfr. nota 1, in F. DOSTOEVSKIJ, Le notti
bianche, Einaudi, Torino 2014, p. 3).
Introduzione
6
«Le realtà cosmiche, debitamente valorizzate, sono espressive d’altro; sono a loro volta un
linguaggio inconscio. L’universo cosmico fa simbolo con un universo interiore».5
L’interrogarsi e il riflettere sui simboli cosmici come archetipi dell’uomo e in riferimento alla
Sacra Scrittura si legano alla constatazione che nei racconti evangelici le azioni di Cristo sono spesso
legate a elementi naturali, come ad esempio la grotta della Natività e quella della Risurrezione, il
fiume del Battesimo, la montagna delle Beatitudini, il giardino dell’agonia del Getsemani e quello
dell’incontro del Risorto con Maria di Magdala.
Anche le teofanie veterotestamentarie hanno tutte una cornice cosmica: il fuoco ardente del
roveto, il mare dell’Esodo, la roccia percossa nel deserto, o la grotta di Elia.
Nell’immagine figurativa come nella icona, il luogo (topos) è significativo del senso del mistero
reso presente. Questa caratteristica non è esclusiva del linguaggio figurativo ma appartiene a ogni
linguaggio spirituale. Per tale motivo esso trova riferimento anche nella grande letteratura
dell’umanità, oltre che nei miti archetipici delle diverse culture.
Ci sono realtà, infatti, che sono esprimibili con un linguaggio concettuale, altre che
appartengono all’interiorità, che sono dicibili solo attraverso un linguaggio simbolico e poetico.
L’elemento cosmico, presente nei racconti creazionali, ritorna nella profezia di Baruc quando
si descrive liricamente l’istante in cui il Creatore chiama le sue creature ed esse gli rispondono
prontamente: «Le stelle brillano nelle loro postazioni e gioiscono. Dio le chiama per nome ed esse
rispondono: Eccoci! E brillano di gioia per il loro Creatore» (Bar 3, 34-35).
L’autore sacro attraverso questa immagine poetica descrive l’obbedienza delle realtà cosmiche
alla voce di Dio, il loro sottomettersi al giogo di amore del Signore – cosa che, invece, non farà
l’uomo decidendo di disobbedire alla parola e di nascondersi al suo sguardo – e narra così
simbolicamente la sua profonda esperienza di credente.6
C’è in questa pagina un riposare orante nel mistero in quel compiacimento divino che
appartiene al Principio: «E Dio vide che era tutto bello-e-buono». Per tradurre in termini umani questo
mistero della creazione che appartiene all’eterno e tocca il mistero stesso di Dio, la prontezza della
risposta: «Eccoci!» ci trasmette immediatamente la luce di gioia che brilla sul volto delle creature che
si sentono chiamate e accolte in una relazione di comunione con il loro Creatore e Signore.
Se gli eventi più importanti della storia della salvezza possiedono una cornice cosmica e gli
elementi della natura diventano essi stessi significanti sia nell’espressione verbale, sia in quella
figurativa, questo significa che sono strettamente legati con il contenuto dell’evento o della realtà
spirituale.
Esiste, in altri termini, un passaggio e una donazione di senso che va dall’evento alla cornice
cosmica e ritorna dalla cornice cosmica all’evento, ognuno illuminando ed essendo illuminato
dall’altro, ognuno rivelando ed essendo rivelato dall’altro.
5 É. LECLERC, I simboli dell’unione. Una lettura del Cantico delle Creature di san Francesco d’Assisi, EMP, Padova
20122, p. 29. 6 Quando l’uomo deve descrivere un’esperienza dell’interiorità lo fa sempre attraverso delle immagini e un linguaggio
simbolico-spirituale, perché si accorge che il linguaggio concettuale gli resiste, non potendo restringere in un concetto
ciò che per la sua ampiezza e profondità non si lascia esaurire. Il simbolo è, dunque, l’unica forma di linguaggio - come
vedremo - atta a significare il mistero di Dio e il mistero che è l’uomo. Vi è poi una dimensione fondamentale del narrare:
raccontando non solo si comunicano delle cose ma si conosce se stessi. La propria interiorità non è dicibile in altro modo
se non attraverso un racconto e una “rivelazione” simbolica.
17
Capitolo primo
IL COSMO NELLA BIBBIA
Tutto l’Antico Testamento s’inquadra in uno scenario cosmico: l’acqua primordiale, il mare, il
deserto, il fiume, la terra fertile, il giardino di Canaan, la montagna, il cielo trapunto di stelle, i lampi,
il fuoco, la caligine…
L’uomo biblico è consapevole di essere inseparabile dalla terra e di essere nato da essa. Il
secondo racconto della creazione7, infatti, descrive l’uomo come un manufatto di creta attratto alla
vita dal bacio di amore del Creatore che gli ha inalato il suo stesso respiro.8 L’uomo, pertanto, vive
una osmosi con il cielo e la terra: ha i piedi ben piantati al suolo ma nella verticalizzazione della sua
postura si protende naturalmente verso l’alto.
La natura è pertanto teofanica, perché è manifestativa di Dio ed è per l’uomo la via della prima
conoscenza di lui, come canta l’orante: «I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera delle sue mani
annuncia il firmamento» (Sal 18).
L’uomo biblico però è ben consapevole che il cosmo non è Dio, né si confonde con lui. Il cosmo
è manifestativo di una sapienza altra, ed è attraverso questa sapienza - di cui esso diviene trasparenza
e rimando - che l’uomo può risalire a Dio.
L’uomo biblico non ha un sentimento romantico rispetto alla natura: non si dice mai che una
data cornice naturale di un evento provochi un particolare stato d’animo, ma la cornice naturale
costituisce un dato oggettivo dell’evento.
Al sentimento di immensità del cosmo si accompagna quello della sua inconsistenza e
precarietà: il sole, la luna, le stelle sono sospesi nel firmamento e possono cadere in ogni momento,
perché Dio può scuotere le potenze del cielo e può togliere il respiro agli esseri viventi.
7 Cfr. Gen 2, 4b-24. 8 Il termine ebraico ruah significa sia soffio che spirito. Nella sua ampiezza semantica indica anche il respiro, declinabile
nella sua qualità di bacio che trasmette vita e che diventa condivisione. L’immagine del secondo racconto della creazione
sembra andare proprio in questa direzione là dove descrive l’atto del Creatore di inalare nel fantoccio di creta la sua stessa
vita attraverso un bacio che esprima allo stesso tempo il suo amore e la partecipazione di ciò che è [l’immagine] e di ciò
che ha [la vita] (Cfr. Ct 1, 2). Se l’uomo rimane attratto in questo bacio potrà restituire al suo Creatore ciò che è diventato
[somiglianza] e ciò che ha ricevuto in dono [l’amore], in una circolazione di vita che non conoscerà la morte, perché più
forte di essa (Cfr. Ct 8, 6-7). Sebbene l’uomo, pretendendo la sua autonomia, si è sottratto dal bacio del suo Signore
candendo nella morte, il suo generoso amante non lo ha abbandonato all’oblio ma lo ha cercato per trarlo dalla morte alla
vita attraverso questo ultimo sigillo della sua amorosa passione dato sulla croce, in quel soffio che ha inondato di vita
l’universo (Cfr. Gv 19, 30). Interessante a questo proposito è il commento midràscico della morte di Mosè legato al testo
di Dt 34: «Si udì una voce dal cielo che disse: “Mosè è la fine! Il tempo della tua morte è venuto!”. Mosè disse a Dio: “Ti
supplico, non abbandonarmi nelle mani dell’Angelo della morte”. Ma Dio scese dall’alto dei cieli per prendere l’anima
di Mosè e gli disse: “Mosè chiudi gli occhi!”. Mosè li chiuse. Poi disse: “Posa le mani sul petto”. E Mosè così fece. Poi
disse: “Accosta i piedi” e Mosè li accostò. Lo preparò così alla morte. Allora chiamò l’anima di Mosè dicendole: “Figlia
mia, ho fissato un tempo di 120 anni nel quale tu abitassi nel corpo di Mosè, ora è giunta la tua fine. Parti, non tardare!”.
E l’anima: “Re del mondo, io amo il corpo santo e puro di Mosè; non voglio lasciarlo!” Allora Dio baciò Mosè sulla
bocca in silenzio. E l’anima di Mosè si rifugiò in Dio che lo rese partecipe dell’eternità» Cfr. E. WIESEL, Personaggi
biblici attraverso il Midrash, Giuntina, Firenze 2011, p. 156. Sull’argomento si può consultare: M. FISHBANE, Il bacio di
Dio. Morte spirituale e morte mistica nella tradizione ebraica, Giuntina, Firenze 2002. L’evento drammatico della morte
è interpretato dall’uomo biblico come un nascere alla Vita, sostenuto dal bacio/Spirito che Dio continua a dare nella
fedeltà del suo amore. Solo Dio poteva trasformare la morte in vita, non annullando il mistero tremendo del morire, ma
cambiandone il significato tragico in un dono di comunione. La morte così non è più ciò che divide ma dove siamo uniti
al mistero pasquale di Cristo per partecipare della sua risurrezione e della sua gloria.
Il cosmo nella Bibbia
8
Anche in questo senso – che potremmo considerare negativo – il creato possiede un carattere
teofanico e l’uomo sente di condividere con tutte le realtà create la fragilità del proprio essere
corporeo e la relazione in lui intima con il suo Creatore: «Se nascondi il tuo volto vengono meno,
togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere» (Sal 104).
Paradossalmente per l’uomo biblico il creato è più vasto che per noi moderni: esso include oltre
agli esseri terrestri e acquatici, anche altri esseri viventi, i quali pur non essendo terrestri, esercitano
un influsso sugli abitanti della terra: si tratta delle potenze del cielo e delle potenze degli inferi, ossia
angeli e demoni.9
Sebbene l’uomo biblico non parli mai delle risonanze interiori che gli elementi cosmici hanno
su di lui, tuttavia gli eventi salienti della storia della salvezza sono tutti legati a elementi cosmici che
non sono assolutamente marginali o casuali. La rivelazione del Nome del Signore a Mosè avviene
per esempio sulla sommità di una montagna ed è indissolubilmente legata all’elemento fuoco e
all’elemento vegetale del cespuglio incombusto: «Dio lo chiamò dal roveto» (Es 3, 4). Così, Dio si
rivelerà a Elia nel sussurro leggero quando egli uscirà dalla caverna in cui si era rifugiato per venire
alla luce di una conoscenza nuova del Signore (1Re, 19, 11-13). In entrambi i casi appare chiaramente
l’impossibilità di separare l’evento spirituale teofanico dal suo supporto cosmico. Come ricorda
Leclerc nella sua lettura del Cantico delle Creature di san Francesco: «Le realtà cosmiche hanno da
offrirci una profondità che rimanda a valori interiori inconsci».10
Questa “oggettività” relativa all’elemento cosmico trova la sua espressione più limpida nella
rivelazione fatta a Mosè della struttura della Tenda, il cui archetipo è il tempio cosmico, opera di Dio:
«Guarda ed esegui secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte» (Es 25, 40).
Il cosmo e l’uomo contemporaneo
Per l’uomo moderno non esiste più questo legame diretto tra le realtà cosmiche e la sua vita. La
natura diventa oggetto di indagine scientifica, di godimento estetico, oppure un bene di consumo, o
un ambiente da sfruttare, o un bene da conservare e da salvaguardare.
La superiorità che l’uomo moderno pone tra sé e la natura - poiché si sente in grado di dominarla
– di fatto oggettualizza il cosmo.
«La cultura odierna è, in gran parte, dominata dalla visione scientifica del mondo. Per ‘mondo’ o
‘cosmo’ intendiamo la realtà che circonda e in cui vive l’umanità. […] Al binomio “Dio e l’uomo”,
caratteristico della cultura medievale impregnata di fede, dall’illuminismo in poi si è sostituito il
binomio “l’uomo e le cose”. Si è imposto il cosiddetto interesse scientifico per le cose e il loro
sfruttamento tecnologico, ossia la conoscenza degli aspetti quantitativi, misurabili e verificabili delle
cose da ‘usare’ e plasmare. La cultura moderna tende quindi a considerare il cosmo in sé, ossia nei
meccanismi del suo ‘funzionamento’ fisico indipendentemente dalla relazione con Dio, e in funzione
dei bisogni dell’uomo. Di conseguenza, la cultura moderna è anche cultura del potere: lo scopo della
vita è acquisire potere per soddisfare dei ‘bisogni’. Coerentemente il cosmo è anch’esso considerato
in funzione del potere dell’uomo. […]
La visione religiosa biblica non si propone come antiscientifica, ma rifiuta la pretesa totalizzante
della scienza, intesa illuministicamente, e rifiuta di essere adoratrice del potere. La fede infatti non è
ricerca di potere, bensì del senso e del dono che si offre a noi gratuitamente e liberamente. Nel
frastuono delle voci sollevate dalla scienza che serve al potere e della filosofia ridotta a scienza, la
fede – in quanto fede ragionevole o ragione credente capace di integrare in sé la visione scientifica
del mondo – cerca il senso e il valore del mondo per l’uomo in quanto essere-nel-mondo».11
9 Nell’ebraico biblico non troviamo un termine che corrisponda esattamente al nostro ‘cosmo’ o ‘mondo’, infatti usa dire
‘tutto’ per renderne il senso. Così nella cosmografia biblica il binomio cielo-terra, variato a volte in cielo-mare (Is 50,2)
o nel trinomio cielo-terra-mare (Ez 38,20) o inferi-cielo-mare (Am 9,2), designa l’universo intero come in Gen 1,1: «Nel
principio Dio creò il cielo e la terra». 10 É. LECLERC, I simboli dell’unione. Una lettura del Cantico delle Creature di san Francesco d’Assisi, p. 12. 11 A. BONORA, voce: Cosmo, in P. ROSSANO-G. RAVASI-A. GILARDA (a cura di), Nuovo Dizionario di Teologia Biblica,
p. 322.
Il cosmo nella Bibbia
9
Teoricamente, dunque, anche per l’uomo moderno il cosmo è immenso. Certamente, dal punto
di vista delle conoscenze teoriche lo è molto di più che per l’uomo antico, ma le conoscenze
scientifiche e la padronanza tecnica sulla materia e sullo spazio affievoliscono in lui questa coscienza
di relazione e di mediazione.
In forza di questo rapporto di dominio l’uomo moderno non percepisce più gli elementi cosmici
come creature imparentate con lui, ma come oggetti che si possono manipolare, utilizzare e dominare.
Nella relazione equilibrata, bilaterale, ma non paritaria tra Dio e l’uomo, è compreso anche il cosmo
di cui l’uomo non si considera ‘signore’ ma servitore e custode. Il cosmo è per lui una realtà dotata
di senso perché data in dono da Dio e a lui aperta. Servendo la terra Adamo servirà il suo Creatore e
Signore e pertanto la terra si presenta a lui come il fattore che media la relazione. L’uomo credente
percepisce che il senso ultimo delle cose riposa in Dio, così la fede toglie alla scienza e al potere
dell’uomo cui essa serve la loro pretesa totalizzante.
Nel binomio “uomo-cose” solo apparentemente c’è una mutua relazione; infatti il cosmo,
perdendo il suo significato alto di mediazione relazionale, è sottomesso allo sfruttamento e
all’acquisizione di potere per soddisfare dei bisogni.
Tra l’uomo e la natura si viene così a delineare un distacco fondamentale che si ripercuote anche
nella percezione del tempo. L’uomo moderno, infatti, non si corica più con il tramonto del sole, né si
alza con il suo sorgere, alterando così in sé i ritmi naturali della veglia e del riposo.12
Il rapporto dell’uomo contemporaneo con il mondo è fondamentalmente dualistico: circondato
quasi esclusivamente da manufatti umani, egli non è più in grado di percepire la comunanza, il legame
essenziale che a causa della sua condizione corporea lo lega alla natura e pertanto è portato a
considerarsi sopra e non più in essa.
Questo distacco però non è privo di conseguenze, come spiega Leclerc:
«Il guaio è che la natura non è soltanto davanti e fuori di noi; è anche dentro di noi. Siamo corpo e
anima, necessità e libertà, il tutto in maniera indivisibile. L’essere umano non è solo una coscienza
di sé che avrebbe qualche relazione accidentale con il cosmo, ma potrebbe benissimo essere
compreso a parte, nella sua soggettività pura, in relazione con altre soggettività pure. L’uomo
moderno, identificandosi con la propria coscienza e libertà, crede di potersi stare al di sopra del suo
essere naturale, di fare tabula rasa della sua “archeologia” e di tutta quella parte oscura, immersa
nella natura e nella necessità. In realtà, non fa altro che respingere nell’ombra le forze che sono sue
proprie, ma che non vuole riconoscere. Non per questo tali forze smettono di esercitare la loro azione
all’interno dell’essere umano, dentro la sua anima. L’anima, infatti, è più vasta della coscienza. […]
L’atteggiamento dualistico dell’uomo moderno, opponendo l’umano e il naturale, ha come
conseguenza la divisione dell’uomo stesso e quindi l’impossibilità di una sua riconciliazione totale
con sé e con i propri simili».13
Quando l’uomo ha verso il cosmo uno sguardo positivista che gli fa perdere il senso della
propria creaturalità, allora il cosmo perde per lui la sua caratteristica di manifestazione del sacro.
Percepire la lode cosmica che sale al Creatore è possibile là dove sotto la dimensione cosmica
appare la dimensione psichica, ovvero «Cosmo e Psiche sono i due poli dell’unica “espressività”; [in
quanto] mi esprimo esprimendo il mondo; esploro la mia stessa sacralità decifrando quella del
mondo».14
12 Anche per l’uomo antico la notte non è solo il tempo del sonno. Nei giorni invernali, senza luce artificiale, le notti sono
lunghe e pertanto dedicate in una sua parte allo studio, alla meditazione e alla contemplazione del cielo stellato, come
abbiamo visto fare dal sognatore di Dostoevskij. In molte vite dei Santi si dice che essi dedicavano il giorno al lavoro e
la notte alla riflessione e alla preghiera. Nell’esperienza rabbinica la notte era anche l’occasione per disquisire sulla Legge,
ovvero il tempo della conversazione edificante. La stessa celebrazione della Pasqua avviene di notte quale memoriale di
ciò che Dio ha operato per il suo popolo. La notte è, dunque, per l’uomo religioso – e l’uomo è di sua natura religioso –
il tempo in cui prendere contatto con la profondità di se stessi e unificare le proprie esperienze. Perdere il senso della
notte è quasi perdere il senso del proprio ‘Io’ più profondo. 13 E. LECLERC, I simboli dell’unione. Una lettura del Cantico delle Creature di san Francesco d’Assisi, p. 182. 14 P. RICOEUR, Finitudine e colpa. La simbolica del male, Il Mulino, Bologna 1970, pp. 257-258.
Il cosmo nella Bibbia
10
La lode cosmica è sempre una manifestazione esterna, attraverso il linguaggio simbolico e
poetico, di un cammino interiore e inconscio. Questo passaggio dall’ordine cosmico all’ordine
spirituale permette, infatti, a san Francesco di Assisi di cantare: «Laudato sì, mi’ Signore, cum tucte
le tue creature, spezialmente messor lo frate Sole… de te, Altissimo, porta significazione».15
Nel Poverello di Assisi c’è una unificazione totale dell’essere: l’esperienza del sole fornisce
una donazione di senso per cui egli accede dal livello sensibile a una dimensione ontologica.
«Francesco non si accontenta di vivere accanto alle cose. Vuole dirle, celebrarle in un canto che è
lode dell’Altissimo. Il canto è espressione di un’esperienza stupita del mondo. […] Le cose trovano
eco in noi solo nella misura in cui ci lasciamo sorprendere da loro nello stupore. […] Tirando l’uomo
fuori da se stesso, la meraviglia lo disappropria del suo ego e lo apre a una profonda comunione con
il mondo».16
Il cosmo è per l’uomo occasione di rendimento di grazie e di ricerca, perché l’universo nasconde
in sé un tesoro che il linguaggio della lode desidera portare alla luce.
Il simbolo dis-vela, infatti, qualcosa che è nascosto e non esiste per sé, ma è un mezzo per
veicolare significati altri. Il simbolo a differenza dell’allegoria, non fa ritornare al concetto, ma
permette di passare oltre, dal significante al significato senza mai esaurirlo.
Per esprimere questa potenza del simbolo, Pavel Florenskij muove da un paragone e usa
l’immagine della finestra che non fa passare la luce: in questo caso essa è un mero assemblaggio di
legno e di vetro, allo stesso modo il simbolo che non fa accedere a una realtà di ordine spirituale non
è simbolo.17 Il simbolo anche purifica, perché libera dal ripiegamento su se stessi e orienta alla luce
dell’Essere. Una luce che annuncia l’alba del sacro/del Santo.18
Sia la storia delle religioni sia la psicologia del profondo illustrano il significato simbolico che
il creato ha per l’uomo, ovvero il rapporto che intercorre tra natura e psiche.
La grotta, ad esempio, si presenta in tutte le culture con tre possibili valenze: come luogo di
germinazione e di nascita; di lotta mortale e di rinascita; di iniziazione a una sapienza nascosta.
Il simbolo cosmico ha dunque sempre un valore esistenziale, poiché rivela qualcosa che
definisce il destino dell’uomo-nel-mondo.
Per Eliade: «Il simbolo religioso traduce una situazione umana in termini cosmologici e,
reciprocamente; più precisamente, esso rivela la corrispondenza tra le strutture dell’esistenza umana
e le strutture cosmiche».19 La natura, insomma, non è che la proiezione e l’estensione al di fuori
dell’uomo del suo stesso essere corporeo.
Sempre Eliade mette in luce il nesso inscindibile che lega esperienza spirituale e linguaggio
simbolico.
«Oggi si sta comprendendo qualcosa di cui il XIX secolo non poteva avere nemmeno un
presentimento: che il simbolo, il mito, l’immagine appartengono alla sostanza della vita spirituale,
che li si può camuffare, mutilare, degradare, ma che non li si estirperà mai. […] Le immagini
degradate (dei miti antichi) offrono lo spunto possibile del rinnovamento spirituale dell’uomo
moderno. […] Sta all’uomo moderno “risvegliare” questo inestimabile tesoro di immagini che porta
con sé. […] Avere immaginazione è vedere il mondo nella sua totalità, giacché è potere e missione
delle Immagini mostrare tutto ciò che è refrattario al concetto».20
15 Fonti Francescane 263, Editrici Francescane, Padova 2004. 16 E. LECLERC, I simboli dell’unione. Una lettura del Cantico delle Creature di san Francesco d’Assisi, p. 229. 17 Cfr. P. FLORENSKIJ, Le porte regali, Adelphi, Milano 1977, pp. 60-61. 18 Come si vedrà meglio nel capitolo successivo, sacro e santo non sono sinonimi. Infatti, mentre il sacro si oppone
naturalmente e distintivamente a ciò che è profano, viceversa la realtà di santità apre a una dimensione di comunione. Lo
spazio e il tempo possono essere sacri, mentre l’uomo non può che essere santo, a immagine e somiglianza di colui che è
Santo (Cfr. Lv 19, 2). La santità si manifesta, dunque, non come opposizione ma come relazione e accoglienza di un
amore che sempre precede e trasforma. 19 M. ELIADE, Osservazioni sul simbolismo religioso, in Mefistofele e l’Androgine, Edizioni Mediterranee, Roma 2011,
p. 194. 20 M. ELIADE, Immagini e simboli, Jaca Book, Milano 2015, p. 15 e 22.
Il cosmo nella Bibbia
11
La problematica in campo cristiano.
L’illusione che accompagna la civiltà tecnologica e industriale è la pretesa di riposare sul potere
che l’uomo esercita sulla natura. Questa hybris moderna «è l’espressione di una ragione che domina
il mondo e che la scienza ha portato al suo massimo sviluppo. Non lascia spazio al canto o alla
celebrazione delle cose. Oggetto del canto e della celebrazione è, semmai, il potere umano della
ragione».21
Questa crisi dell’uomo-nel-mondo non ha solo un riflesso nella realtà spirituale ma anche nel
campo dei rapporti sociali che vengono sempre più esperiti come privi di profondità e di “umanità”.
Infatti, là dove lo sfruttamento tecnologico e industriale della natura sembra imporsi, anche la stessa
realtà umana viene compresa semplicemente in prospettiva funzionale e di puro rendimento.
Afferma a proposito Leclerc:
«La ferocia razionale con cui l’uomo moderno tratta la natura, si rivolge contro di lui e si ripercuote
sui rapporti con i suoi simili. Gli impedisce qualsiasi comunione profonda con gli altri, come anche
l’accesso alle sue stesse profondità. Lascia spazio soltanto a un’esistenza programmata: al regno di
un uomo “unidimensionale”».22
L’azione che l’uomo esercita sulla natura ha sempre inconsciamente un riferimento a lui. La
relazione che intercorre tra l’uomo e la terra è la grande intuizione della sapienza di Israele che abita
le pagine della Scrittura. L’uomo può incontrare Dio se con orecchio teologico sa riconoscere i passi
del Signore che incede nel giardino alla brezza del giorno per stare in compagnia con l’uomo (Cfr.
Gen 3, 8). Non è un caso che il libro dell’Apocalisse si chiuda con la visione dei cieli nuovi e della
terra nuova in cui è scomparso il mare come simbolo di morte, per accogliere la Città-Giardino che
scende dall’alto e in cui Dio e l’uomo dimoreranno insieme (Cfr. Ap 21, 1-4).
Certo, l’immagine del giardino richiama una natura non selvaggia e aspra ma addomesticata
dall’uomo. Dante stesso all’inizio del suo viaggio nei tre strati dell’anima, confida di essersi perso in
una selva che gli appariva come oscura e intricata, simbolo di una natura selvatica, ostile all’uomo,
in cui si perdono i punti di riferimento e dunque ci si smarrisce e si oblia il senso del proprio esistere.
In un corso monografico tenuto presso la Facoltà di Lettere di Padova, il professor Manlio
Pastore-Stocchi ricercò, nella cultura letteraria dalla tardo-latinità fino alla modernità, come la natura
venisse percepita e raccontata attraverso la relazione che l’uomo intratteneva con essa. Emerse da
quegli studi che il prototipo della natura letteraria bella e buona dovesse essere identificato nella valle
di Tempe. Ora, essa in se stessa è una comunissima vallata che si trova in una gola a nord della
Tessaglia, un luogo non particolarmente fascinoso, eppure assurse come topos letterario della natura-
giardino a portata dell’uomo. 23 Anche l’uomo antico, dunque, ha bisogno di un processo di
territorializzazione e, quindi, di intervenire sulla natura perché possa essere abitabile e gradevole,
oltre che utile; ma come osserva acutamente Marcuse: «la coltivazione del suolo è cosa
qualitativamente diversa dalla distruzione del suolo, l’estrazione delle risorse naturali è cosa diversa
dal loro sfruttamento dissipatorio, lo sfoltimento delle foreste non vuol dire disboscamento
indiscriminato».24
Nel secondo racconto creazionale il mondo è messo tutto a disposizione dell’uomo (Cfr. Gen
2, 16); così la Bibbia riconosce che c’è un potere che l’Adamo può esercitare sulla natura, purché sia
al servizio dell’uomo tutto intero. Immediatamente dopo, però, Dio raccomanda all’Adam di non
mangiare del frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male (v. 17), limitandolo nel suo
desiderio insaziabile, perché il rifiuto del limite porterà alla morte della relazione.
Porre un limite al godimento del tutto non è contrario alla vita: Dio mette in guardia l’umano
contro la bramosia che consisterebbe nel cedere alla tendenza totalizzante del desiderio, rifiutando
21 E. LECLERC, I simboli dell’unione. Una lettura del Cantico delle Creature di san Francesco d’Assisi, p. 234. 22 Ibidem, p. 235. 23 Cfr. E. MALASPINA, La Valle di Tempe, descrizione geografica, modelli letterari e archetipi del “locus amoenus”, in
Studi Urbinati B, LXIII (1990), pp. 105-135. 24 H. MARCUSE, L’uomo a una dimensione, Einaudi, Torino 1968, p. 249.
Il cosmo nella Bibbia
12
che un limite lo possa strutturare. Come abbiamo già detto, il rapporto non-ordinato con la natura
altera anche la relazione con l’altro da sé: Dio e i propri simili. La natura, divenuta oggetto
indiscriminato di sfruttamento non rinvia più all’alterità di Dio come fine ultimo dell’uomo -l’albero
del bene e del male, così come l’albero della vita, sono in realtà due ramificazioni del medesimo
tronco, ossia due attributi inalienabili di Dio: il quale è fonte della vita e quindi della norma. Allo
stesso tempo però fa dimenticare anche che essa è un bene di tutti. Il fallimento della comunione si
manifesta così come il fallimento della vita sociale. La Bibbia esprime questa tragedia umana
attraverso la pretesa dell’uomo di imporre un nome alla donna che dice la presunzione e il tentativo
di rimpossessarsi della costola di cui si era lasciato privare perché ella sorgesse al suo orizzonte di
senso e di valore (Cfr. Gen 3, 20; 2, 21-22).
Non dobbiamo meravigliarci se dopo la pagina drammatica di Genesi 3 in cui è messa in scena
la frattura della coppia, il narratore sacro racconti anche la rottura della fraternità e il sorgere di una
socialità violenta e vendicativa (Gen 4). Ma non è estranea alla Scrittura neppure la grande ubriacatura
tecnologica a seguito della scoperta del mattone che permette all’umanità di compiere la scalata al
cielo confidando nella sua capacità tecnico-scientifica (Gen 11). Proprio con l’episodio della
costruzione della città degli uomini e della torre di Babele, e la conseguente dispersione dell’umanità
sulla faccia della terra portando il segno dell’incomprensibilità, termina il racconto mitico del libro
della Genesi. Sappiamo che il linguaggio mitico è usato proprio per raccontare ciò che non è puntuale
e storico ma si verifica sempre, ovunque e in ogni contesto sociale. Il mito, quindi, esprime una
dimensione universale che ci permette di riconoscere quei processi che caratterizzano l’uomo nel suo
essere-nel-mondo.
La tentazione dell’uomo di questo inizio del III millennio di essersi essenzialmente staccato dal
mondo per porsi al di sopra della natura e del cosmo non è dunque nuova. Sebbene questo processo
sia in atto, tuttavia è vero anche che la relazione con la natura e il cosmo è sempre necessaria all’uomo
perché possa auto-comprendersi nella sua totalità. Così, appare chiara l’urgenza di riscoprire il senso
profondo di quella relazione che fa del cosmo un simbolo, ossia una chiave di accesso che permetta
all’umano di comprendersi nel suo mistero.
Se ciò è vero in generale, tanto più sarà pressante questa riappropriazione perché la vita cristiana
sia vissuta in pienezza. Questo richiede, però, un processo di riconciliazione e di unificazione della
persona, per poter dire con il salmista: «Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente» (Sal 84,
3). Un senso analogo lo ritroviamo nell’episodio evangelico in cui il Cristo «trasalì di gioia» (cfr. Lc
10, 21-24) prima di prorompere nel ringraziamento al Padre, dove il «trasalire» implica appunto la
partecipazione totale della sua persona che si unisce, con il corpo, all’esultanza dello spirito.
Il mondo cristiano, e in particolare quello occidentale, non solo è partecipe della crisi del
rapporto uomo-natura che caratterizza la civiltà industriale e ancor più, se possibile, la civiltà
cibernetica delle realtà virtuali, ma è stato segnato negli ultimi secoli da una forte connotazione
pessimistica nei confronti del corpo, la quale lasciava «supporre più o meno inconsciamente che esso
rappresentasse quasi un elemento limitativo delle potenzialità dell’anima, un peso o un ostacolo».25
Le conseguenze di questa situazione sono duplici: la prima, si caratterizza in una mancanza di
attenzione a ciò che attiene la corporeità, come se non esistesse la necessità di una sua integrazione
nel progetto spirituale personale e non dovesse perciò anch’essa venire evangelizzata nel profondo.
La seconda, intimamente legata alla prima, si manifesta nell’incapacità di ravvisare in quel linguaggio
simbolico cui fanno incessante ricorso le Sacre Scritture, la liturgia, i sacramenti e gli autori spirituali
d’Oriente e d’Occidente, l’unico linguaggio in grado sia di parlare alla totalità dell’uomo - coscienza
incarnata - e in particolare dell’uomo redento destinato alla risurrezione della carne, sia di esprimere
tale totalità. La corporeità non ben integrata nella vita spirituale, infatti, si “vendica” seguendo altre
vie espressive. A tale proposito scrive il gesuita psicoanalista Beirnaert:
«Nella misura in cui il sacramentalismo e, in generale, una rappresentazione religiosa, trascura l’uso
di figure archetipe e riduce il suo rituale a uno svolgimento schematico, perde la sua efficacia
sull’uomo pagano che dorme in ciascuno, le sfugge l’evangelizzazione del profondo. Allora gli
25 C. ROCCHETTA, Per una teologia della corporeità, Edizioni Camilliane, Torino 1990, p. 83.
Il cosmo nella Bibbia
13
archetipi che dormono nel fondo della psiche si creano degli idoli e fanno risorgere il paganesimo.
Allora ugualmente si è tentati di voltare le spalle al cristianesimo per cercare in altre figure e in altre
simbolizzazioni iniziatiche la pace del profondo».26
Se da una parte si riscontrano questi aspetti problematici, dall’altra c’è il recupero di un ampio
filone di ricerca, caratteristico della Chiesa occidentale nel XX secolo, sfociato nei grandi studi di
esegesi patristica e di liturgia.27 La riscoperta del linguaggio degli autori spirituali e della simbolica
figurativa medievale 28 ha condotto a una riappropriazione dell’espressione simbolica cristiana,
indicata come via privilegiata per uscire dalla sterilità dell’individualismo.
Scrive a proposito Hugo Rahner:
«Laddove i Padri hanno sviluppato dietro il velo delle immagini la loro teologia, noi troviamo una
tal ricchezza di simboli e di verità espresse attraverso i simboli, che potrebbe forse rendere ancor più
vive le nostre moderne proposizioni dommatiche sull’apologetica e il diritto ecclesiastico. Il
complesso dei simboli della Chiesa, che la teologia del primo millennio ci ha conservato, potrebbe
rinnovare completamente il nostro pensiero teologico sulla Chiesa, che per lungo tempo è stato
piuttosto sterile».29
La prima inculturazione del cristianesimo non si situa a livello filosofico, ma artistico, poetico
e liturgico; una operazione che è stata possibile proprio attraverso il linguaggio simbolico.
Si tratta per noi ora di compiere un esodo: passare dall’aridità dell’individualismo e dalla sua
deriva alla riscoperta del linguaggio dell’interiorità che non isola ma pone in comunione. La centralità
esasperata dell’individuo, ereditato dai secoli precedenti, ha portato nel suo crepuscolo e nel suo
momento di crisi a una frammentazione che si oppone recisamente al simbolo.30
La via che conduce alla riappropriazione del linguaggio simbolico cristiano si manifesta
provvidenzialmente come via ecclesiale, dove il primato non è più dell’individuo ma della persona,
ossia della comunione e della relazione, perché la persona è un volto che mi interpella e mi invita non
solo a prenderlo con me, ma in me.
È l’esperienza profonda di san Paolo che lo porta a esclamare: «Sono stato crocifisso con Cristo
e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me» (Gal 2, 20).
Questa è la novità della sua vita che egli non può non annunciare: questa è la salvezza che si
sente chiamato a testimoniare. San Paolo è divenuto per un dono di amore, teofanico, capace di
rivelare il volto dell’uomo redento e innestato in Cristo Gesù. L’efficacia apostolica di Paolo non si
fonda sulla sua capacità e abilità, ma sulla manifestazione di quanto Dio opera in lui per grazia.
Quando sarà chiamato a raccontare per tre volte la sua vocazione, Paolo avrà sempre chiaro che
Cristo, crocifisso e risorto, lo ha cambiato! (cfr. At 9, 1-19; At 22, 6-16; At 26, 12-18).
La Chiesa di Oriente e di Occidente è depositaria di un grande tesoro di sapienza spirituale, in
parte dimenticato; tuttavia esso è un bene il cui possesso non è indifferente, poiché appartiene
all’ordine della vita. La Sapienza che la Chiesa annuncia non è qualcosa di teorico ma sempre
esperienziale, perché la vera Sapienza è una persona che appella a un dialogo e a una comunione. È
un invito ad abitare in una casa solida, a mangiare e bere, a vivere in pienezza: «La Sapienza si è
costruita la casa, ha intagliato le sue sette colonne... e ha imbandito la tavola. A chi è privo di senno
essa dice: “Venite e mangiate il mio pane, bevete il vino che ho preparato. Abbandonate la stoltezza
e vivrete”» (Pr 9,1-5).
Questo tesoro, proprio in quanto esperienziale, è alla portata di tutti: il cielo, infatti, con il suo
sole e le sue stelle non è, malgrado tutto, un concetto vuoto nemmeno per l’uomo che vive nelle
26 L. BEIRNAERT, Esperienza cristiana e psicologia, Borla, Roma 1965, citato in M.G. MUZJ, Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente. Dispense universitarie, Pontificio Istituto Orientale, Roma 2002, p. 12. 27 Per citare solo alcuni nomi tra i più eminenti, ricordiamo quelli di Romano Guardini, Henri de Lubac, Jean Danielou,
Louis Bouyer. 28 Di particolare interesse lo studio divenuto ormai classico di Gerard de Champeaux sui simboli figurativi del Medioevo
cristiano (G. DE CHAMPEAUX -S. STERCKX, I simboli del Medioevo, Jaca Book, Milano 1988). 29 H. RAHNER, Simboli della Chiesa. L’ecclesiologia dei Padri, introduzione, Ed. San Paolo, Milano 19952, p. 10. 30 Il simbolo – come si vedrà meglio nel capitolo successivo – è di sua natura unione e rimando.
Il cosmo nella Bibbia
14
grandi città, né la montagna ha cessato di essere un invito a salire. Il fuoco continua a terrorizzare e
affascinare al tempo stesso e le viscere della terra, anche per chi non è mai entrato in una grotta,
evocano comunque immagini contrastanti di seppellimento e di protezione. L’acqua travolge e
distrugge o disseta e appaga; il giardino è sempre pace, ristoro, intimità.
Si tratta, dunque, di ascoltare la risonanza vitale contenuta nei grandi simboli cosmici che prima
di essere fuori di noi sono in noi e innervano costantemente il linguaggio della fede e della vita
cristiana. Ce lo testimoniano degli uomini, che hanno vissuto in pienezza la loro dimensione
spirituale, se ne sono serviti per esprimere l’itinerario di unificazione della loro persona e la loro
esperienza di comunione con quel «Gesù di cui i cristiani dicono che è vivo» (cfr. At 25, 19).
Poiché il simbolo non solo parla a noi ma parla di noi, di ogni elemento cosmico prenderemo
in esame quattro livelli: quello della simbolica generale o livello mitico-religioso; il livello della
Rivelazione biblica, osservando il ricorrere di un dato elemento cosmico nell’Antico e nel Nuovo
Testamento; quindi si farà emergere i significati simbolici attraverso i testi liturgici e le spiegazioni
mistagogiche dei Padri o di alcuni autori spirituali e, infine, come esso appare nell’espressione
letteraria e poetica non solo classica.
Questo itinerario a più livelli di senso ci permetterà di osservare come i simboli cosmici siano
presenti nella vita dell’uomo e non solo del cristiano; e come ricorrano nell’espressione di situazioni
spirituali diverse e di modalità differenti di vivere la relazione a Dio.
Un simile itinerario di riscoperta e di riappropriazione può suscitare una moltitudine di
domande in coloro che si accostano per la prima volta in modo sistematico alla problematica del
linguaggio simbolico quale parte integrante della vita dell’uomo.
Avventuriamoci in questo cammino che ci porterà nelle profondità di noi stessi per dare eco
alle tante domande che interpellano la nostra interiorità di uomini che, in quanto tali, sono di natura
religiosi.
L’uomo biblico e la natura: esperienza simbolica in letteratura
Christian Bobin è un autore francese contemporaneo, ancora poco conosciuto al grande pubblico
italiano, anche se negli ultimi anni è stato molto tradotto. È uno scrittore di forme ibride, che spesso
si muovono senza soluzione di continuità tra poesia e prosa, tra romanzo e saggio. La lingua di Bobin
è una lingua attenta, all’erta, che si muove in un cauto equilibrio tra i registri, tutta tesa com’è a
restituire la presenza dell’essere, celata in un dettaglio. La lingua di un cacciatore di farfalle, o di un
entomologo, che, una volta impadronitosi dell’incanto dell’«infinitamente piccolo», lo compone in
straordinarie miniature, in aforismi sospesi in una eterna, quanto quotidiana, immobilità. A chi gli
chiedeva, in una recente intervista, se non potesse essere considerato un “nostalgico dell’era
romantica”, Bobin ha risposto così:
«Penso solo che abbiamo nel petto un piccolo tamburo rosso e che abbiamo perduto le bacchette. La
scrittura ci restituisce le bacchette, permettendoci di ascoltarci a vicenda e di salutarci come esseri
viventi che non sono delle merci o dei clienti. Ognuno di noi, anche quando non ne ha coscienza, sta
giocando la partita della propria eternità. Le nostre anime hanno bisogno di ridere, dei poeti di tanti
secoli fa e di tutte le cose che oggi vengono definite inutili. Le nostre anime sono ignoranti in
contabilità. Tanto meglio così». 31
Le nostre anime sono ignoranti in contabilità: le cose inutili a cui esse rivolgono la loro
attenzione, anzi, di cui esse hanno bisogno sono le parole che si costellano in immagini, in storie. È
la scrittura che è in grado di restituirci il gusto dell’attenzione e la possibilità di reason not the need,
per dirla con King Lear, di non cavillare sul bisogno. In altre parole, la letteratura può restituirci
almeno il desiderio della nostra originaria e radicale libertà, e strapparci alla signoria pervasiva
dell’economia del mercato globale, in cui siamo solo consumatori, o come dice Bobin con più
gentilezza, clienti.
31 Da un’intervista su Avvenire, 30 aprile 2013.
Il cosmo nella Bibbia
15
Tornando al nostro autore, ciò che rende difficile riportare Bobin a un sentire “romantico” è
probabilmente proprio l’attenzione agli elementi concreti che fanno il mondo, e non alle reazioni del
soggetto che li dice. Una attenzione che è tutta linguistica, una attenzione “poietica” (poesia viene
dal greco poiesis, che a sua volta deriva da poieo, faccio) in cui non ha posto il sentimento dell’io
romantico comunemente inteso.
L’esperienza della scrittura, e quella speculare della lettura, è fondante: Bobin sembra suggerire
che essa fa il mondo: può aiutarci a comprendere secondo un’altra modalità ciò che viene affermato
dell’uomo biblico, che “non ha un sentimento romantico della natura”.
Da: Francesco e l’infinitamente piccolo
«La Bibbia è un libro fatto di molti libri, e in ciascuno di questi libri vi sono molte frasi, e in ognuna
di queste frasi molte stelle, olivi e fontane, asinelli e alberi di fico, campi di grano e pesci – e il vento,
dovunque il vento, il malva del vento della sera, il rosa della brezza mattutina, il nero delle grandi
tempeste. I libri d’oggi sono di carta. I libri di un tempo erano di pelle. La Bibbia è il solo libro d’aria:
un diluvio d’inchiostro e di vento. Un libro insensato, cha ha perduto il suo senso, perduto nelle sue
pagine come il vento nei parcheggi dei supermercati, fra i capelli delle donne, negli occhi dei
bambini. Un libro impossibile da tenere fra le mani tranquillamente, per una lettura calma, distaccata:
spiccherebbe immediatamente il volo, spargerebbe la sabbia delle sue frasi fra le dita. Si prende il
vento fra le mani e istantaneamente ci si arresta, come al principio di un amore, appagati: ho trovato
– ci si dice -, e ora finalmente, qui mi fermo, a questo primo sorriso, a questo primo incontro, a questa
prima frase che per caso era là». 32
«Si entra nella Bibbia attraverso la Genesi. Si è all’interno della Genesi come nella cassa toracica di
Dio, all’altezza del diaframma; ad ogni respiro il mondo si solleva, strati interi di mondo sorgono,
dapprima le acque, poi le terre, poi le pietre e le piante, poi gli animali, e infine, al termine del respiro,
l’uomo – e questa cosa sorprendente, questo enigma dell’ignoranza di Dio davanti alla sua creazione.
Poiché Dio che fa tutto non sa nulla di ciò che fa. Dio che fa gli animali non conosce i loro nomi:
“Allora il Signore Iddio modellò dal terreno tutte le fiere della steppa e tutti i volatili del cielo e li
condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato
gli esseri viventi, quello doveva essere il loro nome”. Le bestie vivendo accanto a Dio senza un nome.
Esse conservano in sé qualcosa di questo primitivo silenzio. Per un verso devono la loro esistenza a
Dio, per un altro all’uomo, Esse vagano, impaurite, fra l’uno e l’altro».33
«Il popolo ebraico è un popolo che Dio si è inventato nella sua miseria d’amore, un popolo solo per
lui. Per secoli Dio ha lasciato vagare la lanterna della sua voce sulla terra, vicino alle paludi, negli
anfratti remoti delle grotte, per secoli ha cercato qualcuno che potesse rispondere al suo amore, alla
sua follia, e non avendo trovato nessuno, li ha inventati, li ha presi al fondo estremo dell’Egitto
opulento: degli schiavi, delle ombre. Uno ad uno li ha radunati sotto le ali della sua voce, e ha detto
loro: ho messo il mio cuore in una terra lontana, in un paese di sorgenti e di ulivi solo per voi, vi ci
condurrò, vi porterò laggiù, nella terra promessa. Ed eccoli che si mettono in cammino, lasciando
l’Egitto e marciando in fila nel deserto, in colonne di nere frasi nella Bibbia. Quando levano la testa,
intuiscono la lunghezza del cammino, lo spessore del Libro, e talora si fermano, accendono un fuoco,
piantano le tende. Si fermano su dieci pagine per dieci anni. (…) Non è faticoso andare da un capitolo
all’altro. Ciò che è faticoso è sperare. Allora ogni tanto disperano, si abbandonano a un sonno
disperante, disperato. Non un passo di più. Non un solo passo di più. Maledicono Dio, poi si stancano
di maledirlo. Ne prendono un altro, più consono ai loro gusti. Qualunque cosa può servire da Dio
quando Dio manca. Allora Dio, quello vero, colui che li ama come un folle, colui che li conta uno
per uno, viene a rovesciare i picchetti delle loro tende, a tirarli per i capelli fuori dal letto tiepido
della disperazione, e di nuovo ripartono tra le dune di sabbia, lungo righe piene d’inchiostro. Dei
vecchi muoiono, dei bambini nascono. Il tempo passa. Si volta una pagina della Bibbia ed è un secolo
che passa, un secolo o due».34
32 CH. BOBIN, Francesco e l’infinitamente piccolo, trad. it Giovanna Troisi Spagnoli, San Paolo Edizioni, Cinisello
Balsamo 1994. 33 Ibidem. 34 Ibidem.
Il cosmo nella Bibbia
16
La scrittura di Bobin ci propone la fisicità che è alla radice del simbolo: le stelle, gli olivi e le
fontane, e gli asinelli e gli alberi di fico sono nelle frasi, esattamente come, nella Genesi, si è
all’interno della cassa toracica di Dio.
Nelle pagine che seguono i simboli cosmici sono a volte immediatamente evidenti, e sono
oggetto, o tema, del canto o della narrazione, altre volte sono mediati dalla riflessione. Tutti gli esempi
scelti, comunque, sono focalizzati sull’espressione di una esperienza simbolica, nel nostro caso di
un’esperienza di cielo, di acqua, di fuoco, di terra. Una realtà esperita simbolicamente si esprime
come un’apertura, come una domanda, come un movimento verso ciò che è oltre. Una realtà esperita
simbolicamente è dunque la domanda di una integrazione di senso. Un grande testo offre sempre al
lettore la possibilità di un’esperienza integrata tra ideazione e interpretazione. La grande letteratura
offre, in altre parole, la possibilità di un incontro. Nelle parole di Antonio Spadaro:
«Solo il lettore può tradurre l’espressione creativa in preghiera attraverso l’atto della lettura, e questo
perché la poesia richiede una risposta attiva del lettore: non rimane lettera inerte».35
È dunque possibile una dimensione orante nella lettura del testo letterario, che si configura come
risposta attiva del lettore alla sollecitazione che il testo gli offre.
San Paolo afferma che «lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo infatti
come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili» (Rm 8,
26), ma, per i nostri intenti, non si tratta di partire da categorie interpretative cristiane, in base alle
quali accettare o rifiutare quanto l’immaginario ci propone. A noi, in questo contesto, interessa
l’esperienza simbolica dell’uomo che, come il dolore nelle parole di Umberto Saba, è eterna: ha una
voce e non varia.
In questa nostra breve rassegna di suggestioni letterarie sulla simbolica cosmica metteremo
dunque da parte i paradigmi interpretativi del Novecento. La profonda riflessione del secolo scorso
sulla natura del testo letterario, sulle sue strutture e i suoi meccanismi, pur nella sua imprescindibile
validità (pensiamo alla narratologia), ha però progressivamente allontanato il discorso critico da una
dimensione, privata o pubblica che sia, che possiamo chiamare di risposta personale all’incontro con
un testo.
Per i nostri intenti, potremmo partire da quella volontaria sospensione dell’incredulità che,
nelle parole di Samuel Taylor Coleridge, costituisce la fede poetica. In un suo intervento l’anglista
Agostino Lombardo parlò felicemente alcuni anni fa di un passo ulteriore che si poteva compiere,
dopo Coleridge:
«Ma c’è, io credo, un ulteriore, e decisivo, e angoscioso passo che potrebbe definirsi della
“sospensione della sospensione dell’incredulità”: ovvero quando il diaframma pur sempre
rassicurante della finzione viene infranto, lacerato, dalla rivelazione che siamo sì di fronte a una
finzione, a un’illusione, ma che questa non scancella, non esorcizza la verità: questa esiste, ed è il
dolore, la morte, quel che possiamo chiamare il “sacro”».36
Il “sacro” non è solo dolore, non è solo morte, certamente. Ma colpisce la schiettezza lapidaria
di queste parole, che dicono di una ricerca tenace verso la verità, una ricerca in cui la letteratura può
aiutarci, essere nostra compagna, essere nostra voce, pregare con noi.
35 A. SPADARO, Letteratura e cristianesimo, Introduzione a Karl Rahner, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo 2014. 36 A. LOMBARDO, Il testo e la sua “performance”, Editori Riuniti, Roma 1986.
17
Capitolo secondo
IL SIMBOLO COME VIA ALL’UOMO
Eliade nei suoi studi sulla struttura e morfologia del sacro coglie anch’egli una differenza
sostanziale tra l’uomo delle culture arcaiche e l’uomo moderno, affermando che quest’ultimo ha
dimenticato la capacità di esperire la vita organica come sacramento, comunione, vincolo con
un’alterità originaria sconosciuta ma intuita presente.37 In altre parole, ha abbandonato la possibilità
che permetteva all’uomo arcaico di contemplare la volta celeste e di cogliervi la rivelazione di
significati decisivi per la sua maturazione interiore e spirituale.
«Per i “primitivi” in genere non esiste una differenza netta fra “naturale” e “sovrannaturale”, fra
oggetto empirico e simbolo. Un oggetto diviene se stesso (cioè incorpora un valore) nella misura in
cui riproduce un archetipo […]».38
Questa differenza si gioca a livello profondo dello spirito umano nel suo tentativo di
manifestare la propria intuizione delle cose e la propria interiorità. Lo spirito può rimanere ancorato
alla dimensione del sensibile oppure astrarsi, creandosi un campo concettuale che tende a diventare
tecnico.39
L’esperienza del sacro appare come un elemento strutturale della coscienza umana e non
semplicemente una condizione storica. Ovvero, l’essere religioso dell’uomo non rappresenta uno
stadio della sua evoluzione che, in linea di principio, può essere superato; quanto, piuttosto si tratta
di una condizione permanente dell’esperienza umana.
In quanto portatore di un fine l’uomo è naturalmente simbolico cosicché «mangiare è più che
nutrirsi, far l’amore è più che accoppiarsi, abitare è più che stanziarsi, la legge della casa, l’oikonomia
è più che accumulare beni».40
Il suo essere simbolico colloca l’uomo in rapporto con l’alterità - perché il simbolo è sempre
rinvio a un altro da sé – e, pertanto, lo definisce anche come apertura. In quanto homo symbolicus41
può cogliere, pertanto, un particolare legame tra la cornice cosmica, il significato spirituale di un
evento biblico e la propria interiorità.
Che cos’è il Sacro? La proposta di Eliade
Prima di veleggiare sul mare incantevole dei simboli cosmici è opportuno controllare i nostri
strumenti di navigazione.
Il primo strumento che vogliamo verificare è la stessa nozione di sacro, che attingiamo
dall’opera di Mircea Eliade. Dovendone definire i limiti egli offre questa definizione:
37 In verità questa capacità contemplativa non è mai perduta del tutto, perché l’uomo rimane di natura sua simbolico, cioè
capace di creare legami con un’alterità che sempre lo precede come Principio di ogni cosa. In quanto religioso poi è
portato a esprimere ed esperire le realtà della vita in chiave sacramentale, ossia come operosità e risposta a un dono (cfr.
M. MARELLI, Tutto è Cristo, Society Edition, Roma 2017, pp. 129-132). 38 M. ELIADE, Lo sciamanismo e le tecniche dell’estasi, Edizioni Mediterranee, Roma 1974, p. 287, nota 15. 39 Cfr. C.A. BERNARD, Teologia simbolica, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 19842, p. 11. 40 D. NAVARRIA, Introduzione all’antropologia simbolica. Eliade, Durand, Ries, Vita e Pensiero, Milano 2015, p. 136. 41 Homo symbolicus e homo religiosus non si equivalgono, né si sovrappongono o sono interscambiabili. Infatti, la
religiosità è una particolare regione del simbolico. L’uomo religioso non può non essere simbolico, ma questo non è
viceversa necessariamente valido (cfr. D. NAVARRIA, Introduzione all’antropologia simbolica. Eliade, Durand, Ries, op.
cit., p. 8).
Il simbolo come via all’uomo
18
«L’uomo prende coscienza del sacro perché esso si manifesta, si mostra come qualcosa del tutto
diverso dal profano. Per tradurre l’atto di questa manifestazione del sacro abbiamo proposto il
termine ierofania, che è comodo, tanto più in quanto non implica alcuna precisazione supplementare:
non esprime niente di più di quanto è intrinseco al suo contenuto etimologico, vale a dire che qualcosa
di sacro ci si mostra».42
Il sacro è dunque ciò che manifesta se stesso in un atto o evento; è un fenomeno distinto dalla
coscienza, che appare al soggetto e questi, in forza del suo scoprimento, ne prende consapevolezza.
Il sacro mostra di sé di essere diverso dal profano, perché mostrandosi o entrando nel campo dei
fenomeni, vi introduce un’opposizione polare e determinata. Essa è concomitante al suo mostrarsi, e
non si dà che con il suo manifestarsi. Il campo fenomenico prima omogeneo viene perciò segnato da
una differenza interna, del tutto nuova.
Il termine ierofania va assunto nel suo significato etimologico, tenendo presente che nessuna
religione sacralizza totalmente il campo dell’esperienza umana perché il sacro manifestandosi
introduce una spaccatura nel campo dell’esperienza, altrimenti omogeneo e indifferenziato. La nuova
differenza o opposizione caratterizza qualsiasi religione; anche se l’opposizione sarà configurata
diversamente a seconda dell’oggetto ierofanico, proprio di ciascuna di esse.
Il sacro si manifesta alla coscienza ma non entro la coscienza; la sua manifestazione avviene
nel campo dei fenomeni, che è distinto dalla coscienza; e non si dà a conoscere nel suo contenuto
mediante i sentimenti specifici che provoca al suo apparire ma si fa riconoscere in forza della
opposizione che introduce nel campo fenomenico. Eliade ritornerà su questa nozione fondamentale
della sua analisi.
«Si potrebbe dire che la storia delle religioni, dalle più primitive alle più elaborate, è costituita
dall’accumularsi di ierofanie, ossia dalle manifestazioni di realtà sacre. Dalla ierofania più
elementare, per esempio la manifestazione del sacro in un oggetto qualsiasi, una pietra o un albero,
alla ierofania suprema, che per un cristiano è l’incarnazione di Dio in Gesù Cristo, non vi è soluzione
di continuità. È sempre lo stesso atto misterioso: la manifestazione di qualcosa di completamente
diverso, di una realtà che non appartiene al nostro mondo, in oggetti che fanno parte integrante del
nostro mondo naturale, profano». 43
Appare chiara la rilevanza che ha la nozione di ierofania. Essa è in grado di dire quale sia il
fondamento di ogni religione o perché una religione sia tale; e di conferire unità e continuità all’intera
storia delle religioni. Potremmo dire che l’essenza del sacro, ciò che qualifica e determina un
fenomeno come religioso e lo distingue da ogni altro fenomeno non religioso è la ierofania, il
mostrarsi del sacro e l’opposizione al profano che esso istituisce al suo apparire. La continuità che la
ierofania stabilisce tra religioni diverse non abolisce la diversità; essa elimina la nozione corrente di
idolatria e la distinzione tra religioni idolatriche e false, o religioni del vero Dio e vere, basata sulla
dottrina religiosa. Nessuna religione è idolatria, perché nessuna religione adora un oggetto materiale
nella sua materialità.
È quanto Eliade spiega immediatamente, precisando ulteriormente la nozione di ierofania.
Qualcosa di sacro si manifesta in un oggetto del nostro mondo, ma come totalmente altro da ciò in
cui si manifesta. Si ha qui la nozione di oggetto ierofanico: vi sono gli oggetti che appaiono all’interno
del nostro mondo naturale o orizzonte di conoscenza di oggetti omogenei; in qualcuno di essi si
mostra il sacro, e mostrandosi introduce la differenza radicale tra la realtà che dischiude e quella
dell’oggetto in cui si manifesta. Non la pietra in generale è sacra, ma questa e solo questa pietra è
sacra, perché ierofanica. L’uomo arcaico, pertanto, non adora pietre o alberi in se stessi ma ciò che
in essi si manifesta e cioè il sacro che è tutt’altro dall’oggetto in cui si manifesta, proprio perché
quell’elemento diventando simbolico rimanda ad altro da sé.
L’oggetto ierofanico appare in un punto dello spazio e in un momento del tempo. Quel punto
permette di tracciare una linea di opposizione distintiva o di disomogeneità e discontinuità nel campo
fenomenico.
42 M. ELIADE, Il sacro e il profano, Bollati Boringhieri, Torino 1973, p. 14. 43 Ibidem, p. 14-15.
Il simbolo come via all’uomo
19
L’apparire del sacro introduce una differenza qualitativa entro lo spazio e entro il tempo, tra
il livello profano di realtà e il suo livello di realtà di tutt’altra qualità rispetto al profano. La ierofania
introduce così nello spazio, altrimenti omogeneo e amorfo, un punto di riferimento o centro, ossia un
asse di orientamento che permette un’organizzazione attorno ad esso di uno spazio sacro, essa può
essere un’area appena delimitata da segni tracciati sul terreno come la Roma quadrata di Romolo e
Remo), oppure uno spazio costruito come il tempio; segnando il passaggio dalla capanna alla casa,
dal villaggio alla città.
Lo spazio non è solo diviso in sacro e profano; la linea di divisione è anche linea di confine e
soglia di comunicazione. Il profano è sì distinto ma non isolato dal sacro, tanto meno esso occupa
tutto lo spazio. Infatti, solo se vi è comunicazione tra sacro e profano, il profano è per l’uomo arcaico
o primitivo, vivibile, organizzabile e abitabile.44
Lo stesso si dica del tempo. La ierofania introduce la discontinuità tra tempo omogeneo non
qualitativo e tempo sacro.
Sacro è il principio del tempo, non perché ne sia l’inizio, ma perché carico di sacralità o
differenza qualitativa rispetto agli istanti profani che seguono. Il principio con la sua differenza
qualitativa è immobile e eternamente ritorna. Esso offre il punto di riferimento e di determinazione
della linea temporale che è circolare e ciclica: al tempo del principio segue il tempo profano, ma la
successione più si allontana più si riavvicina al tempo del principio. Nella successione degli istanti
profani il principio del tempo è perciò sempre recuperabile e attualizzabile. Perciò sacro è ogni
principio, sia esso del giorno, della settimana, del mese o dell’anno, come pure di ogni azione. Ed è
il principio che permette di ordinare il tempo e istituire i calendari, dividendo il tempo sacro della
festa dal tempo profano feriale.45
Che significa tutto questo? Senza ierofania lo spazio è caos, privo di punto di riferimento, o
di orientamento, né vi è possibile alcuna organizzazione; pertanto non è abitabile dall’uomo; il tempo
è a sua volta una caotica e insensata corsa verso la morte. Un mondo totalmente profano è un mondo
senza senso e fondamento. Ma quella qualità viene iscritta dalla ierofania nel mondo fenomenico
dell’esperienza comune, come orizzonte aperto su un’altra realtà perenne ed efficace, che rende
abitabile lo spazio e vivibile il tempo, perché conferisce al mondo profano quel senso che l’uomo
cerca in esso.
Di qui quella nozione di cosmo, che varia da cultura a cultura e di esistenza santificata che la
ierofania e solo la comunicazione con essa consentono.
Simbolo, mito, rito sono per Eliade tre aspetti del sacro.
Il simbolo, infatti, che riproduce l’oggetto ierofanico - per esempio la lunetta in una religione
lunare che si appende al collo -, si distingue dalla ierofania; ma la rimemora, la prolunga, e anche la
sostituisce. Chi porta simboli vive nello spazio e nel tempo ierofanico.
Ma oltre a queste funzioni del simbolo, Eliade lo definisce come oggetto-segno che media la
conoscenza del sacro e ne è l’unico mediatore. Senza simbolo, o oggetto ierofanico, il sacro non è
conoscibile. La conoscenza religiosa è dunque una sfida per la conoscenza empirico-scientifica,
perché è altra da quella e fa conoscere qualcosa che quella non può conoscere. Spiegare il mondo
degli oggetti e comprendere il senso dell’esistenza umana nel mondo non è affatto la stessa cosa; lo
spiegare o la scienza, senza questa comprensione profonda, è priva di senso umano.
Infine, in quanto simbolo, l’oggetto ierofanico perde i suoi limiti di oggetto particolare,
divenendo frammento del tutto o del cosmo. In tal modo si carica di innumerevoli significazioni,
integra e unifica il maggior numero possibile di settori dell’esperienza antropocosmica, istituendo in
base alla opposizione distintiva una rete coerente di molteplici significati. Si tratta di una sorta di
costellazione semantica propria di ciascuna religione, un insieme coerente di senso del mondo sacro
e profano e del vivere umano in esso.
Il mito, a sua volta, è un racconto sacro. Se si chiedesse perché il cosmo o altro è sacro, l’uomo
religioso risponderebbe con il racconto di un mito.
44 M. ELIADE, Il sacro e il profano, Bollati Boringhieri, Torino 1973, pp. 19-46. 45 Ibidem, pp. 47-74. Si legga anche il saggio di N. SPINETO, La festa, Editori Laterza, Roma-Bari 2015.
Il simbolo come via all’uomo
20
Il mito è «storia sacra, racconto della ierofania avvenuta nel tempo del principio e primo atto
di costituzione del cosmo che è istitutivo delle forme di pensiero e di azione con cui l’uomo si
comprende nel suo mondo. Esso fissa i modelli esemplari di tutti i riti e di tutte le azioni umane
significative».46
Il mito racconta la ierofania originaria che sta alla base di una religione, il primo apparire del
sacro e la prima costituzione spazio-temporale del mondo come cosmo; un mondo umanamente
sensato per la presenza in esso di una differenza qualitativa perenne ed efficace. Non è, pertanto, una
spiegazione dell’origine fisica del mondo fisico, né si pone come antagonista ad essa.
Il mito è altresì distinto dalla fiaba o da una saga o leggenda, perché il mito è storia sacra o
meglio storia vera, storia dell’apparire di ciò che offre un senso a un mondo che altrimenti ne è privo.
Per tale ragione il mito svela il senso umano del mondo e l’origine del senso e fornisce all’uomo le
forme della comprensione di sé e del mondo in cui egli è; così delle azioni o del modo sensato di
praticare la sua esistenza nel mondo.
Infine, il mito offre il modello esemplare di tutti i riti o del come dare principio nel gesto sacro
ad ogni azione profana. Si pensi ai riti della nascita, adolescenza, matrimonio, ma anche al come
santificare l’azione profana lavorativa qualunque essa sia.
In questa triade il rito è celebrazione agita o drammatica del mito e la sua attualizzazione. Non
si tratta tanto del ricordo psicologico nel presente della ierofania spazio-temporale cosmica originaria,
quanto piuttosto il comunicare e il rendersi presenti all’ierofania originaria, ovvero il parteciparvi nel
presente eterno cui essa appartiene. Perciò il rito rigenera il mondo profano e lo ricrea, per così dire,
esso interrompe il fluire del tempo verso la morte e il caos introducendo nel tempo profano l’attimo
di eternità della festa, che rovescia periodicamente il senso del fluire temporale ripresentando al
tempo del principio. Il rito viene celebrato non per sottrarsi al profano, ma per potere vivere nel
profano attraverso la comunicazione con il sacro che libera dal non senso.
Per Eliade, la religione non è altro che una esperienza che conferisce un senso all’esistenza
umana nel mondo, senza il quale l’uomo non potrebbe esistere o vivere.
L’esperienza religiosa è dunque afferrare una differenza tra due livelli di realtà, di opposto
segno, qualitativo o no, portatrice di un’istanza di senso o privo di essa, rilevante in modo decisivo
per l’esistenza umana.
Il sacro sembra, dunque, la condizione di possibilità primaria perché l’uomo possa funzionare
e cioè esercitare tutte le azioni di produzione culturale, da quelle minime legate alla sopravvivenza e
alla convivenza sociale, alle massime legate al progresso.
Eliade parla di convinzione di cui però l’uomo ha bisogno. La religione, il sacro e l’esperienza
di esso, non è uno stadio della storia della coscienza; essa pertanto è anistorica, ossia la religione non
è una fase della storia dello spirito umano, un fenomeno storico apparso entro la storia, pari ad altri
fattori culturali ed economici. Senza il sacro e il mito non vi è alcuna storia umana possibile. C’è solo
l’insensatezza di un tempo che va irreversibilmente verso la morte, e privo perciò di ogni senso.
La religione appare come il fattore primario della costituzione della coscienza di sé; ed è un
elemento che la struttura la coscienza, ovvero la relaziona a quella realtà profonda senza la quale la
coscienza umana non potrebbe arrivare ad essere coscienza del proprio essere nel mondo. È, invero,
la religione che consente alla coscienza di scoprire il proprio essere nel mondo e la attiva ad istituire
il senso dei vari ambiti dell’esistenza profana.
Il sacro e il suo apparire alla coscienza è un evento costitutivo perché libera e salva la
coscienza dal non senso. La funzione antropologica della religione è dunque fondamentale per il
costituirsi della coscienza umana della propria esistenza nel mondo.
Se però tutta l’analisi si riducesse a questa ipotesi avremmo un grande elogio della religione,
ma l’elogio finirebbe con il coincidere con lo svilimento della religione stessa in funzione della
coscienza, quale realtà strutturante di sé.
Credo invece che Eliade voglia richiamare i limiti dichiarati della sua ricerca: non il sacro
come contenuto religioso esperienziale in opposizione alle nozioni speculative o razionali di esso, ma
46 M. Eliade, Trattato di storia delle religioni, Bollati Boringhieri, Torino 1999, p. 156.
Il simbolo come via all’uomo
21
il sacro come fonte di un’opposizione distintiva tra due livelli di realtà e due esperienze, sacra e
profana, e perciò funzione della coscienza e elemento primo che la struttura.
Che cos’è il mito? La proposta di Ricoeur
Paul Ricoeur riprende alla lettera la definizione di mito formulata da Eliade, ma con una doppia
precisazione.
La prima: per l’uomo moderno il mito è tale perché il suo spazio e tempo qualitativo non è
coordinabile allo spazio geografico e tempo fisico. Il mito non è storiografia o narrazione di fatti
storici avvenuti in un tempo cronologicamente databile e in uno spazio geograficamente definibile.
Da questa prima precisazione ne trae una seconda: il mito non è un racconto eziologico o un
tentativo fallimentare di spiegazione dell’origine del mondo fisico o di istituzioni sociali; il mito non
intende spiegare l’origine di nulla. Non è né scienza della natura né storiografia scientifica, che
sarebbe nel caso falsa.
Bisognerà, pertanto, operare una demitologizzazione, ossia liberare il mito dal senso letterale o
involucro primo che risulta scientificamente falso circa l’origine del mondo fisico, per coglierne il
messaggio religioso. Significa, in altre parole, comprendere che il mito è un discorso eterogeneo
rispetto a quello scientifico e storiografico, e non ha perciò alcun intento esplicativo dell’origine di
fenomeni fisici o storici. Il mito non va liberato da nulla; va solo identificato il genere di discorso che
gli è proprio, perché spazio e tempo sono concepiti qualitativamente e non sono collegabili a spazio
e tempo quantitativi della scienza e della storiografia.
Una volta stabilita la differenza tra storia e mito, Ricoeur esplicita la nozione di mito:
«Abbandonando la pretesa di spiegare, il mito rivela però la sua capacità di esplorazione e
comprensione, ciò che chiameremo più oltre la sua funzione simbolica, cioè il suo potere di scoprire,
di svelare il legame dell’uomo col suo sacro. Anche se ciò può apparire paradossale, il mito,
demitologizzato a contatto con la storia scientifica ed elevato alla dignità di simbolo, è una
dimensione del pensiero moderno».47
Ciò che identifica il genere di discorso proprio del mito e lo distingue a livello linguistico e
contenutistico è la sua funzione simbolica; è proprio la presenza del simbolo che identifica
linguisticamente il discorso mitico e il suo contenuto. In quanto simbolo e in forza della sua funzione
simbolica, il mito ha il potere di esplorare, scoprire e svelare il suo contenuto o il rapporto dell’uomo
al suo sacro. Così, l’analisi della esperienza religiosa è interpretazione e ermeneutica dei simboli e
dei miti in cui essa si esprime.
Anche per Ricoeur al pari di Eliade la dimensione religiosa è una dimensione dell’uomo
moderno e non solo dell’uomo arcaico. Ma Ricoeur non critica immediatamente la secolarizzazione
che fa perdere all’uomo moderno la coscienza di una sua dimensione fondamentale; gli ricorda solo
che in forza della differenza tra discorso religioso e discorso scientifico cui è possibile pervenire
chiaramente, mediante l’identificazione dell’eterogeneità di forma linguistica e contenuto dei due
generi di discorso, è in grado di distinguere tra i due senza perciò rinunciare alla dimensione religiosa
della coscienza umana.
Questa è la reale portata della demitologizzazione. L’uomo moderno in forza della scoperta
della scienza della natura e della storiografia scientifica è in grado di distinguere, a differenza
dell’uomo arcaico che non conosceva tale differenza, tra discorso religioso simbolico-mitico e
discorso scientifico.
Ricoeur non intende proporre una teoria completa del mito, ma limitare l’ambito dell’esperienza
religiosa presa in esame all’esperienza del male o alla confessione dei peccati, perché servirà a capire
più rigorosamente il legame dell’uomo col suo sacro.
Infatti, «Il male – impurità o peccato – è il punto sensibile, la crisi di questo legame che il mito
esplicita a suo modo; limitandoci ai miti concernenti l’origine e la fine, avremo la possibilità di
47 P. RICOUER, La simbolica del male, in Finitudine e colpa, Mulino, Bologna 1970, p. 249.
Il simbolo come via all’uomo
22
accedere a una comprensione più intensiva che estensiva del mito. Infatti, proprio perché il male è
per eccellenza l’esperienza critica del sacro, la minaccia di dissoluzione del legame tra l’uomo e il
suo sacro fa sentire con estrema intensità la dipendenza dell’uomo dalle forze del suo sacro».48
L’esperienza del male, essendo un momento di crisi dell’esperienza religiosa o di crisi del
legame dell’uomo al suo sacro, manifesta più chiaramente la dipendenza dell’uomo dalle forze o
dall’energia salvifica del sacro, che paradossalmente si coglie meglio, nel momento in cui l’aspetto
unitivo o partecipativo salvifico sembra svanire o è messo in crisi dalla colpa.
«Il mito della crisi è allora, al tempo stesso, il mito della totalità: raccontando come le cose sono
cominciate e come finiranno, il mito ricolloca l’esperienza dell’uomo in una totalità che riceve dal
racconto orientamento e significato. Si esercita così attraverso il mito una comprensione della realtà
umana in toto attraverso una reminiscenza e un’aspettazione».49
Il racconto dell’origine e della fine del male, collocato entro il racconto dell’origine, offre
all’uomo orientamento e significato circa la sua esperienza del male, cioè un itinerario per accedere
al senso del suo vivere il presente come colpa, attraverso una reminiscenza dell’origine del male e
un’aspettazione della sua fine. Per la coscienza religiosa l’esperienza del male che confessa nel mito
non è particolare o isolabile dalla totalità dell’esistenza umana nel mondo.
È possibile, dunque, percorrere l’itinerario di ricerca sull’esperienza del male perché oltre il
discorso speculativo e il mito c’è ancora il linguaggio: ossia il simbolo.
Se l’esperienza del male non riuscisse ad esprimersi e a pervenire al linguaggio e al linguaggio
del simbolo, sarebbe cieca, equivoca, scandalosa; un non-senso vissuto emotivamente ma non
analizzabile.
Ma come ha potuto l’esperienza emotiva riuscire ad esprimersi linguisticamente ed esprimersi
in quel linguaggio che è il simbolo?
L’emotività «ha suscitato l’oggettivazione nel discorso»; noi diremmo ha fornito la carica
necessaria per il passaggio all’espressione e a un genere specifico di espressione, il simbolo:
L’esperienza del male che restava opaca o insensata e sembrava contraddire l’istanza di senso
della coscienza, diventa analizzabile perché l’esperienza si è data in forza dell’emozione o della carica
emotiva un’espressione linguistica specifica e propria, prespeculativa e premitica, il linguaggio dei
simboli primari.
E i simboli sono dell’ordine del linguaggio, sono il primo livello del discorso: da un lato sono
il primo venire a parola dell’esperienza viva del male, espressione linguistica specifica e propria
prodotta dall’esperienza stessa; dall’altro lato il linguaggio dei simboli permette l’analisi
dell’esperienza mediante l’interpretazione, che partirà necessariamente dai simboli.
L’esperienza viva è dunque analizzabile, interpretabile, con un’ermeneutica dei simboli primari
e mediante i simboli dei miti, definiti in base alla loro funzione simbolica o potere di esplorazione,
scoperta, svelamento della cecità, equivocità, scandalosità dell’esperienza al suo livello meramente
emotivo.
Il simbolo ierofanico emerge in un oggetto del mondo ed è cosmico, il simbolo che emerge nel
sogno è onirico, il simbolo che emerge nella poesia è poetico, verbo creativo.
In ogni simbolo autentico sono presenti queste tre dimensioni.
Ma, i tre simboli sono tutti dell’ordine del linguaggio? Per il simbolo poetico non vi è dubbio;
è essenzialmente parola. Lo stesso per il simbolo onirico perché simbolo non è il sogno sognato ma
il sogno raccontato. Il problema sorge per il simbolo cosmico, che è un simbolo-cosa e non una parola.
È, dunque, anteriore o addirittura estraneo al linguaggio?
Ricouer non è di questo parere:
«Nient’affatto: essere simbolo, per queste realtà, significa raccogliere in un nodo di presenza una
massa di intenzioni significative che prima di far pensare, fanno parlare; la manifestazione simbolica
come cosa è matrice di significazioni simboliche come parole… la manifestazione attraverso la cosa
48 Ibidem, p. 249. 49 Ibidem, p. 250.
Il simbolo come via all’uomo
23
è una specie di condensazione di un discorso infinito; manifestazione e significazione sono
strettamente contemporanee e reciproche; la concrezione della cosa è la contropartita della
sovradeterminazione di un senso inesauribile che si ramifica nel cosmico, nell’etico e nel politico. Il
simbolo-cosa è quindi potenza di innumerevoli simboli parlati che a loro volta si combinano in una
manifestazione particolare del cosmo».50
Ricoeur si serve della definizione di simbolo ierofanico di Eliade come il centro che unifica e
integra realtà diverse. Ma ne trae la conclusione che la cosa o l’oggetto ierofanico è oggetto
sovraccarico di significati, simbolo-cosa che è simbolo o potenza di innumerevoli significati, che non
esplicita però le sue molte ramificazioni se non entrando nel linguaggio del simbolo-parola.
L’oggetto ierofanico non è un oggetto significante come la parola ed è simbolo solamente
quando il suo essere concentrazione in se stesso di molti significati si sviluppa in parola. Si noti che
per Ricoeur l’oggetto ierofanico non è sovraccarico di potenza benefica o malefica, ma di significati.
L’oggetto ierofanico è tale quando viene a parola la molteplicità dei suoi significati, quando si frange
in una molteplicità di simboli. L’oggetto ierofanico è perciò dell’ordine del logos.
Tra i simboli non vi è opposizione o contrasto: il simbolo cosmico rivela il sacro; il simbolo
onirico rivela la storia della coscienza individuale; il primo ha una funzione cosmica, il secondo ha
una funzione psichica.
Infine, vi è la terza modalità, quella del simbolo poetico o della immaginazione poetica:
«L’immagine poetica è più vicina al verbo che al ritratto; come dice molto bene Bachelard, essa ci
pone all’origine dell’essere parlante; diviene un essere nuovo del nostro linguaggio, ci esprime
facendoci ciò che essa esprime; a differenza delle altre due modalità del simbolo, quella ierofanica e
quella onirica, il simbolo poetico ci mostra l’espressività allo stato nascente; nella poesia il simbolo
è colto nel momento in cui costituisce un’insorgenza del linguaggio, in cui pone il linguaggio nel suo
emergere, anziché essere raccolto nella sua stabilità ieratica sotto la custodia del mito e del rito, come
nella storia delle religioni, oppure essere decifrato attraverso il riaffacciarsi dell’infanzia passata».51
C’è, dunque, una correlazione espressiva tra i simboli: dire il mondo dicendo sé e dire sé
dicendo il mondo, è esprimersi, il primo venire a parola del sé e del mondo.
In ognuno dei tre simboli sono presenti le tre dimensioni, ma i tre simboli si distinguono per un
loro tratto caratteristico: l’espressività originaria.
I simboli sono segni o espressioni che comunicano un senso; chi parla esprime un’intenzione
di significare, cioè di fare venire una cosa al significato o senso e comunicarlo.
L’intenzione di significare è interna, attraversa e permea il parlare. Ma non tutti i segni sono
simboli; il simbolo, infatti, nasconde nella sua visuale una doppia intenzionalità, un senso letterale
primo, convenzionale, (la macchia come sporco fisico) che mira però a una seconda intenzionalità o
senso al di là del primo (l’impurità, la situazione dell’uomo rispetto al sacro).
Il senso primo non dice la cosa (l’impurità), ma tramite la cosa (lo sporco) dice la situazione di
impurità dell’uomo, e lo dice perciò analogicamente; e non può dirla che così.
Il senso secondo è altro dal primo, dissimile dal primo, ma non è esprimibile se non attraverso
quel senso primo.
Che vuol dire analogicamente? Non è l’analogia di proporzionalità (a:b = c:d) in cui il secondo
rapporto è legato e dato dal primo; se il quarto termine dell’analogia è un’incognita, essa diventa
solubile. Nel caso del simbolo non si può dominare il legame tra senso secondo e senso primo o
letterale, e scoprire il secondo termine.
Ricouer propone un significato di analogia nuovo: solo vivendo nel senso primario sono da
questo trascinato al di là di esso. Il simbolo esprime dunque un movimento espressivo di cui mi è
dato solo il punto di partenza e di accesso al secondo, (lo sporco fisico), ma che mi spinge oltre verso
ciò che va esplorato per dire analogicamente ciò che altrimenti non potrei dire.
Il simbolo è una messa in tensione del linguaggio convenzionale e letterale per poter andare
oltre il senso letterale e convenzionale, e dire ciò che altrimenti sarebbe indicibile.
50 Ibidem, pp. 255-256. 51 Ibidem, pp. 258-259.
Il simbolo come via all’uomo
24
Il simbolo non è allegoria: nell’allegoria, secondo Pépin, il significato primario o letterale è
contingente e il significato secondo è sufficientemente esterno per essere direttamente accessibile. In
altre parole: l’allegoria o dire una cosa mediante un’altra è un artificio retorico; oppure è un
procedimento ermeneutico per dire che sotto il senso primo dei miti greci che sembra una falsa
teologia, ci sta il secondo che è una vera teologia.
Quello pertanto che si dice allegoricamente è traducibile in un significato letterale; fatta la
traduzione, l’allegoria diventa inutile. Il simbolo al contrario non offre un senso secondo coperto,
traducibile in un senso letterale; il suo senso secondo è opaco, enigmatico, cioè un senso evocato e
suggerito dal primo senso. Il simbolo linguistico di cui tratta non ha nulla da spartire con il simbolo
della logica matematica.
L’oggetto ierofanico è, dunque, un nucleo sovraccarico di significati che vengono a parola nel
simbolo o nell’atto del dire quei significati.
Per Ricoeur, mito e rito non sono più il racconto della ierofania originaria e la sua
drammatizzazione; non sono due segmenti di un’azione, che rendono partecipi del sacro e del suo
originario atto istitutivo del cosmo; al contrario sono parola e gesto che ripetono la relazione
intenzionata e non partecipata al sacro, e devono essere detti e agiti proprio perché la partecipazione
non è data, mentre è data la scissione attraverso l’esperienza del male.
Allo stesso modo, l’analisi del simbolo non può limitarsi alla identificazione del sistema del
mondo simbolico o alla coerenza interna dei suoi significati, perché in questo caso viene esclusa la
domanda di verità. Il simbolo, dice Ricoeur dà a pensare, ossia spinge a pensare a partire da esso, ad
andare verso il pensiero e la domanda di verità.
Ricoeur parte da Freud, perché la psicanalisi è un linguaggio: il suo oggetto di indagine è infatti
il sogno narrato che sviluppa simboli, i simboli onirici appunto, ed esige una interpretazione. Ma vi
è un secondo motivo: Freud non è solo uno studioso di un ramo della medicina, ma un interprete
dell’esistenza umana attraverso l’interpretazione della cultura, perché il simbolo onirico e il sogno
narrato non è solo individuale e biografico ma si estende all’area dei simboli religiosi e artistici che
sono presenti nelle culture e costituiscono la cultura nelle sue differenze storiche e etniche
Vi è infine un terzo motivo: il simbolo è un’espressione dal doppio senso, che muove da un
significato letterale primo a un significato secondo o intenzionato, l’interpretazione pertanto sarà
interpretazione del senso doppio.
Questa definizione ha una conseguenza notevole: l’interpretazione e l’ermeneutica si sdoppia
in meditazione del senso, propria della fenomenologia descrittiva delle religioni.
Ricordiamo che Eliade elabora l’ermeneutica del sospetto poi praticata da Freud, Marx e
Nietzsche.
La coscienza di sé non è affatto immediata; è mediata, simbolica o doppia, ed è perciò esposta
all’istanza del sospetto di essere fin dall’origine falsa coscienza mistificatoria. Di qui nasce poi il
conflitto delle interpretazioni e la necessità di abbandonare un’analisi ingenua e neutrale della
coscienza (Eliade) e correggerla con una analisi critica anche se non necessariamente distruttiva.
Ricoeur critica Freud, perché anziché distinguere tra simbolo cosmico, onirico, poetico, egli
riduce ogni simbolo al simbolo onirico che divide in due aspetti opposti e distinti tra loro, l’uno come
espressione del rimosso e dell’inconscio, e l’altro come espressione della immaginazione poetica.
Questa riduzione del simbolo onirico e la interpretazione del simbolo religioso motivano la critica
della religione come nevrosi e illusione sostitutiva e compensativa del desiderio inibito e rimosso, e
dall’altra l’interpretazione del simbolo poetico motiva la riduzione della poesia a sublimazione
sostitutiva ma non compensativa del desiderio inibito.
Se la riduzione freudiana del simbolo religioso al simbolo onirico fosse vera, la religione non
sarebbe che un’illusione, e il senso secondo o latente del simbolo sarebbe il desiderio rimosso e
inconscio. In tal modo verrebbe meno la distinzione del simbolo poetico da quello onirico.
Ricoeur elimina la riduzione freudiana e distingue il simbolo onirico da quello cosmico, in base
al diverso accento posto sul contenuto secondo, l’archeologia del soggetto (rimosso, infanzia) e la
teleologia (anticipazione dell’avvenire) del soggetto.
Il simbolo come via all’uomo
25
Il loro rapporto è dialettico; e cioè: il simbolo cosmico è ambiguo, può essere esposto a
perversioni oniriche, ed essere inficiato di immagini del sacro infantili o regressive, ma se ne distingue
anche specificamente. Anche il simbolo poetico non è riducibile al simbolo onirico o una sua
distinzione interna: il simbolo poetico pone l’accento sull’espressione anziché sul contenuto ed è il
verbo dell’immaginazione poetica, «che ci pone all’origine dell’essere parlante, un essere nuovo del
nostro linguaggio, ci esprime modellandoci secondo ciò che essa esprime».
Ricoeur offre un’ultima definizione di simbolo in rapporto circolare con quella di
interpretazione:
«Vi è un simbolo là dove l’espressione linguistica, a causa del suo senso duplice o dei suoi sensi
multipli, si presta a un lavoro di interpretazione. A suscitare questo lavoro è una struttura intenzionale
che non consiste nel rapporto del senso con la cosa, ma in una architettura del senso, in un rapporto
del senso con il senso, del senso secondario con quello primario, sia o no questo rapporto di analogia,
oppure sia il senso primario che nasconde il senso secondario o lo rivela. E’ questa trama che rende
possibile l’interpretazione, benché solo il movimento effettivo dell’interpretazione la renda
manifesta».
Il simbolo dunque ha una struttura intenzionale, che è quella del doppio senso, e non riguarda
il rapporto del senso alla cosa proprio di ogni segno, ma quello tra primo e secondo senso, analogico
o no, come quello onirico.
Conosciuta la struttura del simbolo è possibile interpretarlo, ma solo l’atto dell’interpretazione
la rende manifesta, la mette in luce. L’interpretazione di cui parla Ricoeur è limitata al simbolo; in
quanto dobbiamo ricordare che il simbolo è segno ma non tutti i segni sono simboli.
Classificazione dei simboli: la proposta di Girard
La caratteristica del simbolo - come abbiamo visto sia in Eliade che in Ricoeur - è il suo essere
plurivalente. Il lemma viene dall’antichità ed è già esso un termine composto: sym-bolon
(). Il primo elemento “syn” () è una preposizione che indica l’unione, mentre il
secondo “bólon” () è un deverbale da bàllein () che indica l’azione di “gettare”, nel
suo significato di “mettere insieme, far coincidere”. Quindi il symbolon indica il principio della
comprensione, ossia la capacità di comporre tante informazioni.
L’operazione rinvia a un procedimento arcaico di identificazione. Si spezzava un oggetto, in
genere una brocca o un oggetto di ceramica; i due pezzi venivano ad assumere una forma
assolutamente unica e solo mettendoli insieme potevano combaciare e determinare una unità. I due
pezzi sono da mettere insieme, ma non è che ognuno dei due pezzi fosse chiamato simbolo; il “sým-
bolon” è propriamente l’azione di mettere insieme i due pezzi, il passaggio dalla parte al tutto, dal
frammento all’unità. L’elemento importante è proprio questo: ristabilire l’unità e determinare una
conoscenza e una comprensione di senso.
Proprio perché il concetto di simbolo è molto ampio Marc Girad ha proposto una
organizzazione delle categorie e delle classi di simboli: si tratta di uno modello classico e
comunemente accettato.52
Partiamo dai simboli di quarta classe, che rappresentano la categoria più semplice.
I simboli di quarta classe
Questo gruppo accoglie i simboli meno importanti e la simbolizzazione più elementare.
All’interno di questo insieme possiamo identificare i simboli chimici. Si tratta di abbreviazioni dei
lemmi per lo più latini con cui vengono nominati i diversi elementi.53
52 M. GIRAD, Les symboles dans la Bible. Essai de théologie biblique enracinée dans l’expérience universelle, 1995. 53 Per esempio, per indicare il rame viene usato il simbolo “Cu” (dal latino cuprum), così per dire l’elemento oro il simbolo
“Au” (dal latino aurum).
Il simbolo come via all’uomo
26
È una pura convenzione per cui anche chi adopera una lingua completamente diversa, come un
chimico tedesco, abbrevia nello stesso modo. È quindi una convenzione e la matematica è piena di
simboli di questo genere. “X” ad esempio è sempre una incognita, ma anche le lettere dell’alfabeto
fonetico sono segni di questo tipo. L’alfabeto latino ha le sue lettere, il cirillico, il greco, l’arabo
hanno le loro, però il suono corrispondente all’alfabeto fonetico è sempre quello.
Sono dei segni, dei simboli estremamente convenzionali, non c’è nulla di fondato; sono pure
convenzioni. Ecco perché sono di quarta categoria. Non c’è nulla nel simbolo “Au” che richiami
l’oro, è solo la convenzione di usare le prime due lettere del nome latino (aurum) a giustificare questa
scelta. Per poter comprendere questi segni è necessario conoscere la convenzione (cultura) per cui si
è operata quella determinata scelta. Non c’è nessun rapporto con la realtà, è puro accordo
convenzionale. Dunque, tutti questi elementi simbolici di quarta categoria sono i più deboli, i meno
significativi e per il nostro studio i meno importanti.
Simbolizzazione di terza classe
Anche a questa categoria appartengono degli emblemi convenzionali, che hanno, però, la
caratteristica di essere dei segni distintivi. Un esempio classico è la bandiera.
La bandiera è un pezzo di stoffa con dei colori, eventualmente dei disegni, delle righe, degli
oggetti.
Perché la bandiera italiana è a tre strisce verticali e la bandiera tedesca è a tre strisce orizzontali?
Qual è la motivazione che le distingue?
È soltanto questione di una abitudine inveterata e di una fissazione in cui però un popolo e una
Nazione si riconosce e si contraddistingue dalle altre.
I tre colori della bandiera italiana allora che cosa rappresentano? Secondo un’antica poesiola
scritta nei “sussidiari” delle scuole elementari di un tempo, nel vessillo dell’Italia ci sarebbe il verde
per ricordare i nostri prati, il bianco per le nostre nevi perenni, e il rosso in omaggio ai soldati che
sono morti in tante travagliate guerre. Su questo tema hanno profuso rime anche poeti di fama come
Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Renzo Pezzani, Ada Negri....
Davvero il verde dei prati, il bianco delle nevi, e il rosso di un sangue versato tra le lacrime di
un’intera nazione per duecento anni è la trasposizione allegorica del nostro Tricolore? È difficile
identificare tra i tanti chi e come ha inventato una simile leggenda. Leggenda romantica, ma non vera.
Alla luce della Storia essa appare puerile e senza senso. Può essere il tema di una filastrocca, ma è
inconcepibile che una penisola frazionata in tanti piccoli stati, abbia avuto col Risorgimento la forza
di unirsi per celebrare prati e nevai.
Nasce quindi il sospetto che l’ignoto cantore di tale favola abbia voluto nascondere una realtà
ben diversa, e molto più seria e drammatica. Una verità difficile da gestire quando oggi, grazie ai
motori di ricerca come Google, la storia patria reale, è interamente riscritta. La bandiera italiana è
nata nel 1794, quando due studenti di Bologna, Giovanni Battista De Rolandis e Luigi Zamboni,
tentarono una sollevazione contro il potere assolutista che governava la città da quasi 200 anni. I due
presero come distintivo la coccarda della rivoluzione parigina, ma cambiarono l’azzurro col verde
per differenziarla dall’originale francese. Il significato allegorico è rimasto comunque lo stesso: un
Tricolore come traguardo di un popolo che mirava ad avere Giustizia, Uguaglianza, Fratellanza.
Può dunque riprodurre un modello antico o qualche cosa di simbolico, certo è che la bandiera
rappresenta la patria a tal punto che è ritenuto un reato il vilipendio della bandiera perché non è
semplicemente un pezzo di stoffa, ma un simbolo importante.
È un simbolo che richiama qualcos’altro; dobbiamo tener presente che la stessa nozione di
patria è, d’altra parte, un concetto astratto.
L’Italia può essere una «mera espressione geografica» come avrebbe detto il Metternich,
tuttavia è certamente una realtà concreta, ma che non è possibile raffigurare come patria italiana, se
non attraverso una simbolizzazione come la Bandiera.
Il simbolo come via all’uomo
27
Eppure, stranamente la squadra di calcio italiana ha la maglia di colore “azzurro” e i nostri
giocatori sono semplicemente appellati come gli “Azzurri”. Di nuovo ci troviamo di fronte a una
convenzione!
Simboli di seconda classe
I simboli di seconda classe sono quelli che potremmo definire emblemi radicati in una realtà.
La pace, per esempio, è generalmente simboleggiata da una colomba. Se una persona è coraggiosa
verrà facilmente paragonata a un leone, se invece timida piuttosto a un coniglio.
Lo scettro, il bastone, è il simbolo del potere, del comando; così la Croce è il simbolo del
cristianesimo; la Mezzaluna dell’Islam; la Stella di Davide dell’ebraismo.
Sono segni convenzionali?
Partiamo dagli ultimi tre: Croce, Mezzaluna, Stella di Davide.
La Stella di Davide - gli ebrei propriamente lo chiamano Scudo (in ebraico “maghen”) - e la
Mezzaluna sono simboli arbitrari, quindi appartengono di più alla terza classe, come le bandiere.
La croce, invece, ha un fondamento perché c’è il riferimento a un oggetto fondamentale nella
realtà del cristianesimo. La croce è un segno, che rimanda a un oggetto concreto ed è un oggetto che
ha segnato in modo decisivo la realtà cristiana, per cui c’è un fondamento nella realtà così come la
colomba è animale mansueto e pacifico.
Questo simbolo porta in sé un elemento naturale, come il leone che è aggressivo, forte,
coraggioso. C’è un elemento in natura che giustifica questi abbinamenti.
Il bastone, che viene utilizzato come arma, è la simbolizzazione degli strumenti che si
adoperano nel comando, nell’esercizio dell’autorità. Ci sono quindi molti strumenti di questo tipo che
diventano simbolici; ad esempio nel mondo dell’Apocalisse abbiamo l’agnello con sette corna e sette
occhi che rappresenta Gesù Cristo.
Anche in questo caso si tratta di emblemi radicati nell’esperienza: l’occhio è la conoscenza, gli
animali che hanno le corna le usano per combattere quindi è segno di forza. L’agnello riprende tutta
la tradizione della liturgia di Israele, del sacrificio, il servo paragonato all’agnello, e quindi riassume
una grande quantità di messaggi. Tuttavia, non siamo ancora nella prima classe.
La prima classe di simboli
I simboli di prima classe sono quelli fondamentali che a livello psicologico si chiamano onirici,
ossia che appartengono ai sogni; sono gli elementi comuni alla natura umana.
A noi interessano soprattutto da un punto di vista mitico-religioso; sono dei simboli che
raccontano un fondamento di fede. Si potrebbe adoperare la terminologia di Carl Gustav Jung che
parla di “archetipi”, ovvero di “modelli che stanno al principio”, che sono primordiali e primari.
Questi sono i simboli di fondo, gli elementi che hanno un particolare significato per la comprensione
della vita e valgono, in genere, per tutti gli uomini.
Partiamo da un esempio: le ali come strumento del volo. Ora, nessun uomo vola, ma tutti gli
esseri umani hanno sempre sognato/desiderato di volare e ci sono dei miti, in tutte le culture, in cui
degli uomini hanno in qualche modo imparato a volare o che vengono sollevati su ali d’aquila e
portati in alto. Le ali sono pertanto il simbolo del volo e non possono voler dire altro. Tutti - di ogni
cultura o religione - pensando alle ali riflettono su una dimensione di sollevamento e di innalzamento.
Si tratta di elementi importanti anche nei sogni. Si sogna, infatti, di volare, oppure di cadere nel vuoto.
Il mito di Icaro che vola e precipita è un elemento fondamentale poiché abita nel simbolo archetipico.
Nel nostro studio ci occupiamo di questi simboli di prima classe che sono i simboli
fondamentali dell’immaginario umano.
Girard nel suo libro li elenca e li prende in rassegna a uno a uno. Essi sono: il fuoco, l’acqua,
la tenebra, il vento, la nube, la pietra, la terra, il lievito, le ali, la montagna, gli animali ostili,
l’arcobaleno etc.
Il simbolo come via all’uomo
28
Terra, fuoco, acqua, aria sono i quattro simboli fondamentali. Quindi, quando si parla di fuoco
o si parla di acqua, si fa riferimento ad una situazione archetipica, di fondamento primordiale che
appartiene al nostro modo di pensare anche se inconscio.
Le esperienze fondamentali
Nell’ambito dei simboli di prima classe Girard suppone un quadro interpretativo in funzione di
quattro esperienze essenziali. Ritiene, infatti, che - in base a una sintesi di tipo psicologico e filosofico
– si possa parlare di quattro esperienze umane assolutamente fondamentali.
La prima esperienza è la coscienza che esista qualcosa di trascendente che si manifesta.
Trascendente nel senso dell’alto, è la coscienza di una forza dall’esterno che si rende presente e si fa
sentire e percepire.
La seconda esperienza è quella legata ai nostri primi nove mesi di vita; sono stati i mesi
fondamentali di cui non abbiamo nessun ricordo e sono l’esperienza della incubazione, cioè
dell’essere raccolti e avvolti nel seno materno. È una esperienza che segna profondamente la nostra
psiche. Il seno materno da una parte avvolge, protegge e nutre, ma oltre quel tempo determinato dalla
natura uccide per cui è necessario nascere, uscire dall’utero materno e venire alla luce. L’esperienza
che si determina è quella della uscita dall’elemento avvolgente, proteggente, con il desiderio, tuttavia,
di ritrovare l’ambiente primordiale da cui veniamo, quindi il desiderio di avvolgimento, di protezione
fino al grembo della madre terra. È uno dei motivi per cui i popoli primitivi seppelliscono i morti in
posizione fetale, non distesi ma raggomitolati; li rimettono nel seno della madre terra in attesa di una
nuova nascita.
La terza esperienza, fondamentale, è la coscienza di essere assaliti da forze ostili; è
l’esperienza dei nemici, degli avversari, del male, di qualcuno o qualcosa che ci ferisce o ci toglie la
vita, uccidendoci.
La quarta esperienza è il bisogno di elevazione e di auto-superamento, cioè di crescita, di
maturazione. È l’esperienza del desiderio, del diventare, di essere.
Le realtà simboliche possono allora essere rapportate a questi elementi di fondo, e pertanto i
simboli vengono catalogati secondo queste quattro esperienze basilari.
Una prima categoria raccoglie i simboli teofanici, cioè quelli che manifestano la divinità.
Una seconda categoria comprende i simboli matriziali; in termine tecnico si chiama “matrice”
l’utero, il seno materno e quindi non simboli materni, ma simboli matriziali o matriciali, ossia legati
cioè all’esperienza dell’avvolgimento, della protezione ma anche del bisogno di uscita, del venire alla
luce
La terza categoria abbraccia i simboli ponerologici. “Poneròn” in greco vuol dire “male” e
quindi l’aspetto ponerologico è un modo per dire il mondo negativo; sono tutti i simboli del male,
della morte, di ciò che assorbe o toglie vita.
La quarta categoria assembla i simboli di verticalità cosmica, che tendono ad una salita di tipo
spaziale e indicano un itinerario verso l’alto.
Queste quattro esperienze non sono isolate ma in rapporto fra di loro.
La prima e la terza riguardano delle forze esterne al soggetto che le sperimenta e di cui prende
coscienza. Ecco perché c’è conoscenza di un trascendente che si manifesta o percezione di qualche
forza maligna che può far male. Essendo una presa di coscienza, riguarda l’intelligenza e la
comprensione. La persona si accorge che c’è qualcos’altro oltre a lui, qualcosa che gli produce un
bene e qualcosa che gli fa del male e gli crea danno; qualcuno che lo aiuta e qualcuno che invece lo
ostacola.
Bisogna qui fare attenzione, perché il riferimento è a una realtà al di là della dimensione umana;
non si tratta infatti del fatto di avere delle persone amiche o dei nemici. Il nesso è piuttosto
quell’esperienza comune per cui si pensa che ci deve essere qualcosa di più, qualche essere, qualche
ente oltre noi. Poi in ogni cultura gli si attribuiscono una varietà diversa di nomi, ma essendo una
esperienza primordiale essa è presente in ogni latitudine e in ogni tempo. Così questi esseri vengono
esperiti buoni o malevoli a seconda dell’influsso che hanno sulla nostra vita.
Il simbolo come via all’uomo
29
La seconda e la quarta, invece, riguardano proprio la persona in sé ed esprimono dei bisogni
profondi. L’esperienza del ciclo lineare e orizzontale della vita, l’esperienza indicata come matriziale,
è quella della linea temporale dell’esistenza, dalla nascita alla morte; è il ciclo.
La parola “ciclo” vuole infatti indicare il cerchio, una cosa chiusa; è l’idea del ritorno dal seno
della madre al seno della madre terra. Noi parliamo di una linearità, ma abbiamo anche l’idea di un
ciclo che ritorna. È un elemento naturale nella fisiologia femminile, è anche il ritorno della luna e il
ritorno della fecondità che è al principio della nascita e della generazione.
Sono i simboli radicati nell’esperienza della vita ed è il bisogno profondo di vivere, di
continuare vivere.
La quarta esperienza è il bisogno profondo di salire. L’immagine verticale indica la necessità
che la persona umana ha di “diventare”. In genere nessuno desidera scendere, ma tutti desideriamo
salire. È solo una immagine, un elemento simbolico, però è archetipo della coscienza. Migliorare,
vuol dire salire, ma può essere degradato al semplice desiderio di far carriera per salire di grado.
Possiamo notare delle altre relazioni. La prima e la quarta sono caratterizzate dalla verticalità;
il simbolo teofanico indica anche qualche cosa che dall’alto viene verso il basso, è il trascendente che
si dà a conoscere attraverso una discesa. Il simbolo cosmico invece indica una salita, una ascesa; è
proprio il processo inverso. Si immagina che qualcuno dall’esterno venga giù fino a me, ma c’è anche
il mio desiderio di salire fin lassù.
Invece gli altri due, il secondo e il terzo, hanno fra di loro il rapporto che potrebbe essere quello
di azione e di reazione. Da una parte c’è la vita, la generazione, dall’altra l’opposizione: far vivere e
far morire. È l’esperienza di ciò che opera il bene e l’esperienza contraria di ciò che opera il male.
Tutti questi elementi sono raccolti intorno ad un unico tema. Finora non si è fatto un discorso
religioso, ma semplicemente umano che può essere filosofico o psicologico, però il grande tema
unitario che tiene insieme queste esperienze fondamentali e questo processo di simbolizzazione ha
una radice profondamente teologica: l’idea che sta alla base è quella di liberazione, ovvero di
salvezza.
Il tema unitario di tutte queste realtà simboliche è l’intervento del trascendente che salva, il
desiderio di uscire, di essere liberato per vivere ed essere salvato; il difendersi dalle forze che
aggrediscono e il salire verso l’ambiente della realizzazione piena della salvezza.
Capitolo terzo
IL CIELO
Il cielo è per gli uomini di tutti i tempi la rivelazione della trascendenza: è alto, infinito,
immutabile, incorruttibile, totalmente altro rispetto a noi.
San Basilio, meditando la settimana primordiale del libro della Genesi, commenta:
«Se, qualche volta, in una notte serena, fissando gli occhi sulle bellezze inesprimibili delle stelle, hai
pensato all’Autore dell’universo, [domandandoti] chi, di questi fiori, ha ricamato il firmamento».54
(BASILIO IL GRANDE, Omelia 33 sull’Esamerone).
Basilio percepisce il cielo nella sua valenza simbolica, richiama alla sua interiorità un prato
trapunto di fiori luminosi, un mare in cui navigano nuvole leggere, è il cielo dello stupore e della
meraviglia.
«La conoscenza poetica del mondo precede, come conviene, la conoscenza razionale degli oggetti.
Il mondo è bello, prima di essere vero. Il mondo è ammirato prima di essere verificato. Ogni
primitività è onirismo puro».55
Per l’umanità nel suo insieme, come per ogni piccolo di uomo, prima viene lo stupore, poi la
contemplazione, infine la rappresentazione.56
Il cielo come rivelazione della Trascendenza
Alla contemplazione del cielo è legata l’esperienza religiosa primordiale dell’umanità; come
spiega Mircea Eliade:
«Il cielo rivela direttamente la sua trascendenza, la sua forza e la sua sacralità. La contemplazione
della volta celeste suscita nella coscienza primitiva un’esperienza religiosa - non un’idea ma una
esperienza. L’espressione “contemplazione della volta celeste” ha un significato del tutto diverso se
la riferiamo all’uomo primitivo, aperto ai miracoli quotidiani con un’intensità difficilmente
immaginabile per noi. Questa contemplazione equivale, per lui, a una rivelazione. Il Cielo si rivela
quel che è in realtà: infinito, trascendente. La volta celeste è per eccellenza “cosa del tutto diversa”
dalla pochezza dell’uomo e del suo spazio vitale. Il simbolismo della sua trascendenza si deduce,
diremmo, semplicemente dalla constatazione della sua infinita altezza. “L’altissimo” diventa, nel
modo naturale, un attributo della divinità».57
Dio non può che abitare il cielo, ossia in uno spazio diverso dal finito, altro, rispetto allo spazio
misurabile.
Nel cielo non ci sono punti di riferimento, c’è una profondità senza fine e la categoria di infinito
è insita nell’uomo, è dentro di lui.
Tutte le cosmologie primitive collocano la divinità suprema nella profondità dei cieli, in un
luogo estraneo allo spazio misurabile. Alto, puro, irradiante splendore, cielo notturno scintillante di
54 BASILIO IL GRANDE, Omelia 33 sull’Esamerone. 55 G. BACHELARD, Psicanalisi dell’aria, Red Edizioni, Cornaredo (MI), 2008. 56 Ibid. 57 M. ELIADE, Trattato di storia delle religioni, Bollati Boringhieri, Torino 2008.
Il cielo, rivelazione della trascendenza
31
stelle, cielo diurno «mondo della trasparenza, materia vibrante»58, il cielo è sempre per l’uomo
rivelazione della Trascendenza.
In Guerra e pace, Tolstoj offre un ottimo esempio di “esperienza del cielo”.
Quando il principe Andrej Volkonskij, ferito, giace a terra supino, scopre il cielo:
«Sopra di lui non c’era più nulla, se non il cielo: un cielo alto, non sereno, ma pure infinitamente
alto, con nuvole grigie che vi strisciavano sopra dolcemente. “Che silenzio! Che quiete! Che
solennità! Non è più come quando correvo – pensò il principe Andrej, - non è più come quando
correvamo gridando e combattendo; […] non è così che le nuvole scorrono su questo cielo alto,
infinito. Come non lo vedevo prima questo cielo così alto? E come sono felice di averlo finalmente
conosciuto. Sì! Tutto è vuoto, tutto è inganno, fuori che questo cielo infinito. Non c’è niente, niente
all’infuori di esso. Ma anch’esso non esiste, non c’è nulla all’infuori del silenzio e della tranquillità.
E Dio ne sia lodato!».59
L’esperienza del cielo è dapprima quella di un nulla, poi di un nulla profondo, poi di una
profondità che si manifesta come quiete e come silenzio.
Ciò che il principe Andrej conosce non è la natura scientifica del cielo, ma esso gli attesta
piuttosto un evento spirituale che lo coinvolge affettivamente: egli ha scoperto il cielo “alto, infinito”
che si impone come unica realtà esistente, al di fuori della quale “tutto è vuoto, tutto è inganno”, ossia
in ultima analisi non-essere, il nulla.
L’esperienza del cielo è quella dell’alterità assoluta: mentre agitazione e rumore caratterizzano
il mondo degli uomini, il cielo diventa il tramite attraverso cui l’uomo giunge alla scoperta del silenzio
che è pienezza di significato.
L’esclamazione finale: “E Dio ne sia lodato!”, traduce il sentimento di ringraziamento per la
rivelazione di un segreto vitale per l’uomo.
Il principe Andrej riporta a Dio la manifestazione del mistero di cui l’uomo ha l’intuizione sin
da quando appare sulla terra.
L’immaterialità del cielo è “solenne”, rivelativa per l’uomo, perché vi coglie un rapporto tra la
natura del cielo e il suo proprio essere. Un rapporto che si configura come parentela: «Sono figlio
della terra e del cielo stellato: in verità sono di stirpe celeste».60
Mentre fa l’esperienza dell’alterità assoluta del cielo “altissimo”, l’uomo pone l’esistenza di un
legame intrinseco tra sé e il cielo. Il convincimento di questo legame trova fondamento sulla capacità
dell’uomo di “abbracciare” il cielo e di cantarlo. Se l’uomo può cantare i cieli significa che vi è
qualcosa in lui che partecipa del loro essere simbolico.
Solo l’uomo è capace tra tutte le realtà create di udire il canto del cielo e di cantare il cielo.
Nei salmi, il canto del cielo è innanzitutto canto di silenzio, l’inno muto ma possente che
riempie l’universo.
«I cieli narrano la gloria di Dio, / l’opera delle sue mani annuncia il firmamento. / Il giorno al giorno
ne affida il racconto / e la notte alla notte ne trasmette notizia. / Senza linguaggio, senza parole, /
senza che si oda la loro voce, / per tutta la terra si diffonde il loro annuncio / e ai confini del mondo
il loro messaggio» (Sal 19).
Come nel bianco luminoso sono contenuti tutti i colori dello spettro, così in questa musica di
silenzio è contenuto il canto del mondo: l’uomo, pur percependo solo il silenzio, ne «conosce» la
qualità di pienezza:
«O Tu, l’Aldilà di tutto, / come chiamarti con un altro nome? / Quale inno può cantarti? / Nessuna
parola ti esprime. / Quale spirito può coglierti? / Nessuna intelligenza / Ti concepisce. / Solo, tu sei
ineffabile; / tutto ciò che si dice è uscito da te. / Solo, tu sei inconoscibile; / tutto ciò che si pensa è
uscito da te. / Tutti gli esseri ti celebrano, / quelli che parlano e quelli che sono muti. / Il desiderio
58 G. BACHELARD, La fiamma di una candela, Edizioni SE, Milano 2010. 59 L. TOLSTOJ, Guerra e pace, libro I, parte III, cap. 16. 60 Frammento orfico 17
Il cielo, rivelazione della trascendenza
32
universale, / il gemito di tutti aspira a te. / Tutto ciò che esiste ti prega / e verso di te / ogni essere
che sa leggere il tuo universo / fa salire un inno in silenzio. / Abbi pietà, o Tu l’Aldilà di tutto; / come
chiamarti con un altro nome?».61
Anche il silenzio è un simbolo informale: non è assenza ma piena presenza. Il cielo narra in
silenzio.
Il cielo come rivelazione del centro
Come suggerisce con un’immagine poetica Gerard de Champeaux, la ripetizione delle
interminabili osservazioni eseguite nel grande silenzio misterioso delle notti da pastori e nomadi per
secoli e millenni ha inciso nelle profondità dell’uomo, fino nel suo subconscio, come su un disco di
cera, l’immagine concentrica tracciata in cielo dalle stelle ed è proprio la presa di coscienza del valore
rivelativo di tale immagine-esperienza a costituire «la via regale che conduce alla riscoperta dei
grandi segreti del passato».62 Se accogliendo questa suggerimento, cerchiamo di percorrere la via
regale della contemplazione del cielo notturno, scopriremo che, oltre alla rivelazione dell’altezza
come valore sacrale, essa offre anche quella del Centro, scaturigine del movimento universale e di
ogni esistenza.
L’esperienza del Centro è inseparabile dall’osservazione della rotazione delle stelle intorno a
un punto-centro immobile, identificato con la stella polare. Questo movimento circolare invariabile,
senza inizio, né fine, né mutamento, avviene in un profondo silenzio ed evoca la figura di una danza
celeste.63
Il cielo trapunto di stelle è sempre un cielo teofanico ed è il modello perfetto del cosmo. Esso
è immaginato come una immensa tenda circolare, tesa a partire da un’asta centrale che coincide con
l’asse celeste, o asse cosmico, e ha il suo perno nella stella polare.
Il centro è prima di tutto il Principio, è Dio stesso. Per irradiazione questo punto principale e
assoluto determina tutti gli esseri. La Polare è il Centro, il Principio del movimento celeste, il luogo
simbolico del trono di Dio. Questo trono si colloca al di sopra del firmamento e sopra le acque
superiori (in excelsis). Dio fa ruotare la cupola celeste su quella colonna di vuoto che è l’asse del
mondo. Nulla sostiene questo asse, mentre esso sostiene tutto, comunica il suo movimento di
rotazione al firmamento e in questo modo dà vita alla terra. Questo asse fa comunicare i piani del
mondo: cielo, terra, sheol. Si intende allora la parola di Giobbe: «Egli stende il settentrione sopra il
vuoto» (Gb 26,7).
Oltre al punto-centro, la contemplazione del cielo rivela una seconda figura simbolica
fondamentale, il cerchio. Questo è prima di tutto un punto esteso: quindi partecipa alla sua perfezione.
Così punto e cerchio condividono alcune proprietà simboliche: perfezione, omogeneità, assenza di
distruzione o di divisione.
Il cerchio, però, proprio perché si distingue dal suo Principio, svela il mondo come effetto creato
che si diffonde dal centro.
Il Paradiso terrestre, prima della caduta, viene raffigurato in forma circolare attraverso
l’immagine delle viscere di misericordia che abbracciano e proteggono, separando lo spazio
lussureggiante dal deserto (Cfr. Gen 2, 4b-25). Ne sono un esempio figurativo il mosaico della
creazione nell’atrio della Basilica di san Marco a Venezia e le miniature con la creazione di Adamo.
Anche la creazione dell’uomo, come la creazione del cosmo è dunque in Dio. Il Paradiso
terrestre è circolare perché anteriore al tempo, esso partecipa dell’Eterno. Non ha senso un cielo senza
centro, poiché il cerchio è sempre un’estensione del punto-centro.
61 Gregorio di Nazianzo. 62 G. DE CHAMPEAUX - S. STERCKX, Simboli del Medio Evo, Jaca Book, Milano 1988, p. 17. Per questo paragrafo sul
significato del cielo nell’immaginario umano seguiamo da vicino il testo di Champeaux, pp. 263-268. 63 Platone («il coro di danza degli astri» (Timeo 40c), Dionigi («E tutto ciò che è e diviene, è e diviene a causa del Bello-
e-Buono e tutto guarda verso di lui, è mosso e mantenuto da lui» DN IV,10,705C).
Il cielo, rivelazione della trascendenza
33
Ma il cielo non è solo rivelatore dell’alterità assoluta, lo è anche dell’interdipendenza tra mondo
celeste e mondo terreno e, in quanta tale, fonte straordinaria di immagini verbali e figurative. Se
passando dall’osservazione del girotondo immutabile degli astri intorno alla stella polare, centro del
cielo, l’uomo ferma lo sguardo sulla linea dell’orizzonte, puntandolo sui due punti privilegiati del
sorgere e del tramontare del sole, può osservare un altro movimento grandioso che nel corso dell’anno
fa compiere alle costellazioni dello zodiaco - la fascia dell’eclittica - un movimento che va da est a
ovest. Attraverso un’osservazione antica quanta l’umanità, l’uomo ha infatti verificato che la
collocazione delle costellazioni dello zodiaco rispetto a questi due punti nei momenti significativi
dell’anno (equinozi e solstizi), corrispondeva alle quattro stagioni e scandiva dunque i cicli stessi
della vita dell’uomo: le quattro costellazioni cardinali segnano i tempi forti nella corsa solare: sono il
Toro (Primavera), il Leone (Estate), lo Scorpione (Autunno), l’Acquario (Inverno).64
L’uomo fa esperienza così che la sua sussistenza dipende dal cielo: fissando lo sguardo sulla
linea dell’orizzonte coglie i due punti privilegiati del sorgere e del tramontare del sole, che segna
l’alternarsi di giorno e notte, di luce e tenebre.
Il movimento circumpolare incrociandosi con il movimento delle costellazioni viene a
determinare una croce.
In tale osservazione, il sole svolge il ruolo fondamentale di cursore celeste. La figura che viene
evocata, di importanza incalcolabile per la simbolica generale, e quella di una gigantesca giostra a
quattro cavalli che gira senza fine intorno all’asse della sfera del mondo. Nell’arte primitiva la
svastica è il disegno del centro creazionale, in cui le braccia della croce sono riduzioni del movimento
circolare. Il movimento a vortice esprime proprio il dinamismo creazionale. Grazie al sole, l’arco di
cerchio disegnato nel cielo dalle costellazioni zodiacali entra dunque in rapporto con la quaternità
dell’orientamento terrestre.
«Il sole che ogni mattina appare in questa direzione e che scompare al contrario nella direzione
opposta; che, nel corso della giornata, culmina a mezzogiorno, poi ridiscende dalla parte opposta,
disegna nello spazio abitato dall’uomo quattro direzioni primordiali che sono le quattro grandi strade,
attraverso le quali questi prende coscienza del suo dominio terreno. La prima consapevolezza del
quaggiù-generato-dal-cielo si realizza così sotto lo schema immaginario generale di tale quaternità;
ricordiamolo bene. La ragione ne è che l’uomo è un animale essenzialmente orientato, per struttura
psichica, tanto quanto organica e scheletrica. Egli possiede una faccia ventrale e una dorsale, una
lateralità destra e una sinistra. Non può compiere nulla senza riferire, almeno inconsciamente, la
propria orientazione a quella del paesaggio cosmico in cui deve necessariamente inserirsi per essere
sé stesso e agire. […] La rivelazione attraverso il sole delle quattro direzioni rivela così l’uomo a se
stesso e, contemporaneamente, alla distesa spaziale che con lui e in lui entra nella realtà».65
La giostra è il derivato del modello del cielo e la si ritrova come immagine simbolica nella
visione di Ezechiele del carro di Jahvé:
«Io guardavo, ed ecco un vento tempestoso avanzare dal settentrione, una grande nube e un turbinìo
di fuoco, che splendeva tutto intorno, e in mezzo si scorgeva come un balenare di metallo
incandescente. Al centro, una figura composta di quattro esseri animati, di sembianza umana con
quattro volti e quattro ali ciascuno. Le loro gambe erano diritte e i loro piedi come gli zoccoli d’un
vitello, splendenti come lucido bronzo. Sotto le ali, ai quattro lati, avevano mani d’uomo; tutti e
quattro avevano le proprie sembianze e le proprie ali, e queste ali erano unite l’una all’altra. Quando
avanzavano, ciascuno andava diritto davanti a sé, senza voltarsi indietro.
Quanto alle loro fattezze, avevano facce d’uomo; poi tutti e quattro facce di leone a destra, tutti e
quattro facce di toro a sinistra e tutti e quattro facce d’aquila. Le loro ali erano spiegate verso l’alto;
ciascuno aveva due ali che si toccavano e due che coprivano il corpo. Ciascuno andava diritto davanti
a sé; andavano là dove lo spirito li sospingeva e, avanzando, non si voltavano indietro. Tra quegli
esseri si vedevano come dei carboni ardenti simili a torce, che si muovevano in mezzo a loro. Il fuoco
risplendeva e dal fuoco si sprigionavano bagliori. Gli esseri andavano e venivano come una saetta.
64 «Periodi culminanti di un ciclo, si intercalano tra gli equinozi (21 marzo, 21 settembre) e i solstizi (21 giugno, 21
dicembre); separano le stagioni; dividono il cerchio zodiacale in patti uguali di 90°». (Chevalier, 1038). 65 G. CHAMPEAUX – S. STERCKX, I simboli del Medioevo, Jaca Book, Milano 1988.
Il cielo, rivelazione della trascendenza
34
Io guardavo quegli esseri, ed ecco sul terreno una ruota al fianco di tutti e quattro. Le ruote avevano
l’aspetto e la struttura come di topazio e tutte e quattro la medesima forma; il loro aspetto e la loro
struttura erano come di ruota in mezzo a un’altra ruota. Potevano muoversi in quattro direzioni;
procedendo non si voltavano. Avevano dei cerchioni molto grandi e i cerchioni di tutt’e quattro erano
pieni di occhi. Quando quegli esseri viventi si muovevano, anche le ruote si muovevano accanto a
loro e, quando gli esseri si alzavano da terra, anche le ruote si alzavano. Dovunque lo spirito le avesse
sospinte, le ruote andavano e ugualmente si alzavano, perché lo spirito degli esseri viventi era nelle
ruote. Quando essi si muovevano, anch’esse si muovevano; quando essi si fermavano, si fermavano
anch’esse e, quando essi si alzavano da terra, anch’esse ugualmente si alzavano, perché nelle ruote
vi era lo spirito degli esseri viventi. Al di sopra delle teste degli esseri viventi era disteso una specie
di firmamento, simile a un cristallo splendente, e sotto il firmamento erano le loro ali distese, l’una
verso l’altra; ciascuno ne aveva due che gli coprivano il corpo. Quando essi si muovevano, io udivo
il rombo delle ali, simile al rumore di grandi acque, come il tuono dell’Onnipotente, come il fragore
della tempesta, come il tumulto d’un accampamento. Quando poi si fermavano, ripiegavano le ali.
Ci fu un rumore al di sopra del firmamento che era sulle loro teste. Sopra il firmamento che era sulle
loro teste apparve qualcosa come una pietra di zaffìro in forma di trono e su questa specie di trono,
in alto, una figura dalle sembianze umane».66
Tutto nella visione si ordina attorno al Centro, dove è il Trono. Il testo descrive la gigantesca
rotazione notturna delle costellazioni. In questa giostra celeste, per una sovrapposizione di immagini
che a noi evoca la simultaneità cinematografica, ognuna delle quattro costellazioni cardinali viene
successivamente a prendere il posto della precedente, sovrapponendosi e fondendosi tra loro, sicché
si ritrovano ognuna in tutte e tutte in ognuna.
Esse hanno tutto in comune, appartenendo tuttavia a quattro animali. Le ruote cosparse di occhi
evocano le costellazioni formicolanti di stelle. Il carro richiama l’ubiquità di Dio, la cui presenza non
è più legata a un luogo determinato. I quattro esseri alati corrispondono alle quattro principali
costellazioni dello zodiaco: Toro (primavera), Leone (estate), Scorpione (Autunno), Acquario
(Inverno), che sono il supporto mobile della volta celeste e i basamenti del trono della Maestà divina.
Nella terminologia ebraica lo Scorpione viene pensato come un uomo e l’Aquila, avendo stelle
particolarmente brillanti, sostituisce l’Aquario.
La simbolica cosmica raccontata da Ezechiele ha come modello la disposizione del campo di
Israele durante l’Esodo: le dodici tribù, divise per gruppi di tre, erano disposte ai quattro punti
cardinali, mentre al centro del campo c’era la tenda del convegno, segno della Presenza di Dio.
I quattro emblemi di ciascun gruppo erano proprio quelli del tetramorfo: il leone a est, l’uomo
a sud, il toro a ovest e l’aquila a nord.
Il campo ebraico si presenta così come un cosmo sacralizzato.
Questo stesso schema ritorna nella descrizione della Gerusalemme celeste dell’Apocalisse.
La simbolica giudaica non fa altro che riprendere l’ordine dei grandi simboli naturali: il
rapporto tra l’Uno, il Centro, il Polo celeste e il quaternario della sua manifestazione e della sua azione
nel mondo creato.
Vi possiamo riconoscere il passaggio dal cerchio al quadrato che determinerà la semplicità
armonica della chiesa-edificio.
Il cielo come memoriale della creazione nella liturgia dell’Apocalisse
Il capitolo 4 dell’Apocalisse, che è una liturgia creazionale - riprende i temi della visione di
Ezechiele combinata con quella di Isaia:
«Ed ecco c’era un trono nel cielo, e sul trono uno stava seduto. [...] Un arcobaleno simile a smeraldo
avvolgeva il trono. [...] Davanti al trono vi era come un mare trasparente simile a cristallo. In mezzo
al trono e intorno al trono vi erano quattro esseri viventi pieni di occhi davanti e di dietro. Il primo
vivente era simile a un leone, il secondo essere vivente aveva l’aspetto di un vitello, il terzo vivente
66 Ez 1, 4-26.
Il cielo, rivelazione della trascendenza
35
aveva l’aspetto d’uomo, il quarto vivente era simile a un’aquila mentre vola. I quattro esseri viventi
hanno ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati di occhi; giorno e notte non cessano di ripetere:
Santo, Santo, Santo, il Signore Dio, l’Onnipotente, Colui che era, che è e che viene».67
Nella visione apocalittica la creazione terrestre viene vista da Giovanni come l’opera del Dio
architetto che, prima ancora che il mondo fosse, ne aveva fatto un modello celeste. Come la
costruzione del Tempio terrestre corrisponde a un modello preesistente nei cieli rivelato a Mosè (Cfr.
Es 24,9; 25,40), così la realtà della creazione corrisponde a questo suo modello celeste.
Nella liturgia apocalittica la prima lode è quella del creato (rappresentato dai Viventi) e degli
esseri angelici, ma – come già in Ezechiele – attraverso la presenza dell’arcobaleno viene indicato
che questo creato si trova in uno stato di alleanza con Dio. Con una bellissima immagine, Champeaux
spiega che in questo modo la terra si trova avvolta nell’abbraccio celeste dell’iride. Questa figura ideale è tratta dalla contemplazione del cielo, che dal centro, attraverso la croce,
segna quattro punti simmetricamente opposti, facendo così apparire il quadrato terrestre.
La tradizione cristiana, e prima di tutti sant’Ireneo, non fa che proseguire l’interpretazione
universalistica della visione del tetramorfo:
«Del resto i vangeli non possono essere né più né meno di questi. Infatti, poiché sono quattro le parti
del mondo, nel quale siamo, e quattro i venti diffusi su tutta la terra e la Chiesa è disseminata su tutta
la terra, e colonna e sostegno della Chiesa è il Vangelo e lo Spirito di vita, è naturale che essa abbia
quattro colonne [...]. Perciò è chiaro che il Verbo Artefice dell’universo, che siede sopra i Cherubini
e sostiene tutte le cose, dopo essersi mostrato agli uomini, ci ha dato un Vangelo quadriforme, ma
sostenuto da un unico Spirito. [...] Ora i Vangeli sui quali siede Cristo Gesù sono in accordo con
questi animali». 68
Il cielo nell’esperienza spirituale
La contemplazione del cielo induce un movimento di trascendimento continuo. «I cieli cantano
la gloria di Dio»: il cielo stellato nella notte incantevole è sempre un cielo rivelatore di Dio.
Lo troviamo già nel battistero della casa cristiana a Dura Europos, oppure nel clipeo con il
Chrismon incoronato dalla mano del Padre al centro della volta del battistero di S. Giovanni in Fonte
a Napoli; nel battistero di Albenga, nell’immenso disco glorioso che circonda la croce gemmata
nell’abside di S. Apollinare in Classe, sulla volta del mausoleo di Galla Placidia a Ravenna.
Qui la contemplazione sognante del cielo stellato diventa una realtà: novecento stelle d’oro a
otto raggi brillano in cerchi concentrici intorno ad una croce d’oro al centro della volta. Ma, questo
cielo non è pietrificato nell’istante, è un cielo che continua a girare insensibilmente intorno al suo
perno. Il segreto di questa movimento non si scopre a prima vista, né voleva essere scoperto: per chi
lo ideò, quel che contava era che girasse e palpitasse. Ma se si vuole capire come si può far girare un
cielo di stelle incastonate nella pietra, allora bisogna guardare i primi due giri intorno alla croce e si
scoprirà che sono incompleti: il primo conta solo due stelle, il secondo, cinque; la loro disposizione
in rapporto all’asse orizzontale della croce dà l’impressione di un movimento, a spirale, originato dal
centro, all’incrocio dei due bracci. Dal terzo al settimo giro le stelle disposte a raggiera si allontanano
dal centro: movimento centrifugo incessantemente richiamato verso il centro dall’altro che si allaccia
intorno alla croce. Poi, a partire dal settimo giro –e la differenza balza agli occhi -, una leggera
sfasatura fra le stelle fa sì che appaiono meno mobili, più fitte e più vicine a noi rispetto al cerchio
interno, ma soprattutto non tracciano più una raggiera, ma curve che si intersecano, disegnando
segretamente un’immensa rosa di luce.
Frossard, che ha “visto” questa rosa, si domanda se Dante non abbia attinto proprio dalla
contemplazione del cielo di Galla Placidia, «forse senza esserne consapevole, l’idea dei nove cori
67 Ap 4,2-8. 68 IRENEO DI LIONE, Adversus haereses, III, 11, 8
Il cielo, rivelazione della trascendenza
36
angelici che egli ha visto disegnare come una rosa di neve in paradiso, “in forma dunque di candida
rosa”».69
Oltre a rivelare il prototipo simbolico del movimento creazionale e il rapporto inscindibile che
lega il quadrato al Centro, il finito all’Infinito, il tempo all’eterno Immutabile, il cielo è la sede della
rivelazione della luce.
Cielo diurno irradiato dallo splendore sfolgorante del sole, cielo notturno illuminato dal
chiarore della luna e dal luccichio delle stelle.
Ma la luce materiale è per l’uomo, immediatamente, simbolo di una luce immateriale.
Se è vero che, come dice san Paolo, chi non dà gloria a Dio e non gli rende grazie è inescusabile,
perché «dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con
l’intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità» (Rm 1,20), questo non
significa ancora per l’uomo conoscere il senso della vita.
Gli astri sono implacabili, cioè il cielo è separato dalla terra.
La novità della Rivelazione cristiana è l’apparizione del Senso. «I cerchi (della ripetizione
indefinita) sono distrutti» dice sant’Agostino. E quest’apparizione è quella di una luce che abbraccia
ogni cosa, definendone la forma.
Si spiega così il ruolo simbolico predominante che la luce è chiamata a svolgere
nell’espressione liturgica, nella riflessione teologica, nell’espressione figurativa.
Alla necessità delle stelle, conduttrici ineluttabili dei destini dell’uomo - e che la magia si sforza
di sfruttare -, si contrappone, secondo la bellissima espressione di sant’Ignazio di Antiochia, un «astro
nuovo»:
«Tutte le altre stelle, e il sole e la luna facevano corona a questo nuovo astro, che col suo splendore
le offuscava tutte... Allora fu sciolta ogni magia, ogni laccio d’iniquità fu abolito; l’ignoranza fu
tolta, il vecchio regno cominciò a sgretolarsi, essendo apparso Dio in forma umana a recare la novità
della vita eterna… Cominciava così a compiersi ciò che presso Dio era un fatto compiuto. Per questo
il mondo era sconvolto, perché si preparava la sconfitta della morte».70
L’esperienza della Luce è sempre religiosa.
Trattando delle esperienze della luce mistica, Eliade dopo aver precisato che bisogna
distinguere tra la luce percepita soggettivamente e i fenomeni luminosi percepiti oggettivamente da
altre persone, osserva che nelle tradizioni indiana, iranica e cristiana queste due categorie di
esperienze sono solidali: la divinità (o l’essere in India) essendo Luce o emanando dalla luce, i saggi
(India) o coloro che giungono all’unio mystica irradiano luce.
All’interno della vasta morfologia delle esperienze soggettive della Luce Eliade individua
quattro tipi più frequenti:
1. Luce talmente sfolgorante da annullare per così dire la luce fisica, cosicché l’epopte (il veggente)
ne è come accecato: san Paolo.
2. Luce che trasfigura il mondo senza abolirlo: esperienza di una «luce soprannaturale molto intensa
che illumina fino alle profondità della materia, ma nella quale le forme sussistono.
Sorta di Luce paradisiaca che rivela il Mondo quale era nella sua perfezione originaria -, nella
tradizione giudeo-cristiana, quale era prima della caduta di Adamo»: san Benedetto, sant’Ignazio.
3. Luce che risplende improvvisamente o che viene percepita progressivamente e la cui intensità
crescente è accompagnata da un sentimento di pace profonda.
4. Luce che si rivela come Presenza divina personale e Luce che disvela una sacralità impersonale
(del Mondo, della Vita, dell’Uomo)
In ogni caso, osserva Eliade, qualunque sia «la natura e l’intensità dell’esperienza della Luce,
essa evolve sempre in esperienza religiosa».
I diversi tipi di esperienza della luce hanno un elemento in comune: fanno uscire l’uomo dal
suo universo profano o dalla sua situazione storica e lo proiettano in un altro Universo, opposto a
69 A. FROSSARD, II Vangelo secondo Ravenna, SEI, Torino 1985, p. 37. 70 IGNAZIO DI ANTIOCHIA, Lettera agli Efesini, 18-20.
Il cielo, rivelazione della trascendenza
37
quello profano o che lo trascende per il fatto di essere di natura spirituale, ovvero per il fatto di essere
accessibile unicamente a coloro per i quali lo Spirito esiste.
Cielo, cerchio, centro: esperienze letterarie
Chi, con Ulisse, naviga per i mari dell’Odissea, ha per compagne le stelle:
Lieto del vento, distese le vele Odisseo luminoso.
Così col timone drizzava il cammino sapientemente,
seduto. Mai sonno sugli occhi cadeva,
fissi alle Pleiadi, fissi a Boòte che tardi tramonta,
e all’Orsa, che chiamano pure col nome di Carro,
e sempre si gira e Orione guarda paurosa,
e sola non ha parte ai lavacri d’Oceano;
quella infatti gli aveva ordinato Calipso, la dea luminosa,
di tenere a sinistra nel traversare il mare.71
Il catalogo celeste serve, qui, da cosmografia. Di quelle stelle, sotto cui Ulisse naviga per
arrivare a Scheria, terra dei Feaci, non è detta la bellezza, esse vengono semplicemente nominate.
Così come non ci si sofferma, in questo caso, sui sentimenti di Ulisse. La voce omerica non è lirica.
Le stelle omeriche servono a indicare una direzione, che segue la linea dell’orizzonte. Al cielo si
guarda per non sbagliare strada, e non bisogna addormentarsi.
Sempre volgendoci ai poemi omerici, questa volta all’Iliade, la descrizione dello scudo di Achille si
configura come una cosmografia in forma di cerchio:
Ivi ei fece la terra, il mare, il cielo
E il Sole infaticabile, e la tonda
Luna, e gli astri diversi onde sfavilla
Incoronata la celeste volta,
E le Pleiadi, e l’Iadi, e la stella
D’Orïon tempestosa, e la grand’Orsa
Che pur Plaustro si noma. Intorno al polo
Ella si gira ed Orïon riguarda,
Dai lavacri del mar sola divisa.72
La lunghissima descrizione omerica procede poi per cerchi concentrici. Lo scudo di Achille
contiene non solo il cielo, ma il mondo intero, gli uomini con le loro vite, nelle loro città, le loro
attività. L’intera cosmografia omerica è racchiusa dal grande fiume Oceano. È Efesto che forgia,
sbalza e cesella per Achille il mondo. Egli lo fa su richiesta di Teti, la madre di Achille, la bellissima
divinità marina. È come se questa madre divina volesse consegnare al figlio destinato a morire una
epitome del mondo in forma di scudo; ma ella sa che l’intero mondo non servirà da scudo ad Achille
per il suo fato.
Uno dei più grandi poeti del Novecento, W.H. Auden, ha descritto un suo scudo di Achille.
Anche su questo scudo viene rappresentato un mondo, ben diverso da quello, brulicante di vita
ordinata in un universo ordinato, che ci ha consegnato Omero. Lo sguardo di Teti, in Auden, cerca
nello scudo che Efesto sta forgiando la formalizzazione di un’armonia cosmica che non esiste più.
Ella cercava da sopra la sua spalla
vigneti ed oliveti
città di marmo ben governate
71 Odissea, Trad. Rosa Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1989, vv.269-272. 72 Iliade, Trad. Vincenzo Monti, Le Monnier, Firenze 1861, XVIII, 671-679.
Il cielo, rivelazione della trascendenza
38
e navi su mari mai domati,
ma lì sul metallo scintillante
le sue mani invece avevano posto
una distesa selvaggia artificiale
e un cielo come piombo.
Una pianura immobile, vuota e scura,
non un filo d’erba, non un segno di vita,
niente da mangiare e per sedersi niente,
ma, radunata su quella nudità, stava
una moltitudine inintelligibile,
un milione di occhi, un milione di stivali allineati,
senza espressione, in attesa di un segnale.73
La moltitudine inintelligibile di Auden che sta sotto un cielo come piombo ci suggerisce la
perduta intelligibilità di quello stesso cielo. La poesia fa riferimento infatti sia ai disastri della
Seconda Guerra Mondiale che alla Guerra Fredda.
Ma non dobbiamo pensare che solo la modernità parli di un cielo lontano e indecifrabile. Il
cielo come alterità, come estraneità, come correlativo oggettivo della solitudine, domina
sorprendentemente in questo frammento di Saffo (VII-VI sec. a.C.):
Tramontata la luna / tramontate le Pleiadi; è mezza- /
notte; il tempo passa / e io giaccio sola. 74
Siamo qui alle sorgenti della poesia lirica. Tornando ad Ulisse e alla sua zattera, la solitudine
di Ulisse sotto il cielo è soltanto una nostra deduzione. Non è sbagliata, certo, ma non viene detta.
Né, tantomeno, viene collegata alla tristezza. Anzi, Ulisse viene detto lieto del vento. E forse proprio
perché è lieto mai sonno sugli occhi cadeva. Invece, il frammento di Saffo enfatizza la solitudine
dell’io. La voce poetica dice io. Una donna giace da sola, sotto un cielo da cui sono spariti i corpi
celesti che ella può nominare: è un cielo ignoto, distante e oscuro. Il rapporto tra creatura e cielo, qui,
è posto liricamente, perché la solitudine del cielo senza luna è la solitudine del poeta.
Spesso quand’io ti miro
Star così muta in sul deserto piano,
Che, in suo giro lontano, al ciel confina;
Ovver con la mia greggia
Seguirmi viaggiando a mano a mano;
E quando miro in ciel arder le stelle;
dico fra me pensando:
a che tante facelle?
Che fa l’aria infinita, e quel profondo
Infinito seren? Che vuol dir questa
Solitudine immensa? Ed io che sono?75
La solitudine del pastore di Leopardi che parla alla luna sotto il cielo stellato è una
realizzazione poetica di un archetipo letterario: si tratta di una situazione che non è tematizzata solo
nell’Odissea, o nei primi lirici, ma anche nella Bibbia. Siamo dunque alle fonti dell’immaginario
occidentale. La Bibbia ci presenta infatti la solitudine di un altro “errante” sotto le stelle:
Dopo tali fatti, fu rivolta ad Abram, in visione, questa parola del Signore: «Non temere, Abram. Io
sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto grande». Rispose Abram: «Signore Dio, che cosa mi
darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Elièzer di Damasco». Soggiunse Abram:
«Ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede». Ed ecco, gli fu rivolta
73 W.H. AUDEN, Lo scudo di Achille, 1955. Se non specificato altrimenti, le traduzioni dall’inglese sono di chi scrive. 74 SAFFO, Frammenti, a c. G. Tedeschi, EUT, Trieste 2015. 75 G. LEOPARDI, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, in Canti, canto XXIII.
Il cielo, rivelazione della trascendenza
39
questa parola dal Signore: «Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». Poi lo
condusse fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle»; e soggiunse: «Tale
sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. (Gen 15, 1-6)
Ad Abram la parola del Signore è rivolta in visione: è la “visione della voce” che conduce
Abram fuori, che gli fa guardare il cielo stellato. La solitudine di Abram davanti al cielo stellato è
compresa, ed espressa, nella voce di Dio, la voce che chiama.
Se possiamo leggere la vicenda di Abram/Abramo come la storia dell’attesa della voce di Dio,
anche molta letteratura del Novecento può essere considerata una letteratura dell’attesa; l’attesa di un
messaggio di aiuto (pensiamo solo ad Aspettando Godot di Samuel Beckett); l’attesa di un
cambiamento (Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati); l’attesa di una invasione (Aspettando i barbari
di Konstantinos Kavafis).
L’attesa, estatica, di un messaggio dall’alto è il centro del breve racconto di Kafka Un
messaggio dell’imperatore.
«L’imperatore – così si dice – ha inviato a te, al singolo, all’umilissimo suddito, alla minuscola ombra
sperduta nel più remoto cantuccio di fronte al sole imperiale, proprio a te l’imperatore ha mandato un
messaggio dal suo letto di morte. Ha fatto inginocchiare il messaggero accanto al letto e gli ha
bisbigliato il messaggio nell’orecchio; tanto gli stavi a cuore che s’è fatto ripetere, sempre all’orecchio,
il messaggio.
Con un cenno del capo ne ha confermato l’esattezza. E dinanzi a tutti coloro che erano accorsi per
assistere al suo trapasso: tutte le pareti che ingombrano sono abbattute e sulle scalinate che si ergono
in larghezza stanno in cerchio i grandi dell’impero; dinanzi a tutti questi ha congedato il messaggero.
Il messaggero s’è messo subito in cammino; un uomo robusto, instancabile; stendendo a volte un
braccio, a volte l’altro fende la moltitudine; se incontra resistenza indica il petto, dove c’è il segno del
sole; egli avanza facilmente come nessun altro. Ma la moltitudine è enorme; le sue abitazioni non
finiscono mai. Come volerebbe se potesse arrivare in aperta campagna e presto udresti il meraviglioso
bussare dei suoi pugni al tuo uscio. Invece si affatica quasi senza scopo; si dibatte ancora lungo gli
appartamenti del palazzo interno; non li supererà mai, e se anche ci riuscisse nulla sarebbe ancora
raggiunto; dovrebbe lottare per scendere scale, e se anche ci riuscisse nulla sarebbe ancora raggiunto;
bisognerebbe attraversare i cortili, e dopo i cortili il secondo palazzo che racchiude il primo; altre scale,
altri cortili; e un altro palazzo, e così via per millenni; e se riuscisse infine a sbucare fuori dal portone
più esterno – però questo non potrà verificarsi mai e poi mai – si troverebbe ancora davanti la capitale,
il centro del mondo, ricoperta
da tutti i suoi rifiuti. Nessuno può uscirne fuori e tanto meno col messaggio di un morto. Tu, però, stai
alla tua finestra e lo sogni, quando scende la sera.76
Lo sguardo di Emily Dickinson è quello di una contemplativa: la percezione converge verso
un centro dell’oggetto, di cui il linguaggio del poeta svela il segreto. È una percezione cauta, perché
gli oggetti sono segni, simboli fragili pronti a frantumarsi come il vetro, come il paradiso della poesia
che segue.
Ogni vita converge verso un centro –
Espresso – o silente –
Esiste in ogni natura umana
Una meta –
Incarnata a fatica a se stessa – forse –
Troppo bella
Perché una presunzione d’attendibilità
La sporchi –
Adorata con cautela – come un fragile paradiso –
Impossibile da raggiungere – come il manto dell’arcobaleno
da toccare –
76 F. KAFKA, Un messaggio dell’imperatore, trad. E. Pocar, Mondadori, Milano 1997.
Il cielo, rivelazione della trascendenza
40
Eppure perseguita con tenacia – più certa – per la distanza –
Per quanto alto –
Nella lenta diligenza dei santi –
Il cielo –
Non meritata – forse – da una vita che poco ha rischiato –
Ma allora –
Possa l’eternità concedere di riprovare
Ancora.77
L’esperienza della vita come rotazione ordinata intorno a un centro è il tema di questa poesia
di Clemente Rebora. La sferza di cui si parla è la cordicella che, avvolta intorno alla trottola,
svolgendola la fa girare.
Gira la tròttola viva
Sotto la sferza, mercé la sferza;
Lasciata a sé giace priva,
Stretta alla terra, odiando la terra;
Fin che giace guarda il suolo;
Ogni cosa è ferma,
E invidia il moto, insidia l’ignoto;
Ma se poggia a un punto solo
Mentre va s’impernia,
E scorge intorno, vede d’intorno;
Il cerchio massimo è in alto
Se erige il capo, se regge il corpo;
Nell’aria tersa è in risalto
Se leva il corpo, se eleva il capo;
Gira, - e il mondo variopinto
Fonde in sua bianchezza
Tutti i contorni, tutti i colori;
Gira, - e il mondo disunito
Fascia in sua purezza
Con tutti i cuori, per tutti i giorni;
Vive la tròttola e gira,
La sferza Iddio, la sferza è il tempo:
Così la tròttola aspira
Dentro l’amore, verso l’eterno.78
77 J680 in T. H. JOHNSON, (a c.) The Poems of Emily Dickinson, Harvard UP, Cambridge Mass, 1955. 78 C. REBORA, Le poesie, Garzanti, Milano 1988.
Capitolo quarto
LA TERRA COME GROTTA O CAVERNA
SIMBOLO DELL’INCONSCIO
All’esperienza del cielo si accompagna e si contrappone immancabilmente quella della terra:
questa si presenta sotto tre aspetti: come deserto, come ambiente di lavoro, come giardino.
Come deserto prende la forma di una distesa pietrosa o polverosa, luogo dove non cresce nulla,
luogo sterile; ad esso sono connessi elementi quali la roccia, la grotta o la caverna.
Come ambiente del lavoro faticoso dell’uomo: coltivata, diventa terra fertile, capace di offrire
i suoi frutti a uomini e animali, ma ha sempre bisogno di acqua dal cielo; la fecondità infatti è sempre
dono di Dio (Dt 29, 9-28).
Dio opera continuamente perché il deserto porti frutto e si trasformi in giardino. Dio non può
riposare finché l’uomo si perde e non raggiunge il suo fine (il suo frutto), ossia la comunione con lui
nel giardino della redenzione.
La terra-giardino non è più un simbolo cosmico puro e semplice, bensì di una natura
umanizzata: il giardino esiste infatti in quanto porzione di terra recintata e irrigata, in cui vengono
piantati alberi e fiori che non servono al nutrimento dell’uomo ma al suo godimento e al suo riposo.
Il giardino è in relazione con la vita, come per esempio nelle Metamorfosi di Ovidio.
Sempre a livello letterario può essere il “locus amoenus” di Tasso; recintato e protetto, ma
anche magico e fantastico, come quello in cui avviene l’iniziazione della piccola Alice di Lewis
Carroll o come i Kensington Gardens di Peter Pan.
Il giardino può ospitare la memoria dolorosa da cancellare, come nel caso di Burnett, o può
essere luogo di guarigione del corpo e dell’anima. Il giardino è dunque sempre un microcosmo.
Il giardino non è solo luogo d’amore, ma anche di morte, come nel racconto di Buzzati “Le
gobbe nel giardino”, dove il terreno nasconde “strati di memoria”. Esso diviene testimone
dell’estinzione di una intera famiglia ne “Il giardino dei Finzi Contini”, così come può essere il luogo
dove la natura è in lotta con il cemento, come nel racconto di McEwan, o essere il testimone della
decadenza di grandi famiglie, come nel Gattopardo.
Il tema della Terra-Giardino è molto importante nella sacra Scrittura per il fatto che, costituito
dalla sua recinzione, simboleggia la relazione piena con Dio.
Non ci fermiamo sul simbolismo della terra, in quanto legata alla fatica e al sudore dell’uomo,
ma passiamo piuttosto a considerarla proprio nella sua valenza antitetica al cielo, quali viscere della
terra connotate da spessore, profondità, oscurità, attraverso la figura della grotta o della caverna.
Simbolismo generale della terra
In italiano caverna indica dei semplici vani, mentre grotta – in greco: krypta -, specifica
qualsiasi cavità sotterranea.
Luogo naturale di rifugio dalle intemperie, le grotte che si addentrano nel seno oscuro della
terra sono state oggetto di venerazione fin dalla preistoria.
L’antro sotterraneo appare all’uomo come un gigantesco ricettacolo di energia tellurica, quella
che si manifesta nei vulcani, che può mettere in comunicazione, nelle operazioni magiche, con le
potenze ctonie della morte e della germinazione.
La grotta è il seno della Terra madre dove germina la vita, ma è anche il luogo delle tenebre,
della morte, l’ingresso agli inferi; luogo tenebroso pieno di pericoli, di mostri o draghi.
La grotta, simbolo dell’inconscio
42
Ma può anche custodire tesori preziosissimi, come la fonte segreta di un’acqua di vita e dalla
quale si può uscire a costo di una lotta mortale dall’esito vittorioso.
Appaiono così i primi due significati simbolici della grotta presenti in tutte le religioni: grotta
della nascita e grotta della morte-risurrezione.
Presso i popoli classici le grotte sono considerate abitazione delle divinità terrestri, - Demetra,
ninfe, fauni -, legate al ciclo vegetale della germinazione oppure, in particolare se connesse con
fenomeni vulcanici (emanazione di vapori sulfurei o letali), delle divinità degli inferi.
Ma le grotte sono sacre anche alle divinità celesti come Apollo e Zeus, sia perché servirono di
riparo ai simulacri delle divinità, sia perché alle divinità maggiori si erano assimilate divinità locali
ctonie, appropriandosi anche dei loro santuari. Così la grotta di Delfi fu incorporata nel tempio di
Apollo.
In quanto cavità oscura, regione sotterranea dai limiti invisibili, abisso pauroso dove abitano e
donde escono i mostri, la grotta è un simbolo dell’inconscio.79
Nell’universo onirico, caverna, donna, mammifero, universo soggettivo vanno insieme.
La caverna simboleggia il luogo dell’identificazione, cioè il processo di interiorizzazione
psicologica secondo il quale l’individuo diventa sé stesso e giunge alla maturità.
Proprio in quanto la grotta è potenziale luogo di passaggio dalla terra al cielo e dunque di un
cambiamento di livello, a essa si ricollegano le famiglie simboliche dell’iniziazione, ovvero la terza
valenza simbolica generale.
Nel mito greco ripreso da Platone la caverna rappresenta il mondo dove le anime incatenate
sono state rinchiuse dagli dèi e dove la vera realtà è vista in un gioco di riflessi.80
Qui avviene il passaggio dalla non-conoscenza alla conoscenza, infatti “conosce” solo colui che
riesce a uscire dalla caverna, venendo alla luce, nascendo a una conoscenza nuova e più piena.
La nostra esperienza del seno materno, nel ventre della madre terra, nel seno della roccia, è
segnato dall’incoscienza: infatti nessuno di noi ne ha reminiscenza. La conoscenza è cominciata
quando siamo venuti alla luce.
Non si può però rimanere per sempre nella grotta, bisogna uscirne per vivere. Il grembo materno
è il momento della gestazione, ma se il bambino maturo non esce dal grembo della madre muore. Per
continuare a vivere deve nascere.
Possiamo coglierne immediatamente il significato spirituale: il tempo della preparazione si
deve aprire all’operosità. Per questo molte cerimonie iniziatiche incominciano con il passaggio del
candidato attraverso una grotta, per poi farlo riuscire all’esterno.
Sintetizzando la tradizione greca che unisce simbolismo metafisico e simbolismo morale-
spirituale, Plotino spiega:
«La caverna in Platone, come l’antro in Empedocle, significa mi sembra il nostro mondo, in cui il
cammino verso l’intelligenza è per l’anima la liberazione dai suoi legami e l’ascensione fuori dalla
caverna».81
Nel periodo tardo antico, le grotte assumono particolare importanza nelle religioni dei misteri
in connessione con i miti di morte-risurrezione, legati al sole che ad ogni tramonto si inabissa in una
stanza profonda nel fondo del mare (nel caso di Mitra divinità solare), o alla luna (nel caso di Iside).
I mitrei consistevano proprio in una grotta naturale o imitata.
Sono collegate anche con i riti di iniziazione che contemplano sempre un passaggio da una
condizione inferiore, tenebrosa, attraverso le diverse sfere celesti, fino alla luce della visione divina
(cfr. Racconto dell’iniziazione di Apuleio nelle Metamorfosi di Ovidio).
Ernst Benz che al tema della grotta sacra ha dedicato un denso articolo, scrive:
79 Cfr. CHEVALIER, Caverne. 80 Cfr. Rep VII, 514ab. 81 PLOTINO, Enneadi IV, 8, 1
La grotta, simbolo dell’inconscio
43
«Il tema della morte e rinascita ciclica che si realizza annualmente nella natura, viene riportato non
solo sulla vicenda del singolo iniziato, ma anche sulle ere del mondo. Tutto il cosmo si muove in
questo ritmo di morte e di rinascita, e dopo ogni tramonto del mondo si aspetta una nuova primavera
o, detto storicamente, il ritorno del tempo d’oro dei re originari. Un salvatore, un principe sacerdote,
un pastore di popoli, un portatore di luce, un germoglio verginale verrà, combatterà, soffrirà, morirà
e ciononostante sconfiggerà i nemici risorgendo fulgido come il sole».82
In Estremo Oriente la grotta è il simbolo del mondo, luogo di nascita e di germinazione,
immagine del centro e del cuore.
Il simbolo della caverna vi si trova congiunto con quello della montagna, poiché la caverna
comporta un foro centrale nella volta, quale luogo di passaggio dell’asse cosmico.
La caverna simboleggia il centro spirituale del macrocosmo e del microcosmo, quello del
mondo e quello dell’uomo.83
La grotta nella Sacra Scrittura
Nelle teofanie veterotestamentarie la grotta appare in due casi: il primo dove Mosè vede Dio di
spalle stando nel cavo di una roccia. Va tenuto presente che già l’incavo della mano di Dio è una
seconda caverna protettrice: «Tu starai sopra la rupe: quando passerà la mia Gloria, io ti porrò nella
cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato» (Es 33, 21-22).
Il secondo caso è il racconto di Elia che, giunto all’Oreb, assiste alla teofania divina all’ingresso
di una caverna: «Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci
fu il mormorio di un vento leggero. Come l’udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò
all’ingresso della caverna» (1Re 19, 9-18).
In linea generale, nell’antico Testamento la caverna del sepolcro ha la valenza di luogo di
passaggio dalla condizione terrena nella protezione eterna di Dio, che è un Dio dei viventi.
Il tema della grotta si presenta con estrema ricchezza nella tradizione cristiana antica.
È vero che nei vangeli sinottici non si parla di grotta al momento della Natività, ma essa è
menzionata nel Protovangelo di Giacomo della metà del II secolo, molto amato in Oriente da Greci,
Siri, Copti e rifiutato invece in Occidente come eretico.
In questo racconto leggiamo che mentre Maria e Giuseppe erano in viaggio verso Betlemme,
«Maria disse a Giuseppe: Discendimi dall’asino, perché quello che è in me mi pressa per uscire. La
calò giù dall’asino e le disse: Dove posso condurti per mettere al riparo il tuo pudore? Il luogo infatti
è deserto. Trovò lì una grotta: ve la condusse, lasciò presso di lei i suoi figli ed uscì a cercare
un’ostetrica nella regione di Betlemme. [Quando Giuseppe torna con l’ostetrica] Si fermarono al
luogo della grotta ed ecco una nube splendente copriva la grotta. L’ostetrica disse: Oggi è stata
magnificata l’anima mia, perché i miei occhi hanno visto delle meraviglie e perché è nata la salvezza
d’Israele. Subito la nuvola si ritrasse dalla grotta e nella grotta apparve una grande luce che gli occhi
non poterono sopportare. Poco dopo quella luce andò dileguandosi fino a che apparve il bambino:
venne e prese la poppa da Maria, sua madre».84
Qui, come fa notare Benz, c’è già una specie di «teologia della grotta»: «il Figlio, che viene dal
cielo, concepito dallo Spirito Santo, nasce nella profondità della terra. L’Altissimo si rende presente
nell’infimo, la luce del Cielo rifulge nella tenebra della grotta».85
L’altare antico di san Saturnino a Tolosa manifesta questa teologia in chiave eucaristica, là dove
la mensa è incavata per alludere a un sepolcro da cui viene ricevuto il fermento di vita che è
l’Eucaristia.
82 E. BENZ, Die heilige Höhle in der alten Christenheit und der östlichenorthodoxen Kirche, in Eranos-Jahrbuch, 22,
1953. 83 Cfr. J. Chevalier, Caverne (voce) in Dictionnaire des symboles, Laffont, Parigi 1982, 180-184 (tr. it. Dizionario dei
simboli, Rizzoli, Milano 1986). L'indicazione delle pagine segue l'edizione originale. 84 B. BAGATTI, La Chiesa primitiva apocrifa, ed. Paoline, Roma 1981. 85 E. BENZ, art. cit., 369.
La grotta, simbolo dell’inconscio
44
L’importanza del significato religioso della grotta nel pensiero della Chiesa antica si manifesta
pienamente con Eusebio di Cesarea, quando inizia il grande flusso di pellegrinaggi verso i Luoghi
Santi, durante quel IV secolo segnato dalla costruzione dei martyria costantiniani.
Eusebio indica tre luoghi teofanici che sono appunto tre grotte mistiche: la grotta della Natività,
la grotta del sepolcro e della risurrezione, e la grotta dell’Ascensione.
Ecco il testo di Eusebio:
«Scegliendo in questa regione tre luoghi che avevano l’onore di possedere tre grotte mistiche,
(Costantino) li abbellì di ricche costruzioni, assegnando alla grotta della prima apparizione di Dio la
venerazione dovutale; onorando nell’altra, in cima al monte, la memoria dell’ultima Ascensione, ed
esaltando nella grotta di mezzo le vittorie di cui il Salvatore coronò tutta la propria battaglia.
L’imperatore abbellì tutti questi luoghi, facendo risplendere dappertutto il simbolo della salvezza (la
croce)».86
Eusebio usa un lessico misterico, sostituendo il termine spelaion con il termine antron, che
definisce la grotta cultuale, parla sempre di santa grotta (hieron antron) o di grotta mistica (mystikon
antron) o di grotta salvifica (soterion antron) o di grotta divina (theion antron): la grotta del sepolcro
è la grotta «santa tra le sante». Quando poi parla della grotta nel Monte degli U1ivi in cui il Signore
aveva iniziato i discepoli ai misteri del Regno prima della sua Ascensione, lo storico cristiano utilizza
il lessico tipico dell’iniziazione misterica.
Vicinissime alla simbolica generale della grotta - luogo di nascita, di morte-passaggio e di
iniziazione - presente nella tradizione pagana, le tre grotte storiche di Betlemme, Gerusalemme e del
Monte degli Ulivi, hanno ormai soppiantato ogni culto pagano nelle grotte.
Cristo non solo è l’opposto e il superamento delle figure mitiche di divinità morenti e risorgenti,
di cui erano piene le religioni dei misteri del Vicino Oriente, ma ne costituisce anche il compimento.
Realizza ciò che in esse di vero veniva anticipato e espresso attraverso figure mitiche.
La grotta è allora il luogo storico - senza cessare di essere il luogo simbolico - del dramma della
Salvezza, e dell’accesso alla vita divina.
La grotta della Natività: la discesa assoluta
Le profondità della terra. - La prima, nell’ordine temporale, delle tre grotte storiche sopra le quali fu
costruita una chiesa-martyrium è la grotta della Natività.
Alla sua ubicazione nelle viscere della terra la riflessione cristiana lega il mistero
dell’abbassamento del Figlio di Dio che si fa uomo. Dicendo che è disceso nelle profondità della terra
si esprime con un’immagine il movimento di discesa assoluta costituito dall’Incarnazione.
Aveva detto Isaia: «Chiedi un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure lassù
in alto» (Is 7,11). E Ireneo risponde:
«Perciò il Signore stesso ci diede un segno, in profondità e in altezza, segno che l’uomo non
domandò, poiché non si sarebbe mai aspettato che una vergine potesse divenire madre e partorire un
figlio, continuando ad essere vergine, e che il frutto di questo parto fosse ‘Dio-con-noi’, e che egli
discendesse nelle profondità della terra87 a cercare la pecora che era perduta, cioè la sua propria
creatura, e salire in alto ad offrire e presentare al Padre l’uomo che era stato ritrovato, avendo
prodotto in se stesso la primizia della risurrezione dell’uomo».88
Anche nelle più antiche raffigurazioni, che provengono dalla parte occidentale dell’Impero, la
Natività del Signore è ambientata in una grotta.
86 EUSEBIO DI CESAREA, Vita di Costantino, III, 41 87 Qui Ireneo riprende Ef 4,9: «Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per riempire tutte
le cose». 88 IRENEO DI LIONE, Adversus Haereses III,19,2.
La grotta, simbolo dell’inconscio
45
Questa è indicata nell’iconografia dei sarcofagi romani attraverso la piccola tettoia sostenuta
da due pali che sovrasta la mangiatoia. L’ingresso delle grotte adibite a riparo per il bestiame era
infatti coperto da una piccola tettoia.
A partire dal V-VI secolo, nelle composizioni di provenienza orientale, siriaco-palestinese, la
grotta viene invece raffigurata come tale: macchia oscura o addirittura nera, luogo dove non giunge
la luce del sole, ma dove penetra l’unico triplice Raggio.
Lo schema compositivo delle icone bizantine e russe segue, nelle grandi linee, quello dei
prototipi siriaci.
La Vergine Madre: la Terra-Grotta che accoglie il Signore. - La grotta storica, la terra che ha accolto
fisicamente il Re e Salvatore, possiede però sempre il suo valore simbolico di grembo matriziale.
In modo assolutamente privilegiato la figura di Maria sostituisce quella della Terra-grotta che
accoglie il Signore: il seno di Maria è la grotta sigillata, è lei la montagna spirituale da cui viene
staccata una pietra (Dn 2, 31) e il monte ombroso dal quale nasce l’albero della vita, secondo la
traduzione della Settanta del testo di Abacuc 3, 3.
I simboli si richiamano l’un l’altro: la grotta, la montagna, l’albero di vita, il germoglio, il
giardino del Paradiso. Poiché la cavità sigillata del seno verginale conteneva il germoglio divino, essa
costituisce incoativamente il Paradiso, cioè il giardino chiuso della presenza reciproca del Creatore e
della creatura.
Ma proprio perché è cavità sigillata, il seno della Vergine Maria evoca l’immagine di quell’altra
cavità sigillata che sarà il sepolcro, matrice della nascita per l’eternità del Verbo incarnato.
«Il ventre della Madre e gli inferi annunciarono con gioia la tua risurrezione: il ventre ti ha concepito
mentre era chiuso, il sepolcro ti ha lasciato uscire mentre era sigillato. Contro le leggi della natura il
ventre ti ha concepito e il sepolcro ti ha restituito».89
Immancabile è il passaggio dall’accoglienza di Maria e della Terra a quella del credente, egli
stesso grotta che accoglie il Re: mentre come il Tempio di Gerusalemme era diventato spelonca di
ladroni, ora diventa casa e dimora del Signore:
«O Signore, che sei nato nella grotta, manifesta me che ero diventato una spelonca di ladroni come
la tua dimora e la dimora del Padre tuo e dello Spirito Santo, affinché io ti glorifichi nei secoli».90
Questo aspetto verrà approfondito successivamente, quando si parlerà del simbolo della grotta
nella vita spirituale.
La grotta del Sepolcro: la discesa agli Inferi
La seconda grotta-martyrium è quella del sepolcro nel quale è stato deposto il corpo del Cristo
immolato. Lì giunge a compimento estremo quel movimento di discesa che simbolizza l’opera della
Redenzione. Come dice un’Antica Omelia sul Sabato Santo: «Certo egli va a cercare il primo padre,
come la pecorella smarrita. Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e
nell’ombra di morte. Dio e il Figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva che si trovano
in prigione». Il Grande, il Forte, il Buono non può che piegarsi verso il piccolo, il debole, l’indifeso:
all’esperienza originaria della totale dipendenza del bambino che aspetta di essere sollevato in alto
da braccia amorose, corrisponde quest’immagine altrettanto originaria di un amore forte e
soccorrevole che si china e che, chinandosi, salva: «Come un bambino ti ho sollevato alla guancia»
(cfr. Os 11, 3).
89 EFREM IL SIRO, Inni sulla Natività, X. 90 Canone bizantino del 23 dicembre, ode VIII.
La grotta, simbolo dell’inconscio
46
Sant’Efrem mostra bene che il movimento di discesa è uno solo, quello che è iniziato con
l’Incarnazione:
«Dall’alto discese il Signore, dal seno della Vergine uscì schiavo; nello Sheol si prostrò davanti a lui
la Morte, alla sua risurrezione i vivi lo adorarono».91
Nella caverna tenebrosa il Servo di Jahvè affronta il Maligno, «il grande drago, il serpente
antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra» (Ap 12, 9). Nelle viscere
della terra avviene la lotta mortale: «Mors et vita duello conflixere mirando», cantiamo nella
Sequenza di Pasqua. Il Morto sconfigge la morte con la sua Vita.
Il motivo di questa sconfitta non è però una potenza di distruzione, ma la sorpresa assoluta:
Satana, nella sua malizia, non poteva concepire l’umiliazione di Dio.
È un tema antichissimo, già presente nelle Odi di Salomone del II secolo: «Lo Sheol mi ha visto
ed è stato vinto; la morte mi ha lasciato tornare, e molti insieme con me»92 e che la tradizione siriaca
orientale ha prediletto: «La divinità si nascose sotto l’umanità e si avvicinò alla morte, la quale uccise
e a sua volta fu uccisa. [...] Non si accorse che nel frutto mortale che mangiava era nascosta la Vita.
Fu questa che causò la fine della inconsapevole e incauta divoratrice»93.
Un tema che risuona nell’ufficiatura del Grande Sabato:
«Oggi l’Ade gemendo grida: Meglio per me se non avessi accolto il Nato da Maria. Infatti,
venendomi addosso, ha distrutto la mia potenza, ha spezzato le porte di bronzo, ha fatto risorgere,
perché Dio, le anime che prima possedevo. […] Ho accolto un morto come uno dei mortali, ma non
posso assolutamente trattenerlo e con lui perderò i morti su cui regnavo».94
La connessione diretta tra la morte sulla croce e il risollevamento di Adamo prigioniero
nell’Ade è resa plasticamente dai racconti immaginifici sulla sepoltura di Adamo nel monte Calvario,
là dove fu poi eretta la Croce, cosicché il sangue del Salvatore scorrerà sul suo capo.
Ne è un esempio un testo di origine siriaca, del tempo di sant’Efrem, dal titolo: La caverna dei
tesori. Come spiega H. Rahner, queste leggende:
«sono la trasformazione in immagini e la forma ingenua e popolare di quello che chiamiamo il
mistero della Croce nell’Antichità cristiana. Sullo sfondo di tutta questa formazione mitica sta il
convincimento teologico del rapporto che vi è qui tra Adamo e Cristo, l’uomo terrestre e l’uomo
spirituale». 95
La qualificazione dei simboli è altrettanto importante quanto i simboli stessi: una grotta di pietra
non ha niente a che vedere con una caverna nella terra, così come una montagna pietrosa è tutt’altro
che un monte di terra.
Se nel simbolismo universale la pietra significa incorruttibilità ed è perciò sempre legata alle
realtà dello spirito, la terra, luogo del ciclo vegetativo che abbraccia germinazione, fruttificazione e
putrefazione, è sempre simbolo ambivalente di fecondità-corruzione.
Ecco perché la Sposa del Cantico, il cui amore è fedele non può che stare «nelle fenditure della
roccia, nei nascondigli dei dirupi» (Ct 2, 14).
Per lo stesso motivo il corpo di Gesù, morto, non può che essere messo «in una tomba scavata
nella roccia, nella quale nessuno era stato deposto» (Lc 23, 53), perché non è un corpo destinato alla
corruzione, essendo il Signore della vita.
Il sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato seppellito è come un secondo seno
verginale, dal quale uscirà la Vita incorruttibile.
91 EFREM IL SIRO, Inno sulla Risurrezione. 92 Ode 42, 14-15. 93 Efrem Siro, Disc. sui Signore, 3-4.9. 33. 94 Dai vespri del Grande Sabato. 33H. 95 H. RAHNER, Miti greci nell’interpretazione cristiana, EDB, Bologna.
La grotta, simbolo dell’inconscio
47
La discesa nelle acque del Battesimo. - C’è una forte analogia tra la discesa nelle viscere della terra
e la discesa nelle acque del Battesimo poiché i simboli dell’immersione nell’acqua, della caverna,
della sepoltura e del seno materno si richiamano a vicenda.
Molto spesso nelle raffigurazioni del Battesimo di Gesù le acque appaiono come racchiuse in
una grotta di pietra che viene a formare un utero materno da cui germina la vita nuova.
Diventa allora evidente nel senso proprio del termine come l’immersione nell’acqua sia
simbolicamente affine alla permanenza nella caverna o nelle viscere della terra. Luogo di morte e di
sepoltura e luogo di nuova nascita misteriosa.
Il battistero paleocristiano di Napoli nella sua forma rotonda non solo ricorda che il battezzando
rinasce al cielo raffigurato nella calotta sopra di lui, ma che egli viene alla luce dal grembo della
Chiesa-madre dopo essere stato immerso nelle viscere di amore materno/paterno della Trinità.
La grotta storica dell’iniziazione
Dopo le viscere della terra che si aprono ad accogliere il Signore che i cieli non possono
contenere, dopo l’abisso tenebroso in cui il Servo obbediente affronta e vince il Forte, c’è la grotta
immersa nel silenzio e nell’oscurità, nella quale l’uomo che ha accettato di seguire l’itinerario
pasquale del suo Signore vede apparire improvvisamente una Luce mai vista prima.
In riferimento alla vita storica di Gesù, si tratta della terza grotta di cui parla Eusebio.
Egli riferisce che l’imperatrice Elena, madre di Costantino, aveva fatto costruire due edifici
religiosi sul Monte degli Ulivi: un grande edificio ottagonale detto Imbomon, sulla sommità del
monte, nel luogo «de quo ascendit in caelis»; leggermente più in basso, sopra la grotta mistica «in
qua docebat Dominus», la chiesa dell’Eleona, nome formato da quello del Monte degli Ulivi:
«La madre dell’imperatore aveva esaltato con superbe costruzioni sul monte degli Ulivi, il ricordo
del passaggio del Salvatore nei cieli, facendo erigere sulla cima l’edificio sacro di una chiesa e
fondandovi un santuario... E, certo, questi due santuari l’imperatrice li eresse su due grotte mistiche,
a prova dei suoi sentimenti di pietà, [...] con l’aiuto delle risorse economiche di suo figlio».96
La grotta misteriosa, nella quale il Signore risorto istruiva i discepoli, ha la valenza tutta positiva
della grotta come luogo simbolico dell’iniziazione ad una sapienza nascosta.
Una miniatura armena che raffigura la teofania del Signore risorto a san Tommaso presenta
sullo sfondo una grotta grande ed elevata, disegnata tra le pareti frastagliate di una montagna che è
un unico blocco di roccia:97 il fondo di questa grotta è oro. A essa si accede attraverso una porta d’oro,
ornata di pietre preziose e incassata nella pietra viva. Sopra di essa è scritto: «la montagna di Galilea
dove aveva dato appuntamento».
La porta è chiusa, perché è allo stesso tempo il sepolcro sigillato nella roccia e la camera
superiore, nella quale il Risorto è entrato a porte chiuse.
La porta è preziosa perché indica l’accesso a una Sapienza fino allora sconosciuta che è il
Signore stesso che si definisce la Porta. Questa porta dà accesso al Regno raffigurato dall’albero a
nove rami che si erge sulla verticale della porta, i cui nove fiori brillano come pietre preziose contro
il blu intenso del cielo.
All’interno il Signore risorto, vestito di bianco e di oro, quasi un gigante vicino agli Apostoli,
poggia i piedi su un prato verde dove fioriscono tre gigli rossi, per simboleggiare appunto che la
grotta è il Regno dei cieli.
Le sue vesti sono sollevate verso l’alto come nelle immagini della Discesa agli Inferi e la lunga
croce astata inclinata verso destra accentua la percezione di un movimento di salita in atto.
Il Risorto afferra il polso di un giovanissimo Tommaso – è la creatura nuova –, allo stesso modo
in cui nella Discesa agli Inferi prende la mano di Adamo, per introdurre la mano con forza nel suo
96 Vita Cost., III, 41. Cfr. A. GRABAR, Martyrium. Recherches sur ie cuite des reliques et l'art chretien antique, Parigi
1946, vol. I, 283-289. 97 Professione di fede di S. Tommaso, miniatura armena, Vangelo di Malatia 1297, n. 7482, XlI sec
La grotta, simbolo dell’inconscio
48
costato, come ha espresso con intelligenza teologico-simbolica Caravaggio nel quadro
dell’Incredulità di Tommaso.
Tommaso-Adamo, reintrodotto nel Regno, tocca il segno del dono totale di sé iscritto nella
carne del Salvatore e ne proclama solennemente il Nome: «Tu, mio Signore e mio Dio» (Gv 20, 28).
Il Signore risorto è l’Iniziatore e allo stesso tempo il soggetto di cui il battezzato fa esperienza.
La conoscenza di Tommaso non è intellettuale ma esperienziale per via di amore: può toccare le
piaghe gloriose del Risorto che sono le sue piaghe ormai glorificate dall’amore.
C’è un ultimo “segreto” nell’immagine della grotta pasquale dell’iniziazione, poiché il centro
del movimento di tutta l’immagine è costituito dalla ferita del costato, che è la grotta divina all’interno
della pietra viva che è Cristo Signore.
La sua apertura è la giustificazione ultima della luce che pervade tutto.
Il Costato aperto del Signore – il Sacro Cuore – è la grotta da cui veniamo alla luce come Chiesa,
è l’esperienza di una Vita rinnovata dall’amore e che riverbera la luce divina.
È il mistero di misericordia che guarisce l’umanità e le restituisce la giovinezza che possedeva
nel giardino della relazione: Tommaso imberbe è l’Adamo ringiovanito, ossia la creatura restituita
alla bellezza primigenia, datagli dal Creatore.
La grotta nella vita spirituale
Tutta la ricchezza simbolica del tema della grotta ha assunto nel Cristo un valore storico-
salvifico: grotta della Natività, grotta della morte-risurrezione, grotta dell’iniziazione.
Proprio perché è entrata nella Storia della salvezza, la grotta - non più oggetto di sospetto per il
fatto di essere legata ai culti della terra98 - può diventare a pieno titolo luogo paradigmatico a partire
dal quale il discepolo ripercorre le tappe della vita del Signore: affronta le potenze delle tenebre, il
Serpente antico, entra nella morte e rinasce come uomo nuovo, spirituale, in grado di vedere la Luce
immateriale; per essere poi invitato dal Signore ad penetrare in una caverna diversa, di pietra
incorruttibile, posta molto in alto: lì entrerà nella Tenebra più che luminosa del Silenzio.
A. La grotta come luogo di combattimento e di rinascita
Molti grandi itinerari spirituali e molte grandi gestazioni incominciano con la permanenza in
una grotta materiale: ancor più del deserto al quale manca la valenza dell’oscurità e il riferimento al
grembo materno, la grotta come luogo fisico è simbolo di uno stato interiore di oscurità, di vuoto, di
agonia mortale e in quanto tale luogo per antonomasia del combattimento con le potenze del Male,
fuori e dentro l’uomo e di una nuova nascita spirituale.
L’itinerario spirituale di alcuni tra i più grandi iniziatori di nuove forme di vita cristiana
incomincia in una grotta: sant’Antonio Abate, san Benedetto, san Francesco.
Nella grotta l’uomo affronta il drago, 99 simbolo delle forze bestiali che si oppongono al
movimento ascensionale dello spirito e quando esce vincitore da questa battaglia è ormai l’eroe, il
cavaliere che cavalca il destriero bianco, colui che dopo aver attraversato una morte simbolica è rinato
come uomo spirituale.
Come spiega Eliade:
«Il ritorno all’origine prepara una nuova nascita; ma questa non ripete la prima, la nascita fisica.
Avviene propriamente una rinascita mistica, di ordine spirituale, in altre parole un accesso ad un
98 Benz ricorda a questo proposito la lotta plurisecolare condotta da Israele conto i culti cananei della Madre terra: la dea
della fertilità e della vita che si rinnova ciclicamente, culto da sempre legato alla terra e alle sue viscere. Solo
appoggiandosi al fatto totalmente nuovo dell'Incarnazione, la Chiesa ha potuto recuperare il simbolo della grotta alla luce
del mistero di Cristo, in questa subito seguita dall'iconografia. 99 Sul drago e i mostri marini nell'antichità, cfr. H. RAHNER, L 'ecclesiologia dei Padri, Paoline, Roma 1971, pp. 470-
509.
La grotta, simbolo dell’inconscio
49
modo nuovo di esistenza – che comporta maturità sessuale, partecipazione al sacro e alla cultura,
apertura allo Spirito -. L’idea fondamentale è che per accedere a un modo superiore di esistenza
bisogna ripetere la gestazione e la nascita, ma le si ripete ritualmente, simbolicamente; in altri termini
si ha a che fare con azioni orientate verso valori dello Spirito e non con comportamenti legati
all’attività psico-fisiologica».100
Francesco, entrato “novizio” nel suo riparo sotterraneo, ne esce uomo solare.
L'esperienza spirituale della purificazione rinnova il passaggio di Cristo attraverso la passione,
la morte, il sepolcro e la risurrezione ed e significativo che i due temi del drago e del sepolcro si
trovino combinati come nella descrizione che san Giovanni della Croce fa della notte oscura:
«[La contemplazione] divina frange e oscura in modo tale la sostanza spirituale, assorbendola in una
totale e abissale oscurità, che l'anima si sente consumare e struggere alla vista delle proprie miserie
da una crudele morte dello spirito; come se inghiottita da una fiera sentisse di essere digerita nel
ventre tenebroso di essa, soffrendo le stesse angosce di Giona nel ventre di quell'animale marino.
Bisogna infatti che si trovi in questo sepolcro di morte in vista della risurrezione spirituale che
l'attende».101
L’oscuramento del peccato ha fatto sì che la verità manifesta diventasse una verità nascosta;
bisogna comunque morire prima di rinascere, cioè simbolicamente entrare nella caverna per fare
ritorno alle origini e da lì salire al cielo, uscire dal cosmo per entrare nel mondo spirituale. È quanto
ricorda Gesù a Nicodemo nel vangelo di Giovanni (cfr. Gv 3, 1-21).
La grotta è la proiezione simbolica del cuore dell’uomo: è l’uomo in quanto mistero a sé stesso. Come dice Teilhard: «Noi altri, creature, siamo da parte nostra l’Oscuro e il Vuoto».102
B. La grotta della iniziazione
Accettando di entrare nell’oscurità di quella caverna che è lui stesso, l’uomo fa una scoperta
paradossale: riconoscendosi come assolutamente vuoto e povero, in positivo scopre sé stesso come
capacità illimitata di accogliere Dio ed entra così nello spessore del mistero.
Si comprende allora che il tema della grotta si ripresenti quando l’esperienza spirituale si
avvicina al culmine: è questo «l’immenso e prezioso tesoro» di cui parla Francesco. La traversata-
discesa compiuta nell’oscurità - san Giovanni della Croce parla di discesa attraverso la scala segreta-
sfocia ad un certo momento nella scoperta dell’immensità sconfinata della Presenza.
Il Cielo è dentro di noi; come scrive santa Teresa di Gesù: «L’anima è talmente bene unita a
Dio da non costituire che una cosa sola con lui; essa è sistemata nell’alloggio di quel cielo empireo
che noi dobbiamo avere nel più intimo di noi stessi».103
In realtà, il Cielo che appare nella grotta, la Presenza divina, è la conoscenza amorosa di Cristo.
Appoggiandosi sull'identificazione paolina del Cristo con la pietra (cfr Cor 10,4), san Giovanni della
Croce scrive nel Cantico spirituale: «Allora alle alte caverne della pietra ce ne andremo che sono ben
nascoste» (CS 36) e spiega: «Le alte caverne sono i misteri rivelati, sublimi e profondi in Sapienza di
Dio, che si trovano in Cristo».104
C. La grotta seno matriciale: la nascita di Dio nel cuore
La grotta, strettamente legata al simbolismo della terra, possiede una valenza matriciale; è il
simbolo della terra feconda che dà il suo frutto. Nella vita spirituale, questa valenza è espressa con il
tema della nascita di Dio nel cuore del credente. Si tratta di un tema molto antico che si rifà al mistero
della Chiesa, la quale generando cristiani, genera il Cristo.
100 M. ELIADE, Aspects du mythe, Parigi 1963 101 GIOVANNI DELLA CROCE, Notte oscura, II, 6; citato in TS, p. 189. 102 TEILHARD DE CHARDIN, La Messe sur le monde, p. 27. 103 TERESA DI GESÙ, Castello interiore, VII, 4. 104 Citato in CH.A. BERNARD, Teologia Spirituale, San Paolo, Cinisello Balsamo 1983, p. 277.
La grotta, simbolo dell’inconscio
50
Già Ippolito stabiliva un triplice parallelo «fra la nascita del Verbo da Dio e da Maria, la sua
nascita nella Chiesa e la sua nascita nel cuore dei fedeli».105 «La bocca del Padre ha lasciato uscire
da sé un Verbo puro, un secondo Verbo appare di nuovo generato dai santi; generando
incessantemente i santi, egli stesso è generato dai santi».106
È vero che il Signore è nato «una sola volta da Maria», ma dato che Maria è «nostra terra» (Sal
67,7), «anche noi possiamo partorire il Cristo se lo vogliamo»107; chi si converte infatti «diventa
vergine e concepisce il Figlio di Dio e lo genera. [...] Se vogliamo, ogni giorno nasce il Cristo;
attraverso le singole virtù egli nasce. Se infatti “il Cristo è virtù di Dio e sapienza di Dio” (1Cor 1,24),
chiunque pratica la virtù genera la Virtù».108
Per un innamorato dei Luoghi della vita del Signore come san Girolamo, la felicità del cristiano
non può essere altro che quella di essere una Terra Santa vivente: «Felice colui che porta nel suo
cuore la croce e la risurrezione e il luogo della natività di Cristo e il luogo della sua ascensione. Felice
colui che ha Betlemme nel suo cuore, colui nel cui cuore ogni giorno il Cristo nasce».109
Per comprendere come si possa parlare di molteplici nascite del Verbo, bisogna avere un
profondo senso teologale, avere cioè il senso della vita divina infinita, inesauribile, perpetua
scaturigine, come lo aveva ad esempio Origene:
«Beato colui che è sempre generato da Dio. Infatti, io non dico che il giusto è nato una volta da Dio,
ma il giusto nasce in ogni opera buona, poiché in essa Dio genera il santo. Se ti dovessi paragonare
al Salvatore - per il fatto che il Padre non generò il Figlio e non lo distaccò da sé dopo la sua
generazione, ma lo genera sempre - potrei dire cose simili a proposito del giusto. Ma noi sappiamo
che il nostro Salvatore è lo splendore della gloria; ora lo splendore della gloria non nasce una volta
per poi cessare di nascere, ma, quanto dura la luce da cui proviene la luminosità, per altrettanto tempo
nasce lo splendore della gloria di Dio [...]; se dunque il nostro Salvatore nasce sempre dal Padre suo,
così anche te, se possiedi lo spirito di filiazione, Dio genera sempre in sé, in ogni opera, in ogni
pensiero e, così generato, tu sei un figlio di Dio, sempre generato in Cristo Gesù».110
Il Padre ci genera eternamente nel Figlio e, in noi, in quanto sue membra, genera eternamente
il Figlio.111
Il presepe di Greccio: grotta e seno
Tre anni prima di morire san Francesco volle evocare la nascita del Bambino a Betlemme nella
sua ricorrenza liturgica: fu collocata una mangiatoia all’interno della grotta vicino a Greccio e vi
furono condotti un asino e un bue. Lì, nella notte, fu celebrata la Messa della Natività in cui Francesco
officiava da diacono, cantando il Vangelo e tenendo l’omelia.
Un testimone degno di fede, il cavaliere Giovanni, discepolo di Francesco riferisce la “mirabile
visione” di quella notte:
«Vedeva nel presepio giacere un bambinello esanime, al quale vedeva avvicinarsi il santo di Dio e
come risvegliare quel bambino dal sopore del sonno. Né tale visione era inopportuna, visto che il
bambino Gesù era dimenticato nei cuori di molti».112
105 G. AEBY, les Missions divines de saint Justin a Origene, Ed. Universitaires, Friburgo 1958, p. 99. Il tema della nascita
di Dio nel cuore estato ampiamente studiato da Hugo Rabner (Ecclesiologia dei Padri). 106 IPPOLITO, Daniele I,8,9. 1,8,9 (GCS Hipp 1,17,16-20); citato ibid, p. 100. 107 GIROLAMO, De Ps. LXXXIV, 13; CCL 78,108. 108 DePs. LXXXVI, S; CCL 78,117-118. 109 De Ps. XCV,lO; CCL 78,154-155. 110 ORIGENE, ...; citato ibid., p. 253. 111 Questa idea di una perpetua generazione si può applicare al padre spirituale; infatti il mistero della trasmissione della
vita spirituale evoca i simboli della nascita e della generazione: «Figliuoli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore
finché non sia formate Cristo in voi» (Gal 4,19). 112 TOMMASO DA CELANO, Vita I, XXX,86.
La grotta, simbolo dell’inconscio
51
La visione del Bambino che Francesco risveglia dal sonno è stata una esperienza spirituale
intensa e una manifestazione simbolica della conformazione totale di san Francesco a Colui che è
l’Immagine del Padre. Qui l’immagine è quella del Bambino eterno, ovvero del mistero dell’eterna
novità e semplicità di Dio, mentre a La Verna sarà quella del Crocifisso.
Tutto avviene in un’atmosfera dalla carica fortemente affettiva: Francesco sta davanti alla
mangiatoia, piange, è pervaso di gioia interiore; canta il Vangelo, parla del mistero della Natività, il
sacerdote che presiede è pervaso di una nuova consolazione.
Tutto avviene di notte.
Il Bambino appare tra le braccia, sul seno di Francesco: il simbolo della grotta dove il Cristo
nasce è il cuore dell’uomo.
Pietro il Venerabile non ha timore di accostare il sepolcro di Cristo al cuore del credente:
«Imiterò il sepolcro di Cristo che custodì per così dire il suo corpo nel seno della terra; io custodirò
nel mio cuore, che si trova in qualche modo nel più profondo del mio essere, il suo ricordo continuo.
In spirito lo terrò sempre con me; sarà in me come in un sepolcro, dimorerà secondo la parola del
cantico “inter ubera mea”. Sarà sempre con me e non si discosterà da me in alcun momento. Certo,
in alcun momento, perché disdegnando e rigettando tutto ciò che non è lui, mi attaccherò a lui solo.
Gesù sarà la mia vita, il mio nutrimento, il mio riposo, la mia gioia. Sarà per me la patria e la gloria.
Gesù sarà tutto per me».113
La terra e le grotte in letteratura
Chi sono il padre e il figlio che camminano lungo una strada, in un paesaggio allucinato, coperto
di cenere, tra i resti carbonizzati della civiltà, diretti verso un non meglio precisato “sud” con un
carrello del supermercato?
La strada, di Cormac McCarthy (2006) è sicuramente uno dei romanzi più importanti dello
scorso decennio.
L’autore vi affronta un genere, quello della letteratura post-apocalittico/distopica, consolidato,
con una sua tradizione e una sicura presa sul pubblico, e crea un capolavoro.
Anche Shakespeare ha affrontato un genere consolidato e di sicuro successo ai suoi tempi come
quello della “tragedia di vendetta” e ha creato Amleto.
L’accostamento con Shakespeare non sembri qui peregrino, né troppo iperbolico: la lingua di
McCarthy è un inglese con forti risonanze bibliche: la tradizione protestante ha infatti sempre
sottolineato l’importanza del rapporto personale con la Bibbia, vale a dire la sua lettura personale, in
una dimensione anche privata. Dunque, la lingua letteraria inglese sarebbe impensabile senza la lunga
storia delle traduzioni della Bibbia. E gli autori anglofoni hanno sempre attinto, più o meno
consapevolmente o volontariamente, a temi, motivi, situazioni e lingua della Bibbia, Shakespeare per
primo. Davvero la Bibbia è il grande codice su cui questa tradizione è fondata.114
Noi non entreremo in particolare nella rete di suggestioni bibliche che è possibile tracciare, ma
che meriterebbe una trattazione più approfondita; ci basterà riflettere su questa coppia di protagonisti
(Abramo e Isacco?) in viaggio verso un non meglio specificato sud dove fa caldo e si può dunque
sopravvivere (Esodo?) e si può forse sfuggire alle atrocità compiute dai resti dell’umanità, ridotta
dalla fame a uno stadio animalesco (Geremia?). Il carrello che il padre sospinge fa pensare a ciò che
resta dell’arca dell’alleanza, così come telo di plastica che ripara la coppia durante la notte è quanto
resta del telo (azzurro!).115
Ora, ciò che è particolarmente importante sottolineare in questo contesto, è il tono profetico
dell’intero romanzo. È come se, implicitamente, ciò che accade fosse la conseguenza della violazione
113 PIETRO IL VENERABILE, A lode del santo Sepolcro. 114 Per una concisa e chiara storia delle traduzioni inglesi della Bibbia si veda G. STEINER, Il libro dei libri, Vita e Pensiero,
Milano 2012. 115 «Then they are to cover the curtain with a durable leather, spread a cloth of solid blue over that and put the poles in
place», Nm 4: 6, New International Version.
La grotta, simbolo dell’inconscio
52
di un patto. Noi non sappiamo quale patto, politico, o economico, o culturale, e via dicendo. Il
narratore è volontariamente oscuro sulle cause della catastrofe. C’è stata una frattura irrimediabile, e
apparentemente irredimibile, nella Historia Mundi. C’è una colpa radicale, che si manifesta nel
paesaggio e nelle situazioni che il padre e il figlio devono affrontare per sopravvivere. C’è una
sorprendente assenza, fin quasi alle ultime pagine del romanzo, di personaggi femminili. O meglio,
c’è una presenza, nel ricordo dei due protagonisti, che rende quantomeno problematica la riflessione
sulla femminilità.
Simbolo matriciale per eccellenza, la grotta è presente, in varie declinazioni, all’interno del
romanzo. Compare nei sogni del protagonista, praticamente in apertura:
Nel sogno da cui si era svegliato vagava in una caverna con il bambino che lo guidava tenendolo per
mano. Il fascio di luce della torcia danzava sulle pareti umide piene di concrezioni calcaree. Come
viandanti di una favola inghiottiti e persi nelle viscere di una bestia di granito. Profonde gole di pietra
dove l’acqua sgocciolava e mormorava. […] Poi si ritrovavano in una grande sala di pietra dove si
apriva un lago nero e antico. E sulla sponda opposta una creatura che alzava le fauci grondanti da
quel pozzo carsico e fissava la luce della torcia con occhi bianchissimi e ciechi come le uova dei
ragni. Dondolava la testa appena sopra il pelo dell’acqua come per annusare ciò che non riusciva a
vedere. Rannicchiata lì, pallida, nuda e traslucida, con le ossa opalescenti che proiettavano la loro
ombra sulle rocce dietro di lei. Le sue viscere, il suo cuore vivo. Il cervello che pulsava in una
campana di vetro opaco. Dondolava la testa da una parte all’altra, emetteva un mugolio profondo, si
voltava e si allontanava fluida e silenziosa nell’oscurità.116
Qui la grotta è solo il “primo livello di cavità onirica”: c’è il lago, nero e antico; la stessa
creatura appare traslucida, vale a dire trasparente, è dunque essa stessa un contenitore, di cui si
vedono ossa, viscere, cuore vivo. Il cervello in una campana di vetro opaco.
La terra si muove a volte, è viva; è sperimentata come un’entità cava:
Tre notti più tardi, ai piedi delle montagne orientali, si svegliò nelle tenebre e sentì qualcosa che si
avvicinava. Rimase sdraiato con le braccia lungo i fianchi. La terra tremava. La cosa veniva verso di
loro.
Papà?, disse il bambino. Papà?
Shh. Va tutto bene.
Papà, che cos’è?
La cosa veniva avanti, sempre più rumorosa. Tremava tutto. Poi passò sotto di loro come un
convoglio della metropolitana e si allontanò nella notte e scomparve, il bambino gli si aggrappò
piangendo, la testa nascosta contro il suo petto. Shh, non è niente.
Ho una gran paura.
Lo so. Non è niente. È passato.
Ma cos’era, papà?
Era un terremoto. Adesso è passato. Non è successo niente. Shh.
Le cavità nella terra, in questo romanzo e in molto McCarthy in generale, possono celare orrori,
ma anche rivelarsi inaspettate “grotte del tesoro”:
Le pareti del bunker erano fatte di blocchi di calcestruzzo. A terra, una colata di cemento coperta di
piastrelle da cucina. […] Casse su casse di cibo in scatola. Pomodori, pesche, fagioli, albicocche.
Salumi in scatola. Carne affumicata. Centinaia di litri d’acqua in taniche da quaranta litri. Tovaglioli,
carta igienica, piatti di carta. Sacchi dell’immondizia pieni di coperte. Si portò una mano alla fronte.
Oh mio dio, disse. Si voltò verso il bambino. […] La ricchezza di un mondo scomparso. Perché sta
qui questa roba?, chiese il bambino. È vera?
Oh sì. È tutta vera.
(…)
L’uomo tirò giù uno degli scatoloni, lo aprì con le mani, e ne estrasse una scatoletta di pesche. Sta qui
perché delle persone hanno pensato che forse ne avrebbero avuto bisogno.
Ma non hanno fatto in tempo a usarla.
116 C. MCCARTHY, La strada, trad. di Martina Testa, Torino, Einaudi 2007.
La grotta, simbolo dell’inconscio
53
No, infatti.
Sono morti prima.
Sì.
E va bene che la prendiamo noi?
Sì, va bene. Loro sarebbero contenti. Proprio come noi al posto loro.
Erano buoni?
Sì, erano buoni.
Come noi.
Come noi. Esatto.
Quindi va bene.
Sì, va bene.
[…]
Va tutto bene?
Non lo so.
Ti senti bene?
Sì.
Allora cosa c’è?
Secondo te dovremmo ringraziarli questi signori?
Quali signori?
I signori che ci hanno regalato tutte queste cose.
Be’. In effetti potremmo ringraziarli.
Lo fai tu?
E perché non tu?
Non so come si fa.
Sì che lo sai. Lo sai come si fa a dire grazie.
Il bambino rimase seduto a fissare il piatto. Sembrava smarrito. L’uomo stava per parlare quando il
bambino disse: Cari signori, grazie per le cose da mangiare e tutto il resto. Sappiamo che le avevate
messe da parte per voi, e se voi ci foste ancora noi non mangeremmo niente, neanche se stessimo
morendo di fame, e ci spiace che non siate riusciti a mangiare queste cose ma speriamo che siate sani
e salvi in Paradiso vicino a Dio.
Alzò gli occhi. Così va bene.
Sì. Direi che va bene.
Questa preghiera pronunciata dal bambino è una delle pagine più toccanti di un romanzo in cui
il rapporto con Dio è il vero motore dell’intera narrazione. Molti, in questo testo, sono i momenti
oranti; essi sono declinati in un continuum che va dall’esperienza del padre, che è quella del silenzio
di Dio, a quella del figlio, che è quella dei puri di cuore. Le cavità della terra, siano esse oniriche,
naturali o opera dell’uomo, evidenziano e allo stesso tempo proteggono la fragilità dei protagonisti e
il loro legame reciproco, incorniciandone la condizione creaturale.
La simbolica della grotta trova una potente realizzazione narrativa nelle pagine dei Miserabili
(1862) dedicate alla traversata delle fogne di Parigi. Jean Valjean, per salvare Marius e sottrarlo
all’arresto (siamo nel 1832, il 5 giugno, durante i moti dell’insurrezione repubblicana) s’inoltra in
quel che è chiamato Intestin de Léviathan. La simbologia della grotta in Victor Hugo ha dunque una
valenza espressamente biblica, così come la figura possente, eroica, di Jean Valjean che porta sulle
spalle il corpo inanimato di Marius in un viaggio sotterraneo che è anche, letteralmente, una
immersione-emersione, possiede potenti suggestioni cristologiche.
“Lui aussi porte sa croix, “Anche lui porta la sua croce” afferma il narratore fotografando in
uno dei titoli la situazione di Jean Valjean, col corpo di Marius sulle spalle, nel temibile labirinto
sotterraneo.
La salvezza viene dalla discesa nelle profondità: «la pupilla si dilata nelle tenebre, e finisce per
trovarvi la luce, così come l’anima si dilata nella disgrazia e finisce per trovarvi Dio». L’immersione
nelle viscere di Parigi avviene per gradi, così come ogni viaggio di iniziazione procede per tappe; il
combattimento finale, che prelude alla rinascita-rigenerazione è il più temibile. Per il nostro
La grotta, simbolo dell’inconscio
54
protagonista la prova finale consiste nell’attraversamento di un fontanile, di una frana sotterranea che
rigurgita acqua:
Che cos’è un fontanile? È la sabbia mobile della riva del mare, incontrata all’improvviso sottoterra;
[…] il suolo, inzuppato, è come in fusione, e tutte le sue molecole sono in sospensione in un mezzo
molle; non è terra e non è acqua, fino a una profondità talvolta grandissima.117
Nella caratteristica ambivalenza dei simboli, qui abbiamo una compenetrazione di due elementi
simbolici primari, terra e acqua, senza che uno prevalga sull’altro.
È possibile figurarsi una morte simile? Se essere inghiottiti è spaventoso sul greto marino, cosa può
essere nella cloaca? […] la sordità, l’accecamento, una vòlta nera, un interno di tomba bell’e fatto,
la morte nel fango, sotto un coperchio! […] Oh, indescrivibile orrore d’una siffatta morte!
Jean Valjean affronta la sua prova e:
Fece uno sforzo disperato e lanciò il piede in avanti: il piede urtò qualche cosa di solido, un punto
d’appoggio. Era tempo.
Si rizzò si contorse e si radicò quasi con furia su quel punto d’appoggio, che gli fece l’effetto del
primo gradino di una scala che risalisse alla vita. […]
Uscendo dall’acqua, urtò in una pietra e cadde in ginocchio. Trovò che era giusto e rimase lì qualche
tempo coll’anima inabissata in chissà quale frase, rivolta a Dio.
Si rialzò, rabbrividendo, intirizzito, infetto, curvo sotto quel moribondo che trasportava, tutto
inzuppato di fango, ma coll’anima piena di una strana luce.
L’anima, nelle parole di Victor Hugo, è inabissata nel momento in cui è rivolta a Dio, così
come l’umiliazione estrema è oggettivata nell’immersione totale nelle acque fetide della fogna.
L’esperienza dell’elevazione de profundis è attivata, fisicamente, da quel qualcosa di solido che è un
primo gradino di una scala.
117 V.HUGO, I Miserabili, trad. it. Renato Colantuoni, Mursia, Milano 1958.
Capitolo quinto
LA MONTAGNA
All’opposto della grotta che evoca abitualmente la discesa e comunque la penetrazione nelle
profondità della terra, la montagna indica, invece, la tensione della terra verso il cielo. L’elemento
che le unisce intimamente è la roccia.
Altezza, elevazione, ascensione, passaggio e rottura di livello, luce e prossimità del cielo: tutto
questo è immediatamente richiamato dalla semplice sagoma della montagna. Per l’uomo infatti le
immagini di elevazione sono quelle che implicano maggiormente il suo impegno totale. Pensiamo
all’incredibile costanza con la quale il bambino si rialza dopo ogni caduta e alla vittoria dei primi
passi.
Cogliendo il senso profondo dell’esperienza originaria della verticalità, Gaston Bachelard si
domanda:
«Ogni valorizzazione non è forse una verticalizzazione? Ogni ascensione è una rottura di livello, un
passaggio nell’aldilà, un superamento dello spazio e della condizione umana. La consacrazione
attraverso i rituali di ascensione o di scalata dei monti o delle scale deve la sua validità al fatto di
inserire il praticante in una regione celeste superiore».118
Il supporto immaginativo dell’ascensione può essere una scala eretta tra cielo e terra, come nel
sogno di Giacobbe, un albero, una colonna, un aquilone, una torre, un campanile, un obelisco…
Ma il simbolo per eccellenza dell’ascensione è la montagna.
In tutte le culture religiose essa è riconosciuta come il luogo dove avviene la rottura dei livelli,
il superamento dell’umano per opera del divino.
In quanto punto d’incontro tra la terra e il cielo è idealmente localizzata al centro del mondo.
Non però questa o quella montagna fisica, ma ogni montagna, e sempre.
In quanto è il simbolo per eccellenza della ri-unione tra il celeste e il terrestre, tra Dio e l’uomo,
la montagna «è il primo e il più sacro di tutti santuari, l’archetipo di tutti i templi».119
Cosi, da una parte, in tutte le religioni il simbolismo della montagna e quello del tempio sono
intercomunicanti e la struttura stessa del tempio evoca la forma della montagna; dall’altra, molto
spesso la cima della montagna è anche il luogo prescelto per la costruzione stessa del tempio (inteso
come edificio che l’uomo consacra al culto).
Per la sua posizione centrale infine la montagna coincide con l’asse invisibile del mondo: la sua
cima si trova sotto la stella polare, perno o ombelico del cielo. All’arco trionfale che ha come centro
del “cielo” la pietra chiave di volta – Cristo o la croce – corrisponde a terra l’altare, pietra angolare,
che definisce il centro del mondo. L’altare, infatti, è su gradini che simboleggiano la santa Montagna
che è di nuovo Cristo stesso, asse del mondo – la croce.
Le montagne nell’Antico Testamento
Il simbolismo universale della montagna sacra aiuta a comprendere meglio il ruolo della
montagna nella storia d’Israele. Come abbiamo osservato a proposito della grotta, alla potenza
evocativa dei simboli universali si sovrappone una valorizzazione derivante dal fatto che «sono
118 Citato in J. CHEVALIER – A. GHEERBRANT, Dizionario dei simboli, BUR, Milano 198612, p. 889. 119 Voce: Montagna, in J. CHEVALIER – A. GHEERBRANT, Dizionario dei simboli, BUR, Milano 198612, pp. 665-669.
La montagna, simbolo di elevazione o di caduta
56
radicati in esperienze storiche concrete. Non più i miti o le leggende li attivano, ma gli interventi di
Dio, sopravvenuti in circostanze rimaste incise in tutte le memorie».120
Sono due i monti santi: in primo luogo il Sinai. Su questa montagna, dopo aver rivelato il suo
Nome e donato la Legge, il Signore rivela a Mose la struttura della tenda nella quale egli dimorerà.
Così, agli occhi del Popolo d’Israele, l’immagine della montagna storica dell’Incontro si combinerà
per sempre con quella della Tenda-Dimora eretta secondo il modello rivelato da Dio.
Viene poi il monte Sion sul quale si erge il Tempio, che è il «duplicato liturgico del Sinai».121
I salmi di salita cantano il pellegrinaggio verso il «monte santo di Sion»: e questa qualifica di «santo»
si riferisce al fatto che lì si trova la dimora e la presenza del Signore, e non a una sacralità del monte
per sé stesso, come nei culti resi sulle alture sacre dei popoli idolatri che circondano Israele.
Poiché il senso del monte coincide con quello del tempio, pertanto la riconciliazione finale degli
uomini con Dio e tra di loro viene interpretata da Isaia come la salita escatologica di tutta l’umanità
dai quattro angoli della terra verso «il monte del tempio del Signore» (Is 2,2)
D’altra parte il monte Sion è legato anche al sacrificio di Abramo, poiché il secondo libro delle
Cronache identifica il territorio di Moria di cui si parla a proposito di Abramo [«Prendi il tuo figlio,
il tuo unico che tu ami, Isacco, e va’ nel paese di Moria e la l’offrirai in olocausto su una montagna
che ti indicherò» (Gen 22, 2)] con il monte sul quale Salomone fa erigere il Tempio: «Salomone
incominciò a costruire il tempio del Signore in Gerusalemme sul monte Moria dove il Signore era
apparso a Davide suo padre» (2Cr 3, 1). Una localizzazione accettata anche nella tradizione
posteriore.
È allora comprensibile il fascino che una simile identificazione avrebbe esercitato sulle prime
comunità cristiane, le quali identificheranno il monte Sion con il Golgota, omphalos del mondo.
Le montagne del Nuovo Testamento
Se ora passiamo al Nuovo Testamento, vediamo che il cammino di Gesù e segnato da ripetute
ascese. Ricordiamo le montagne principali di questo itinerario:
- il «monte altissimo» della terza tentazione;
- la montagna o collina delle beatitudini;
- la montagna dei pani;
- la montagna della Trasfigurazione;
- i1 Monte degli Ulivi;
- la montagna del Golgota;
- la montagna della missione e dell’Ascensione.
Nella visione escatologica dell’Apocalisse appare infine l’ultimo monte, l’ottavo, quello del
Paradiso (Ap 14,1). Si tratta del monte santo che si oppone al monte di Meghiddo (Har-magheddon),
localizzazione storica di molte battaglie sanguinose, che assurge a simbolo del monte scalato da parte
dei malvagi per usurpare il trono di Dio (cfr. Ap 16, 16); o alle sette balze su cui è coricata la grande
prostituta (cfr. Ap 17, 9), che è simbolizzazione di Roma ma anche la città che si oppone a Dio.
Nell’apparente perfezione del numero “sette” sta la sua perversione, che non le garantirà la vittoria
finale, poiché ormai la storia si è aperta sul giorno ottavo, che non conosce tramonto perché nel ciclo
settenario della settimana si manifesta come la novità che spezza la circolarità chiusa del tempo per
introdurvi l’esperienza dell’eterno.122
120 Ibidem. 121 Voce: Montagna, in J. CHEVALIER – A. GHEERBRANT, Dizionario dei simboli, BUR, Milano 198612, pp. 665-669. 122 Cfr. N. MARCONI, Le mille immagini dell’Apocalisse. Una introduzione al linguaggio audiovisivo dell’Apocalisse, Ed.
Paoline, Milano 2002.
La montagna, simbolo di elevazione o di caduta
57
Il «monte altissimo» della terza tentazione
«Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo
con la loro gloria e gli disse: “Tutte queste cose ti darò, se prostrandoti, mi adorerai”» (Mt 4, 8-9).
Questo luogo elevatissimo è da ricollegare con la torre altissima di Babele che doveva
congiungere la terra al cielo, in un sogno di potere e di gloria (cfr. Gen 11, 1-10). Lo sfondo biblico di
questa tentazione è il sogno di esaltazione suprema proprio di certe concezioni messianiche del tempo
di Gesù; pertanto sulla montagna della tentazione bisogna discernere chi darà al Figlio dell’uomo la
dominazione universale promessa a Israele: Dio o il Tentatore?
Il monte altissimo non ha nessuna collocazione geografica, ed è l’immagine della montagna in
negativo: non il luogo dove l’uomo sale per incontrare Dio che gli si rivela, ma luogo simbolico
dell’autoesaltazione dell’uomo. In questa senso va compresa l’affermazione scritturistica della
scomparsa delle montagne come manifestazione degli ultimi tempi e del giudizio divino. Come è
detto in Isaia: «Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati» (Is 40, 4), immagine ripresa
nell’Apocalisse, dove il castigo simbolico del peccato della Grande Citta è questo: «Ogni isola
scomparve e i monti si dileguarono» (Ap 16, 20). Tuttavia, alla scomparsa di tutte le montagne - nella
misura in cui queste sono segno dell’auto-esaltazione dell’uomo -, fa riscontro alla fine dei tempi,
l’unica montagna - di natura teologica - che è «il monte del tempio del Signore» di cui parla Isaia e
che si ritrova nell’Apocalisse: «L’angelo mi trasportò in spirito su un monte grande e alto» (Ap 21,
10).
«Ma Gesù gli rispose: “Vattene, Satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto”.
Allora il diavolo lo lasciò ed ecco gli angeli gli si accostarono e lo servivano» (Mt 4, 9-11).
La risposta di Gesù ristabilisce l’ordine del rapporto creatura-Creatore e il servizio degli angeli
è il riconoscimento dello stato di alleanza che unisce l’uomo a Dio e che ne fa la dignità. Adamo è
rimesso nella condizione della perfetta relazione con Dio, espressa simbolicamente attraverso lo stato
di pace della natura con l’uomo che caratterizza i tempi escatologici. Come dice Isaia: «Il lupo e
l’agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà la paglia come un bue, ma il serpente mangerà la
polvere, non faranno né male né danno in tutto il mio santo monte, dice il Signore» (Is 65, 25) (cfr.
Os 2, 20).
È interessante osservare che i mosaici pavimentali delle sinagoghe del V-VI secolo presentano
spesso nella zona adiacente la nicchia della Torah - la zona simbolicamente più sacra di tutto l’edificio
-, una scena escatologica di natura pacificata.
La montagna dell’insegnamento o delle Beatitudini
«Vedendo le folle Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli.
Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: “Beati...”» (Mt 5, 1 - 8, 1).
Tutta questa sezione del vangelo di san Matteo si concluderà con la discesa di Gesù dalla
montagna, che è la cornice cosmica dell’insegnamento di Gesù. Questa montagna – anche se si tratta
piuttosto di una collina, sulle sponde del lago di Tiberiade - evoca il monte Sinai dove Mosè ha
ricevuto la Legge da Dio.
La montagna dell’insegnamento però è un luogo simbolico, in quanto Cristo stesso è il Sinai.
Questa identificazione del Cristo con la montagna teofanica si ricollega a quella del Cristo con la
Sapienza. Infatti, in lui, si verifica visibilmente l’invito che la Sapienza rivolgeva agli uomini:
«La Sapienza forse non chiama e la prudenza non fa udire la voce? In cima alle alture, lungo la via,
nei crocicchi delle strade essa si è posta, presso le porte, all’ingresso della citta, sulle soglie degli
usci essa esclama: “A voi uomini, io mi rivolgo, ai figli dell’uomo e diretta la mia voce”» (Pr 8, 1-
4).
La montagna, simbolo di elevazione o di caduta
58
Il movimento di fondo che spinge il Cristo a rivolgersi agli uomini è ciò che la lettera agli Ebrei
chiama la sua compassione. Il verbo «ebbe pietà», sia in ebraico che in greco, indica il fremito delle
viscere materne, e perciò un tipo di reazione protettiva davanti alla miseria umana. Si comprende
meglio allora l’accostamento tra la profonda umanità - e l’umiltà di Dio che qui si manifesta -
dell’invito della Sapienza e l’identificazione di Cristo con la Sapienza stessa:
«Quando proclama il suo messaggio, Gesù non assume l’aspetto del dominatore, bensì del seduttore;
come una volta Jahvé, egli vuole “attrarre con legami di bontà, con vincoli d’amore” (Os 11, 4)».123
L’insegnamento di Gesù sul monte, non costituendo un evento storico-salvifico puntuale, non
ha dato luogo a un modulo iconografico teofanico; tuttavia, facendo attenzione alla presentazione di
Matteo: «salì sulla montagna, si mise a sedere, prese la parola», possiamo comprendere che sia la
cattedra sulla quale, già nelle catacombe, Gesù appare seduto. Va ricordato che per tutto il Medioevo,
a eccezione delle raffigurazioni contenute nei codici miniati, aventi di per sé carattere illustrativo-
narrativo, i moduli iconografici vengono creati in funzione di eventi che hanno valore teofanico.
La montagna dei pani
«Allontanatosi di là, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, si fermo là. Attorno a
lui si raduno molta folla recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati; li deposero ai
suoi piedi ed egli li guarì… Allora Gesù chiamò a sé i discepoli e disse: “Sento compassione di questa
folla”» (Mt 15, 29-37).
Il banchetto che segue le guarigioni ha dunque luogo sulla montagna. C’è un richiamo di
situazioni, tra la teofania del miracolo delle quaglie nel libro dei Numeri e questa seconda
moltiplicazione dei pani. Il riferimento alla montagna, a un intervallo di tre giorni, ai pesci e
all’impossibilità di saziare una moltitudine tanto grande rinvia al cammino/pellegrinaggio del popolo
nel deserto:
«Così partirono dal monte del Signore e fecero tre giornate di cammino... Gli Israeliti presero
a lamentarsi dicendo: “Chi ci darà da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in
Egitto gratuitamente”» (Nm 10, 33-11, 32).
«Dopo aver ordinato alla folla di stendersi per terra - un’espressione che nel linguaggio dei vangeli
non indica il tipo di movimento, ma il «mettersi a tavola» -, Gesù prese i sette pani e i pesci, rese
grazie, li spezzò... Tutti mangiarono e furono saziati» (Mt 15, 35-37).
Gesù è infinitamente di più di Mosè, non ha bisogno di intercedere e di dubitare. Di sua autorità
distribuisce il pane di cui la folla ha fame. Il rapporto figurativo tra la moltiplicazione dei pani e
l’Eucaristia è antichissimo; questa stessa scena dà luogo in Oriente alla raffigurazione liturgica
dell’Ultima Cena, come Cristo che distribuisce la Comunione agli Apostoli. Ma la montagna sulla
quale avviene la moltiplicazione dei pani è anche figura simbolica di quel banchetto messianico di
cui parla Isaia, che si svolgerà sul santo monte del Signore:
«Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questa monte, un banchetto di grasse vivande,
un banchetto di vini eccellenti» (Is 25, 6).
La montagna della Trasfigurazione
«Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte,
su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro» (Mt 17, 1-2).
Come attesta Pietro, sulla montagna della Trasfigurazione Gesù «ricevette onore e gloria da
Dio Padre quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce» (2Pt 1, 16-18).
123 CH. A. BERNARD, Teologia spirituale, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1983.
La montagna, simbolo di elevazione o di caduta
59
Si può dire, per cogliere ancora meglio il radicale capovolgimento di situazione, che l’alto
monte della Trasfigurazione si contrappone alla figura negativa di quel monte altissimo della terza
tentazione, simbolizzazione della vertigine di gloria e di potenza: qui non è Satana a proporre, ma il
Padre a donare.
La Trasfigurazione si presenta come una teofania regale, segnata da tre momenti successivi:
1. l’investitura regale: «E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillo come il sole e le sue vesti
divennero candide come la luce» (Mt 17, 2);
2. la proclamazione regale: «Una nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che
diceva: “Questi è il mio Figlio prediletto”» (Mt 17, 5): «Questi è...».124 La nube richiama la simbolica
giudaica della presenza di Dio (la nube sulla tenda nel deserto (Es 49, 35. 38); la nube che scende sul
Tempio di Salomone (1Re 8, 10); la nube che adombra la Vergine nel suo concepimento (Lc 1, 35).
Qui però, secondo la precisazione di san Matteo, si tratta di una «nube luminosa», ossia non c’è più
bisogno di luce esteriore perché Cristo stesso manifesta la bellezza dell’uomo all’uomo:
«è sufficiente che Gesù non trattenga più la luce interiore che abita in lui, perché questa esploda
all’esterno e, dall’alto della montagna, nella nube divina, rischiari la notte del mondo».125
3. L’adorazione tremante degli apostoli: «All’udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e
furono presi da grande timore» (Mt 17, 6). Matteo è l’unico a riportare la reazione dei discepoli - tipica
dei testimoni di una teofania -, ed è anche l’unico a riferire il venire di Gesù verso di loro e il suo
gesto taumaturgico: «si avvicinò e toccatili disse: “Alzatevi, non temete”» (Mt 17, 7). È una chiara
immagine di risurrezione, perché attraverso il tocco e l’invito ad alzarsi (risorgere) li richiama alla
Vita. Dietro la montagna del Tabor appare di nuovo il monte Sinai, ma in una contrapposizione per
maggiorazione tra ombra e luce rilevata anche dai testi liturgici:
«Ti sei fatto vedere da Mose sulla montagna della legge e su quella del Tabor; un tempo nella nube
oscura, ora nello splendore inaccessibile della tua Divinità».126
Proprio a causa della visione diretta della divinità, la montagna del Tabor prefigura il santo
monte escatologico. Così nell’evento della Trasfigurazione, i Padri della Chiesa hanno sempre
ravvisato un’immagine della seconda venuta del Signore e, d’altra parte, nella contemplazione
ecclesiale del Mistero, viene già anticipata lo stato di visione della fine dei tempi:
«Per dare un’idea della tua inenarrabile seconda venuta, quando, Dio altissimo, ti farai vedere in
mezzo alle potenze, sei indicibilmente rifulso sul Tabor davanti agli Apostoli, a Mosè e Elia»;
«Venite popoli, seguitemi: saliamo sulla montagna santa e celeste; rimaniamo spiritualmente nella
città del Dio vivente e contempliamo con la mente la divinità immateriale del Padre e dello Spirito
che risplende nel Figlio unigenito».127
Il Monte degli Ulivi: Gesù è Re
Nessuno dei Sinottici suggerisce una successione cronologica tra l’Ingresso trionfale di Gesù a
Gerusalemme e la sua Passione. Questo Ingresso trionfale possiede diversi elementi comuni con la
festa ebraica delle Capanne (Sukkoth) che aveva luogo in autunno, alla fine dell’anno liturgico
giudaico: le palme, le acclamazioni liturgiche prese dal salmo 118, la presenza delle folle.
Per questo motivo, la maggior parte degli esegeti, ipotizza che l’Ingresso a Gerusalemme abbia
avuto luogo nei giorni della festa ebraica, circa sei mesi prima della Passione.
La festa dei Tabernacoli era celebrazione della regalità di Jahvè (Cfr. Zc 14, 16-17) - cui era stata
collegata in un secondo tempo la festa annuale dell’instaurazione regale con il rinnovamento
124 Questa formulazione: «Tu sei...» faceva parte del rituale di intronizzazione. 125 CH. A. BERNARD, Teologia spirituale, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1983. 126 Canone della Trasfigurazione, Ode I. 127 Canone della Trasfigurazione, Ode IX.
La montagna, simbolo di elevazione o di caduta
60
dell’alleanza da parte del re davidico - e possedeva un forte accento escatologico: era come una
prefigurazione delle gioie materiali del regno messianico.
La sua cornice arborescente, con la costruzione di capanne di fronde - reminiscenza della
protezione divina nel deserto e prefigurazione delle tende in cui abiteranno i giusti - evocava il
giardino del Paradiso.
L’ottavo giorno della festa, durante la processione solenne, gli Ebrei giravano intorno all’altare,
portando il lulab, un mazzetto fatto con tre specie di ramoscelli (salice, mirto, palma) in una mano e
nell’altra un frutto di limone, mentre veniva cantato il lungo salmo 118.
Come spiega Danielou, la palma nel mazzetto del lulab significava non solo la vittoria ma anche
la risurrezione, la speranza dell’immortalità. I frutti di etrog - cedro o arancio - richiamavano i frutti
dell’albero della vita; mentre le libagioni di acqua che accompagnavano la processione facevano
riferimento alle acque vive che escono da Gerusalemme e alla sorgente paradisiaca.128
Matteo mette in risalto l’importanza del Monte degli Ulivi come luogo specifico, facendo
riferimento al profeta Zaccaria, il quale parla di questo Monte a proposito del combattimento finale
che precederà l’istaurazione perenne del Regno di Jahvè:
I piedi di Jahvè «si poseranno sopra il monte degli Ulivi che sta di fronte a Gerusalemme verso
Oriente... In quel giorno acque vive sgorgheranno da Gerusalemme... Il Signore sarà re di tutta la
terra» (Zac 14, 4-9).
Questa profezia si realizza pienamente nel Cristo. L’entrata di Gesù nel Tempio, che segue
immediatamente l’Ingresso a Gerusalemme, non è caratterizzata solo dalla cacciata dei mercanti, ma
anche dalla nuova dignità che Cristo dà a quelli che secondo la legge giudaica non avevano diritto di
accedere al sacerdozio e nemmeno di celebrare il culto, e cioè i bambini e i malati:
«Gli si avvicinarono ciechi e storpi nel tempio ed egli li guarì, Ma i sommi sacerdoti e gli
scribi, vedendo le meraviglie che faceva e i fanciulli che acclamavano nel tempio “Osanna
al Figlio di Davide” si sdegnarono...» (Mt 21, 14-15).
La guarigione dei malati li restituisce alla comunità santa di Israele, mentre per quanto riguarda
i bambini, Gesù ne prende le difese ricorrendo al salmo 8, 3: «Dalla bocca dei bambini e dei lattanti
ti sei procurata una lode».
Vediamo così ricomparire in filigrana la salita escatologica che alla fine dei tempi «tutti i
popoli», senza nessuna esclusione, compiranno verso il monte del Signore, verso il Signore Gesù,
nuovo Tempio aperto a tutta l’umanità.
La montagna del Golgota
Anche se, riguardo al luogo della Crocifissione, il vangelo non parla di una montagna, lo stesso
termine Golgota, luogo del cranio, adombra la presenza almeno di una piccola elevazione pietrosa.
D’altra parte, alla metà del I secolo, il libro di Enoch parla di tre montagne a Gerusalemme: la
montagna santa sulla quale è costruito il Tempio, una montagna più alta, a est: il Monte degli Ulivi,
e una più bassa, a ovest: il Calvario. In ogni caso, simbolicamente il Golgota costituisce la sommità
del Monte Sion.
Sul Monte degli Ulivi Gesù è stato riconosciuto come il Messia Re; sul Golgota il titolo di
Figlio di Dio gli viene attribuito ancora, ma come suprema ironia e come sfida. L’apostrofe della
gente sotto alla croce: «Se sei il Figlio di Dio scendi dalla croce», ricorda la parola di Satana sulla
montagna della tentazione: «Se sei Figlio di Dio, gettati giù» (Mt 4, 3).
In questo modo, all’inizio e alla fine della vita pubblica, ritroviamo la stessa formula e la stessa
sfida.
128 J. DANIELOU, Simboli cristiani primitivi, Arkeios, Roma 1990.
La montagna, simbolo di elevazione o di caduta
61
«[…] senza frasi ma in un quadro impressionante, Matteo presenta prima della morte di Gesù,
l’ultimo combattimento del Signore e il suo esito. In lui, da una montagna all’altra, si affrontano due
messianismi: quello di Satana e quello di Dio».129
Non per niente Luca conclude il racconto delle tentazioni, scrivendo: «Dopo aver esaurito ogni
specie di tentazione, il diavolo si allontano da lui per ritornare al tempo fissato» (Lc 4, 12).
Il monte sul quale si manifesterà la gloria del Servo obbediente è in realtà il luogo
dell’insondabile umiliazione. All’altissimo monte della tentazione si contrappone qui la
profondissima discesa nelle viscere dello Sheol.
Mosè era salito sul colle, per impetrare con le mani alzate, sostenute da Aronne e da Ur, la
benedizione di Dio e la vittoria del popolo d’Israele (Es 17, 10-13); Cristo, sul Golgota, allarga
liberamente le braccia sulla Croce, asse cosmico vivente tra Cielo e terra, per operare la liberazione
di Adamo: «Quando sarò elevato attirerò tutti a me» (Gv 12, 32). È lui l’unico Mediatore eterno tra
Dio e l’umanità, in quanto vero Dio e vero uomo.
La montagna dell’Ascensione-glorificazione e della missione
Riguardo ai luoghi delle ultime apparizioni ci sono due tradizioni (solo in Galilea: Marco e
Matteo; oppure solo in Giudea: Luca e Giovanni, il quale però aggiunge un’ultima apparizione in
Galilea). Accanto a queste c’è la tradizione gerosolimitana dell’Ascensione dal Monte degli Ulivi
attestata negli Atti, e che determina nel IV secolo la costruzione di una basilica sulla sommità del
monte, l’Imbomon, nominata insieme a quella costruita sulla sacra grotta dell’Eleona (cioè:
nell’oliveto), poco distante.
Da rilevare, seguendo Mora, che sull’ultima montagna, prima di ascendere al cielo, il Cristo
risorto, il Kyrios, fa conoscere il suo essere divino: in primo luogo, si identifica con il Figlio
dell’uomo di Daniele:
«Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco apparire, sulle nubi del cielo, uno simile ad un figlio
di uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui che gli diede potere gloria e regno; tutti i
popoli, nazioni e lingue lo servivano; il suo potere e un potere eterno» (Dn 7, 13-14).
Il Risorto, infatti, dice: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra» (Mt 28, 18).
A questa signoria universale, corrisponde la missione universale degli apostoli: «Andate
dunque e ammaestrate tutte le nazioni... Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt
28, 20). Qui è l’apice di tutta la Rivelazione neotestamentaria, infatti il Signore risorto rivela che lui
stesso è il Dio-che-sta-con-gli uomini.130
Già il Re Ciro, nell’atto di liberare il Popolo d’Israele dalla schiavitù di Babilonia, mentre stava
proclamando il suo dominio universale, non poté che aggiungere questo augurio:
«Dice Ciro re di Persia: il Signore, Dio dei cieli mi ha consegnato tutti i regni della terra. Egli mi ha
comandato di costruirgli un tempio in Gerusalemme […]. Chiunque di voi appartiene al suo popolo,
il suo Dio sia con lui» (2Cro 36, 23).
Questo auspicio è volutamente ripreso all’inizio del vangelo di Matteo: «Il figlio della Vergine
sarà chiamato Emmanuele, Dio-con-noi» (Mt 1, 23), vedendolo realizzato in Cristo, che afferma di sé
stesso: «Io sono con voi».
Anche l’iconografia cristiana più antica presenta l’evento dell’Ascensione come un ascensus
secondo il tipo dell’apoteosi, ma il modulo che si impone a partire dal V secolo è quello delle teofanie-
visioni. Non più una salita ma la sessione nella gloria.
129 MORA, op. cit. pp. 99-100 130 Matteo è l’evangelista dell’Emmanuele, del Dio-con-noi. Di nuovo nella finale del suo Vangelo torna il nome che
esprime il desiderio di Dio di essere con l’uomo per sempre. Infatti, volendo interpretare la promessa di Gesù si può
leggerla secondo questo tenore: «Io sono l’Emmanuele (il Dio-con-voi), finché il mondo raggiunga il suo fine» ossia la
comunione dell’amore trinitario, l’ingresso nel giorno in cui finalmente Dio può riposare in compagnia dell’uomo.
La montagna, simbolo di elevazione o di caduta
62
Il Cristo risorto e asceso alla destra del Padre è l’Emmanuele, il Dio-con-noi. «Colui che discese
è lo stesso che anche ascese» (Ef 4, 10), portando al Padre il frutto maturo di una umanità rinnovata
nell’amore.
La montagna escatologica
«Dopo ciò ebbi una visione: una porta era aperta nel cielo» (Ap 4, 1); «L’angelo mi trasporto in
spirito su un monte grande e alto, e mi mostro la città santa» (Ap 21,10); «Poi guardai ed ecco
l’Agnello ritto sul monte Sion» (Ap 14,1).
Il “monte grande e alto” di cui parla il libro dell’Apocalisse è il santo monte profetizzato da
Isaia:
«Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto
dei colli; ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: “Venite, saliamo sul
monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie, e possiamo camminare
per i suoi sentieri”» (Is 2, 2-3).
Su questo monte teologico-spirituale la vita raggiunge una pienezza assoluta: non c’è più fame,
né sete (Ap 7, 16), non ci sono più lacrime; la musica [suonatori di arpa (Ap 14, 2-3)] e il canto risuona
incessante, una luce senza ombre illumina e riscalda (Ap 21, 22); l’aria è piena di profumi (Ap 5, 8);
c’è un fiume di acqua viva (Ap 22, 1) e un albero ricco di fogliame e di frutti (ib.).
Come va inteso questa linguaggio?
Dio manifesta al veggente di Patmos la pienezza ineffabile della Vita, che è lui stesso, attraverso
figure sensibili che fanno appello alle esperienze vitali primarie e alla risonanza affettiva che hanno
nell’uomo: essere sazi, essere dissetati, non avere freddo, non avere paura, non essere lasciati soli ma
vivere nella concordia e nell’armonia-bellezza.
Diversi sensi sono direttamente interessati: la vista, l’udito, l’olfatto, il gusto.131
Diventa allora evidente che la realtà più spirituale di tutte, e cioè la vita con Dio che è la Vita,
viene rivelata a noi attraverso un linguaggio legato alle esperienze sensibili vitali primarie che sono
dotate di una fortissima risonanza affettiva. Il fatto è che l’affettività spirituale - cioè i desideri di
ordine spirituale -, trova la sua espressione a partire dall’esperienza originaria del sentirsi-vivi (vita
organica): il desiderio è sempre desiderio di vita, a qualunque livello ci si ponga.
L’itinerario ideale che dalla prima santa montagna, il Sinai, conduce fino al santo monte
escatologico, abbracciando tutto l’arco della Storia della salvezza, è la vita. Sul monte Sinai Jahvè si
rivela per fare alleanza con il suo popolo, ma in questa offerta di alleanza è contenuto già il progetto
dell’Alleanza nuova ed eterna stipulata nel Golgota, non più con un popolo debole e infedele, ma con
il Figlio stesso Nuovo Adamo «obbediente fino alla morte e alla morte di croce» (Fil 2, 8).
Il Golgota è dunque quell’unico monte che sta al centro del mondo, sul quale si rivela il Dio
che salva, che dà la pienezza della vita. Per questo tutti i monti della Storia della salvezza sono come
contenuti in lui e il monte santo della fine dei tempi è lo stesso Golgota ormai immerso nella luce
della beatitudine eterna; non più testimone della morte, ma della Vita nella comunione e nell’amore.
Il simbolismo della montagna: centro dell’universo, punto di passaggio dell’asse cosmico,
luogo santo dell’incontro tra il Cielo e la terra -, assume così una pienezza indicibile. Non si trova
sintesi più straordinaria di questa passaggio dalla montagna luogo fisico della teofania divina alla
Montagna spirituale, di quella offerta dalla Lettera agli Ebrei:
«Voi infatti non vi siete accostati a un luogo tangibile e a un fuoco ardente, né a oscurità, tenebra e
tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole [...]. Voi vi siete invece accostati al monte di
Sion e alia città del Dio vivente, [...] al Mediatore del Nuova Alleanza e al sangue dell’aspersione
dalla voce più eloquente di quello di Abele» (Eb 12, 18-24).
131 Può essere utile porre una distinzione tra sensi rappresentativi e sensi appropriativi (Cfr. CH. A. BERNARD, Il Dio dei
mistici, Le vie dell’interiorità, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1996.
La montagna, simbolo di elevazione o di caduta
63
Appare così la meraviglia ultima: il santo monte è lo stesso Cristo Signore morto e risorto:
«L’angelo mi trasportò in spirito su un monte grande e alto» (Ap 21,10), «vidi ritto in mezzo al trono
circondato dai quattro esseri viventi e dai vegliardi un Agnello come immolato» (Ap 5,6).
Ma il monte siamo anche noi come desiderio naturale di verticalizzazione.
Le ascensioni dell’uomo
La valorizzazione segue l’asse verticale - Il fascino delle montagne, l’attrattiva irrefrenabile a salire
ha il suo fondamento nel simbolismo primordiale della stazione eretta.
A questo proposito Bachelard parla di un movimento ominizzante. Prendendo coscienza della sua
forza ascensionale, «l’essere umano prende coscienza di tutto il suo destino. Più esattamente, sa di
essere una materia di speranza, una sostanza sperante».132 Per questo motivo le metafore dell’altezza
non nascono da pure convenzioni arbitrarie, sono «metafore assiomatiche», «più naturali di tutte le
altre».133 Lo stesso concetto si ritrova in Mircea Eliade:
«L’alto è una categoria inaccessibile all’uomo in quanto tale; appartiene di diritto alle forze e agli
esseri sovrumani; colui che si innalza salendo cerimonialmente i gradini di un santuario o la scala
rituale che porta al Cielo, cessa allora di essere un uomo; le anime dei morti privilegiati, nella loro
ascensione celeste, hanno abbandonato la condizione umana».134
Bisogna che in noi la salita e la discesa solidarizzino. Come spiega Julien Naud sintetizzando
il pensiero di Bachelard:
«Prima di essere espressa metafisicamente nella categoria corpo-spirito, la dicotomia umana è iscritta
vitalmente nell’immaginazione verticale, il cui movimento va dalla terra all’aria, verso una
spiritualizzazione che non si stacca mai completamente dalla materia».135
La coscienza di questa duplice appartenenza alla Terra e al Cielo è iscritta nell’esperienza
dell’umanità; un frammento orfico ne dà l’espressione poetica: «Sono figlio della terra e del cielo
stellato: in verità sono di stirpe celeste».136
L’ascensione può essere rovinosa: una salita che conduce in basso. - Nell’Antico Testamento, le
conseguenze di un’ascesa che non tenga conto della matrice creaturale vengono espresse attraverso
eventi simbolici riconducibili sempre al tema della caduta. Ne è un esempio l’episodio della torre di
Babele, la cui costruzione significa appunto la volontà da parte degli uomini di innalzarsi, salire in
cielo, con le proprie forze, volontà cui è connessa una pretesa di auto-glorificazione: «Venite,
costruiamo una citta e una torre la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome, per non disperderci
sulla terra» (Gen 11, 4). È un atteggiamento che dimentica che la lode spetta solo a Dio.
Invece della scala innalzata verso il cielo, gli orgogliosi possono cercare di scalare la colonna
di vuoto che regge il cielo. Dice così il re di Babilonia: «Salirò in cielo, sulle stelle di Dio innalzerò
il trono, dimorerò sul monte dell’assemblea, nelle parti più remote del settentrione» (Is 14, 13). Ma la
loro sorte è di cadere rovinosamente, ancora più in basso del punto dal quale erano partiti: «E invece
sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell’abisso» (Is 14, 15).
132 G. BACHELARD, L’air et les songes: essai sur l’imagination du mouvement, Jose Corti, Parigi 1943, pp. 18; 73-74
(citato in J. NAUD, Structure et sens du symbole. L’imaginaire chez Gaston Bachelard, Desclee-Bellarmin, Tournai-
Montreal 1971, pp.73; 75) 133 G. BACHELARD, op. cit., p. 18 (citato in Naud, p. 86). 134 M. ELIADE, Trattato di storia delle religioni, Bollati Boringhieri, Torino 2008, p. 43. 135 J. NAUD, op. cit., p. 80. 136 Frammento orfico n. 17
La montagna, simbolo di elevazione o di caduta
64
Gregorio di Nissa dirà in estrema sintesi: «Il termine cui conduce l’innalzarsi per orgoglio è la
discesa sottoterra».137 Non bisogna dimenticare che il monte altissimo della tentazione di Cristo è,
potenzialmente, una caduta vertiginosa.
Nietzsche: il rifiuto del radicamento nella terra
Il Poeta-superuomo di Nietzsche vorrebbe essere totalmente celeste; il suo desiderio è di
raggiungere il Cielo, ovvero lo stato dell’uomo-dio, totalmente libero da vincoli con la realtà
sensibile. Immancabilmente, le immagini che emergono sono quella del cielo e quella del volo:
«Eccomi leggero, ora volo, mi vedo sotto di me.
Un dio ora danza in me».138
Ma tale coscienza divina di leggerezza assoluta non può durare che un istante fugace, perché
nell’uomo coesistono la terra e il cielo, l’animale e il dio. Egli esprime un desiderio irresistibile di
salire, di volare:
«E quando camminavo solo di che aveva fame l’anima mia nelle notti e sui sentieri dell’errore?
E quando salivo i monti, chi cercavo sulle cime se non te [il cielo]? [...]
Tutta la mia volontà non ha altro scopo che prendere il volo, volare nel cielo! [...]
O cielo sopra il mio capo, cielo puro e alto! …».139
Rifiuta di fraternizzare con le umili realtà terrestri:
«Né per terra, / né per acqua, / troverai la via / che conduce agli iperborei».140
In queste immagini, come osserva Leclerc, c’è un rifiuto degli elementi femminili e fecondabili, un
rifiuto delle immagini materne. Anche gli elementi mediatori sono odiati: una funzione rivestita
simbolicamente dalle nuvole:
«E che cosa odiavo di più delle nuvole che passano ...?
Ce l’ho (J’en veux) con le nuvole che passano, gatti selvatici striscianti...[...]
Ce l’abbiamo (Nous en voulons) con questi mediatori e questi mescolatori, le nuvole che
passano...».141
Sorge allora un’altra immagine, potentemente simbolica, ad esprimere la presenza e l’agire di tutte
quelle forze inconsce che lo legano alla terra e alla vita: quella del mostro:142
«Tutto dorme ancora ora: anche il mare è addormentato.
Il suo occhio guarda verso di me, straniato e sonnolento.
Ma il suo alito è caldo, lo sento. E sento anche che [il mare] sogna.
Nel sognare si agita su cuscini duri.
Ascolta! Ascolta! Come cattivi ricordi lo fanno gemere! oppure si tratta di cattivi presentimenti?
Ah! sono triste con te, mostro oscuro, e per causa tua sono in collera con me stesso.
Ah! perché la mia mano non ha forza abbastanza?
Quanto vorrei veramente liberarti dai sogni cattivi!».143
137 GREGORIO NISSENO, Vita di Mosè, II, 280. 138 F. NIETZSCHE, Zarathoustra, L’Esprit et la lourdeur, trad. Albert, p. 223 (citato in Leclerc fr. p. 226; sp. 224). 139 F. NIETZSCHE, Ainsi par/ail Zarathoustra, Avant le lever du Soleil, trad. Albert, p. 189 (citato in Leclerc fr. p. 222; sp.
p.220). 140 F. NIETZSCHE, Ecce Homo, poésies (trad. Albert), Mercure de France, Parigi 1944, p. 245 (citato in Leclerc fr. p. 223;
sp. p. 220). 141 F. NIETZSCHE, Ainsi par/ail Zarathoustra, Avant le lever du Soleil, p. 190 (citato Leclerc fr. p. 223; sp. p. 221). 142 Cfr. quanto già rilevato parlando della grotta. 143 F. NIETZSCHE, Zarathoustra, Le Voyageur, trad. Albert, p. 178 (citato in Leclerc fr. p. 227; sp. p. 224-225).
La montagna, simbolo di elevazione o di caduta
65
Dall’aria rarefatta delle vette e del cielo puro, alto, senza nuvole, si passa qui a un contesto
notturno, opprimente: un mare personificato che dorme con un alito caldo e, nel fare sogni cattivi,
geme; un mare che si identifica con un mostro tenebroso e triste. La scena è costituita da simboli che
appartengono alla costellazione dell’interiorità, in un’atmosfera avviluppante, da incubo. Il Mare
primordiale, che svolge la stessa funzione della Madre Terra, rinnegato, non assunto, è pronto a
distruggere il proprio figlio: il Poeta sa bene di non essere in grado di combattere contro il «mostro
tenebroso» che è la propria natura animale; per questo è in collera con sé stesso, attribuendo al mostro
la propria tristezza. Una tristezza segno, come direbbe Henri Bergson, che la vita è stata sconfitta. 144
Il cammino spirituale di Nietzsche sfociò nella scissione della coscienza, nella follia. Il fatto è che
ogni volta che l’uomo sale, prende coscienza del suo essere-legato-alla terra: «Non c’è salita eterna,
non c’è elevazione definitiva, scrive Bachelard. In realtà, la verticalità ci dilania: essa mette in noi
al tempo stesso l’alto e il basso».145 E Paul Ricoeur scrive dal canto suo: «Rifiutare la necessità di
quaggiù, significa sfidare la Trascendenza». 146
San Francesco: l’albero ripiantato nella terra
L’atteggiamento profondo di san Francesco riguardo al desiderio di elevazione emerge
chiaramente dal suo sogno dell’albero. Prima di cercare di coglierne il senso, è bene ricordare che
l’albero è un simbolo universale sia del cosmo che dell’uomo; come spiega Eliade:
«Il cosmo è stato immaginato sotto la forma di un gigantesco albero [...] L’immagine dell’albero non
è stata scelta solo per simboleggiare il cosmo, ma anche per esprimere la vita, la giovinezza,
l’immortalità, la sapienza. [...] In altre parole, l’albero è giunto a esprimere tutto ciò che l’uomo
religioso considera reale e sacro per eccellenza, tutto ciò che egli sa essere posseduto dagli dei per
loro natura e solo raramente accessibile a individui privilegiati, eroi, semidei».147
Vi è un’omologia simbolica tra l’albero e l’uomo, dovuta al fatto che:
«Solo l’albero, nella natura, per un motivo tipifico, è verticale, con l’uomo».
Secondo l’immagine poetica suggerita da Bachelard, l’albero è una forza che trascina una vita
terrestre verso il cielo azzurro. Per questo motivo l’immagine dell’albero può servire anche a
esprimere il desiderio di conquista del mondo, come avviene nel caso del sogno di Nabucodonosor,
sorprendentemente vicino, come si vedrà subito, a quello di san Francesco: «Io stavo guardando ed
ecco un albero di grande altezza in mezzo alla terra. Quell’albero era grande, robusto, la sua cima
giungeva al cielo» (Dan 4,7-8); e quando Daniele svela al re il significato del sogno, afferma
esplicitamente l’identificazione tra l’albero della visione e il re stesso: «L’albero che tu hai visto [...]
sei tu, o re, che sei diventato grande e forte» (Dan 17-19).
Ecco, dunque, il sogno di Francesco:
«Una notte mentre dormiva gli parve di star camminando per una strada, sul ciglio della quale si
elevava un albero gigantesco, un albero dall’aspetto splendido, vigoroso, enorme, dal tronco
immenso; mentre, avvicinatosi, se ne stava di sotto a contemplarne la bellezza e l’altezza, d’un tratto
egli stesso crebbe tanto da poter toccare la cima dell’albero; lo prese e, d’una sola mano, con tutta
facilità lo piegò fino a terra».148
È impressionante l’accumulazione di aggettivi che si riferiscono alle proporzioni
“sproporzionate” dell’albero: gigantesco, splendido, vigoroso, enorme, dal tronco immenso,
144 «La joie est le signe que la vie a réussi (H. BERGSON, Le due fonti della morale e della religione, SE, Milano 2006). 145 G. BACHELARD, L’air et les songes, p. 181 (citato in Naud, p. 78). 146 P. RICOEUR, Philosophie de la Volonté, vol. 1, Le Volontaire et l'lnvolontaire, Aubier, Parigi 1950, p. 449 (citato in
Leclerc fr. p. 228; sp. 225-226). 147 M. ELIADE, Le Sacre et le Profane, Gallimard, Parigi 1965, pp. 126-128 (citato in Leclerc fr. p. 178; sp. p. 177). 148 I. CELANO (citato in Leclerc fr. p. 177; sp. p. 176).
La montagna, simbolo di elevazione o di caduta
66
bellissimo...; e Francesco a sua volta cresce fino ad acquistare una statura gigantesca quando giunge
ad afferrare con la mano la cima dell’albero; anche qui va notata l’indicazione specifica "con una sola
mano'', che sta a dire la facilità con la quale viene eseguito il gesto.
In questa visione, che si riferisce chiaramente al cammino spirituale di Francesco: si succedono
due movimenti: il primo solleva Francesco, aspirandolo quasi, fino alla cima dell’albero; l’albero in
quanta pura verticalità è come una scala per attingere il Cielo e simboleggia la ricchezza interiore di
Francesco, egli stesso albero altissimo. Come osserva Leclerc: «L’attrazione possente che solleva
Francesco a quell'altezza sovrumana traduce il desiderio profondo del suo essere di vivere della vita
più elevata, della stessa vita divina, nella ricerca della propria parte pili alta».149
Il secondo movimento e invece di senso contrario: giunto alla cima dell’albero, Francesco ne
afferra la cima e con estrema facilità (facillime) e piega l’albero fino a terra.
«In altre parole egli ripianta l’albero nella terra. [...] Partito dalle altezze del cielo dove lo aveva
portato il primo slancio della sua anima, nel sogno come nel Cantico Francesco torna alla Terra
Madre. Non che rinunci al richiamo dell'Altissimo, ma la sua ricerca del sacro e la sua nascita alla
vita divina passano attraverso l’umile comunione con la Terra Madre e con tutto ciò che essa può
significare quanto a forze intime e oscure. Il cammino religioso di Francesco e un cammino totale.
Essendo un cammino di profonda umiltà e di accoglienza, abbraccia l’uomo intero con le sue radici;
riconcilia l’uomo con la sua totalità, riconciliandolo con Dio. E ciò in un unico movimento».150
Scrive suggestivamente Pierre Emmanuel: «La mia convinzione è che la verticale della
trascendenza si immerge attraverso la nostra oscurità; che l’altezza dello spirito coincide con la
profondità dell’anima, l’esplorazione delle tenebre essendo la via verso quella chiarezza suprema che
dal fondo ignorato di noi stessi ci ordina di metterci in cammino nella notte».151
L’albero capovolto
Il sogno di san Francesco riporta alla mente anche il tema dell’albero capovolto: infatti, nella
simbolica religiosa universale, l’albero divino è rovesciato a significare che la sua radice, il suo
principio vitale, non affonda nell’humus terrestre ma nella trascendenza dei cieli.
Dante vede questa albero capovolto nel Paradiso;152 Chagall a sua volta, nella scena della
Cacciata dal Paradiso terrestre, dipinge un meraviglioso albero capovolto che è al tempo stesso un
albero di luce. Ben coscienti della natura divina di questa albero le cui radici affondano in Cielo, gli
spirituali siriaci hanno ravvisato nella Croce l’albero celeste ripiantatosi per amore sulla terra.153 Per
sant’Efrem, Gesù è il «ramo della verità» del Grande Albero la cui radice è in cielo154 che, per amore,
si è piegato fino allo Sheol:
«Gesù, piega verso di noi il tuo amore, perché lo possiamo afferrare!
Questo è il ramo che piegò il suo frutto verso gli ingrati;
mangiarono e furono saziati, ma si rivoltarono e lo insultarono;
eppure si piegò fino ad Adamo nel cuore dello Sheol.
[Il ramo] ascese portando su Adamo e con esso questi torno in Eden.
149 E. LECLERC, op. cit., p. 166. 150 E. LECLERC, op. cit., pp. 166-167. 151 P. EMMANUEL, Le goût de l’Un, Parigi 1963, p. 196 (citato in Leclerc, p. 167). 152 «L’albore che vive della cima / e frutta sempre e mai non perde foglia» (DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia,
Paradiso XVILI, 29-30). 153 R. MURRAY, Symbols of Church and Kingdom. A Study in Early Syriac Tradition, Cambridge University Press 1975;
in particolare it cap. III: «The Vineyard, the Grape and the Tree of life». 154 Nell’universo di immagini di sant'Efrem, il ramo simboleggia il Cristo mentre la «radice celeste» simboleggia il Padre:
un tema che ricorre di frequente negli Inni sulla Fede (cfr. Murray, p. 107).
La montagna, simbolo di elevazione o di caduta
67
Benedetto sia colui che piegò il ramo verso di noi
perché lo potessimo afferrare e ascendere per mezzo di esso».155
Non si può non rimanere colpiti dalla affinità di questa immagine con la visione-sogno di san
Francesco.
La simbolica cristiana dell’elevazione: bisogna scendere per salire - Come si è visto, sempre
l’attrazione dell’uomo verso l’alto deve essere equilibrata dall’accettazione e dalla conoscenza della
nostra creaturalità - il «basso» -, perché egli non perda il senso del reale concreto in un processo di
sublimazione irrealista e l’equilibrio psichico sia preservato.
Tuttavia, l’ascesa cristiana si differenzia dalla simbolica ascensionale generale: infatti, poiché
il discepolo non può che seguire la via del Maestro, essa presuppone una prima discesa.
Questo duplice movimento, del tutto esplicito nel Vangelo, è già presente nella rivelazione
veterotestamentaria; è evidente infatti che l’episodio di Betel possiede un rapporto antitetico con la
storia della torre di Babele: lì, l’uomo voleva salire da solo al cielo, qui Dio stesso getta una scala tra
cielo e terra.
Il senso più profondo della visione di Giacobbe consiste nel paradosso di una elevazione che
emerge da una umiliazione. Giacobbe è fuggitivo, esiliato, rigettato da tutti:
«Un abbattimento totale è piombato su di lui. In quel momento ha raggiunto il colmo
dell’umiliazione. Giacobbe ha conservato un’unica cosa: la capacità di portare come si deve la
disgrazia scoppiata sopra di lui. Ha còlto il senso della catastrofe: abbandono completa alla guida di
Dio».156.
Ed è precisamente in questa condizione che scopre di trovarsi nella Casa di Dio e alla porta del
Cielo (cfr. Gen 28,17). Per il suo cuore umiliato Dio pianta la scala del cielo. Colui che si esalta, in
realtà va scendendo, perché si allontana da Dio. Più si è umili, più dunque si è vicini a Dio. «Ma
l’uomo tutto quanto, corpo e anima, deve essere trafitto dall’umiltà».157
Il vero agente dell’ascesa cristiana è lo Spirito Santo; quello Spirito che ha condotto il Signore
Gesù attraverso gli abissi dell’umiliazione (summae humilitatis culmen) fino alla glorificazione (ad
exaltationem caelestem). Secondo l’affermazione scarna e assoluta di Ireneo, lo Spirito Santo è la
«scala della nostra ascesa verso Dio».158
Il movimento cristico dell’ascesa attraverso la discesa e quello indicato da san Paolo quando
esclama: «Ma che significa la parola “ascese”, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra? Colui
che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per riempire tutte le cose» (Ef 4,8-
10). Riemerge l'immagine dell’albero che unisce i tre livelli della realtà: le viscere della terra, il suolo
e l'aria, e si comprende meglio l'equiparazione tra l'albero e la Croce: anche questa, per essere elevata,
ha dovuto essere piantata in terra e ora abbraccia tutte le dimensioni dello spazio. Dall’umiliazione
estrema, il cui movimento si compie nella Discesa agli inferi, nasce la Risurrezione e la glorificazione.
Tale movimento proprio dell’Incarnazione viene poi assunto da coloro che sono chiamati ad
essere «cristi-formi»159 ed è mirabilmente disegnato in un poema di san Giovanni della Croce:
155 Inno «Riposate sicuri sulla Verità» (CSCO 174, Syr. 78, pp. 67-70; trad. fr. di R. Lavenant in SC 137), stanza 8; citato
in Murray, p. 109. 156 DOM ILDEFONS HERWEGEN, Sinn und Geist der Benediktinerregel, 1944 157 CH. A. BERNARD, Teologia spirituale, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1983. Nel canto del Magnificat Maria
contempla i potenti sradicati dai loro troni e gli umili innalzati; così come i ricchi ridotti a mani vuote mentre gli affamati
sono ricolmati di beni. Non si tratta di una giustizia sociale o di un ribaltamento rivoluzionario: in verità Maria sta
annunciando la misericordia di Dio che, gettando a terra colui che si è elevato insensatamente, gli permette di alzare lo
sguardo in alto e di attendere di essere rialzato da colui che si è fatto povero per salvarlo. 158 IRENEO DI LIONE, Adversus Haereses ILI, 24, 1. 159 L’ascensione è la parabola finale del movimento di Incarnazione: infatti colui che è disceso dal cielo, dopo l’evento di
morte e risurrezione, vi ritorna portando con sé il frutto di una umanità glorificata (umanizzazione/divinizzazione), capace
cioè di custodire il dono della comunione nell’amore.
La montagna, simbolo di elevazione o di caduta
68
«Quanto mas alto llegaba / de este lance tan subido,
tanto mas bajo y rendido / y abatido me hallaba;
dije: No habrà quien alcance; / y abatime tanto, tanto,
que fui tan alto, tan alto, / que le di a la caza alcance».
«Quanto più in alto giungevo / in quello slancio così sublime,
tanto più in basso ed arreso / e abbattuto mi trovavo;
dissi: “Non vi sarà chi vi giunga!”; / e mi abbassai tanto tanto
che fui in alto, tanto in alto, che raggiunsi quel che perseguivo».160
Terra e scale di pietra, montagne, alberi e insetti
Denise Levertov è nata in Inghilterra ma naturalizzata statunitense; suo padre era un ebreo di
tradizione chassidica convertito al cristianesimo che divenne pastore anglicano; lei stessa si convertì
al cattolicesimo negli ultimi anni della sua vita. Levertov ha trovato l’originalità della propria voce
poetica nella fusione tra l’attenzione contemplativa verso le cose come segni (propria anche della
tradizione paterna) e la poesia americana di William Carlos Williams, che le presentava esempi di
una medesima attenzione verso gli oggetti, espressa però in una lingua che abbandona ogni lirismo
tardo romantico. La scala di Giacobbe (1961) è una poesia che poniamo a contrappunto della discesa-
salita di Valjean, della sua tensione verso il cielo. Entriamo dunque nelle esperienze dell’altezza.
La scala di Giacobbe
Non è una scala
di filamenti di luce
apparizione evanescente
per i piedi degli angeli,
giusto da sfiorare con lo sguardo, senza
toccare la pietra.
Essa è di pietra.
Pietra che sembra sfumare in una luce rosata
solo perché dietro il cielo sta dubbioso, un incerto
grigio notte.
Una solida scala fatta ad angoli
acuti.
Uno capisce che gli angeli devono
saltellare giù un gradino alla volta, aiutandosi
un poco con una spinta delle ali:
e che un uomo che si arrampica
deve sbucciarsi le ginocchia, e aiutarsi
con la presa delle mani. La pietra squadrata
conforta i piedi esitanti. Ali lo sfiorano passando.
La poesia ascende.161
La poesia ascende, nella voce poetica di Levertov. E si tratta di una ascesa dolorosa, che si
compie con passi difficili, esitanti. Ci si fa male. Così come Giacobbe, nel racconto biblico. A volte
bisogna aggrapparsi con le mani per continuare. Cosa può significare, in poesia, aggrapparsi con le
mani? In quella americana del Novecento, che in qualche modo qui stiamo avvicinando, non significa
trovare un oggetto, o una configurazione di oggetti il cui significato rimandi, allegoricamente, a
160 GIOVANNI DELLA CROCE, La notte oscura, strofa 3. 161 D. LEVERTOV, The Jacob’s Ladder, in The Norton Anthology of American Literature, Norton & Company, New York-
London 1989.
La montagna, simbolo di elevazione o di caduta
69
qualcos’altro, in un gioco infinito di specchi. No. Il valore è nella cosa in sé. Il valore qui, è nella
pietra, nella sua solidità. Persino gli angeli devono percorrerla un gradino alla volta. L’occhio del
poeta vede la cosa e nel nominarla la crea.
La stessa attenzione alla composizione intesa come costruzione materiale è manifesta in questa
poesia di Wallace Stevens, un altro poeta americano, che proviene da una raccolta intitolata, molto
significativamente, The Rock (1954)
La poesia che prese il posto di una montagna
Stava lì, parola per parola,
la poesia che prese il posto di una montagna.
Egli ne respirò l’ossigeno,
anche quando il libro giacque, faccia in giù, nella polvere del tavolo.
Gli ricordò come avesse desiderato
Un posto dove dirigersi lungo il suo cammino,
Come avesse ricomposto i pini,
spostato le rocce e scelto la sua strada tra le nuvole,
verso un punto da cui guardare che fosse quello giusto,
dove essere completo in una completezza non spiegata:
La roccia esatta dove le sue inesattezze
Scoprissero, alla fine, la vista verso cui si erano spinte,
dove sdraiarsi e, guardando in basso verso il mare,
riconoscere la sua unica e solitaria casa.162
L’esperienza dell’altezza nasce qui dalla contemplazione di una pagina, che,
significativamente, giace a faccia in giù nella polvere del tavolo. Una pura orizzontalità, dunque,
genera, nella contemplazione dell’oggetto-libro, l’esigenza di una ascesa. Si tratta di una ascesa
creativa, poiché ciò che viene descritto è la composizione della poesia. Si descrive cioè la tensione
verso una esperienza di pienezza che nasce dall’esigenza di una perfetta espressione poetica. Si tratta
di una perfezione da raggiungere: è l’ascesa verso un linguaggio che sia quello esatto, che nomini
esattamente la realtà, indicata dalla scelta di una strada tra le nuvole che non sia generica, ma
personale. La strada giusta, e personale, che possa portare al riconoscimento, dall’alto, della propria,
preziosa perché unica e solitaria, origine.
La montagna incantata (1924), di Thomas Mann, può essere considerato come una sterminata
“esperienza dell’altezza”, ma anche, e soprattutto, delle sue contraddizioni e ambiguità. Il narratore,
attraverso la galleria di personaggi che interagiscono a vari livelli con il giovane Hans Castorp, il
protagonista, articola una narrazione delle principali posizioni della cultura europea alla vigilia della
Grande Guerra. Il giovane Castorp, stanco di duelli intellettuali di cui non capisce bene il senso,
decide di intraprendere una solitaria escursione con gli sci.
Il suo orologio segnava le tre del pomeriggio. […] Provava un senso di benessere al pensiero di avere
davanti a sé tante ore per girovagare all’aperto, in mezzo a quella natura grandiosa. […] Pareva
volesse nevicare, nevicare più forte quasi per accontentare un bisogno assillante, pareva che la
nevicata dovesse mutarsi in un turbine vero e proprio. Difatti sul pendio aperto i fiocchi piccoli e
silenziosi cominciarono a scendere con maggiore abbondanza. Giovanni Castorp uscì dal suo riparo
per raccoglierne due o tre sulla manica e contemplarli con occhi di conoscitore e studioso innamorato.
[…] sapeva benissimo di quali preziose e perfette minuzie essi fossero formati; erano gioielli, stelle,
spille di brillanti […] miriadi di particelle d’acqua cristallizzate in svariatissime forme simmetriche
[…] uno sconfinato piacere inventivo nel mutamento e nella elaborazione minuziosissima dello
162 W. STEVENS, The Poem That Took the Place of a Mountain, in Harmonium, poesie 1915-1955, Einaudi, Torino 1994.
La montagna, simbolo di elevazione o di caduta
70
stesso schema fondamentale, l’esagono regolare […] una simmetria assoluta, di una gelida regolarità,
e questo era l’elemento pauroso, antiorganico, ostile alla vita. […] la sostanza ordinata per la vita
non lo era mai fino a questo punto, la vita rifuggiva dall’esattezza, la riteneva micidiale, quasi come
il mistero stesso della morte e Giovanni Castorp credette di capire perché i costruttori di basiliche
degli antichi tempi avessero introdotto a bella posta e in segreto piccole modificazioni nella
simmetria dei loro ordini di colonne.163
L’autore sta immettendo il suo personaggio in un inesorabile e potenzialmente mortale
incantesimo (la montagna è incantata): dalla bellezza dei cristalli alla considerazione della loro
innaturale regolarità. L’ascesa di Castorp è una sfida incauta; la verticalità che nel pensiero di Castorp
prende la forma degli ordini di colonne degli antichi tempi è qui una esperienza di estraneità, di
alterità. La montagna dischiude una epifania del totalmente altro. Essa si pone come una meta
proibita. Ma Castorp si comporta da “piccolo” Icaro:
Assaporava con soddisfazione la sua indipendenza alata, il suo libero girovagare. […] Sì, il fascino
delle lontananze e delle alture, della solitudine sempre rinnovatesi si faceva sentire con forza
nell’animo di Giovanni Castorp, cosicché, a rischio di tornare in ritardo, si addentrò nel silenzio
selvaggio, nel mondo sinistro che non prometteva nulla di buono, e ciò quantunque l’agitazione e
l’oppressione che sentiva dentro di sé divenissero paura in vista dell’oscurità che scendeva (…) come
un velo grigio, su tutta la contrada. […] Tuttavia non si decideva a fuggire […] la paura, la sua
sincera paura in cospetto degli elementi lo opprimesse pure a suo piacere.164
Le cose si mettono male per il nostro eroe, che a un certo punto decide di tornare, ma deve
affrontare la tormenta in un tentativo di discesa controvento:
I fiocchi gli volavano in massa contro il viso e vi si scioglievano procurandogli un tormento
indicibile; gli penetravano nella bocca dove pure si scioglievano con un leggero sapore acquoso, gli
volavano contro le palpebre che si chiudevano convulsamente, gli inondavano gli occhi
impedendogli ogni sguardo in giro. […] Era il nulla, il nulla bianco e turbinante in cui egli guardava
quando si sforzava di vedere. […] - Un bell’affare! – disse fra i denti, e si fermò. […] Capiva di non
avere diritto a parole grosse ed a bei gesti; la provocazione aveva fatto la sua parte, e tutti i pericoli
erano da ascrivere unicamente ad essa. – Non c’è male – disse, e sentì che i suoi lineamenti, i muscoli
espressivi del suo viso non obbedivano più all’anima e non erano in grado di ridare né la paura, né il
furore, né il disprezzo, essendo completamente irrigiditi.165
Castorp, quasi assiderato, riesce a trovare una piccola baita, ma è chiusa; non potendo entrare, si
poggia in piedi contro una parete, nel tentativo di non cedere all’istinto di sdraiarsi e dormire. A
questo punto, comincia a delirare. Il delirio da pre-assideramento di Castorp viene descritto con
estrema minuzia, si tratta di una lunga digressione, talmente lunga da mimetizzare letteralmente la
perdita della percezione del tempo reale da parte del protagonista (solo dieci minuti). Il sogno di
Castorp comincia vagheggiando una specie di età dell’oro, una non meglio definita civiltà dei “figli
del sole” in cui tutto è armonia e bellezza, per terminare in un terribile incubo in cui due streghe sono
intente a compiere un sacrificio umano. Ciò che è interessante notare è che, in questo incubo, la
verticalità del motivo delle colonne che abbiamo riportato nella prima citazione riappare e diventa
centrale nell’ambientazione del sacrificio umano: la mente di Castorp si trova in una specie di tempio
archetipico, ma si tratta di un tempio ostile all’uomo. E il protagonista osserva il tutto appoggiato a
una colonna del tempio che si rivela al risveglio essere la parete della capanna. Nello stato tra il sonno
e la veglia Castorp così conclude:
“Lo immaginavo bene che stavo sognando! […] Che sogni terribili e meravigliosi! Lo sapevo, in
fondo, che quelle immagini erano parto della mia fantasia […] Non si sogna soltanto con la propria
anima, vorrei quasi dire: i nostri sogni sono anonimi e comuni quantunque abbiano il loro tipo
163 TH. MANN, La montagna incantata, trad. Bice Giachetti Sorteni, Dall’Oglio, Milano 1930. 164 Ibidem. 165 Ibidem.
La montagna, simbolo di elevazione o di caduta
71
speciale. La grande anima, della quale tu sei soltanto una piccola parte, sogna è vero talvolta per
mezzo tuo, a tuo modo, di cose che sogna sempre in segreto, della sua gioventù delle sue speranze
di felicità e di pace … e del suo pasto cruento. Eccomi qui appoggiato alla mia colonna; dentro di
me ho ancora i resti del mio sogno, l’orrore davanti allo strazio ed anche la gioia di prima […] Ho
sognato della condizione umana e della sua convivenza cortese, intelligente e rispettosa, dietro la
quale, nel tempio, si svolge l’orribile pasto cruento. […] Voglio essere buono. Non voglio concedere
alla morte alcuna supremazia sui miei pensieri! Poiché in ciò consiste la bontà e l’amore del
prossimo, e non in altre cose. La morte è una grande partenza. […] ci si veste severamente e di nero
in suo onore. La ragione sta con aria sciocca davanti alla morte, poiché quella non è che virtù, questa
è libertà, assenza di forma, piacere. Piacere, dice il mio sogno, non amore. Morte e amore, questo è
un cattivo binomio, un binomio falso e scipito. L’amore è contrario alla morte, soltanto l’amore, non
la ragione, è più forte della morte. […] forma e costumatezza, comunità intelligente e affettuosa,
bella umanità sociale, in silenziosa vista del pasto cruento. […] Ci voglio pensare. […] Per riguardo
alla bontà e all’amore l’uomo non deve concedere alla morte la signoria sui propri pensieri. E con
ciò mi sveglio. […] Su, su! Apri gli occhi! Sono le tue membra queste, le tue gambe, qui, nella neve!
Raccogli le tue forze e alzati!”
È da sottolineare che Castorp viene definito dal narratore “un sempliciotto”: in questo lungo
monologo che abbiamo necessariamente ridotto, egli viene come attraversato da echi di grandi nodi
speculativi della cultura del tempo; cose che ha orecchiato, partecipando o più spesso assistendo alle
discussioni degli altri ospiti del sanatorio: in questo specifico passo, ad esempio, i riferimenti sono a
Freud e Jung. Ma la sintesi che riesce a dare, e questo è ciò che ci interessa in questa sede, gli viene
da una personale e molto concreta “esperienza dell’altezza”, che è quella del limite. Solo accettando
il limite Castorp vive una esperienza che non lo divora. La tormenta, cioè, si pone come limite
salutare. Le vertiginose altezze che il romanzo descrive sono quelle effettive delle montagne, di cui
abbondano splendide descrizioni, ma anche, e soprattutto, quelle umane dell’attività speculativa, che
Castorp, in questo monologo, sente come incantesimi nefasti, se non collegati alla consapevolezza
dello stato creaturale, dunque del limite. L’escursione incauta ad alta quota è potenzialmente mortale,
esattamente come la speculazione che egli percepisce come incauta, se dimentica il limite. La morte
è una grande partenza, afferma Castorp.
La verticalità è propria degli uomini e degli alberi. L’albero è simbolo dell’uomo, ma anche del
cosmo. È simbolo di vita, e di vita ordinata a un fine. È infatti anche simbolo di sapienza:
Eccoci davanti a un albero. Poniamo che sia una quercia, colosso dalla pelle screpolata. Brehm
chiama la quercia “l’albero della federazione” perché, egli dice, “nel suo interno e nelle sue parti
esterne, gl’insetti trovano cibo e abitano in pace gli uni accanto agli altri, in numero maggiore che su
qualsiasi altro albero”.
La quercia offre dunque il modello di una Terra in cui gli uomini vivessero fianco a fianco senza
sbranarsi. Mondo di rami e di foglie cha dà asilo a un mondo di abitanti; dabbasso gli insetti, nascosti
nell’erba e nel musco umido; i molluschi minuscoli che vivono negl’incavi del tronco; poi i nidi sui
primi rami; al piano superiore, nidi di maggiori dimensioni: colombacci, corvi, gazze. E, a un tratto,
la vetta: l’ombra è vinta, l’anima della terra è salita da un ramo all’altro, e si espande sull’ultimo, col
canto di un uccellino.166
Sono parole tratte da un libro incantevole: Canti d’uccelli e musiche d’insetti (1947), di Marcel
Roland, poeta, romanziere, naturalista e divulgatore scientifico. La quercia, è qui, nelle parole
dell’autore, un modello. La quercia, emblema della forza, della nobiltà, si staglia in questa miniatura
dell’autore come simbolo edenico, di una vita in cui tutti vivono insieme senza discordie e senza
fratture. Come indicato nel titolo, Roland descrive nel suo testo il comportamento e il canto delle
creature che abitano i boschi e il mondo vegetale in genere, diffondendosi molto nella descrizione di
alberi e foreste. La sua prosa è caratterizzata da un tono sottilmente elegiaco, e la sua visione è
inquadrata in una prospettiva profondamente cristiana:
166 M. ROLAND, Canti d’uccelli e musiche d’insetti, trad. Remo Costanzi, Rizzoli, Milano 1951.
La montagna, simbolo di elevazione o di caduta
72
[…] dopo il magico spettacolo del tramonto, guardavo attardarvisi [nella foresta] le brevi luci che
appendevano qua e là lampade d’altare segnalanti la presenza di Dio. […] E in quel momento, come
il chierichetto agita il campanello per l’Uffizio delle Tenebre, l’ultimo pettirosso si metteva a
cantare.167
L’albero, la cui simbolica esprime la comunicazione tra più livelli di realtà, è esso stesso, nel
realismo magico di Dino Buzzati, espressione naturale di una vita che non si esaurisce nella sua
fisicità. Il segreto del Bosco Vecchio (1935) sta proprio negli abeti, perché essi sono abitati da genî,
creature degli alberi, che possono assumere sembianze umane o di animale, e uscire dagli alberi a cui
sono legati:
La loro forza, così risulterebbe, non poteva in alcun modo opporsi a quella degli uomini. La loro vita
era legata all’esistenza degli alberi rispettivi: durava perciò centinaia e centinaia d’anni.
Di carattere ciarliero, se ne stavano generalmente alla sommità dei fusti a discorrere fra loro o col
vento per intere giornate; e spesso anche di notte continuavano a conversare.168
Come si vede, non si tratta di personificazioni della forza vitale, di epigoni nietzschiani alla
maniera di un D’Annunzio nella Pioggia nel pineto, ad esempio. La natura benigna e pacifica di
queste creature è espressa dalla loro mitezza e, tipicamente, dalla possibilità di assumere aspetto
umano e comportamenti civilizzati. Uno di loro, il Bernardi, ha addirittura deciso di vivere
stabilmente fra gli uomini, e di entrare a far parte della Commissione forestale, solo per difendere i
fratelli dal taglio del bosco. Ma il nuovo proprietario, il colonnello Procolo, intende tagliare degli
abeti, e si reca al Bosco per assistere all’operazione. Vi incontra i genî, riuniti per il taglio di un abete,
dunque per il funerale di un loro fratello. Notiamo qui la lingua di Buzzati, asciutta, semplice, mai
iperbolica, quasi un sermo humilis del fantastico:
Erano persone alte ed asciutte, con occhi chiari, il volto semplice e come seccato dal sole. Portavano
vestiti di panno verde fatti secondo la moda del secolo prima, senza pretese di eleganza ma molto
puliti. Tenevano tutti in mano un cappello di feltro. Nella maggioranza avevano i capelli bianchi ed
erano sbarbati. Nessuno sembrò accorgersi che fosse arrivato il colonnello. Il Procolo ne approfittò
per avvicinarsi alle loro spalle e assistere così da vicino a quello che stava succedendo. E come fu a
ridosso della schiera dei genî, con molta circospezione, toccò la falda di una delle loro giacche,
costatando che era stoffa vera e non una semplice illusione. […]
Seduto su un sassone, da solo, vicino alla base dell’albero, stava uno dei genî, simile a tutti gli altri;
era il genio dell’abete che si stava tagliando. Seguiva il lavoro dei boscaioli con grande attenzione.
[…]
A un tratto il Bernardi si staccò da un punto del semicerchio, avanzò per il terreno libero e si avvicinò
al genio che sedeva solo, battendogli una mano sulla spalla.
“Siamo venuti per salutarti, Sallustio!” disse a voce alta come per far capire che parlava anche a
nome di tutti gli altri compagni. Il genio dell’abete rosso si alzò in piedi, senza però staccar gli occhi
dalla sega che rodeva il suo tronco.
“Quello che succede è triste, non ci siamo assolutamente abituati” continuò il Bernardi con voce
pacata. “Ma tu sai quanto io abbia fatto per cercare d’impedirlo […]
Questa sera stessa tu sarai lontano, nella grande ed eterna foresta di cui in gioventù abbiamo tanto
sentito parlare. La verde foresta che non ha confini […] Ritroverai i nostri compagni caduti. Essi
hanno ricominciato la vita, questa volta definitivamente. Sono tornati piantine a fior di terra, hanno
di nuovo imparato a fiorire e sono saliti lentamente verso il cielo. Molti di loro devono esser già
cresciuti bene. Salutami il vecchio Terbio, se lo rivedi, digli che un abete come lui non si è più visto,
e sì che son passati più di 200 anni. Questo gli potrà far piacere.
Sì, è un po’ dura una partenza così. Ci si era affezionati l’un l’altro e tutto questo sembra strano. Ma
un bel giorno finiremo per ritrovarci. I nostri rami si toccheranno ancora, e riprenderemo i nostri
discorsi e gli uccelli ci staranno a sentire. Ce ne sono lassù di grandi e bellissimi, uccelli a molti
colori, come da queste parti non esistono.”
167 Ibidem. 168 D. BUZZATI, Il segreto del Bosco Vecchio, Mondadori, Milano.
La montagna, simbolo di elevazione o di caduta
73
[…]
Il Bernardi tacque. L’altro gli strinse la mano, dicendo:
“Grazie, adesso va’ pure con gli altri, perché mi pare che si metta al brutto. Non è il caso di far
cerimonie”.169
L’ultima esperienza della terra che proponiamo è un’esperienza di insetti. Di un enorme
insetto, del protagonista, cioè, della celeberrima Metamorfosi di Franz Kafka.
Sull’immaginario che popola le storie di Kafka afferma Walter Benjamin:
È più facile trarre conseguenze speculative dalla raccolta postuma delle note kafkiane che penetrare
anche uno solo dei motivi che affiorano nelle sue storie e nei suoi romanzi. Ma solo essi possono
dare qualche lume sulle forze preistoriche da cui è stata impegnata l’attività di Kafka; e che pure si
possono considerare, allo stesso titolo, come potenze storiche dei nostri giorni. Chi dirà sotto qual
nome sono apparse a Kafka? Certo è solo che egli non ha saputo raccapezzarvisi; che non le ha
conosciute; che ha solo visto apparire, nello specchio che la preistoria gli presentava nella forma
della colpa, l’avvenire nella forma del giudizio170.
Le forze preistoriche non alludono qui soltanto all’eterna esperienza simbolica dell’uomo ma
al senso, radicale, della colpa e del giudizio. Una colpa passata, preistorica, appunto, e un giudizio
che pare circoscrivere tutta la storia umana nell’avvenire. La preistoria, che vive nell’esperienza
simbolica, è uno specchio i cui simboli ci interpellano, ci chiamano, ci provocano. La Metamorfosi
può essere letta come un’enorme parabola, gigantesca e grottesca quanto il suo protagonista, il
commesso viaggiatore Gregor Samsa che un mattino, al risveglio da sogni inquieti, si trovò
trasformato in un enorme insetto. Una parabola è appunto un racconto che mi interroga in prima
persona. E lo fa a vari livelli. Nella caratteristica concretezza della tradizione ebraica, a cui Kafka
appartiene, la parabola nasce da situazioni molto reali, della vita di ogni giorno. Ma l’inconsistenza
sul piano di realtà della situazione metamorfizzata del protagonista lo pone immediatamente sul piano
simbolico, preistorico, per dirla con Benjamin. Dunque c’è qui un paradosso, che nasce proprio dal
fatto che la storia è resa plausibile dal tono realistico del racconto. E allora, se la parabola è una storia
che ci riguarda, e lo fa a vari livelli, è proprio qui che possiamo assumere quell’atteggiamento orante
di cui parlavamo nell’introduzione. Ad esempio, potremmo chiederci: che faccio, se una mattina mi
sveglio e sto male? Se molto rapidamente capisco che non guarirò? E all’interno della mia struttura
familiare, che succede? Le famiglie che assistono i malati cambiano, lentamente e inesorabilmente.
Di chi è la metamorfosi? Del malato o della famiglia? O di tutta quanta la struttura?
Questo è un primo livello di riflessione orante, vale a dire di apertura a una domanda.
Ma, se volessimo continuare con la medesima dimensione tornando alle categorie preistoriche
della colpa ed avveniristiche del giudizio, come potremmo non cogliere echi biblici nella vicenda di
questo povero commesso viaggiatore che si fa egli stesso peccato, assumendo l’aspetto di uno degli
insetti più immondi, che non si lamenta mai, che capisce tutto ma non viene capito, che suscita un
orrore tale che si distoglie la faccia da lui?
Non ha apparenza né bellezza
per attirare i nostri sguardi,
non splendore per poterci piacere.
Disprezzato e reietto dagli uomini,
uomo dei dolori che ben conosce il patire,
come uno davanti al quale ci si copre la faccia;
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze,
si è addossato i nostri dolori
e noi lo giudicavamo castigato,
percosso da Dio e umiliato.
169 Ibidem. 170 W. BENJAMIN, Kafka, in Angelus Novus, trad. Renato Solmi, Einaudi, Torino 1962.
La montagna, simbolo di elevazione o di caduta
74
Egli è stato trafitto per i nostri delitti,
schiacciato per le nostre iniquità.
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui;
per le sue piaghe noi siamo stati guariti. (Is 53, 1-5)
Così commenta Gianfranco Ravasi le parole del quarto Carme del Servo del Deutero-Isaia, da
cui è tratta la citazione:
È il carme a cui si richiamano continuamente i racconti della passione di Gesù […] perché gli
evangelisti hanno costruito il loro racconto avendo sempre come pietra di riferimento proprio questo
quarto carme del Servo che vedevano attuato nel Cristo.171
Grottesca, a dire poco, è la situazione in cui viene a trovarsi Gregor Samsa, e tragico è il suo
esito. Ma se, come sappiamo, il Figlio di Dio narra sempre in noi la storia del figlio del falegname
noi possiamo cogliere, in questa povera creatura, la situazione di una vittima vicaria: Samsa assume
su di sé, nella forma dell’enorme insetto, la colpa di un mondo, non la sua colpa. Il narratore ci
informa sulla sua stanchezza estrema, sulla volontà di reggere su di sé il peso del fallimento
dell’impresa paterna, di pagarne i debiti, di far studiare musica alla sorella. Samsa è un mite.
Concludiamo tornando a Benjamin: le categorie del preistorico, dunque dell’archetipico, e
dell’avveniristico, o escatologico, sono i catalizzatori dell’esperienza simbolica della lettura di questo
racconto. Colpa e giudizio restano inesprimibili. Solo una parabola può aiutarci. Non a caso, Kafka
vietò che il protagonista venisse raffigurato nelle illustrazioni.
171 G. RAVASI, Commenti a La Bibbia di Gerusalemme, EDB, Edizione Speciale per il Corriere della Sera, Bologna 2006.
Capitolo sesto
IL FUOCO
A che cosa pensiamo quando evochiamo il fuoco?
Il fuoco, per noi uomini alle soglie del duemila, è l’energia primordiale usata dal big bang che
ha originato miliardi di soli; energia luminosa della materia incandescente, energia oscura e più
misteriosa che mai delle stelle collassate. In forma più vicina e sperimentabile, è folgore che attraversa
il cielo, incendio che devasta le foreste, energia racchiusa nelle viscere della terra che prorompe e
distrugge. Fuoco costretto e divampante di fornaci e altiforni, fuoco nucleare di 100.000 soli; e ancora
è luce tranquilla di una candela, fiamma luminosa e alta di un falò, fuoco che riscalda del focolare
domestico. Fiamma luminosa, che si eleva danzando, libera; fuoco fumante, oscurato dalle scorie e
che pur brucia.
Ciò che prima di tutto e in ogni caso caratterizza il fuoco è la sua attività. Tra i quattro elementi
(acqua, aria, fuoco, terra), 172 da sempre il fuoco è considerato l’elemento motore, che anima,
trasforma, fa evolvere dall’uno all’altro i tre stati della materia (solida, liquida, gassosa). L’essere del
fuoco, come dice Jung, simboleggia l’agente di ogni evoluzione.
Il dio che parla dentro il fuoco
Nella storia religiosa dell’umanità, il fuoco appartiene ai grandi simboli della forza divina, anzi
dell’essere divino. Rimonta alla notte dei tempi la coscienza della sacralità del fuoco espressa nei
diversi miti che riferiscono il dono del fuoco da parte degli dèi o il suo furto da parte di un essere
umano. E non basta che la fisica nucleare ci abbia spiegato il come della fusione nucleare e
dell’energia che ne deriva, perché noi perdiamo il senso dello stupore di fronte a queste energie
incommensurabili e al loro piegarsi ad un ordine che rimane pur sempre misterioso. Anche il fuoco
atomico è, in fondo, un fuoco rubato agli dèi e nessuna conoscenza scientifica ci potrà impedire di
provare il terrore o il fascino del fuoco.
L’immagine del fuoco è un’immagine ierofanica che si ritrova nella maggior parte delle
religioni, molto spesso associata a quella del sole. Come scrive Jung: «Il padre visibile del mondo è
il sole, il fuoco celeste; quindi padre, Dio, sole, fuoco sono mitologicamente sinonimi».173 Da dove
il fuoco trae la sua dimensione sovrumana, mitica, come pure la sua capacità di suscitare fascino e
emozione? «Da dove si slancia la materia per trasferirsi nella categoria del divino?», si domanda
Claudel davanti ad una fiamma.174 «Per saperlo - risponde Leclerc - bisogna ascoltare la voce del dio
che parla dentro il fuoco. Questo dio è essenzialmente un dio vivente; e la vita in quanto forza
creatrice».175
172 Voce: Elementi, in J. CHEVALIER – A. GHEERBRANT, Dizionario dei simboli, BUR, Milano 198612, pp. 407-410.
Proprio «i quattro elementi sono la base di ciò che Bachelard ha chiamato l’immaginazione materiale, quello stupefacente
bisogno di penetrazione che, al di là della seduzione dell’immaginazione delle forme, si mette a pensare la materia, a
sognare la materia, a vivere nella materia oppure - ciò che è lo stesso - a materializzare l’immaginario... La fisiologia
dell’immaginazione, ancor più che la sua anatomia, obbedisce alla legge dei quattro elementi» (p. 408). 173 C.G. JUNG, La libido; simboli e trasformazioni; citato in Leclerc, 140. 174 Citato da BACHELARD, La Flamme d’une chandelle, Parigi 1964, in Leclerc, p. 141. 175 Leclerc, p. 141.
Il fuoco, mistero di ignificazione
76
Il fuoco e l’uomo. - Come si passa dal grande simbolo proteiforme - che assume cioè molteplici forme
diverse - del fuoco a raffigurazioni su misura umana? Per rispondere bisogna ricordare un principio
fondamentale: vi è una corrispondenza, una sintonia di fondo tra la natura e l’uomo, coscienza
incarnata, e sono sempre le esperienze vitali primarie - fame, sete, riposo - o i grandi simboli cosmici
a offrirgli il materiale espressivo quando egli vuol dire qualcosa di se stesso.176
L’uso linguistico comune attesta che il simbolo del fuoco connota esperienze umane vitali:
parliamo del fuoco divorante dell’ira o della passione, del fuoco tenebroso della rivolta interiore, del
fuoco torbido dell’esaltazione, del fuoco consumante della sofferenza, della fiamma del sacrificio che
purifica e trasforma, del fuoco o meglio della fiamma dell’amore che riscalda, vivifica e innalza...
«Da Eraclito in poi, osserva Jung, la vita è stata sempre raffigurata come un pyr aei zoan, un fuoco
sempre vivo...»;177 il dio che parla dentro il fuoco è una potenza di vita che vuole unirsi, comunicarsi,
propagarsi come la fiamma. Di Eraclito è l’immagine della freccia del fuoco che attraversa senza
posa il vasto mondo. Questo fuoco vivo, “questa energia che vuole fondere insieme tutte le cose”, gli
antichi Greci l’avevano chiamata eros: è la facoltà di amare, la grande forza attiva dell’universo:
«L’uomo che comunica al fuoco, intensamente, cosmicamente, per mezzo dell’immaginazione, ha a
che fare con questa forza affettiva originaria dell’anima, con l’eros. Egli stesso è attraversato nelle
sue profondità da questa “freccia di fuoco che penetra da parte a parte il vasto mondo, senza lasciare
niente in riposo”. È visitato da questa potenza di vita che trascende la sua coscienza, di cui non
dispone, ma che si identifica con il suo desiderio più profondo, il desiderio di vivere in plenitudine
nella comunione con tutto ciò che è».178
Nei momenti più alti della vita interiore dell’uomo può emergere la grande immagine ierofanica
del fuoco. Il famoso memoriale che ci trasmette la scoperta del Dio vivente da parte di Pascal, in una
notte illuminata dal fuoco - e Pascal ha scritto questa parola in lettere maiuscole - un immenso fuoco
teofanico, è più eloquente di tante spiegazioni:
«Lunedi, 23 novembre, giorno di san Clemente papa e martire e di altri nel martirologio.
Vigilia di san Crisogono martire e di altri.
Dalle dieci e mezzo di sera fino a circa mezzanotte e mezzo
FUOCO
“Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe”,
non dei filosofi e dei sapienti.
Certezza. Certezza. Sentimento. Gioia. Pace.
Dio di Gesù Cristo.
Non lo si trova se non tramite le vie insegnate dal Vangelo».179
Il Dio, riconosciuto come vivente, e nel caso del Dio della Rivelazione giudeo-cristiana, come
personale e agente nella storia, suscita nell’uomo l’immagine del fuoco, portandolo lui stesso come
a uno stato di incandescenza (si può vedere la figura di Giacobbe in Chagall). Dal punto di vista
simbolico è significativo il ripetuto riferimento di Pascal ai martiri: il martirio, infatti, è affine
all’olocausto: offerta pura, totale, e senza ripensamenti, in un’elevazione ardente a Dio.
Il fuoco fa vibrare l’uomo interiormente; è iscritto nella sua psiche. Anche qui l’uso linguistico
comune è significativo di per sé: parliamo di desideri ardenti o di desideri che consumano, di desideri
cioè che hanno un’azione simile al fuoco, che spingono a grandi azioni e a grandi imprese o possono
anche distruggere l’unità della persona. È infatti ciò che nell’uomo
«vi è di più primitivo, di più fondamentale e di più irresistibile, cioè il dinamismo del desiderio,
dell’amore e dell’odio, è percepito da lui come un dinamismo che riscalda e brucia al tempo stesso:
176 ‘Cfr. Ch. A. BERNARD, Teologia affettiva, Paoline, Milano 1985 (in part. il cap. IV: La coscienza affettiva) e Teologia
spirituale (in part. il cap. 1: Il campo simbolico). 177 C. G. JUNG, Psicologia e religione, citato in Leclerc, 141. 178 Leclerc, pp. 141-142. 179 B. PASCAL, Pensieri, Manoscritto di Louis Périer, Città Nuova, Roma 2003, pp. 486-487.
Il fuoco, mistero di ignificazione
77
come un fuoco. Il fuoco e così uno dei grandi simboli della libido. Esprime il dinamismo ardente
della vita, in tutte le sue forme, dalla grande azione spirituale fino alla passione più arcaica e
selvaggia».180
Il valore ambivalente del fuoco: vivificante a distruttore. - La forza vitale dell’eros è perennemente
minacciata dalla forza cieca e caotica della passione; ecco perché il fuoco vivo viene immaginato
anche come fuoco divoratore; può distruggere, come pure essere fonte di vita. È quanto sta a
significare l’ambivalenza dell’immagine archetipica del fuoco, al tempo stesso fuoco che cova nella
brace, fiamma che si innalza luminosa, serpente infuocato che avvolge nelle proprie spire e soffoca:
«Non è solo la voce del Dio vivente a far scaturire le fiamme dal fuoco; anche i draghi, il Leviatan o
i cavalli dell’Apocalisse sputano fuoco». 181 Jean Chevalier presenta sinteticamente questa
ambivalenza della figura del fuoco:
«Come il sole con i suoi raggi, il fuoco con le sue fiamme simboleggia l’azione, fecondante,
purificatrice e illuminatrice. Ma presenta anche un aspetto negativo: oscura e soffoca con il suo fumo;
brucia, divora, distrugge: fuoco delle passioni, del castigo, della guerra. [...] Il fuoco fumante e
divorante - al contrario della fiamma illuminante -, simboleggia l’immaginazione esaltata... il
subconscio... la cavità sotterranea... il fuoco infernale... l’intelletto nella sua forma di rivolta: in breve
tutte le forme di regressione psichica.182
Tuttavia, aggiunge subito Chevalier, in quanto brucia e consuma, il fuoco è anche simbolo di
purificazione e di rigenerazione, e ci si trova così davanti all’aspetto positivo della distruzione.
La grande immagine mitica del fuoco con la sua ambivalenza, appare dunque legata al destino
intimo dell’uomo. Il fuoco vivo primordiale esiste per sé: l’uomo non lo ha acceso né può spegnerlo;
dipende però da lui esserne bruciato o illuminato, distrutto o vivificato; in altre parole, dipende da lui
se diventa rogo o luce, inferno o cielo. Comprendiamo meglio allora perché in molte religioni
extrabibliche, come in particolare nell’Antico Egitto e nel Tibet, il fuoco appare legato anche al regno
della morte e alla fine del mondo: i morti devono attraversare prove del fuoco, le quali devono
attestare o provocare la loro purificazione cultuale. Oppure, ci sono fiumi di fuoco che sbarrano al
defunto la via della salvezza. Così tutte le raffigurazioni apocalittiche della fine dei tempi parlano del
fatto che il mondo rinascerà dal fuoco.
Gli uomini solari: passaggio alla raffigurazione simbolica. - La raffigurazione simbolica del rapporto
intimo tra la psiche umana e il segno cosmico del fuoco è legato alla figura del sole. L’esperienza del
sole è l’esperienza primaria universale: il sole è fuoco trascendente, sorgente di potenza vitale. Come
spiega Jung, il sole esprime l’energia psichica nella sua pienezza; cosi, quando i mistici scendono nel
profondo del loro essere trovano «nel loro cuore» l’immagine del sole.183 Questo sole che appare al
centro dell’anima, designando così al tempo stesso il Sé e Dio esprime simbolicamente la
metamorfosi più elevata dell’anima, «le cui forze affettive primigenie e oscure, quelle del desiderio
e dell’eros, si sono trasfigurate in forze di luce e di dono, partecipando ormai alla mira più alta
dell’anima».184 Come ricorda Bernard:
«secondo l’interpretazione comune, “ogni rappresentazione di un personaggio che si slanci in un
carro di fuoco verso il regno dell’immortalità è il simbolo dell’uomo spirituale che distrugge, cammin
facendo, il proprio corpo fisico a beneficio di un’ascensione estremamente rapida”. Il simbolo del
cavallo, così universale e così ricco, non può che accentuare il senso dell’impetuosità del desiderio
spirituale culminante nell’apoteosi solare».185
180 Leclerc, pp. 138-139. 181 Leclerc, p. 142. 182 Voce: Fuoco, in J. CHEVALIER – A. GHEERBRANT, Dizionario dei simboli, BUR, Milano 198612, pp. 475-479. 183 Cfr. CH. A. BERNARD, Teologia simbolica, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 19842, p. 295. 184 Leclerc, p. 82. 185 CH. A. BERNARD, Teologia simbolica, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 19842, p. 219.
Il fuoco, mistero di ignificazione
78
Riprendendo il pensiero di Mircea Eliade,186 Leclerc rileva che nei popoli antichi vi sono molti
esempi di relazioni di parentela tra la divinità solare e a1cune persone o categorie di persone:
«Queste relazioni filiali o fraterne con il dio sole sono sempre privilegio di alcuni uomini soltanto:
sono riservate a una minoranza di eletti. Tale elezione è operata o attraverso un rituale di iniziazione
o attraverso la sovranità. [...] Non soltanto gli iniziati e i sovrani hanno relazioni immediate di
parentela con il sole, ma molto spesso anche gli eroi e i filosofi. In entrambi i casi, tali relazioni
traducono sempre la coscienza di un’elezione, la coscienza di una vocazione o di un destino
superiore».187
Per esprimere questa parentela con il sole di alcuni esseri umani privilegiati vi è un’immagine
che appartiene al fondo mitico dell’umanità: quella del carro di fuoco e del carro solare. Attributo
della divinità solare stessa, come Apollo, è anche il veicolo che trasporta in cielo eroi188 e sovrani
divinizzati. In linea generale si può dire che l’immagine del carro di fuoco trainato da cavalli e che
porta il sole
«simboleggia una totalità nella quale la natura animale con le sue forze oscure e selvagge si trova
associata all’elemento luminoso e divino, allo spirito e alle sue aspirazioni più alte e, per ciò stesso,
trasfigurata, illuminata. Quest’immagine è uno dei simboli della riconciliazione della vita e dello
spirito, delle nostre origini più oscure e della nostra vocazione divina. Si comprende che essa sia
anche molto spesso quella di un’ascensione al cielo: l’eroe trasformato egli stesso in sole è trasportato
nell’etere sul carro di fuoco».189
Notiamo, però, che questo rapimento in cielo si conclude simbolicamente in una dissoluzione
o un assorbimento nel sole-fuoco.
Il fuoco nella Sacra Scrittura
Il valore ierofanico, manifestativo del sacro, del fuoco non può venir meno nella Bibbia.190
Tuttavia, al fine di evitare l’evocazione di una continuità con l’energia biologica, ovvero affinché non
ci sia alcuna mescolanza possibile con una divinizzazione dell’elemento naturale (fuoco o sole che
sia), nelle teofanie veterotestamentarie il Signore Jahve - come osserva Leon-Dufour - si manifesta
«in forma di fuoco» sempre nel corso di un dialogo interpersonale. Inoltre, a tradurre l’essenza della
divinità il simbolo del fuoco non si trova mai solo, bensì associato a simboli contrari, come il soffio,
l’acqua, il vento, o inserito in un contesto cosmico più ampio, oppure ancora trasformato in luce.191
Così, per Israele, il fuoco diventa segno teofanico puro del Dio vivente.
Diamo qualche esempio: quando il popolo d’Israele è inseguito da Faraone, una colonna di
fuoco gli rischiara la via nella notte, proteggendolo al tempo stesso dall’inseguitore: «di notte una
colonna di fuoco per far loro luce» (Es 13,21), mentre nel deserto, la gloria del Signore appare agli
occhi degli Israeliti «come un fuoco divorante in cima alla montagna» (Es 24,17): una circostanza
che aggiunge al simbolismo cosmico dell’energia attiva del fuoco, quello dell’elevazione, dell’alterità
e della lontananza. Movimento delle ruote e arcobaleno, simboli di onnipresenza e di comunicazione,
sono associati all’uragano e al fuoco nel caso della visione di Ezechiele:
«Io guardavo ed ecco un uragano avanzare dal settentrione, una grande nube e un turbinio di fuoco,
che splendeva tutto intorno. [...] Tra quegli esseri si vedevano come carboni ardenti simili a torce
che si muovevano in mezzo a loro. Il fuoco risplendeva e dal fuoco si sprigionavano bagliori. Gli
186 «Il sole e i culti solari» in M. ELIADE, Trattato di storia delle religioni, Bollati Boringhieri, Torino 2008. 187 Leclerc, p. 82 188 Ad esempio Ganimede rapito da Giove. 189 Leclerc, pp. 156-157. 190 Come il sole, il fuoco primordiale è infatti riconosciuto «come la sorgente universale della vita, come il fecondatore e
il generatore universale, insomma come un simbolo paterno. È l’immagine del Padre, l’immagine della potenza e della
generosità creatrici» (Leclerc, p. 78). 191 Voce: Fuoco, in X. LEON-DUFOUR, Dizionario di Teologia Biblica, Marietti, Genova 19765, pp. 433-440.
Il fuoco, mistero di ignificazione
79
esseri andavano e venivano come un baleno. [...] Quando quegli esseri viventi si muovevano, anche
le ruote si muovevano accanto a loro» (Ez 1, 4-19 passim).
Ma nella teofania a Elia, il fuoco, in quanto considerato soggetto alla dismisura, viene
addirittura negato come simbolo della presenza di Dio, e al suo posto c’è quello della brezza leggera
(1Re 19,12), a significare una presenza divina commisurata alla condizione dell’uomo.
Un vento impetuoso, che segnala l’eccezionale potenza dell’intervento divino, precede
l’apparire delle lingue di fuoco nella Pentecoste: il vento è infatti nella simbolica generale immagine
dell’essere assolutamente spirituale di Dio, annuncio di rivolgimenti profondi e di grande energie
spirituali all’opera:192 «Fai dei venti i tuoi messaggeri, delle fiamme guizzanti i tuoi ministri» (Sal
104,4).
Una volta distaccato da qualsiasi riferimento a una continuità con l’energia biologica, il fuoco
appare realmente come il simbolo per eccellenza della sfera spirituale. È caratteristico della tradizione
siriaca l’insistenza sull’elemento fuoco, come simbolo dello Spirito vivificante e trasformante. Come
osserva Bernard, sulla profonda consonanza tra il simbolo del fuoco e l’ordine spirituale nessuno ha
riunito un così gran numero di elementi, e in modo cosi preciso, come Dionigi Areopagita.193 Ecco
infatti come giustifica il fatto che la teologia pone «le allegorie tratte dal fuoco al di sopra di tutte le
altre»:
«Il fuoco sensibile è per così dire, presente ovunque; illumina tutto senza mescolarsi a nulla e pur
rimanendo totalmente separato, brilla di uno splendore totale e rimane al tempo stesso segreto, poiché
in sé resta sconosciuto, all’infuori di una materia che ne rivela l’operazione propria. Non si può né
sostenerne lo splendore né contemplarlo faccia a faccia, ma il suo potere si estende ovunque e, là
dove nasce, attrae tutto a sé, facendo dominare il suo atto proprio. Attraverso questa trasmutazione,
il fuoco fa dono di sé a chiunque lo avvicini sia pure un poco: rigenera gli esseri con il suo calore
vivificante, li rischiara con le sue illuminazioni splendenti, ma in sé rimane puro e senza mescolanza
[...]. Vive sulle alture, sfugge ad ogni attrazione terrestre, si muove incessantemente, muove sé stesso
e muove gli altri. Il suo dominio si estende ovunque, ma esso non si lascia rinchiudere in nessun
posto».194
Un fuoco che purifica l’uomo di terra. - Questa duplice caratteristica del fuoco: manifestazione
simbolica dell’intervento attivo creatore e ricreatore del Dio vivente e al tempo stesso della sua totale
alterità, radicata nella sua purezza e santità assolute, connota tutte le teofanie veterotestamentarie.
Ecco perché il segno del fuoco ha sempre una duplice portata: dalla parte di Dio, è manifestazione
del suo essere vivente e santo; dalla parte dell’uomo, si traduce in un’esigenza di purificazione. Dio,
infatti, non si rivela per distruggere l’uomo con lo splendore terribile del suo volto, ma rende puri e
invita a purificarsi quelli che chiama. Cosi, Mose davanti al roveto ardente:
«Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo: perché il roveto non brucia? ... E Dio lo
chiamò dal roveto e disse: Mosè! Mosè! Rispose: Eccomi! Riprese: Non avvicinarti! Togliti i sandali
dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa! E disse: Io sono il Dio di tuo padre, il
Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si velò il viso, perché aveva paura
di guardare verso Dio» (Es 3, 3-6).
Cosi Isaia che pensa di morire per essersi accostato alla santità divina e le cui labbra vengono
purificate da un carbone di fuoco:
«E dissi: “Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo a un
popolo dalle labbra impure io abito; eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti”.
Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le
molle dall’altare. Egli mi toccò la bocca e disse: “Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è
scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato”» (Is 6, 5-7).
192 Voce: Vento, in J. CHEVALIER – A. GHEERBRANT, Dizionario dei simboli, BUR, Milano 198612, pp. 1103-1104 193 Cfr. CH. A. BERNARD, Teologia simbolica, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 19842, pp. 171-172. 194 DIONIGI AREOPAGITA, Gerarchia celeste, XV, 2.
Il fuoco, mistero di ignificazione
80
L’affermazione del Deuteronomio: «Poiché il tuo Dio è un fuoco divoratore, un Dio geloso» (Dt
4,24), traspone nel simbolo il tema della gelosia divina: il fuoco viene a simboleggiare l’intransigenza
di Dio dinanzi al peccato. O, detto altrimenti, il Dio vivente non può non trasformare quelli ai quali
si avvicina. Anche l’ira ardente di Dio (Ger 4, 4) - «La mia parola non è forse come il fuoco e come
un martello che spacca la roccia?» (Ger 23, 29); «Un fuoco si è acceso nella mia collera e brucerà»
(Dt 32, 22) - non ha come ultimo scopo la distruzione, ma la purificazione: «Chi resisterà al suo
apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare»
(Ml 3, 2-3).
Ecco allora che, mentre sperimenta la sofferenza fisica o morale, l’umiliazione, la persecuzione,
l’esilio come il fuoco che consuma o come le grandi acque che sommergono, il Popolo d’Israele
scopre anche che questo crogiuolo della sofferenza purifica e trasforma gli eletti. Dio, dal canto suo,
può salvare i suoi figli anche dal fuoco. Dice Daniele al re: «Sappi però che il nostro Dio, che noi
serviamo, può liberarci dalla fornace con il fuoco acceso» (Dn 3, 17).
Il fuoco trasforma perché ci rende simili a Dio: questa è la purificazione, una divinizzazione o
autentica umanizzazione. È l’immagine della fenice, l’uccello mitico che rinasce dalle ceneri della
propria combustione, per spiccare il volo verso l’alto.
Il fuoco e le scorie. - Tuttavia la Scrittura parla anche di un fuoco del giudizio che distrugge in modo
irreversibile. In che senso va inteso questa fuoco di discernimento? Esso diviene distruttore, nella
misura in cui non può più purificare. Come spiega Leon-Dufour:
«Il fuoco del giudizio diventa castigo senza rimedio, vero fuoco dell’ira, quando cade sul peccatore
indurito. Ma allora - tale è la forza del simbolo - questo fuoco che non può più consumare le impurità,
rimesta ancora le scorie. La rivelazione esprime così quel che può essere l’esistenza di una creatura
che rifiuta di essere purificata dal fuoco divino ma ne rimane bruciata».195
Per bocca del profeta Ezechiele Jahvè rimprovera al suo popolo di essere diventato scoria, cioè
materia non più passibile di trasformazione:
«Sono tutti rame, stagno, ferro e piombo dentro un crogiuolo: sono scoria di argento. Perciò così dice
il Signore: Poiché vi siete tutti cambiati in scoria, io vi radunerò dentro Gerusalemme. Come si mette
insieme argento, rame, ferro, piombo, stagno dentro un crogiuolo e si soffia nel fuoco per fonderli,
cosi io, con ira e con sdegno, vi metterò tutti insieme e vi farò fondere. [...] Come si fonde l’argento
nel crogiuolo, cosi sarete fusi in mezzo ad essa: saprete che io, il Signore, ho riversato il mio sdegno
contro di voi» (Ez 22, 18-22).
Il fuoco inestinguibile è dunque quello che brucia per sempre ciò che non può essere consumato;
fuoco che, da questo punto di vista, esclude dalla rigenerazione.196 Dal punto di vista simbolico, è
importante notare sia lo stato di mescolanza che caratterizza le immagini negative del fuoco (le scorie
di metalli diversi; lo stagno di fuoco e zolfo in Ap 20, 10), sia il fatto che il fuoco distruttore cade
sotto forma di materia incandescente: «Il sole divenne nero come sacco di crine, la luna diventò tutta
simile al sangue, le stelle del cielo si abbatterono sopra la
terra» (Ap 6, 12-13). In Ap 8, 2-6, l’angelo getta la brace sulla terra (cfr. Lc 10,18: «Io vedevo Satana
cadere dal cielo come la folgore»). Quando invece manifesta l’elemento luminoso ed elevato, come
avviene quando il Signore accetta il sacrificio offertogli dall’uomo, questo fuoco misterioso è sempre
una fiamma pura. Ricordiamo il sacrificio di alleanza con Abramo: «Quando, tramontato il sole, si
era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali
divisi. In quel giorno il Signore concluse quest’alleanza con Abram: “Alla tua discendenza io do
questa terra, dal fiume d’Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate; la terra dove abitano i Keniti, i
Kenizziti, i Kadmoniti, gli Ittiti, i Perizziti, i Refaìm, 1gli Amorrei, i Cananei, i Gergesei e i Gebusei”»
(Gen 15,17-19).
195 Voce: Fuoco, in X. LEON-DUFOUR, Dizionario di Teologia Biblica, Marietti, Genova 19765, pp. 433-440. 196 Voce: Fuoco, in J. CHEVALIER – A. GHEERBRANT, Dizionario dei simboli, BUR, Milano 198612, pp. 475-479.
Il fuoco, mistero di ignificazione
81
Così, a suggerire il senso dell’atteggiamento di Abramo pronto a sacrificare il proprio figlio,
l’unico, Chagall lo raffigura tutto quanto avvolto come in una fiamma.
Il baldacchino di fuoco. - La prova del fuoco opera un discernimento: può avviare verso la luce o
verso le tenebre terrestri. Mentre il fuoco interiore, che rimesta le scorie di coloro i quali non hanno
accettato di essere purificati non si spegnerà (Is 66, 24), gli scampati al fuoco saranno circondati come
da un bastione di luce gloriosa, dal muro di fuoco che Jahvè stesso sarà per loro:
«Chi sarà rimasto in Sion e chi sarà superstite in Gerusalemme sarà chiamato santo, cioè quanti
saranno iscritti per restare in vita in Gerusalemme. Quando il Signore avrà lavato le brutture delle
figlie di Sion e avrà pulito l’interno di Gerusalemme [...] allora verrà il Signore su ogni punto del
monte Sion [...] come una nube e come fumo di giorno, come bagliore di fuoco e fiamma di notte,
perché sopra ogni cosa la gloria del Signore sarà come un baldacchino» (Is 4, 3-5).
Straordinaria immagine finale che significa simbolicamente che Dio sarà tutto in tutti!
La partecipazione alla natura divina. - Gli uomini di Dio sono uomini di fuoco: annunciano la Parola
trasformatrice. Ricordiamo Geremia: «Mi dicevo: non penserò più a lui, non parlerò più in suo nome.
Ma nel mio cuore c’era come un fuoco divorante, chiuso nelle mie ossa; mi sforzavo di contenerlo,
ma non potevo» (Ger 20, 9). Egli stesso diventa il crogiuolo incaricato di provare il popolo: «Io ti ho
posto come saggiatore fra il mio popolo, perché tu conoscessi e saggiassi la loro condotta» (Ger 6,
27).197 Elia, dal canto suo è «simile al fuoco» e «la sua parola bruciava come una fiaccola» (Sir 48,
1); è l’uomo del sacrificio sul monte Carmelo, che fa «scendere il fuoco» (Sir 48, 3) sull’altare:
«Cadde il fuoco del Signore e consuma l’olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando
l’acqua del canaletto» (1Re 18, 38).
Questi uomini ardenti di zelo per il Signore sono trasportati verso la Sorgente viva e santa: si
tratta in ogni caso di un processo interiore di trasformazione, ma esso può assumere anche l’aspetto
di un evento violento e visibile, come nel caso di Elia. Leggiamo nel secondo libro dei Re: «Poi,
volendo Dio rapire in cielo in un turbine Elia, questi partì da Galgala con Eliseo. [...] Mentre
camminavano conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero tra loro due. Elia
salì nel turbine verso il cielo» (2Re 2, 1-11 passim).
Si riaffaccia l’immagine del carro solare. E questa non è che uno degli innumerevoli esempi
della universalità del linguaggio simbolico. Per esprimere la vittoria dell’elemento spirituale e la
riconciliazione della vita come energia ardente con lo spirito, e cioè la nostra vocazione divina, anche
l’uomo biblico fa ricorso al grande segno cosmico del carro solare che ascende, energia primigenia,
luminosa e vitale, diretta verso l’alto. Tuttavia, mentre nelle apoteosi gli eroi solari scompaiono nel
sole, l’uomo di Dio usa il carro di fuoco solo come un veicolo. Proprio tenendo presente questo
significato del carro, si intende l’importanza dell’episodio del Rapimento di Elia sin dai primi secoli
cristiani: tale evento era infatti da una parte figura della Risurrezione-Ascensione di Cristo Signore198
e dall’altra figura del Battesimo, esso stesso veicolo verso il Cielo. In linea generale, nel quadro della
Rivelazione giudeo-cristiana, il tema dell’ascensione sul carro di fuoco guidato da cavalli alati viene
a simboleggiare l’impetuosità del desiderio spirituale dell’uomo di Dio che si traduce in un processo
di trasformazione-ascensione, forte e rapido al tempo stesso.
L’olocausto. - L’olocausto è la risposta simbolica di un dono totalmente puro e irreversibile. Nella
sfera cristiana non si tratta più di un fuoco cultuale, ma di quello che consuma la vita stessa in un
culto accetto a Dio. Tra questi due fuochi c’è il sacrificio della Croce. È veramente notevole la
sequenza che si incontra nel capitolo 12 della Lettera agli Ebrei: prima viene richiamato il fuoco delle
teofanie veterotestamentarie ma per affermare che tutti gli aspetti sensibili delle teofanie sono superati
197 Così, nell’ultimo giorno, i capi del popolo saranno come fiaccole accese nella stoppia (Zc 12,6), per esercitare loro
stessi il giudizio divino. 198 Come si vede in alcune catacombe e nel Mausoleo degli Julii della necropoli vaticana. Per un’ampia trattazione di
questa tema, vedi «Il carro di Elia» in J. DANIELOU, I simboli cristiani primitivi, Arkeios, Roma 1990.
Il fuoco, mistero di ignificazione
82
ora che c’è il Mediatore della Nuova Alleanza; e poi, alla fine, riemerge l’antica figura del fuoco,
legata non alle teofanie ma al mistero stesso di Dio che non può cambiare, e rimane «fuoco
divorante»:
«Voi infatti non vi siete accostati a un luogo tangibile e a un fuoco ardente, né a oscurità, tenebra e
tempesta. Voi vi siete accostati al Mediatore della Nuova Alleanza e al sangue dell’aspersione dalla
voce più eloquente di quello di Abele. Perciò, poiché noi riceviamo in eredità un regno incrollabile,
conserviamo questa grazia e per suo mezzo rendiamo un culto gradito a Dio, con riverenza e timore;
perché il nostro Dio è un fuoco divoratore» (Eb 12,18. 29).
Finite le teofanie tremende nel fuoco e i sacrifici cruenti dell’Antica Alleanza, riecheggia di
nuovo l’affermazione dell’Antico Testamento: «Il nostro Dio è un fuoco divorante», poiché rimane
immutato il fatto che nulla di terrestre può accostarsi a Dio, senza essere totalmente ignificato da Lui.
E la domanda è: come può l’uomo di terra partecipare alla vita del Dio vivente «fuoco che divora»,
se non gli viene dato di avvicinarsi a Lui senza morirne?
Il mistero cristico del fuoco
«Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione»
(Lc 22,14). La meditazione della Chiesa ci fa penetrare allora nel segreto più intimo del fuoco che il
Verbo di Dio è venuto a portare sulla terra. Due immagini dell’Antico Testamento ci indicheranno la
via: la prima, ben nota, è quella che ci mostra la purificazione di Isaia mediante un carbone ardente
che un cherubino depone sulle sue labbra dopo averlo preso con le molle dall’altare (Is 6, 6); la
seconda si trova in Ezechiele e avviene nell’ambito di una visione apocalittica:
«Appena ebbe dato all’uomo vestito di lino l’ordine di prendere il fuoco fra le ruote in mezzo ai
cherubini, egli avanzò e si fermò vicino alla ruota. Il cherubino tese la mano per prendere il fuoco
che era fra i cherubini; ne prese e lo mise nel cavo delle mani dell’uomo vestito di lino, il quale lo
prese e uscì» (Ez 10, 6-7).
Nel pensiero di sant’Efrem e in tutta la tradizione siriaca, questa immagine del fuoco nel cavo
delle mani si lega al grande mistero dell’Eucaristia: a costituire questa sacramento è infatti
eminentemente l’unione di un elemento materiale - il pane e il vino - con un elemento spirituale:
«Nel tuo pane è nascosto lo Spirito che non si mangia,
e nel tuo vino risiede il fuoco che non si beve.
Lo Spirito nel tuo pane, il fuoco nel tuo vino:
meraviglia somma che le nostre labbra hanno ricevuto.
Il Signore è disceso sulla terra presso i mortali,
li creò in una creazione nuova come quella degli angeli,
poiché mescolò in essi fuoco e Spirito,
affinché diventassero interiormente fuoco e Spirito.
Il serafino non ha toccato la brace con le dita:
solo la bocca di Isaia l’ha sfiorata
- senza che il primo la tocchi, né il secondo la mangi -
poiché a noi il Signore riservava queste due cose».199
Mistero dell’Eucaristia e mistero dell’Incarnazione sono inseparabili: nel Signore Gesù il
lievito-fuoco della Divinità si è unito alla pasta dell’umanità, perché noi potessimo avvicinarci al
Fuoco ed essere ignificati senza morirne.
199 EFREM IL SIRO, Inni sulla fede X.
Il fuoco, mistero di ignificazione
83
Il Fuoco divampato nella Cena risuona nella grande tovaglia rossa che in una miniatura armena
copre il piano della mensa, riverberandosi sulla pietra chiara dell’abside di una chiesa che chiude la
scena sulla sinistra.
Ma diversi secoli prima, in un evangeliario siriaco, il rosso fuoco del vino nell’ampia coppa
che il Cristo porge agli apostoli calamita su di sé tutta l’attenzione.
Lo stesso colore infiammato può appartenere ai calici; due in particolare si impongono: un
calice di sardonica che sembra ardere di una luce interna e un calice in legno, confezionato in Russia,
interamente dipinto di color rosso fuoco.
Il tema del “mangiare il Fuoco” risuona nella contemplazione di Giovanni di Ruusbroec,
verificando ancora una volta che la distanza nel tempo e nello spazio non significa nulla, per
l’esperienza della vita nello Spirito:
«Egli fa in noi di se stesso il suo pane e quindi brucia dentro al suo amore vizi, falli, peccati. […]
Vuole consumare la nostra vita per cambiarla nella sua, la nostra vita piena di vizi, mentre la sua è
piena di grazie e di gloria e tutta preparata per noi, solo che rinunciamo a noi stessi. […] Quando noi
inghiottiamo l’uno e l’altro [il suo corpo e il suo sangue] con raccoglimento interiore, il sangue di
Gesù, ricco di calore e di gloria, scorre da Dio nelle nostre vene e il fuoco si accende in fondo a noi.
[…] Così la rassomiglianza delle sue virtù sorge in noi ed egli vive in noi e noi viviamo in lui. […]
e questo amore immenso ci brucia, ci consuma, col nostro spirito, e ci attira nell’unità dove ci attende
la beatitudine. […] A questo pensava Gesù Cristo quando diceva ai suoi discepoli: Ho desiderato,
con un immenso desiderio, di mangiare con voi, in questa Pasqua, prima della mia passione».200
“Io non consumo colui che mi mangia, ma chiunque non si avvicina a me”: per un meraviglioso
rovesciamento di situazione, il Fuoco nascosto nel pane chiede di essere mangiato, perché l’uomo
non abbia a morire lontano da Lui.
Appare allora sotto una nuova luce il logion201 del Signore riportato da Origene e dal vangelo
di Tommaso: «Chi è vicino a me, è vicino al fuoco; chi è lontano da me, è lontano dal Regno».202
L’amore più grande da sempre è cantato come fuoco e fiamma: «L’amore è una fiamma di Jahvè, le
grandi acque non possono spegnerlo» (Ct 8, 6); non soltanto le grandi acque della tribolazione e della
morte non possono esaurirlo, ma nemmeno la distanza infinita tra la creatura e il Creatore l’ha potuto
fermare. Il Fuoco divino si è sposato con la pasta della nostra umanità ed è diventato Pane.
La fiamma che purifica e trasforma
Quando Gesù parla del fuoco che è venuto a portare sulla terra e del battesimo che deve ricevere
(Cfr. Lc 12, 49) non si tratta del fuoco del giudizio, ma di quello annunciato da Giovanni Battista:
«Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco» (Lc 3, 16).
Nel tempo cristiano la purificazione avviene all’insegna dell’amore: è una fiamma di fuoco che
purifica e al tempo stesso trasforma. Si presenta così l’immagine ignea della fenice diffusa nella prima
iconografia cristiana. Ad essa ricorre Pavel Florenskij per significare il processo di ignificazione
contenuto nella purificazione: «La fenice intesse il proprio rogo mortale e risuscita rinata nel fuoco,
la carne risuscita nell’infuocata rinuncia di sé, perché questo battesimo di fuoco è soltanto il lato del
rinnovamento spirituale che guarda al peccato».203
200 GIOVANNI DI RUUSBROEC, L’ornamento delle nozze spirituali, A. Mondadori, Milano 1998 201 Nell’ambito della critica biblica, il termine logia (“detti” o “oracoli”, al singolare logion) indica i detti di Gesù. Più in
generale, per logia si intendono brani brevi che non sono presenti altrove e sono generalmente unici. Più in specifico, si
fa riferimento a una ipotetica collezione di detti di Gesù alla quale avrebbe fatto riferimento lo scrittore cristiano del II
secolo Papia di Ierapoli. Molti studiosi identificano questa collezione con la presunta fonte narrativa “Q“, postulata per
spiegare le caratteristiche comuni ai vangeli sinottici (Matteo, Marco, Luca). 202 Citato in Bible Chrétienne II*, p. 240 203 P. FLORENSKIJ, La colonna e il fondamento della verità, Rusconi, Milano 1974.
Il fuoco, mistero di ignificazione
84
Degna di nota la sottolineatura del fatto che l’aspetto purgativo è “soltanto” uno strumento per
raggiungere lo scopo finale della vita cristiana nello Spirito che consiste, come spiega più avanti nel
“vedere la bellezza della creatura”:
«Com’è noto, il fine dell’ascetismo è di raggiungere l’incorruttibilità e la divinizzazione della carne attraverso
l’acquisto dello Spirito. [...] Lo scopo delle fatiche ascetiche è perciò di percepire tutto il creato nella sua
vittoriosa bellezza originaria. Lo Spirito Santo rivela se stesso nella capacità di vedere la bellezza della
creatura».204
L’unità profonda tra questi due aspetti - la capacità di vedere nelle creature la trasparenza della
Bellezza e la trasformazione per ignificazione - si verifica in modo forse unico nella figura di
Francesco d’Assisi:
«Chi potrebbe descrivere degnamente il fervore di carità, che infiammava Francesco, amico dello
sposo? Poiché egli, come un carbone ardente (Cfr. Sal 17, 13-14), pareva tutto divorato dalla fiamma
dell’Amore divino. Al sentir nominare l’Amore del Signore, subito si sentiva stimolato, colpito,
infiammato: quel nome era per lui come un plettro, che gli faceva vibrare l’intimo del cuore.
Contemplava, nelle cose belle, il Bellissimo e, seguendo le orme (Cfr. Gb 23, 11) impresse nelle
creature, inseguiva dovunque il Diletto (Cfr. Ct 5, 16). [...] Con il fervore di una devozione inaudita,
in ciascuna delle creature, come in un ruscello, delibava quella Bontà fontale [...] Cristo Gesù
crocifisso dimorava stabilmente nell’intimo del suo spirito, [...] in Lui bramava trasformarsi
totalmente per eccesso e incendio d’amore».205
Dal punto di vista simbolico bisogna distinguere bene tra la fiamma e il fuoco: la fiamma
luminosa e danzante è come l’anima del fuoco che si slancia verso l’alto. Sempre attiva e libera, è
“simbolo dinamico di illuminazione e di sublimazione” e si incontra spesso nei mistici a significare
gli stati spirituali più elevati. Un esempio forse insuperabile è il poema La fiamma viva d’amore di
san Giovanni della Croce, nel quale la fiamma “è simultaneamente viva, luminosa, ardente”.
Il fuoco, invece, possiede molteplici valenze e può anche essere – come abbiamo visto – un
fuoco distruttore. Gli autori spirituali usano il termine “fuoco” intendendolo nella sua qualità di
“fiamma”, o di “fuoco buono”, che non distrugge, ma nel momento in cui si unisce donandosi a ciò
con cui viene in contatto lo infiamma e lo trasforma in sé. Per questo motivo lo stesso fuoco opera
sia la purificazione che la trasformazione:
«Nel dono di te, noi riposiamo; / lì, di te godiamo; il nostro riposo è il nostro luogo. / L’amore ci
solleva ad esso, e il tuo spirito buono / esalta la nostra bassezza [...] / Un corpo in virtù del suo peso
tende al proprio luogo / Il peso non va necessariamente in basso, ma verso il luogo proprio. / Il mio
peso, è il mio amore; / lui mi porta dove mi porto. / Il dono di te ci infiamma e ci porta in alto; / ci
infiamma e partiamo. / Montiamo le salite che sono nel nostro cuore / e cantiamo il cantico delle
ascensioni (Sal 119, 1). / Il tuo fuoco, il tuo fuoco buono ci infiamma e partiamo, / perché partiamo
in alto verso la pace di Gerusalemme, / poiché ho trovato la mia gioia in coloro che mi hanno detto:
/ partiremo per la casa del Signore (Sal 122, 1) / Là ci porrà la buona volontà / così che non volgiamo
più nient’altro / che dimorarvi eternamente».206
Nel testo di Agostino, si vede che intorno a quella del fuoco sono ordinate una serie di immagini
di elevazione fortemente dinamiche che si succedono l’una all’altra senza sosta: “partiamo in alto”,
“montiamo le salite”, “cantiamo il cantico delle ascensioni”.
Il dinamismo così delineato è al tempo stesso attivo: ben quattro volte risuona il verbo “partire”
che sottintende la figura del distacco, e passivo, in quanto il movimento consiste nell’essere portati:
“mi porta dove che mi porta”, “Il dono di te ci infiamma e ci porta in alto”.
Non si tratta di una salita o di un volo - immagine suggerita dalla fiamma - in un’altezza
indeterminata. Anche in questo senso il testo contiene un’indicazione precisa:
204 P. FLORENSKIJ, La colonna e il fondamento della verità, Rusconi, Milano 1974. 205 Legenda Maior 9,1: 1161-1163. 206 AGOSTINO DI IPPONA, Confessioni, XIII, IX,10.
Il fuoco, mistero di ignificazione
85
quest’ascensione/distacco sempre di nuovo annunciata e dunque continua, irresistibile, possiede
infatti una sorta di ancoraggio segreto espresso all’inizio attraverso la nozione di “luogo proprio” e
verso la fine con il verbo “trovare” che significa la stabilità del permanere.
Tutto il processo di rottura degli ormeggi a terra può avvenire perché chi parla ha già il “suo
luogo” e ha già “trovato la sua gioia”, e perché questa gioia, che coincide con il suo luogo, costituisce
il nuovo ancoraggio in alto, “nell’interno del velo del santuario” (Eb 6, 19-20).
Precisamente in funzione di tale ancoraggio avviene il capovolgimento della legge di gravità
terrestre: così il peso, invece di scendere, può salire come la fiamma.
Naturalmente quest’ascesa infiammata verso la casa del Signore evoca di per sé l’immagine
universale del carro di fuoco trainato da cavalli di fuoco sul quale un uomo sale verso il cielo:
«simbolo universale dell’uomo spirituale che distrugge, strada facendo, il proprio corpo fisico a
beneficio di un’ascensione estremamente rapida».207
Il braciere del Cuore
L’espressione più consueta della devozione al Sacro Cuore nella Chiesa latina - e
dell’iconografia che la accompagna - è un caso emblematico di impoverimento simbolico: rileggendo
la descrizione della visione fatta dalla stessa santa Margherita-Maria Alacoque, si rimane infatti
colpiti dalla sua ricchezza e complessità: «Gesù Cristo, il mio dolce Maestro, si presentò a me, tutto
sfolgorante di gloria con le sue cinque piaghe, splendenti come cinque soli e da quella sacra umanità
si sprigionavano fiamme da ogni parte, ma soprattutto dal suo petto adorabile che somigliava a una
fornace ed essendosi aperto, mi scoprì il suo amantissimo e amabilissimo Cuore che era la sorgente
viva di quelle fiamme».208 In realtà, se si fosse fedeli al testo non si potrebbe arrivare a circoscrivere
un cuore-oggetto, come avviene invece abitualmente; infatti, secondo il rilievo di Bernard, l’elemento
che caratterizza l’umanità sofferente e glorificata di Cristo è il carattere irradiante, la solarità, il
movimento e la centrazione.
Rimanendo fedeli al testo non si potrebbe arrivare a circoscrivere un cuore-oggetto; infatti,
l’elemento che caratterizza l’umanità sofferente e glorificata di Cristo è il carattere irradiante, la
solarità, il movimento e la centrazione.
E se si volesse tradurre la visione in immagine rimanendo fedeli al contenuto in essa espresso
simbolicamente, bisognerebbe piuttosto optare per una immagine informale di fuoco, nella quale vi
fosse un centro e una quadripartizione dello spazio.
La stessa immagine del Cuore di Cristo quale Fornace e Braciere ardente ritorna nel mistico-
poeta Teilhard de Chardin; è interessante notare che, secondo lui, proprio attraverso l’apertura del
costato, il Signore Gesù ha voluto fornire al nostro amore «il mezzo per sfuggire a quanto vi era di
troppo angusto, di troppo preciso, di troppo limitato»209 nell’immagine che ci facciamo di Lui: «Al
centro del tuo petto, non vedo più nient’altro che una fornace»210. Un’immagine che si espande
significativamente in quella del Cristo glorioso, descritto con i caratteristici tratti apocalittici:
«Tu, la cui fronte è di neve, gli occhi di fuoco, i piedi più splendenti dell’oro in fusione; Tu le cui
mani imprigionano le stelle, Tu che sei il primo e l’ultimo, il vivente, il morto e il risorto; Tu che
riunisci nella tua unità esuberante tutti gli incanti, tutti i gusti, tutte le forze, tutti gli stati; eri Tu che
il mio essere chiamava con un desiderio vasto quanto l’universo: Tu sei veramente il mio Signore e
il mio Dio».211
207 Voce: Carro, in J. CHEVALIER – A. GHEERBRANT, Dizionario dei simboli, BUR, Milano 198612, pp. 209-213. 208 Autobiographie, ed. Gauthey n. 55; citato in CH. A. BERNARD, Il Dio dei mistici. 2.La conformazione a Cristo, San
Paolo, Cinisello Balsamo, 2000, p. 365. 209 TEILHARD DE CHARDIN, La Messa sul mondo, Queriniana, Brescia 2006. 210 Ibidem. 211 Ibidem.
Il fuoco, mistero di ignificazione
86
Fiammiferi, pane e manoscritti
Nella Bambina dei fiammiferi di Hans Christian Andersen è il fiammifero, il portatore di
fiamma, che accende l’elemento fiabesco.
L’esperienza dell’infinitamente piccolo, l’esperienza evangelica del grano di senape, è qui
quella di un minuscolo fuoco, intorno a cui è costruita la perfetta compiutezza della fiaba, articolata
su un modello di equilibrio classicistico, poiché “rispetta” le famose tre unità (di tempo, luogo e
azione). Questa compostezza formale è ciò che impedisce alla vicenda di sciogliersi in un
sentimentalismo generico e la ferma, la gela in un exemplum. Gli elementi fiabeschi vi sono presenti,
ma tutto è mimetizzato, a cominciare dall’eroe, che è colui che porta il fuoco. È intorno al fuoco
infatti che si ordinano non solo l’azione della bambina (accendere i fiammiferi per scaldarsi) ma
l’intera realtà materiale, indicata qui dal muro, che è il freddo, la fame, l’angoscia, nelle parole di
Andersen. Eppure, attraverso lo sfregamento del fiammifero la realtà (che è il cattivo, l’antagonista)
è trasfigurata. L’azione volontaria della bambina provoca, nelle parole dell’autore, “una luce chiara
e calda come una piccola candela se la proteggeva con la mano; era una strana luce”. La materia
opaca, inerte, se accesa, contribuisce alla rivelazione, diventa essa stessa rivelazione: “quella parte
del muro dove la luce cadeva divenne trasparente come un velo”.
L’indicazione temporale dell’incipit è importante, era freddo, ma era anche l’ultima sera
dell’anno, la vigilia di Capodanno. È il tempo della storia umana che si chiude nel tempo di una
piccola vita. Tutta la scala naturae, il mondo ordinato nei regni minerale, vegetale e animale ( ma
qui, in modo significativo, l’ultimo gradino è l’albero, perché l’albero di Natale qui è l’Uomo e il
cosmo) è accesa, per la bambina, in una incandescente trasfigurazione.
Faceva un freddo tremendo; nevicava, e saliva la buia notte; era anche l’ultima sera dell’anno, la
vigilia di Capodanno. In quell’oscurità e con quel freddo, una bambina povera camminava per la
strada, col capo scoperto e i piedi nudi; […] la bambina camminava […] portava una quantità di
fiammiferi, e un mazzetto ne teneva in mano, andando; […] I fiocchi di neve le cadevano sui lunghi
capelli biondi, che s’inanellavano sulla nuca in un modo molto grazioso; ma davvero, lei non pensava
a questa sua leggiadria. Le finestre erano tutte illuminate e per la strada si sentiva un odore squisito
di oca arrosto; infatti era la vigilia dell’anno nuovo, e lei proprio a questo pensava.
[…]
Andò a sedersi in un angolo tra due case, di cui una sporgeva sulla strada più dell’altra; […] a casa
non osava tornare, perché non aveva venduto neppure un fiammifero […] Ah! Un fiammiferino le
avrebbe fatto bene! Bastava che ne tirasse uno fuori dal mazzetto e lo sfregasse contro la parete, per
scaldare le dita. Ne prese uno e: ritsch! Che fiammata fece, e come ardeva! Mandava una luce chiara
e calda come una piccola candela se la proteggeva con la mano; era una strana luce! Alla bimba
sembrò di essere seduta davanti a una grande stufa di ghisa, adorna di pomi d’ottone e con uno
sportelletto anche di ottone; ah! Come riscaldava la dolce fiamma del fuoco! […] Ne prese un
secondo, che arse e rischiarò; quella parte del muro dove la luce cadeva, divenne trasparente come
un velo; essa guardò nella stanza, dove c’era una tavola apparecchiata con una tovaglia candida e
porcellane fini, e un’oca arrosto, farcita di prugne e mele, fumava deliziosamente! Ma ecco, cosa più
straordinaria ancora, l’oca salta dal piatto e ruzzola sul pavimento con coltello e forchetta conficcati
nel dorso e si mette a camminare fino alla povera bambina; ma in quel momento il fiammifero si
spense, e davanti ai suoi occhi non rimase che il gran muro freddo.
Ne accese un altro. Allora come per incanto si trovò seduta ai piedi dell’albero di Natale, il più bello
che si possa immaginare; […] innumerevoli candeline splendevano sui rami verdi […] la piccola tese
le manine verso di esse, ma il fiammifero si spense; tutte le candeline salirono in alto, sempre più in
alto, ora erano diventate stelle luminose; una cadde, lasciando un lungo solco nel cielo.
– Adesso c’è uno che muore! – disse la bambina, poiché la vecchia nonna, la sola persona che era
stata buona con lei, ma ora era morta, le aveva detto “Quando cade una stella, un’anima sale a Dio!”
Sfregò contro il muro un altro fiammifero, che rischiarò tutt’intorno, e in quella luce abbagliante
apparve la vecchia nonna; aveva un’aria così dolce, radiosa e buona!
[…]
Nell’alba fredda, all’angolo tra due case, sedeva una bambina con le guance colorite e il sorriso sulle
labbra […] teneva ancora in mano i fiammiferi, di cui un mazzetto era quasi tutto bruciato. – Ha
Il fuoco, mistero di ignificazione
87
cercato di scaldarsi! – diceva la gente; ma nessuno sapeva le belle cose che lei aveva visto, e in
quanto splendore, insieme alla vecchia nonna, lei era entrata nella gioia dell’anno nuovo!212
Predrag Matvejević ha dedicato il suo ultimo libro al pane.
Pane nostro (2009) parla di semi, di nomi, di rotte, di fedi, di guerre, di carestie. Del corpo. È
un testo impossibile da costringere in un genere. La forma di Pane nostro è affine a quella dell’opera
che lo ha reso famoso, Breviario mediterraneo.
Claudio Magris, nella prefazione al Breviario, parla di affascinante genere intermedio fra il
portolano, il lessico e il saggio-romanzo basato su una assoluta fedeltà al reale. Sono considerazioni
che possono valere anche per questo testo.
“Il reale” in questo scrittore parla sempre del rapporto tra l’uomo e il potere. Ma l’autore non
ci offre dissertazioni di taglio antropologico, o storico, o linguistico sul pane, anche se troviamo, in
questo mirabile arazzo, anche questi fili, questi colori. Parlando del pane, l’autore parla di noi, e a
noi. Commentando un’affermazione del Mahatma Gandhi, per il quale in un mondo affamato Dio
non può che apparire nel segno del pane, Matvejević così conclude:
E Cristo così è comparso come Dio e come uomo.
Fu condannato e crocifisso.213
Entriamo, guidati dall’autore, in una simbologia fin dall’inizio legata a quella del fuoco: «È
nato nella cenere, sulla pietra. Il pane è più antico della scrittura e del libro»214 ci viene detto all’inizio
del primo capitolo, “Il pane e il corpo”.
Una simbologia, quella del pane, che rimanda al posto dell’uomo nel cosmo. Poche righe più
avanti così è infatti introdotto il tema del grano:
Resterà un mistero, forse per sempre, dove e quando germogliò la prima spiga di grano. La sua
presenza richiamò lo sguardo dell’uomo e suscitò la sua attenzione. La collocazione dei chicchi – il
loro ordine all’interno della spiga – offriva un modello di armonia, di misura, forse anche di
uguaglianza.215
Queste considerazioni sulla madia sembrano ispirate dalla meditazione su un’icona della
Natività:
[…] la madia in cui si impasta la farina somiglia alla culla dove si ninna il neonato, al letto dove ci
si corica, alla bara dove il corpo dell’uomo viene deposto dopo la morte, alla barca con cui si passa
da una sponda all’altra.216
In Pane nostro un capitolo intero è dedicato al seme: il seme è nel chicco, nel frumento, nel
nome.
Sant’Isidoro di Siviglia con le sue Etimologie ha stimolato la riflessione sull’origine delle parole e
delle cose. Non è riuscito a scoprire da dove derivassero alcuni dei primi nomi del grano e del pane.
[…] Pa-yu – così scrivono gli studiosi questa parola – indica in sanscrito il custode o il protettore. Alla
sua base si trova il verbo pati – che significa appunto proteggere e conservare. Da questa radice
derivano il latino pater, il padre che difende e protegge, e panis, il pane che nutre e preserva. Anche
pastor ha la stessa origine, come pascere (pascolare) […]217
Così procede questa voce narrante, per giustapposizioni che spesso sono salti iperbolici nel
tempo e nello spazio, e che qui è impossibile riprodurre e commentare. L’ultimo capitolo, però, si
chiama “Pretesti. Postfazione”, e presenta una serie di ricordi personali e dolorosi, tutti legati alla
212 H. C. ANDERSEN, Fiabe, trad. it. Marcella Rinaldi, Einaudi, Torino 1954. 213 P. MATVEJEVIĆ, Pane nostro, trad. it Silvio Ferrari, Garzanti, Milano 2010. 214 Ibidem. 215 Ibidem. 216 Ibidem. 217 Ibidem.
Il fuoco, mistero di ignificazione
88
storia europea, di quell’Europa che in un suo lavoro Matvejević ha definito “maledetta”. Ne
trascriviamo uno:
Era in corso la guerra mondiale, la seconda nel secolo alle nostre spalle. Nella mia infanzia ho vissuto
quattro anni di fame […]. Mio padre era stato deportato in un campo di concentramento, con la
semplice motivazione che proveniva da una nazione con la quale il paese in cui vivevamo era in stato
di guerra. Era fuggito da una Russia tormentata dopo la rivoluzione, vent’anni prima che la Germania
tornasse a farle guerra. Chiamato alle armi da una Iugoslavia che si stava sfaldando per la prima
volta, era stato fatto prigioniero come soldato semplice. La maggior parte di quelli che erano stati
deportati con lui non sono sopravvissuti. E lui invece, per miracolo, si è salvato. Quando lo rividi,
feci fatica a riconoscerlo.
Tra la fine del ’42 e l’inizio del ’43 ci fu uno degli inverni più tremendi del secolo. Mio padre si
trovava ai lavori forzati nella Germania del Nord […] tagliavano i boschi per aprire una nuova
ferrovia […]. Un piccolo gruppo di cinque o sei detenuti, vestiti di stracci e con zoccoli di legno,
provati dal gelo e affamati, tornava verso sera nella baracca. […] Uno sconosciuto venne loro
incontro sullo stretto sentiero e li invitò a entrare nella sua casa.
“Entrammo con diffidenza, insieme con la guardia che ci custodiva e ci sorvegliava. Erano i giorni
che precedevano il Natale. La dimora era calda e gradevole.”
Il padrone di casa era un pastore protestante. Seguendo l’indicazione di Abramo nel Genesi, offrì a
questi ospiti sconosciuti ciò che aveva e poteva. Innanzitutto li fece scaldare, lavare, radere. A tavola
ci fu una fetta di pane e un bicchiere di vino per tutti, come si conviene alla festività cristiana, la sera
della Vigilia di Natale. In segno di gratitudine mio padre si sedette al pianoforte ed eseguì una parte
di un’antica liturgia russa, naturalmente così come poteva con le dita irrigidite dalla fatica e dal
freddo. Da quella volta non identificò mai più quelli che lo avevano chiuso nel campo con il popolo
a cui appartenevano. “In ogni campo di frumento ci sono delle malepiante” ripeteva. “Quante ne
abbiamo viste noi in Russia e in Ucraina, nella mia Odessa natia!”218
In Ucraina, a Kiev, è nato uno dei più grandi scrittori del Novecento: Michail Afanas'evič
Bulgakov.
Il Maestro e Margherita (I ed. italiana 1967) è costruito su una struttura doppia, due storie che sono
tra loro in relazione dialogica su un piano metanarrativo: l’oggetto del dialogo, il punto di incrocio
tra queste due storie è Gesù. Il piano che possiamo definire della realtà è la Mosca degli anni Trenta
dello scorso secolo; il romanzo si apre con una vivace discussione circa l’esistenza storica di Gesù,
che viene contestata da un funzionario di un’associazione letteraria moscovita a un giovane poeta,
autore appunto di un’opera che l’associazione gli aveva commissionato: un grande poema
antireligioso, nelle parole del testo. La discussione viene interrotta dall’arrivo di un personaggio,
sedicente professore di magia nera che fa piazza pulita di tutte le argomentazioni del funzionario
contro l’esistenza storica di Gesù:
- Tengano presente che Gesù è esistito.
- Vede, professore, - (…) noi rispettiamo il suo vasto sapere, ma al proposito abbiamo un punto di
vista diverso.
- Non c’è bisogno di alcun punto di vista, - rispose lo strano professore, - è esistito e basta.219
Il “professore” è Satana.
- Ma ci vuole qualche prova … (…)
- E neppure di prove c’è bisogno, rispose il professore, e parlò con voce sommessa. La sua pronuncia
straniera era scomparsa.
È tutto molto semplice: al mattino presto del giorno quattordici del mese primaverile di Nisan,
avvolto in un mantello bianco foderato di rosso, con una strascicata andatura da cavaliere […]220
218 Ibidem. 219 M. BULGAKOV, Il Maestro e Margherita, trad. Vera Dridso, Einaudi, Torino 1988. 220 Ibidem.
Il fuoco, mistero di ignificazione
89
Il professore ci introduce nella seconda storia, che è quella del processo a Gesù. Questa vicenda
è racchiusa nelle pagine di un romanzo su Pilato, scritto dal Maestro. I capitoli del romanzo su Pilato,
dunque, si intrecciano a quelli ambientati a Mosca. Satana e il suo seguito (Korov’ev, Behemoth,
Azazello), si prenderanno gioco in una rocambolesca serie di avventure di tutto l’apparat letterario
moscovita, che ha condannato all’isolamento e alla follia il Maestro, autore di questo romanzo che
viene definito sfortunato. La storia della composizione del romanzo sul Pilato è anche quella
dell’amore che unisce il Maestro a Margherita. Anche questo amore è sfortunato: si tratta di una
relazione segreta, destinata a essere travolta dagli eventi che si accompagnano al tentativo di
pubblicazione del romanzo su Pilato.
È impossibile in questa sede riassumere il complesso intreccio che lega i due piani narrativi,
quello moscovita e quello del romanzo su Pilato. Ma a noi qui interessa notare che quanto è sfortunato
per il mondo trova invece la propria casa, la propria vera patria, sul piano metafisico, che qui è il
piano metaletterario, il piano cioè della riflessione sulla letteratura. E proprio su questo piano si attiva
la dimensione orante: ciò che emerge progressivamente dall’intreccio è che la riflessione, o il
discernimento, sul valore della letteratura è cruciale, poiché in essa abita la Verità. Il romanzo su
Pilato, infatti, è stato letto, come Satana afferma, da Gesù.
Il Maestro aveva gettato nel fuoco in un accesso di disperazione il manoscritto del suo romanzo
su Pilato e Margherita era riuscita a salvarne un solo quaderno. Ma non importa, perché, nella
celeberrima frase di Woland (Satana), i manoscritti non bruciano.
- Dica un po’, perché Margherita la chiama Maestro? – domandò Woland.
L’altro sogghignò e disse:
- È una debolezza imperdonabile. Essa ha un concetto troppo alto del romanzo che ho scritto. Un
romanzo su che cosa?
- Un romanzo su Ponzio Pilato.
A questo punto le fiammelle delle candele ripresero a ondeggiare e a guizzare, i piatti tintinnarono
sulla tavola. Woland scoppiò in una risata tonante, (…).
- Su che cosa, su che cosa? Su chi? – disse Woland, e smise di ridere. – Questa è grossa. E non poteva
trovare un altro argomento? Faccia un po’ vedere -. E Woland tese la mano con la palma all’insù.
- Io, purtroppo, non posso farlo, - rispose il Maestro, - perché l’ho bruciato nella stufa.
- Scusi, non ci credo, - replicò Woland, non può essere, i manoscritti non bruciano -. Si voltò verso
Behemoth [uno dei diavoli del seguito, che assume la forma di un gigantesco gatto] e disse – Su,
Behemoth, dammi qua il romanzo.
Il gatto, all’istante, saltò giù dalla seggiola e tutti videro che era seduto su un grosso pacco di
manoscritti. Con un inchino, il gatto porse a Woland l’esemplare che stava sopra gli altri.221
La Verità, dunque, si svela nel processo di ignificazione del manoscritto. Questo processo
sacralizza la letteratura, poiché in essa è la Verità.
Il fuoco dunque è centrale nel Maestro e Margherita, esso si disperde in fiammelle molteplici,
come è possibile individuare già solo da quest’ultima citazione (le fiammelle delle candele), ed è
anche protagonista, come elemento tradizionalmente legato al diabolico, di alcune tra le pagine più
significative del romanzo. Woland e il suo seguito bruceranno tutto, tutti i luoghi della loro avventura
moscovita: è il fuoco della satira, che, letteralmente e letterariamente è il fuoco del giudizio.
Il fuoco è presente in innumerevoli particolari disseminati tra le pagine di questo capolavoro
del Novecento, che Eugenio Montale salutò come l’apparizione di un miracolo: è nel tramonto che
apre e chiude l’avventura moscovita, nei vetri delle finestre che riflettono il sole frantumato; il fuoco
è nella testa martoriata dall’emicrania di Pilato, nelle scintille dei suoi occhi; nella abbacinante luce
del sole di Yerushalaym; nel portasigarette di Woland, enorme, d’oro massiccio, in cui quando viene
aperto scintillò d’un fuoco bianco e azzurro un triangolo di brillanti.
- Allora, il fuoco! – esclamò Azazello. – Il fuoco da cui tutto è cominciato e col quale facciamo
terminare tutto!222
221 Ibidem. 222 Ibidem.
Capitolo settimo
L’ACQUA
«Potremmo dire, con formula sommaria, che le acque simboleggiano la totalità delle virtualità sono
fons e origo, la matrice di tutte le possibilità di esistenza. “Acqua, tu sei la fonte di tutte le cose e di
ogni esistenza!” dice un testo indiano, sintetizzando la lunga tradizione vedica. Principio
dell’indifferenziato e del virtuale, fondamento di ogni manifestazione cosmica, ricettacolo di tutti i
germi, le acque simboleggiano la sostanza primordiale da cui nascono tutte le forme, e alle quali
tornano, per regressione o cataclisma. Le acque furono al principio e tornano alla fine di ogni ciclo
storico o cosmico; esisteranno sempre, però mai sole, perché le acque sono sempre germinative, e
racchiudono nella loro unità indivisa le virtualità di tutte le forme. Nella cosmogonia, nel mito, nel
rituale, nell’iconografia, le Acque svolgono la stessa funzione, quale che sia la struttura dei complessi
culturali entro cui si trovano: precedono ogni forma e sostengono ogni creazione. L’immersione
nell’acqua simboleggia la regressione nel preformale, la rigenerazione totale, la nuova nascita,
perché l’immersione equivale a una dissoluzione delle forme, a una reintegrazione nel modo
indifferenziato della preesistenza. E l’uscita dalle acque ripete il gesto cosmogonico della
manifestazione formale. Il contatto con l’acqua implica sempre rigenerazione; da una parte, perché
la dissoluzione è seguita da una «nuova nascita», e d’altra parte, perché l’immersione fertilizza e
aumenta il potenziale di vita e di creazione».223
Questa densa citazione di Eliade ci introduce nel cuore della simbolica dell’acqua, mettendo in
risalto sinteticamente i grandi temi legati a questo elemento naturale primordiale: quello della vita
con le sue infinite potenzialità e quello della purificazione/rigenerazione.
L’acqua della vita nella Scrittura
Ci sono tante qualità di acque diverse: acque tranquille, trasparenti, acque glauche, immobili,
acque torrenziali che travolgono tutto, acque profonde come abissi che ricoprono intere città
sommerse. Ma l’acqua è innanzitutto l’acqua pura della sorgente, acqua viva e che dà la vita.
È impossibile sopravvalutare l’impatto dell’esperienza dell’acqua dissetante che salva dalla
morte. L’uomo biblico ne conosce la precarietà o addirittura l’assenza. Immaginiamo che cosa abbia
rappresento per gli Ebrei in balia della sete e della sterilità del deserto l’acqua pura della sorgente. La
scoperta dei pozzi è fonte di continua meraviglia, perché ai pozzi, letteralmente, gli Israeliti attingono
la vita per sé e per il bestiame.
Dall’acqua materiale che fa rifiorire il deserto, si passa immediatamente a un’altra acqua, questa
spirituale, che fa vivere e disseta il cuore dell’uomo:
«Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio. L’anima mia ha sete di
Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto di Dio?» (Sal 42, 2-3).
Anche Isaia, quando vuole descrivere la salvezza di Jahvè, accosta i due piani, della vita corporale e
della vita spirituale:
«Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno
acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il luogo
riarso si muterà in sorgenti d’acqua» (Is 35, 6-7).
223 M. ELIADE, Trattato di storia delle religioni, Bollati Boringhieri, Torino 2008.
L’acqua, germinatrice di vita
91
Chi cerca il Signore trova in lui la sapienza come un’acqua pura e feconda. La letteratura
sapienziale mette spesso in risalto il nesso che collega la Sapienza creatrice - che all’inizio separò le
acque inferiori (dei mari e dei fiumi) dalle acque superiori (quelle che si trovano al di là della volta
cristallina del firmamento) - e la Sapienza che abita nei cuori. Così parla la Sapienza riguardo
all’opera di creazione:
«Quando egli fissava i cieli, io ero là; quando tracciava un cerchio sull’abisso; quando condensava
le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell’abisso; quando stabiliva al mare i suoi limiti, sicché le
acque non ne oltrepassassero la spiaggia» (Pr 8, 27-29).
È la stessa Sapienza a fissare la sua dimora nel giusto, diventando sorgente nel suo intimo:
«Come acque profonde sono i consigli nel cuore umano, l’uomo accorto le sa attingere» (Pr 20, 5).
Il senso del simbolo dell’acqua viva che zampilla si applica non all’impeto ma alla perpetuità del
fluire. Altri simboli, come il fuoco o il vento, significano lo Spirito nella sua potenza e capacità di
trasformazione; l’acqua che si diffonde significa la sostanza spirituale stessa.224
A volte nell’iconografia cristiana si incontra l’episodio riferito dai vangeli apocrifi
dell’Annunciazione presso il pozzo: in molti casi al centro della scena c’è anche un albero fiorito.
L’acqua preziosa. - «Laudato si, mi Signore, per sora Acqua, la quale e molto utile et humile, et
pretiosa, et casta»: cosi san Francesco canta l’acqua nel suo Cantico delle Creature.
Leclerc sviluppa il senso simbolico degli attributi, unici, che qualificano questa lode dell’acqua:
«L’acqua “pretiosa” è un’acqua viva. E quest’acqua viva sgorga da profondità inviolate, da una
sorgente nascosta, sacra. Nella visione del profeta Ezechiele, per esempio, il torrente di acqua viva
che al suo passaggio rende tutto fertile e che giunge a bonificare e vivificare le acque dello stesso
Mar Morto ha la sua scaturigine sotto il Tempio ricostruito e sgorga dal lato destro, verso Oriente
(Ez 47,1). Quando Gesù s’intrattiene parlando “dell’acqua viva” con la Samaritana, lo fa sull’orlo
del pozzo profondo; e la Samaritana non manca di fargli notare: “Il pozzo è profondo. Da dove hai
dunque quest’acqua viva?” (Gv 4, 11). L’acqua viva ha sempre una sorgente più profonda del pozzo
più profondo. È una sorgente senza contatto con il mondo esterno, una sorgente intatta, vergine,
sacra».225
La lode francescana dell’acqua non implica nessun verbo di azione; il valore dell’acqua è nel
suo stesso essere; l’acqua è presenza, e gli aggettivi ne fanno il simbolo della presenza femminile
«servizievole, benefica, e al contempo riservata, segreta e pura».
Bernard osserva: «Così è dello Spirito, sorgente di vita, naturalmente imparentato con l’anima,
la parte dell’uomo aperta al Sacro nella semplicità e nella purezza delle profondità inviolate».226
Le acque distruttrici nella Sacra Scrittura
La nozione di tribolazione, di angoscia e di morte è strettamente legata nell’Antico Testamento
all’immagine del mare e degli abissi. Senza propriamente essere lo sheol, il mare che circonda l’orbe
terrestre ne è la via e, l’oceano inferiore, il vestibolo. Questa rappresentazione emerge chiara dalle
parole di Dio a Giobbe: «Sei tu giunto fino alle sorgenti del mare e nelle profondità dell’abisso hai tu
passeggiato? Forse ti furono aperte le porte della Morte e le porte dell’ombra hai tu vedute?» (Gb 38,
16-17).
La cosmografia degli antichi. - Nel Trattato di Topografia cristiana di Cosma Indicopleuste risalente
al VI secolo, la terra viene concepita come un grande disco delimitato dall’orizzonte, sotto il quale e 224 Cfr. CH. A. BERNARD, Teologia simbolica, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 19842, p. 164. 225 E. LECLERC, I simboli dell’unione. Una lettura del Cantico delle Creature di san Francesco d’Assisi, EMP, Padova
20122. 226 CH. A. BERNARD, Teologia simbolica, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 19842, p. 167.
L’acqua, germinatrice di vita
92
al di là del quale si stende un mare infinito, l’oceano primordiale o fiume amaro, fonte inesauribile
dei mari e, in particolare, delle acque che circondano la terra. Dato, poi, che questa massa enorme di
terra e roccia non può galleggiare sulle acque del grande oceano, la si immagina sostenuta da
pilastri.227 Il disco terrestre è coronato, come da una cupola, dalla volta solida del firmamento,
provvista di fori, dai quali scorrono le acque superiori sotto forma di pioggia o tempesta. Il trono di
Dio si trova al di sopra del firmamento, al di sopra delle acque superiori, ovvero in excelsis. Al
firmamento sono fissati gli astri: mentre le stelle si muovono con esso, sole e luna hanno il proprio
corso. Lo sheol o soggiorno dei morti è situato sotto terra, in una misteriosa regione di tenebre. Ma,
dato che anche il mare primordiale si trova sotto la terra, è facile intravvedere l’affinità tra il mare,
gli inferi e l’abisso.
La divisione ternaria cielo-terra-inferi, che emerge da questa rappresentazione cosmografica, è
rintracciabile in tutte le civiltà; tuttavia essa viene abitualmente ridotta al binomio terra-cielo, con il
quale si designa la totalità del cosmo. In questo caso, la terra viene ad opporsi al cielo e ad indicare
tutto il resto, compresi i mari e gli inferi: siamo così di fronte alla caratteristica e onnipresente
opposizione dualistica tra il quaggiù terreno e il lassù celeste! 228
Se il Signore regna sulla totalità dell’universo, il suo dominio sul mare riveste però un aspetto
speciale. La tradizione giudaica, in questo strettamente dipendente dalle cosmogonie babilonesi, lo
presenta come conseguente a un combattimento contro le potenze malefiche verificatosi prima della
creazione. Molte volte gli autori veterotestamentari ci dicono che all’origine del mondo il Signore
trionfò dei mostri mitici Leviatàn e Rahab, di quelle bestie del mare, figure del male e simboli del
caos cui succedette l’ordine della creazione. Dice il Signore a Giobbe, incalzandolo:
«Chi ha chiuso tra due porte il mare [...] quando erompeva uscendo dal seno materno, quando lo
circondavo di nubi per veste e per fasce di caligine folta? Poi gli ho fissato un limite e gli ho messo
un chiavistello a parte» (Gb 38, 8-11); e ancora: «Puoi tu pescare il Leviatàn con l’amo [...]? Metti
su di lui la mano: al solo ricordo della lotta, non ci riproverai» (Gb 40, 25. 32).
Sempre, nella Bibbia, lo scatenarsi delle grandi acque annuncia prove e calamità; le acque che
distruggono e inghiottiscono non possono che contenere una potenza cattiva. Per tale primitiva
associazione delle acque e delle potenze demoniache, si ritiene che ogni azione di Dio su questa
elemento raggiunga quelli che vi abitano. Così deve essere inteso il passaggio del Mar Rosso: sempre
si tratta di un’affermazione della potenza di Jahvè sul mare. Le acque che avrebbero dovuto ingoiare
il popolo ebreo obbediscono e fermano il loro corso: «Tu domini l’orgoglio del mare. Tu plachi il
tumulto dei suoi flutti. Tu hai calpestato Rahab come un vinto, con braccio potente hai disperso i tuoi
nemici» (Sal 88, 10-11). Senza danneggiare Israele, le acque ingoiano i suoi persecutori: carri ed
esercito del Faraone scompaiono ne1 mare. Rahab, che qui ha preso il posto di Leviatàn, indica sia il
mostro mitico, sia lo stesso Egitto. Il passaggio del Mar Rosso costituisce per il Signore una duplice
vittoria: la vittoria sulle acque e la vittoria sull’Egitto, segni entrambi del suo trionfo sui nemici del
suo popolo. In linea generale, mentre le grandi acque sommergono i peccatori, non possono travolgere i
giusti: per loro, infatti, esse si trasformano alla fine in acque di vita.
La concezione delle acque distruttrici, ricettacolo delle potenze del male, vivissima nella
tradizione giudaica, è passata nel patrimonio cristiano: la ritroviamo prima di tutto nell’Apocalisse di
Giovanni. L’abisso è il rifugio delle potenze demoniache: al quinto angelo «fu data la chiave del
pozzo dell’Abisso; egli aprì il pozzo dell’Abisso e salì dal pozzo un fumo come il fumo di una grande
fornace» (Ap 9,1). Lo stesso vale per il mare che ne è l’equivalente simbolico: «E quando poi avranno
227 L’architettura dei templi ha senso solo in quanto riproduzione simbolica delle strutture cosmiche: l’ambiente denso di
oscurità del sotterraneo dei templi, la cripta delle chiese, comunica sia con le grandi acque degli abissi sia con la Terra-
madre. La struttura evocata è sempre quella di un microcosmo e i pilastri delle fondamenta evocano i pilastri che
sostengono il disco terrestre 228 Questo schema, che è poi quello di ogni tempio, risalta chiaramente dalla raffigurazione dell’edificio ecclesiale in cui
sono ambientate le due scene dell’Ascensione e della Pentecoste nel Codice di GIACOMO KOKKINOBAPHOS: Il mistero
della Chiesa, min. biz., Vat. gr. 1162, fol 2v, sec. XII.
L’acqua, germinatrice di vita
93
compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall’Abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e
li ucciderà» (Ap 11,7); «Vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna
dieci diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo» (Ap 13,1).
Da un punto di vista generale l’acqua contiene tutte le promesse di sviluppo, ma anche tutte le
minacce di riassorbimento:
«L’acqua, come tutti i simboli, può essere considerata su due piani rigorosamente opposti, ma in nessun
modo irriducibili, e questa ambivalenza si pone a tutti i livelli. L’acqua è fonte di vita e fonte di morte,
creatrice e distruttrice».229
Verifichiamo così, ancora una volta, l’ambivalenza tipica del simbolo: il mare primordiale è
ambivalente perché ricettacolo di vita e covo di mostri.230
Il simbolismo delle acque, principio di distruzione e di morte, è profondamente radicato nel
subcosciente: «L’immaginazione della disgrazia e della morte trova nella materia dell’acqua una
figura materiale particolarmente potente e naturale».231 Se ne trova un riscontro impressionante nei
testi biblici, dove l’invocazione dell’uomo nella prova si esprime il più delle volte come il grido di
uno che si sente affogare: «Salvami, o Dio, l’acqua mi giunge alla gola. Sono caduto in acque
profonde e l’acqua mi travolge» (Sal 69, 2-3); «Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e
nell’ombra della morte. Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi» (Sal 88, 7-
8). L’apocalisse di Isaia porta un ulteriore elemento, in quanto presenta la nuova creazione della fine
dei tempi come un’ultima, definitiva, vittoria di Dio sul mostro del mare: «In quel giorno il Signore
visiterà, con la sua spada dura, grande, forte, il Leviatàn, l’agile serpente, il Leviatàn, il serpente
tortuoso e ucciderà il mostro che è nel mare» (Is 27, 1).
Vittoria di Cristo sulle acque distruttrici e loro santificazione
Nel Battesimo del Signore, la visione finale di Isaia trova la sua prima realizzazione. Entrando
nelle acque del Giordano, Gesù abbatte il serpente, il mostro del mare, schiaccia la testa del drago;
proprio il suo abbassamento annienta l’orgoglio di Satana. Per un meraviglioso capovolgimento della
situazione, le acque, sino allora rifugio dei draghi, diventano lo strumento del loro supplizio, in quanto
ormai partecipano della santità e della purezza di Cristo che è «il fuoco immateriale»: «In questo
giorno ti sei coperto di un’acqua di fuoco per bruciare il crudele rapace che vi si celava».232 (Canone
della Festa, tropario della VII Ode). E ancora:
«Le acque ti videro, Signore, le acque ti videro e presero paura: poiché i Cherubini non osano fissare
gli sguardi sulla tua gloria, né i Serafini posarvi gli occhi, ma con timore servendoti, gli uni ti portano,
gli altri glorificano la tua potenza. Insieme a loro, o Misericordioso, proclamiamo la tua lode,
dicendo: Dio che ti sei manifestato, abbi pietà di noi. In questa giorno il Creatore del cielo e della
terra si avvicina, nella carne, al Giordano per chiedere il battesimo, lui, l’Immacolato, al fine di
purificare l’universo dall’errore in cui il Nemico lo aveva indotto».233
L’antica e tradizionale presentazione del Battesimo del Signore, che potrebbe a prima vista
disorientarci, esprime invece esattamente una verità di fede: il Battesimo nel Giordano è una vittoria
di Cristo su Satana. Entrando nelle acque, Gesù trionfa già sul Nemico, come trionferà sul Tentatore
nel deserto, e come trionferà alla fine, quando sarà venuta l’Ora, sul Principe delle tenebre. Ma come
è avvenuto che si sia fatto vincere nel suo territorio - le acque oscure, il deserto ululante, l’abisso
informe - colui che ne è il dominatore astuto?
229 Voce: Acqua, in J. CHEVALIER – A. GHEERBRANT, Dizionario dei simboli, BUR, Milano 198612, pp. 4-10. 230 Cfr. CH. A. BERNARD, Teologia simbolica, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 19842. 231 G. BACHELARD, Psicanalisi delle acque. Purificazione, morte e rinascita, Red Edizioni, Cornaredo (MI) 2006. 232 Canone della Festa, tropario della VII Ode. 233 Apostichi di Anatolio della Vigilia della Festa.
L’acqua, germinatrice di vita
94
Solo un modo di precedere essenzialmente alieno da lui poteva trarlo in inganno. Così, la Bestia
che regna sull’Abisso accoglie stupita ma ancora ignara dell’estremo abbassamento del Verbo di Dio
quel Gesù che entra nelle acque del Giordano, ma, dopo averlo ucciso, ingoia Colui che, pur morto
nel corpo, è la Vita immortale, e ne rimane uccisa a sua volta, per sempre.
Solo a uno sguardo superficiale un simile modo di esprimere il mistero della lotta drammatica
tra la Morte e la Vita (Mors et vita duello conflixere mirando) potrà apparire infantile: essa esprime
in realtà una consapevolezza acuta della misura divinamente smisurata alla quale la misericordia
paterna è dovuta ricorrere per vincere l’abissale orgoglio. Si tratta di quella modalità simbolica di
esprimere le verità teologiche che è propria dell’espressione semitica e caratteristica dei primi secoli
cristiani. Essa è particolarmente rappresentata nella tradizione siriaca orientale, strettamente affine
all’espressione semitica. Sant’Efrem ne è l’esponente più importante:
«La divinità si nascose sotto l’umanità e si avvicina alla morte, la quale uccise e a sua volta fu uccisa.
La morte uccise la vita naturale, ma venne uccisa dalla vita soprannaturale. Siccome la morte non
poteva inghiottire il Verbo senza il corpo, né gli inferi accoglierlo senza la carne, egli nacque dalla
Vergine per poter scendere mediante il corpo nel regno dei morti. [...] Avvenne allora che la morte
si avvicinasse a lui per divorarlo con la sua abituale sicurezza e ineluttabilità. Non si accorse, però,
che nel frutto mortale, che mangiava, era nascosta la Vita. Fu questa che causò la fine della
inconsapevole e incauta divoratrice. La morte lo inghiottì senza alcun timore ed egli liberò la vita e
con essa la moltitudine degli uomini».234
Nelle raffigurazioni orientali del Battesimo di Gesù spesso, accanto ai suoi piedi immersi
nell’acqua si vedono le due figure allegoriche del Giordano e del Mar Rosso: il fatto di tenere le
anfore capovolte esprime il terrore sacro dal quale le acque sono state colte quando il Signore e sceso
dentro di esse. Abitualmente infatti queste personificazioni del mare e dei fiumi - moduli iconografici
originari del mondo classico - reggono le loro anfore in posizione eretta a significare la perpetuità del
fluire dell’acqua.235
Conservando il parallelismo simbolico con la discesa nelle acque del Giordano, le immagini
della Discesa agli Inferi rappresentano quasi sempre il Cristo nell’atto di calpestare un mostro o un
uomo incatenato che personifica l’Ade o Satana, ossia le potenze del male, delle tenebre e della
morte.236 Nel Battesimo come nella Discesa si realizza definitivamente la parola del Salmista: «Tu
con potenza hai diviso il mare, hai schiacciato la testa dei draghi sulle acque. Al Leviatàn hai spezzato
la testa, lo hai dato in pasto ai mostri marini» (Sal 74, 13-14).
La riapertura dei cieli. - «Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ecco si aprirono i cieli ed egli
vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui» (Mt 3, 16): immagine cosmica
grandiosa, il tema della riapertura dei Cieli permette di visualizzare il ristabilimento della
comunicazione lungo l’asse cielo-terra-cielo. Nella descrizione di san Gregorio di Nazianzo viene
particolarmente sottolineato questa movimento ascensionale che è quello della Risurrezione. C’è un
rapporto costante tra Battesimo di Cristo e Creazione, peccato-diluvio-Esodo che conferisce
all’evento del Battesimo una portata universale, ricapitolativa:
«[Dopo essere sceso nel Giordano], Gesù risale dall’acqua, facendo risalire con sé il cosmo; vede
aperti quei cieli che Adamo aveva chiusi, per lui e per quelli che sarebbero venuti dopo di lui, come
[il Signore] aveva chiuso il Paradiso con la spada di fuoco. E lo Spirito rende testimonianza alla sua
divinità, accorrendo verso colui che gli è simile, e una voce viene dal cielo, perché da lì viene colui
al quale egli ha reso testimonianza».237
234 S. EFREM, Discorso sul Signore, 3-4. 9. 235 Cfr. M. G. MUZJ, Trasfigurazione. Introduzione alia contemplazione delle icone, Paoline, Milano 1987, pp. 113-117. 236 Nella Discesa agli Inferi, min. biz., Urb. gr. 2, fol 260v, XII sec. si scorge con particolare chiarezza, la figura
dell’Inferno rappresentato come un vecchio steso a terra e incatenato, mani e piedi. 237 S. GREGORIO DI NAZIANZO, Orat. 39, 16; PG 36, 353.
L’acqua, germinatrice di vita
95
La santificazione delle acque. - In parallelo con l’immagine ad andamento verticale disegnata dal
tema dell’apertura dei cieli appare quella della Via-Persona che è il Cristo: il risultato è, ancora una
volta, l’identificarsi simbolico di Cristo con l’asse cosmico. Qui il titolo di Mediatore acquista uno
spessore di realtà.
Con la santificazione delle acque attraverso il duplice movimento di immersione-emersione in
esse di Cristo - prefigurazione del movimento analogo di discesa-ascesa della sua morte-risurrezione
-, l’acqua del Battesimo diventa lo strumento della rigenerazione spirituale. L’immersione nell’acqua
del Battesimo equivale così alla sepoltura del Cristo: «Non sapete che quanti siamo stati battezzati in
Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte?» (Rm 6, 3). Simbolicamente, l’uomo muore nel
momento dell’immersione, per rinascere, purificato, come nuova creatura alla vita nuova, cosi come
Cristo, dopo essersi immerso nella morte, risuscitò dal sepolcro. È l’insegnamento fondamentale
dell’Apostolo:
«Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo
fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una
vita nuova. Se infatti siamo stati completamente uniti a lui con una morte simile alla sua, lo saremo
anche con la sua risurrezione» (Rm 6, 4-5).238
«Gesù nacque e fu battezzato al fine di consacrare l’acqua con la sua sofferenza» afferma
sant’Ignazio di Antiochia. 239 Fermandosi a considerare il mistero dell’incontro delle acque con
l’essere divino, Cirillo di Gerusalemme dice che il Cristo conferisce loro il colore della divinità,
mentre Severo di Antiochia ricorre al paragone delle radici e dei germogli che fanno diventare verdi
le acque per dire che Cristo ha messo in esse, facendone loro dono, tutto ciò che egli possiede per
essenza. Rinverdire significa anche letterariamente ritornare a una nuova giovinezza a una nuova
bellezza.
Acqua e Spirito: acqua e vento. - In questa visione, la valenza distruttrice delle acque è dimenticata
ed emerge invece lo stretto legame tra gli interventi creatori di Dio e l’elemento acqueo: «In principio
Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo
spirito di Dio aleggiava sulle acque» (Gen 1, 1-2). L’acqua fu infatti il primo elemento cosmogonico
abitato dallo Spirito divino che, come scrive Tertulliano, «la preferì a tutti gli altri elementi»240 e non
manca mai il riferimento dei Padri e delle Liturgie a questa che è l’immagine iniziale in assoluto. Il
soffio divino prelude alla creazione, feconda le acque: è il respiro di Dio che diviene il suo bacio di
amore alla sua creatura.
Se, come osserva Bachelard, ogni combinazione immaginaria di elementi materiali è uno
sposalizio, il significato proprio dell’unione del vento e dell’acqua nel linguaggio poetico o religioso
consiste nel raffigurare o nell’annunciare un rinnovamento profondo, una nuova nascita o una
creazione.241 Il vento che soffia sulle acque rappresenta un altro principio, esso pure necessario a
suscitare il nuovo essere. Al principio acquatico femminile deve unirsi quello maschile del vento
potente. Nessuna forza è più potente di quella dello Spirito-Soffio di Dio. Esso già aleggiava sopra le
acque primordiali per fecondarle; per tutti gli esseri lo Spirito è soffio di vita: «Togli loro il respiro,
muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della
terra» (Sal 104, 29-30).
Acqua e vento sono presenti quando si tratta di annunciare una nuova nascita, una nuova
creazione. Così, l’immagine profetica che troviamo in Ezechiele dell’acqua pura e del nuovo soffio
238 Nell’iconografia monumentale, un bellissimo esempio di raffigurazione dei deli aperti è quello di Mistra. Cfr. la
miniatura Il Battesimo, min. biz., Urb. greco 2, fol 109, XII sec. 239 IGNAZIO DI ANTIOCHIA, Ad Eph., 18, 2. 240 TERTULLIANO, De Bapt., 3-4, citato in M. ELIADE, Trattato di storia delle religioni, Bollati Boringhieri, Torino 2008,
p. 203. 241 Cfr. E. LECLERC, I simboli dell’unione. Una lettura del Cantico delle Creature di san Francesco d’Assisi, EMP,
Padova 20122.
L’acqua, germinatrice di vita
96
annunciano la creazione del nuovo popolo di Jahvè. Similmente, l’immagine giovannea dell’acqua e
del vento simboleggia la nuova nascita, la nascita dall’alto. E la liturgia della veglia pasquale,
nell’antichissima preghiera di benedizione dell’acqua, riprende anch’essa l’immagine iniziale del
libro della Genesi (1, 2).242 Dopo aver soffiato sull’acqua, il celebrante dice:
«Fin dalle origini il tuo Spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza di
santificare. [...] Ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa’ scaturire per lei la sorgente del
Battesimo. Infondi in quest’acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio [...]
Discenda, Padre, in quest’acqua la potenza dello Spirito Santo, perché tutti coloro che in essa
riceveranno il Battesimo, sepolti insieme con Cristo nella morte con lui risorgano alla vita
immortale».
Il mistero del Fiume dall’alto. - Con la santificazione delle acque e la riapertura dei cieli, il Giordano
si manifesta infatti per quello che è realmente: il Fiume dall’alto.
Questo fiume dall’alto, presente nella tradizione giudaica, è quello della grazia celeste, che
scorre verticalmente lungo l’asse del mondo e poi si irradia nelle quattro direzioni a partire dal
centro.243 All’inizio, il fiume di vita è infatti uno: «Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino
e formava quattro corsi» (Gen 2, 10). Ora invece che è giunta la pienezza dei tempi, come scrive san
Gregorio Nisseno, commentando il salmo battesimale e pasquale del “Buon Pastore”: «Il fiume di
grazia scorre dappertutto e non ha più la sua sorgente in Palestina per gettarsi nel mare più vicino, ma
abbraccia 1’intera oikumene e sfocia in Paradiso».244 Con la logica propria del linguaggio simbolico,
il fiume che convoglia l’acqua della benevolenza divina, vivificando spiritualmente l’intera terra
abitata, non solo ha la sua sorgente in Paradiso, ma va anche a sfociare in esso.
L’Apocalisse di Giovanni visualizza la scaturigine del Fiume dal trono di Dio:
«Mi mostrò poi un fiume d’acqua viva limpida come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e
dell’Agnello. In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall’altra del fiume si trova un albero
di vita» (Ap 22, 1).
In una nuova, grandiosa, visione sintetica vediamo allora fondersi con l’immagine del Fiume
dall’alto che è «in principio», quella del Giordano storico, nel quale si è immerso il Salvatore, quella
del Giordano sacramentale, nuovo fiume di vita che abbraccia il mondo intero. E, alla fine dei tempi,
quella del fiume della Gerusalemme celeste che scaturisce dal trono di Dio e dell’Agnello.
L’acqua viva che scaturisce dal lato destro: la Transfissione. - Tuttavia, per comprendere sino in
fondo il mistero del Fiume dall’alto, bisogna aver ugualmente presente la visione del fiume che sgorga
dal lato destro del Tempio riferita da Ezechiele, di cui è ben nota l’incessante utilizzazione nelle
Catechesi dei Padri:
«Mi condusse poi all’ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia del tempio usciva acqua verso
oriente. Quell’acqua scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla parte meridionale dell’altare. Mi
condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all’esterno fino alla porta esterna che guarda
a oriente, e vidi che l’acqua scaturiva dal lato destro [...]. Ne misurò altri mille: era un fiume che non
potevo attraversare, perché le acque erano cresciute, erano acque navigabili, un fiume da non potersi
passare a guado. Allora egli mi disse: “Hai visto, figlio dell’uomo?” Poi mi fece ritornare sulla
sponda del fiume; voltandomi, vidi che sulla sponda del fiume vi era una grandissima quantità di
alberi da una parte e dall’altra. Mi disse: “Queste acque escono di nuovo nella regione orientale,
scendono nell’Araba ed entrano nel mare: sboccate in mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente
che si muove dovunque arriva il fiume, vivrà: il pesce vi sarà abbondantissimo, perché quelle acque
dove giungono, risanano e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà [...]. Lungo il fiume, su una riva
242 Si comprende che proprio negli Exultet se ne trovino le piu belle raffigurazioni: Un esempio: Benedizione del fonte,
min., Benedizionale, Bari, XI sec. 243 Voce: Fiume, in J. CHEVALIER – A. GHEERBRANT, Dizionario dei simboli, BUR, Milano 198612, pp. 451-453. 244 GREGORIO DI NISSA, in Psal 23, 6. Qui Gregorio sta commentando il salmo battesimale e pasquale per eccellenza del
buon Pastore.
L’acqua, germinatrice di vita
97
e sull’altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui fronde non appassiranno: i loro frutti non
cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti
serviranno come cibo e le foglie come medicina» (Ez 47, 1-12).
Se l’acqua del Giordano era stata santificata dall’immersione in essa di colui che è la Vita, il
mistero della sua capacità di rigenerare e di fecondare non era però ancora stato rivelato. «E vidi che
l’acqua scaturiva dal lato destro del Tempio» (Ez 47, 2). Questo «lato destro» è il Costato di Cristo,
dal quale al momento della transfissione, sgorgano «sangue e acqua». La verità ultima rivelata in
Cristo è che il Fiume dall’alto sgorga dal Cuore stesso di Dio. Infatti, è vero che l’acqua sgorga dal
cuore di Cristo, ma in realtà sgorga dal seno del Padre, sorgente assoluta, imprincipiata.245
Sant’Atanasio nella sua Prima lettera a Serapione, insiste sull’immagine della fonte e sulla
mirabile continuità che vi è dal Padre al Figlio allo Spirito:
«Il Padre essendo fonte, e il Figlio essendo chiamato fiume, si dice che noi beviamo lo Spirito. Poiché
sta scritto: “Tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito” (1Cor 12, 13). Ma, abbeverati dallo Spirito,
noi beviamo Cristo, poiché: “Bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella
roccia era Cristo” (1Cor 10, 4)».246
Un antico smalto georgiano che rappresenta la Crocifissione, visualizza il mistero del Fiume di
vita che sgorga dal cuore di Dio.247 Sotto alla croce, oltre alla Vergine Madre e all’apostolo Giovanni,
si vedono le personificazioni della Chiesa e della Sinagoga. La Chiesa raccoglie in un calice il sangue
e l’acqua viva che sgorgano dal Cuore di Dio: è il «calice mirabile» dell’Eucaristia. La Sinagoga
invece volge le spalle al Crocifisso, precludendosi la visione salvifica dell’Agnello di Dio: poiché
proprio questa visione salva, secondo la parola del profeta riportata da Giovanni: «Volgeranno lo
sguardo a colui che hanno trafitto» (Zc 12, 10 citato in Gv 19, 37). Questa figura dell’incomprensione
o del rifiuto, identificata storicamente in Occidente come in Oriente alla fine del primo millennio con
la Sinagoga, possiede un significato universale: in tutti i tempi, infatti, il mistero della Croce avvince
o scandalizza, come san Paolo aveva detto una volta per tutte:
«Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che
sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio» (1Cor 1,
23-24).
Tuttavia, al di là della non-accettazione o dell’accettazione degli uomini, la Vita che sgorga dal
cuore di Dio e si effonde nel mondo opera la riconciliazione definitiva tra il Cielo e la Terra; una
riconciliazione che qui viene espressa attraverso un simbolismo cosmico. Quando guardiamo questa
immagine ne percepiamo la profonda armonia e un sentimento di pace, ma ne afferriamo subito il
motivo. Il fatto è che ci troviamo qui in qualche modo di fronte alla realizzazione del grande sogno
dell’umanità: la «quadratura del cerchio», vale a dire che ciò che è divino (il cerchio) acquista una
dimensione umana (il quadrato), perché questa significa, di riflesso, che quanto è umano può a sua
volta acquistare una dimensione divina. Le due strutture cosmiche fondamentali: il cerchio per il
cielo - che si tratti di quattro cerchi non fa che intensificare l’effetto -, il quadrato per la terra, sono
qui indissolubilmente unite: il cerchio passa nel quadrato e il quadrato passa nel cerchio. È questa
anche la struttura simbolica del tempio ed è la struttura della Gerusalemme celeste.
Nel mistero dell’acqua e del sangue che sgorgano dal Costato trafitto di Gesù è dunque
contenuto e ricapitolato il mistero della divinizzazione dell’uomo. Il fiume che sgorga dal Paradiso
sfocia anche nel Paradiso, poiché è l’unico Fiume della vita intratrinitaria partecipata all’uomo dalla
divina filantropia in Cristo Gesù nostro Salvatore.
245 Cfr. CH. A. BERNARD, Teologia Spirituale, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1983, p. 165. 246 ATANASIO DI ALESSANDRIA, Lettera a Serapione, Città Nuova, Roma 1986. 247 La Crocifissione di Shemokhmedi, smalto cloisonné, Tbilisi (Georgia), X sec.
L’acqua, germinatrice di vita
98
Il Giordano che è il Cristo. - Secondo l’etimologia indicata da Filone, il nome “Giordano” viene da
yarad, discendere, e potrebbe esser tradotto «colui che discende».Tale significato, individuato da
Origene, diventa per lui spunto per una lettura teologica molto forte, in cui il Giordano diviene il
simbolo stesso di Cristo: «Giordano vuol dire discesa: è là che è disceso il fiume di Dio, la vera
bevanda, l’acqua della vita, Cristo».248 Egli vi ritorna a più riprese, ad esempio, citando l’oracolo di
Ezechiele 29, 3 contro il re d’Egitto - «il grande drago seduto in mezzo ai suoi fiumi» -, cui gli oppone
il Giordano-Cristo:
«Il fiume dell’Egitto che non fu nemmeno capace di uccidere Mosè bambino, non è forse il dominio
del drago, nostro nemico? Come il drago dimora nel fiume dell’Egitto, così Dio nel fiume che rallegra
la città di Dio; perché il Padre è nel Figlio. Per questo coloro che vengono a bagnarvisi depongono
l’obbrobrio dell’Egitto, sono meglio preparati ad essere rapiti in cielo, puri della più immonda delle
lebbre, capaci di ricevere due volte più grazie e pronti ad accogliere lo Spirito Santo. Perché la
colomba dello Spirito non vola su nessun altro fiume».249
Il fiume “Che discende” è Colui che assumendo la carne compie la Discesa assoluta:
«Quale è dunque quel fiume che significa “la loro discesa”, al quale bisogna venire a farsi purificare,
e che non discende della propria discesa ma di quella degli uomini, se non il nostro Salvatore? […].
Bisogna intendere per Giordano il Verbo di Dio fatto carne e che ha abitato in mezzo a noi, Gesù: è
lui che ha dato in eredità l’umanità che aveva ricevuta; è anche lui la pietra angolare ed è lui che,
vivendo personalmente nel seno della divinità del Figlio di Dio, è battezzato, poiché assunto da lui,
e può dunque ricevere la colomba pura e senza frode della Spirito».250
Tale interpretazione non è “un’esclusiva” di Origene, ma patrimonio comune dell’espressione
della fede, la si ritrova ad esempio in un’omelia armena per l’Epifania: «È venuto e si è recato nella
regione del Giordano, perché la parola Giordano significa: la sua discesa. Infatti la luce senza
tramonto è discesa da presso il Padre, nella carne, nel mondo».251
Qui, come scrive Danielou, «arriviamo al culmine della tipologia del Giordano, figura stessa
del Verbo».252
Preparata da tutta la tradizione giudeocristiana del Battesimo di Gesù, questa visione del
Giordano-Cristo possiede una forza evocatrice impressionante.
Il mare nel mondo ebraico e nel Nuovo Testamento
In linea generale il mare è simbolo del dinamismo della vita; per le sue acque in movimento,
simboleggia uno stato transitorio tra i possibili ancora informi e le realtà formali, dunque una
situazione di ambivalenza. Per questo il mare è immagine allo stesso tempo di vita e di morte. 253
Il mare richiama le costellazioni simboliche della nave e della navigazione, di cui uno degli
scopi principali è quello di giungere alla Pace:254
«Dal punto di vista del destino personale bisogna attraversare l’oceano dell’esistenza; dal punto di vista
psicologico “la traversata del mare delle passioni si conclude nell’oceano della tranquillità».255
Gli Ebrei conoscono il mare soprattutto attraverso racconti degli stranieri e dei commercianti:
«Dio con la sua parola ha domato l’abisso e vi ha piantato isole. I naviganti parlano dei pericoli del
248 ORIGENE, Commento su Luca. 249 Ibidem, Commento a Gv 6. 250 Ibidem. 251 F. C. CONYBEARE, Rituale Armenorum, p. 183. 252 J. DANIELOU, Sacrameruum futuri. Etudes sur les origines de la typologie biblique, Paris 1950, p. 239. 253 Voce: Arca e Navigazione, in J. CHEVALIER – A. GHEERBRANT, Dizionario dei simboli, BUR, Milano 198612, pp. 88-
90; 681-682. 254 Ibidem. 255 CH. A. BERNARD, Teologia Spirituale, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1983, p. 218.
L’acqua, germinatrice di vita
99
mare... là ci sono anche cose singolari e stupende» (Sir 43, 23-27); «Ecco il mare spazioso e vasto: lì
guizzano senza numero animali piccoli e grandi. Lo solcano le navi, il Leviatàn che hai plasmato,
perché in esso si diverta» (Sal 104, 25-26).
Il mare è presente anche nella lingua corrente: infatti, mentre l’est si chiamava «davanti a sé»
o «dove si leva il sole» (Gs 19, 12), l’ovest si chiamava «il mare» (Gen 12,8) o «il mare di dietro»,
perché ci si orientava verso l’est (Dt 11, 24; 34, 12). D’altra parte, il mare ricorda agli Ebrei il
Passaggio del Mar Rosso, segno grandioso della vittoria della potenza e della sapienza di Jahvè e,
prima ancora, la creazione, prima vittoria di Dio sul caos di cui il mare è l’immagine. È evidente che
tutto quanto è stato detto a proposito della vittoria di Dio sulle acque distruttrici vale anche per il
mare; tanto più che, benché esista un termine proprio per indicare il lago, lo stile orientale, così come
fa di ogni elevazione una montagna, fa di ogni distesa d’acqua un mare.
Il mare “via gentium”: la scelta di Cafarnao-sul-mare.256 - «Avendo intanto saputo che Giovanni era
stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea e, lasciata Nazareth, venne ad abitare a Cafarnao-sul-mare,
nel territorio di Zàbulon e di Neftali» (Mt 4,12-17). Dopo il Battesimo, Gesù abbandona Nazareth e
si stabilisce a Cafarnao. Vincent Mora fa un parallelo tra questo passo e il ritorno della sacra Famiglia
dall’Egitto. Ritroviamo la stessa spiegazione psicologica - il pericolo mortale nel quale Gesù si trova
in entrambi i casi - e una straordinaria finalità teologica che si trova soltanto in Matteo: manifestare
già simbolicamente l’universalità della salvezza.
«L’evangelista Matteo pone il ministero di Gesù sotto il segno del mare»: 257 questa
osservazione di Mora è estremamente suggestiva. Gesù si è spostato dal suo villaggio nativo,
nell’entroterra, e viene a stabilirsi a Cafarnao che è alla frontiera con il mondo pagano; anche se il
ministero di Gesù è riservato alle pecore perdute della casa d’Israele, esso è già proteso verso il mondo
delle genti, al quale Gesù stesso si recherà e verso il quale «costringerà» i discepoli a recarsi. In questo
modo, l’evangelista spalanca l’orizzonte del ministero di Gesù su una dimensione sconfinata. E non
c’è di che meravigliarsi: il mare e le isole nel Deutero Isaia evocano i pagani in attesa di Dio:
«Ascoltatemi in silenzio, isole, e voi nazioni, badate alla mia sfida! Chi ha operato e realizzato questo,
chiamando le generazioni fin dal principio? […] Le isole vedono e ne hanno timore» (Is 41, 1-5
passim).
Il mare - qui il lago di Tiberiade - costituisce al tempo stesso una frontiera tra il mondo pagano
e Israele e un luogo di passaggio. Il mare e la via gentium, la strada che conduce i discepoli dai popoli
pagani da evangelizzare.
Il mare imago mundi: la chiamata degli Apostoli. - «Salì in una barca che era di Simone, e lo pregò
di scostarsi un po’ da terra. [...] Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: “Prendi il largo e cala
le reti per la pesca”. [...] Gesù disse a Simone: “Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini”.
Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono» (Lc 5, 1-11).
«Seguitemi, vi farò pescatori di uomini» (Mt 4, 19): nell’episodio della vocazione dei discepoli,
il mare è imago mundi, immagine del mondo: i nuovi pescatori di uomini devono gettare le reti e
pescare gli uomini in vista della cernita finale.
L’immagine della pesca è biblica e legata ad un contesto di giudizio.
In Abacuc ad esempio, gli uomini sono paragonati a dei pesci e l’invasore caldeo al pescatore (Ab 1,
14-21); in Geremia invece, il Signore minaccia i peccatori di mandare lui stesso pescatori e cacciatori
(in ebraico usa lo stesso termine) per castigarli (Ger 16, 16). Che la promessa del Signore sia legata
all’idea del giudizio finale lo si intende anche attraverso la parabola della rete:
«Il regno dei cieli è simile anche a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci.
Quando è piena i pescatori la tirano a riva e poi, sedutisi, raccolgono i pesci buoni nei canestri e
buttano via i cattivi» (Mt 13, 47-49).
256 Per questa argomento ci ispiriamo prevalentemente alia sezione del libro di Vincent Mora intitolata La symbolique de
la mer, pp. 127 e 182. 257 V. MORA, La symbolique de la création dans l’Évangile de Matthieu, Cerf, Parigi 1991.
L’acqua, germinatrice di vita
100
La tempesta sedata: la missione della Chiesa ai pagani. - «Essendo poi salito su una barca i discepoli
lo seguirono. Ed ecco scatenarsi nel mare una tempesta (seismòs) così violenta che la barca era
ricoperta dalle onde; ed egli dormiva... Quindi levatosi, sgridò il vento e il mare e si fece grande
bonaccia, Gli uomini furono presi da grande stupore e dicevano: “Chi è mai costui al quale i venti e
il mare obbediscono?”» (Mt 8, 19 -9,1). Mora osserva le differenze del racconto di san Matteo rispetto
a quello di Marco: qui c’è una sola barca, la tempesta qui è un «seisma», ha cioè un carattere
apocalittico; Gesù chiama i discepoli «piccoli credenti» e poi, alla fine non sono discepoli che si
meravigliano e dicono «Chi è costui?», ma degli «uomini» e cioè già i pagani.
C’è un forte parallelismo tra la tempesta sedata, con Gesù che dorme, e l’episodio di Giona che
dorme nella stiva della nave, mentre poi quando confessa di essere la causa della tempesta e viene
buttato in mare, questa si placa improvvisamente e «quegli uomini ebbero un grande timore del
Signore, offrirono sacrifici al Signore e fecero voti» (Gn 1, 16). Per Mora il «segno di Giona» non va
inteso soltanto in riferimento alla risurrezione, ma anche specificamente come la missione di Gesù e
della Chiesa presso i pagani.
Un testo di san Girolamo mette in risalto questa parallelo tra Giona e Gesù:
«Noi leggiamo in Giona una figura di questa miracolo: mentre tutti sono in pericolo, lui solo è al
sicuro e dorme e lo svegliano. Mediante il suo comando e con il sacramento della sua Passione, il
Cristo libera quelli che lo svegliano».258
Lo sfondo missionario di questa brano è messo in risalto anche dal ripetuto insistere di Gesù
sulle esigenze del «seguirlo». L’urgenza di questa missione va al di là dei doveri più sacri degli Ebrei:
come seppellire il proprio padre; ma come osserva Mora, si tratta di andare a salvare delle vite, e in
questo senso la priorità è riconosciuta anche dalla Legge mosaica! Qui, dunque, il riferimento al
«seguire» Gesù non riguarda soltanto la perseveranza e la fede necessarie, ma proprio il seguire il
Maestro che sta partendo verso la riva dei pagani. Gadara era infatti una città pagana celebre per la
sua cultura e per la sua università. Gli indemoniati sono la figura simbolica dei popoli pagani, ancora
schiavi dei demoni.
Si può dire che in tutto questa episodio, che comprende anche la guarigione-esorcismo di due
indemoniati nel paese dei Gadareni, cioè in terra pagana, il Signore dà un esempio, anticipa quella
che sarà la missione della Chiesa. Conclude Mora:
«Come si vede, il tema della missione illumina nel migliore dei modi il racconto fatto da Matteo del
viaggio di Gesù in terra pagana e la tempesta placata che ne è il centro. Non si tratta solo di una
catechesi, peraltro mirabile, sulla fede o la logica della fede in questo Gesù che, in quanto Dio, calma
le tempeste. Si tratta secondo noi di molto di più. Si tratta della Chiesa e della sua missione
evangelizzatrice presso i pagani. Quando Matteo scrive il suo vangelo, l’ora dell’evangelizzazione
in tutte le nazioni e già suonata. Come Giona, la Chiesa si sa inviata presso i pagani. È dunque invitata
a seguire il Figlio dell’uomo, a sacrificare tutto per la missione, anche i doveri che le sembrerebbero
più sacri; deve imitare l’errare del Figlio dell’uomo che non aveva un posto per posare la testa. Si
tratta per la Chiesa di affrontare il mare e le sue tempeste, perché l’ora dell’evangelizzazione del
mondo pagano è anche l’ora del combattimento escatologico che Matteo descrive nei capitoli 24-25
del suo vangelo. In questa combattimento, la Chiesa non deve contare sulle proprie forze, ma sulla
presenza del suo Signore nella nave-Chiesa, quel Signore che è più di Giona».259
La nave-Chiesa; la nave-Croce. - L’affermazione di Gesù: «Più di Giona c’è qui» (Mt 12,41), assume
tutto il suo peso sulla nave-Chiesa sballottata dalle onde e presente il Signore stesso. Tutto infatti va
letto alla luce della promessa finale: «Io sono con voi fino alla fine dei tempi» (Mt 28,18), in cui il
Cristo risorto applica a sé il titolo di Emmanuele.
Nella tempesta sedata, Gesù viene in soccorso della nave-Chiesa, presa nelle tempeste del
mondo e nelle grandi crisi della storia. Vediamo così apparire il simbolismo ecclesiale della nave.
Proprio a proposito della tempesta placata Tertulliano scrive:
258 SAN GIROLAMO, In Mt 1,9; PL 26, 53. 259 V. MORA, La symbolique de la création dans l’Évangile de Matthieu, Cerf, Parigi 1991, p. 153.
L’acqua, germinatrice di vita
101
«Del resto, la barca prefigurava la Chiesa che sul mare del mondo, è scossa dalle onde delle
persecuzioni e delle tentazioni, mentre il Signore nella sua pazienza sembra dormire, fino al momento
in cui, svegliato dalla preghiera dei santi [gli Apostoli], padroneggia il mondo e ridona la pace ai
suoi».260
Come osserva Danielou, questa metafora del mare del mondo e delle tempeste come
espressione delle tribolazioni e delle prove della vita individuale e della storia, è in perfetta continuità
con l’Antico Testamento che conosce una simbolica del mare per significare le prove escatologiche
sia sotto l’aspetto personale che come prove per Israele. Prove dalle quali può 1iberare solo
l’intervento potente di Dio ottenuto con l’intercessione dei santi. In questo filone apocalittico, la nave
non appare come mezzo di salvezza per sé, e dunque simbolo di speranza, ma soltanto come ciò che
è salvato.261 Nel contesto simbolico del diluvio universale l’Arca-nave costituisce invece lo strumento
della sa1vezza. Per questo motivo, trasponendone il significato Filone Alessandrino aveva indicato
nell’Arca l’immagine dell’anima che va verso la vita beata; un’immagine che si ritrova in ambito
cristiano. 262
I temi della nave e della tempesta sono legati in modo particolare al contesto battesimale: la
tempesta placata essendo figura del Battesimo è la nave simbolo della Croce, sia a causa della forma
dell’albero, il quale con l’antenna, cioè il palo trasversale, disegna una croce, sia per il fatto di essere
di legno. Giustino, che per primo introduce questa interpretazione, elencando le diverse figure della
Croce, nomina l’albero della nave e osserva: «Non si può solcare il mare se questa trofeo che si
chiama vela non si innalza intatto sulla nave».263 D’altra parte, in quanta fatta di legno, la nave
richiama anche necessariamente l’Arca di Noè che aveva peraltro già significato battesimale a causa
dei suoi otto occupanti (cfr. 1Pt 3, 20-21). Così, sempre Giustino scrive:
«Il giusto Noè con gli altri uomini del Diluvio, cioè sua moglie, i tre figli e le mogli dei suoi figli,
formavano il numero di otto e mostravano il simbolo dell’ottavo giorno, il giorno in cui il Cristo è
risuscitato dai morti. Ora il Cristo, primogenito di ogni creatura, è divenuto, con un senso nuovo, il
capo di un’altra razza, di quella che era stata rigenerata da lui, dall’acqua, dalla fede e dal legno che
conteneva i misteri della croce, così come Noè fu salvato nel legno dell’arca, portato sulle acque con
la sua famiglia».264
Le due esegesi finiscono in un certo senso per fondersi perché, anche quando la nave viene
identificata con la Chiesa, l’albero rimane il simbolo della Croce.
In questa modo il simbolismo della nave abbraccia sia ciò che viene salvato che lo strumento della
salvezza. Un ottimo esempio di questa fusione si trova in Ippolito:
«Il mare è il mondo. La Chiesa vi sta come una nave, sballottata sull’abisso. Ma non viene distrutta,
perché possiede un abile pilota, il Cristo. Essa porta nel centro il trofeo issato sopra la morte. Porta
infatti la croce del Signore. [...] Lo Spirito che viene dal cielo è presente e le forma una splendida
vela. [...] E porta ancora dei marinai sulla dritta e sulla manca, seduti come gli angeli santi che sempre
governano e difendono la Chiesa».265
Gesù cammina sulle acque: il mare della storia, luogo della teofania di Gesù grazie alla Chiesa. -
«Subito dopo ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull’altra sponda, mentre egli
avrebbe congedato la folla [...]. La barca intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata
dalle onde, a causa del vento contrario. Verso la fine della notte egli venne verso di loro camminando
sul mare. [...] Appena saliti sulla barca il vento cessò. Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono
davanti, esclamando: “Tu sei veramente il Figlio di Dio”» (Mt 14, 22-33).
260 TERTULLIANO, De Baptismo XII, 8. 261 Cfr. J. DANIELOU, 1 simboli cristiani primitivi, Arkeios, Roma 1990, pp. 69-81. 262 Per esempio nell'iscrizione di Firmia Victora, 1V sec., Museo Pio Cristiano, Città del Vaticano. 263 GIUSTINO, Apologia 1, LV, 3. 264 GIUSTINO, Dialogo con Trifone, 138, 1-2. 265 IPPOLITO DI ROMA, De Antichristo, 59.
L’acqua, germinatrice di vita
102
L’interpretazione battesimale di questa scena è testimoniato da una sua raffigurazione che si
trova già nel battistero di Dura Europos. Anche in questo episodio, si tratta di passare all’altra riva,
quella dei pagani; ma, mentre nella tempesta sedata Gesù si trovava con i discepoli e dormiva, qui li
«costringe» a salire sulla barca per recarsi sull’altra riva, mentre lui invece sale sulla montagna a
pregare. Scrive Mora: «In questo quadro, la montagna si oppone al mare, come se la montagna fosse
il luogo naturale di Gesù, e il mare quello dei discepoli e degli uomini».266 Mentre Gesù è lontano, la
barca è sballottata dalle onde.
Con l’intermezzo di Pietro: «Matteo vuole inculcare una verità profonda. Proprio nell’esperienza
attuale dell’aiuto portato da Gesù, Pietro riconoscerà che Gesù è ciò che dice di essere: “Io sono”
[...]. Pensiamo che Matteo ha voluto insistere sulla necessità della fede nella salvezza portata da
Gesù, come conditio sine qua non della salvezza. Ma perché Pietro? Pietro è il modello del discepolo,
il modello del cristiano [...]. Se dunque la barca, come riteniamo, è simbolo della Chiesa, il
personaggio di Pietro era indicatissimo per svolgere questo ruolo esemplare».267
La confessione di fede «di coloro che erano sulla barca: “Veramente tu sei il Figlio di Dio”»
rimanda a tutti coloro che sono sulla nave-Chiesa e che hanno fatto l’esperienza del Risorto. Ma allora
possiamo cogliere il senso più profondo di questa teofania sul mare: «Il Cristo risorto ha lasciato i
suoi. È ora sulla montagna di Dio e prega. Ha costretto i discepoli a prendere il largo per la missione
evangelizzatrice della Chiesa. La notte è calata sul mare...».268 Grazie alla fede della Chiesa che
annuncia il Vangelo destinato a tutte le nazioni, il mare, simbolo del mondo in preda alle tempeste,
diventa l’altro luogo, accanto alla montagna, della teofania del Signore.
Ma proprio per questo, alla fine non ci sarà più il mare cosmico, perché la storia sarà finita, i
cieli verranno arrotolati e la missione alle genti sarà compiuta. Rimarrà solo il mare trasparente simile
a cristallo (cfr. Ap 4, 6), figura delle Acque superiori e simbolo dell’essenza divina.
L’apparizione sul lago di Tiberiade: la riva eterna dell’approdo escatologico. - «Dopo questi fatti,
Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade [...]. Quando era già l’alba, Gesù si
presento sulla riva [...]. Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce»
(Gv 21, 1-14).
«In quella notte non presero nulla» (Gv 21, 2b): il parallelismo di questa pesca infruttuosa con
quella raccontata da san Luca prima della chiamata di Pietro e Andrea si impone; ma il confronto tra
l’una e l’altra fa apparire un aspetto complementare. In entrambi i casi, dopo una notte trascorsa senza
prendere niente, la presenza del Cristo porta nelle reti una pesca sovrabbondante; tuttavia, nella prima
pesca miracolosa Gesù è sulla barca, le reti rischiano di rompersi e ci si affretta a tirare i pesci nelle
barche anche a rischio di farle affondare. In questa seconda pesca, invece, Gesù è sulla riva e viene
specificato che ordina di gettare le reti «a destra» della barca e poi che «non si spezzarono» malgrado
il gran numero di pesci pescato, numero che questa volta viene indicato: 153 grossi pesci. A proposito
di questo numero, Mora ricorda che i naturalisti antichi distinguevano 153 specie di pesci; averne
pescato esattamente tale numero è dunque un modo per indicare la totalità e l’universalità della
salvezza.269
«C’è qui un grande mistero (sacramentum)» commenta sant’Agostino. L’interpretazione viene
d’altronde dal Vangelo stesso: «Il Regno dei cieli è simile a una rete... La tirano a riva e poi
raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo» (Mt 13,
47-49).
Nella prima pesca miracolosa, figura della fecondità della missione apostolica nel tempo, Gesù
era «nella barca», con i discepoli - «Io sono con voi fino alla fine dei tempi» - e la conduceva «al
largo», in acque profonde. Nella seconda pesca, invece, dopo la Risurrezione, viene prefigurato
l’approdo della nave-Chiesa sulle rive dell’eternità, dove Gesù ci ha preceduti: è la pesca del Giudizio
266 V. MORA, La symbolique de la création dans l’Évangile de Matthieu, Cerf, Parigi 1991, p. 170. 267 Ibidem, p. 170-171. 268 V. MORA, La symbolique de la création dans l’Évangile de Matthieu, Cerf, Parigi 1991, p. 172. 269 V. MORA, La symbolique de la création dans l’Évangile de Matthieu, Cerf, Parigi 1991, p. 129.
L’acqua, germinatrice di vita
103
definitivo, quando il Cristo ordina agli Apostoli di gettare le reti «a destra della barca» della Chiesa,
per raccogliere soltanto gli Eletti.
Le annotazioni simboliche si accumulano: durante la notte, che qui è il tempo della storia, il
mare sembrava senza pesce, ma quando al mattino appare il Signore risorto, il mare si riempie di
pesci che la rete degli Apostoli può accogliere e condurre sulla riva dell’Eternità. E ancora: il Signore
sulla riva ha preparato un pasto: pane e pesce arrostito, ricordo della moltiplicazione dei pani e dei
pesci, figura eucaristica e figura del banchetto nel Regno.
Finite le tribolazioni e le prove è compiuta nel Porto di pace la navigazione della nave-Chiesa.
Nella Gerusalemme celeste rimane una duplice grandiosa presenza dell’elemento acqueo: quella del
mare trasparente simile a cristallo (cfr. Ap 4, 6) e quella del fiume di acqua viva, «limpida come
cristallo» che scaturisce dal trono di Dio e dall’Agnello (Ap 22, 1-2).
La prima significando l’infinitezza di Dio, la seconda il fluire incessante della Vita
intratrinitaria. Da Dio veniamo a Dio ritorniamo, avendo prodotto frutto qui sulla terra, in mezzo alle
tribolazioni della storia che però si aprono all’Infinito.
Acqua: dal mare alla lacrima nella Tempesta di William Shakespeare
Scrivere sulla Tempesta di William Shakespeare è come scrivere sull’acqua. Si crede di avere
un foglio, di carta o elettronico, su cui poggiare la mano che tiene la penna, o su cui le dita possano
muoversi leggere sui tasti mentre sullo schermo luminoso i caratteri corrono a formare lunghi
filamenti di parole. Ma tutto si discioglie, e restano solo la mano e l’acqua.
L’acqua letteralmente imbeve di sé le situazioni e il tessuto di immagini dell’opera, con tutta
l’ambivalenza del simbolo: essa è, in breve, morte e vita. Vediamo come.
L’opera, che venne rappresentata per la prima volta nel 1611, si apre con una tempesta marina
che travolge una nave. La nave trasporta il re di Napoli, Alonso, e suo fratello, Sebastiano; Antonio,
duca usurpatore di Milano; Ferdinando, il figlio del re di Napoli; Gonzalo, un vecchio cortigiano;
Adriano e Francesco, due nobili, Trinculo e Stefano, il primo un buffone, il secondo un cantiniere.
Tutti costoro, insieme all’equipaggio della nave, vengono colti dalla tempesta durante il viaggio
di ritorno da Tunisi, dove aveva avuto luogo il matrimonio della figlia del re di Napoli.
Fanno naufragio sulle coste di un’isola incantata, dove vivono Prospero, fratello del duca
usurpatore di Milano, Miranda, figlia di Prospero, Calibano, un essere mostruoso schiavo di Prospero,
e Ariel, uno spirito. Prospero, il vero duca, è anche un mago: ha suscitato la tempesta per
riappropriarsi del suo ducato e per “combinare” il matrimonio tra sua figlia Miranda e Ferdinando,
figlio del re di Napoli. Tutto va in porto, Prospero riesce nel suo intento, e alla fine tutti partono
dall’isola con la nave, rimasta intatta con l’intero equipaggio, mentre Ariel, lo spirito, viene liberato.
La prima scena è sulla nave, in mezzo al mare. La tempesta è terribile non solo per tutti coloro
che ne sono coinvolti, ma anche agli occhi di Miranda, che dall’isola, insieme al padre, assiste allo
spettacolo, nella seconda scena:
Miranda
Se con la vostra Arte, mio carissimo padre,
Avete gettato le acque selvagge
In questo fragore,
Ora calmatele. Sembra che il cielo
Voglia rovesciare fetida pece
Ma il mare
Montando fino alle guance delle nubi
Spegne il fuoco.
Oh, come ho sofferto
Con quelli che vidi soffrire!
Una splendida nave
(Che certo aveva dentro nobili creature)
Tutta a pezzi.
L’acqua, germinatrice di vita
104
Ah, come quel gridare
Mi ha battuto sul cuore.
Povere anime, tutte perdute.
Se avessi avuto il potere di un dio
Avrei sprofondato il mare nella terra
Prima che s’ingoiasse il bel veliero
Con il suo carico di umani.270
È da notare che le parole di Miranda descrivono una tempesta che ha già raggiunto il suo apice:
“come ho sofferto con coloro che vidi soffrire”.
Miranda chiede al padre di far cessare la tempesta, anche se ancora in dubbio sull’effettiva
provenienza magica dell’evento atmosferico: “Se con la vostra arte, mio carissimo padre”.
In altre parole, Miranda sta descrivendo una visione, e gli effetti di quella visione su di lei:
Oh, come ho sofferto
Con quelli che vidi soffrire!271
E la visione di Miranda è una visione dalle risonanze apocalittiche:
Il secondo angelo suonò la tromba: come una gran montagna di fuoco fu scagliata nel mare. Un terzo
del mare divenne sangue, un terzo delle creature che vivono nel mare morì e un terzo delle navi andò
distrutto (Ap 8, 8).
Prospero, appunto, rivela alla figlia, la natura magica dell’evento rovinoso:
Prospero
No, nemmeno un capello fu strappato
A coloro che tu udisti, dalla nave, gridare,
A coloro che tu vedesti affondare.272
Se la suggestione del testo evangelico è qui potentissima: «Ma nemmeno un capello del vostro
capo andrà perduto» (Lc 21, 18), bisogna pur dire che la “linea evangelica” all’interno delle molteplici
strade d’interpretazione di quest’opera si può certamente tracciare ed è presente, ma è molto
importante non chiudere il dramma in nessun sistema interpretativo. Perché la Tempesta è come
l’acqua: prende la forma del contenitore in cui la si pone, ma non ha una sua forma solida, a meno
che non la si voglia congelare.
Nell’opera sono dunque presenti molti temi: la riflessione sul potere, sulla sua natura e i suoi
limiti; quella sulla scienza e la magia; tutte le suggestioni derivanti dal “mondo nuovo”, l’America,
le cronache di naufragi, i problemi della colonizzazione (espressi nell’opera dai rapporti di Prospero
con Calibano), dunque i rapporti con “i selvaggi”; il problema dello stato utopico, e altro ancora.
Tutto questo, e la riflessione sull’arte, sui suoi poteri e i suoi limiti è la Tempesta. Ma continuiamo
con l’acqua.
Il potere distruttivo dell’acqua come abbiamo visto viene dunque rappresentato all’inizio.
Coloro che affrontano questi flutti magici credono di morire. Approderanno invece tutti sani e salvi
sull’isola incantata.
Prospero
E dimmi, Ariel,
Sono davvero salvi tutti?
Ariel
270 W. SHAKESPEARE, La tempesta, trad. Agostino Lombardo, Feltrinelli, Milano 2004. Tutte le citazioni che seguono
sono tratte da questa edizione. 271 Ibidem. 272 Ibidem.
L’acqua, germinatrice di vita
105
Nemmeno un capello si è perduto.
E sugli abiti che li tenevano a galla
Non c’è nemmeno una macchia.
Sono più nuovi di prima.
Le stesse osservazioni verranno fatte più avanti da uno dei naufraghi, il buon vecchio Gonzalo:
[…] I nostri abiti, pur immersi come sono stati nel mare, mantengono, ciononostante, la loro
freschezza e lucentezza, quasi fossero stati tinti di fresco piuttosto che macchiati dall’acqua salata.273
Non è un caso che proprio Gonzalo rifletta sulla freschezza, sulla novità. Egli è, tra i naufraghi,
il solo personaggio che con Prospero è stato, in passato, leale, avendolo aiutato a fuggire insieme alla
piccola figlia, con cibo acqua e libri su una barca che poi era approdata all’isola. Gonzalo è un
personaggio buono.
L’immersione nell’acqua, l’esperienza della morte, l’emersione a una novità sono qui esperiti
da Gonzalo come temi battesimali.
Ma esiste anche un caratteristico rovesciamento grottesco del battesimo e del suo vissuto. È
quanto capita a Stefano e Trinculo, il buffone e il cantiniere, che si uniscono a Calibano in una
congiura contro Prospero, che viene naturalmente sventata:
Prospero:
Dimmi di nuovo,
Dove hai lasciato questi manigoldi?
Ariel:
[…]
Li ho lasciati nello stagno
Dalla lurida schiuma
Dietro la tua grotta,
A ballare lì dentro fino al mento,
Con l’acqua sporca che puzzava
Più dei loro piedi.274
Quando tutti si incontreranno nella scena dell’agnizione finale, Trinculo così risponde ad
Alonso, che gli chiede dove è stato:
Dall’ultima volta che vi ho visto sono stato in una tale salamoia che ho paura che non mi uscirà più
dalle ossa: le mosche mi staranno lontane per sempre.275
L’immersione, il baptysmos, non sempre prelude ad una emersione nella Tempesta; nel
caratteristico stemperarsi del tragico e del comico propri del dramma (che appartiene ai cosiddetti
romances, dunque non tragedia né commedia) assistiamo a varie rappresentazioni della morte per
acqua (che peraltro è proprio ciò che Gonzalo teme: “avrei preferito una morte asciutta”). Queste
rappresentazioni mantengono in sé una connotazione rituale per come vengono vissute dai
personaggi, come abbiamo visto nel caso di Gonzalo e di Trinculo. Vale a dire, grazie all’incantesimo.
Ma, poco dopo il naufragio, troviamo Ferdinando, il figlio del re di Napoli, solo e triste sulla
riva. Egli insegue una musica, una musica che gli strisciò accanto sulle acque, mentre piangeva la
morte del padre. Si tratta di Ariel, lo spirito al servizio di Prospero, che sta ordendo l’incantesimo per
Ferdinando.
A cinque tese sott’acqua
Tuo padre giace.
Già corallo
Son le sue ossa
273 Ibidem. 274 Ibidem. 275 Ibidem.
L’acqua, germinatrice di vita
106
Ed i suoi occhi
Perle.
Tutto ciò che di lui
Deve perire
Subisce una metamorfosi marina
In qualche cosa
Di ricco e di strano.
Ad ogni ora
Le ninfe del mare
Una campana
Fanno rintoccare.276
Questo incantevole song aggiunge al tema battesimale il tema metamorfico. Ariel sta
proponendo in forma poetica a Ferdinando ciò che Ferdinando già sa: la canzone ricorda mio padre
annegato.
Anche qui, come nei casi precedenti, un’esperienza, tramite un incantesimo, diventa un vissuto.
La metamorfosi marina esiste solo nel canto di Ariel (il padre è sano e salvo in realtà) e non ha nulla,
nella sua stessa rappresentazione verbale, di tragico. Però attiva, tramite l’immagine metamorfica, la
consapevolezza, e l’accettazione, che qualcosa deve morire.
L’acqua che distrugge, l’acqua che purifica, l’acqua che trasforma, l’acqua che fa vivere e che
dà la morte.
L’acqua circonda l’isola, ma è spesso citata, in meravigliose immagini, come elemento di vita,
naturale e/o magica, al suo interno. È l’acqua della rugiada dalle Bermude che Ariel porta a Prospero;
è l’acqua con dentro i mirtilli che Calibano riceveva in dono da Prospero quando erano amici (prima
che Calibano tentasse di violare Miranda); è nelle ninfe dei ruscelli serpeggianti, nelle Naiadi dalle
corone di alghe e l’aria sempre mite che vivono lungo canali increspati; è negli elfi delle colline, dei
ruscelli, degli immobili laghi e delle selve. È qui, ed è nella danza delle ninfe sulla riva del mare: voi
che sulle sabbie inseguite con piede che non lascia impronta il rifluente Nettuno e gli sfuggite quando
di nuovo avanza…
Tutta una vita, fatata, legata all’acqua.
Un’acqua battesimale, dunque, che stempera i grumi del tragico, i grumi della colpa, nella
forma del romance.
Prospero significa “favorevole”. Così come “tempestas”, in latino indica, la “tempestività”. Un
tempo giusto per un fatto preciso. Un “qui e ora”. Tutti i naufraghi sono, come ora ribadiamo, preda
di un incantesimo. Le ricerche, il vagare senza senso e senza sosta di tutti i naufraghi sull’isola
possono essere letti come un percorso di espiazione. Cosa cercano i naufraghi, questi potenziali
signori di una terra incognita, che attivava nelle menti degli spettatori del 1611, quando l’opera venne
rappresentata per la prima volta a corte, suggestioni sui nuovi mondi che cominciavano a venire
colonizzati? Tutti inseguono, nell’incantesimo, i propri personali idoli: chi cerca di impadronirsi
dell’isola, chi cerca il padre che crede morto, chi cerca il figlio che crede morto a sua volta, chi
vaneggia l’instaurarsi di uno stato utopico; chi, come gli infimi nella scala sociale e, secondo la
visione del mondo elisabettiana, morale, cerca addirittura di allearsi con Calibano, il mostro che abita
l’isola e che è schiavo di Prospero, per ucciderlo, e prendere il potere. Nessuno è vincitore, nessuno
trova ciò che cerca, tutti sono irretiti in una condizione delirante, alla mercé degli incantesimi di
Prospero. Dunque, alla fine di questo presunto percorso di espiazione dovrebbe esserci il perdono di
questo mago potentissimo, di questo Prospero di cui tutti sono in balia, che sembrerebbe avere dei
tratti quasi divini.
E questo perdono c’è, ma Prospero è una figura ambigua. Non è un buono. Egli, tanto per
cominciare ha una colpa, un peccato d’origine tragico: ha trascurato il regno per ritirarsi in una
dimensione privata, contemplativa e intellettualistica, diremmo oggi. Si è chiuso nei suoi studi di
magia. E questo è uno dei grandi temi dell’opera, la riflessione sulla scienza e sui metodi d’indagine
del reale. Siamo nel 1611: il Novum Organum di Bacone è alle porte, sarà pubblicato nel 1620, e la
276 Ibidem.
L’acqua, germinatrice di vita
107
riflessione che esso porta con sé, cioè sul metodo scientifico inteso in senso moderno convive con la
magia rinascimentale e la sua ossessione di trasformazione della realtà; in questo senso Prospero
rimanda a figure storiche come Rodolfo II d’Asburgo, l’imperatore collezionista che era anche
alchimista, e che trasportò la capitale dell’impero da Vienna a Praga; ma Prospero che domina gli
spiriti è anche, in questo senso e non solo, omaggio ideale alla stessa figura di Giacomo I Stuart, che
fu un cultore di demonologia.
Egli ha dunque una colpa: ha trascurato il regno per dedicarsi ai suoi studi di magia. Per questo
è stato spodestato, e ne è consapevole. Gli abitanti dell’isola che sono con lui, la figlia Miranda, e
Ariel, lo spirito tuttofare, e Calibano, tutti contribuiscono a individuare lati diversi del suo carattere.
Ciascuno di essi collabora a fare della figura di Prospero una figura del dubbio.
Il rapporto con la figlia è da dominatore, ma anche quello di un padre single, diremmo oggi,
che cresce, educa la figlia e la consegna al mondo, vale a dire a Ferdinando, figlio del re di Napoli.
Ariel cosa è, nell’opera? È uno spirito. È un principio buono? Sicuramente è uno spirito
sottomesso a Prospero. Egli porta in sé i semi della riflessione spirituale di Prospero, perché è proprio
lui a farlo riflettere sulla possibilità di perdonare i naufraghi.
C’è poi Calibano: questo personaggio è ispirato da un saggio di Montaigne “sui Cannibali” vale
a dire sugli abitanti del nuovo mondo. Il saggio era stato tradotto da John Florio ed è forse la sola
fonte certa per la Tempesta. Il saggio di Montaigne è all’origine del filone moderno sulla bontà
dell’uomo cosiddetto naturale, che tramite Rousseau arriva fino a noi. Ma, profondo conoscitore
dell’anima umana quale è, Shakespeare non crede nella originaria bontà. Non crede in una assenza
cioè di peccato d’origine.
Ed è proprio questo peccato d’origine che rende inassimilabile l’isola coi suoi abitanti all’Eden,
non è una condizione edenica quella dell’isola. E Prospero non è Dio.
Attraverso il tempo dell’incantesimo sull’isola, che coincide con quello della rappresentazione,
e che è una rappresentazione nella rappresentazione, anche Prospero viene messo di fronte alla sua
propria illusione, che è quella dell’onnipotenza. Ed egli alla sua onnipotenza rinuncia volontariamente
annegandone il libro.
Spezzerò la mia verga,
La seppellirò
Mille tese sotto terra
E più in fondo
Di quanto mai scandaglio si sia spinto
Annegherò il mio libro.277
Queste parole preludono all’agnizione finale, e al finale perdono, prima della partenza di tutti
dall’isola.
Chi riconosce la propria colpa piange. E la lacrima, acqua salata, è l’ultima immagine d’acqua
su cui brevemente sostiamo.
Molte sono le immagini di lacrime in quest’opera, ma ce n’è una che è particolarmente bella.
Ancora una volta è legata a Gonzalo, il buon vecchio cortigiano.
Prospero:
[…]
E il re e i suoi come stanno?
Ariel:
[…]
Sono in preda alla pazzia
E gli altri piangono per loro
Stracolmi di dolore e di paura:
Ma specialmente quello
Che tu hai chiamato, padrone,
“Il buon vecchio nobile Gonzalo”.
277 Ibidem.
L’acqua, germinatrice di vita
108
Le lacrime gli scorrono
Lungo la barba
Come gocce d’inverno
Da grondaie di canne.278
Le lacrime sono come gocce di pioggia invernale; esse introducono, all’interno della
lussureggiante natura dell’isola e degli altrettanto lussureggianti spettacoli orditi da Prospero, il
freddo di una immagine invernale. Essa porta con sé la meditazione di Prospero sulla possibilità del
perdono:
Ariel:
[…]
Il tuo incantesimo
Agisce con tanta forza
Che se tu li vedessi ora,
Ne avresti tenerezza.
Prospero:
Lo credi, spirito?
Ariel:
Io sì,
se fossi umano.
Prospero:
E allora io lo sarò.279
E Prospero perdona. Perdona anche se stesso, rinunciando all’onnipotenza. Questa cosa del
buio la riconosco mia, afferma Prospero rivolto a Calibano. Se questo significa da un lato ribadire la
propria signoria sopra di lui, dall’altro è anche l’accettazione della parte di tenebra che è anche in lui
stesso.
Alla fine della rappresentazione, che coincide con la fine dell’incanto ordito da Prospero,
abbiamo un epilogo da lui pronunciato, rivolto al pubblico, a noi, in cui, ormai libero dal delirio di
onnipotenza, egli ci chiede di essere perdonato, di essere rimesso in libertà.
Il tema del perdono esce allora dallo spazio-tempo dell’artificio, per investirci personalmente,
per investire noi spettatori, noi che abbiamo le nostre vite tempestose, le nostre tempeste interiori, ma
che anche suscitiamo tempeste, siamo in grado di suscitare continue tempeste. Ecco che
l’accettazione della parte nostra di oscurità, della nostra tempesta, ci lava, ci purifica.
Possiamo dunque riflettere sulla Tempesta come se ci riflettessimo su uno specchio d’acqua.
Questa riflessione porta con sé un movimento quasi naturale verso temi quali colpa, espiazione e
perdono. L’acqua è trattata nella Tempesta secondo tutta la sua simbolica, ma, perché sia viva, va
lasciata scorrere liberamente.
Nelle ultime parole di Prospero, che sono anche le ultime del dramma:
Come voi per ogni colpa
Implorate il perdono,
Così la vostra indulgenza
Metta me in libertà.280
278 Ibidem. 279 Ibidem. 280 Ibidem.