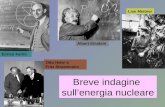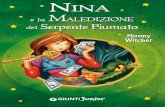Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
-
Upload
pinealismus -
Category
Documents
-
view
230 -
download
2
Transcript of Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
1/180
Aesthetica Preprint
Supplementa
La maledizione della paroladi Fritz Mauthner
Centro Internazionale Studi di Estetica
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
2/180
Il Centro Internazionale Studi di Estetica un Istituto di Alta Cultura costituito nel novembre del 1980 da un gruppodi studiosi di Estetica. Con D.P.R.del 7 gennaio 1990 stato riconosciuto EnteMorale. Attivo nei campi della ricerca scientifica e della promozione culturale,
organizza regolarmente Convegni, Seminari, Giornate di Studio, Incontri, Tavolerotonde, Conferenze; cura la collana editoriale Aestheticae pubblica il perio-dico Aesthetica Preprintcon i suoi Supplementa. Ha sede presso lUniversitdegli Studi di Palermo ed presieduto fin dalla sua fondazione da Luigi Russo.
Aesthetica Preprint
Supplementa
la collana editoriale pubblicata dal Centro Internazionale Studi di Esteti-ca a integrazione del periodico Aesthetica Preprint. Viene inviata agli stu-diosi impegnati nelle problematiche estetiche, ai repertori bibliografici, allemaggiori biblioteche e istituzioni di cultura umanistica italiane e straniere.
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
3/180
Aesthetica Preprint
Supplementa
22Settembre 2008
Centro Internazionale Studi di Estetica
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
4/180
Fritz Mauthner, 1849-1923
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
5/180
Fritz Mauthner
La maledizione della parolaTesti di critica del linguaggioa cura di Luisa Bertolini
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
6/180
Il presente volume viene pubblicato col contributo del MIUR(PRIN2006, respon-sabile scientifico prof. Gianna Gigliotti) Universit degli Studi di Roma TorVergata, Dipartimento di Ricerche Filosofiche.
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
7/180
Indice
Presentazione: Fritz Mauthner e la maledizione della paroladi Luisa Bertolini
1. Linguaggio e metafora in Fritz Mauthner 72. Il linguaggio come metafora 133. Metafora e rappresentazione 234. La teoria della metafora 34Bibliografia 59
La maledizione della parola: Testi di critica del linguaggiodi Fritz Mauthner
Critica del linguaggioPrefazione 77Introduzione 78Lessenza del linguaggio 79Linguaggio e socialismo 90La superstizione della parola 93Pensare e parlare 96Anima e sensi 100Larte della parola 102La metafora 104
Dizionario di FilosofiaSignificato (Bedeutung) 117Coscienza (Bewusstsein) 120Cosa (Ding) 121Unit (Einheit) 123Conoscere (Erkennen) 129Umorismo (Humor) 132Ridere (Lachen) 140Bello (Schn) 140
Verit (Wahrheit) 148Mondo aggettivo 152Mondo sostantivo 154Mondo verbale 155
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
8/180
Le tre immagini del mondoLe tre nuove categorie 161Dappertutto tre mondi. Lattore 166Epilogo 166
Indice dei nomi 169
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
9/180
7
PresentazioneFritz Mauthner e la maledizione della paroladi Luisa Bertolini
1. Linguaggio e metafora in Fritz Mauthner
Mauthner del tutto Mauthner, vorrei dire pi di quanto lo sia.
un uomo intelligente e pieno di spirito, ma c una stoffa di setache credo si chiami cangiante. Si presenta molto bene, ma non si sase sia verde, rossa oppure marrone; Mauthner evoca sempre qualcosa,quando per si vuol dire: mi permetta, gi andato via Mauthner lospite pi splendido, ma insieme anche il cameriere pi ordinario,quello che ti porta via il piatto proprio quando stai per cominciare.Cos lo scrittore berlinese Theodor Fontane ci presenta Fritz Mauthner,cogliendo in pochi tratti il carattere delluomo e del pensatore 1: il con-tributo di questo filosofo per lunghi anni dimenticato e in Italia pococonosciuto 2 si pu riassumere infatti nel lavoro critico contro ogniovviet e pregiudizio filosofico e nellindividuazione dellanalisi del lin-guaggio come terreno fondamentale per questa operazione. Lapprodo una posizione radicalmente scettica e nominalistica che sembra esaurirsinellosservazione arguta e brillante che svuota ogni cosa di senso e lasciail lettore a mani vuote. Da una pi attenta considerazione del percorsointellettuale di questo autore emergono per alcuni nuclei tematici cherivelano maturit teoretica e ritornano nella filosofia contemporanea,mostrando una sua fortuna, per cos dire, sotterranea.
Mauthner indica come compito di tutta la sua produzione intellet-
tuale la critica del linguaggio e nella ricostruzione posteriore delle sueErinnerungen3afferma di esservi stato in un certo modo predestinatoin quanto ebreo nato in una provincia slava dellImpero austro-unga-rico, dove il tedesco era la lingua degli impiegati, della formazione,della poesia e dei parenti; il ceco la lingua dei contadini e delle donnedi servizio, ma anche la lingua storica del regno di Boemia; lebraico,la lingua sacra dellAntico testamento, divenuta il Mauscheldeutschdeirigattieri ebrei, ma anche talora degli eleganti uomini di commercio 4.In un altro passo lo scrittore attribuisce per il fallimento della scrit-
tura poetica proprio a questo, al cattivo tedesco di Praga, il tedescocartaceo 5, troppo artificiale, imposto dal padre, oppure il cosiddettoKleinseitner Deutsch, il tedesco con influenze austriache, parlato nelsuo quartiere, oppure ancora il misto di tedesco e ceco, definito con
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
10/180
8
spregioKuchelbmisch, il ceco della servit; di qui il rancore, che dure-r per tutta la vita, per lassenza di una lingua madre e di un dialetto,mescolato al risentimento per la mancanza di uneducazione religio-sa 6. Orgoglio e rancore insieme caratterizzano del resto tutte le svolteprincipali della sua vita intellettuale: labbandono degli studi per lapoesia, la scelta della carriera giornalistica a Berlino, la svolta filosoficae il primo allontanamento dalla citt nel quartiere di Grnewald, lafuga da Berlino e gli studi filosofici e scientifici a Freiburg e, infine, lascelta dellisolamento a Meersburg, sul lago di Costanza.
Mauthner era nato il 22 novembre del 1849 a Horschitz (Horice),una piccola cittadina della Boemia orientale, vicino a Kniggrtz eSadowa, come egli ricorda con una punta di orgoglio nazionalistico te-desco 7, da padre ebreo non religioso e da madre antireligiosa, in
una famiglia borghese completamente assimilata che pochi anni dopo,nel 1855, si era trasferita a Praga per dare ai figli unistruzione adegua-ta. Lo scrittore ricostruisce con astio il periodo della sua formazione edel suo insuccesso scolastico: dalla scuola privata elementare ebraica,laKlippschule(scuola dellabbicc), al Piaristengymnasium, scuola cat-tolica, dove met degli studenti erano ebrei e non mancava qualcheprotestante, e infine nel Kleinseitner Gymnasium 8, liceo di lingua te-desca. Alle lamentele contro lastrattezza e la meccanicit degli studisi accompagna linsofferenza per la preparazione superficiale in tutte e
tre le lingue della sua formazione, il tedesco, il ceco e lebraico. Il 1866segna una svolta politica: la vittoria prussiana nella guerra contro lAu-stria con la battaglia di Sadowa e loccupazione di Praga provocano nelgiovane Mauthner il passaggio da un coscienza genericamente austriaca(non eravamo per la grande Germania 9; noi austriaci dovevamo ri-manere i signori della Germania (credevamo di esserlo), per poter poi,in casa, farla finita con i cechi 10) a un nazionalismo grande-tedescocon tratti talora fanatici e deciso odio anticeco 11. Lacutizzarsi del con-flitto etnico, la progressiva diminuzione della componente tedesca nellaPraga della seconda met dellOttocento 12, la rovina finanziaria delpadre che muore nel 1874, costituiscono lo sfondo del periodo deglistudi universitari in giurisprudenza e del loro abbandono, anche in se-guito a un attacco di emottisi, a favore della poesia. Queste premesse,a cui si aggiunge lo scarso successo letterario, rendono comprensibilela scelta, nel 1876, del trasferimento a Berlino.
Mauthner sceglie Berlino e non Vienna, la citt pi veloce del mon-do contro la capitale della lentezza: Berlino la sola capitale tedesca delfuturo 13, centro oltre che della politica e delleconomia, della scienzae della cultura, del giornalismo, delle riviste culturali, della produzio-
ne libraria e della critica teatrale. Qui si rivolge a Arthur Levysohn,direttore di uno dei giornali pi importanti della citt, il Berliner Ta-geblatt delleditore Rudolf Mosse 14. Non trova immediatamente unacollocazione fissa, ma dalla met del 1877 collabora regolarmente per
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
11/180
9
sette anni al settimanale Deutsches Montags-Blatt, dello stesso edi-tore, come scrittore satirico e critico teatrale. La fama improvvisa glideriva dalle parodie pubblicate su questo giornale a partire dalliniziodi giugno del 1878, raccolte lanno dopo in un libro con il titolo Nachberhmte Muster15, al quale fanno seguito anche alcuni romanzi.
Nellambiente culturale berlinese questo signore altissimo e magro,con naso adunco e una lunga barba che lo fa assomigliare a un anti-co profeta 16, sembra a suo agio. La sua figura di intellettuale ebreoassimilato 17 si colloca al centro della vita culturale della capitale 18.Molto ampio anche lo spettro delle sue conoscenze personali: com-prende nomi come Lou Andreas-Salom, Else Lasker-Schler, OskarMaria Graf, Richard Beer-Hofman, Kurt Hiller, Hermann Hesse, ErichMhsam, Theodor Fontane, Maximilian Harden, Gerhard Hauptmann,
Theodor Mommsen, Walter Rathenau e Franz Oppenheimer 19. Anchesul piano personale questo momento appare sereno, segnato dal matri-monio con Jenny Ehrenberg e dalla nascita dellunica figlia Grete.
Mauthner non per soddisfatto di un successo che gli pare troppoeffimero e mondano, si lamenta di aver speso tanti anni in un lavoromaledetto e di esserne a ragione stanco. Ma gi dal 1891 egli avevainiziato, la notte, quasi in segreto, un nuovo e imponente lavoro filo-sofico di analisi e di critica del linguaggio. Le radici psicologiche diquesta scelta risalgono ancora pi indietro (un primo abbozzo, gettato
nel fuoco, nel 1873, poi la ripresa segreta del tema e ventisette anni dipreparazione, come ci dice Mauthner nella prefazione); decisivo sembraper lincontro con il giovane scrittore anarchico Gustav Landauer.Nonostante la diversit del carattere e delle opinioni politiche, per moltiversi contrapposte 20, Landauer di stimolo e di concreto aiuto nellastesura dellopera, soprattutto dopo la morte della moglie di Mauthnernel gennaio del 1896 e linsorgere di una grave malattia agli occhi. I tregrossi volumi deiBeitrge zu einer Kritik der Sprache verranno pubbli-cati tra il 1901 e il 1902 dalleditore Cotta e ottengono una risonanzamaggiore di quanto lautore lamenti 21, non paragonabile per al suosuccesso come scrittore satirico.
Per altri versi la critica del linguaggio ha origine proprio nellattivitgiornalistica, nellatto di mimesi dello scrittore di parodie che si na-sconde dietro la maschera del linguaggio altrui, per forzarne i momentipi deboli e rivelarne il pregiudizio; nasce dallavventarsi contro il lin-guaggio che egli usa quotidianamente con successo, dal voler scavareda autodidatta nella cultura filosofica e scientifica del suo tempo allaricerca della superstizione della parola, oscillando, come rivela nellaprefazione, tra momenti di presunzione e momenti di abbattimento e
mortificazione 22.Il primo volume deiBeitrgeprende avvio dallimpossibilit di defi-nire lessenza del linguaggio che immediatamente si declina nelle diver-se lingue, nei dialetti, nelle lingue particolari, nelle lingue individuali,
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
12/180
10
spesso diverse nelle diverse fasi della vita, presente solo nel suonopronunciato che svanisce nellattimo. Alla mancanza di una definizioneanalitica suppliscono allora le metafore che si accumulano una sullaltrae che si esauriscono nellaffermazione pragmatica che il linguaggio non altro che luso del linguaggio. Con la metafora eraclitea che raffiguralincessante mutamento del significato delle parole nellimmagine dellegocce dacqua della corrente di un fiume Mauthner inizia la disso-luzione di qualsiasi fondamento che assicuri al mondo e al soggettoconoscente una qualsiasi continuit e solidit. Come per il seguace diEraclito del Teetetoplatonico le sostanze si sgretolano nel mutamentoe le qualit si presentano solo negli attributi sensibili, nella consapevo-lezza che il compito critico esigerebbe, come pretendeva Socrate 23, unnuovo linguaggio e che il linguaggio a nostra disposizione appunto
il nostro linguaggio.Il problema diventa ancor pi evidente per il linguaggio della psi-cologia cui Mauthner addebita di aver prodotto la duplicazione delmondo in interno ed esterno, linguaggio e pensiero, memoria e co-scienza, e di aver applicato al mondo interno il linguaggio del mondoesterno. Mauthner vi trova tuttavia alcune indicazioni importanti chesi concludono nella teoria, se cos si pu chiamare, dei Zufallssinne,in gran parte ripresa dalla concezione di Ernst Mach, con qualchesuggestione ricavata da Schopenhauer e Nietzsche. La tesi consiste
nellaffermazione che i nostri organi di senso, costituitisi nel corso diuna evoluzione biologica che ha seguito vie traverse e casuali in unastoria senza leggi, sono simili a filtri che lasciano passare solo unaminima parte delle caratteristiche delle cose, che sono quindi inadat-ti a cogliere linfinita complessit del reale e sufficienti soltanto alloscopo di orientarsi nel mondo, di sopravvivere e di comunicare. Lerappresentazioni, le immagini che ci facciamo delle cose, si modificanocontinuamente come in un caleidoscopio e il concetto contenuto nellaparola, cerniera provvisoria per un complesso di sensazioni, sorge dallastratificazione di rappresentazioni simili, ma non identiche, che scivola-no luna sullaltra senza potersi mai sovrapporre in modo esatto. Mau-thner per consapevole della provvisoriet di una simile definizione,sa che in questa enunciazione vi sono aspetti metaforici, immagini cheinducono allinganno, come il concetto di immagine, appunto.
Nella disamina delle teorie del linguaggio contemporanee, contenu-ta nel secondo e nel terzo volume, Mauthner accoglie sostanzialmen-te la teoria dei neogrammatici e in particolare di Hermann Paul cheaveva accentuato la dissoluzione dellapriori di una lingua presuppostacome unitaria nella comunit dei parlanti che raccontano storie comu-
ni. Nonostante alcune critiche che rimangono alla superficie, Mauthnercondivide con Paul limpostazione della ricerca delle condizioni dipossibilit dellaccordo linguistico, laccento posto sulluso individualedella lingua, sulla discrepanza tra lutilizzazione della parola da parte
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
13/180
11
dellindividuo e quella sancita dalluso, laffermazione dellimpossibi-lit di comunicare il contenuto rappresentativo mediante la parola, ilricoscimento del carattere polisemico del linguaggio e dellinevitabilitdel malinteso. La classificazione dei mutamenti linguistici costituiscepoi la premessa della teoria della parola come metafora che Mauthnerelabora aggiungendovi altre suggestioni provenienti dalla filosofia dellinguaggio e dallestetica.
La pubblicazione dei Beitrgeavviene in un periodo della vita diMauthner di difficolt e di depressione; nellottobre del 1905 si trasfe-risce a Freiburg con lintenzione di dedicarsi agli studi, lontano dai ru-mori della grande citt e dallattivit giornalistica. A dicembre scriveKhn segue il cane 24, e nelle lettere agli amici Mauthner riferiscedi lunghe passeggiate con il cane nella solitudine e nel dubbio di non
riuscire pi a vivere. Riprende per lentamente gli studi, frequentaluniversit seguendo corsi di matematica e di discipline scientifiche,conosce Hans Vaihinger e per suo tramite entra nella societ kantiana,incontra Martin Buber, per il quale scrive la breve monografia divulga-tivaDie Sprache. Ma la novit principale la frequentazione di HedwigStraub, scrittrice ebrea e tedesca 25, che aveva studiato filosofia a Zurigocon Avenarius, il teorico relativista dellesperienza pura 26, e medicina aParigi e che aveva poi lavorato come medico per dieci anni tra i bedui-ni nel deserto del Sahara. Con laiuto della Straub, che diverr la sua
seconda moglie, Mauthner affronta un lavoro nuovo e impegnativo, lastesura di un dizionario dei principali termini filosofici.Das Wrterbuch der Philosophie, questo Mauthner voleva come ti-
tolo, non per vanit, scrive nellintroduzione, ma perch con larticolodeterminativo egli non intendeva ildizionario come unico o migliore,ma il dizionario dei termini che la filosofia ha usato, il dizionario dellanostra filosofia. La filosofia, a sua volta, teoria del conoscere e lateoria del conoscere critica del linguaggio, rassegnazione scettica difronte allimpossibilit di conoscere il mondo, che non vuole presentar-si come pura negazione, ma come il nostro miglior sapere. Nel circolodi memoria, pensiero e linguaggio termini che si sovrappongono espesso vengono identificati le parole sono soltanto i segni per ri-cordare o i nomi per le esperienze senza nome, numerose, troppe peressere senza parole e senza nome 27. Nel corso di una storia priva dileggi e di direzione le parole migrano assieme agli uomini e alle coseche essi portano con s e con esse migrano anche i concetti astratti.Egli sceglie allora poco pi di duecento parole della filosofia, dellequali non ricostruisce letimo alla ricerca di un significato originario,ma ne segue le migrazioni (Wortwanderungen) attraverso le deriva-
zioni, i prestiti (Entlehnungen) e i calchi (Lehnbersetzungen). Nonquindi un catalogo del mondo, ma un insieme di piccole monografiedei concetti astratti, di concetti morti e di concetti apparenti (Schein-begriffe), ai quali nulla corrisponde nella nostra esperienza. Mauthner li
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
14/180
12
chiama concetti sostantivi, ipostatizzazioni arbitrarie del linguaggio,capaci tuttavia di dare vita a rappresentazioni che diventano motivodellagire, pregiudizi in grado di provocare una guerra di religione ola caccia alle streghe. La decostruzione critica assume cos anche unadimensione pratica nella consapevolezza della potenza psicologica ditali concetti, delle loro radici nellessenza stessa del linguaggio: i con-cetti della filosofia dato che la filosofia inizia l dove finisce il saperedellesperienza rimangono sospesi nelle pi alte regioni tra il pericolodellapparenza e il pericolo dellantica mistica 28.
La critica del linguaggio della filosofia si esprime gi nellimposta-zione enciclopedica che rifiuta lordinamento gerarchico per sostituirlocon il criterio infantile dellordine alfabetico 29, prende di mira le pa-role pi usate, trasforma la domanda sullessenza nellindagine sulluso
del nome. Ne risulta una disamina dei problemi pi importanti dellastoria del pensiero che rivela conoscenze amplissime, ma anche conclu-sioni affrettate e soggettive. In ogni caso la materia pi ordinata, leconoscenze scientifiche si sono ampliate anche alle discipline matema-tiche e fisiche, il tono a parte qualche caso anche clamoroso 30 pipacato. A questo non certo estranea la presenza della Straub con lasua personalit delicata e tenace, con le sue conoscenze linguistiche escientifiche.
Con Hedwig, che sposer lanno seguente, si trasferisce nel 1909 a
Meersburg sul lago di Costanza in una casa di vetro, la Glaserhusle,dove trascorre gli ultimi anni dedicandosi a un componimento poeticosulla figura del Buddha, alla mistica e ai quattro volumi dellopera DerAtheismus und seine Geschichte im Abendlande, pubblicata nel 1920.Anche questo lavoro concepito come critica del linguaggio e partedalla disamina dei concetti di Dio, eresia, superstizione, ateismo e dialtri termini legati alla storia delle religioni, in particolare della religio-ne cristiana. La ricostruzione della liberazione dal concetto di Dio 31prende in considerazione allora anche le critiche filosofiche, le soluzionieretiche, le lotte contro il potere della Chiesa. La scepsi conoscitiva elinguistica impedisce una soluzione materialistica e trasforma lateismoin una mistica senza Dio, nella quale non vi nome per un Dio, comenon vi sono nomi adeguati per le cose del mondo 32. Ma lidillio delBuddha di Meersburg era gi stato avvelenato da alcune polemichepolitiche e religiose, ma soprattutto dallo scontro con Landauer per gliarticoli nazionalistici che Mauthner aveva scritto allinizio della guerramondiale e per il suo giudizio negativo sulla partecipazione dellamicoalla Repubblica dei consigli di Monaco, nella repressione della qualeLandauer aveva trovato la morte, assassinato in prigione.
Nel suo ultimo anno di vita Mauthner riassume le sue tesi filosofi-che nello scritto Die drei Bilder der Welt, interrotto dalla morte, il 29giugno del 1923.
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
15/180
13
2. Il linguaggio come metafora
La filosofia di Mauthner non ha propriamente un inizio, e non vor-rebbe averlo, eppure la sua critica del linguaggio prende avvio proprionel modo pi classico, con la citazione dal Vangelo di Giovanni: inprincipio era la parola 33. Con la parola continua per gli uominisono al principio del conoscere e rimangono fermi se restano presso laparola; chi voglia procedere oltre, deve liberarsi dalla parola e dalla su-perstizione della parola, riscattare il mondo dalla tirannia del linguag-gio 34. Sembra un punto di partenza, ma lautore ci avverte subito chelespressione in principio muta il suo senso appena procediamo oltrenel pronunciare le cinque parole della proposizione in principio erala parola. Subito dopo, la metafora della scala accresce il disagio del
lettore disorientato. I suoi gradini ci incatenano al linguaggio dellat-timo, di quel determinato gradino che abbiamo toccato anche solo disfuggita e solo con le punte dei piedi, anche se ci siamo costruiti danoi i gradini per quellattimo. Del resto non troviamo la scala, perchMauthner come far Wittgenstein lha distrutta: devo annientareil linguaggio passo dopo passo dietro di me e davanti a me e dentrodi me, devo distruggere ogni piolo della scala mentre salgo. Chi vuoleseguire, ricostruisca i pioli per poi distruggerli di nuovo 35.
La circolarit di questo inizio si manifesta nella struttura delle pri-
me pagine. In effetti non questo linizio: come ha notato ElisabethBredeck, le prime pagine del testo presentano una successione apparen-temente scoordinata di citazioni e annotazioni: prima lepistola dedica-toria di Descartes dei Principia, a cui seguono, nella seconda edizione,la prefazione con il programma di critica del linguaggio e lindice, poile citazioni di Locke, Vico, Hamann, Jacobi e Kleist 36. Linvocazionedello spirito cartesiano si accosta al richiamo allempirismo e alla tra-dizione asistematica. Lapproccio al tema gi decostruzione.
Lo stile della scrittura riflette questa tensione: Mauthner non vuoleprocedere verso la verit, il linguaggio diventa un mezzo di sperimenta-zione, viene piegato e rotto, alla ricerca di una formulazione libera danorme e pregiudizi 37. uno stile espressionistico, capace di far sentiredavvero la lingua, provocatorio nelluso compiaciuto degli ossimori 38,scandito dagli scarti e dagli slittamenti improvvisi verso il basso, nellasciatteria ostentata della lingua da mercato. Non sempre il risultato felice: talora lautore risolve con arguzia ebraica un intreccio comples-so, altrove si perde in lunghe divagazioni che gli prendono la mano.Rimane lobiettivo di presentare lo scetticismo linguistico nellanda-mento stesso della lingua nella quale il significato della parola ripetuta
slitta, viene trasposto, diventa ostensione della metafora.Forse questa la ragione della sua fortuna tra i letterati e dellasfortuna presso i filosofi. Dalle lettere che Mauthner scrive a Hugovon Hofmannsthal, dopo la pubblicazione della Chandos-Brief 39, tra-
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
16/180
14
spare lorgoglio di ritrovare nelle riflessioni del protagonista, lo scrittoreclassico che si commiata dalla parola, leco di molti passaggi della suacritica del linguaggio 40e limbarazzata richiesta di un adeguato rico-noscimento. Nonostante la reticenza del poeta ad ammettere di avertrovato esclusiva ispirazione dalle tesi del filosofo 41su una problematicadaltronde molto presente nella letteratura austriaca del tempo, sappia-mo che nella sua biblioteca sono presenti il primo e il terzo volume deiBeitrgee che nei fogli del NachlassMauthner viene citato pi volte 42.Christian Morgenstern, il poeta del grottesco e dellassurdo, si dichiarainvece esplicitamente seguace di Mauthner e attribuisce alla lettura dellaKritik der Sprache lessere venuto in chiaro sullessenza del linguaggio,giustificazione teorica del suo gioco poetico con la parola 43.
Mauthner letto anche da Samuel Beckett e James Joyce, quando,
tra il 1929 e il 30 a Parigi, Joyce sta lavorando alla contaminazionelinguistica di Finnegans Wakee Beckett cerca nei Beitrgequalcosa chepossa servire alla scrittura di Joyce; ne copia su un quaderno comeriferisce a Linda Ben-Zvi anche un lungo passo sul nominalismo esulla sua indimostrabilit, sullinutilit della parola 44. Sempre nellam-bito della sperimentazione linguistica, ma in un diverso contesto, neglianni sessanta, il viennese Oswald Wiener, nel suo romanzo di decostru-zione, die verbesserung von mitteleuropa, lo cita come provvisorio rife-rimento per una scelta ancor pi radicale di rinuncia al linguaggio 45.
Infine Jorge Luis Borges afferma di consultare spesso il Wrterbuch derPhilosophiedi Mauthner e a lui si ispira in alcuni racconti 46.La diffidenza dellaccademia si conferma invece con il passare degli
anni; nonostante lopinione di Ernst Mach che prevedeva un ricono-scimento, lento ma certo 47, la letteratura critica tarda a prenderlo inconsiderazione e il suo nome rimane legato alla proposizione 4.0031 delTractatus logico-philosophicus, nella quale Wittgenstein afferma: tuttala filosofia critica del linguaggio. Ma non nel senso di Mauthner.Solo a partire dal saggio di Gershon Weiler del 1958 iniziato uno stu-dio pi attento del suo pensiero; eppure ancora Hans Khn, il criticoche gli dedica il testo analitico pi completo, corredato dallintera bi-bliografia dei suoi scritti, lo intitola Gescheiterte Sprachkritik, il naufra-gio della critica del linguaggio. Gli studi successivi, che prenderemo inconsiderazione in relazione a problemi specifici, hanno certamente unapproccio pi cauto, eppure affiora spesso lidea che Mauthner non siaproprio un filosofo. In un certo senso non lo , e non ha voluto esserlo.Egli rimane ai margini della tradizione filosofica, scarta problemi, che anoi continuano a parere importanti, con battute di spirito che ci lascia-no stupefatti per la superficialit; in qualche altro passo sembra voler
cancellare con un solo gesto di insofferenza lintero impianto dei temidella Critica della ragion pura e di un secolo successivo di interpretazio-ni. A tutto questo si aggiungono le querimonie sullaccademia che san-no pi di risentimento che di consapevolezza. Mauthner propone per
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
17/180
15
un cambiamento del punto di vista che richiede unattenzione ineditaalla dimensione empirica del linguaggio. Per questo la sua riduzionedella filosofia a critica del linguaggio mantiene una dimensione filosoficae permette di tornare ai temi di prima con uno sguardo diverso: doposi ascolta, si pensa, si parla diversamente 48. Del resto la filosofia nonha mai preteso di fare di pi e lo stesso Wittgenstein finir per fare unacritica del linguaggio proprio nel senso di Mauthner 49.
Partiamo allora dallindicazione di Elisabeth Bredeck che, nel sag-gio sulle metafore del conoscere in Mauthner, suggerisce una lettura,per cos dire, non letterale dellopera: dopo un iniziale approccio ana-litico che cercava nel testo la contraddizione e lincoerenza, concedeuna valutazione pi indulgente che ci presenta lunica possibilit diapproccio allopera di Mauthner, la lettura delle sue metafore. Il lavoro
della studiosa americana parte dallanalisi della circolarit dellinizio efinisce con la citazione dantesca dei primi versi del IIcanto del Paradi-soche chiude i Beitrge50: un nuovo gioco sullinizio e la fine: Danteallinizio del suo percorso verso la verit garantita da Dio 51, Mauthnerdavvero alla fine e con il sorriso beffardo di chi dice al lettore che ilsuo suggerimento a non seguirlo arriva troppo tardi.
La conclusione non del tutto una sorpresa perch lo stile argo-mentativo di Mauthner procede fin dalle prime pagine nel continuospostamento del piano del discorso, nella posizione di sempre nuove
domande metafisiche che riguardano lessenza del linguaggio e nellosvuotamento delle stesse domande. Cos nella prefazione alla secondaedizione deiBeitrgeMauthner definisce come obiettivo principale delsuo lavoro filosofico lindagine sullessenza del linguaggio, ma sug-gerisce immediatamente limpossibilit di una definizione: il linguaggio un termine generale, astratto, inafferrabile, perch costituito dallamassa enorme di tutti i suoni umani [...] detti o scritti dagli uominiper comprendersi in un qualche luogo della terra 52 e, nello stessotempo, si presenta soltanto nella singola parola, nel singolo suono chesvanisce appena lo si pronunciato; il linguaggio concluder pocopi avanti propriamente non esiste, preso in s una non-cosa senzaessenza (ein wesenloses Unding) 53.
Eppure lintenzione di lavorare sullessenza del linguaggio non sem-bra un semplice espediente, perch la critica del linguaggio viene defi-nita come un compito inevitabile. Ma se non possibile un approccioanalitico lunica strada sembra la metafora e la prima metafora cheMauthner usa nei Beitrgeper descrivere il linguaggio eraclitea: lacorrente del fiume rende in immagine il carattere instabile dei signi-ficati; il fiume, paragonato alla singola lingua, muta a sua volta il suo
corso con landare del tempo. Non soddisfatto del fluire dellacqua,lautore accenna alla possibilit di paragonare la lingua a una correntedaria e al letto di questa corrente. Ma limmagine del fiume sugge-risce anche linutilit al fine di coglierne lessenza dello studio
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
18/180
16
geografico-scientifico che ne ricostruisca il percorso o la costituzionefisico-chimica e richiama la mitologia delle divinit fluviali che rego-lano il flusso dellacqua. La trinit di pensiero, logica e grammatica,alla quale attribuiamo un valore normativo ed esterno al linguaggio,si nasconde piuttosto dentro di esso 54.
Limpossibilit di definire il linguaggio se non mediante metafore,conduce Mauthner alla tesi che il linguaggio semplicemente e prag-maticamente luso del linguaggio. Luso suggerisce una nuova metafora:il linguaggio un gioco di societ le cui regole diventano pi cogentiquanti pi giocatori vi partecipano 55, ma anche la bella immagine dellinguaggio come citt del socialismo realizzato, nelle condutture dellaquale scorrono luce e veleno, acqua e sporcizia 56. Di qui si moltipli-cano le metafore della maledizione: il linguaggio lostetrica dalle dita
sporche che uccidono la partoriente 57, la sferza con la quale ognuno guardiano e schiavo dellaltro, la scimmia addomesticata del circoche si crede un artista, la diavolessa che ha promesso alluomo i fruttidellalbero della conoscenza e in cambio gli ha dato un frutto cancero-geno, parole per cose, etichette per bottiglie vuote 58; il linguaggio ilvecchio frac del signore di Gerlach, rammendato fino a non essere pilo stesso 59, laringa immersa nella soluzione salata del pensiero 60, ilveleno prodotto dalluomo che gli antichi chiamavano antropotoxina 61.Laccumulo di metafore vecchie e nuove modifica il significato di quelle
tradizionali e rivela non solo che il linguaggio non un catalogo delmondo, ma che alla sua essenza appartiene il malinteso, lincompren-sione, la sinonimia (in senso aristotelico, per cui il bue e luomo, inquanto animali, sono sinonimi) e i pi gravi malintesi si manifestanonella morale, nella politica, nel diritto, nella cultura, dove le paroleridono come a casa propria 62.
Il crescendo delle metafore ha per anche un senso teoretico, vuolecondurci alla tesi che la parola in quanto tale metafora; essa non haa che vedere n con il mondo esterno, n con quello interno, caricasolo della sua storia, non evoca immagini, ma immagini di immaginidi immagini in uno sviluppo senza fine di metafora in metafora 63.Questa autoreferenzialit della parola ha senso soltanto nella poesia,dove la maledizione diventa magia e le parole, che conservano la ric-chezza della metafora originaria, hanno peso scrive Mauthner citandoMaeterlink grazie al silenzio in cui sono immerse 64. Il silenzio di unamistica senza Dio, che si pone con il sentimento di fronte a una realtinafferrabile al pensiero, laltro esito dello scetticismo linguistico diMauthner. Linvocazione del silenzio, apparentemente in contraddizionecon la scrittura di migliaia e migliaia di pagine, rimane un avvertimento
critico: guardando al passato egli scrive la critica del linguaggio scetticismo, guardando al futuro misticismo 65. La nostra analisi silimita allo sguardo verso il passato.
Lesposizione della tesi che la parola metafora si trova circa a
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
19/180
17
met del secondo volume dei Beitrgee si colloca dopo la critica allaquestione dellorigine del linguaggio. Rovesciando il rapporto trascen-dentale tra Ursprunged Entstehung, Mauthner rifiuta con decisione laquestione delle origini del linguaggio e preferisce parlare di evoluzionedella lingua, proponendoci di provare di nuovo con una metafora cheprende il concetto nel senso pi ovvio e comune e finisce con unanuova domanda su questo senso. La domanda posta volontariamentein modo banale: qual il nutrimento che fa crescere il linguaggio?La metafora dellorganismo, gi criticata altrove 66, introduce la tesicentrale: il linguaggio, che forse deriva dalle espressioni primordialidello stupore, della gioia e del dolore, si sviluppa e questa peril nostro autore una vera e propria ipotesi attraverso la metafora:il linguaggio scrive cresciuto e ancor oggi cresce a partire dal-
la memoria umana (e memoria umana a sua volta solo linguaggio)soltanto mediante la trasposizione (bertragung, metafeJrein) di unaparola definita (fertig) su unimpressione indefinita, mediante confrontodunque, mediante questo atto eterno del -peu-prs, mediante questoinfinito circoscrivere e parlar figurato, che costituisce la forza artisticae la debolezza logica del linguaggio 67.
Lidea del carattere essenzialmente metaforico del linguaggio non certo una concezione originale di Mauthner; se ne potrebbero cercarele tracce in innumerevoli fili che annodano la storia della filosofia con
la rinascita della retorica, con le teorie del conoscere, con le ricerchepsicologiche e la nascita della semantica. Le tracce lontane vengonocercate da Mauthner nellanalisi gnoseologica del rapporto tra la pa-rola e la cosa degli empiristi inglesi e nella riflessione sul linguaggiodi Vico, Hamann e von Humboldt; gli influssi pi diretti si possonoindividuare invece nel dibattito psicologico e linguistico della fine Ot-tocento. Del resto il carattere originale della posizione di Mauthnernon consiste tanto nella elaborazione di una nuova teoria, dato chetutti gli elementi che ne fanno parte si possono rintracciare nei suoipredecessori, ma come ha notato Weiler nel sottomettere questielementi allidea dominante della critica del linguaggio 68. Questa im-postazione richiede che anche la nostra ricerca debba considerare letesi dellautore in continuo dialogo con le posizioni teoriche che egliriprende, critica e decostruisce.
La prima fonte citata dal nostro autore Locke e pi volte egli siripromette di dedicare unanalisi adeguata al suo libro sul linguaggio, ilterzo delSaggio sullintelligenza umana. Il pensatore inglese non consi-dera per la metafora come uno strumento per comprendere la naturadel linguaggio in generale; quando parla della metafora, la considera
come un vero e proprio inganno nel suo alludere a incerte somiglian-ze pi che analizzare e distinguere 69. Mauthner interessato per aquesto elemento di ambiguit che egli ritrova nel rapporto stabilitoda Locke tra parola e idea, nellaffermazione che le parole sono segni
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
20/180
18
sensibili per le idee; il che stava a significare che esse non sono segnidelle cose e nemmeno delle idee che stanno nella mente dellaltro,che il loro contenuto rappresentativo del tutto privato: lesempio diLocke quello delloro, nel quale il bambino vede solo il colore bril-lante, mentre altri possono aggiungervi il peso, la malleabilit e altrecaratteristiche. Ma la soggettivit della rappresentazione viene argina-ta da Locke con la distinzione tra vari tipi di idee; le idee semplici,corrispondenti alle qualit sensibili, resistono allalbero di Porfirio ealla definizione per via della differenza specifica (non c nulla cheposso tralasciare dallidea di bianco e di rosso per farle concordarenel genere colore), e in questa loro originariet possono essere inqualche modo esibite e riprodotte. Nei modi misti invece, come nelcaso di giustizia o beatitudine, abbiamo a che fare con concetti
astratti e combinati in modo del tutto arbitrario; nel caso poi dellesostanze egli sembra propenso a considerarle come una collazione dicaratteristiche da enumerare 70, difficilmente risolvibile in una chiaradeterminazione del significato. Nella definizione delloro allora lenu-merazione aggiunger al colore giallo la duttilit, la fusibilit, la fissite cos via senza pretendere di penetrare nella sua essenza reale che cirimane sconosciuta. Questa cautela critica alla base dellacuta analisidellambiguit e delle oscurit del linguaggio che si accompagna allaconsapevolezza della difficolt di questo compito: tanto difficile il-
lustrare il vario significato e le molteplici imperfezioni delle parole,quando non abbiamo altro che parole per farlo, una frase che, ab-biamo visto, compare tra le citazioni che introducono la trattazionedellessenza del linguaggio nel primo volume dei Beitrge71. In LockeMauthner trova quindi lattenzione posta sulla funzione del linguaggionel processo stesso della conoscenza, lidea della discrepanza tra con-tenuto rappresentativo e parola e quindi la necessit, nella formazionedei concetti astratti, di far uso di parole provenienti dalle operazionisu cose sensibili trasferendole ai processi del pensiero 72.
Per laffermazione dellorigine metaforica del linguaggio poi ancorpi pertinente il riferimento a Vico, che egli cita subito dopo 73. Nelpensatore napoletano Mauthner trova prima di tutto unattenzione allalingua come documento della storia dellumanit e al suo legame conla storia delle cose, in una prospettiva antirazionalistica, come di-mostra laltra citazione posta allinizio dei Beitrge, accanto a quella diLocke: homo non intelligendo fit omnia. Questa impostazione trovaconferma nel racconto metaforico delle origini della storia ideale eternache fa precedere geneticamente il parlar figurato alluso dei terminipropri: la metafora allora, come accorciata Favoletta, condensa in un
universale fantastico phantastische Gattungsbegriff, traduce Mauthner gli eventi della natura e del cielo e li attribuisce allimmagine di unadivinit, il nome della quale prende forma dal grido della paura. Tuttele lingue procedono quindi nel dare alle cose inanimate trasporti del
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
21/180
19
corpo animato, e delle sue parti, e degli humani sensi e umane passioni,il che corrisponde a una delle definizioni di Quintiliano 74. Vico pro-cede oltre nellesame della metonimia, che veste concetti astratti conleffetto al posto della causa (la morte pallida), e della sineddocche chetrasporta la parte al tutto, mentre assegna la figura dellironia a tempipi tardi, quelli della riflessione 75.
Mauthner scrive per di essere arrivato a Vico solo in un secondomomento, dopo aver elaborato la propria teoria e attraverso una sug-gestione di Goethe 76; lo considera pi un precursore della critica dellinguaggio che uno stimolo diretto al proprio lavoro. Del resto latten-zione alla funzione della metafora non solo in ambito retorico e poetico,ma come strumento teorico in grado di spiegare aspetti fondamentalidellevoluzione del linguaggio in generale, era elemento acquisito nel-
la filosofia e nella linguistica dellOttocento tedesco. Mauthner stessotraccia un filo che collega Vico, Hamann e Herder 77 e, nonostantesia decisamente dalla parte di Herder nel negare lorigine divina dellinguaggio 78, rivela una maggiore affinit e simpatia per le affermazionioracolari del Mago del Nord che aveva letto nelle figure della Bibbia latraduzione del dialetto di Dio nel linguaggio delluomo.
Hamann fonte di ispirazione in primo luogo per lo stile, per ilsuo lento prendere avvio nel groviglio dei titoli, delle dediche spessooccasionali e incomprensibili, dei motti duplici e triplici 79, per la sua
sensibilit per la lingua che accosta la profezia a intermezzi scurrili,per la sua predilezione per la maschera, la parodia e, non ultimo, lametafora. E le metafore che scorrono una sullaltra nellAesthetica innucedipanano la tesi sullorigine del linguaggio dalla poesia, linguamaterna del genere umano 80, nel ventaglio delle immagini che dal-la prima parola di Dio, sia la luce, alla creazione delluomo a suaimmagine, proseguono in un crescendo di citazioni che devono esse-re state modello al lavoro di Mauthner. La trasposizione che avvienenel processo metaforico viene spiegata da Hamann con una ulterioremetafora: pensare tradurre: da un linguaggio di angeli in un lin-guaggio di uomini, ossia pensieri in parole, fatti in nomi, immagini insegni, che possono essere poetici o kyriologici, storici, o simbolici ogeroglifici e filosofici o caratteristici 81 e questa stessa esigenza direndere in immagine, di mettere mani, piedi, ali 82alle astrazioni ealle ipotesi alla base della metacritica alla Critica della ragion puradellamico Kant, che Mauthner cita a pi riprese. In questo breve testoHamann aveva richiamato la tesi di Berkeley, ripresa da Hume, chetutte le idee generali non sono altro che idee particolari congiunte auna certa parola che d loro un significato pi esteso e fa s, alloccor-
renza, che ne richiamino altre individuali simili a loro. Il linguaggiodiventava cos, come sottolinea Mauthner, primo e ultimo organo ecriterio della ragione, senza altra garanzia allinfuori delluso e dellatradizione 83. Contro lidolo della pura ragione Hamann richiama la
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
22/180
20
priorit genealogica del linguaggio: suoni e lettere sono le pure formea priori, dalle quali sorge la lingua pi antica della musica, come dalritmo del polso e del respiro la prima misura del tempo e dalle figu-re del disegno e della pittura la determinazione dello spazio 84. Nonidee innate, dice, ma certo matrici che vanno a ricomporre la fratturakantiana tra sensibilit e intelletto, facendo scorrere tra luna e laltroschiere di intuizioni e di concetti.
Si pu quindi considerare Mauthner come il continuatore di questametacritica della ragione ed egli stesso ha la pretesa di presentare leproprie ricerche come continuazione e completamento dellimpresadel filosofo di Knigsberg, come critica della ragione impura Kritikder unreinen Vernunft, scrive Lktenhaus a proposito, usando perunespressione di Gerber 85 come trasformazione della critica della
ragione in critica del linguaggio. Il primo passo in questa direzione stato fatto, secondo Mauthner, proprio da Kant nella Kritik der Ur-teilskraft, da intendersi come una critica dei concetti e delle parolenellambito del bello; sarebbe stato meglio scrive che fosse statocos anche per la ragion pura: avremmo lacritica del linguaggio 86.Certamente la disamina kantiana della forma soggettiva del giudizioestetico, della funzione dellimmaginazione, dellanalogia e delle ipoti-posi simboliche nella terza critica doveva essere importante per Mau-thner, ma egli non entra nel merito.
Le metacritiche di Hamann e Herder costituiscono poi solo unaprima tappa di un processo di relativizzazione e di storicizzazione del-lapriori che prosegue nel corso dellOttocento con la trasposizione deltrascendentale dal pensiero al linguaggio attuata da von Humboldt 87,con la dialettica traa priorie a posteriori nello spirito dei popoli dellaVlkerpsychologiedi Steinthal e si conclude nellestrema dinamicizzazionedelle analisi dei neogrammatici sulluso della lingua e lo scarto indi-viduale 88. Mauthner trae le conseguenze di questo percorso e in questosenso lo si pu senzaltro considerare, come scrive Lia Formigari,partecipe di un approccio attualistico al tema del linguaggio che hail suo lontano ascendente nel concetto di ejnevrgeia di von Humboldte nello stesso tempo il punto di non ritorno di quella tradizione 89.La ripresa della visione della lingua come qualcosa di continuamente,in ogni attimo, transeunte, non opera (e[rgon), ma attivit (ejnevrgeia),secondo la famosa definizione di von Humboldt 90, avviene infatti solo dallato della definizione dellatto individuale del parlare, mentre laccentoposto sulla produttivit conoscitiva, sulla creazione della soggettivit e lafiducia nella corrispondenza tra rappresentazioni proprie e altrui, fondatasul riferimento alla totalit della lingua, vengono lasciate cadere nella
critica antimetafisica. Nello stesso tempo la frattura che si aperta tracontenuto rappresentativo e parola pronunciata, teorizzata dal principaleesponente dei neogrammatici, Hermann Paul, e ripresa da Mauthner,rappresenta davvero un punto di non ritorno.
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
23/180
21
Nella ricostruzione storica delle teorie sul linguaggio del secondovolume dei Beitrgevon Humboldt rimane un riferimento molto im-portante e lammirazione per la sua presa di posizione politica auten-ticamente liberale e contraria a ogni dispotismo si mescola al consensoper la tesi che le lingue in ultima analisi con una leggera forzatura diMauthner rimangono creazioni dellindividuo 91. A Mauthner piaceil carattere asistematico di un pensiero che non perviene a definizioniconclusive, e non tanto perch le consideri ovvie, ma proprio perchnon ne viene davvero a capo, forse per il carattere circolare di ognidiscorso sul linguaggio. Queste osservazioni rimandano allimpossibilitdi cogliere lessenza del linguaggio se non per mezzo di metafore, allaconsiderazione della lingua come un tessuto, una rete di analogiein cui si cristallizzata una visione del mondo 92, come un cerchio dal
quale possibile uscire solo passando in unaltra lingua metaforaquesta che ritorna neiBeitrge ma in una visione unitaria, a sua voltaresa in metafora con limmagine del prisma 93.
Mauthner passa invece subito alla critica delle formulazioni, a suoparere oscillanti e contraddittorie, sullo spirito che creerebbe la linguae sulla lingua che creerebbe lo spirito; ripete laccusa di Steinthal neiconfronti del maestro, di voler cio dedurre il linguaggio dal pensie-ro, mentre sarebbe pi semplice ricavare dal linguaggio le leggi delpensiero. In particolare il nostro autore riprende il concetto di innere
Sprachform, che von Humboldt aveva posto a fondamento della diversaattenzione delle lingue ai diversi aspetti delle cose, del prevalere del-la componente intellettiva oppure di quella sintetica, e gli conferisceun senso del tutto diverso ed empirico. Ritiene che questo concettosia finalistico e contraddittorio, perch assegna una forma a qualcosadi interiore che non pu aver forma, indicando talora linsieme delleidee che fanno riferimento alla lingua, talora luso del linguaggio 94. Inconcreto per il filosofo illuminista, come Mauthner non si fa scrupolodi definire von Humboldt 95, intenderebbe per forma interiore dellalingua una cosa diversa a ogni paragrafo: la logica del pensiero comeessa si esprime nella grammatica oppure la grammatica astratta comesi esprime nelle singole forme linguistiche e qualche volta persino iltertium comparationis che compare alla fantasia nella formazione dinuove parole 96. Non dobbiamo allora prenderlo alla lettera, la formainterna soltanto la nostra sensibilit (Gefhl) linguistica per la nostramadrelingua che ci fa intendere una parola inesistente come flierbtecome un imperfetto del verbo altrettanto inesistente flierben.
Per dimostrare la sua tesi della parola come metafora, Mauthner at-tinge per al bagaglio delle argomentazioni e degli esempi degli studi di
semantica, che non solo avevano individuato nella creazione dellespres-sione figurata uno dei principali processi che accompagnano il muta-mento semantico, ma ne avevano fornito anche una trattazione analitica.Mauthner conosce e cita numerosi studi di semasiologia, il filone di
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
24/180
22
ricerca che nella Germania dellOttocento costituisce la premessa dellanascita della semantica, disciplina inaugurata dalla pubblicazione, nel1897 a Parigi, del testo di Michel Bral Essai de smantique. Science dessignifications. Di Bral cita il detto: noi siamo, pi o meno, dei dizionariviventi della lingua francese 97, invero per criticarlo subito dopo per lamancanza di un approfondimento psicologico. Ma lapproccio semanticodello studioso francese era vicino alla critica del linguaggio per il concet-to non normativo delle leggi linguistiche che si limitano a rilevare delleregolarit, per la concezione del rapporto tra le parole e le cose e perlimportanza centrale della metafora. La logica del linguaggio per Braluna logica di tipo particolare, avanza per tappe, devia, sosta e riparte,procede per analogie e contiene continui riferimenti soggettivi. Braldedica poi una particolare attenzione alla metafora, affermando come
sia spesso difficile riconoscere le metafore pi antiche, ormai scolorite;esse poi non rimangono legate alla lingua in cui nascono, ma viaggianoda un idioma a un altro. Questo contribuisce a dare alla parola uncarattere polisemico: il linguaggio designa le cose, ma in modo incom-pleto e inesatto; i sostantivi racchiudono solo quella parte di verit chepu essere racchiusa da un nome e che necessariamente pi piccolaquanto maggiore il grado di realt posseduto dalloggetto 98. Il lin-guaggio conclude con una tesi che Mauthner ripete pi volte pusolo restituirci leco del nostro stesso pensiero 99.
Il linguista pi vicino a Mauthner per Hermann Paul: egli locita spesso, anche se talora in maniera polemica 100. Lesponente prin-cipale del movimento dei neogrammatici, influenzato dal darwinismodi Spencer, aveva proposto un approccio radicalmente empiristico allascienza del linguaggio, considerata come disciplina storica, disaminadelle espressioni degli uomini nel loro operare concreto. Mauthner in-dica il passo in avanti compiuto da Paul rispetto alla Vlkerspychologienel focalizzare linteresse sullindividuo, sulluso linguistico del parlantee sulle condizioni di possibilit di comprensione da parte dellinterlo-cutore, e di giungere cos allidea fondamentale che ogni innovazionefonetica e semantica sia opera dellindividuo 101. Nei Prinzipien derSprachgeschichteMauthner poteva trovare unimpostazione psicologicadi stampo herbartiano, centrata sul meccanismo, conscio e inconscio,di aggregazione delle rappresentazioni nella mente dellindividuo, eunindagine sul rapporto tra questo piano, privato e incomunicabile, eluso linguistico. La spiegazione storico-genetica dei mutamenti foneticie semantici, fondata sulla dialettica di significato usuale di un termine edi significato occasionale 102, era basata sul riconoscimento del caratterepolisemico di molte parole in uso e sulla necessit quindi di rendere
tale significato univoco e concreto allo scopo della comprensione traparlanti. Queste deviazioni dalluso comune venivano classificate da Paulsecondo gli opposti princip della specializzazione 103e dellampliamentodel significato 104, princip ai quali egli aveva aggiunto il trasferimento
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
25/180
23
a quanto collegato nello spazio, nel tempo e per causa 105. La metaforadiventava allora uno dei mezzi pi importanti per la creazione di nomiper complessi rappresentativi per i quali non esistono ancora paroleche li designino, ma anche per quelli che gi possedevano un nome,costituendo un complesso di immagini sedimentate che caratterizza ledifferenze di interesse degli individui e dei popoli.
La rassegna dei tipi di metafora di Paul non rappresenta per sol-tanto un fondo di idee ed esempi a cui attingere 106: il nuovo rap-porto stabilito dallanalisi dei neogrammatici tra linguistica e psicologiae il riferimento a Herbart impegnano Mauthner a fare i conti con latradizione degli studi di psicologia 107, aprendo un altro ventaglio diprospettive che richiedono una sintesi.
3. Metafora e rappresentazione
In un primo momento sembra senzaltro di poter definire la con-cezione mauthneriana della metafora con il cattivo attributo di psico-logica, riconducendola alla categoria peggiorativa di psicologismo,se intendiamo con questo termine la dissoluzione dellapriori e la suaspiegazione in termini genetici. Lo stesso Mauthner ribadisce pi voltedi voler ridurre la filosofia a psicologia e per la linguistica afferma che
essa costituisce soltanto un capitolo della psicologia108
. Nello stessotempo per il nostro filosofo afferma che lo psicologismo sarebbe laverit, se la nostra psiche non dovesse parlare 109, se la parola potesse,per cos dire, assomigliare alla rappresentazione. Ma lidea della parolacome metafora collegata al suo carattere polisemico, ambiguo, nonriconducibile a un concetto definito, ma a una pluralit di rappresen-tazioni; in ogni momento egli scrive sono presenti una quantit dirappresentazioni individuali che stanno pronte fuori della cruna dellanostra coscienza 110e che passiamo velocemente in rassegna. Alla pa-rola corrisponde la sedimentazione di rappresentazioni simili, mai egualiper, che fluttuano una sullaltra, senza poter combaciare in modo esat-to. Pi avanti lautore torner a riflettere sul termine rappresentazioneche gi indicherebbe unattivit spirituale complessa, richiedendo a suavolta la mediazione del linguaggio 111: provvisoriamente possiamo direallora che la parola evoca un mondo di associazioni, un complesso disensazioni e di percezioni sensibili. Gli organi di senso a loro volta nonsono poi certamente lo specchio del mondo, essi hanno avuto unevo-luzione casuale, orientata dai criteri delleconomia e del bisogno, costi-tuiscono quindi dei filtri, dei setacci, che lasciano passare soltanto una
minima parte delle caratteristiche delle cose 112. Questa selezione stataessenziale per la vita quotidiana, perch una configurazione pi precisadegli organi di senso che ci facesse percepire differenze microscopiche,come ad esempio lintera variazione delle oscillazioni ondulatorie stu-
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
26/180
24
diate dalla fisica nel campo dei suoni e dei colori, non avrebbe resopossibile lorientamento delluomo nel mondo.
Sul piano gnoseologico una conoscenza trasparente del mondo rima-ne impossibile: intelletto e mondo non combaciano, non si adattano lunlaltro come un guanto alla mano o la mano al guanto (e con questo ro-vesciamento allude alla rivoluzione copernicana di Kant, e stando allametafora non ci nemmeno dato sapere se nel guanto vi sia davverouna mano 113); il mondo svanisce nellillusione, dissolto nelle ombre delmito della caverna di Platone e coperto dal velo di Maya delle antichedottrine dei Veda interpretate da Schopenhauer, coinvolgendo ancheil soggetto nel mistero dellinconoscibile. Ma lo scetticismo radicale,applicato allambito del soggetto del conoscere, apre un nuovo pianodi indagine per la critica del linguaggio e la seconda parte del primo
volume dei Beitrgesi presenta come unacuta disamina delle teoriepsicologiche del tempo che ne individua alcune importanti aporie. Laduplicazione del mondo attuata dal materialismo, dallo spiritualismo, maanche dal parallelismo psico-fisico ha, secondo Mauthner, come imme-diata conseguenza lapplicazione al mondo interno dei concetti elaboratiper il mondo esterno, con il risultato di costruire enigmi senza soluzionesul rapporto tra anima e corpo e problemi senza senso, come il tentativodi individuare la collocazione dellanima o la diatriba sullanima deglianimali 114. Allo stesso modo la psicologia fisiologica, che scopre nel
cervello i correlati fisici delle associazioni psichiche, non farebbe altroche raddoppiare lenigma 115, e Fechner, che chiama parallele due coseche invero coincidono, risolverebbe il problema del rapporto tra fisicoe psichico soltanto a parole: i pesci commenta Mauthner con unametafora vedono la superficie del mare da sotto, gli uccelli dallaltoe in psicologia noi ci troviamo nellimbarazzante situazione di un uomoche possa guardare solo da un lato lo specchio del mare 116. Anima ecorpo sono quindi solo parole, metafore appunto; lio, con i suoi con-fini incerti e incostanti, illusione delle illusioni 117, la coscienza vuotopleonasmo 118: lo specchio del nostro cervello riflette di volta in voltaquello che gli davanti, ma non si pu guardarvi dentro come in unospecchio oculare 119.
Mauthner afferma di aver maturato queste sue convinzioni nel suoperiodo di formazione a Praga; fa risalire lidea della povert dei nostricinque sensi, della struttura contingente della sensibilit, alla lettura diNietzsche (ma su questo pi avanti) e sostiene di essere stato stimolatoalla critica del linguaggio da una conferenza sul principio di conser-vazione del lavoro che Ernst Mach aveva tenuto a Praga nel 1872. Sitratta invero di una ricostruzione a posteriori 120, ma questo non toglie
che si possano rintracciare nelle pagine dei Beitrgemolte suggestioniche derivano con evidenza dalla rilettura del lavoro di Mach.Il testo della prolusione contiene una disamina critica dei concetti
fondamentali della fisica considerati secondo il motto la storia ha fatto
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
27/180
25
tutto, la storia pu mutare tutto 121. I concetti, sostiene Mach, sonoastrazioni che debbono essere sempre riconducibili ai fenomeni sus-sunti; per alcuni concetti abbiamo scordato il percorso compiuto perraggiungerli e li chiamiamo metafisici 122. La scienza si deve limitare allaconnessione pi ampia possibile dei fatti, senza cercare di immaginarequalcosa dietro i fenomeni, e deve essere consapevole che quello cheli tiene insieme sempre una forma arbitraria, che varia con il no-stro punto di vista culturale 123. Universalizzare questo punto di vista,come tenta di fare la concezione meccanica del mondo, significa, perMach, ritornare alla metafisica; la conclusione kantiana: se il mondo una macchina, in cui il movimento di certe parti determinato dalmovimento di altre, nulla per determinato per lintera macchina 124.Accanto poi al procedimento che collega i fenomeni, la scienza ha
anche il compito di scomporre i fatti complessi in fatti pi semplici,non ulteriormente scomponibili: questi fatti-base, come egli li chiama,non sono altro che incomprensibilit non abituali ridotte a incompren-sibilit abituali e la scelta di questi fatti-base questione di comodit,storia e abitudine 125. In breve, la conferenza di Praga conteneva tuttii presupposti per una critica del linguaggio della metafisica nella scien-za, come Mauthner riconosce pi volte.
La critica al meccanicismo veniva poi confermata dalle ricerchesuccessive dello scienziato sullo spazio e sul tempo della percezione,
sui suoni e sui colori, esposte nel libro Die Analyse der Empfindun-gen, la cui prima edizione del 1886. Nelle Osservazioni preliminariantimetafisiche, che introducono le ricerche fisiologiche, il punto dipartenza del nostro conoscere viene descritto fenomenologicamente:colori, suoni, calore, pressioni, spazi, tempi ecc. sono connessi fraloro in modo molteplice e ad essi sono legati disposizioni, sentimenti evolizioni. Da questo tessuto emerge ci che relativamente pi stabilee durevole, imprimendosi nella memoria ed esprimendosi nella parola.Come relativamente pi durevoli si segnalano innanzitutto complessicoordinati (funzionalmente) nello spazio e nel tempo di colori, suoni,pressioni ecc., i quali proprio perci assumono nomi specifici e ven-gono indicato come corpi (Krper). Tali complessi non sono affattopersistenti in senso assoluto 126. In questa formulazione Mach evitalespressione complessi di sensazioni: gli elementi sono sensazioni allivello dellastrazione, dellidealizzazione, cio dellordinamento di unaserie che permette di renderli oggetto di esperimento 127; essi scriveMach sono sensazioni soltanto sotto un certo rispetto: un colore un oggetto fisico in relazione alla sorgente di luce, una sensazionein relazione alla retina 128. I complessi di elementi si compongono poi
variamente e possono esigere una descrizione fisica o fisiologica oppurepsicologica: in relazione allelemento ordinatore si danno diverse im-magini del mondo, come dir Mauthner, oppure reti a diverse maglie,come dir Wittgenstein.
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
28/180
26
Questo approccio permetteva a Mach di sfuggire alla duplicazionemetafisica di soggetto e oggetto, di fenomeno e cosa in s, di illusionee realt: la matita immersa nellacqua, emblema dellillusione dei sensi,risulta otticamente spezzata, ma tattilmente e metricamente diritta. Icomplessi, ordinati herbartianamente in modo seriale (ordinamentospaziale e temporale, serie cromatica o tonale), sono poi scomponibilisenza il residuo di una cosa in s: la sostanza, al contrario, non altroche lipostatizzazione di unentit che viene staccata dalla serie dellesensazioni in base a unistanza di totalit.
E semplice complesso di elementi risultava anche laltro polo delconoscere, lio, che perdeva cos la sua identit definita. Mach sanciscein questo modo la fine dellio, fonte, a suo dire, di tutte le assurdit me-tafisiche, e indica come premessa di questa concezione unosservazione
di Lichtenberg sulla difficolt di tracciare una netta linea di demarca-zione tra le rappresentazioni che dipendono da noi e quelle che nonne dipendono. Lichtenberg osservava che non si dovrebbe dire ichdenke, ma piuttosto es denkt, allo stesso modo in cui si dice esblitzt 129. Riassumendo con un appunto di Mach: Mondoe io sonopi o meno soltanto sintesi (Zusammenfassungen) arbitrarie 130.
Mach offriva cos alla cultura del suo tempo un approccio ai con-cetti di io, cosa, spazio, tempo e causa, che costitu un punto di rife-rimento non solo per scienziati, ma anche per scrittori e letterati: la
sua critica al feticismo del linguaggio, alla superstizione della parola come egli si esprime in Erkenntnis und Irrtum, citando lantropologoTylor 131 ritorna in espressioni e in immagini, spesso con richiamiespliciti, in tutta la riflessione sulla crisi della parola, sul divario, ormairiconosciuto, tra le parole e le cose, nella dissoluzione e nelle estremedifese dellio nella letteratura della Vienna dellinizio del Novecento(basti citare Musil, Hofmannsthal e Weininger). Non stupisce quindiche Mauthner nel periodo della stesura dei Beitrge torni a quellalontana suggestione, legga i libri di Mach e cerchi anche di stabilireun contatto personale con il pensatore moravo 132.
La definizione del rapporto tra fisico e psichico come semplicediversit di rapporti tra elementi che possono essere oggetto di de-scrizione da parte della fisica, della fisiologia oppure della psicologia,linutilit di riferirsi a una componente ulteriore che faccia da sostratoai due ambiti come ancora il parallelismo tendeva a fare ritornanelle analisi gnoseologiche e antropologiche di Mauthner, nellaffer-mazione della diversit solo di grado tra il pensiero animale e quellodelluomo, nella definizione dellintelletto come capacit intuitiva che sisviluppa per necessit di sopravvivenza biologica, nella considerazione
della memoria non solo come sedimentazione psichica, ma anche ma-teriale delle esperienze in tutte le vie sensibili e motorie 133. QuandoMach paragona lattivit della memoria alluso di vecchi violini bensuonati e Mauthner si meraviglia di quante tracce mnemoniche debba
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
29/180
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
30/180
28
tuaggio che riproduce le tinte dei fiori e dei frutti, divengono autonomi,astratti, vengono intesi senza pensare al loro primitivo riferimento. Laformazione del concetto deriva allora dallindividuazione dellugua-glianza di una parte di un complesso di sensazioni con una parte diun altro complesso, che permette lassociazione per somiglianza. Mail passaggio pi interessante di questa trattazione, almeno dal puntodi vista di Mauthner, il rapporto che Mach stabilisce tra concetto eintuizione. Il concetto afferma Mach enigmatico: se lo consideria-mo dal punto di vista logico, lo vediamo come il prodotto psichico pipreciso e determinato, se ne cerchiamo il contenuto intuitivo, reperiamosoltanto unimmagine confusa. Il procedimento di formazione delle ideeviene paragonato alla composizione delle figure della pittura dellanticoEgitto, che non corrispondono a ununica percezione visiva, ma sono
composte di percezioni diverse: la testa e il capo sono rappresentatidi profilo, ma la copertura del capo e il petto si vedono di fronte; sitratta di una sorta di percezione intermedia che appunta lattenzionesu alcuni aspetti e ne trascura altri. Nella stessa nota, che rimanda aquesta osservazione contenuta in una conferenza, Mach cita Paul Carusche definisce il concetto in analogia alle somiglianze di famiglia che ilsuocero Hegeler aveva osservato in alcune foto composte da Galton 138.Limmagine individuale, come le foto dei singoli componenti dellafamiglia, il concetto non sta in rapporto con una immagine definita,
con una rappresentazione finita (fertig), piuttosto unindicazione aesaminare alcune caratteristiche della rappresentazione, a individuarele somiglianze di famiglia. Acquisire un concetto significa allora avvia-re un sistema di operazioni che si pu apprendere solo nella prassi,nellesercizio, come ci si deve esercitare per imparare la matematica ouna lingua straniera. La definizione del concetto in Mauthner ripren-de allora questa impostazione nellaffermare che il concetto non inrelazione con una determinata rappresentazione, ma con una catenao un tessuto, una rete o ancor pi esattamente un piccolo mondo, unmicrocosmo di associazioni di idee, un microcosmo che non uni-dimensionale come una catena, non bidimensionale come un tessutoo una rete, ma tridimensionale o, in relazione al tempo, quadridimen-sionale come un mondo 139.
Nel capitolo sul linguaggio della Wrmelehre Mach, riprendendolidea del carattere operativo dellacquisizione del concetto, sostiene chei segni sonori hanno preso senso e significato alla presenza di osservatoricomuni e di una comune attivit, citando Geiger 140e Noir 141, ma que-sti riferimenti non sembrano a Mauthner sufficienti, egli pensa di essereandato pi avanti di questi autori nella critica del linguaggio 142.
Nel Wrterbuch der Philosophie (1910) Mauthner continua a fare ri-ferimento al pensiero di Mach in numerose voci e con molte citazioni,lo considera anche una fonte per la sua teoria delle tre immagini delmondo. Ora ha anche a disposizione Erkenntnis und Irrtum(1905), il
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
31/180
29
testo epistemologico che riassume e approfondisce i risultati di tutta lariflessione di Mach sulla formazione dei concetti scientifici, sulla lororadice nel precategoriale e nel linguaggio ordinario. La parola vienedefinita come centro di associazioni, viene indagata nel sua dimensionemagica e superstiziosa, nella sua funzione nel processo di astrazione,nei suoi significati mutevoli e nei suoi trasferimenti e, in una nota,troviamo anche il riconoscimento dello stimolo ricevuto dalla letturadegli scritti di Mauthner. In particolare vanno poi segnalate le pagi-ne in cui Mach tratta il concetto di analogia e afferma limportanzadelluso euristico delle immagini nella scienza 143.
Mauthner si propone per la filosofia un compito analogo a quelloche Mach ha svolto nei confronti dei principali concetti della scienza,ma il diverso punto di vista e la differenza delloggetto in questione
svelano la dimensione scettica e radicale del progetto del filosofo. Lor-dinamento alfabetico, triviale (termine dal paradossale doppio senso:volgare o riferito alla cultura del trivio medievale), brutale e infanti-le, si adatta perfettamente alla dimensione circolare del suo pensiero,alla condensazione in nuclei decentrati dellargomentazione; non solo,esso rappresenta lunico ordine possibile che permette i rimandi da unqualsivoglia punto ad un altro e una consultazione semplice. Lenciclo-pedia filosofica che espone lo stato della filosofia sancisce nel contem-po la mancanza del suo fondamento, limpossibilit di individuare un
criterio gerarchico nel nostro conoscere, di mettere ordine nel sape-re; e nelletimo del termine (e[gkuklo") Mauthner non vuole coglierelidea di completezza, ma del girare in cerchio, del mordersi la coda 144.Nella rassegna dei tentativi storici di sistemazione enciclopedica, oltreallapprezzamento per il dizionario storico e critico di Bayle, lessicodi conversazione di tutti gli spiriti scettici 145, troviamo una citazionedi Stumpf a conferma della provvisoriet e della circolarit del sistemadelle scienze: gli oggetti delle scienze non sono disposti come cerchiconcentrici intorno a un unico punto centrale, ma formano parecchieondate, che si incrociano partendo da punti centrali autonomi 146.
Al posto di concetti puri, ai quali siano state strappate, derubateper via di astrazione (un calco coniato da Boezio del greco ejx ajfairev-sew", usato da Aristotele e tradotto in un altro contesto da Ciceronecon detractio) tutte le caratteristiche concrete, troviamo soltanto le pa-role in uso nella filosofia, parole che sono migrate, sono state trasferite,traslate, assieme alle cose e ai popoli, portando con s, nelle derivazioni,nei prestiti, nelle traduzioni e nei calchi, molteplici sfumature di senso.Mauthner non crede quindi alla possibilit di una definizione rigorosadei singoli termini, afferma che una definizione pulita sarebbe tauto-
logica, illusoria, come la pretesa di calmare la fame con un men chepone accanto ai nomi francesi la loro traduzione in tedesco 147.Questo non vale solo per le parole della filosofia, ma in genere per
tutte le nostre parole. Possiamo dire che una parola ha significato allo
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
32/180
30
stesso modo in cui possiamo dire che una cosa ha delle propriet,anche se non c una cosa al di fuori e accanto alle sue propriet. Ilsignificato appartiene alla parola, non c un significato in s, un signi-ficato obiettivo-ideale e qui Mauthner scrive frettolosamente, traparentesi: Husserl; lo possiamo indicare solo pressappoco, ricostruendola storia della parola, criticando il significato momentaneo, riportandola discussione su quel significato.
Lindeterminatezza dei concetti e delle parole viene descritta conlaiuto del termine fringe, che forse possiamo rendere con margine(Saum), alone (Hof), e che viene utilizzata da William James perindicare limprecisione dei confini della rappresentazione. Mauthnerse ne serve indifferentemente per la rappresentazione e per la parola eriprende limmagine fluida della mente dello psicologo americano che
deriva lorlo sfrangiato delle rappresentazioni dalla successione delleonde delle impressioni che parzialmente si sovrappongono, accostan-dola alla teoria delle onde del linguista Johannes Schmidt.
Per altri versi le parole, tutte le parole, sono gi da sempre concetti,a diversi gradi di astrazione, e indicano gi da subito di aver perso il ri-ferimento allintuizione immediata; esse si formano attraverso il processodellassociazione che non affatto governato da leggi stabili, sistematenei paragrafi della teoria psicologica, ma da regolarit (Gesetzmssigkeite non Notwendigkeit) che mutano da una lingua allaltra dando vita
a sfere associative diverse, condizionate dalluso linguistico. Mauthnernon nega che vi siano innumerevoli similarit nelle associazioni, comevi una sorta di imprecisa comprensione nella prassi del linguaggio; sitratta per di somiglianze, affinit, parentele (ma non di sangue), analo-gie che escludono lidentificazione completa 148. Analogia addiritturaun errore logico che inferisce da propriet simili conosciute proprietsimili sconosciute, esigenza psicologica di generalizzazione, semplicecomparazione che non pu essere scambiata con la conclusione logicadella proporzione matematica 149. Lapplicazione di conclusioni analo-giche inconsce colpevole della creazione del linguaggio metaforico,improprio, non scientifico che abbiamo usato per descrivere in imma-gini lintera nostra vita interiore e abbiamo poi riportato allesterno, perpenetrare nellinterno delle cose, per spiegarne la loro natura 150.
Viene cos ribadita la disgregazione del soggetto e delloggetto delconoscere, dellio e della cosa. Ci che comunemente chiamiamo cosa(Ding, Sache) non quindi altro che il machiano complesso di sensa-zioni, e questa cosa soltanto una rappresentazione astratta (Gedan-kending), una cosa del pensiero. Mauthner precisa che con questonon intende un concetto inventato, uno Scheinbegriff, come potrebbe
essere ad esempio lidea di strega, n un fenomeno o unapparenza(Erscheinung) nel senso di Berkeley e Kant, e nemmeno una cosa in s,come continuano a sostenere i neokantiani, ma semplicemente la causa(Ursache) delle sensazioni, aggiungendo subito dopo che lo stesso con-
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
33/180
31
cetto di causa un enigma 151. Se poi una cosa isolata propriamentenon esiste, come afferma il nostro autore citando di nuovo Erkenntnisund Irrtum, non esiste nemmeno un io isolato, esso non che la catenadei vissuti: cosa e io, insomma, sono finzioni provvisorie 152.
Mauthner cerca per di procedere oltre. Mentre Mach in Erken-ntnis und Irrtum articola la sua disamina critica degli strumenti concet-tuali legati alla ricerca scientifica mantenendo le distinzioni e la fiducianel loro valore conoscitivo, anche se provvisorio, Mauthner opera unariduzione del pensiero a linguaggio, del concetto a parola, della parolaa immagine, dellimmagine a immagine di immagine. Lidentificazionedelle funzioni del pensare e del parlare invero non completa, perchanche in questo caso si tratta, possiamo dire, di diversi giochi lingui-stici, e dipende dallestensione che attribuiamo ai due concetti 153, ma
questa cautela non viene sempre rispettata e spesso Mauthner ribadiscelidentit di pensiero e linguaggio, la valenza di mera parola del con-cetto, la natura metaforica del concetto stesso.
I diversi punti di vista da cui guardare il mondo che Mach avevaconnesso alla possibilit di combinare in modo diverso il complesso dielementi, ma che aveva sempre ricondotto alla descrizione scientifica diventano in Mauthner tre categorie grammaticali che egli chiama letre immagini del mondo. Egli mantiene il termine greco di categoria,svuotandone il senso logico e conoscitivo, sulla scia dellinterpretazione
grammaticale delle categorie aristoteliche di Trendelenburg: kathgorei'n scrive significa semplicemente asserire; forse allora sarebbe me-glio usare il termine Aussaglichkeit, oAussagenmglichkeit, possibilitdi asserire, ma Mauthner si accontenta del linguaggio in uso, consa-pevole di dover lavorare sullo slittamento del significato. Le categoriedella grammatica sono dunque: laggettivo, il sostantivo e il verbo, maanche qui non nel senso delle forme grammaticali tradizionali. Si trattadi vere e proprie categorie della grammatica che trasferiscono dallascienza alla filosofia la concezione machiana dei punti di vista.
Il mondo aggettivo il mondo delle impressioni sensoriali, dellespe-rienza immediata, del dato; si presenta frantumato, pointilliert, comeun quadro dipinto dai divisionisti, descritto da parole come blu, ru-moroso, dolce, duro, ma anche giusto, bello, che infilzanolimpressione con la punta dellago dellattimo 154. Esso ci consegna lepropriet delle cose, senza permetterci di interrogarci su cosa esse sianoal di l delle loro propriet; il suo linguaggio, per essere coerente, do-vrebbe essere costituito appunto di soli aggettivi, come nella grammati-ca dellemisfero boreale del mondo immaginario di Uqbar nel raccontodi Borges, che non dice luna, ma una serie di aggettivi accostati.
Il mondo sostantivo d il nome alla sostanza, integra questo lin-guaggio sensistico con concetti mitologici, inventando gli dei, gli spiriti,le forze, le cause, ma anche le cose, le singole cose, che sono tutte ipo-statizzazioni. Il mondo delle idee platoniche, immagini originarie delle
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
34/180
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
35/180
33
sensazioni contraddittorie e soffocato dalle spire di un mondo esternoa esso ostile, produce e inventa, per sopravvivere, artifici del pensieroche danno vita, accanto allarte della logica pura, a forme indirette,meno nitide e rigorose, spesso contraddittorie rispetto al dato e in sstesse, ma di innegabile valore euristico. La scala dellartificiosit va,come scrive anche Mauthner, dalle finzioni massime della morale allefinzioni minime della scienza, ma lintero mondo delle nostre rappre-sentazioni affetto dalla soggettivit e non certo destinato a diventareunimmagine immediata dellessere.
Particolare interesse dato alle finzioni simboliche o analogiche,che vengono analizzate con argomenti molto simili alla teoria della me-tafora di Mauthner. In modo affine alla creazione poetica e mitica ilprocedimento analogico si costituisce nellappercezione di una nuova
intuizione da parte di una funzione rappresentativa nella quale esisteuna relazione simile, una proporzione analoga a quella della serie giosservata delle sensazioni 158. Il pensiero elabora cio simboli o immagi-ni che non intendono riprodurre la realt al modo di uno specchio, maintroduce in essa forme di comparazione e connessioni che ne intessonoi fili dispersi 159.
Vaihinger si rivela vicino a Mauthner anche nelluso delle metaforeche descrivono la funzione provvisoria dei concetti-finzione (non la lorofalsit che sarebbe espressa da immagini come gli occhiali colorati o
lo specchio deformante, immagine questultima che troviamo invece inMauthner). Egli sostiene che tutto ci che incontriamo nella vita quoti-diana e nella scienza e che va sotto il nome di conoscenza un insiemedi gusci vuoti; rovescia cos il senso della critica di Herbart allapriorikantiano come guscio vuoto e afferma la validit puramente strumen-tale di tali gusci, che si rompono quando non servono pi, quando ilfine viene raggiunto 160. Definisce i concetti anche come cerniere chechiudono provvisoriamente la combinazione delle sensazioni 161, oppurecome pezzi di ricambio del meccanismo del pensiero 162. Unaltrametafora suggerisce lidea che tra mondo interno e mondo esterno visia una zona di permutazione, dove i valori dei due mondi sono illu-soriamente assimilati gli uni a quelli dellaltro, dove reso possibileun vivo scambio fra i due e dove la sottile carta-moneta dei pensieri scambiata nelle pesanti monete della realt, dove, viceversa, il metallodella realt viene dato in cambio di quella merce leggera, che ha resopossibile lo scambio. [] Poich si posseduta molta carta-monetafalsa, si sono introdotte furtivamente molte idee false, che non pos-sono essere trasformate in valori materiali; non senzaltro sufficientetener conto del valore nominale della carta, ma si deve far riferimento
allaggio sulloro, che essa pu fare 163.Nonostante quindi le vie del conoscere e quelle dellessere sianoeterogenee, si possono ottenere risultati che permettono di orientar-ci 164. A questo proposito sono interessanti alcune note di Vaihinger
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
36/180
34
sul fatto che nel flusso della percezione ricorrano determinate formestrutturali che hanno una certa, precisa coloritura che ci permette difissare gli oggetti come sostanze, come cose con delle propriet. Non visono cose senza propriet n propriet senza cose: il concetto di zuc-chero una finzione, il concetto di bianco altrettanto una finzione,ma lo zucchero bianco un fatto. Il complesso qui ricompostopermette in qualche modo il passaggio dal pensiero che sembra opera-re per perifrasi alla prassi della comunicazione che richiede la finzione,lerrore della sostanza. Mauthner preferisce un esempio diverso: lozucchero dolce; con questo risulta forse pi chiara la distinzionetra il riferimento alla sensazione di dolce e la regola del gioco dellinguaggio che chiama dolce e la sensazione e lo zucchero, mentre nellanostra coscienza non troviamo altro che la sensazione di dolce 165. La
conclusione del nostro autore assume anche in questo caso una colo-ritura pi scettica, che nega non solo la possibilit della comprensionedel mondo, ma anche la sua conoscenza.
4. La teoria della metafora
Nella critica del linguaggio non poteva mancare la disamina dellatesi di Aristotele, che Mauthner presenta con laccusa di voler spiegare
il linguaggio figurato della poesia dal punto di vista logico, risolvendoogni metafora nella proporzione matematica, completa o incompleta.La seduzione poetica consisterebbe allora nel lasciar indovinare unoo due membri, e qui lautore accenna agli esiti barocchi di questa im-postazione e non risparmia dellironia a proposito dellesempio dellacoppa come scudo di Dioniso 166. A differenza per di tutti gli altriluoghi nei quali il nostro autore accenna o tratta del filosofo greco e,nonostante la conoscenza superficiale dei suoi testi e della letteraturacritica, che gli verr rimproverata dai recensori del libriccino polemicosu Aristotele del 1904 167, qui il nominalista si sofferma sulla teoriaaristotelica e prende sul serio la sua analisi concettuale.
Non solo il problema gli appare cruciale per lesito della sua analisicritica, ma egli ha anche a disposizione una serie di studi filologici efilosofici, apparsi in quegli anni in Germania, che convergono nella tesidel carattere essenzialmente metaforico della parola proprio a parti-re dalla disamina della tesi dello stagirita. Nella lettura di AristoteleMauthner utilizza ampiamente il testo di Alfred Biese,Die Philosophiedes Metaphorischen, che era stato pubblicato nel 1893, e la sua biblio-grafia che comprende il lavoro di Kurt Bruchmann, Psychologischen
Studien zur Sprachgeschichte (1888), e limportante libro sui tropi diGustav Gerber, Die Sprache als Kunst(1871, seconda edizione 1884),che il nostro autore invero non cita mai, anche se rivela sorprendentianalogie con le sue conclusioni.
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
37/180
35
La prima mossa del nostro autore consiste nel sottolineare in Ari-stotele luso del termine metafora come titolo generale dei tropi.Anche Biese aveva ravvisato in questo un merito del filosofo greco,nellaver riconosciuto cio anche nella metonimia e nella sineddocche ilmomento della bertragung, del trasferimento. Su questo Mauthner decisamente daccordo: Aristotele scrive parla greco e per metaforaintende traslato, non un termine tecnico secondo la classificazionedella retorica latina. Il problema solo apparentemente una questionedi termini ed stato pi volte rilevato nella storia della teoria dellametafora: lambiguit delluso aristotelico che chiama metafora siala figura come tale, il tropo, la trasposizione di un termine, sia la me-tafora in senso stretto, la figura retorica della somiglianza, rivela uninteresse per il processo stesso della trasposizione e estende lindagine
dal nome a tutte le entit del linguaggio portatrici di senso 168. Taleampliamento permette di individuare nella teoria aristotelica qualcosadi pi dellanalisi di un semplice meccanismo di sostituzione, che alla base della concezione della metafora come ornamento retoricoo poetico, e di coglierne invece una dimensione gnoseologica, di sta-bilirne il valore semantico. Naturalmente le riflessioni novecenteschesulla metafora approfondiranno questo approccio facendo ricorso aglisviluppi della logica e della linguistica, ma molte intuizioni e riflessionierano gi state formulate in queste letture di fine Ottocento. Questa
prima affermazione di Mauthner sembra quindi cogliere bene lo spiritodellindagine di Aristotetele, ponendosi immediatamente sul piano dellovgo"semantico o linguistico 169.
Il punto di partenza di Aristotele era, quindi, la definizione dellametafora come ejpiforav, come trasferimento dal linguaggio ordinario,normale, consueto (parola come kuvrion) a un uso sempre pi alterato(Morpurgo-Tagliabue scrive: al limite). La traduzione di kuvrion stataa lungo discussa nella storia dellinterpretazione e la resa con termineproprio aveva accentuato lopposizione con figurato, ma nel contestodi una teoria che tende a escludere qualsiasi termine proprio il pro-blema di cosa intendesse il filosofo su questo punto non viene nemmenoaffrontato. A Mauthner interessa invece il processo di associazione chesta alla base del traslato.
Nella Poetica, per, il criterio della classificazione , almeno allini-zio, quello della sostituzione: luso pi ordinario quello di ricorrerea un termine generico per un fatto specifico o di impiegare termini dispecie per concetti di genere. Nonostante compaia gi qui un processodi confronto logico-intuitivo 170, questo diviene pi esplicito con lametafora da specie a specie, come esempio della quale Aristotele cita
due versi di Empedocle: con la spada di bronzo avendogli attinta lavita (come si attinge da una fonte con una tazza), e con la tazza diindistruttibile bronzo avendo reciso lacqua (come con una spada) 171.Infine la metafora per analogia: si chiamer perci la coppa scudo di
-
8/13/2019 Fritz Mauthner - La Maledizione della parola
38/180
36
Dioniso e lo scudo coppa di Ares, oppure: la vecchiezza sera dellavita; secondo la proporzione tra due rapporti. Questo accostamento importante spiega Mauthner per chiarire la differenza tra la meta-fora che pone il rapporto in modo immediato e la similitudine che siesplicita nel come. Vi sono similitudini complesse continua chediventano sprone per una fantasia poetica, come quella omerica, chedimenticano il paragone di partenza e procedono oltre, e similitudiniin senso stretto; esse si basano su tre termini, come nel caso di capellineri come il carbone, che egli chiama regola del tre. Il tertiumcomparationis ancora unaltra cosa e si riferisce a un concetto pigenerale, al colore, nel caso dei capelli e del carbone, allattributo, nelcaso della coppa di Dioniso e dello scudo di Ares.
La metafora quindi, a differenza della similitudine, un paragone
di due rapporti, nel qual viene tralasciato il concetto pi comune.Nellesempio di Mauthner la prudenza la madre della saggezza, lasaggezza si rapporta alla prudenza, come la figlia alla madre; il tertiumcomparationis che la madre abbia procreato la figlia. Si potrebbeanche pensare che la figlia sia simile alla madre oppure che sia obbe-diente, ma noi non lo pensiamo. Lautore individua qui un punto es-senziale della teoria aristotelica: la cogenza dellimmagine. Anche Biesesottolinea questo momento dellimmagine e afferma esplicitamente cheAristotele ha riconosciuto lessenza del metaforico nellanalogia, nella
proporzione, nella relazione tra due rapporti offerta allintuizione echiama Veranschaulichungquesta visualizzazione che egli, come vedre-mo, estender a tutti i processi dello spirito umano.