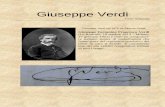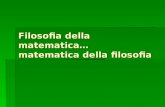Étienne Gilson. Il realismo.metodo della filosofia
-
Upload
cosetta-baroni -
Category
Documents
-
view
72 -
download
0
description
Transcript of Étienne Gilson. Il realismo.metodo della filosofia

ÉTIENNE GILSON, Il realismo. Metodo della Filosofia, a cura di Antonio Livi, Casa Editrice Leonardo da Vinci, S.
Marinella (Roma) 2008, pp. 185, pz. 20,00 €.
L’opera è una raccolta di saggi pubblicata da Étienne Gilson nel 1935 a Parigi sotto il titolo Le Réalisme
méthodique all’interno della collana “ours et documents de Philosophie” diretta da Yves Simon. Già
pubblicata da diversi anni in spagnolo e più recentemente in inglese, quella che qui presentiamo è la prima
in italiano in versione integrale. La traduzione è stata curata da Antonio Livi. Il libro è accompagnato da
un’introduzione storica di Maria Antonietta Mendosa e da una postfazione del medesimo traduttore e
curatore. Vi è anche una nota bibliografica sulle opere di Gilson tradotte in italiano.
L’opera fa parte della collana “Biblioteca di Sensus communis” diretta da Livi all’interno della sezione dei
testi classici della filosofia del senso comune. La scelta del direttore, di accoglierla nella collana, è motivata
dal fatto che Gilson, in quest’opera, sostenendo il “realismo” come unico metodo possibile della filosofia,
afferma al medesimo tempo il senso comune come unico fondamento veritativo della conoscenza in
generale. Nella postfazione Livi ne propone un’interpretazione ricostruendo in modo critico alcuni aspetti
del pensiero gilsoniano.
Il libro si divide in cinque capitoli. Il primo capitolo, intitolato “Realismo come metodo”, pone in termini
rigorosi il problema del realismo tomista confrontandosi con l’idealismo di Descartes, di Berkeley e di Kant.
La posizione che il filosofo francese delinea è un’interpretazione differente rispetto ad alcuni neotomisti
suoi contemporanei. Avanza l’ipotesi che non è possibile «superare l’idealismo opponendovisi dal di
dentro, perché facendo così ci si sottomette, ma[…]» occorre dispensarlo dall’esistere (p. 60).
Questa affermazione diventa oggetto di riflessione di tutto il secondo capitolo confrontandosi con le
posizione di Désiré Mercier e Léon Noël, della scuola di Lovanio, rappresentanti del realismo critico. Gilson
si oppone ai due pensatori e dimostra come il tentativo dei filosofi di Lovanio di dialogo con l’idealismo sia
costruito su un equivoco. Il cogito cartesiano esclude di principio tutto ciò che non sia pensiero, mentre
quello di Noël è carico fin dall’inizio dell’oggetto della conoscenza, cioè il non-io che si rende presente al
nostro pensiero. Include nel concetto di cogito ciò che nella concezione di Descartes veniva di principio
escluso. Nella parte conclusiva del capitolo, Gilson ripropone il metodo tommasiano, senza escludere
l’ipotesi che il realismo possa «ricavare dallo studio [dell’idealismo] tante istruttive nozioni, ma a
condizione di rimanere se stesso, cioè di avere come fondamento l’evidenza […]: la presa diretta
dell’esistenza delle cose attraverso l’esperienza sensibile» (p. 92). Quest’ultimo aspetto viene approfondito
nel terzo capitolo.
Nel terzultimo e penultimo capitolo, dopo un breve excursus storico sul pensiero moderno, la riflessione si
concentra sulle ragioni della scelta necessaria del realismo come metodo e del modo con cui occorre
intenderlo. Nel percorso molto articolato della sua riflessione, Gilson riconosce che la scelta del metodo
realista equivale ad optare per la filosofia. I due termini realismo e filosofia sono tra loro correlati in modo
univoco al punto che il realismo è l’unico modo di fare filosofia e, di converso, la filosofia, autenticamente
tale, è solo realista. Il metodo adeguato è quello che parte dal fatto che “le cose sono”. Esso è il principio e
il termine medio che deve collegare le parti di ogni riflessione. In questo modo Gilson sostituisce il cogito
cartesiano e fa del suo giudizio res sunt il principio e la legge ricorsiva di ogni altra sua affermazione
filosofica.
In fine, l’ultimo capitolo, diviso in trenta punti, sembra essere un decalogo per chi volesse cimentarsi con
un sano realismo. Ma, a mio avviso, è riduttivo ritenere che sia una giustapposizione di diversi punti. Si

tratta di una sintesi ben strutturata della riflessione che il filosofo francese porta avanti nei capitoli
precedenti. Evidenzia e chiarifica le connessioni logiche dello sviluppo discorsivo del suo pensiero.
Due considerazioni occorre presentare quali note a margine sul lavoro gilsoniano: una storica e l’altra
teoretica.
Gli interlocutori dell’opera gilsoniana sono i rappresentanti del realismo critico secondo la scuola di
Lovanio. Gilson prende direttamente in considerazione la posizione dei suoi più importanti rappresentanti:
il Card. Désiré Mercier e Léon Noël, suo discepolo e continuatore. Ritiene che il tentativo della scuola di
Lovanio, di interpretare il realismo dialogando con le posizioni idealiste secondo la prospettiva cartesiana e
kantiana, sia fallimentare. Infatti, la filosofia realista e quella idealista sono tra loro incomunicabili. Usando
l’espressione gilsoniana l’idealismo cartesiano, pur avendo punti in comune con il realismo, si muove in
direzioni diametralmente opposta: il realismo ab esse ad nosse valet consequentia, mentre l’idealismo a
nosse ad esse valet consequentia (p. 87).
Il filosofo francese vede nel metodo tomista l’unica via di uscita. Propone una sua interpretazione che si
discosta dai suoi interlocutori neoscolastici. Gilson difende Noël da chi lo accusa di aver voluto re-
interpretare il tomismo in modo idealista, ma se ne discosta profondamente quando afferma
l’incompatibilità del pensiero del filosofo di Lovanio con lo spirito tomista (pp. 86-7).
Non si tratta, però, di un ritorno tout court alla Scolastica (p. 106). Del resto, sarebbe assurdo poiché
occorre condannare – a detta di Gilson – la sterilità scientifica del Medioevo. Il fallimento della fisica
medievale non autorizza arbitrariamente a decretare anche quello della filosofia che ha una sua autonomia
rispetto alla concezione dei moti dei corpi celesti di quell’epoca storica (pp. 111-2). Per Gilson, la filosofia
medievale, e più propriamente quella tommasiana, custodisce al suo interno i principi del sano realismo
che consentono la costruzione di un metodo adeguato per lo sviluppo di un pensiero filosofico fecondo (p.
112). Ciò che rimprovera ad Aristotele e agli scolastici, è di non essere rimasti fedeli al loro principio (p.
108).
Per Tommaso, invece, è evidente che la res è la cosa reale e l’oggetto proprio del nostro intelletto e che
l’essere-conosciuto non può prescindere dall’essere reale. Per il filosofo francese queste affermazioni sono
contenute in unico giudizio: res sunt. Quest’ultimo è una delle evidenze del senso comune. È il principio da
cui occorre muoversi per costruire una filosofia vera ed anche il principio a cui occorre rimanere sempre
fedeli in modo coerente nello sviluppo del proprio pensiero anche se critico (pp. 128-9).
Un ulteriore glossa occorre fare al testo. Vorrei riprendere una distinzione, accennata nell’introduzione
storica (p. 18) e ripresa nella postfazione (pp. 161-2), tra postulato, assioma ed ipotesi. La genesi di questi
termini è greca: aitemata, axiomata e ypothesis. Una chiara testimonianza, sui primi due termini, c’è data
da Euclide d’Alessandria nell’opera gli Elementi, attribuitagli da Proclo. Ma il pensatore alessandrino non da
un’esatta definizione, ritenendoli delle “nozioni comuni”: coinai ennoiai. Sarà Proclo, nel suo commentario
agli Elementi di Euclide, a fornire tre modi di intendere la differenza tra postulato ed assioma. Nel terzo
modo cita l’autorità di Aristotele in Analytica Posteriora, I. 10 in cui propone una distinzione tra postulato,
assioma e ipotesi. Lo Stagirita non sembra usare questi termini in senso esclusivamente matematico ma li
carica anche di un valore epistemologico accostando, per distinguerli, alla parola verità: aletheia.
Negli Analitici, Aristotele, afferma che tutti è tre sono delle proposizioni che sono poste quali principi e
premesse di un pensiero epistemico che proceda secondo il metodo deduttivo-analitico. Sono le cause di
tutte le ulteriori proposizioni che ne derivano. Tutte le preposizioni che sono legate ad esse da un rapporto

di causalità ne ereditano geneticamente il valore di verità. Questi principi, se sono veri per se stessi, e
dunque evidenti ed “indimostrabili”, sono indicati come assiomi. Di converso, l’ipotesi e il postulato sono
veri perché vengono posti “come se” lo fossero. Però, il valore veritativo dell’ipotesi non si è in grado di
dimostrarlo, mentre del postulato è possibile. Di conseguenza, si ha questa situazione: sia l’ipotesi che il
postulato non sono evidenti di per sé; ma del postulato, la sua evidenza è dimostrabile.
Questa distinzione aristotelica è stata oggetto di un forte interesse da parte dei matematici contemporanei
Si ricorda G. Vailati, in una sua comunicazione al terzo Congresso Mat. [Heidelberg, 1904], in cui richiamò
l'attenzione degli studiosi sul significato di queste parole presso i greci. (Cfr. “Intorno al significato della
distinzione tra gli assiomi ed i postulati nella geometria greca”, in Ver. des dritten Math. Kongresses,
Teubner, Leipzig 1905 p. 575-581).
Ritornando al pensiero gilsoniano, fecondati da questo breve exursus sul pensiero ellenico, possiamo trarre
alcune conclusioni. Per il filosofo francese il cogito cartesiano e l’a-priori kantiano non posso essere
considerati assiomi, cioè veri per se stessi. Lo stesso idealismo, nel suo sviluppo storico, lo ha dimostrato e
la critica del realismo di Merciel e Noël ne è un’ulteriore riprova.
Ma non possono essere considerati neppure come postulati perché né Cartesio né Kant provano a dare una
dimostrazione della loro verità, ritenendoli appunto degli assiomi. Dunque, in ultima analisi, Gilson ritiene
che i principi, da cui l’idealismo muove il suo pensiero, siano delle ipotesi. Per il filosofo francese ciò è
legittimo, accosto, però, che l’idealismo rimanga, attraverso il suo procedimento deduttivo-analito,
coerente ai suoi principi (pp. 115-7).
Infatti, nei tentativi da parte di Cartesio di provare l’esistenza del mondo esteriore e da parte di Kant di
trovare un adeguato fondamento alla morale, Gilson avverte una profonda incoerenza ai principi del
pensiero idealista (pp. 74-5; 82; 120-1; 125). Un “sano” idealismo non può non sfociare in una critica della
conoscenza ed in un profondo scetticismo nelle capacità della razionalità umana di conoscere ciò che è
altro da se stessa (p. 127-8).
In fine, però, occorre porsi un ulteriore interrogativo: cosa è il res sunt di Gilson? Livi ci informa che Gilson,
nella fase matura del suo pensiero, ove teorizza la giovanile intuizione del realismo come metodo, pone
questo giudizio come principio del suo pensiero (p. 161). Questa proposizione è posta come assioma in
quanto è qualificato come giudizio analitico e cade sotto l’immediata evidenza dei nostri sensi (p. 162).
È un giudizio analitico perché il concetto del sunt, oggetto del giudizio gilsoniano, è contenuto in quello del
soggetto, res. Livi sottolinea che res è al plurare ed equivale a dire entia. Gilson pone come principio del suo
pensiero, non un’improbabile intuizione dell’essere in sé, bensì la presenza innegabile di una pluralità di
enti limitati ed in movimento: gli esistenti che cadono sotto la nostra percezione sensoriale. Quest’ultimi
sono la vera causa del nostro pensare (p. 162).
Va colto un’ulteriore sfumatura che a nostro avviso emerge dall’opera che stiamo presentando. Si tratta di
una lettura retrospettiva alla luce delle conclusioni mature del pensiero gilsoniano. Il res sunt, che non
appare come termini nell’opera, ma lo si rileva nella sua opzione al metodo realista, è posto, nella sua
giovanile intuizione, non come principio o premessa della sua riflessione filosofica, bensì come
presupposto: condizione necessaria di possibilità di un pensiero che voglia dirsi filosofico.
Tra gli scolastici, il res sunt, come argomenta lo stesso Gilson, da buono storico, era un presupposto
condiviso e di suo evidente, al punto che non sentono la necessità di discuterne: appartiene, in altre parole,
ad una nozione comunemente intesa (pp. 51-2 e 91).

Ma nella nostra epoca contemporanea, alla luce del percorso storico compiuto dall’idealismo e dalle nuove
scienze, Gilson comprende che questo presupposto, ampiamente condiviso in epoca medievale, non è più
tale. È per questa ragione che, nella sua riflessione succesiva e matura, lo pone come principio e premessa
del suo pensiero. Cosa sia effettivamente, assioma o postulato, non credo che siamo in grado di esprimere
a tal proposito un giudizio esatto. Sicuramente non è un’ipotesi perché sarebbe negare il presupposto
stesso di un pensiero che sia filosofico.
Il merito di Gilson, in quanto autenticamente storico da non confondere né con la storiografia né con lo
storicismo (p. 156), è stato quello di smascherare l’idealismo e il realismo critico della loro pretesa di essere
l’unico modo di fare filosofia. Inoltre, il filosofo francese non può essere considerato un semplice
commentatore del pensiero medievale, bensì, pur rimanendo un valido interprete, va oltre: eleva il
presupposto della filosofia scolastica a principio del suo pensiero. In questo possiamo rinvenire l’originalità
e la genuinità del pensiero gilsoniano.
Daniele D’Agostino
Anagni, Istituto Teologico Leoniano
Roma, Pontificia Università Regina Apostolorum


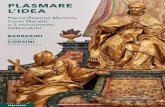


![FILOSOFIA · Filosofia tardoantica [NOVITÀ] Storia e problemi a cura di Riccardo Chiaradonna Aula Magna, pp. 324, € 15,00 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE Loris Sturlese Filosofia](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5f87bb58bab8c371326590fe/filosofia-tardoantica-novit-storia-e-problemi-a-cura-di-riccardo-chiaradonna.jpg)