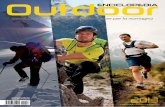Enciclopedia della Chimica Vol.2
-
Upload
autori-vari -
Category
Documents
-
view
257 -
download
23
Transcript of Enciclopedia della Chimica Vol.2




Giuseppe BIARDIAssistente ordinario presso la Cattedra di Princdi Ingegneria Chimica, Professore incaricatoAnalisi dei Sistemi presso la Facoltà di Ingegiria, Politecnico di Milano - AUTOMAZIONE E OIMAZIONE; CALORE, TRASMISSIONE DEL.
Roberto BIFFOLIDirettore del Laboratorio Chimico Provincid'Igiene di Firenze, Incaricato di Chimica Bmatnìrtffira nressn l'TTnivprsità di Firen7e — Rl

Adriano NHNZLibero docente in Chimica OrganicaIncaricato di Chimica ilndustriale pcolta di Scienze dell'Università di PEtore dello Stabilimento Monteflbre dghera - CAPROLATTAME.
Rodolfo NESIAssistente ordinario di Chimica Oril'Università di Firenze-ARNDT-EISTE

Giuseppe PROTALibero docente in Chimicarali, Professore incaricatopresso la Facoltà di Scienzepoli - BECKMANN, TRASPOSIZBENZOFENONE; BOUVEAULT-IVON BRAUN, DEGRADAZIONI
Franco QUADRIFOGLIO

ANTIMETABOLITI
II termine antimetaboìita vto ad una sostanza la quasi trova nella cellula vivfo interferisce con l'attiv:metabolita proprio della e

concentia/ionc ilei substrato,si,in/,i 11iiIntlice può .itine sisilo UDII corrispondente al corquelle questo substrato e cocaso, rinibilorc e incapace dversibilmente con il substratnnrlMiitiì lìmi clii'ior(* frìrQf* P

lina (Rogers, 1962). Mentre la piritl'Amprol® inibiscono la captazic
ammina nelle cellule tumorali, l'ossa ha poco effetto al riguardo.\ntimetaboliti della biotina. Una serie)ghi della biotina (caratterizzati dspetto ad essa, una catena lateraleinghezza), inibiscono la crescita dianismi in sua presenza.

1958). A. efficaci del piridossale vengononuti per variazione dei gruppi sostituentaccati all'anello piridinico. L'analogo pimunemente usato è il 4-deossipiridoiQuesta sostanza non ha attività come vina B6 ed è un antagonista della piridossiipulcino : due molecole di analogo neutrano una di piridossina.
I più potenti inibitori della piridossalsono composti del piridossale con vari <reattivi carbonilici; infatti l'attività delh

lulc clic hanno un'attività proliferarapida. Un analogo noto della pi<)-mcrcaptopurina, è stata usata ecesso nella cura della leucemia acutiliirtr Iner un temnn limitatnV un r

Le fenilciclopropilammine soncmolto efficaci della monoamminos2-fenilciclopropiIammma(tranilcipruna struttura che rassomiglia a quelfetamina ed ha anche alcune prò]macologiche di questo farmaco. EsslTt"> QlltYlO

mente reversione: in tal caso l"adi tipo competitivo. D'altra parbolita può interagire con Tenzirrdolo in conseguenza di una rea;irreversibile con il centro attivo <enzimatica: si tratta quindi di unnon competitivo poiché la consenza effetto sul determinarsi e

posti inorganici e organici di varia natura.Alogeni. Soltanto lo iodio e gli ioduri di sodice potassio vengono impiegati topicamente.Zolfo. Lo zolfo, precipitato o colloidale, inpomata al 2-15% è un eccellente fungicida inquanto sembra che le cellule epidermiche letrasformino in un composto di ossidazione:l'acido pentationico (H,S5O6).
Anche l'anidride solforosa ottenuta in loco

e i suoi derivati alogena7-iodo-8-idrossichinolinaidrossi-2-metilchinolina, smatofiti e candidosi.
I derivati della chinolin;liposolubili in grado di ]del miceto, ove, in forma i

È stato isolato da diverse specie di Strejces. Attivo in vitro contro il Cryptoneoformans, offre in vivo risultati discoiPrima della scoperta dell'anfotericina Bto impiegato nella terapia della criptociSaramicetina. Isolata da uno Streptomil primo agente non polienico che mostrprta attività npi rnnfrrtnti HPIIP infp7Ìnni

Ci sono alcuni esempi di oggetti fatti equasi puro, ritrovati tra le rovine di acittà. I minerali di Sb avevano un ruolo itante nell'alchimia, poiché si credeva crsero sostanze adatte per trasformare i rin oro.
Nel nostro secolo la fortuna commidell'Sb è rimasta legata ai vari eventi 1

gioni montagnose o in quelle vL'età geologica delle catene moi
loro conseguente erosione hanno umentale importanza. Se da un latodi catene relativamente recenti, il prcsivo non ha raggiunto livelli tali dadepositi di questi minerali facilmenbili, dall'altro per montagne di etàavanzata, ha reso tali depositi più ;

ui impurezza, meline la icgiusulta maggiormente pura. Locoefficiente di segregazione mcui si muove in direzione oppmento della zona contaminarsteriore. 11 Cd invece si muovidi avanzamento, tuttavia siache lo Zn sono sufficientemencontaminare il materiale purifmeccanismo di trasporto di

adatto, a causa delle sue proprietà, per dispo-sitivi che si basano su effetti galvanomagnetici.Sono state costruite fotocellule di InSb pergrandi lunghezze d'onda, ottime per le bassetemperature.
Considerevole interesse hanno suscitato si-stemi ternari combinati III-V. Come vari com-posti III-V possono avere proprietà che non

Le proprietà di SbF5 sono dh;he ci aspetteremmo sulla base'ormula. In generale i fluoruri <igli stati di ossidazione più altinolto volatili; l'AsF6 ad es., 1'SF6, sublima a —63°. Tuttaiiquido viscoso, (solidifica a 7° eQuesti dati suggeriscono l'esistei

ioni fluorometallici. Anche l"SbCI5 forma igran numero di addotti, compresi molticui l'addizione di cloruro ha luogo con fcmazione di ioni SbCl6 •
Esistono alcuni composti misti cloro-fluoche furono preparati per la prima volta itorno al 1910 da Ruff. Sono state riportevarie composizioni, come (SbF5)3-SbCl5SbF5-(SbCl3).2, ma in genere le loro struttinon sono note. È possibile interpretare tprodotti sia come specie molecolari miste peta-coordinate, sia come specie ioniche connenti ioni a ponte o ioni non a ponte. Que

?olo di legame H—Sb—H di 9tanza Sb—H di 1,707 A.
mposti organometalliciSb forma un vasto numero di d<:i (V. ELEMENTO-ORGANICI COMPOenze che variano ampiamente,i comuni implicano una co\R3, quattro, R4Sb+X~, cinque,5b(QH5)6. Tutti questi compostossidazione di tre o cintine Fsi

solubile in solventi polari, insolubile in sol-venti non-polari ed ha una bassa volatilitàDall'altra parte, i bialogenuri di Sbv, R3SbX;sono composti covalenti peritacoordinati corstrutture bipiramidali trigonali in cui gli alo-geni sono assiali e i gruppi organici equato-riali. Questi composti vengono preparati fa-cilmente addizionando l'alogeno alla stibinjterziaria:
I trialogenuri e tretraalogenuri tipo R2SbCl

SJtlUIS BJ3IU13UJ Ul 3JI§B3J OUOSSOdaipilEuiO-re smiuiuE sq 'aìpijvuiOA
•spimiS oddojj aoddnjg jsp 03U31S oiusuiipsdiuij ssB§U3A (8) 3UOIZB3J E] 3qO 3JBSU3sqouB g "ODIIUBISSO 3[B3ipBJ pp oousis OJJ:-J3J1B B^nAop auoizBzziiiqt'js BI auyin ps ous-ISSO ip OUIOlBJpp 3}JBd Bp 3UOJJJ313J OJBJ3q3U3IA ino UOO BJIIIDEI 131 'BZUBUOSU -glISp OJJ3JU

uurame i auiossiuazione auiaverso reaomolitiche ed eterolitiche degli stabilizsolforati con gli idroperossidi, è il corri]veramente attivo, perché è in grado di deporre cataliticamente gli idroperossidi:
ROOH I SO.. > prodotti inattivi

Dato che la loro attività è elevata anche acentrazioni relativamente basse e, contr;mente agli UV assorbitori, non dipende espessore del campione, il numero degli srzatori di energia (Ni11 chelati, complessi etri metalli o altri tipi di accettori) è destiad aumentare.
È bene tener presente, però, che certi e

pi che in ordine di crescente coo: invecchiamento durante la eossidazione normale, invecchia
>re, invecchiamento alla luce, osilizzata da ioni metallici, fessuraone e fessurazioni atmosferiche'ivprrhinmento durante la conser,

chetoni od aldeidi e le diarilamminele miscele di diarilammine; ricordianaltri, la 4,4'-dimetossidifenilamminaflex della Du Pont;, la 4-isopropilamnilammina (Nonox ZA della Harwicdiidro-2,2,4-trimetil-6-etossichinoliruflex AW della Monsanto), l'AritiBLE 25 della Naugatuck (NonoxICI). l'Antox della Du Pont, il Flect<

Comunemente gli antiparassitari sono pnti chimici, naturali o sintetici, impiegatcombattere le specie animali e vegetali dase per l'uomo, gli animali domestici e kture (con esclusione dei microrganismicausano le malattie dell'uomo e degli anir
iuiuaiauiiiz.z.aLC viene ani
portanza al fatto che il fésoddisfacente durante le finon sensibilizzi la fotossi
Per tutte quelle applica;fumo non può essere usatosono gli stabilizzanti allamente usati. Come è giàclassi DÌÙ importanti per

3) un terzo periodo, caratterizzajiego di sostanze non più ad azioììergica, ma capaci di diminuire il)amminico, si è aperto nel 1961,?rattutto a Birkmayer e Hornykiew)rimi riportarono l'efficacia terape.-DOPA in pazienti parkinsonian
Sulla base delle conoscenze attui

e usato nei trauamenio uei moroo ui rkinson dal 1949 sotto forma di cloridrato.sua azione sul sistema nervoso autonomocorda quella dell'atropina, di cui però è memeno attivo.
È usato per il controllo sintomatico di tile forme di parkinsonismo comprese quipostencefalitiche, arteriosclerotiche e idiotiche. Influenza parzialmente rigidità ed acisia, mentre è scarsamente attivo sul trem

eriore a quella della L-DOPA Catti collaterali.Sul piano farmacologico il suo mazione non è riferibile ad un effeergico ma è invece probabilmentn una interferenza a livello del me[le catecolammine. Un suo impie;zione con la L-DOPA è sostenuitnrf snprip in nnp.i rasi in rni pii

sere costituiti da sali inorganici (per es., eie"uro di litio), ammine (trietanolammina), an-nidi [A',A'-bis(2-idrossietilstearammide)], pciossietilenderivati (esadecilestere di polietenglicoli), composti ammonici quaterna]cloruro di octadeciltrimetilammonio), alchi"osfati, sali amminici di acidi alchilfosfoniisale di trietanolammina ed acido octadecibsfonico) ed alcoli mono e polivalenti (gì;erina). Tali sostanze, poiché si prescinde dall

-metilmorfina (clorid., fosf.)
-etilmorfina
-benzilmorfina (clorid.)-acetilmorfina
-(2'-morfoliniletil)-morfina
-metil-6-desossimorfina-metil-6-acetilmorfina (*)
-metil-6-nicotinoilmorfina

/-x-2-metil-8-metossi-6,7-metilendiossi-
l-(6,7-dimetossi-3-ftalidil)- 1,2,3,4-tetraidrochinol
ac. 3,4,6'-trimetossi-4',5'-metilendiossi-
2'-(/3'-dimetilamminoetil)- desossibenzoin-2-carb(

2-[2-(di-2,6-xililmetossi)-etossi]-etildrmetilamrnin

notevole distanziamento fra dose iil riflesso per la tosse e quella inibìipiro. È per questo che la codeina, d<affini dimostrano una buona inibiziorJe della tosse, terapeuticamente sfrutquanto essa si realizza molto primase raggiunga la soglia di tossicità per

diminuzione nel grado di acetila2l'INH e permette quindi di ottenere ]livelli ematici della forma attiva.
Acido p-amminosalicilico. L'acido psalicilico (acido amminosalicilico, acminosalicilico, PAS), sintetizzato danel 1946, è un chemioterapico antiti

stro-intestinale. Dopo una singola sestrazione orale di 4 g, la massima coizione ematica viene raggiunta entro Ldue ore. Il sale sodico viene assorbitopiù rapidamente.
Provvisto di elevata capacità di dinei tessuti, attraversa invece difficili!barriera emato-liquorale. Il PAS viene

scurare lmtervento diiperplasie o neoplasie
:i ormonale, che inducoia gastrinica.
L'altro aspetto eziople riguarda l'alterazione dia della mucosa. I mecca:f- gici possono essere cosi- aspetti più significativi :Si 1) inibizione della sen tica ad opera soprattu1_ inculat*i e* rrcictiv^infpctin

trofizzanti (Barbara, 1970; Miiller-WiekOssenberg, 1971).
AntiacidiLa pepsina, enzima proteolitico, manife;sua azione solo in ambiente acido, è inatipH superiore a 4 e si denatura in amhfortemente alcalino. Compito degli anti

atoria e quena vascolare ea 1pia dell'ulcera vengono usatirmaci che possiedono ancherSammatoria come il carbenoixolina ed il sialoglicopeptide sle migliorano la circolazioneilio spasmo dei piccoli vasi cor

5-(2,4-diclorofe:5-(mercaptomel5-fluorouracile8-azaguanina2,6-diamminopi
6-azauridina

Tipo di infezione
luenza A

ficientemente documentata, anche o sin vivo, in uno o più modelli d'infeziormentale dell'animale e in qualche virl'uomo: sostanze quindi chemioterapievirali, dotate, in vario grado, della capinibire selettivamente la riproduzione ein funzione soprattutto del parametronel rapporto cioè fra stadio evolutivo

non conosciamo ancora u rapporto trastruttura della molecola adamantanica etipo della sua azione antivirale, di cuialtro ignoriamo il meccanismo.
I derivati adamantanici non ostacolano 1sorbimento cellulare dei virus, ma ne impscono l'ingresso nel citoplasma con un n

duzione virionica aspecificamente e sonociò globalmente definite interferoni: i viriducono la sintesi degli interferoni di serklecolare più piccola e con una latenza12 ore, mentre i polimeri anionici arti!sono responsabili del cosiddetto early ,feron, o interferone pronto, a peso molecpiù elevato e che le cellule liberano con irt^ * f% 4- i-x —wT—T f\ 4 •< T/» i • * i • >'* * - ^ * ^ i~ ** y^ ^7 s~± -»• y% s^ *^ 1 "é" ••*^% A- 4 r% *^~i j-

e derivati (tab. I) che agiscono sulla RNlimerasi RN A-dipendente inattivandola (
Nel secondo gruppo sono elencatali gìIoghi purinici e pirimidimici, ed i lorcleosidi, ribosio ed arabinosio compostistriamo il meccanismo d'azione del 1rouracile (5FU) (VII), della 5-trifluoro2'-desossiuridina (F3TDR) (Vili), della 5-2'-desossiuridina (IUDR) (XIII), e dell;n-arahinnfuranosilcitosina (ARA-CYÌ

sistema polimerasico nucleinico (fig.pedita dall'ARA-CY: questa molecctra parte può essere incorporata nel IRNA di cellule leucemiche del topo.
Lo studio della riproduzione virioivirus della pseudo rabbia in presiIUDR ha dimostrato che il DNA-iorale non è in grado di dirigere la siuna proteina funzionale ed è perciò ihilp. la rinrnrhi zinne rtai virinne, or

Proprietà chimiche e fisicheLe antocianine sono sostanze solubiliqua ed in alcool, ma insolubili nei snon ossidrilati, come etere e benzene.
Hanno carattere anfotero ed i loro ;acidi forti, come acido cloridrico, sonce facilmente cristallizzabili.

Nella tabella IV sono elencate le antocche contengono acidi organici insiemfonte da cui si ottengono, all'antocianidalle unità glucosidiche relative.
Le antocianine, per riscaldamento corinorganici diluiti, si idrolizzano dandocianidine e uno o più residui zuccherini :
antocianina > antocianidina+zuc

e una seconda compresa tra 475 e 511 valore massimo della lunghezza d'
questa seconda banda è funzione del nidella posizione dei gruppi ^OH e -oltre che del solvente e del pH della so
Le antocianidine sostituite in 4'-, '.3', 4', 5'- possono venir identificate dsizione dei loro massimi di assorbimen520, 530 e 540 nm rispettivamente (f

Questa struttura era in accordo con la prepa-razione dell'a. a partire dal tetrabromoetanoe benzene. In seguito a studi sulla reattività siarrivò alla formulazione dell'a. come un ibridodi risonanza fra le seguenti strutture limiti:

a 120° si decompone senza svolgimersigeno. Sono noti anche fotossidi di Schil- o diarilantraceni. In tal caso pescaldamento si ha svolgimento di o:ripristino dei composti di partenza.Reazioni di Diels-Alder. L'a., a diffeifenantrene, da luogo alla reazioneAlder quando venga trattato con reajnofìli. Così con l'anidride maleica si 1

per fusione alcalina dei corrispondsolfonici a 300°. Un altro metodinella riduzione di idrossiantrachinoe ammoniaca mentre l'uso di stari;idrosolfiti può portare all'eliminigruppi ossidrilici degli anelli lateratroli sono colorati in giallo, hannoacido e sono facilmente ossidabili. <in presenza di HC1 a caldo si ot

iiinnoKrunaCatlclain E.,in «Truité dcChimie Organiqus
fase. II, a cura di Grignard V..DupontY.eR., Paris, Masson et C.ie, 1949.
Coffey S., Van Alpen J., in « Chemistry olCompounds », III parte B, a cura diH., Amsterdam, Elsevier Pubi. Comp., 19
Finar I. L., Organic chemistry I, London, Le1967.
PIERO SARTI I

viene eneuuaia. in aiccza di KOH.. un metodo più recentehinone e butadiene inza di p-?-butilcatecolo'5° ottenendosi diretta]
viene impiegato gen(tto tecnico per la fabbri; però in alcuni casi desublimato, titolo 99,5°ha luoso in un sublima

sione di quest'ultimo non sia completa, anè conveniente che sia limitata ad un massindel 50%.Acido antrachinon-X-solfonico. C14H8SO5:
O SO:iH

dell'a. con soda caustica e clorato o nifcsodio in autoclave a 200°.
Esiste in commercio in diversi tipi.extra è alizarina pura ed allo stato seforma di fine suddivisione è di colorarancio. I tipi meno puri contengonotriossiantrachinone e sono nettamente p:

ducendo vapore diretto. Agitandgiungendo HC1 concentrato la chini;cipita in aghi sottili. Dopo filtralo]riore trattamento all'ebollizione econtenente HC1 si filtra bollente epanello ad 80-90°.
La chinizarina così ottenuta può

nente la reazione di Friedel-Crafts dairide ftalica e clorobenzene. La clorurazliretta dell'a. con Cl2 molecolare in oL)orta a polisostituzione con formazioni,4,5,8-tetracloroantrachinone; ma dee:on monosostituzione a nel caso del 2-mmtrachinone. La reazione di scambic-Sn.H mn — Ci fu «-nnertn nel 1907

y.m. z.z.j,^z., (jiis>idiiiz.za in agili lu;
alcool od acido acetico) a p.f. 302°.ma. È insolubile in acqua ed eterebile in alcool, acetone, benzene, eloro)Può essere preparato dal 2-cloroantraco dall'acido antrachinon-2-solfonico. Gmente si preferisce partire dal 2-cloroarnone: 1 parte di 2-cloroantrachinone asotto forma di pasta al 56% viene mecon 3,15 parti di NH3 al 25 %, con 0,0'

p.i. iiy (,aa alcool), suolimiin acqua, poco solubile in aletone, benzene, nitrobenzene.
L'l,5-diamminoantrachinompreparato per riduzione con NPl,5-dinitroantrachinone alloII dinitro- va prima in soluziczione verde per formazioneminoderivato, solubile in alcaltempo si separa n.5-diammii

ne (Bohn, 1901), gli studi(Bally, 1904), sulle antrimrsugli antrachinonacridoni (Eantrachinoncarbazoli (Isler,lamminoantrachinoni (Deir,condotto a una vasta serie ddi elevato pregio, mentre 1

lizzazione preventiva). Altri metodi ;consigliati consistevano nell'aggiuntporanea al bagno di tintura del coloisale prescelto (metallizzazione coinea) oppure in un post-trattamentogià tinta con la soluzione di un sale(metallizzazione successiva). Tali pr<

Coloranti derivati dall'I-amminoantrachRappresentano il gruppo più numeroseteressante della classe dei coloranti antnonici acidi, sia per i toni particolarmentlanti, sia per le solidità ottenibili.
Sottoponendo Fl-amminoantrachincun processo di bromurazione esaurienANTRACHINONE) si ottiene l'1-ammino-^

[ coloranti acidi ottenuti da tale intermedipreparano per riscaldamento di questoanimine primarie di vario tipo (es. arilarrne, alchilammine, alchilarilammine) inbiente acquoso in presenza di sali di r;(es. Cu.2Cl2) come catalizzatori e di accetdi acidità quali Na2CO3 o NaHCO3. Poil gruppo solfonico è già presistente nel nu<antrachinonico non è necessario che lemine imnieeate siano ulteriormente solfe

tecnologia del rayon si pose subito il prdella tintura della nuova fibra. OCCOJcoloranti di costituzione relativamenplice che, pure essendo esenti da grupsolubilizzanti, potessero essere applicsuccesso in bagno acquoso. Questa eparve in un primo momento essere sodcon la scoperta che gli amminoderivatchinnnici notevano essere resi snlul

la cellulosa all'acetato, le fibre poliammidi-che, e, in qualche caso, il polipropilene e lefibre poliacriliche; tuttavia essi sono selezio-nati per il poliestere in virtù delle loro par-ticolari caratteristiche sia di affinità che ditermostabilità.
Effettivamente molti dei coloranti già ri-

i genere poco intense e in partiislide a quei trattamenti di termi nobilitazione a temperatura eggi vengono effettuate quasi g<jl manufatto tinto.Dalla vasta letteratura esistent
lento saranno riportate alcune stee ad essere applicate vantaggiosi fibra poliestere.Per l'ottenimento di toni gialli

Le strutture (L1V) e (LVI), rosa, sono iportate nei brevetti BASF, rispettivamenF.P. 1.570.635 e G.B.P. 913.902. La strutura (LV), rubino, è dovuta alla IntercherCorp. (U.S.P. 2.773.071).
Per i toni violetti ricordiamo il coloranCI. violetto disperso 28, N° 61102 (LVHl'unico a struttura ufficialmente nota di miesi

Altre possibilità interessanti sono rappresitate dalle strutture del tipo (LXIX) e (LX:rivendicate dalla Sandoz, rispettivamenteP. 581.785 ed F.P. 1.563.068, con le qualpossono ottenere rispettivamente toni rubie blu molto solidi e brillanti :
O NH,

acquoso in presenza di carbonato sitre a pulire il manufatto tinto ne sttono, rendendolo meno sensibile aieventuali lavaggi alcalini.
Un buon colorante al tino, come èquasi tutti i derivati antrachinoniciclasse, deve rispondere, come già è st;nato, ad alcuni particolari requisiti dOltre ad una elevata solidità alla luc<dono eccellenti stabilità ai lavaggi

lesto colorante (CI. blssenta eccellenti soliditàilla bollitura alcalina, tilido al eloro e al cloriti'etti si ricorre ad alogeinte, mediante le qualrivati che vengono mes:

za La struttura riportata esemplinca un gridi termini esiguo ma molto interessante p
ite brillantezza delle tinte e l'elevate solidiin- colorante (XCVIII) tinge con un tono iV) bluastro, molto brillante e solido,rail- Antrachinonacridoni. Costituiscono un gn

che si ottiene industrialmentee glicerina in acido solforicoNE), costituisce un intermedinel campo dei coloranti al ti:none. Da esso, e principalmeivati 3-bromo e 3,9-dibromo, 1importanti gruppi di termin

che la sua solidità alla luce non è eiDal!" 1 -aza-2-idrossibenzantrone (C
schema in alto) è stato ottenuto recail colorante (CXIII) (Montecatini-Edi869.691 ), che risolve il problema dellsal eloro ed agli agenti ossidanti in gìcoloranti al tino blu.
Questo colorante (6,15-dimetossi-

plicc. La tintura si effettua normalmente nellsoluzione acquosa del colorante a 40-50° ipresenza di solfato sodico. Il materiale spremuto viene ossidato con NaNO2 in soluzionsolforica al 3-4%; così il leucoestere si idrelizza e il tino formatosi si riossida rapidamentalla struttura rhinoide originaria F, ovvio eh

di acqua a ponte.È chiaro che la specie con un num
dinazione inconsueto è stabilizzatiportuno contributo di energia libeiderivante da un impacchettamentcfavorevole.
Come si è detto, il legame negliè di natura essenzialmente elettrosgami cioè sono ionico-dipolari op

è lo stesso nei due stati. Si deve però tenersente che gli a. nelle soluzioni acquose ;sempre ulteriormente idratati, potendosstinguere una prima sfera di molecole d'acdirettamente coordinate allo ione, e uneconda sfera d'idratazione, costituita da ncole d'acqua legate mediante legami d'igeno alle molecole d'acqua della prima s
Come vedremo in seguito, le molecole <qua coordinate nella prima sfera si scambi

: deve avere un carattere notevolmente co-lente poiché l'intensità delle bande d'assor-mento risultano abbastanza elevate, al con-ìrio di quanto si trova invece nel caso di le-imi elettrostatici.Un metodo molto elegante, per la misura:1 numero di idratazione della prima sfera,insiste nello scambio isotopico di H2
16O coti218O. Possiamo distinguere il caso di a. cine-
;amente molto inerti, come Cr3+ e Rh3+,

assibile osservare le trasformazion• PbSO4-> PbCO3. Può assumere ujle importanza industriale per l'esìl Pb (Mies in Cecoslovacchia; Ni URSS; Sardegna in Italia).La witherite è un minerale abbasta
trovato associato a barite e galenejsiti idrotermali di bassa temperata
GIUSEPPE

no vuoti e collegati fra loro si ha una pemeabilità ai fluidi, che diminuisce fortemerse gli interstizi vengono riempiti dal cemeno dalla matrice. La porosità è determinata drapporto fra il volume degli interstizi vuotiquello totale della roccia.
Classificazione

potrebbero consentire un'attribuzione suesclusivamente chimiche.
Nella tabella sono riportate le composimedie per i tre tipi fondamentali e perle a. (ricalcolate dai dati di Pettijohrcomposizione media delle a. risulta dalla sdei rapporti esistenti fra i vari tipi di areranche di quelli non trattati in questa sede

struttura (Jorto 7-10 Hz, / „ , „ 1-3 Hz, e Jvara0-1 Hz). Queste proprietà spettroscopiche for-niscono molto spesso informazioni sicure, peres. sulle strutture dei prodotti di reazioni disostituzione o di prodotti naturali che con-tengono anelli benzenici ed hanno largamentesostituito i metodi classici per la determina-zione della struttura, basati sulla degradazio-ne chimica e sulla correlazione di comporta-

«servato sono oasati sugli stessi aue iipprossimazione usati per la sostituzionrofila. Il metodo della molecola isol>asa sul parametro di valenza libera d)itale molecolare (Fr) per il sistema dironi 7r dell'a. m. : più alto è il valore di Ieattiva diventa la posizione r. L'appros:ione dell'energia di localizzazione prei:onsiderazione il cambiamento di ener

ha importanza commerciale come inset(lindano, gammaesano, gamma BHC).
Il benzene e gli altri a. m. reagisconomente con ozono per dare ozonuri, che ssono decomporre con contemporanea fi:dell'anello. Questa reazione non ha gèmente importanza preparativa (un'impoprrp7Ìnnf è rrKtitiiita Hfllla «interi HpHa «1

sistema anulare azepinico, difficilmente otte-nibile. La reazione termica di Diels-Alder deglia. m. richiede un dienofilo altamente reattivo ei soli esempi conosciuti riguardano l'addizionein 1, 4 degli arini, per dare i derivati del ben-zobiciclo [2, 2, 2] ottatriene, quella del dicia-noacetilene, per dare il prodotto (XXVIIa), e

I composti policiclici, che sono costituanelli benzenici condensati nei modi pversi, mantengono in parte le propriesistema benzenico monociclico (v. AREÌNOCICUCI) e possono quindi essere chiaromatici e vanno sotto il nome di arenciclici. Oltre ai sistemi che contengoncanelli a sei atomi, ne esistono alcunicome il fluorantene (1) ed il tetrafenilenche possono essere considerati, correttarsistemi aromatici a causa delle oroDrietè

quali un componente mono- o poncicnco ge-neralmente limitato a benzo- o nafto-) è unitead un sistema preso come base, per es., i com-posti (Vili) e (IX).
La posizione alla quale è unito il compo-nente è stabilita indicando con una lettera :lati del composto di base, partendo dal la-to 1,2 (a) e includendo ogni lato del perimetreesterno. Se è necessario si può anche indicare,con numeri, il lato al quale è unito il compo-nente, come in (XX). Il sistema completo «

tive di questi processi corrispondoibene agli indici di reattività calcolametodo MO nonostante sia chiaro ehla reazione di alogenazione è moltosibile agli effetti strutturali di quantsia la reazione di nitrazione. Ad eccesistemi policiclici a peso molecolarein particolare naftalene (->), fenante antracene (->), gli aspetti preparareazioni di sostituzione negli a. p. spoco studiati. Tuttavia si possono :

In tutti i casi esaminati è stato trovato ebromo si comporta in modo analogo. !stati preparati addotti di altri a. p., maè stata studiata completamente la loro stura e la loro stereochimica. In molti casisti prodotti di addizione eliminano piutfacilmente acido alogenidrico per dare ilma aromatico alogenosostituito. Le readei sistemi policiclici con gli alcossicarb

diando lo stilbene in presenza di iodio;l'estensione di questo processo a prodotti anIoghi allo stilbene, derivati da sistemi policicci, porta alla sintesi di composti più complesPer es., il composto (XXXIX) fornisce il [1'elicene (XL) con una resa del 29 % attraverun doppio processo di ciclizzazione che coi

o decresce au aumentare dei nicnei. i aì leghe contengono piccole quantità diio (1-2%) che ne migliorano le pròneccaniche. L'argentana comunementecostituita da 50 % di rame, 25 % di ni
:5 % di zinco. Per il suo colore e la suaita è adatta per una grande varietà di

ficie posteriore, nei quali la radiazione, che at-traversava due volte la lastra di vetro, assu-meva dei riflessi giallognoli.
La tecnica di fabbricazione degli specchi su-bì un'innovazione di rilievo nel 1843 quandol'inglese Drayton introdusse il procedimentochimico di a. ; da soluzioni alcaline di argento,questo veniva separato e fissato sul vetro at-traverso una reazione di riduzione. Si ottenevacosì una superficie speculare di aspetto piùbrillante, meno delicata e più resistente, con

suo recupero dai bagni usati. Infatti i ccsi ammoniacali Ag(NH3)f e Ag(NH3)iluzioni alcaline possono dar luogo a pesplosivi (nitruro e fulminato d'aquando siano riscaldati o quand'anchsemplicemente lasciati a riposo. Si de

;rivando dall'alterazione di originisolfosali di argento.Solo il 20% della produzione megento (ca. 9500 t annue) è ricavìltivazione diretta dei suoi mineràaiti rossi, argento nativo e cherargie circa il 50 % è ricavato quale sott<;1 trattamento metallurgico dei minZn e il restante 30% dalla metallurerosi altri metalli: Cu,Sb,Ni,Cc

del lato della cella elementare tAltre proprietà fisiche sono e
tabella I. Nella tabella II sono igli isotopi delFAg con le loro picipali ed il metodo per ottene
Proprietà chimiche

Lgno ai mirato tu argento aciumcaio. ^>la poi la differenza di potenziale in nle solo l'Ag si depositi sul catodo. I eenti più nobili (Au, ecc.) sono separati <nghi anodici, mentre quelli meno nobangono nel bagno.Nella maggior parte dei casi, il pròirkes è il più economico anche per i rli che sono trattati quasi esclusivamenttrarre Ag. Il minerale, generalmente ìlito per flottazione (fig. 4), viene aggiminerale di piombo e DOÌ trattato e

I metodi classici di analminazione gravimetrica conterminazione volumetrica edi tiocianato (in presenza dipunto finale della reaziomformazione di un complessotenso fra l'eccesso di tioc

ìe leghe per saldatura quando siisabili forti giunzioni,'on mercurio l'Ag forma faciline]le già a temperatura ordinaria (fìgjna concentrazione pari al 50 % icurio, si forma una soluzione soliia monofasica). Amalgame di Ajo i materiali più usati per Tot

zione dell'Ag non somigliano affatto a qitrovate per gli altri metalli dello stesso gru]Per il rame è preferito lo stato bivalente, ntre quello monovalente esiste in presenzagenti stabilizzanti come alogenuri o cianPer l'oro, lo stato trivalente è di gran lun;più stabile; lo stato monovalente è stabilpochi casi, ad es., in presenza di cianu:ioduro.
La maggior parte dei composti dell'AgHntta Ha rar1ia7i'nni elpttrnmafrnptirhe

ne che ha una torte affinità per qire, il complesso neutro è, di regolbile in acqua, come pure in altricezioni a questa regola si hanncarica anionica non è localizzatdonatore, come, ad es., nel caso

recipitazionc di una soluzione di ijbile di Ag con una soluzione e
icetiluroon l'acetilene, l'Ag1 forma faciline)
iluro secondo la reazione:HC=CH+2Ag+-^ AgC^CAg

to, con un legame molto più corto degli a,1 complessi con l'ammoniaca isolati ;
stato solido sono caratterizzati dallo ioneneare [Ag(NH3)2]~. Sono stati preparati ccposti in cui i contraioni sono: NO^, SCIO3 e COI-.
Nella figura 11 si mostra la struttura[Ag(NH3),]2SO4: la distanza Ag-N è 1,88Altri sali complessi in cui l'azoto è Tato

ualora si consideri la titolazione inveiggiunta di Fml di soluzione di cloru:concentrazione e, a Vo mi di soluziointo avente concentrazione c0, la co:one di cloruro all'equilibrio è rappreìziché dall'equazione (1), dalla relaz

Curve logaritmiche più compliicora calcolabili, sulla base dellconsiderazioni, quando nella solisente più di un componente (peiscela di alogenuri) in grado di reagento, oppure quando quest'ultbina con lo stesso componente i

giunge lo stesso volume di una solucloruro sodico avente la stessa concerdi quella di nitrato d'argento. Se le ddita risultano uguali, la soluzione erafolata fino al p.e. ; in caso contrario, litorbidità rivelano da quale parte ri:p.e. si trova in quel momento la soluzi

segue, nel caso della titolazione di clorur0,1 M con argento 0,1 M, è inferiore allo 0,1 'e quindi trascurabile in molti casi. Con solizioni più diluite l'errore diventa sensibile (cica 0,7% nella titolazione di cloruro 0,01 1con argento 0,01 M) e si rende necessaria urprova in bianco con soluzione esente da eliruri, contenente la stessa concentrazione icromato e un po' di precipitato bianco inete in sospensione, quale carbonato di cale:(esente da cloruri). Si aggiunge nitrato d'agento in quantità sufficiente da uguagliarecolorazione ottenuta nella titolazione e taquantità viene sottratta a quella usata nel

sta e immediata può provocare errori inguito ad adsorbimento di argento, quinconsigliabile agitare la miscela per quaminuto oppure farla bollire per breve teiper coagulare AgCl. La filtrazione può esevitata aggiungendo solventi organici chenimizzano la reazione tra AgCl e CNS~ ircesso, probabilmente perché proteggono ilcipitato con una pellicola impermeabile, e

hard che assicura una notevole accurate;si presta alla determinazione anche di s<zioni diluite di cloruri (0,02 N) e permetttitolazione in soluzione acida e in presenzinumerosi ioni estranei. Piccole quantitàbromuri e ioduri sono preferibilmente deminate previa ossidazione rispettivamenteiodato e a bromato: distrutto selettivamel'eccesso di ossidante, aggiunto KI e acfìcata la soluzione si titola lo iodio libeicon tiosolfato.

jnsumo mondiale odierno di questi piara sufficiente darne un'idea riprendaani dati forniti, dal Bureau of Minesiiìe sono riportati nella tabella I. Se eimo poi quanto riportato nella tabellaflette anche uno studio di previsionomanda USA per le principali qualitìIle fino all'anno 2000, potremo aveiù concrete sull'importanza di questito e sul valore economico di prodott

in, la porosità, la durezza o il colufatti che verranno essiccati ; quiito è forzato nella mattoniera ovelo comprime e lo forza sotto vuo
idatta filiera ad orifizio di date din-colonna solida di argilla che fuoriipoi tagliata da una taglierina aliilensioni.uccessivamente i pezzi verdi sonoessiccatoi e fornaci di tipo continiitinuo. L'essiccazione avviene in t72 ore e la cottura, intorno ai 1
ìpleta in cicli di 5-7 giorni.)ltre al procedimento di cui sopra

idustria ceramica tradizionale poss:e divise in caolini veri (che compreii purissimi usati per le porcellane piargille a base caolinitica. I caolin:opri sono bianchi, anche dopo coultano costituiti da particelle conmpresa tra 0,5 e 2 ji. Le argille caol

a) argille per porcellane: viene usato solil caolino puro perché esso solo è in grado (dare il desiderato color bianco;
b) argille per terraglie: si adoperano argil;aolinitiche, ecc. ;
e) argille da gres: il gres deve avere ujorpo a pori chiusi, dopo cottura degli inpasti a temperature relativamente basse (110(

montmorilloniti). Inoltrc certc argillpossono csscre utilizzati dopo calcimelevate temperature per produrre agjbasso peso per malte, cementi e gesargille infine sono in grado di svilupfqualita pozzolaniche per cementi spCEMENTO).
FonderiaSebbene negli anni recenti sia stata iiin fonderia una serie di nuovi proces

aci-odi- Nella pellettizzazione, o agglomerazione (->),tipo dei minerali fini di ferro in sferette di pochide- millimetri di diametro (Colombo et al.), un'ar-
>lar- gilla, la bentonite, e impiegata per legare lenza, particelle fini di questi minerali che derivano•sla- dalla concentrazione di rocce a basso tenore> ed di ferro, sottoposte ad una macinazione a fi-In- nezza spinta prima di subire la concentrazione

iso, anziche ricorrere allo sc:1 centro della citta, i piedritstati costruiti, scavando auci alti palazzi, tracciati largtcentimetri immergendovi f
i, senza rivestire le pareti d>si sia sulle proprieta di vi:i (per riportare a giorno iproprieta chimico-fisiche delreeeere. con il sottile inton

to da calcinazione, su argil]Uonite, halloisite, caolinite.il;pesso indicato col termineI, aumenta infatti la superfklei prodotti senza demolirneno, sebbene questo sia piiile montmorillonitiche datodi caolinite o halloisite tendiaro struttura nella succes

conosciuti come minerali asono fondamentalmente (v. :di alluminio, con il magnesiin alcuni minerali, sostituisccin parte, l'alluminio e con glialcalino-terrosi present!, in ame costituenti principali. Tiun'unica eccezione (allofane)

Minerali di caolinite. Questa struttiposta da un unico strato di unita t(Si—O)' e da un unico strato di unit:che (Al—OH, O) cosi che i vertici d(SiO4 e uno dei piani dello stratoformano un piano comune (fig. 3
Le cariche alPinterno dell'unitralp snnn hilanrint^ t* la fr*rmiil

specie di strato a doppia nfile di apici tetraedrici a ircima e in fondo agli strati,disposti in modo che gli apisivi sono orientati gli unisono tenuti insieme da allurrin coordinazione ottaedriccapici di strati successivi. Lce completato da gruppi cen

tecenti ricerche hanno din. a. hanno proprieta diivo per molecole organic!meccanismo non e peralti
:ema argilla-acqua. In ccnormali i m. a. contengojerduta per riscaldamentc

viene distrutta e cominciano aaaove fasi cristalline. Nel caso delke dell'halloisite le nuove fasi soe e la cristobalite. Nel caso dei mati possono comparire una consideia di fasi d'alta temperatura: per esforsterite, cordierite, ecc. (a sei
struttura e della composizione deli partenza). Si ha spesso la forma

concentrazioni di arginina (<0,02 jconcentrazioni molto basse di enzir
Kolb e Greenberg hanno svilupprocedimento enzimatico basato sulminazione di ornitina. In questo proito 1'ornitina amminotransferasi e iiper trasferire il gruppo amminico i1'ornitina all'a-chetoglutarato. II glulcosi formato e ossidato cataliticame

Fe2+ e Cd2+, mentre l'attivita catatre a. e inibita da questi ioni mt
Differenze sono state trovate nedi a. di organismi uricotelici e ure<ra et al. hanno rivelato per primistanti di Michaelis differiscono pejdi 10 (tab. II); i valori di Km vanr200 mM per a. di specie uricotelicmolecolare delle a. di organismi

demic Press, 1951, p. 893.berg D. M., The Enzymesk, Academic Press, 1960, pberg D. M., Hoppe-Seyìerjìi der physiologisch und patholyse X, 7a ed., Berlin, Sprii54.i-Kolb H., Greenberg D. \

giumiuimcu e siaio usaiu 11 ìeiiaiurciicnilasciando come catena residua la glutamy-semialdeide.
Inoltre due enzimi specifici per la L-ar]sono utili per il rivelamento e il dosaggiodi questi è la L-arginindecarbossilasi, otida alcuni ceppi batterici. Come con alt

Sebbene l'ornitina sia sintetizzatedi certi animali, come dimostrateche essa, slmilmente all'a., non ènella dieta, le vie metaboliche per lanon sono conosciute in modo così e.nei microrganismi, dove lo studio ddella regolazione esercitata dal pro(e degli enzimi isolati, ha contribuìnoscenza di tale via metabolica. O)che l'ornitina possa derivare dalla jl'azione della prolinaossidasi e dell

•e manca nei legato degli uccelli e di moltiesci. L'enzima ottenuto da fegato di bue han peso molecolare di 100.000. L'equilibrioella reazione è fortemente spostato verso laintesi della citrullina (^T=10s a pH 7,5 e a 37°).L'argininasuccinatosintetasi catalizza la
ondensazione della citrullina e dell'acidospartico (->). L'equilibrio favorisce la for-ìazione del prodotto di condensazione. L'en-ima è ampiamente distribuito in natura; èlato trovato infatti nella frazione solubile distratti ottenuti da rene di mammifero e daevito.

Per quel che riguarda la regola,biosintesi, si hanno dati sulFinibi;sintesi dell'acetilglutammato da piin E. coli. Al contrario, in Chlannel quale lW-acetilglutammato risinire da una reazione di transacetsecondo enzima che interviene nelledelFornitina, Facetilglutammatocirbito dall'a. La repressione da pidegli enzimi che portano da acidiglutammico ad a. è stata rilevata i

:i singoli amminoacidi o di una miscelanminoacidi o per somministrazione diammonio (v. AMMINOACIDI). In questo esomministrazione di a. ha avuto un efftotettivo. Anche composti correlati conil punto di vista metabolico, quali l'ornita citrullina, hanno avuto tale effetto. Poisomministrazione di a. tende a ridurr
'elio ematico e tissutale e ad aumentar

tato naturaleli isotopi dell'argo più abbond>no 36Ar e 38Ar. L'abbondanza :uguale a quella che si ha pei>pi nell'atmosfera. L'36Ar erigine primordiale, mentre 1re più abbondante, r40Ar, d;r decadimento radioattivo. !jmero totale di atomi 40Arida lentamente ma continuando, ad una velocità di 1,5 x

>are Infine il gas veniva fatto gorgogli;con so una soluzione di idrossido diime essiccato con calce. Tutta la succeI di zione di Ar si basò sul frazionameV. l'aria liquida (la maggiore sorge;on- gas nobili residui dopo la fissazionida- I primi a realizzare un processibbe per la liquefazione dell'aria furo]

castellature silicio—ossigeno. Shaffer e Sesuyfurono i primi ad intrappolare gas nobili inzeoliti accuratemente selezionate, forzandogli atomi di gas sotto pressioni di 2000-5000 atm nella zeolite espansa ad una tempe-ratura di 200-500°. In queste condizioni il gasè capace di entrare nei pori e riempire i canalidella zeolite. Per raffreddamento, il gas in-cluso non può più passare attraverso i pori

poco tempo sono anche disponibili cotalmente laser ad Ar ionizzato. I laseiA.r, costruiti dalla Coherent Radiationratory, Inc., Palo Alto, California USJliscono, nel loro modello 52B-A, le lunl'onda riportate nella tabella V.
Il laser ad argo è particolarmente uta spettroscopia Raman.
Anche le insegne luminose spesso conno Ar. Te inseene verdi contensono /

per cui L assume il significato di pòcalore totale AH che non viene otemperatura To e si può scrivere:
AH = -(Lut + TodS)
che è l'espressione del teorema di Csia l'energia totale che noi forniamono, in parte si trasforma in lavoro i

ca. L'a. compressa in modo iscprima nello scambiatore per r;spese dell'a. uscente, quindi sulsione attraverso la valvola e in jin parte ritorna indietro attravebiatore.
Sia H l'entainia rlp.ll'a mmi

dite dovute a indesiderati assorbimenti di e;lore, alla temperatura di uscita dallo scambi:tore che non è mai uguale a quella di entraie al rendimento del compressore, per cuirendimento totale non supera il 5 %.Ciclo Claude ad espansione isentropica. L'icompressa e preraffreddata nello scambiato]segue, successivamente, due percorsi: un'alQuota a viene esnansa in una vaiunln mmp n,

mentre l'espansione in una mi:hina a pistone, turbina) avvier:ostante.
I due procedimenti sono allaLinde e Claude rispettivamente;iffinché un processo del generiattenere a. liquida bisogna poterji fine espansione collocato si

sono allo stato gassoso; il ccè di 0,44-0,55 kWh/Nm3 di
I processi a bassa press[impianti Linde-Frànkl), pngassoso al minor costo; ptfreddo si impiegano rigeneriscambiatori {reversing hea\permettono un recupero de["80-85% degli altri proces;

i è posto un coibente pantenuto sotto un vuoteggiunge pochi micronometriche variano dari fino a centinaia di ritoi fissi, e da alcune mi1 massimo di 20-25.000isporto.

i, antrachinone; anidride solforosa dale zolfo o H2S; eloro da HC1 (processo II- ghisa da minerale di ferro, calcarei- acciaio da ghisa (forno Martin-Siem«.e vertitori Bessemer e Thomas); nero!i: metano o gasolio; acetaldeide da etile:r cesso Wacker); acido acetico ed anidiÌ- tica da acetaldeide; acido acetico da n-a acido acrilico da propilene; acido 1
da toluene; acrilonitrile da propilenemoniaca (processo Sohio); acido to

carattere assai generale e, oreazioni, misero a punto uimente semplice per trasfornbossilico nell'omologo supe
II passaggio dal diazochido (V):
TJ rr\ r u m Ag2O D r

;entemente tuttavia alcuni ricercati sono tornati a postulare la partecali intermedi, essendo riusciti a dii:, dalla decomposizione fotochimiciio acquoso del composto (XI),nte marcato con 13C, si ottiene ado difenilacetico del tipo (XXIII)l'atomo di carbonio terziario,n alcuni casi anche meccanismi e

T nelle prime espeano reagire con l'ailatori, per dare ii.anzen ha inoltre e5osti contenenti unmo di carbonio in

ìando i valori teorici ergia di risonanza di um:nto (generalmente il ben;iltre molecole come il me il fenantrene possono
:i in buon accordo con i vmtalmente. T semplici miici usati da Hiickel e Po un'elaborazione e un niale per trattare aspetti piportamento aromatico, sodi più precisi di indagi

elettroni debbano avere spintato elettronico fondamenta!i gli elettroni si trovano neglsa energia (fìg. 2). È ora p(die il gruppo di sei elettroiinatico sia così stabile e pe:do chiuso. I primi due elettrbitale più basso e i successi1

jtalene (XIII) apparentemente mostritazione negativa in accordo con lejra pseudo-aromatica; una piccola e;le può essere dovuta a un errore speri, ma dove venga sicuramente accertajre negativo, si deve dedurre che la corlello ha un effetto paramagnetico, laa suggerisce che la molecola è anti-at
«itiia7Ìnnp HIP. A stata ammessa da t<

er un lungo periouo 11011 si conoooelecole pseudo-aromatiche, marecentemerè stato sintetizzato un certo numero eo state studiate le proprietà. L'eptaleII) è stato preparato nel 1961. Le sue prita sono quelle di una poliolefina, a can: non aromatico, come è mostrato dal v; trovato per la risonanza dei protoni ee nella regione dei protoni olefinici senaodificazione dovuta a una corrente d'an<C'è da aspettarsi che quando una molecc

, np3, è la stessa degli elemeazoto, ma la presenza di orcrea possibilità di legami
rato non ha.è uno di quegli elementi e
;li antichi. Sebbene, sia st;;a successiva a quelle in ci)ro, l'argento e il rame, 1<almente remote da non

he gli stessi minerali di As.L'As non è un elemento part
ondante: è presente sulla tenuale di circa 1-10 ppm.
'roprielà fisiche/As si presenta in due modifiiche: la forma così detta mei

itica la reazione viene esegsemplicemente appropriate
rio, CH3COOH e H3AsO4,:rando il prodotto.
odi per determinare l'As site che quantitativamente s<ti secondo le tecniche classi:, la ricerca analitica dell'Aiapplicando le tecniche stru:al fine di ottenere determ
5 e metodi più sensibili. Per

industria elettronica di p:^s ad alto grado di pure;nno discussi più ampiameii arseniuri, ma possiamo dieffetto collaterale di queo quello di render disponihiposti di As estremamentetriossido di arsenico è la s
:a per la produzione di quti dell'As ed è perciò il princsi trova in commercio. È iazione del vetro, e Der otte

mo ai aiarsenico si i<> all'aria o si ottieiirante vari processi iìublima abbastanzaiella sua purificazioriene molecole As4O6ne tetraedrica di atc.u ciascuno spigolo,come mostrato nelknente, si può pensaredi ossigeno con gli <quattro facce dell'c
ì corta As O è 1,8stono due modificaed una fase vetro
li molecole As4O6 iio cubico. La claudel

particolare quelli con piombo. Un eietato dei composti con il piombo è dtabella IV. Sebbene le composizioni 5veramente insolite, esse diventano esibili quando siano esaminate le strutstato solido. C'è un numero limitato ebinari fondamentali. I tipi più comurifpricrnnn ali** fnrmnl^ pmninVVip nf

classificati riferendoci agli stati formalisidazione 4 3 e 4-5. Nel primo stato d'<zione l'As ha un doppietto di elettroicondiviso, mentre nel secondo non esdoppietti liberi. Alcuni esempi di taliposti figurano nella tabella V. Con poccezioni. come eli aloaenuri ionici di tet

uanto riguarda le bassissime tem]IUÒ pensare che l'arseniuro di ineuà piccola separazione fra le bandetossa operare intorno alla tempeielio liquido. Sono state trovate eler questi composti III-V altre prò]aggiose rispetto a quelle dei disposio o al germanio. Sono stati suggerìori a diodo più veloci con GeAsolari costituite da GaAs sembrairomettenti. A causa del numeroole di composti III-V disponibili, 1

dotti in circolo vengono in graii dalle cellule reticoloendoteliaio la barriera ematoencefalica,rsa diffusibilità hanno quindiìza a fissarsi nel SNC. Nell'org;io ossidati con rottura del ponimi di As e formazione di arse•presentano, come già indicato,sti attivi. Per quanto riguarda il razione, si pensa che questi comti i derivati dell'As, esercitino il.gendo coi gruppi sulfidrilici d

resenza aei quaie iornisce una inteiizione rosso bruna.Un reagente notevolmente miglior*
rofilo della sensibilità della reazione,•dimetilamminoazofenilarsonico :
H,C

di migliaia d'anni. Molte proprietà nipossono essere perspicuamente rappresin un diagramma (fig. 1) in cui si ripeascisse il numero di neutroni Ar e in 01il numero di protoni Z contenuti in un rQuesto diagramma è talvolta chiamatgramma del Segrè. I nuclei stabili si aclano in una ristretta zona, quasi una
Al di sopra di questa si trovano nuclidi (cadono B per emissione di positroni, al dsostanze che decadono B per emissione i

98Mo + 2H = "Te +
dà luogo al "Te, con periodo 2,12reazione è brevemente indicata,dovuta a Bothe, come: 98Mo(d,primo simbolo chimico è quellobombardato (con la massa ad eguito in parentesi da quello d<dopo la virgola, da quello delle pse durante il bombardamento, nsimholn chimico (con la massa

menti di scissione non hanno energie astiche come le particelle a e quindi norno essere attribuibili a un dato isotoporemo oltre dell'identificazione chimprodotti.
Si raggiunge l'ultimo limite di seiquando si rivela un singolo atomo,caso non è raro per gli elementi più(Z > 100) e tra gli ingegnosi artifici usadiamo quello illustrato nella figura 5
Per l'identificazione chimica dei numenti, quando essi sono prodotti in emacroscopiche, per esempio un milligisi procede con i mezzi classici della <

suo peso fresco. La distribuzione di vall'interno del frutto è spesso molto viIn generale, è possibile affermare chemina è concentrata in regioni ad elevivita metabolica. Non è possibile, su 1sonomiche, indicare o selezionare kper il loro contenuto vitaminico. Le 1ad es., comprendono la rosa comunfrutto contiene la vitamina in una coizione 200 volte maggiore della mela,partiene alla stessa famiglia. Anche :

bile. L'analisi delle formule rivela che petività antiscorbutica, l'anello pentatomiive essere a destra della catena di atocarbonio, quando la formula è scritta seila convenzione di Fischer. A tutt'oggistata riportata in letteratura nessunazione a questa regola. La necessità di eanello può anche essere compresa per ilche sostanze come l'acido reduttico, iltone e l'acido diidrossimaleico, che hai

che procede dal D-galattosio attr;galatturonico e l'acido galattonicbe le vie si verifica l'ossidazioneacido uronico e la riduzione dell'inel corrispondente acido aldoniccsidazione di questo acido ad aibico. Durante questa sequenza dviene l'inversione della molecolaraggiunta la configurazione condell'atomo di carbonio in posizicdotto finale. La sequenza di re;

za di molti altri animali da laboratili- incapaci di sintetizzare la vitamina (na sono basati sullo studio di variazioon che dei denti o dei livelli della fodi siero. Il livello di questo enzimasi- nettamente nello scorbuto mentre ioi- nuovo quando viene somministrcal- ascorbico. Il procedimento raccomaita siste nell'ottenere, mediante dietaer- gena, la riduzione del livello dell'*tra siero e saggiare poi la risposta alla;o, strazione della vitamina. Il semp;si- curativo della crescita è tuttavia u;

;l suo isomero: l'acido D-aralEsistono anche metodi basati
;Ila forma ossidata dell'acidotilizzano la reazione di cond<icido L-deidroascorbico e la 2,drazina per dare l'idrazone. Arletodi le forme ossidate del redicido reduttico possono interfet>rmano, i rispettivi idrazoni. Ri;irati si ottengono previa sepaIrazoni per cromatografia su eimina. I metodi polarografici eDssidazione mediante l'elettrodlercurio sono stati impiegati e

g ^ ^
:o basico di piombo. La scarsissimìdell'a. in acqua, circa 0,2% a 0°,ottenere l'amminoacido ad un alpurezza mediante ripetute cristalsoluzioni acquose calde. L'isolani*
oteine può essere effettuato solo•olisi enzimatica della molecolaiché l'idrolisi acida determina laizione dell'amminoacido in acido ;
p torii di sintesi

: piante l'a. rappresenta un importantebolita intermedio, poiché l'azoto ammi-è utilizzato dai germi di grano per la sin-di glicinammideribonucleotide; come ri-dai dati di Uzman (1952), l'a. è più effi-
della glutammina nel promuovere la for-one di glicinammideribonucleotide a par-la fosforibosilpirofosfato. È possibile chevolga compiti analoghi a quelli della giù-nina nelle reazioni di trasferimento del-to ammidico. Il catabolismo dell'a. s:

e il residuo adiacente legato al suo e;l'apertura dell'immide può portare simente alla formazione di un legamiuna catena peptidica.
IsolamentoL'a. a. fu isolato per la prima volta iteine dei semi di fagiolo da Rittha

risoluzione nei due antipodi L e D; r:re l'isomero D dall'acido L-aspartiquello che si trova in natura, è neocedere alla racemizzazione seguii;oluzione. L'a. a. otticamente specifìicemizzato per riscaldamento concesso a 170-180° o per riscaldarne:i(OH)2 in soluzione acquosa a 175°.--aspartico può essere risolto pre]

> con altri composti (acido fumariealico, acido fosfoenolpiruvico e aico) sono rappresentate da reazio>rtanza fondamentale in moltissii. MALEICO E FUMARICO ACIDO J MALI!RUVICO ACIDO, METABOLISMO DEL).
irgente di a. a. è rappresentata dainazione dell'asparagina, sebbenazione non rappresenti una nuo;rché la sintesi dell'asparagina rich)lta a. a. come precursore. L'acidoio essere un possibile precursore

una componente ad alta lunghezza d'onda peralte concentrazioni del soluto; l'intensità diquesta nuova banda di fluorescenza decresceall'aumentare della temperatura, e ciò per-mette di distinguerla da bande dovute a im-purezze; tale banda è attribuita alla forma-zione del dimero eccitato (excimer):
che si decompone secondo:
«X+X+hv

questo caso la trattazione è pssa, tuttavia in alcuni casi è ]re la costante di equilibrio pe
Z,, Zjt Z,
luindi calcolare l'energia, l'enitropia relative all'addizionea ad un associato di numerosmare un associato di numeros

formano tali complessi. La figurauno schema delle transizioni possilcomplessi.
Riguardo alle forze di Van derserviamo che l'interazione di Loncsente anche tra molecole apolari egenere sugli altri due tipi di interazsi ripartiscono tali forze intermoleccterazione di London favorisce la fcdi associati tra molecole della ste( "L^Q+ÌÌI o nr\ e± m i n t-»r\t* f a ve* al Ira flr»t*rv

HA0 è la costante di Henry nel s>/ la forza ionica della soluzion
ostante che dipende (debolmentei degli ioni interessati.
ca dell'assorbimentojrbimento si verifica allorché liparziale di un componente in fapA = jcyA, è superiore al valore eper la concentrazione dello stess

issati il valore di L e, dalla equazione (alore di XAB. Note le portate delle dusa scelta del tipo di torre e il calcolo denetro richiesto possono essere condottinetodi classici delle apparecchiature corn controcorrente, quali ad es., le tolistillazione.

soluzioni usate (acquose) sono principalmen-te di: carbonato e bicarbonato di sodio, talora:on aggiunta di catalizzatori omogenei comegli arseniti; le varie etanolammine; soda cau-stica; fosfati. Tali processi presentano tutti,in varia misura, una forte (e desiderabile) se-lettività per l'idrogeno solforato. Ciò è dovutoal fatto che la reazione:

Ae = e 2 — Ej = hv
re A è la costante di Planck edio le energie degli stati della mole
e dopo l'interazione con la racvelli energetici di una molecola sornerosi ma di tutte le possibili tr<D alcune sono permesse in assor»ole di selezione). Secondo il modi

del momento di transizione e quindi in jcipio contiene informazioni sulla distribuzdi carica nella molecola.
Per quanto riguarda l'inviluppo delle bale molecole mostrano assorbimento su regdi frequenza varianti da bande molto st]a bande molto larghe; queste bande la:possono originarsi o dalla sovrapposizionmolte righe che Io strumento non riesirisolvere o da un vero e proprio assorbirne
tità. È l'ultimo degli elementi delpò A del Gruppo VII del sistemaossia è il più pesante degli alogeni,razione elettronica completa dell';tro probabilmente è [Xe] 4 f14 5 desso possiede cioè un elettrone ispetto al gas nobile Rn. Tutti glil'At sono radioattivi (tabella); l'isha la vita mpHia nifi lnnpa ma mi

. C i4, Denzene, toluene, cicioesene, //-eptano o:tere isopropilico. Se si evapora, anche con>recauzione, una soluzione contenente At°,sso passa allo stato di vapore. Analogamente'At° evapora, anche a temperatura ambien-e, da superfici di vetro. L'At0 coprecipitaluantitativamente con Te metallico formato initu, ad es., per riduzione di TeO^ con SnCl2.
Se si rende alcalina una soluzione conte-ìente At°, l'At cessa di essere estraibile inolventi organici, ma può essere precipitatolalla fase acquosa con Agi o TU probabil-nente in seguito ad una reazione di dismuta--innp CìtW psnp.rimpnti QiillVQtrayinnf1 rlpll'At

gè la parte solida del nostianche altri pianeti hanno uza di tali atmosfere è govitori, tra i quali predomiitemperatura superficiale d<fatti mentre la massa geneincatena a sé le particelle :tura le sollecita ad allont
C'è una grandezza mousata per descrivere questla cosiddetta velocità di fuivocamente anche se non t

lensita numerica n, al suolo,zoto molecolare (N2):issigeno molecolare (O2):.rgo (A):
fi sono anche piccole perceitituenti che per certi aspettimportanza capitale, comelica (CO2) o come il vaporeressano in modo narticoian

detto sopra), in questo intha luogo la dissociazione dcolare in ossigeno atomico, 1fusione di quest'ultimo e finazione dei componenti atmossimultanea di tanti processicomplicata l'analisi della loilativa e il concetto stesso dventa difficile da maneggia:
Si noti che ai tre massimfigura 2 (la superficie terreste la termopausa) sono assoisorgenti di calore, da indivmente nella radiazione solai

solare locale ad un minimo centra3 antimeridiane. Questa oscillazicè ovviamente diversa alle diverse 1alle diverse stagioni e le corrispondezione di temperatura.
Un altro tipo di variazione dell;della temperatura si verifica in corricon i disturbi del campo geomagnebra che l'inizio di una tempestaprovochi anche un aumento di dstemperatura, a quote termosferichi

colazione globale dei vari elerrGEOCHIMICO). I sali marini formpiù semplice di circolazione ilgono trasportati nell'a. sopra 1che e depositati sulla terra fernvengono riportati al mare sottcdisciolti nei fiumi. Elementi ccl'azoto hanno schemi di circola:plessi in quanto coinvolgono latanto è probabile che l'anidrid'sempre stata presente nell'a., e;

babile che aumenti in misur;turo a causa degli indici seicombustione di carburanti i
Si ritiene che l'anidridfluenzi la temperatura dell'sorbe le radiazioni infraroseie. terrestre Onesto effettc

vogadro {—>), erano usati 1 dati de; due scale senza alcuna distinzione,conto anche che non era logico usar; quasi identiche per definire quantta relazione fra loro, come le masstie e i p. a.i Commissione Internazionale si prei cercare di correggere la situazione

chards ad Harvard, e O. Honigsi'orò per un anno nel laboratorio dlopo continuò le sue eleganti riceico di Baviera fino alla sua morteLa validità del metodo dipendev;nte, dall'accuratezza con cui si coapporti dell'argento, del eloro en l'ossigeno preso come element;nto per la scala. Questi rapportiminati da Richards e da Honigscxllente accordo. Un sommario (Itati fu incluso nella Relazione essione Internazionale nel 1961.piccoli e talvolta variabili errorti alogenuro-argento non fu so

iizioni di gas ideali. Erano necessarie?ioni rigorose di purezza dei gas e óratezza nelle misure di pressione e telura. Tuttavia, il metodo risultò utile nper i gas nobili, ma anche per alcuni amenti come carbonio, zolfo e fosforo.M. Ritchie nel 1930 ottenne un valorp. a. del fosforo, da misure di densi

numero atomico Z, ossia dal itoni o cariche positive nel suanche eguale al numero deglicariche negative neutralizzanedel nucleo. Viceversa il numinon è sempre costante per ojchiamano isotopi le specie di a.mento, cioè con ugual numertche hanno numero diverso

0 caratteristico di questo tipo sonoornici di emissione o di assorbirne:"oprietà sembrano variare, all'alimi;so atomico degli elementi, semesso senso; se cioè ordiniamo gli el•dine di peso atomico crescente (1 numero atomico crescente), alcun. variano monotonamente al varassa atomica (o meglio del nume

ura dell'a. si altera: avviene cioè l'esdi un elettrone dall'a. con formazione positivo corrispondente, ossi
tazione, e l'energia dell'a. al limite (spettrale di frequenze più elevate è'energia di ionizzazione dell'elemiderato.• ali elementi più pesanti dell'idroeen

;iain alcalini 1 unico eieurunelenza determina quasi compìratteristiche spettrali, assumenruolo di un elettrone idrogenoizioni maggiori si riscontrano iunenti che contengono più <ergie confrontabili, e dove qui:ioni spettroscopiche hanno luecui energia è determinata in rrile da interazioni complicate eparecchi elettroni di valenza,
snti non idrogenoidi né alcali]DÒ i tipi di interazione che de

Tra le altre proprietà che possojpiegate direttamente mediante tal:azione citiamo tra l'altro: la mai•eattività da parte degli a. dei gas:ui configurazione elettronica esteri; un insieme saturo, e quindi stabsoggetto a trasformazioni chimicheionizzazione e quindi la possibilità eioni positivi monovalenti o bivalent

dello stato degli elettroni, in cui il concorbita evolve in seguito ad una piùvalutazione dei fondamenti della nostrascenza dell'a. che si riassume nel princindeterminazione.
Struttura dell'atomoLa conoscenza odierna della strutturasi fonda sui principi della meccanica estira fili a ranr>resentano uno dei e:

in questa descrizione egamento con le forme gèlite di Sommerfeld; i nicontinuano però a definizio delle distribuzioni enei diversi orbitali. Performe, è opportuno consiatomici, anziché nella fDrma di combinazioni lii
L

della funzione angolare, ovvero <drato (fig. 8). La rappresentaziodell'andamento di un orbitale atodo conto sia della dipendenza nquella angolare, si può fare oppriportando in un piano di sezione ile direzioni di massima densità deuna serie di linee quotate in valezione od in valori della densità elcui la figura 9 riporta alcuni es«sentati vi.
Si tinti rhe. lp. fnn7Ìnni hanno

di inversione dovuti alla dipendenza seco)daria dell'energia da /, ad es. 3d-4s), maspaziature fra i livelli energetici vengonovariare fortemente rispetto al caso idrogenode, tendendo ad espandersi per gli orbitepiù interni, come è mostrato nella figura 1che confronta il sistema di livelli energetici <un atomo idrogenoide (Na XI=Na10+) e del'atomo di Na, con 11 elettroni.
È ancora da notare che la carica efficai

ani di valenza; ciò fa sì che le enerjsttroni degli orbitali di valenza noolto diverse dalle energie idrogenoicrenza delle energie degli orbitali inteventano fortemente più negative), (tte in una fascia di energie di 10-20l'intervallo tipico delle energie deilimici, dei calori delle reazioni chi:lle comuni energie di eccitazione

ui quena cne avviene lungo 1 piccePer le terre rare (lantanidi) ed i tr(attinidi) è più giusto parlare di gdi periodi in quanto le variazioni pdelle caratteristiche fisiche sono m:rivando tali elementi dalla progressizione di orbitali «f (n = 4, 5), in priempimento totale degli orbitali(n -f l)p e degli orbitali («+2)s, ivariazione di struttura elettronicasoltanto orbitali molto interni e f

in uno stato zp* aei e 1 due vettori /i(./1 =dei due elettroni 2p possono combinardare un momento risultante con L = ^pure 1, oppure 0. L'energia dell'interache porta a tali accoppiamenti è dell'cdi grandezza di parecchi eV, ossia, inspettroscopiche, di alcune decine di nrdi cm-1. Parallelamente anche i vettomomenti angolari di spin % dei singoltroni si accoppiano oer dare una risu

razioni eiettromcne ai questi eiecati nella tabella I. Con il celento della serie dei lantanidi,a il riempimento elettronico dehe termina con il lutezio (Z =ici elettroni occupano progreorbitali 4f. Nella serie degli aia formalmente con il torio (ce con il laurenzio {Z = 103), ]ìpano progressivamente gli orine attualmente che la chimicaino di elementi sia simile s

berkelio (Z = 97) fu ottenuto per)lta da Thompson, Ghiorso e Seal•49 con la seguente reazione:
241Am (4He, 2n) 243Bk
californio (Z = 98) fu scoperto dam, Street Jr., Ghiorso e Seaborg ni reazione usata fu:
• 242Cm (4He, n) 245Cf
I due elementi che seguono sono si)tti e scoperti in modo inatteso. Alcuati in tre diversi laboratori negli Sto

. un alto grado di pure:li fusi. Un altro metodc3ne, ad alta temperatu:n un metallo alcalinelerando sotto vuoto os inerte. La temperatusere superiore al puntie si vuoi preparare, peile agglomerato.Gli a. differiscono notedi nello stato metallico,die figure 1 e 2 che nente, l'andamento in fiomico della densità e e:r un numero di coordin

. ili qucsiu cassu buiiu gii a
coordinati che li stabilizzanea proposta per lo stato +1nio, e americio è MOf ; dda quella dello stato +7 di
zio, renio, rutenio e osmio drme MOj.l'altra interessante caratteri!la contribuito molto alla eloro chimica, è il confroi
o ionico con quello dei lant;ndamenti per tipi strutturaiparalleli, e si vede che elemelanno raeeio eauivalente m;

tig.5 tasi cristalline dei tnalogenidi e lantanidi. La linea tratteggiatiindica che l'esistenza di questa fas
forme; come MO| e M6+. Quest'si trova nei composti MF5 in cu;nettunio e plutonio e in UC16. Soi fluoro complessi come NaUF

nento sono espressi in anni edrmico specifico in watt per graper il 249Bk appare piccolo in co:Itri poiché questo isotopo decaie p~, mentre gli aHri decadore a. È evidente che questi studal torio, all'uranio, al nettuce al curio. La presente scarsez
pi 247Cm e 248Cm rende improire assolute di entropia siano fi

Si possono anche fare separazioniusando resine a scambio anionico; icaso è implicato un anione complessetanide o a., e l'ordine di eluizione è s

247Cm non decade per emissione [3 . Co:solo isotopo del berkelio disponibile per simacroscopici è il 249Bk. È da questo isotche si può ottenere il 219Cf, che è una spadatta per esperimenti chimici; intattiessere ottenuto libero da isotopi di califoispontaneamente fissionabili.
L'isotopo dell'einstenio con il tempo di

si usino i guanti. Nel caso del plutonrimanenti a., tutti gli isotopi richiedoidi box e di guanti speciali per maiquantità superiori a tracce.
La quantità di una sostanza emitteticelle a che può essere manipolata indipende non tanto dalla radiazione a,dalla radiazione y associata dell'elemeiso o dei suoi nrodotti di decadimento

•e isolato e purificato da mpuò allora osservare che 1r decadimento.Il terzo isotopo, 225Ac, nondimento di un capostipite ]rale a lunga vita. Tuttavia, ineutroni portano alla forr
rali contenenti U e Th, dimime di 237Np e 233U. I neutti da raggi cosmici, per fissson altri processi nucleari,i del 237Np che del 233U, portdi 22SAc. Peppard et al. (195
; isolare piccole quantità dili di uranio e torio.
•oprietà fìsiche

pitazione, l'estrazione con solventi e i processdi scambio ionico.
Sicurezza e tossicità1 principali problemi radiologici connessi coil'impiego dell'227Ac, sono dovuti alle radiazioni emesse dai suoi figli radioattivi. Questi raggiungono l'equilibrio secolare in pochi mesdopo la separazione chimica del genitore puro227Ac. Ogni disintegrazione di un atomo d227Ac porta (in media) alla successiva emissione di cinque particelle a con una energia totalidi 32,2 MeV. L'emissione di particelle fi ne
' ì / A ^«. *-*

srsagno. ìaie reazione viene ram la notazione (n, n).Nel caso della diffusione anelasti
assa ad un livello quantico più einello fondamentale, per poi tornaliziale mediante emissione di r:azione è rappresentata simbolicìe (n, n').La cattura del neutrone porta ;
imposto che emette fotoni (n, y),ementari, come protoni (n, p),1, a), ecc. In alcuni casi il nucleo

iijipiuni pel icmpi icicuivauicmc IUJ
genere il campione da irraggiare i;ato in un contenitore non facilrrtbile (capsule di polietilene, o di> iperpuro, o fiale di quarzo) e aquesto viene collocato in una cai
'iene introdotta nella zona del reazata per l'irraggiamento,nrocedura ner confezionare il camn

ha attraversato il cristallo. I mecmite i quali il fotone y cede enertroni del rivelatore sono i medesnel caso dei rivelatori a scintilieffetto fotoelettrico, effetto Conmazione di coppie.
Tuttavia il differente meccani;dall'eccitazione degli elettronial segnale elettrico in uscita daconsente di ottenere, nel caso disemiconduttore, un potere risoluvato e di conseguenza picchi y r

presenti e tali da costituire una intela seconda è la discriminazione dei fgli elementi da analizzare tra loro. lipossono interferire vicendevolmente,che alcuni sono presenti con attivimaggiori di altri, sia perché pur esattività in gioco confrontabili, le r;emesse possiedono energie y assaimezzi a disposizione per discriminaivita utili da quelle interfenti, e le prii

A questo proposito è bene ricorcportanza del semiperiodo. Ai fini pil'analisi per a.', si definiscono isotobreve quelli con semiperiodi dell'ominuti. Isotopi a vita media sono esemiperiodo dell'ordine delle ore,vita lunga sono considerati quelli coriodo di giorni e oltre. Se per atthformano radioisotopi con semipericdiversi tra loro, si può, sfruttando o

r analisi di componenti in tracè così visto che elementi come,, Mn, Rb, Sn, Sr, Ta e U soruantità molto minori di quante;o in precedenza. Lo studio ei/Sr ha permesso di rilevare u'accumulo di Sr nelle acque m;itemente gli organismi respoirmazione di rocce sedimentarie

ì (7) devono essere equivalenti poiché ilenziale chimico di una specie i in soluzleve essere lo stesso, indipendentementejnità di concentrazione e dai coefficienittività usati.
Tuttavia i termini /x° non sono gli stessleve fare in modo che siano coerenti, perlata soluzione, con le unità di concentra2;d i coefficienti di attività impiegati.
11 ci<ynif ìr ' i* tr \ AeA r*r*É»flfii~ÌÉ»ntÉ» r i i et À rr»

per il caso non ideale dove / è latermodinamicamente efficace o fugun gas puro o in una miscela di gadizione di non idealità si presentanon segue le leggi di Boyle o Cha:legge generale PV'— nRT per n moltemperatura T, pressione P, occuvolume V.
La fugacità può essere ricavata sgli scarti del gas reale dalle leggirw*rfpttn Tn nartirnlarp npr un tra*: ni

riversamente proporzionale ai quaaralistanza interfonica. Altri tipi di forziluelle di Van der Waals, tra molecoleliminuiscono con l'inverso della settienza della distanza intermolecolare.
La corrispondente energia di interazjende dall'inverso della sesta poten;iistanza mentre per gli ioni dipende/erso della distanza. Per questa ragioììoluzioni elettrolitiche si verificano i

Questa equazione può eodo più soddisfacente ugtali elettrochimici delle spe<l'elettrodo ad equilibrio rII potenziale elettrochimicirica è definito come /J,+jtenziale chimico della sp<ale elettrico della fase in«eie carica. Per una rea

uwua oxiica e una propneia nsica;ostanze presentano indipendente) stato di aggregazione (solido,>oso) quando esse interagiscono ei di luce polarizzata. Le sostanze eio questa proprietà sono dette 01ve e il fenomeno va anche sotto izre rotatorio.,e grandezze fisiche misurabili chiuna variazione nell'interazione di

Più precisamente, una delle due <ida della natura della sostanza,i velocità diversa dall'altra nell'into della sostanza e, in opportini, una delle due onde viene ass[l'altra.La diversa velocità con cui si muzzo otticamente attivo le onde j

Fig.5 Comportamento del potere rotatorio [a]lell'ellitticità [0] in vicinanza di una banda di aìorbimento. In a) si ha un effetto Cotton positivo:ui corrisponde, in b), una curva positiva di dicroimo circolare. In e) si ha un effetto Cotton negato a cui corrisponde, in d), una curva negativa <licroismo circolare. Ào è la lunghezza d'onda con.pendente al centro di una banda di assorbiment
;urve di dicroismo circolare e di disperskattica rotatoria si sovrappongono fra loro dio luogo a risultati di più o meno grai

mi due sono otticamente attivi e imma-eculari l'uno dell'altro. L'ultimo è otti-te inattivo in quanto possiede un pianonetria (linea tratteggiata nelle formule),ultimo prende il nome di mesomero orma.tono delle sostanze che possiedono a. o.:nte allo stato cristallino,npi di queste sostanze sono il quarzo /Sstalli di clorato di sodio (NaClO3). Se

:na vanaDiie contienere il quale si isllo automatico, valiIta per tutte oppurittori esterni secon<nella loro veste piriteri di ottimalitÈifferenza che esiste3 desiderato della •>letta deviazione vove la specificazioia distinzione fra v£tinzione ha una npresenza inevitabilechi degli strumentne dei segnali, che

ocesso possono essere racc:nte (mediante un data loida permettere l'introduzicilatore (ad es. mediante scistri magnetici),ogni caso il modo di funziiLea richiede l'accumulo de> che con un certo ritardoiti al calcolatore e quindidelle imprescindibili limit
:zazione. In effetti si può utore di processo operante fido la raccolta delle inforrr

Si realizza in questo caso il mezionamento detto on-ìine (fig. 5 ail calcolatore ha la capacità di rice\direttamente dagli strumenti dell'trasformarli opportunamente perborazione.
È a questo tipo di calcolatore,capacità, che viene dato solitameidi calcolatore di controllo.Ad anello aperto, ad anello chili:cificazione on-line si riferisce al fiformazioni dal processo al calcolaiso in uscita da un calcolatore on-isere rinviato al processo per traintermediario oppure direttamentQ nnf»ctr\ rM"r\r\rwitr\ Ai flnflln anprtf

ifferenza di quest'ultimoviene utilizzato per regoi uscita del processo che
misurata ma calcolatanisure dirette. Se la vari;;ontrollo non può essereita in linea, ma deve erove fuori linea, si può :di connessione in-line

Raccolta e registrazione dei diFra le funzioni di un calcolatetirientra anche quella di raccogli!sare e registrare una serie di dmento dell'impianto, che sono eiella conduzione dell'impiantoformazioni di questo tipo, che vin base ai criteri gestionali desono relative solitamente a:
a) consumi orari (o giornalieirie prime;

tamente connesso alle prestma anche la temperatura, operatura, a cui è assogettatportanza fondamentale nel itico che rappresenta il reat
L'ultimo stadio della formodello matematico riguardpò di modello in relazione alto e al livello di conoscerposseduta.
La tabella II riassume le edifferenti tipi di modello. Si
a) modelli nrnredurali. cns

izioni del processo; qualunqìtuito dal risultato di un'a:fenomeni che hanno luogobinata con le osservazioni e>scenza pratica che di esso si base teorica per il modell3 è rappresentata dalla conci dei fenomeni chimico-fisic;ono e dalle leggi naturali ehmodello teorico può offrirenzia e un'affidabilità genera; di un modello empirico e pn modo organico, di tutti i '.anti che caratterizzano un pià.

Mia cicli impiumi) quesiu suiliso che l'indice di prestazionÌ estremo compatibile con lejnali e con i valori delle va:nti non controllabili. Perchiìuo non si mantiene nel puntié ci sono dei disturbi che, nelno i valori di queste variar.s variabili possono essere es•bi; in conseguenza il puntoe continuamente e sorge l'esire qualche cambiamento elilnn^iurp l'f»ffV»ttr\ r\p] rlìctur

U pvviai, u«. y^utllU utll Ullllll
isposta dinamica, basata su rrui meno accurati,•a ultimo è opportuno far rileva:e l'esercizio di un impianto, tmite la funzione obiettivo stes'isturbi così rilevanti da modificeconomico da perseguire,
•isturbi di questo genere sononei cambiamenti dei piani di jella situazione di mercato per

lo come una vaga indicazioneve le condizioni base sono rSebbene un lungo camminoisicologica sia ancora da fare ]finire con qualche certezza g;ici dei gas emessi dagli autovtncentrazioni e per diversi terme, appare tuttavia chiaro ehni di irritazione agli occhi, co;turbi alle vie respiratorie di pmalattie croniche, possano eizione con concentrazioni not

a combustione per sintesioto dell'aria comburente, <ne viene bloccata dalla rapIla temperatura, dovuta ;eguente all'apertura delle ALa concentrazione degli os:Ì di scarico dipende da quiponibile per reagire con l'aeratura in camera di comquindi oltre che, come sr gli idrocarburi incombi]
Hplln mìcnpìa anchp ir» f

lire appareccm ai quesio gè>iù precisi che si conoscano pma del CO e della CO2, quelli1 «-esano rivelano con diversarburi di specie diverse. Perè stata proposta una modifici di prova Federale USA, ehire dal 1972, l'uso di un anaazione di fiamma per gli icl'esecuzione delle prove si usazatori non dispersivi all'infr/amente per CO2, CO, bassritrazioni di HC. Gli appanati tra Inrn pH alla snnrfa Hi n

siom di prodotti incombusti datendono in genere ad aumentaredi ossidi di azoto. Questi infattidotti in più alta percentuale ogniparametri motoristici sono tali daefficienza termica ottima duranbustione.
Iniezione di aria in prossimità dellscarico. Questo è stato il primo si:

i totalità dei catalizzi punto mostrano ino!del grado di conversiluando le autovetture;ngono alimentate conlitivi a base di piombun numero di chilorr
riabile con il tipo dinolto elevato, causasnto del catalizzatore

acido indolacetico o indolpropioniprincipio è stato utilizzato per la prerdi diserbanti selettivi, in quanto le phanno /^-ossidazione elevata possoiavvelenate dall'alta concentrazionene, che per tale via metabolica siprodurre, mentre le piante non /?-ossmangono indenni. Vi sono poi altri ipossibili precursori, i quali permetlgrande flessibilità nella produzionecazione di queste sostanze, necessariascita e allo sviluppo delle differenti ppianta.
TI rntaKrvlÌQmn rlpil'ariHn inrlr\l3rf»1

ìgamento della catena porta ad ilell'attività. Infatti è stato osserviposti nei quali « è dispari soldi quelli nei quali n è pari (talsono in realtà poco attivi). Peuesto fenomeno è stata avanzatihe gli omologhi superiori delcetico non siano attivi di pero soggetti alla /3-ossidazione pauxina solo se n è dispari. Se la

le al numero di Avogadro. Lzione con questo metodo fu iin nel 1917 nel corso delle sirienze per la determinazioìl'elettrone. Il valore di N ein era « 6,07 x IO23. Dai vainotevole precisione di F (9(,8024 x IO 1 0 unità elettrosi
7V = 6,023 X IO23.

JIUULHIU ttiv c ac iictiiuu dinne la bi<
;ione P e lo stesso volume V, dovraiinche lo stesso valore di n.
È interessante talvolta enunciare ilii Avogadro in maniera leggermentUna delle varianti più interessantilumeri uguali di molecole gassose isressione e temperatura occupanovolume. Se, ad es., questo numero èVvogadro (v. AVOGADRO, NUMERODressione e la temperatura sono quelle

azione uei luniuaiu nei LCSSil., 1954). Studi successivi hto che l'a. è un inibitore di qiimatiche nelle quali l'azoto amammina è trasferito ad un ac(dcune di queste reazioni interintesi degli acidi nucleici:) 5-fosforibosilpirofosfato+gli-fosfori bosilammina+acido gìirofosfato ;

composizione dell'azeotropo ;re semplificata tenendo conto
Trouton per cui Q°JT° ~ Qlora:
(
T2-T)lazione che è stata applicataddisfacenti. Se le relazioni (1)ituite nella (4) si ha:
P W,AB

teorici e sperimentali finora dispctono in evidenza un marcato caranico con una forte localizzazionetroni n sull'atomo di azoto e sui d(del sistema ciclico.
L'importanza industriale delle arispondenti benzo-derivati è legata :sibilità di ottenere alcune fibre sirpolimerizzazione di particolari dericapitolo sulle proprietà chimiche),

Una delle applicazioni più utili dei derìmminici è rappresentata dalla sintesi <,ll-diidro-5/f-dibenzo[ò,/]azepina (o indibenzile) (XXIII) per ciclizzazione dediamminodibenzile (XXII) facilmente <jile per riduzione dell'o,o'-dinitrostrxxn:

he le monossime degli antrachiintrenchinoni possono essere ulotti di partenza ed in questi casme di Beckmann conduce alla fIcuni diidrodibenzoazepindion;santi.rasformazioni identiche od ale appena esaminate possono esanche per mezzo della traspc
riidt che permette di ottenere dlattami per trattamento dei <con acido azotidrico in ambi'
te acido (H2SO4 conc. o aci<

metodi descritti nei precedenti pippresentano i precursori più verìolte azepine, semplici e condensate,lente o totalmente idrogenate, poicho essere trasformati in questi proc5mplice riduzione con idruro di litilinio. Ad es., l'e-caprolattame (X>

ìntre la cianazide N3—CN può essennientemente usata sia con il benzenti altri composti aromatici (toluene,benzeni, ecc.) per la sintesi della l-if-azepina e dei corrispondenti derivatiAlcuni dei derivati più importanti dellspina sono stati preparati per decor>ne termica o fotochimica di azidi aree in presenza di ammoniaca o di amsì ad es., per irraggiamento della feniCV) in ammoniaca liquida si ottieimmino-3fl-azepina (XCVI a) mentreppnrln 1 « r^n'yir^n^ in nrpspnza A\ ani

nvece si ia. reagire 11 ini;IV) con idruro di sodio ed isi ottiene il tetrametil-deriv;e, per riduzione, conduce al>,7-tetrametil-l//-azepina (CIlotto presenta un notevole iminico e reagisce con Testeacido acetilendicarbossilico ]o(CXXI):

te e, sebbene sia possibile trasformarlil'ammide (CXXXVII) per trattamento ccqua ossigenata in ambiente alcalino, rinstabile in presenza di acidi diluiti e tra:nella iV-fenilcianammide (CXXXVIII)quale, per idrolisi, si ottiene infine la fen(CXXXIX):

izione delle aldeidi o dei chii è possibile ottenere il corris, X=N—NH2, solo quand<con un chetone aromaticei casi la reazione procede ccuna seconda molecola di e

e si ottiene per nitrazione diÈ un termine abbastanza irpossiede discrete solidità geiche trova un certo impiegofibre poliacrilonitriliche.

alta reattività fu attribuita alla jdoppio legame C=C. Solo dopo epò Markwald riconosceva trattiammina secondaria, alla qualebuita la struttura ciclica triatomidina. Subito dopo, in conseguenzinteresse snientifirn che, destavano

ìdiatamente fissati. Genersolventi inerti, usando tricettore di acido. In quesndotta l'acilazione tramitirbossilici, cloruri di acidi ssruri di acidi carbammici,ci e altri composti. Li[XVI), sono completamen

»uita in fase gassosa con iinuo.lo un'aldeide con ammoniac) ammoniaca e eloro, la diareagisce, anche in difetto di ;ì aldeide e ammoniaca peraddico della triazolidina 0

Le aiazinuine suno composti uei3ici, distillabili o cristallizzabili, ala loro struttura. Per riscaldameizioni acquose di acidi mineralisformate (ma con difficoltà notevcgiore delle corrispondenti 1,I-diatena aperta) in composti carbonilQuesta reazione è importante pezione di idrazine sostituite. La sdiaziridine consente l'acilazione sazoto, per es., mediante clorurotoluene solfocloruro. fenile isoc

La formula (1) rappresenta gli a. saila (II) e la (III) rappresentano gliUlteriori notizie su queste sostanzfornite a proposito degli ossazoli

resse commerciale oppure quere presentino presumibilmentissibilità di sviluppo, cercaminquadrarli il più possibile
nogenee: i coloranti di umisse, che possiedono per es. eipure sono adatti per l'applirticolare supporto, saranno ittoclassi omogenee.Inoltre i coloranti saranno

o-dianisidina : acido Chicago (2 moli)CI. Verde diretto 6, N° 30295 (IX):
N=N

ccorre notare che la presenzaidrossi-o'-metossiazo nel Blu0 24410, non impedisce la metDiche il metile si stacca durante lalandò il gruppo o,o'-diidrossiazilessa normalmente con il rame bost-trattamento con composti organvi. Consiste nel trattare la fibra

acido 2-ammino-5-nitrobenzensolfonicacida . , „
>• acido Gamma
È importante ricordare che nellaserie la solidità alla luce varia da 3 atre nella seconda serie la solidità v5 a 7.
3) Coloranti dotati di buon potere r,rio, buona solidità alla luce ed ai trai

za dubbio il più utilizzato nella prepEdi a. a complesso metallico.
Nei coloranti al mordente, usati ptemente per lana, la metallizzazione \fettuata nel processo di tintura, generdopo l'applicazione del colorante norlizzato sulla fibra (post-metallizzazioialcuni casi contemporaneamente ad eimetallizzazione), mentre il pretrattamela fibra con sali metallici seguito dacazione del colorante è attualmente pc

li il metallo coordina due divsi sono particolarmente usatnalità brune omogenee.
zocoloranti a sviluppo su flbili a. a sviluppo su fibra sono e:i pigmenti azoici insolubiliati sulla fibra (cellulosa) perazocomposto con un copulan•egnata la fibra stessa. La ditti

posti contenenti in posizicplessanti (OH, COOH): sbrune e verdi, ma l'appi
Per ampliare ulteriorrrtoni sono state ideate nulanti, dotate di grande aottenute sostituendo il rcon quello dell'antracene,del carbazolo, con le quitonalità brune. nere._ vsr

parziale impedimento sme fotochimica). Como usate ammine terzkno idròssietilico, —CH,ormalmente la funzionilo e quindi più disperdsolidità alla luce, all'u
testa classe di colorant:nte molto elevate, rrto richiede Fapplicaziojita ai gas combusti see: soltanto nel casi
e (LXX1) si ha

nenti notevoli nella solidità allane, senza diminuire l'affinità pejne nel colorante CIBA - brevett1.576.879, rosso bruno (LXXII
N=N

a questa classe gii a. canonicipositiva è distanziata dal sistenquindi non entra in risonanzcausa di ciò il loro potere colo]mente inferiore a quello deigruppo precedente; le soliditàcrilonitrilica sono sufficiente]Nonostante esista una vasta 1vettuale sui cationici a carica 1tanto pochi termini di essi cosiche di vendita: questa classe dnostante sia di facile preparazi

Hodogaya - F.P 1.567.970, rosso
O,N N = N
a

issono citare le diclorottalazine.inazoline, i dicloropiridazoni, i <azoli, i clorobenzossazoli, ecc.ìcludere, tutte le classi di a. reatio mobile non mostrano sostamfra di loro in quanto il meccanis
le con la fibra non varia, mentre fiare le modalità applicative. Qiloltre, uno stesso gruppo cromogiuò essere legato a diversi gru:ome nei coloranti (XCVI), (XCcon risultati praticamente idemmento attuale è quindi quello di ipportunamente il gruppo azoico ein modo da diminuire al massi

Gore T. S. et al., Chemistry of Naturai and SyntheColouring Matters, New York, Academic Pre1962.
Gunter Wippel H., « Melliand Textilberichte »,(1969), 1090.
Lubs H. A., The Chemistry of Synthetic Dyes ePigments, New York, Reinhold Publishing C1955.
Peters A. T., « J. Soc. Dyers Colourists », 85, (196507.
Saunders K.H. , The Aromatic Diazo Compoun2a ed., Londra, Edward Arnold Ltd., 1949.
Searle C. E., «Chemistry in Britain », 6, (1970),VenkataramanK.,7"Ae Chemistry of Synthetic Dyes
New York, Academic Press Inc., 1952.Zollinger H., Diazo and Azo Chemistry, New Yo
Interscience Publishers Inc., 1961.

composizione è ancora più facile quancvece di radicali alchilici sono presenti rafenilici, ciano- e alcossicarbonilici. Ail'a,a'-azoisobutirronitrile si decomponein soluzione di toluene, con una costaivelocità di 1,53 xlO1 s-1. In quasi tuttistudiati la reazione di decomposizione ètata essere rigorosamente del primo oCome è del resto da attendersi, solo con

C2H5—O—C—NH—NH—C—O—QHÌÌ -
il li
-» C2H5—O—C—N=N—C—O—C2H
o oestere etilico dell'acido azodicarbossilico
K2Cr»O, eH,N-C-NH—NH-C-NH2 KC1O8 e ali

stemi aromatici con partecipaziidoppietti elettronici liberi delFamento di energia di coniugazionmotivo per cui gli idrazocomposdanno reazioni di disproporzioalte temperature, formando azo<

La decomposizione termica o fotochimica del-le azidi ad a. con svolgimento di azoto, èlimitata solo a qualche caso. In questo modosi ottiene, ad es., il 4,4'-azobifenile dal 4-azi-dobifenile.
Gli a. aromatici si possono anche ottenereattraverso reazioni di condensazione. Le rea-zioni dei nitrosocomposti con ammine aro-
ip dRrnrrnnn roti hnrm^ rpsp*

uosa. In questi casi la preparazione d;i può ottenere per copulazione ossidaili idrazoni eterociclici con un copulaies., un'ammina od un fenolo. Come oite si potrà utilizzare il ferricianuro di>io, il solfato di rame (II), Pipocloritoio e il biossido di piombo:
r ^ i \ / 7

La sostituzione nucleofila din posizione para od orto \litata dal radicale arilazo. Ptalisi con sali di rame (II)sere sostituito da gruppifenossi oppure anche da ra
-N=N-

Occorre osservare che in molti casi i comples-si 1:1 del rame con gli o,o'-diidrossiazocom-posti si possono ottenere per azione di o-idrossi-o'-alogeno- (o o'-alcossi-) -azocom-posti, nei quali durante la reazione, rispetti-vamente, l'alogeno viene sostituito da un os-sidrile e l'alcossile disalchilato:

Gli a. alifatico-aromaticipreparare per copulazione <con composti che contengo!tinico acido. I composti etuttavia chimicamente instloro preparazione deve estemperatura più bassa pospH deve essere mantenutovalori. Ad es., dal prodotdel cloruro di benzendiaztilacetacetato di etile, in s

-» R—CO—NH-NH—CHR—COOH+H2N—NH—CH2-ì azossicomposti alifatici sec<io decomposti in idrazina e et
)CH-N=N-CH(

. oc u anici pòimpiegata si può avere codeve venire impedita scegcondizioni di reazione. Qudecisivo soprattutto il pHreazione: bassi valori favorzione, valori elevati invecealla formazione di triazeni.casi si ha formazione conte

a. sulla fibra stessa, agendo in ambcon appropriati agenti copulanti.
I triazeni aromatici, che ancora eun legame N—H, possono venire alopportuni agenti alchilanti, e rispeacilati con anidridi di acidi carbossgenuri di acidi carbossilici. In quesi triazeni asimmetrici conducono,guenza della già citata tautomeria,dei due isomeri.
Alcuni idrazo-, azo- e azossiakmostrato di possedere un'attività ca

amente allontanate dal] azcare il gas o attraverso unili di rame a — 400° o facenn una bottiglia di lavaggio coli cromo (II). Il vapore d'acqDntanato facendo passareina trappola raffreddata corttraverso un tubo contenenidratante.
Per i moderni impianti diorre alla combustione dell'con gas di reforming, otteni

gii uiuiitui u ui nuii-iegame uci
no in orbitali molecolari formaiposizione di questi orbitali d (molecolari 2p7i* di antilegame •lecola N2. A causa di questa p;zione degli orbitali molecolaridi N2, l'ordine del legame N-ridotto, come è dimostrato enella frequenza di allungamerN-N da 2330 cm-1 nell'N, liberi

ducibilità elettrica, composi(cioè non stechiometrica), echimica relativamente alta,questi composti esista un lemetallo.
Ammoniaca (->)
Ione ammonio NHJGli acidi protonici reagisconcca per dare sali di ammonioione ammonio (raggio 1,43stesse dimensioni dello ione

Fra i pochi composti ea temperatura e preLiC6H5, NaNH2 )
(C6H5)3PCH2, TiCl8,Vari complessi del Codella vitamina B12, soicomplesso di un metN2O, [Ru(NH3)5N2O]ìr\ r\pr rf*n71 nr\p Hirpt

1840 crrr1 per NO. Lo ione nitrosquando N2O3, N2O4 o HNO2 soracido solforico concentrato:
N2O3+3H2SO4 > 2NO+ + 3H!
N2O4+3H2SO4->NO++NO£+3H
HNO2+2H2SO4 > NO++2H !
Il solfato acido di nitrosile, NO+
venire isolato dalle soluzioni. Ilnitrosile liquido probabilmente siNO+ e CI". Molti cloruri metallici

il irmuoruro ui azounodoro; bolle a —1- 206,79°. Si prepara r.ruro di ammonio fuso i^enodifluoruro di amrdrogeno anidro liquid"etta del fluoro con am:NF3 ha una struttura j:?olo di legame F—N—1stanza di legame N—F idipolare, eccezionalmerbye, è probabilmente idale annullamento de

fluoruro di azina, N3F (p.e.154°) è un prodotto gassoso 1o che si ottiene dalla reazioìotidrico diluito con azoto, eLa difluoroammina, HNF2, è istabile esplosivo (p.e. — 23,6°)re ottenuta con uno dei metoa) per reazione di N2F4 con
N2F4+2RSH -> 2HNF2+]
b) per reazione di anilina coTV-difluorocarbammato :H,NH2+;-C,H7OCONF2 ->

gault vennero tuttavia accettati C(serve sino a che ricevettero confer:da Atwater, il quale condusse a terimenti controllati con piante dibilendo il processo della fissazioniIn questo periodo Schloesing e IV1879) dimostrarono la trasformazmoniaca in nitrato facendo passarca di rifiuti organici attraverso idi gesso e terreno sabbioso. Quesdenominato nitrificazione, venivasando lungo la colonna acqua ca

(N2O, HNO, H2N2O2 e NO2->presentano rispettivamente ossictrossile, acido iponitroso, dimetico nitrossile, e nitrammide);(NH2OH); — 2 (NH2NH2); —

cromo e nduttasi, ma non mnueIla della FADH2-nitrato-riduttasi e'H-nitrato-riduttasi. L'implicazioneittura flavinica venne dimostrata melisi fluorimetrica, studi sulla riattivrove sulla D-amminoacido-ossidasiContrariamente a quanto si è dettoenza(Nason, 1962), la nitrato-ridutt;Veurospora contiene un citocromo iì del tipo b (Garrett e Nason, 196ttro differenziale ridotto-ossidatoDPH-nitrato-riduttasi purificata iDPH o ditionito come riducente

;elli per formare NADFL'enzima così ottenuto eraraggio di NADPH-nitrato-spora secondo tutti i criterpresi in esame. Le attivitàzione della xantina-ossidassi purificate, corrispondomvita degli enzimi ottenutine su gradienti di derisitiambiente neutro. In un gr;

è catalizzata da una formiatospecifica, da due componenti situiti da citocromo bx e da una nitrÈ stata solubilizzata la frazioneduttasi di questo complesso, meimento termico con alcali e si ècoefficiente di sedimentazione pa
La ricombinazione in vitro delduttasi di E. coli è stata conseguidi mutanti resistenti al clorato. L

rie fonti come descritto in precedenza, ilcano l'ubiquità dell'attività di riduzione dedrossilammina associata con l'attività deltrito-riduttasi. L'utilizzazione di NH2CXistituisce tuttavia un aspetto secondarioiologicamente non importante della nitritiiuttasi, a causa del valore di Km maggio::r NH2OH che per NOjP e della maggiilocità di formazione di ammoniaca da NOie da NH2OH da parte di questi sister.azzanni e Atkinson, 1961). La nitrito-ridu

cleolidi ridotti, con o senza aggiuntarisultarono inefficaci. La combinaz;nitrito-riduttasi di Ps. denitrificans eparticolato di ossido nitrico-riduttazava la riduzione globale di NOf a ]si ottenne NO libero e questo dimo;aveva un trasferimento efficiente o ipolamento di questo intermedio dalriduttasi al particolato di ossidc

ìasi. In concomitanza con laubstrato da parte della nitrogenUDP e P ;, il che indica una'idrolisi di ATP e il trasferirne!]idrolisi di ATP dipendente dMolti ricercatori hanno indagatìtechiometrici tra ATP idrolizzirasferiti; i valori riportati va5 ATP utilizzati per coppia di e

ma non lo sviluppo dell'H.,(Jackson et al., 1968; Kelly,Bergersen, 1969). Si sono datazioni. Turner e Bergersen,acellulari di batteroidi nodiJackson et al., servendosi dirificata da Azotobacter vinelai

lorati, generalmente in azzurro,stesso azulene è percepibile finouna parte su IO4 in un solvendi petrolio.
Fino dal XV secolo era stain alcuni olii essenziali, ad es., 1milla, dopo alcune semplici opdistillazione, distillazione in epore o trattamento con acidiossidanti compariva un colore a

il cambiamento di colore dell'al giallo. Alcuni sali di azul<isolati allo stato cristallino; arati e i tetrafluoborati.
Gli a. copulano con i saliposizione 1 o 3. Sono alogenatnosuccinimmidi dando derivatstituiti. Il perbromuro di oiri<

i cuprite. In bei cristalli, l'a. si ritnione (Francia), Laurium (Grecia) e a Tsàfrica del Sud Ovest). In Italia sono stovati bei cristalli di azzurrite nelle muprifere della Sardegna.Da un punto di vista industriale l'i
te costituisce un minerale secondario e

Questi risultati non possono esserisulla base di un intermedio del 1quale, insieme al prodotto (VIIformarsi anche un benzoato (XIIl'ossigeno isotopico nel gruppo icapace quindi di dar luogo ad un

proprio con questa prima fase dellaII meccanismo proposto prevede
zione di una specie chimica assai insitenente un atomo di ossigeno posithtà non esistono prove sicure per qumedio e più verosimilmente la decene dell'idrossiperossido evolve attrprocesso concertato nel quale la rlegame O—O è contemporanea alii

dei prodotti finali risulta condizionche dalle particolari condizioni spedalla natura e dalla posizione dei ssull'anello benzenico; infatti mentretossi- (XLIX) e la o-nitrobenzaldeideducono, per ossidazione con acido prispettivamente al guaiacolo (LI) edn-nitrr>hen7oicn (7.TD i-nn rese nressn

ossidazione di Baeyer-Villiger, del)biamo finora esaminato alcuneoni a composti monocarbonilici, of]ti vantaggiosi anche nel caso deijlicarbonilici : se si usano a-dichetorodotti di partenza si ottengono facjerando in solventi inerti, le corrisiìidridi, mentre, conducendo la rea:nbiente acido o alcalino, è possilirare con buone rese alcuni acidi carfficilmente ottenibili per altra via. i

ossidazione con anidride cromiemo, si ottiene l'omologo inferiore dbossilico di partenza. Poiché tale ]>, a sua volta, essere esterificato ead un analogo processo, è chiar
zione di Barbier-Wieland consenidare la catena alifatica di un acide;o allontanando in maniera selemo di C per volta.

OH OH
erivati. Sotto questo nome vengono desun grande numero di dialchil- e di arilajrivati in 5 dell'acido barbiturico. Per lama parte questi composti sono farmactunente attivi (tabb. I e II).Ricordiamo fra questi l'acido 5,5-dietturico (p.f. 191 °) chiamato Veronal®, l'ietil-5-fenil-barbiturico (p.f. 175-177°)ato Luminal®, Gardenal® efenobarbiicido 5.5-diallilbarbiturico Cn.f. 172°ì det

Luminal '&
BibliografiaReport on Barbiturates, in « Bulletin of thè 1
York Academy of Medicine », 32, (1956), 45Rodd E .H. , Chemistry of Carbon Compounds
Amsterdam, Elsevier, 1959.RODOLFO A. NICOL

to che dosi semplicemente setno completamente nel troncoberazione, indotta per mezzdi questo neurotrasmettitore,trasmettitori probabili, qualil'acido y-amminobutirrico, ntrario influenzati in modoanche a dosi anestetiche. Echiare prove sperimentali in

nsinouzione. uopo essere stati assoriono presenti in tutti i tessuti del coriiresi quelli dell'eventuale feto. I variiscono considerevolmente nel loroon le albumine plasmatiche. Il tiopiegato per il 65 %, mentre il barbi talen maniera trascurabile. La possibilit;arsi alle proteine tissutali è la stessa eiresentata nei confronti delle proteineiche. In questa maniera i b. si distrib

ittavia dosi progressivamente maggi,no una riduzione sempre maggiore (rto volume/minuto. L'azione stimoliratoria del 5 o del 10% di anidride:a diventa sempre più debole e ajmpare. Il meccanismo consiste pinente nella paralisi del centro respdollare; se però il paziente soprav\/erse ore, l'edema polmonare o la poi

indicativo di un danno muscolazione al danno epatico. È stato rijsomministrazione parenterale eseun periodo di 2 ore di 18 mg/kgtale non ha effetti sulla forza, sue sulla durata di contrazione detavia dosi pienamente anestetici!notevolmente l'attività uterina dto. Il prolungato uso di fenobmefobarbitale come antiepiletticfetti saltuari sul sangue e sulle osul sangue si manifesta come am

commerciale. L'estrazione di questiviene eseguita quasi esclusivamente pduzione di composti del Ba. La magidei depositi commerciali di baritinadue tipi: depositi di sostituzione, Ìche parziale, di calcari, dolomiti, ascisti, e depositi residui in cui aggiobarite, derivati dall'alterazione di detipo precedente, sono inclusi in aibaritina si trova anche come miner

estremo del recipiente per corpore di Ba. 11 Ba così ottenutetiene calcio e magnesio come irne ulteriormente purificato p<sotto vuoto. Il metodo descrittoparare il Ba è simile al processpreparare il magnesio attraverssilico-termica della dolomite ca
Ba e leghe di Ba sono statif*lf»ttmlici Hi cali fuoi Hi c-»1i+

assenza di anidride carbonica il jione si abbassa a causa della deene. Il carbonato di Ba è termicami;; la pressione dell'anidride carboido è solo IO"4 atm a 1000°, 1•4° e 10 atm a 1994°. La solul|ua è 0,02 g/1; questo valore aumemente in presenza di anidride casumibilmente a causa della formaarbonato.^a witherite è solo di scarsa iminmerciale e il carbonato di Ba i

H2O e Ba(UH)2H2O; il monoidrato:qua molto difficilmente. L'ottoidratoi solubile in acqua calda (51 % in pesoa molto meno in acqua fredda (4,4so a 25°) e la soluzione risultante,
•qua di barite, è fortemente alcalineirbe anidride carbonica dall'aria.L'idrossido di Ba si prepara sciojjssido in acqua calda e separando i e;r raffreddamento: in aueste condiz

, ) , j
è di 1070-1080° circa. Ha un punto di fine di 1350° e si decompone per riscamento sopra 1400°:
2BaSO4 > 2BaO+2SO2+O2
Viene ridotto a solfuro per riscaldamicon carbone.
La sua proprietà chimica più importarla bassa solubilità in acqua : 2,43 mg/1c<~ir*cr1ÌÉ» in ariAr\ cnlfnripr* rnnrpntrnfn

Bibliografìa
Barium, in « Gmelins: Handbuck der Anorgani:Chemie », System Number 30, Weinheim/BerVerlag-Chemie, 1960.
Hansen M.. Constitution of Binary Alloys, 2a
New York, McGraw-Hill, 1958.Kubaschewski O., Evans E. LI., Alcock C. B.,
tallurgical Thermochemistry, 4a ed., New ^Pergamon Press, 1967.
« Minerai Facts and Problems », U.S. BureaMines, Bulletin 630, 1965.
Pearson W. B., A Handbook of Lattice SpacingStructures of Metals and Alloys, New '

ASALTI
asalto è, in petrologia, uno dei piiorni di roccia che si ritiene derivi daltiope basai, il cui significato è: p\ìntiene ferro. Secondo Plinio i b. furerti per la prima volta in EtiopiaII termine comprende, nell'uso corri

MdUl. nuziale ^augne e ui unii 1 7. 11
lio (augite e pigeonite), finale (ferroaugendenza verso l'augite subcalcica nel en rapido raffreddamento di lave basalta riconosciuta come una tendenza adionamento non all'equilibrio, tendeè assente nelle intrusioni profonde dino basico, raffreddatesi più lentamee olivine dei b. sono soluzioni soliditerite (Fo) e di fayalite (Fa) e hanno ozioni variabili tra Fo85Fal5 e Fo75F;nerali dei b. subsilicici includono nefel

:ll'Uganda S.O., il Nyiragongo e altri 'ini a nord del lago Kivu, nella parte estongo, i Leucite Hills nello Wyoming t'ovincia Navajo in Arizona. I principaliroccia della provincia romana compren
3 basaniti a leucite, tefriti a leucite e leiti. Sul Vesuvio si trovano specialmenteiti a leucite e basaniti a leucite.L'area di estensione della provincia a leui da Orvieto, a nord-ovest, fino a Napo

L'origine dei b. fortemente potassici, conte-nenti leucite, è molto più speculativa. Si èpensato che un processo di zone refining possaoperare nel mantello e così possa produrredelle variazioni nel magma basaltico tipico.Il movimento di una zona fusa attraversoil mantello potrebbe, per soluzione del ma-teriale al tetto della camera magmatica e ri-

anti per aumentare la coesione iL'elettrolita è costituito, nella ndei casi, da soluzioni concentrbasi forti (H2SO4, KOH, NaCìeralmente il componente a n;ibilità elettrica e provoca pevate cadute di tensione del sii?er evitare almeno in parte qviiente, le distanze interelettrodridotte al minimo e i diafran
rano anolita e catolita sono reiteriali che, imbevuti di elettro

ite polarizzazioni elettrodiche e senzialmente di tre tipi:i) polarizzazione di concentrazione, ialla limitata velocità di trasporto iiti e/o dei prodotti dalla soluzione>do o viceversa;b) polarizzazione di attivazione (ome), che proviene dall'irreversibilità eì reazione chimica all'interfase eiettrolita;e) polarizzazione ohmica, che può prIla caduta ohmica entro qualche str;ettrodo, ad es. uno strato di ossii

vantaggioso che tutti i generatori pcessere ricaricati in breve tempo e con tnon troppo diverse dalla f.e.m. della bto introdotto, per le b. secondarie, il odi rendimento in quantità.
Il rendimento in quantità è spesso <anche come il rapporto tra la quantitàtricità ottenibile da una b. e quella nria per la sua ricarica.
Questa quantità di elettricità spes:

o il parametro di valutazione[uanto gran parte degli impieghtallazione su apparecchiature r.nensioni notevolmente ridotte,na che presenta le caratteristivolumetriche) delle tre DrinciDc

che funziona ovviamente a temperavate (250-350°). Essa ha i più alti •densità di energia ma presenta pariconvenienti legati alla temperatura ezio e all'aggressività dei materiali usBatterie a elettrolita solido. II sistema j:
Na / /?-ALO_ / S

bitorc di corrosione il bicromato potL'elettrolita è costituito da una soluzi
NH4C1 e ZnCl2 immobilizzata su gelasu carta; questa tecnica di realizzazionseparazione delle masse attive giustificamine di pile a secco, usato per designcune b. primarie. L'elettrodo positivo ìtuito da biossido di manganese, del quagono usati tipi diversi a seconda del ib. e del tipo di prestazione che si riiNella letteratura scientifica sono riporl

lino è riportato nella figura 11.le tre pile sono sottoposte è abda e mette ben in evidenza leprestazione nei tre casi.
Del sistema Zn/HgO esiste asione secondaria che fu sviluppRuben. Egli modificò la struttudo positivo mediante l'inserirned'argento che impedisce la c<mercurio formatosi durante latribuisce anche a ridurre la il'elettrodo.

temente, per applicazione sulle grijpreparato chimicamente. Lo zinccl'elettrodo negativo è depositatocamente in forma spugnosa per ottrodi ad elevata superficie specifì
L'elettrolita è normalmente umdi KOH al 31,5 % in peso (composi:tica). Alcuni tipi di b. AgO/Zn p<ziale, sterilizzabili a caldo e atthstanza, usano elettroliti contenent

attivi o per impregnazionzate di elevata superficie
Per la realizzazione debetti il materiale di partaforato di acciaio nichela:nichel puro) che viene sajopportunamente (fig. 12)
Gli elettrodi positivi, ehdel tipo a tasche che a tuloiti con NifOHÌ., addizit

ite costante, considerata proceile, è generalmente effettuata coite che permetta di ripristinare 1ziale in 5 ore. La tensione della e) dell'operazione è di circa 1,4 V eitamente fino a 1,5 V in 4 ore (esto punto la tensione sale a l , "stante fino al termine della cariLa carica a tensione costante viei:nte effettuata collegando la b. iin un generatore di corrente conti

razie al potenziale più negativoeso, la sostituzione del cadmio eermette di ottenere f.e.m. più eliita di energia maggiori. Le caperative delle b. Ni-Zn non sonoote, poiché il sistema non è anc<vello di produzione industriale.La reazione elobale di cella DU<

tensioiv: relative ai due stadi si6 V, e, di conseguenza, la curvaesenta i due corrispondenti livemedi scarica inizialeè di 1,35-1,2valore di 1,10-1,05 V quando la cfto il 35-50 % della sua capacità nI valori di densità di energia ragj:vati (40-75 Wh/kg) e così le <irica; con una scarica C/1 la tei;nde al di sotto di 1 V e cade a <n una scarica di 10 minuti (6C)

lega di piombo, per mento sp©Valckmar (1881) e di Sellon (1
oduzione industriale degli accumuincia nel 1890 per opera del lusserrenri Tudor.Vennero in seguito elaborati altistra, come la piastra negativa e'astenplatte) e la positiva Manchexirtante è la piastra positiva detta•onclad, Panzerplattè), che appanima volta verso il 1920 negli Staie ebbe poi sviluppi e perfezionarneteressanti.

p s jurrcjA parità di tutti gli altri fattori,
aumenta con l'aumentare della cone dell'acido e col diminuire deldella piastra.
Carica. Il processo di carica dell'acial piombo consiste nella ritrasfornPbSO4 in Pb e PbO2 rispettivament

^ 2
pera il 3,8% in volume, la miscela pufiammarsi o esplodere se viene innescaiuna fiamma o da una scintilla. Per evitaresto pericolo, negli impianti di b., oltre crsicurare una buona ventilazione dei loc;impiegano particolari accorgimenti per (re inneschi.Quantità di elettricità (capacità). A causareazioni parassite sopracitate, la quantielettricità in Ah che occorre fornire aldurante la carica per ripristinare l'inter

tanziamento. Al posto"o si sta facendo stradasintetica. Citiamo infinelilità di impiego di TNTi fibra sintetica come seittenere grandi quantitàtienti a liquido immobiliDme materiali per la cosper accumulatori in coiggi abbandonato il leg:io e. si tende, ad ahhanr

in precedenza. La conservazione allosecco è ottima e non richiede alcun intto. Per la messa in funzione basta riemcelle con l'acido e dare eventualmentbreve carica. Precedentemente invecegazzinaggio e la messa in servizio eran<tosto laboriosi.
Batterie avviamento monocoperchio. Il sidi chiusura delle celle e di collegamenttrico fra di esse ha subito in questi ultirr

uso di miscele tixotropiche nellparatori assorbenti, ecc. e nelliluppo di gas è reso minimo medi carica e caricatori speciali.
Batterie attivabili con acqua. Si:arica secca in cui basta introdidché acido per la messa in sergià contenuto nell'elemento, è adi silice, allumina o speciali se

sizione di Beckmann furono compiitto che a quei tempi non era noto alo che permettesse l'attribuzione ini;:a della configurazione di una coppi3 isomere. Teoricamente, infatti, ilstereospecifico della reazione potevipiegato sia con uno scambio di pappi in posizione sin rispetto al do]e ossimico, sia con una analoga midei gruppi in posizione ariti:

La reazione di BecKmann puòtanto, considerata come un casdi sostituzione nucleofila del tipil gruppo migrante agisce comecleofilo attaccando l'atomo di azcioè dalla posizione più remotgruppo uscente (OHe). In accointerpretazione si osserva che Lreazione dipende sensibilmentenucleofilo del gruppo migrante Ril riassestamento delle metilch<liche ^-sostituite è accelerato di

sestamento è indotto essenzialmeidonazione dell'ossima che detenile polarizzazione del legame azonecessaria per la migrazione inti; del gruppo R. Dopo la migra;stamento è completato dall'attacia sul carbocatione imminico,perdita di un protone per dare la:a dell'ammide.
meccanismo sostanzialmente a

me tk'gli x-dic/ietoni e degli tx-ia11 riassestamento delle monoschetoni è in genere seguito da uiindaria che provoca la fissione euè frammenti relazionati struticonfigurazione del derivato

Per la maggior parte delle ezioni di reazione più soddioriginariamente descritte1886. Secondo tale metodol'ossima in etere anidro viequantità equimolecolare disforo e la miscela viene rtperatura di —20°. L'isolaiviene quindi effettuato dee

. Durante la reazione si formito cristallino costituito da un eolare del toluene (unamole)conmile (due moli), che per succesito con acqua si decompone ccdi b. e di una miscela di clorurcido cromico:

aromatico che viene usato in prò
Derivati della benzaldeideNitroderivati. Questi composti deib. per sostituzione di uno o più atgeno dell'anello benzenico congruppi —NO2. Sono sostanze soliigiallo poco solubili in acqua, facilbili nella maggior parte dei solveiI tre derivati monosostituiti, le o-,zaldeidi, fondono rispettivamentee 106°. L'isomero meta può esse

tione in corrente di vapore. La pre:gruppo ossidrilico in posizione ortc"ormilico favorisce la formazione;ame a idrogeno intramolecolare eieide salicilica molto più volatile•o para (p.f. 115°).
In presenza di acidi minerali l'a;ilica condensa facilmente con i e

stata rettificata per rimuover!forati, e stabilizzata in modoformazione di gomme. Quespiegata come combustibile p
La maggior parte dei prirjstata svolta in Gran Bretagmesperimenti di Murdochsull'ubone per illuminazione, furogas illuminante olii vegetali, 1'altri olii, facendoli passare atscaldati ad alta temperatura

ai produzione degli impianti di carbonzione del carbone, come fonte unica dicarburi aromatici. L'industria del petrolin grado di aumentare la produzione nonmediante ricupero della piccola quantitànel petrolio naturale, ma anche mediantdozione di nuovi processi per la convenin prodotti aromatici di materie nrime e

Mediante questa formula si spiega cocesso la formazione di un solo derivainosostituito del b. Ladenburg ossenquesta formula potrebbe tuttavia condquattro isomeri derivati bisostituiti, meeffetti se ne riscontrano soltanto tre; 1perciò propose che i doppi legami o:sero rapidamente tra posizione alteri

'industria il catalizzatore pmpiegato è l'acido fosforiiossile. I meccanismi propctriplicano l'attacco elettrof)ltre il primo stadio puòtll'influenza attivante deltlchilico. Una ulteriore ejuanto non sempre indesi;he il gruppo alchilico si;orso della sostituzione; a

ceue nei inouo seguente:Cl2+FeCl3 ^ Cl++FeClj-
e attacco elettrofilo di Cl+.Lo iodio non reagisce se non in
di un agente ossidante, ad es. acidiI fluorobenzeni sono ottenuti con irdiretti.
Il clorobenzene è prodotto industifacendo passare il eloro secco nel 1

Il I 1 1
e che si ritiene sia formato attravetura Dewar del benzene (Srinivas;
PreparazioneLa preparazione industriale del ta materie prime e procedimenti di'cipali dei quali sono di seguito de:
Produzione dal carbone. La disii!carbone è impiegata per tre scop

iti di ebollizione sono rispettivamente 71,45 e 77,4°. Per alcuni scopi il b. deve esser*sriormente purificato per ridurre la con-trazione di queste impurezze. I procedi-riti sviluppati a questo scopo si basano sulle•azione selettiva con solventi oppure sul-distillazione estrattiva. Il processo Ude>ote, 1958), progettato in origine per trai-ì raffinato di petrolio, per quanto appli-ile anche al benzolo ottenuto dalla carbo-sazione del carbone è un nrnceriimentn d

inazione e aumentata in una seconda usr la separazione.Uri metodi di rettìfica. Sono stati mesunto numerósi processi per l'idroraffinaziitalitica del benzolo (Bochman, 1958), acjelli della Scholven-Chemie, Lurgi, Koppari Stili e U.O.P. Questi processi sono divìltanto nei dettagli di ingegneria chim

itallizzazione non è stretto per akdi b. per nitrazione, ma lo può e
ani tipi commerciali ; il colore del 1izione preliminare dell'assenzaze; il contenuto in zolfo totale è0 per combustione del campioneninazione degli ossidi di zolfo fcla fonti petrolifere normalmenteanto tracce di composti solforati1 è lavato con acido solforico; ia, non è necessario l'esame di n

divi nil benzeni
metilfenilcarbinolo
solvente

nte anemia. I sintonmia, diminuzione delore, dispnea da sf(jrragiche. La massimibile nell'aria, per unarnaliere, è di 20 ppm irl 46 % del b. inalatopò ed assorbito rapic. è eliminato parzialne e nelFurina, in graieme a pirocatecolo <

juuecnoenzene.attenere il detergente. L'iiina lineare e la solfonazionlisce un alchilbenzene line;3iù facilmente biodegradaìtituendo il dodecilbenzen

; è poco solubile in acqua a fre a caldo; cristallizzata da ai22°.3. trova numerosi impieghi na. Può essere anzitutto usata <precipitante nei confronti etutto solfato, ma anche irito e fosfato. Un precipitail solfato di b. si presta alla tiìetrica o, se in microquantità,a. Talvolta la b. viene usata arosante di cationi metallici.:go più comune si basa sulla ;

lilcarbazolo con cloranile inQuesto pigmento presenta
:tto brillante a fiamma bluasuo prezzo molto alto ess
otevole interesse commerciip. prre.11e.nti snlirlità crenp.r:

nell'attività sedativa,ticonvulsiva nei topi tto meno efficaci nei (mento di fuga condìl'addomesticamento i
Quando viene sopossido radioattivo aimetil (Ro 5-0883) ristuente nel sangue, nel

bolita principale iV-demetildiaz<al diazepam nell'attività mioìtopi e nei gatti, nell'attività antktopi e nella riduzione del compfuga condizionato nei ratti e nAnche il 3-idrossidiazepam è simal diazepam. Comunque, il metidrilato, l'oxazepam, è generalmecace del diazepam. I metaboliti <la posizione 4' hanno debole s
Nei tnni la somministrazione

na serie di lavori da Guerrero-Fi|1967, 1968, 1969, 1970). Le coniriportanti sono le seguenti:a) quando dei cristalli di ossid
io sono sistemati nel nucleo tal;iminare di gattini, compaiono sirafici e di comportamento che aquelli del piccolo male epilettice
nali sono soppressi dal diazepab) si determinano foci epilettoj
ei gatti adulti per inserimento -lluminio nell'ippocampo. Si svii5condari nelle regioni connesse

ce di causare variazioni distinte nel compoitamento nel suo complesso. Si è quindi osservato che il cloridrato di clordiazepossidalla dose di 10 mg/kg per os non ha influenzsul numero delle risposte al segnale ricorrpensato, ma aumenta sensibilmente i tentatadi aprire la porta dopo il segnale non ricorrpensato. La cloropromazina, alla dose e5 mg/kg per os, non influenza le risposte <segnale non ricompensato, ma diminuisce ser

L'azione anticonvulsivante del diazepam neitopi è rafforzata dall'a-metildopa ed è antago-nizzata dalla reserpina (Diez Altares e DeBonnevaux, 1969).
L'effetto stimolante dell'anfetamina nei to-pi è potenziato da basse dosi di diazepam maantagonizzato da dosi alte (Montuori et al.,1970).
Lap-idrossilazione dell'anfetamina nei rattiè inibita dal diazepam.
Il comportamento aggressivo indotto dal-l'apomorfina nei ratti è antagonizzato daldiazepam.
La biotrasformazione della difenilidantoinaad opera dei microsomi nel fegato dei ratti èinibita dal diazepam.

Gucnero-Figucroa R., Ryc M.M. , GallarBishop M.P., « Neuropharmacology », '.143.
Harris T. H., « J. Àm. Med. Assoc», 17:1162.
Marcucci F., Mussini E., Guaitani A., FiGarattini S., « Europ. J. Pharmacol. », 1311.
Montuori E.,Gonzalez H. A., Cenai E. E.,Rend. Soc. Biol.», 164, (1970), 191.
Pletscher A.,Psychotropic Drugs in InternaiAmsterdam, Excerpta Med. Foundaticpp. 1-15.
Randall L.O. , « Dis. Nerv. Syst.», (Suprj(1961), 7.
Randall L. O.,Schallek W.,Heise G. A.,Ke
Questa reazione può anche esseritrattando una soluzione eterea dimiscela di magnesio e di ioduro dSecondo Gomberg e Backmann (duzione avviene probabilmente adioduro di magnesio monovalentestrato nello schema seguente:
Mg + Mgl2

di sodio di un radicale libero (sodio-chetile):
C6H5)C= )C—ÓNa©
C.H.-In accordo con la struttura radicalica, il com-posto reagisce rapidamente con iodio e conossigeno e viene decomposto dall'acqua conformazione di b. e benzoidrolo. Misure di su-scettività magnetica suggeriscono che in so-luzione il radicale-ione del sodio-chetile è inequilibrio con il dianione del corrisponden-te pinacolo:
|-QH5
LQH
eC O <->
C.H
Q H ,
e .1)C—O Na
IC6H5
a©
: - C H B 2Na©
O eMetodi di preparazioneOltre che per ossidazione del difenilcarbinolo,(QH5)2CHOH, il b. può essere preparato fa-cendo reagire il benzene con il cloruro di ben-zoile in presenza di cloruro di alluminioanidro:
0
HC1
La reazione, che rappresenta un'importanteapplicazione del metodo di acilazione di Frie-del-Crafts (v. FRIEDEL-CRAFTS, REAZIONE DI),viene condotta usando un eccesso di benzenecome solvente oppure aggiungendo come di-luente il solfuro di carbonio. In entrambi icasi l'acilazione del benzene procede esoter-micamente e viene portata a completezza me-diante un breve riscaldamento a ricadere. Ter-minata la reazione il solvente viene allonta-nato per distillazione ed il residuo trattatocautamente con ghiaccio ed acido solforicoper decomporre il complesso col cloruro dialluminio. Il b. viene, quindi, estratto con eteredietilico e purificato mediante distillazione apressione ridotta.
Un metodo di preparazione sostanzialmenteanalogo, che può essere applicato alla sintesidei diarilchetoni simmetrici, consiste nel trat-tare il benzene con fosgene in presenza dicloruro di alluminio:
+ COCl,
A1C1S
+ 2HC1
Un altro procedimento di laboratorio per lasintesi del b. si basa sull'idrolisi del difenildi-clorometano, il quale si può ottenere facil-mente facendo reagire due moli di benzene
con tetracloruro di carbonio secondo il me-todo di alchilazione di Friedel-Crafts :
+ CC14
Aia,
H,0
V
2HC1
Impieghi
II b. ha un intenso odore che ricorda quellodei fiori di geranio; per questa proprietà essotrova impiego come profumo di basso costoe per la preparazione di saponi. Nell'industriafarmaceutica, inoltre, il b. viene usato comeintermedio per la produzione di alcuni anti-istaminici ed ipnotici.
Omologhi
Dei tre metilbenzofenoni, gli isomeri orto emeta sono liquidi che bollono a 315° e a 314°,mentre l'isomero para è un solido che puòesistere in due modificazioni cristalline: for-ma x, p.f. 59°; forma fi (instabile), p.f. 55°.Essi vengono preparati facendo reagire il ben-zene con i cloruri degli acidi toluici corri-spondenti secondo il metodo di Friedel-Crafts;così, ad es.:
H,C
"CI
A1CI,
H,C
Con un procedimento sintetico analogo è pos-sibile preparare la maggior parte degli omo-loghi superiori del b.
In genere, la presenza di gruppi alchilici su-
COSTANTI FISICHEDI ALOGENOBENZOFENONI
MONOSOSTITUITI
Sostituenti Formula P.f.CO
P.e.
2-cloro3-cloro4-cloro2-bromo3-bromo4-bromo2-iodo4-iodo
o-ClCeH.COC.Hsm-ClC.H,COC,Hs
.P-CIC.H.COC.H»o-BrC«HtCOC.H5
m-BrCH.COCH,/>-BrC,H,COC«Hs
0-IC.H.COC.H..p-IC,H.COC,Hs
46837642778232
100
330—
332345
—350210—
gli anelli aromatici non modifica sensibilmen-te il comportamento chimico del gruppo car-bonilico rispetto a quello del b. Nei derivatio-disostituiti, tuttavia, l'impedimento stericodovuto ai gruppi alchilici diminuisce ulterior-mente la reattività del carbonile nelle reazionidi addizione con i derivati dell'ammoniaca(idrossilammina, semicarbazide, fenilidrazi-na, ecc).
Di particolare interesse per la sintesi degliidrocarburi antracenici, è la pirolisi dei deri-vati del b. che hanno un gruppo metilico inposizione orto al gruppo carbonilico. La rea-zione, scoperta da K. Elbs (1884) (v. ELBS,REAZIONE DI), viene effettuata riscaldando ildiarilchetone alla temperatura di ebollizioneo a 400-450°:
H,C
CH3
2,5,3' - trimetilbenzofenone
CH,H,0
2,7 - dìmetilantracene
DerivatiAlogenoderivati. Derivano dal b. per sostitu-zione di uno o più atomi di idrogeno dei nucleiaromatici con uno o più atomi di alogeno : leformule e le costanti fisiche dei termini piùsemplici sono riportate nella tabella.
I monoalogeni derivati del b. vengono ingenere preparati con la sintesi chetonica diFriedel-Crafts a partire da benzene e dai clo-ruri degli acidi alogeno-benzoici. Un altroprocedimento di applicazione generale si basasull'ossidazione degli alogenuri del difenil-metano con anidride cromica in acido acetico.Così, ad es.:
CH^COOH
\
CrO,
Nitroderivati. Sono sostanze solide di coloregiallo o giallo arancio, insolubili in acqua, so-lubili nella maggior parte dei solventi organi-ci. I tre derivati monosostituiti, o-, m-, e/>-nitrobenzofenone, fondono rispettivamentea 105°, 95°, e 138°.
L'isomero orto si prepara per ossidazionedel 2-nitrodifenilmetano con anidride cromi-ca, mentre gli altri due isomeri vengono ingenere sintetizzati per reazione dei corrispon-denti cloruri degli acidi nitrobenzoici con ben-zene e cloruro di alluminio.
Alcuni derivati disostituiti, come ad esem-pio il 3,3' ed il 3,4'-dinitrobenzofenone, pos-sono essere preparati, rispettivamente, per ni-trazione diretta con la miscela solfonitrica
368

Amminodenvati. i principali derivati monedisostituiti si preparano facilmente per ridzione dei corrispondenti nitrobenzofenoni ocloruro stannoso ed acido cloridrico.
Di particolare interesse per la sintesi di '.boratorio sono alcune reazioni di ciclizzazine, caratteristiche dei derivati del b. aveiun gruppo amminico in posizione orto al cibonile. Per riscaldamento in presenza di bi(

5. Proprietà fisicheno Nella tabella I vengono r:. prietà fisiche del b.il Spettro UV. Lo spettro L- (fig. 2) mostra tre bandli 281 nm (e = 3,2-IO3), 27'- 244 nm (e = 1,05-IO4).

ad una miscela di composti e :chilbenzofurano.
Al contrario, l'attacco eleticui l'eterociclo è protetto da alialchilico, è molto più sempliccondurre e da una resa maggi*b. stesso. In tal modo si è potin maniera sistematica le posi:

Anche altri derivati del b. sostituiti izione 3 da un gruppo elettron-attrattoni 3-ciano- ed i 3-carbetossibenzofuraisoggetti, poco o molto, a trasformaziologhe. Infatti, la rottura dell'anello eteco dei b. mediante reattivi nucleofilipossibile allorché il debolissimo impoveto in elettroni della posizione 2, che èal normale effetto induttivo ncoatìvn

geno e un iatture antiemomi/) gli spirocumaranoni fi
griseofulvina;g) le aflatossine e la steri
sono rispettivamente metalgillus flavus e dell'Aspergillustituiscono dei potenti e progeni;
h) gli alcaloidi, il cui printante è la morfina ben nota t
lo relativo alla formazione dei b. binelle posizioni 2 e 3, quale il 2-metibenzofurano, per reazione fra i fen1,1-dialogenociclopropani, come, perdicloro-2-butilciclopropano :

e) con un estere a-alogenato, come, peres., il bromoacetato di metile, Pa-cloro- oa-bromofenilacetato di etile e, soprattutto, ilbromomalonato di etile impiegato nella rea-zione di Tanaka:
COOC2H3
O
Trasformazioni analoghe possono anche es-sere effettuate con i chetoni ossidrilati in orto,benché sia tavolta difficile, se non impossibile,avere la certezza della ciclodisidratazione delprodotto intermedio formatosi con i reattivialogenometilati. È per questa ragione che nonsi possono preparare i nitroderivati del b.trattando questi chetoni con il bromonitro-metano come si fa così facilmente con le al-deidi corrispondenti.
La preparazione del 2-acetilcumaran-3-onea partire dal cloroacetone e dal salicilato dimetile:
/ \ X O O C H 3 CI[ O l + CH.
costituisce un'altra illustrazione dello stessomodo di formazione dello scheletro del b.
Benché differisca dai metodi precedenti peril meccanismo di reazione, bisogna egual-mente citare la condensazione dell'aldeide sali-cilica e del metilen-bis(etilsolfone) che consi-ste in un'aldolizzazione:
OH SO2-C2H3
CH-CH\
SOrC2H5
SO2-C2H5
Infine, è stato più volte segnalato che la rea-zione fra lo ione trimetilsolfossonio ed un'o-idrossialdeide forma un epossido:
e ®,CHSHO—Ar-CHO+CH2—S( ->
IXCH 3O
HO—Ar-C—CH2
CH3 /CH3
-» S +HO—Ar—CH—CH2
O VQuesto viene successivamente trasformato in3-idrossicumarano, sotto l'azione del dimetii-solfossido (DMSO):
Eterociclizzazione di derivati arilici con dueatomi di carbonio.
c—
II procedimento consiste quasi sempre nellaciclodisidratazione di composti /?-(arilossi)-carbonilici o carbossilici per mezzo di varimetodi :
a) fin dal 1900 Stoermer propose la tra-sformazione in b. delle arilossiacetaldeidi edei corrispondenti acetali dietilici:
b) si possono ottenere i 3-metilbenzofuranio molto più facilmente i 2-alchil-3-metilbenzo-furani rispettivamente dagli arilossiacetoni edai 3-(arilossi)butan-2-oni e da alcuni dei loroomologhi :
O
R = H, CH3, alchile superiore
e) la ciclodisidratazione degli arilossiace-tofenoni e degli arilossipropiofenoni è accom-pagnata, talvolta, a seconda delle condizionisperimentali adottate, da una migrazione delgruppo arilico dalla posizione 3 alla posi-zione 2:
R
O
Ar
d) i 2,3-diarilbenzofurani si hanno per ci-clodisidratazione degli arilossidesossibenzoini:
e) dagli arilossiacetilacetati di etile si ot-tengono gli esteri cumarilici:
COOR
R=H,C2H5
/) per ciclodisidratazione degli acidi arilos-siacetici si ottengono cumaran-3-oni :
Le reazioni di ciclodisidratazione viste soprapossono essere realizzate nelle più diverse con-dizioni sperimentali, adattate caso per caso,sotto l'azione di numerosissimi agenti fra iquali i più frequentemente usati sono l'acidosolforico, l'acido cloridrico, il cloridrato dipiridina, l'acido ossalico, il cloruro di zinco,il cloruro di stagno o quello di alluminio, ilpentossido o l'ossicloruro di fosforo, l'acidofosforico, a temperature più o meno elevatee a pressione ordinaria o a pressione ridotta,l'idrossido e il carbonato acido di sodio.Talune di queste reazioni possono avvenireper semplice riscaldamento od anche per ir-raggiamento luminoso.
Benché non si tratti più di una ciclodisidra-tazione, anche altre eterociclizzazioni dellostesso tipo possono essere ottenute con i clo-ruri degli acidi arilossiacetici, che formano icumaran-3-oni mediante una reazione diFriedel-Crafts intramolecolare, in presenza dicloruro di alluminio in benzene oppure congli eteri allilici dei fenoli, che il cloridrato dipiridina, in particolare, trasforma in 2-metiI-2,3-diidrobenzofurani :
CH=CH2
Infine, se si ammette che la sintesi del b.stesso, a partire dal fenolo è dall'etanolo, chesi effettua ad alta temperatura in presenzaspecialmente di allumina, passi attraverso lostadio transitorio di fenetolo, anche questasintesi mette in rilievo lo stesso tipo di for-mazione caratteristica dello scheletro benzo-furanico.Eterociclizzazione di un fenolo sostituito inorto da una catena a due atomi di carbonio.
C—
Questo schema generale comprende parecchievarianti :
a) la deidrociclizzazione ossidativa del 2-
374

ilfenolo in b. che può esserindo semplicemente sui 55mpre viene effettuata in r.di catalizzatori metallici:b) l'eterociclizzazione deialchinilfenoli di cui si conempi. Il più semplice e piila sintesi del b. messa a pi;1 1893, e che consiste nel t

Impiego di O-arilossime dei dialcharilalchilchetoni. Si tratta di un adinella serie ossigenata, della sintesi e
io di Fischer. Si opera in presenza dile ridrico in etanolo o di trifluoruro>n etere :

di Sintesi biochimica:coati Malgrado sia poco
biogenesi della striico dalla formazione eda pra quello omocicsa, uno dei due modidi a) in un precurs<

l'anello benzenico il gruppo caorientante in meta con disattivaziad es., nella reazione di nitrazioiuna miscela contenente I'8O % di ise il 20% di isomeri orto e para.
Fonti naturali
In natura si trova allo stato liberoprovenienti dalla corteccia di alb

conda colonna (pnismng conpuro in testa e prodotti aliche vengono inviati al reatbenzile, bifenile, metilbifen
La conversione per passaintorno al 40%, le rese in a90 kg per 100 kg di toluequesto processo la Dow hadi a. b. nel 1970.
In Italia l'a. b. è prodottViscosa che ha messo a punt

'idrolisi, mentre il resto va alla puriSono stati descritti e brevettati E
Drocessi per la fabbricazione dell'ilon tutti hanno trovato applicazicstriale; verranno riassunti qui di3iù significativi.Produzione dell'acido benzoico dalbe•eazione, applicabile anche aglialcrìd ai naftaleni, rappresenta un'estena reazione di Friedel-Crafts :

l'acqua e con i solventi ossidrilati. Stenere per azione del cloruro di tiorpentacloruro di fosforo sull'a. b. /todi di ottenimento sono Fazionecloruro di fosforo sul benzoato didel eloro sulla benzaldeide. Si è giàpuò essere ottenuto industrialmente etricloruro e a. b.; la Monsanto hamente brevettato un processo perda policloruri alchilici e sali metallib. Infine può anche essere ottenuto daftalica in presenza di acido doridi

re in soluzione ammoniacale, quando purtra in competizione il legante NH3. Il pretato si presta alla determinazione gravimedel Cu, una volta lavato e seccato; tutl'a-b. viene impiegata per la ricerca quitiva di tracce di Cu : operando alla tocccarta da filtro se ne riescono a rivelarea 0,1 [j,g.
L'oc-b. trova impiego anche per l'analismolibdeno e del wolframio, elementi chegono quantitativamente precipitati dal re;

murarii. La tendenza al resicora più spiccata nei 2,2-crealizza con etanolo acido p<o per acido acetico:

I cromeni si possono ottenere pezione dei cromanoli ; così bollendometilcroman-2-olo con acido ossalzene si ottiene il 2,4,4-trimetilcronceversa i cromanoli si possono ottzionando ai cromeni cloruro mer<do composti che sono poi facilmezabili. I cromeni si riducono a ciH2 in presenza di catalizzatori al .Raney. Addizionano inoltre alcilo+HC1) per dare gli etossicromani

Anche in questo caso l'internimenolo. I solventi più usati sotico e l'acido formico. Naturanoli o composti dicarbonilicireazione si può orientare in duCosì da benzoilacetone e resonavere due diversi sali di benzo

Fra i derivati ossigenati delsono noti oltre che l'isotiacunalchilisotiacumarine e gli acirinici.
La isotiacumarina (p.f. 78-7nere partendo da un prodottzione della rodanina con met

LO spciuubande principali della naftalina, eun buon accordo ; gli spettri di fludi massa sono stati invece rispettiscritti da Heckman e da Haines. L'spettro IR ha d'altra parte conattuali concetti sulla struttura del

zioni nella molecola del b.legame C2—C3; ciò è conizione di idrogeno per ridiLiAlH4 o altri riducenti, e2,3-diidrobenzo[è]tiofene.
La sostituzione con metadi resola nella oosizione

Degli omologhi trialchilici delpreparati, mediante disidratazispondente solfuro dell'acetofencmente il 2,3,5-trimetilbenzo[6164-165° a 13 Torr; p.f. 56-57°;metilbenzo[è]tiofene (p.e. 143-1'Krollpfeiffer ha ottenuto il 2,3,'logo per condensazione internasali di solfonio dell'acetofenoni

(ucst'ultimo procedimento è iler la produzione dei derivati 2-. Il 2-fenilbenzo[6]tiofene si foraotto secondario nella sintesi d•afenilbenzo[/>]tiofene, per riscajluene e S a 250°. Con lo stelento usato per gli omologhi diaibile ottenere il 5-metil-3-fenilbe3.e. 162° a 1 Torr) facendo rea,oil-4-metiltioanisolo con solfatecido cloridrico:

Druskel II. V., Sominers A. L., «(1967), 1819.
Elderlìeld R.C. , Heterocyclic CYork, John Wiley and Sons,
Gattermann L., Lockhard A., «2808.
Gesellschaft fur TeerverwertuniPat.,(1918), 325-718; «Chem. 2
Gronowitz S., « Arkiv Kemi », 'Haines W. E.. Vernon M. R., Co<
«J . Phys. Chem.», 60, (1956)Hartough H. B., Meisel S. L., Co
deriseci Thiophene Rings, NewPubi.. 1954.
Hausch S., Blandon P., « J. Am(1948), 1561.

potassio, con sviluppo di idrog<zione di un berillato.
Il diagramma dei potenziali stsidazione è, in soluzione acida,
Be X-85V> Be2+
In soluzione basica il potenzialiossidazione è 2,62 V.
Per quanto generalmente veriionici, i legami formati dal Be insti hanno carattere prevalentemecome si potrebbe del resto prevcvata elettronegatività del Be (t£stato fondamentale 1 s2 2s2, il Be

viene aggiunto per complessare altma non devono essere presenti fiiprova chimica più sensibile per il Ebasata sulla fluorescenza sviluppatesso reagisce con il 3,5,7,2',4'-piflavone (morina) in soluzione di idsodio a pH superiore a 11. In condìtrollate, viene raggiunta una sen0,004 [xg di Be in 100 cm3. Questo mtavia, non è molto specifico, per cude prima la separazione del Be dagl

invece la struttura cubica del tifSi possono ottenere leghe di Bi
cendo fondere insieme i due met;scala commerciale vengono ottenute la riduzione diretta di BeO corsenza di Cu a circa 1800-2000°. S]mente si è trovato che le rese mijtengono quando viene formata uricontenuto di Be tra il 4 e il 4,25lega madre viene poi utilizzata ]

bilmente perché difficilmente le frattino a passare oltre il bordo dei granipotrebbe migliorare la duttilità del Etemperatura, se fosse possibile stabforma cubica a corpo centrato che si 'temperatura. Il moto delle dislocazioTalmente più facile nelle strutture <

con lo ione i$e^; questo processo aumenaumentando il pH della soluzione.
È stato molto approfondito lo studio dl'idrolisi dello ione Be2+. Uno degli studi pconclusivi è quello di Kakihana e Sillén, efornisce le seguenti costanti di equilibrio:3Be2++3H,O ± Be3(OH)|++3H+
1
2Be2++H,O ?±Be.,OH3++H+

struttura simile a quella della silicisita della massa fusa viene diminuìl'aggiunta di fluoruri alcalini, perrottura di legami Be—F—Be; inraffreddamento di queste masse figono materiali vetrosi. Una perBeF2 troppo bassa provoca la fotvetri torbidi per la separazione discibili o per un inizio di cristallizzi

;li altri boruri di Be non si scio!! boruri di Be sono ottenuti tutlliretta degli elementi a circa 1'andò i boruri di Be con C ;;ono stati ottenuti i carburi i3eC2B2 e BeC2B12; il primo hatellina esagonale con ao = 10,84
I boruri di Be sono utilizzabi•iali refrattari data la lentezza drito durante il riscaldamento ir)ssigeno o di azoto, lentezza d(nazione di pellicole protettive ;

si decompongono totalmentenando ammoniaca ed ossoacetComposti simili si formano conìna e l'etilammina, la butilardina. Questi composti sono tuite instabili e si decompongonolento oppure sciogliendoli in so!oroformio. La struttura di questittora argomento di discussion

rialmente. Il nitrato anidro di berilliito per reazione del cloruro anidroluzione di N,O4 in acetato di e! ilein N2O5 liquida. Per riscaldamenlloto fino a 50°, questi compost si>ngono per produrre i sali anidri. Il Bava limitata applicazione nella fabbr:lle reticelle Auer, essendo aggiunteila quantità ai nitrati di torio e ceri

nioiiKi del HcSOj. Il lk-SO, Iloppi con i solfali dei metalliC.,SO,BeSO4-2H2O, (NH4)2SCNH4)2SO4BeSO4. Non si ha[uè, alcuna prova che in qu<ine siano presenti solfato-corJeSO4 esiste anidro in diverse f<^a forma stabile (a) è tetragor0 = 6,90 À) e ha una struttureIella cristobalite. A 588° la foi

e BERILLOele. Il berillo è un silicato di be5, ma attraverso più accuratela messa in evidenza la presenzii- talli alcalini, compreso il rai:o II nome, di origine sconc
noi dal greco (ÌEQÀÀOVQ; quein tempi remoti per indicaminerali alla fine del settespecifico per questo miner,

Fra le caratteristiche del b. si devehe esso è inattaccabile da parte degli;scaldamento tende a perdere acquaDstanze volatili a 800°. Riscaldato cc00° si decompone in fenacite (un siliciIlio) e vetro, mentre, da solo, il b. foniruentemente alla temperatura di cin11 tipico luogo di ritrovamento del
e e della varietà acquamarina sonoHrncp Hf*11f» impomatiti oranitir*lif» 1

-1 ,35 V per la coppia Bk3+/zioni di H2SO4 di concentrazfra 0,5 e 2 M). Questo potenzconfrontato con un valore di iper la coppia Ce3+/Ce4+, misurimezzo con la stessa tecnica eie
Preparazione di laboratorioI radioisotopi del Bk con nuifino a 248 sono preparati per r<ticelle cariche con nuclei di a

due isotopi del Bk di mago il 2"Bk e il -J9Bk, date
medie sono sufficientemeinettere numerosi trattamenlio dei loro composti. Comi, solo il 249Bk può essere pro>apprezzabili. Esso viene prenucleari ad alto flusso per
iazione con neutroni di attinìe 238U, 239Pu e 2i3Am: il sui

giaiio-verae, per aggiunta di amnuna soluzione di BkIv.
Il BkIV può essere ottenuto per <di Bk"1 con NaBrO3 in H2SO4 2solfato forma un complesso con icendo il potenziale di ossidazionepia Bkm/BkIv. Anche il bismutatpuò essere impiegato come ossidaiviene una riduzione radiolitica da ]

per indicare la b. della glieina, il più sicomposto cioè della famiglia delle t
(CH3)3N-CH2COOH
La b. della glieina è otticamente inatun solo gruppo dissociabile, quello e;lieo, il cui pK'n è 1,84.
La b. ha una solubilità di 160 g/100H,O, di 55 g/100 cm3 di metanol8,7 g/100 g di etanolo.
Fonti naturali e isolamentoLa b. della glieina è stata la prima b. e

Il consumo di acqua sotto forma di bessere valutato, in media, sui 1000-1501giornalieri, variabili con le condizionilogiche legate al clima, alla dieta, allae per gli effetti indotti dai costituentib. stessa.
Le b. possono essere distinte in liq.consumarsi freddi o caldi, di sola acquarale o contenente diversi soluti, liquidilogici di origine vegetale (succhi) od an
ui
r*ttpmitt=> npr

(ìli infusi generalmente vengono pre]reltamenle sospendendo il materialecalda o per percolamento, in sovrapped anche stemperando in acqua deg.concentrati ed essiccati (v. CACAO; CAILatte. Il latte può essere posto in cofluido fresco, risanato per pastorizzconservato per sterilizzazione o pertrazione. Viene anche sottoposto

tigliamento a caldo. Il liquido, sottopctrattamento termico con uno scambiatpiastre o a tubi, capaci di resistere alla spressione dei gas disciolti a temperaturanaria, viene introdotto caldo (55-65°) iltiglie, che hanno subito un ciclo di la\senza risciacquo a freddo.
Il recipiente viene riempito raso boccifreddandosi si raggiunge il livello noimantenendo un basso livello d'ossigerliquido.
Per la distribuzione di liquidi tranquil

può cs!>cic uiicnoilucilie agglomeralotaneizzato) per una più pronta solubiline, indispensabile per la distribuzionecon apparecchi automatici.Controllo di qualitàI controlli relativi all'acqua come b. icomponente nella preparazione delle bprendono i dosaggi chimici di azotoniacale, nitrico, nitroso, proteico, di s(organiche, di ossigeno disciolto, di S(degradabili (BOD, COD), di tensioattii•nini R c\\ altrp Qoctflnyp p^traìhilì r*r»n i

la ucscriHX'iiiia;. »JII a. o. ucna sene Lbutano sono stati isolati dalle foglie dixylon coca (acido truxillico ed acidoco), mentre quelli aventi l'anello del epano [(+)-?ra«.y-3-(2-carbossi-l-prop<

ano più grandi di quelle dell acuipende dalla posizione reciproca <irbossilici. L'aumento della dist;ruppi carbossilici diminuisce la eissociazione. La costante di dissocili a. b. dipende anche dalla loroone geometrica (tab. III).La differenza fra i valori del pKa

andò gli aldeidoesteri o i chiere cianacetico oppure mediale di Michael di HCN agli es)uesto metodo viene usato ania per la preparazione dell'aclartendo dall'estere cianaceti'dipico dall'adipodinitrile, ecc.risultati da l'idrolisi alcalinasteri facilmente ottenibili:diante la condensazione di I

isproporzionamento dei sali alcali:li aromatici monocarbossilici è un :;ifico per la preparazione di a. b. aPale metodo è raccomandato per laone su scala industriale dell'acido tt>er riscaldamento del benzoato di fsresenza di catalizzatori, quali i;o o di cadmio, oppure gli ossidi di ;ssidi ferrici.

jli studi compiuti con i raggi X e con ilodo della diffrazione elettronica hannotrato che gli anelli benzenici che costituis'1 b. ed alcuni dei suoi derivati, sono ap]imativamente planari ed esagonali e ciunghezza dei legami C—C è quella pre1,39 À). Anche la distanza del legamearilico C(l)—C(l') è molto vicina (1,48ase vapore e 1,50 À nel cristallo) a qprevista per un legame singolo fra due a

onti in posizione 2,2': così laIX) reagisce con il bromuro diio (1) per dare il sistema bifenil+)-fenildiidrotebaina (X) che halente la configurazione R del sisco. La configurazione Sdel (+)-d

: le rea/.ioni di sostituzionesoprattutto Targazione, noncolari caratteristiche. Infattida luogo alla fenilazione conizoile a 80° con formazione48,5%), meta (23,0%) e paraita della reazione, come è pre-mo superiore a quella che si;. Gli indici di valenza liberano una reattività abbastanza3ne 2. Questo però non acca-sere una consesnen/a desii

Si possono generare radicali arilictrasposizione termica e decompuna /V-nitroso-iV-acetilarilamminavente aromatico, come si vede nne (10):
Ar(CH,CO),CK NH NOCI .
nn> oNO + N.O,

BILIARI ACIDIn->>j I comuni acidi biliarn ROIDICI COMPOSTI) a 2
gruppo carbossilico i8- o tre gruppi idrossili4* 1 gruppi idrossilici pò:
oxo gruppi. In alcune :es con gruppi idrossilici11 ' nella catena laterale.))> a. b. sono 5/3 saturi,
^/v caturi (^r\A\ 5i\\{W~\\

cui la. seguilo in rouuradi litio e alluminio da l'acidoLa bromurazione del 7-oxolitotile consente di ottenere il corribromoderivato, che viene trasfoj7-oxo-3a, 6a-diossi-5-colanoiccTakeda) mediante blanda saporriduzione del chetolo di Takeidruro di sodio fornisce acido itre la riduzione secondo Meejcon r-butilato di alluminio e isopduce acido /?-muricolico. L'elim

esteri metilici dei corrispondenti acidi esilici C27 con idruro di litio e alluminio,ultimi si possono ottenere combinanacido biliare C2l con l'estere monorrdell'acido .metilsuccinico. Gli steroidi Cossidrile in posizione 26 possono veninsì ottenuti dalla criptogenina (5-colestc26-diolo-16, 22-dione) che, per riduziccondo Clemmensen, da il 5-colestene-diolo. Il 5-colestene-3/3,7a-diolo si pbromurando il benzoato di colesterile ilizzando quindi il gruppo 7a-bromo codo di argento, e poi il gruppo benzoialcali. Il 7a-ossi-4-colestene-3-one puòpreparato dal 5-colestene-3/5,7a-diol(diante ossidazione secondo Oppenhaui

HO
rx"OH
CO
NH
CH-CJ
ac. taurocolico

ciosomialc o milocondriulc dciromogcnatilegato di ratto arricchito con NADPH. .centemente è stato dimostrato che la frazimicrosomiale è molto più efficiente della :zione mitocondriale nel catalizzare la reazicSono state fornite prove che il citocroP-150 partecipa al sistema 26-idrossilasicocrosomiale.Conversione del 5(ì-colestano-3a.,7a.,12oc,26trolo in acido 3a.,7a,12a.-triidrossi-5fi-colesif £ /ir/m Mi ìopto rAQTirin^ ^nmrt^rfro I o fnri

co (acido allodeossicolico).Esterificazione degli acidi biliari.degli a. b. viene espulsa con le fecma di esteri, probabilmente cona catena lunga. Almeno il 25%3,12-diidrossi-5/?-colanoici nelle :rificato. Tra tali esteri predomi;dell'acido 3/3,12a-diidrossi-5/?-colale feci l'acido litocolico si riscontitemente in forma non esterific£l'acido 3/?-idrossi-5/?-colanoico è i

Uiiniulsson II., in «The Bile AcPhysiology and Metabolism », a cuKritchevsky D., New York, Plen
Danielsson H., Einarsson K., in <Basis of Medicine », V, a curaBittar N., London, Academic Pres315.
Fieser L. F., Fieser M., Steroids, NewPublishing Corporation, 1959.
Haslewood G. A. D..Biìe salts, Lon<Co., 1967.

no probabilmente il piccolo spe
chetoglutarico spianando a"impostazione del ciclo citriii che, nel 1929, scoprì l'aderì>LTP) e poi, in collaboraz-, identificò la cocarbossilasi piruvicodecarbossilasi) e
'hilterra, il fondatore della

l'emocianina, la precisazione sulossigeno della metemoglobina e<peso determinante per lo svilìin Italia.
In America Sumner cristallizzcvolta (1926) un enzima, l'ureasipepsina (1930), la tripsina (1932tripsina (1935); W. M. Stanley (del mosaico del tabacco. Per qisero il Nobel per la chimica n
I coniugi Cari e Gerty Cori fu

i organismi viventi, oggi st:colare, cioè biochimico,iche queste caratteristicheio portato all'uso di un lir•e, seppure non sempre orto3iù comune di tale libertàita dall'espressione « legam>, la quale è nata in una dala è tanto efficace ed utilsente inesatta. Un legame,rompersi non da, ma rie

cne cne in preceaenza acclamo accennate.Le vie metaboliche sono rigorosamente con-
trollate e il settore della regolazione metabo-lica rappresenta un nuovo e fertile campo distudio.
Il lavoro metabolico è rigorosamente orga-nizzato nella cellula. Da quando il microsco-pio elettronico ha rivelato l'esistenza di orga-nuli intracellulari, e l'ultracentrifuga ha per-messo di separarli, è stato possibile dimostrareuna distribuzione degli enzimi e una divisionedi funzioni : i mitocondri sono la sede dei fe-nomeni energetici, i ribosomi della sintesi prò-

degli amminoacidi essenzialisintesi che l'organismo uinaipiere. Nell'uomo e negli aninsumono invece particolare ifenomeni di correlazione umche non si verificano negli elulari. La biochimica umana r.plicemente una forma applicatenuto dottrinale suo propri
La biochimica vegetale o fit

alle malattie, potrebbe averemento su caratteristiche biochirti molto stretti ed evidenti esistmetabolismo e farmaci, comistudio degli antimetaboliti edella chemioterapia, o tra careie lesioni biochimiche, come ne(Krebs, 1966).
Una forma di carattere anco]è rappresentato dalla biochimiiquale alcuni metodi strettan

per trasformare una forma di eiun'altra con lo scopo specifico di svofunzione di trasferimento di comunidi informazioni; questo indirizzo (comprende lo studio dei meccanismidi tutte le strutture sensoriali utiliziorganismi viventi e cioè recettori usivi (ivi inclusi tutti i tipi di foto]

irotom. bi ritiene cne la variazione ebera risultante dalla ridistribuzioneani si accoppi, sul lato interno deTana, alla fosforilazione dell'ADP eto accoppiamento dipenda da unATPasi legato alla membrana mitoche è stato dimostrato essere un fatteiale (fattore Fa) per la fosforila2idativa.
Attualmente vi sono molte prove sali sia a favore che contro l'ipotesimotica. In accordo con quanto è rie[uesta ipotesi, è stato dimostrato ci

bre muscolari); la stechiometria di questicessi è, nel migliore dei casi, ancora da erire e, secondo alcuni Autori, rappresentiaspetto di importanza irrilevante; infinequesti fenomeni si verificano in sistemiinvece di muoversi verso uno stato fina!equilibrio, sono da considerare più prò]mente come esistenti in uno stato stazionche richiede, per definizione, un cont:flusso di materia e di enereia tra le fasi s

io- rosi piccoli ioni e per varie molecole, ;di tutto zuccheri, nei batteri e lieviti, nelPe
ol- vescicale e intestinale, negli eritrociti, ec-so ticolarmente studiata è stata la diffusior
litata del glucosio e dell'urea all'internieritrociti. Benché la diffusione facilitata
51) una natura puramente cinetica, unodettagliato delle caratteristiche di quesi
ise cesso porta alla conclusione che il sue

>ostanza trasportata, Fia. costante di FaradR la costante dei gas, e0 il potenziale elettiiella fase esterna e e,,, il potenziale più eill'interno della membrana.
Volendo considerare il trasporto attivoina sostanza ; in termini di termodinamrreversibile, l'equazione (36) deve essere Eliticata:J — PC pnF<-e»-em>lST-L- Jf -TI (

cando la rottura dei legami actiiLa fosforilazione dell'ADP legatepolipeptidica ripristina la repuls:statica tra l'ATPasi e tale catenaquale riacquista una estesa corAnche in questo caso l'idrolisi dipresenta il principale evento enerjto il processo.
Dal punto di vista della termodversibile, è stato dimostrato che,
una giunzione neuro-miioni nervose sono moltotrice della cellula muscoliitture vi è un breve sp;ile l'acetilcolina diffondelolarizzazione della memlscolare. In conseguenzauppo di un potenziale dide come un'onda in tutte1 muscolo striato è coste longitudinali le quali'alii regolari, dei solchi tdepolarizzazione vienembrane che delimitano q

costituite per circa il 99,9% dai primmenti del Sistema periodico. Una difondamentale tra la composizionebiente e quella della materia viventescontrarsi negli elementi chimici che sculiari dell'uno e dell'altra. Infatti,l'ossigeno, che è rappresentato in enteil 40-50%, negli organismi viventi predi gran lunga C, H e N, mentre nell'aabbondano Si, AI, Fé, Ca, cioè tuttiti caratteristici del mondo geologico.
In genere gli e. b. vengono suddivi;o tre gruppi, chiamati rispettivamente

Nel regno animale forma l'esocheletro dei ra-diolari e degli infusori.
Infine, tra gli elementi del II ordine, il ferrcmerita un riguardo particolare tanto che, datala sua importanza, alcuni Autori lo pongonoiddirittura tra gli elementi del I ordine
Tale elemento è indispensabile per tutti gì.ssseri viventi in quanto fa parte di enzimi re-spiratori cellulari, ed è inoltre in tutti i verte-

b) un compartimento extracellunonta a circa 14 litri ed è pari3eso corporeo.
Nel compartimento extracellula;tinguere uno spazio intravascolaiico di circa 3 litri ed uno spazioare che raccoglie circa 11 litri dioari al 15,7% del peso corporeo
Nell'ambito dello spazio extravio possibili ulteriori suddivisioni.:e di liquido che si trova attorno; per le quali costituisce un ambii

: nel bambino se ne riscontraig%; al 50° anno di età da 20vecchiaia inoltrata almeno 40amponenti proteici presenti ne:nti anche nel liquor. Nel liquopoche cellule mononucleate I
).imeicrime sono il secreto della gr

La mucina e le proteineorganici più importanti. Lsce da lubrificante per lastituita per il 30% da carmente in forma di acido ssono rappresentate in mase y-globuline e per il restoalcuni enzimi quali l'a-aracida, la fosfatasi alcalinela /3-galattosidasi, la glucuil lisozima, ecc. L'enzima ]il processo digestivo è sen

tracce di altri elettroliti e scarsissimi maiorganici.
La secrezione di una soluzione con unacentrazione idrogenionica un milione disuperiore a quella plasmatica solleva ilblema sulla natura del processo biosintcellulare che è alla base di questo fenonNumerosi dati sperimentali indicano checellule parietali si forma H2CO3 a parti:CO2 e H2O sotto la catalisi della carbonicdrasi (->) di cui queste cellule sono riil'acido carbonico si dissocia in idrogeniin ioni idrogeno carbonato; quest'ultimitann npl nlasma e vpnonnn sostituiti nell:

gallici ((),(>%) ed in parie inorganiciNella tabella Vili viene riportata la
sizione relativa ai principali costituen1 costituenti inorganici sono rappr
principalmente da Na®, Cle e HCOInime quantità di K®, Ca2+ e HPO^". Iposizione ionica non è fissa, ma tendidificarsi con la velocità di secrezioaumento di quest'ultima si accompagnaumento della concentrazione di HCa una diminuzione della concentrazCle ; la somma delle concentrazioni

kji ixaLia a^iiiyit ui lilduui pai ll\*\jlan, 1111.
:o diversi da quelli chimici e che saranno ilistrati nei loro principi fondamentali. Tali m;odi sono spesso molto vantaggiosi per la sp;ifìcità, anche sterica, e per l'estrema seiibilità.
Metodi biologici propriamente dettiLa storia delle titolazioni biologiche risale setanto a circa quarant'anni or sono. Intorno1920 si definirono diverse unità di attivit

ui ormoni e vitamine, almeno iziale, quando cioè non si siano ;pati altri metodi di analisi. Infbiologico è spesso quello più seiessere adottato per svelare e stiipiccolissime di certe sostanze; ilsaggi immunologici (v. il capitendono a sostituire quelli biolistretto, ma soffrono in una certestessa limitazione delle titolaziinel senso che sono incapaci di s

Il metodo d'impiego deitabella III è illustrato nellevengono riportati sotto Sie C3 (rispettivamente: le tr<dard e del campione), menicolonne è riportato il totalesformate ad ogni livello dicolonna successiva viene irper ciascuna riga della tabeltiplicando la somma dei qcoefficienti in quella data i

l'ausa di variazione
Jifferenza tra preparazioni'egressione linearejeviazione dal parallelismo:urvatura combinatacurvatura oppostaotali (Tr)
_ i
- 1+ 1+ 1- 1
3420 3

sione delle risposte percentucQuesto esempio viene riporte
(1947), il quale analizzò i dati d(1939) mediante i probir, i logit (mazioni, servendosi di procedi]secondo il criterio della massimche richiedono molto più tempqui scelto. I dati sono indicatinee si riferiscono ad un confrontonelle rane, di digitale somminis

stati di valido aiuto per chivitamine del complesso B,riabilità di richieste nutrìdi questo gruppo per spescita. I particolari ceppi <mentazione lattica che si svari dosaggi microbiologiisono essere considerati mhanno sviluppato necessicomposti chimici comples;del complesso B, e sono seche il loro habitat naturaletritizio complesso come il

presenza di quantità ignote della ssaggiare.
Nei dosaggi microbiologici di aril campione viene di solito idrolacidi per liberare amminoacidi dallQuesti amminoacidi liberi sono solganismo utilizzato per il dosaggio ressi quantitativamente, mentre ris]parzialmente, o non risponde affattteine nresenti nel camnione oriein;

microbiologico di un antimctabolitenolo, che rappresenta la modificamerciale stabile della forma naturadell'acido pantotenico e che differiisto per avere un ossidrile al postosile, è un antimetabolita del pantoal momento in cui nell'organismotrasformato nella forma naturale <nato. 11 pantenolo è un inibitorenostoc mesenteroides A.T.C.C. Nsta proprietà è stata utilizzata per udel pantenolo con questo microrg;

zano ic condizioni di trasferimento dcll'eigià di eccitazione, per interazione di risonafra il sito reattivo dell'anticorpo ed il deminante aniigene. Se quest'ultimo non è lìrescente, e in particolar modo se presentamassimo di assorbimento in coincidenzapicco di emissione fluorescente dell'antico!si avrà uno smorzamento della fluoresceprimaria che può raggiungere l'85%. 11todo si presta particolarmente bene peistudio delle costanti di associazione, cometernativa al metodo della dialisi ad equilil

ono coniugate con un fluorocromo, slente con l'isotiocianato di fluorescina,arate dal fluorocromo libero mediante (gel-filtrazione.L'antigene da ricercare deve essere ir
ile, fissato in un substrato adatto all'iazione microscopica (striscio di cellulena di tessuto); il preparato viene fatt(ire cnn trii ahtioorni fluorescenti lavat

determinate condizioni, alla reazione fra aitigene ed anticorpo seguono dei fenomeni visbili, in sé sufficienti a rilevare l'avvenuta re;zione. I metodi basati su questi fenomeni ccprono quasi tutta la sierologia clinica, e soncomunque i metodi immunologici più larg;mente usati. Essi sono per lo più di faciesecuzione, e godono appieno della specifici!tipica della reazione antigene-anticorpo; haino sensibilità da media a molto elevata, eprestano ad applicazioni di tipo quantitativiOgni metodo ha una gamma di possibili

e mescolato con dell'antisiero conlemcorpi per l'antigene da titolare; Ja mine versata in una piastra, in modeuno strato di 1 mm; dopo solidificsscavano delle serie di pozzetti di 1-diametro, nei quali si dispongono vodi varie diluizioni degli antigeni stariferimento e di quelli da titolare; s

| I K ' s l i p i n i r i h l l i r l i l l h . l l l I K
I .UK.I lumi.il.i e i piohlcin-•ll.i valuta/ ione dei usuila:ntc intcriori a lincili clic siitisi cinetica,asc metodologie;) del dosdei metaboliti risiede, gè
5terminazione del punto ti enzimatichc catalizzate inn questo caso si stabiliscontali da rendere limitanti i iono dosare.imbi i tipi di analisi en/imente menzionati si basai:lla specificità della catalisiìeguenza, tali metodi enzirrcomune una stessa limiti
afa rìfllta nnten7a e Hall;

l'analisi enzimatica, spetta ai metrici. Tali metodi si basano sugferenziali di assorbanza e sugli s]fazione per fluorescenza di ceibiochimici, la maggior parte dei edescritti per la prima volta da O(1938). A seguito delle sue stequesto Autore mise a punto uibasato sulla registrazione delleestinzione dei nicotinammideader

elTindicatore è più Ientlei test di tipo a, queste;sere resa trascurabile:azione dell'indicatore,ì un'alta attività rispetiole dosare (nel caso dartato una differenza digrandezza può essere s

tazione e di emissione quali Io spostalidei picchi o l'accentuazione delle rese etiche. D'altra parte, nei metodi fluorompossono insorgere dei problemi sperimtdovuti ad una aspecifìca attenuazionefluorescenza; inoltre questi metodi soncpiù laboriosi dalla necessità di una caitura da effettuarsi con opportuni stan<
Un esempio ben noto di fotometrialuce generata per luminescenza è il dosienzimatico dell'ATP mediante il sistemaferina-luciferasi (Strehler e Totter. 1954

,e ricerche su organi intatti possono edotte sia in situ sia sugli organi isolfusi mediante la fluororometria di supeilance, Jòbsis, 1959) oppure medianittrofotometria di riflessione (Liibbers e5). Più recentemente, è stata messa ama tecnica di spettofotometria di asso)adatta per gli organi isolati (Brauser, 1'luale è stata applicata allo studio dell

e nid 1S80 eogijusps suoiuidoj eip 3ZUBIUOIUIJS3} SlUjSSIUIUd 3J|1
-3p IUOIZBUIJOJUI3SJB0S 3|[nS 3 BJ3UBIC-n[0A3 Biuud v.\ sjuBjnp qnu3AAB-UIB3 mS 'BJIA B||3p BSJBdlUOD B[[3pBJ3JSOUJJB BnS BJ[3p 3 3JJS3JJ3) 3]OLfJosiuiiqs 3 ooisg OJBJS sjiqBqoad |n3 BAijiiuud -q B[[9p ouiBiqqB 3q3 o
3U0IZn|0A3 |
•11DA3WIU IJU31

terotrofici tutta l'attività metabolitata limitata dalla ridotta immissiigeno risultante dalla fotodissocic'acqua. Erano presumibilmente p:omposti organici di vario tipo, r"esistenza di reazioni fermentativeebbe la presenza di stati intermedi:ione di composti organici che, atvrebbero richiesta la presenza di
Inoltre, l'assenza di grandi quant;eno nell'atmosfera avrebbe impecnazione dell'ozono che agisce d:>rotettore verso le radiazioni ul

melanti in tali rocce sonobella I. Altri elementi neceagli animali, o ad entrambi.icce magmatiche in quantitàolibdeno, lo zinco, il boroEssenzialmente tutti i prodologica sono degradabili peocessi biologici, la maggioroducendo energia, alimentaè un continuo ritorno di qui•rali alla b. per essere nuov;irte della successiva genera;ai. In condizioni favorevol

jncentrazione atmosferica, con una pile diminuzione della temperatura. Parailente a questi processi, l'espansione delleita della b. dette luogo ad un aumentcspositi carboniosi che ridussero ultelente le concentrazioni atmosferiche diride carbonica.Vi era inoltre un'emissione continua di
ride carbonica da fonti juvenili a vel<roporzionali, all'incirca, a quelle dell'ai vulcanica. La deposizione intensiva di

i b. è stata isolata sotto forma di aghi ;i con punto di fusione 232-233°. L'atocarbonio asimmetrico in posizione 4
rtisce alla forma d, biologicamente attiia rotazione ottica [a]^ di +91° (e =NaOH 0,1 N).
11 pH di una soluzione acquosa allo 0,04,5; la b. ha un punto isoelettrico a5. In acqua a 25° si sciolgono 22 mg/-^ • » S"% I n ^* J~% I n l

di 3,4-(l ',3'-dibenzil-2'-oxoimiimetilenetiofene (VII) ; questogire con d-canfosolfonato di ;mare il sale dell'acido canfoscstallizzazione da alcool isopr/-3,4-(l',3'-dibenzil-2'-oxoimkmetilenetiofene-rf-canfosolfon;gurazione ottica è identica anaturale.
La reazione di questo sale cito sodico da un prodotto che,con acido bromidrico, conduc

Iciìcicnli, è indebolita e 1 giovantrano una serie di alterazioni nellardiaca. I ratti richiedono circa i>. al giorno e i topi 8 jxg per 100
Polli e tacchini mostrano quali m;orni di deficienza di b. dermatite echiusa delle uova è notevolmente ia deficienza non ha effetti apparen;ani riproduttivi. I pulcini richiedoli b. per 100 g di dieta e i tacchi]

carboidrati fermentabili sono normalmenteuelli che contengono 3 atomi di carbonio, omultipli di 3. I monosaccaridi sono fermenta-iili direttamente, i di-, i tri- e i polisaccaridievono essere idrolizzati a esosi prima dioter essere fermentati. Gli esosi fermentabiliono il glucosio, il fruttosio, il mannosio ed ilalattosio. I primi due sono fermentabili daiarte di tutti i lieviti, gli altri due solo daeppi particolari.
La trasformazione in esosi avviene graziegli enzimi contenuti nel lievito. La fermen-abilità di un di- o di un trisaccaride dipendeIQIIQ r*r*cciKilitQ Hn nstrif* Hi un ìipvitr* Hi T rn_

azotate inutili agli effetti della qu;Infine il mosto viene raffreddate
e) fermentazione. Al mosto fredgiunto il lievito, grazie al quale a\za trasformazione caratteristica izione della b., quella degli zucched anidride carbonica. Dopo un

ne. In Italia,! melodi usati apparial gruppo dei metodi a decozione,questi meglio alla b. prodotta corfermentazione bassa e con ciòristiche richieste dal pubblico.Metodi a decozione. I metodi a deecaratterizzati dal fatto che unaparti) della miscela viene fatta

r.holli/.ioiu- del mosto. Il mosto, con aggiuntidi luppolo, deve essere fatto bollire, per sciogliere le sostanze del luppolo e permettenloro le dovute reazioni chimico-fisiche (umuIoni -> isoumuloni), per la coagulazione dell'proteine e quindi la stabilizzazione del mostoper la sua sterilizzazione ed inattivazione enzimatica ed infine per raggiungere la concentrazione voluta all'inizio della fermentazioneII lavaggio delle trebbie con acqua diluiscinfatti il mosto e rende perciò necessaria un:sua parziale concentrazione.
Il mosto rappresenta un substrato moltiadatto ad una larga gamma di microrganismiDerciò fino all'inizio dell'azione del lievito se

a talvolta la vitamina C. Esso però non ha effettodi ossigeno eventualmeniausando per la metà de:colare effetti ossidanti,positivo per l'eliminazic;eno nella b. finita.
>ttigliamento o infestamelista è la fase più delicatae della b. a causa dei ji essa è esposta malgradioni. Una disattenzione j

i igoi ik-ri) ne peggiorano periUna bottiglia aperta deve essi
;ubito per intero, dato che nenon in pressione perde la CO,;ua fragranza.
Altre cause che possono dinjilità colloidale della b. proveng;enza di sostanze precipitabili ijroduzione o per contatto alla"usti). Queste sono:

ISCHLER-NAPIERALSKI, REAZION
|uesta reazione, la cui scoperta risale altppresenta ancora oggi un valido metointesi per la preparazione non solo di deiochinolinici (v. ISOCHINOLINA) ma anchiaverso molteplici estensioni, di moltiimposti eterociclici azotati.Nel primo caso, il trattamento di un
ito acilico della /?-feniletilammina (1)

(XXVll)
0=C
COOCH-,

zolici è stata riscontrata anche per alemidi del tipo (I) contenenti un gruppiin posizione a; il trattamento del e(XXXVI) con POC13 fornisce infatidroisochinolina (XXXVII) soltantoresa del 3 %, mentre il prodotto pdella reazione risulta costituito dallo (XXXVIII):

acide dall'inizio alla fine e ciò epossibilità, come hanno sottolirsawa et al., che alcune ammidiraggruppamenti sensibili agli acidigo a reazioni collaterali con foiprodotti finali diversi da quelliSotto questo aspetto riveste unaimportanza l'impiego, introdottoAutori, di una miscela di anidridi
in niriHina anidra * mipcfr

PRINCIPALI CARATTERIS
ime e composizione j bismutina;uppo spaziale ! Pbnm; aa »e costanti reticolari bt = 11,2
e, = 3,98rezza e densità ! 2; 6,7

duce bismuto puro quasi al 100%. Altre zonein cui si trova il metallo o certe sue leghecon elementi come arsenico, piombo e argentosono: Adelaide e Nuova Galles del Sud(Australia), Svezia, Germania e Cecoslovac-chia. I minerali si trovano negli Stati Uniti,Siberia, Bolivia e Messico. Recentemente, ungrande deposito di Bi è stato trovato in Giap-pone, vicino alla città di Yamaguchi, e si credeche sia il più grande del mondo. Si ritiene che

3iù una piccola quantità di antimoni'Poiché le scorie di Bi contengono
jna discreta quantità di piombo, la scciuovo separata per liquazione. Il m/iene allontanato dalla scoria per enone, il piombo che rimane per ulterii•urazione, e infine, un trattamento cc:austica da Bi di alta purezza. Questelimentn si hasa sul fatto che il maem

sti. Sarebbe da aspettarsi che l'interazioneBi con gli elementi rappresentativi del Gìpò III rivestisse un'importanza notevole. Lsenico (->) e l'antimonio (—>) reagisconofatti con alcuni elementi della famigliaboro per dare composti III-V aventi un 1porto atomico esattamente di 1 :1 ; questi ssemiconduttori paragonabili al silicio e almanio. Sembrerebbe quindi che il Bi, chela stessa configurazione elettronica dell'anico e dell'antimonio, dovesse comportallo stesso modo ed avere quindi una gra

forgiatura. Viene aggiunto anche alla iin quantità fino allo 0,025%, per aiutiprevenire le cosiddette screziature dovutiformazione di grafite.
Piccole quantità di Bi vengono impieg;elettronica. Le leghe Bi-Sn e Bi-Cd a cosizione eutettica sono usate su seleniofunzionare da contro-elettrodi nei raddriz;al selenio. Nei dispositivi termoelettrorcomposti intermetallici del Bi con telluselenio vengono usati come refrigerator

siderare il materiale del futuro. Inoltric'è nessuna indicazione che il bismanokessere impiegato commercialmente.
Un impiego interessante per il futuicreazione di magneti superconduttoritro, impregnati sotto pressione con urBi-Pb.
Dati statistici e capitolatiLa produzione mondiale del Bi ha meun incremento generale negli ultimi diec

sionc di vapore, è 16,8". Sembra ora chemiglior metodo per la preparazione della tsmutina sia la disproporzione del CH3BiIo del (CH3)2BiH, secondo la reazione:
(CH3)3_BBiHK > | ^
Per mezzo di questa reazione se ne possoiottenere solo piccole quantità. La bismuti)si decompone a temperatura ambiente e mol

ilclle energie dell'orbitale moliposto da Corbe» (1968).
Ricerche recenti hanno mostr;Bi esistono anche alcune specieossidazione più bassi. Un lavoret al. (1967) ha mostrato che jBi?T esistono in soluzione diluìfuso. Questi si possono otteruzione di BiCi3 in un sistema

tallico e un eccesso di N2O4 in acetoisi ottiene Bi(NO3)3-0,25N,O4-0,250Questo complesso può essere decontermicamente per dare nitrato anidrspettro infrarosso indica che i gruppi tsono legati covalentemente.
Il nitrato basico di bismuto venivajato ampiamente in farmacia. Veniva:ome disinfettante, deodorante e astri); inoltre per infezioni dello stomaco e etestino (specialmente per il colera e la (teria), sebbene grandi quantità possane
si in avvelenamenti da nitrito a causi

MCI ili vari composti. C oales, Wudc e G(1967) discutono a fondo la chimica org;metallica del Bi. Una raccolta molto ree*pubblicata da Harrison (1970), include nirose pagine di tabelle di vari composti.
La chimica dei composti organomet;del Bi è praticamente la chimica dei comicon stato di ossidazione formale di +3 edei quali il primo prevale nettamente,stato di ossidazione +5 diventa molto nstabile man mano che si scende nel Gru]fino ad arrivare al Bi di cui esistonopochi composti aventi tale stato di oss

Fig.l Bitume nel lago di Trinidad: unapiù grandi fonti di asfalto naturale {foto S
scolato con materiale roccioso è chiasfalto; molte delle prime applicazioniutilizzavano infatti asfalti naturali.
Nella letteratura si trovano riferirnel'impiego di bitumi nell'impermeabilizz;di barche, come materiali leganti nelleture di mattoni, come collanti nella decene di statue e come leganti nella costridi pavimentazioni in mattoni o pietre. 'impieghi erano conosciuti dalle prime <

raffinato. A seconda delle condizioni dellestillazione sottovuoto, una quantità maggo minore di distillato è ottenuta, ed il resisotto vuoto presenta quindi una maggio:minore consistenza. Nel caso di residui sivuoto provenienti da diversi petroli gr<devono essere eseguiti ulteriori trattamentiottenere b. aventi le proprietà meccanichesiderate. In genere questo residuo è trata 200-300° in una torre dove aria compr
i 4 il 4~i -f-«*\ -v* ^^ 1 1 * ^

stato ai D. ai graao penetrazione.Le proprietà del residuo di un qi
ricostituito, dopo indurimento, ddalle condizioni particolari di ciascicazione, nonché dalla natura del fctipi ricostituiti, classificati come amento rapido, medio o lento, somriccorrendo rispettivamente a solve:(acqua ragia minerale), solventi a mtilità (cherosene) e solventi a volati(gasolio o miscele di cherosene e gafigura 10 da una rappresentazione sidelle varie gradazioni dei b. ricosti

complessa e la struttura interna di un bitume,minore risulta la duttilità: infatti i b. ossidatihanno una duttilità molto limitata. A tempe-rature inferiori i tipi da penetrazione ed in-durimento diventano molto fragili, mentre ib. ossidati possono operare a basse tempe-rature senza rottura. Nella preparazione deimateriali destinati alle costruzioni stradali oalle operazioni industriali, i b. sono riscaldatiad una temperatura che consenta la mescolain proporzioni diverse con pietrisco e la sue-

usuali, le sollecitazioni sono elevate edportamento non-newtoniano è normamanifestato; a temperature più elevatescosità è minore e quindi basse sono licitazioni di taglio ed il comportamentotoniano. I b. ossidati mostrano più s]caratteristiche di tipo gel rispetto aipavimentazione, e di conseguenza richconsiderevoli riscaldamenti nelle appliipratiche, ad es. nella preparazione diture asfaltiche per tetti, in modo da o;una fluidità sufficiente per un ricopriadeguato. Questi materiali mostrano
superiori del contenuto in cere; si ritieiciò sia dovuto alle modifiche apportibitume dalle gravose condizioni della d:zione distruttiva.
Proprietà reologicheProprietà reologiche soddisfacenti sorsenziali per un comportamento soddisfidi un b. in servizio. Queste proprietà colano il modo in cui un materiale si de

inferiore (ma/leni). Le micelle sono considerale come asfalteni con un involucro protettiveadsorbito, costituito da resine aromatiche dalto peso molecolare, come strato peptizzantistabilizzante. Più lontano rispetto al centn:della micella, si ha una transizione gradualiverso resine meno aromatiche; questi strati sestendono verso l'esterno nel mezzo di dispersione oleoso meno aromatico. Normalmentila micella stabilizzata non precipita senza l'addizione di un solvente (ad es. w-eptano), chiriduce il potere peptizzante del mezzo di di

di la proporzione delle resine risjasfalteni influisce sul carattere sol o
Le resine separate dai b. hanncmolecolare medio compreso fra 8Cper la maggior parte tra 1000 e 160(que esiste un'ampia distribuzionemolecolare e sovente sono presenlaventi peso molecolare superiore oai limiti sopra indicati.

ponenti con punto di ebolliziil residuo sotto vuoto di conpiù duro. La tabella II illustche avvengono nella compìgenerale durante questo pròi cambiamenti chimici osse:sotto vuoto ottenuti per distidui atmosferici da due petrcLe cifre indicano la rimozicdei componenti con punto diriore, cioè i saturi, nel corse

lerne e possi Due procedere ana separiei componenti del b. a seconda dellatmzione del peso molecolare. Altgelt (1Snyder (1969) hanno comunicato datimentali riguardanti il frazionamento dedoni bituminose mediante cromatogr;aermeazione del gel. Altgelt ha raggiuntni frazionamenti del peso molecolare diiforniani, arabi e venezuelani nelle su'separazioni di prodotti per pavimentaiper uso industriale. È stato trovato chimolecolari dei componenti bituminosi:ompresi tra circa 480 ed oltre 19.00

mescola è chiamato pre-miscela ed èzato negli impianti per la preparazioil'asfalto. Si suddividono i materiali pusati nella produzione in diverse catghiaia, pietrisco fine, e pietra polverizzsia il riempitivo {filler). Il macadam altiene una proporzione elevata di ghiaiae quindi è molto poroso; è prodotto ib. morbido con penetrazione pari a 2(pure b. ricostituito viscoso.Calcestruzzo asfaltico. Il calcestruzzo

; impiegare questi manuiaine di strutture in calcestruz;lento di spazi tra muratura ei metallo, e per il tamponaressure.'cinti. I composti di b. hanmltre nel fissaggio di lastre isene o di sughero o per la rpiastrelle di polivinile per ]o di materiali plastici somemulsioni.Niella figura 15 sono illustraimpiegati nelle diverse applistimi

on G. R., « Proceedings Associa<ing Technologists », 38, (1969),I. A., Dunning H. N., Boien R.
*. Data», 5, (1960), 550.an J. G., Ramsey V. G., «Geocttn. Acta», 25, (1961), 175.er R.B. , «Proceedings Associating Technologists», 34, (1965),:rg A. J., Bituminous Materials -' Pitches, New York, Intersciencen F .N. ,Zube E.,Skog J., «A.;hnica1 Publication No. 277», (•n F .N . , Zube E., Skog J., «Piiation of Asphalt Paving Techi

sostituenti elettrondonatori sul nuditico, ed è resa più difficile da sostittronattrattori.
La clorometilazione, a differenzazione di alchilazione di Friedel-Cicede anche con nuclei aromatici fdisattivati, come il nitrobenzene. <posti aromatici reattivi, per es. antrctalene, anisolo e polimetilbenzeni,una reazione secondaria (2), che èzione del composto aromatico, per

olloforme). Il minerale rivestre importanza quale indicatitale, poiché il suo contenundo associato a pirite, calcona, è strettamente connessora ed alla pressione parzialeambiente di formazione,iiacimenti di interesse economlente distribuiti in Gran Bretacchia, Romania, USA, Can;

Ora sappiamo che i prodotti dzioni sono identici ed hanno la <approssimata KFeUI[Fe"(CN)6]-quantità di acqua è variabile. Qiè solubile in acqua pura (con funa dispersione colloidale), mapitata per aggiunta di sali. È si

tossicità e la difficoltà nel rajloro completa e regolare comi
La nomenclatura per i b., £IUPAC, indica il numero di atoiun prefisso (ad es., di-, tri-, tenumero di atomi di idrogeno enumerico (ad es., B4H10 è c\borano-10).
Preparazione e proprietà

B6H10, è ottenuto sia per idrodi magnesio sia con altri metodno-15, B9H16, per riscaldamelidi esametilentetrammina del piB5HU ; il decaborano-16, B10H16miscela di pentaborano-9 e idnriche elettriche. L'icosaborancsolo idruro di boro noto aventi

ne, si ottiene il metilborato pi rese del 95-96%. Per idrogerdel sodio fuso, disperso in oreparato l'idruro di sodio:
limetossiborano viene quindizione dell'idruro di sodio in <i il metilborato:

rolisi per la preparazione del pent;è di 155-160°, mentre per la preparidecaborano-14 è conveniente opere
In condizioni sperimentali blandesti contenenti legami B—H reagisconfine od acetileni per formare compnici del boro (idroborazione). Neldiborano con le olefine si ha la reaz
B2H6+6RCH=CH2 > 2(RCH

adiabatica; si lavora a pressioni ati; 9-10 atm ed a circa 200°. La converpassaggio è relativamente bassa pe
>pera con riciclo ed i prodotti di reao condensati mediante rapida espangas di reazione o per raffreddamentc
mbiatori di calore o per assorbimenmezzo solvente. Conversioni del dibc6-9% con rese del 68% in pentabco state ottenute dalla Stauffer-Aero.impianto pre-pilota operando alle seg

entalpia e l'entropia di vaporizzispettivamente AHy= 7,61 kcal/r= 22,5cal/°C-mol.
La tensione di vapore del pentra 233° e 280 °K, è data dalla n
logFmmHg= 7,8533- 167:
J&. struttura del pentaborano-1iella figura 5, è stata determinanisure di diffrazione dei raggi X

diluenti sulla pirolisi del dibture comprese fra 150 e 230rimentati vari diluenti, corrtetraidrofurano, tiofene, soruro di idrogeno, tricloruroNessuno di questi però aidecaborano.
La Olin-Mathieson Chemto inoltre la pirolisi del diboi

aventi massa, rispettivamented essi dovrebbero corrispondei3UH1T e B15H21.entemente sono stati preparatiti due idruri di boro fra loro iscla formula B18H22. Attraversc
:ne l'isomero «-B18
tà di wo-B18H22.•ambi questi composti sono dei

preparalo trattando B4H10con io per reazione di NaBH4 con25-60°:
B2H6-l-NaBH4^NaB3l
La struttura dello ionefigura 10.
Sono noti anche altri anioliedrici, come B6H^, B7Hr,BioHlo, BÌÌHÌ!, B12H12, B20H18
L'anione B6Hg" si ottiene pdiborano-6 ad una soluzioneborato di sodio in dimetossietaanche essere ottenuto, assie

to forma di borace. Per quanzie sull'uso del borace già damesi nella lavorazione dei rdei cinesi per la preparazioinell'VIII secolo gli alchimistino il borace nei loro scritti deil nome di bourah da cui de:derno di boro.he produttrici e consumaticiio per lungo tempo le regioìlo nel XIII secolo il boracen Europa sotto il nome di ,I secolo si scoprirono le prò

azione. Nella tabella II sra i più noti minerali del
I giacimenti più impoi"oscana, California, Cile,\irkestan, Kashmir e Ti
'roprietà fisiche1 B elementare si presentiliente come un solido semorfo, o cristallino a sec

ati ossigenati quali glii l'acido borico o ortouali il tetraborato sodito. Altri importanti coiiuri, il fosfato ed i borrburo di boro (v. CARBI/. BORANI); per il nitrur
3 riguarda la nomenclaessa in genere indica
d il numero di atomechiometrica sempliceO è il pentaborato mi; Mg2B.2O5 • 3H2O è il ditriidrato. Un altro siste

i l l l M l l I U l U S M g C I I U l l l g . l). J l
te teoria l'ossido di borosono formati da molecole ida legami dativi.
Il prodotto cristallino è nL'a-B2O3, esagonale, con pisi ottiene in cristalli molto pbianchi, consistenti, per ri:lunjjìto di acido borico a 22monoclino, con peso specifìiin cristalli molto stabili, dal60° e 40.000 atm o dall'

L'acido borico od ortoborico, H3BO3 (3•1B2O3), cristallizza dalle soluzioni acin pagliette bianche, traslucide, cerosipartenenti al sistema triclino. I cristallformati da gruppi BO3 disposti su un ]in strati collegati tra loro da debolimi di Van der Waals e posti ad uistanza di 3,18 A. I lati della cella elemeche contiene quattro molecole, sono a0 == 7,04±0,4 e c0 = 5,56±0,4 À; oc = 9fi = 101° 10', y = 120°.

Lo stato fisico dell'acido borico instato oggetto di molte ricerche (1>luzione acquosa l'acido borico siime un acido monoprotico debolis5ralmente si ammette che si dissoc. reazione:
H3BO3+H2O =pt H2BO^+HE
Dn una costante di equilibrio K, d(illa base di misure di conduttiviti: IO"10 a 18°. Lo stato fisico dell'aci soluzione presenta però ancora dizze legate al suo strano comportaiitti all'aumentare della concentra

L2OW4 u nui. rei ranreuuarjeratura accuratamente contiH3BO3, che viene separato pcaso di attacco solforico le;ono ulteriormente raffreddsolfato sodico decaidrato. Lzo può essere raffinato perallizzazioni.n recente processo, messo iirican Potash & Chemical G-azione liquido-liquido di Hi di borace dell'impianto ]una soluzione in kerosene (tico che estrae sodio, pota:

do solforico. Lacolemanite, dopinazione preliminare, viene inviaarrostimento a piani multipli nece un lento riscaldamento a tegratamente controllata. Occorree l'inizio di vetrificazione del minite l'arrostimento a 450-550°, la etrasforma in una polvere irregolgera e porosa con un tenore ir% circa. Prima di passare alla rt

Le isoterme di solubilitàJH4)2OB2O3H2O sono ripiira 9. Sono noti due peritailarderellite e la ammoniobcnza commerciale sono ilJH4)202B203-4H20, utilizza:utralizzante nella produziondi urea-formaldeide e comt
iscele ininfiammabili, e il1H4)2O-5B2O3-8H2O, usato:nte di elettroliti e nell'indus
«rati alcalino-terrosi

avverrà per soluzioni con rNa2O:B2O3 maggiore di 0,4maggiori di 9. Esiste invecee cioè quella a rapporto mola= 0,41 e pH = 8,91, in ci[HBO2] : [BO^] è perfettamentiche si ottiene nella dissociapolimeri: per essa ovviamen

l'idrolisi, assorbono adride carbonica per ine proprietà fisiche :bella Vili.Produzione industrialecui può essere prodola miscela di boraceil minerale del giacimioppure la salamoia dun borato di calcio, 1
T a raffina 7innp r\f*\

sotto vuoto per dare borace pentdecaidrato. La salamoia dai crist;passa a centrifughe automatiche e simente il prodotto viene essiccato ina piani rotativi.
Il Searles Lake, sfruttato da due ;American Potash and Chemical CWest End Chemical Division delhChemical Company, è costituito da isalina dispersa in una salamoia s;costituisce all'incirca il 45% del v<tale. La salamoia contiene circa il 3:in soluzione e viene direttamente poipozzi agli impianti di lavorazione,borace, che vi si ritrova per l'I,55-peso espresso come Na2B4O7, i sa

ìera di fusione a forma conica recciaio con camicia di raffreddani camera di combustione e la canone rimane un interstizio in cui 'ito continuamente il borace disidr•amogge di alimentazione che ruol0 alla camera di combustione. Sieie conica della camicia di raffrede>rma e si mantiene uno strato di bro solidificato che la riveste compii1 protegge quindi dall'attacco deuesto strato scorre continuamenehe fonde e scende verso l'estremità: evita così anche il contatto con

Le proprietà elettrofile degli alogenuri eaumentano generalmente nell'ordine:
11 BF3 forma complessi con molte so(Olah):
a) con i composti azotati come l'amrca (NH3-BF3), l'idrazina, le ammine, linolammine, le ammidi, l'anilina, le pile chinoline, l'acido cianidrico e i nitri
b) con i composti ossigenati come 1(BF3-H2O, BF3-2H2O), gli ossidi e glisidi (NaOH • BF3, CaO • BF3, CuO • BF3,•BF3), gli ossiacidi e i sali (HNO3Na,SO.-BF.. 1C.PO.-3BF.,1>:

tu aclUU SVJlIVJIl^w, 111 J-MV.awiz.ci VJI u(jv-i
catalizzatore, a temperature compresee - 7 8 ° :Na2B4O7 • 10H2O +12HF (liq) -»
-^Na2O4BF3 +Na2O-4BF3+H2SO4 > 4BF3+Na2SO4
Impieghi. Nel campo della chinrica org:BF3 ricopre un posto di interesse ecce:sia per i vari tipi di reazione che rendebili, sia per l'importanza di alcune e
II BF3 è usato principalmente come <zatore, specie nelle reazioni di alchilpolimerizzazione, isomerizzazione, nitip. <;nlfnna7Ìnne_ nelle reazioni di adi

,Cl4 + 8Me2NH -> B.2(NMe:
3B2Cl4+4BBr3^3B2Bi
diborotetracloruro si puòazione a 200° del BC13 su)ro (Me Closkey) oppure ]pressione ridotta (1-2 mini
averso un arco elettrico traercurio. Il B2C14 formatosi vcorrente di H2 a — 80°.Ricerche con i raggi X sul E

ce, ma mentre per quest ultimuti più tipi di struttura (quairistobalite), il BPO4 presentaa della cristobalite.La proprietà e la stabilità deino comunque legate non soloolare struttura, ma anche alido di idratazione, per cui a sec:go a cui è destinato, si può dibilire la temperatura di cale

irma di atomi isolati. Qu;filtrazione aumenta e le dinli metallici diventano piùi boro si uniscono tra loro <amenti di vario tipo: in diitene semplici, in catene raoppie, in una struttura piaridimensionale. Tutto questibella X (Tannenbaum).Nessun metallo presenta
i struttura sopra menzioìmtalio ne realizza il maggitomi B isolati). Ta,B, (atc

1963), 228.gri N. ,« Svensk Kem. Tidskr », 75, (4)hnston H. L.,Kerr E. C, « J. Amer. C72, (1950), 4733.amlet J. U.S.P 2.646.344 (1953).emp P. H., The Chemistry of BoraLondon, Borax Consolidated Ldt, 1!racek F. C, Mcrey G. W., Merwin HJ. Sci.», 35A, (1938), 143.urnakova A.G. , Nicolaev A. V., « IzNauk. S.S.S.R.,Otdel.Khim.Nauk.»:vin E. M., Robbins C. R., Me MurdieDiagrams {or Ceramists, Columbus,American Ceramic Society, 1964.ang L. H., Dollimore D., « J. Chem. S1608.artin D. R. « Chem. Rev. », 42, (194av F. H.. (American Potash # Ch

sine) e reattivi di Grignard ii:
gX-B(OR')3 > BR3
R3Al+B(OR')3^> BR3TAli
-> 3Et3B+Al(OMe)3+3^
vie = CH3.sst'ultima reazione, assai eso: vantaggiosamente condotte; come diluente,'importanza più limitata hadi di preparazione di boroalimposti che utilizzano le rea;

iti del III Gruppo, in condizioni ireagiscono con l'acqua. È infatti p
tarare i derivati dialchilici del irliante la seguente reazione cond:zo acquoso:
B + 3HgO+3H,O ^3R2Hg+:
i sono invece assai sensibili all'ossio si comportano in modo analogiti alchilici degli altri elementi delIII. I borotrialchili inferiori si inantaneamente all'aria e bruciano codi color verde.

(RBO),
Altri metodi di preparazione dei bcloruri, seppur meno pratici, consisle reazioni fra borotrialchili e Hso. Così, a 110° l'acido cloridricecon (M-C4H9)3B dando quantità(rt-QH9)2BCl (p.e. = 173°):
(w-QH9)3B~HCl -> (w-QH9)2BCl
A 200° si ha ulteriore reazione connendo una miscela di prodotti.

o anche con l'ammoniaca.:omplessi dei boroalchili e deil'ammoniaca o le ammine, perio in tubo chiuso alla tempercirca, subiscono decomposizioneone delle corrispondenti alchilzine, (RBNR')3.rialchii- ed i triarilboro composiza dei corrispondenti derivatio, non formano complessi stabitura ambiente con gli eteri.
posti contenenti legami boro-ossialchil- e gli arilborati (trialcosilossiboro composti) generalme

n mezzo acquoso:)H),^ Br,+HX>->
->CGH5BH HBH-HÌ con l'acqua ossigenata con unaie trova applicazione in chimicalantitativa:
O, r RB(OH), -> ROH + H3BO3
di alchilboronici, ed in particolcd il dodecilboronico, sono repe

monomere o associate è determinata, oltreda effetti elettronici, anche dalle dimensidegli atomi o dei gruppi legati al boroall'azoto. Se questi hanno dimensioni note'l'associazione può essere impedita o additura diventare impossibile.
Gli amminoborani associati, a differenz;quelli monomeri, sono relativamente non ntivi nei confronti dell'acqua, degli acidi alenidrici e del diborano.
Per la preparazione degli amminoboro-rivati possono essere seguiti vari metodisi basano sulle reazioni:

Steinberg H. , Organoboron Chemistry 1, ÌJ e IHNew York, Interscience Publishers Inc., 1964.
Steinberg H., McCloskey A. L., Progress in Boro,Chemistry I, Oxford, Pergamon Press, 1964.
Zeiss H., Organometallic Chemistry, New YorkReinhold Publishing Corp., 1965, pp, 150-193.
SILVANO BRESADOL/
BORT

CH3(CH2)5CH=NOH —n-eptaldossima
-> CH3(Cn-e:
Nella chimica di laboratrativo della riduzione ccconsiderevolmente dimindi riducenti più selettivi,minio idruro di litio eche consentono tra l'altiduzione delle funzioni einsature anche a temperachimica industriale, invBouveault-Blanc riveste t

0 (Werle, Gotze e Keppler, 1937) formato; proteine del plasma per azione degli en-presenti sia nel plasma stesso che nei tes-e nei secreti ghiandolari (Frey, Kraut ele, 1950; Lewis, 1960).
seguito all'isolamento della b. (Elliott,ton e Lewis, 1961) ed alla sua sintesissonnas, Guttmann e Jacquenoud, 1960),imostrato che vi erano almeno altri dueidi attivi di origine naturale che furono1 chinine, e che presentavano una struttura

à (jntraaermicaj o applicata suua super-terna di una vescica, come quella che sita durante una lesione tissulare locale,ono tre valide ragioni in favore dellache la b. giochi un ruolo nella rispostanatoria alla lesione tissulare: infatti leoni sono simili ai principali sintomi deistadi del processo infiammatorio; nellaìlla ferita è stata rilevata la presenza dicomponenti del sistema enzimatico che

ie dipende principalmentesistema eteroanulare e, peo ponderale tra il prodot)ne ed il prodotto di fìssictivo della stabilità dell'arie; reazioni del bromuro die animine monocicliche,:lla II, risulta evidente che Emente l'ordine di stabilità ;mi eterociclici è: tetraidro

: che l'atomo di azoto è comune a distituiti complessivamente da nove:arbonio. La natura biciclica dellaisulta anche dalla reazione del brc•ianogeno con il lupinano, che fonese elevate (90%) il prodotto deriv"apertura dell'anello piperidinico nuito. Inoltre, poiché l'ossidazionelotto di fissione conduce all'acido ehi può concludere che la lupinina co:inello piperidinico con un sostitueposizione 3. Questi risultati completiorinazioni sulla disnosizione deeli

atomo di azoto.
ndi/ioiii sperimentali:ausa delle sfavorevoli proprietà(muro di cianogeno (p.f. 52r, p.gradazione di von Braun vieneidotta in presenza di un solventeicurare un più intimo contatto d<er un migliore controllo della tencondizioni di reazione dipendomente dalla natura dell'ammina

lon siano nocivi; sulla loro non'UCB deve avere il parere del Con;>eriore di Sanità.
In un b. italiano si può rivendicar'lotto nuovo o una classe nuova di e
procedimenti di preparazione ecmpiego.
Requisiti. La dottrina e la giurispruiccordo con la legge (art. 12-16939), stabiliscono che i requisiti iono: novità, industrialità, liceità. I

0) rapporto ai anteriorità (noveity rche viene pubblicato insieme alla don
e) esame differito (deferred examiiper un periodo variabile da 5 a 7 anndata di deposito.
Queste modifiche tendono ad alleggicarico di domande pendenti per l'esamso gli uffici statali, perché il richiedequalche anno di tempo per valutare :la propria invenzione e quindi abband

legge, entrata in vigore il 2 gennaioparte tali modifiche servono a liberaiciò Brevetti tedesco (Patentamt) dadomande pendenti alla fine del 196"chiedevano un tempo medio di 5 El'espletamento di ogni domanda.
Le modifiche sostanziali sono tredifferito, pubblicazione anticipata dmande, brevettabilità delle sostanze

zione anticipata delle domande in alcirende disponibile le nuove informa2rapidamente che con i b. concessi dopper cui è molto importante essere aldelle domande pubblicate (Hurd, 19riferiremo brevemente sulla bibliogrvettuale corrente (brevetti e rivistedendo la bibliografia retrospettiva.
Belgio. I b. sono concessi entro unentro sei mesi dal deposito, dopo i

poi per numero. L indice annuale dein due volumi : uno elenca i titolari infabetico, l'altro i brevetti secondo lislla IPC.
ermania Occidentale. Le domande preopo il 1° ottobre 1969 sono pubblicati mesi dalla priorità (19-20 mesi) sialla, come DOS (Deutsche Offerii•hrift); quelle del 1968 sono numer800.001, quelle del 1969 da 1.900.001.

alteri di un prodotto genuino (il chiÌ stabilire se l'alimento medesimoidulterazioni e quali);
e) controllare lo stato di conservin alimento (il che equivale a stahprodotto ha subito alterazioni e qu
d) ricercare gli additivi volontatontari, ovvero i residui di pesticidinente presenti in un alimento.

del grasso (dal 2,50% al 4,50%), meno nicaso del residuo magro (da 8,50% a 9,50%
Supponiamo ora che nell'analisi di un carrpione di latte si siano ottenuti i seguenti VElori: grasso 3,00%; residuo magro 8,70%. Iquesto caso il chimico può concludere che :tratta di latte regolamentare, ma resta nell'ircertezza se si tratti di prodotto genuino o meno. Infatti il campione esaminato poteva avernaturalmente un contenuto di grasso e di nsiduo magro del 3 % e dell'8,70 % rispettivemente (e in questo caso il prodotto sarebb

di iodio. Dalla tabella vediamo edel numero di iodio dell'olio digeneralmente intorno a 82, può aquanto raramente) fino a 79 e finpuò accadere che nell'analisi di usi trovi un numero di iodio di 8caso ci sarebbero fondati motiviche si tratti di olio di oliva adeolio di semi; ma poiché il valore ttra nei limiti possibili di un pinuino, non si potrà sostenere ur

incarico del Ministero della Sanità. Laviene condotta mediante una tecnica PEre, adattata alla spettrofotometria dbimento atomico. Purtroppo la presemercurio nei pesci è molto frequente igeneralmente in quantità inferiore ad ite per milione, limite attualmente staiItalia come tollerabile. È auspicabile

Officiai Mcthods of Analysis of thè Associatiti» ofOfficiai Analytical Chcmists, a cura di Horwita W.,Il" ed., 1970.
Sumpuolo A., « Ann. Ist. Sup. Sanità », 5, (1969), 125.Secchi G., / nostri alimenti, Milano, Hoepli, 1967.Thomas G., Prospectives d'un statut européen des ma-
teriaux destinés ù entrer en contaci avee Ics denréesalimentaires, Paris, Dunod, 1970.
Villavecchia M., Trattato dì Chimica Analìtica appli-cata, Milano, Hoepli, 1958.
ROBERTO BIFFOLI

5 a 15 ppm.La forma più facilmente recuperabile di Br:rova nell'idrosfera sotto forma di bromuriubili. Sebbene siano state eseguite moltere determinazioni, il valore di 65 mg/1 perconcentrazione di Br nell'acqua marina èto determinato sin dal 1871. Altre fonti diestraibile si trovano nei laghi salati, nelleine e nei mari interni. Tra questi ultimi ilar Morto è quello che ne contiene in mag-

e eseguila con metodi chimici o delirelei sebbene questi ultimi non siano diu- importanza commerciale. Gli agentiu- ossidanti sono in genere il biossido di
nese, l'ipoclorito di sodio o il eloro. Il'unico ad essere impiegato attualmeanche interessante il fatto che sia sta
V per la scoperta del Br nel 1826.Come già si è detto il Br fu prodot
Y prima volta negli Stati Uniti da Davda un pozzo d'acqua salmastra. Nelcostruito un impianto a Tarenton, Pe
y nia, che poi fu trasportato a Pomero

quantità rimanente del eloro necessario. Ilcloruro di idrogeno (acido cloridrico) pro-dotto nell'ossidazione viene eliminato con l'ac-qua salmastra esaurita e neutralizzato. Il Bre il vapore escono dall'alto della torre di eva-porazione, vanno ad un condensatore e daqui il liquido condensato passa in un separa-tore a gravita. I gas non condensati che tra-sportano un po' di eloro e di Br sono rimessiin ciclo nella torre di clorurazione. Dal sepa-

cioè la precipitazione con nitrato dla reazione con composti di mercusidazione.
Le due tecniche di titolazione deicon nitrato d'argento sono ben mtitolazione secondo Mohr si adopiindicatore, il cromato di potassio, rla titolazione secondo Volhard ètitolare per ritorno l'eccesso di nitgento, in presenza di solfato di aiferro (III), con una soluzione a ti

Si pensa che gli alogenocomposti impscano la formazione della fiamma reageessi stessi con le sostanze che dovreblentrare nel meccanismo di combustione,centemente è stato trovato che l'acido brcdrico (HBr) impedisce la formazione efiamma. I composti contenenti Br sono :sperimentati con tutti i tipi di materiali

soni) necessario attrezzature resistenti alla coirosione. Fra i materiali di consumo il costpiù alto riguarda l'ossidante, in genere clorcseguito dal carbonato di sodio e dall'acideo dall'anidride solforosa, a seconda del prccedimento usato. Le spese più alte per 1varie operazioni industriali dipendono, negimpianti che sfruttano l'acqua marina, d£pompaggio e dall'estrazione con aria, e negimpianti che utilizzano salamoie, dal porr

( l I ' . K I l i o I l l o m n s i l V l f l II" p i e p . l l . l l O £
io iiicnk- Irallaiulo il miralo d'aif.eiilo co)ii eccesso. l'roliabilmenlc si p;iss;i altra\li) l'orina/ione ili acido ipobronioso, seciio rc:r/.ioni:s" tir-, i AgNOa ì II.O - HUrO i IINO3
°" 2AgNO-, I HBrO i HO •^ - HBrO. i 2Ag V2Y
io Esso è stato preparato quale intcrmedriduzione di bromati con perossido d'ic

si ottengono alte rese. Anche 1 ossidazione ebromuri per mezzo di clorati ed ipoclorproduce bromati:
KBr+KClO3 -> KBrO3+KCl3NaCICH-NaBr-^ NaBrO3+3NaCl
II bromato di calcio e quello di bario vengo)spesso utilizzati come intermedi per la preprazione di bromati il cui ottenimento è pdifficoltoso. Il bromato di bario serve nepreparazione di bromati di rubidio, cesio, aimonio, lantanio e di altri ancora:

ie- fiammabilità del composto quanto Tintiie- zione di due atomi di eloro,ìu- Le proprietà chimiche sono praticar5 a quelle degli alogenoderivati delle parro- (v. ALOGENOIDROCARBURI) : le bromopar
possono quindi dare reazioni di sostitu2reazioni di eliminazione, possono esse:dotte e possono reagire con i metalli,
usa Anche i metodi di sintesi sono quelli isti. tati in generale per gli alogenoderivatiidi, paraffine. Il trattamento di alcoli o poli:ati con acido bromidrico è molto frequentnte per la buona reattività di questo idracictre per la metodologia piuttosto semplice. Iuà. lito si riscalda l'alcool ODDortuno co

li;he ionie disinfestante per l'umiga/.uMine si ritrova spesso quale componentiiseele antincendio, sia da solo sia misceMI altri liquidi come il tetracloruroirbonio.•omoetatw. Il bromoetano, o bromuroile, è un liquido trasparente, incoloro emente volatile le cui caratteristiche fisiino riportate nella tabella I. Completarneiscibile con alcool, etere e cloroformkilubile nei solventi organici in genere. È:ce poco solubile in acqua: a 30° si sciolgirea 0,89 g di bromuro di etile in 100 |

-» 2KOH4 K2Hg(CN)4+2HC=<moderivati degli idrocarburi insaturi 's> spesso usati nelle sintesi organiche. 1ustria dei polimeri si sfrutta la loro pci di copolimerizzare con altre sostatripartire alle resine particolari proprini di essi sono infine usati comestanti.metilene. È un liquido molto volaanche con il nome di bromuro di vii
i tabella II sono riportate le sue carahe fisiche. È insolubile in acqua e ci

trova in posi/ione x al nucleo bcuna maggior.- reattività, simile abromuro allilico. Ciò è dovuto acgiore polarizzazione del legamebromo, resa possibile dalla dispontronica del nucleo benzenico. Inebocatione che si origina nell'eventizione del bromo è stabilizzato peria e quindi favorito nella sua f

infatti ritrasformato nel compìscaldamento con ammoniaca acammonico.
La reazione di Bucherer si è dticolarmente utile nella chimknaftalinici e viene usata anconindustriale per la preparazioneloranti azoici. La sua importarstrata dalla sintesi della /3-naftla quale non nuò essere convenir

iiflilamniinc gli intermedi sono rrispettivamente dagli acidi 3-t
:(ralonimmin-I-solfonici.
ilicazioni e limitazionieccezione di pochi casi partico!.rasformazione della resorcina (3-diamminobenzene (XV):
OH NH2

ciò insolubile assicura il completento dell'equilibrio verso i prodolAllorché i prodotti di partenza risuubili in acqua si può ricorrere adnte introdotta da McDonald e CI;aldare il composto organico a citubo chiuso con diossano acquoseiviamente saturato a 0° con anidria ; questo metodo ha fornito ottim• alcuni derivati fenantrenici pernes., di ottenere, con una resa del

lieo. Lebedev, così come gli alisi V. Ipatjev e J. J. Ostromislenva in quegli anni delle possibiltesi tecnica del b.
Il b. cominciò ad assumere idustriale su vasta scala dopoparticolarmente durante la TIdiale, furono messi a punto, inegli Stati Uniti, dei metodi cino la produzione di polimeri eprietà tali da renderli adatti peitici. Si ricorderà, ad es., la notoriginario significato è legato7a7i'r>ne eseguita in Germania 1

ni centrali del b. questo valore raggiun1,467 A.
ra le reazioni di addizione del b. que:iva agli alogeni ha avuto una notevcortanza per lo sviluppo della teoria eme chimico ed attualmente viene utilper la sintesi industriale, su larga sca'rodotti organici intermedi.Thiele, verso la fine del secolo scors
;ì a stabilire, nel corso delle sue ricercn A rW T ij-»r» a rìì Y\r r\mr\ nì V» r»Vìo ini 1 oc fa a

DICO, un composto dimoiilo, cioè un'olcon doppio legame reattivo del tipo C <(in cui X indica un gruppo fortemente accre di elettroni come —CHO, —COR, — C
CN o — NO,) oppure un composto scon un legame acetilenico attivato. Le readi Diels-Alder sono fondamentalmentepre reversibili, per quanto la temperi

iecano, che si trasforma in laisando per il ciclododecanoncanonossima. Il laurillattameilizzazione pratica come moniduzione del Nylon-I2 (Mori'
tiraliiella sua notevole reattività esi trova libero in natura. Ti
a già ricordata energia di co3,5 kcal/mol la formazione dane termodinamicamente favo; comprendere come il b. si i1 piccole quantità, negli efflusi cracking termico della maggi

1 processi per la sintesi tecnica di b. dastando interessano oggi solo i paesi in cuimanchi un'industria petrolchimica ma cheabbiano una larga disponibilità di alcool da:arboidrati. I dati forniti nella tabella IV mo-strano però la grande importanza che la tra-sformazione di etanolo in b. ha avuto per gliUSA nella II guerra mondiale, vista l'impos-sibilità, a causa dell'occupazione giapponese,di disporre del caucciù naturale dell'Indonesiaì prima che entrassero in funzione gli impiantidi sintesi del b. per deidrogenazione di bu-

aeiurogenazione. Le condizioni ai iascelte in modo che la quantità di cai>ario per la deidrogenazione sia u;quantità di calore che si sviluppa ne-igenerazione per combustione cor:oke depositatosi sul catalizzatore.:enere cicli abbastanza lunghi edsviluppo di temperature troppo alteperiodo di rigenerazione, al cataliz

dell'ossigeno con l'idrogeno molecolare imatosi per deidrogenazione.
Un processo della Shell per la ossideidrcnazione ad uno stadio di butano a b. si bsull'impiego di iodio elementare come acitore di idrogeno; il processo non è però ancarrivato ad essere sfruttato su scala industr(ECN, 15 febbraio, 1963).
Dal punto di vista storico è interessantetare che il b. prodotto per la prima voltascala industriale dalla Shell in USA durala TI oiifrri» mrvnrii^ilp vpnnp ntfpmitn npr

3 ali evaporazione, 1 composti carbonperossidi vengono determinati di sondo i metodi dell'ASTM, mentre il eto in zolfo è determinato con la norrrisi elementare.Ditolati del b. per impiego come mo) nella preparazione del polibutadieis e secondo le richieste del mere;• riportati nella tabella VI per quairda le impurezze di idrocarburi C3 ealtri valori sono:;nte < 10 ppm in p:ro (vinilcicloesene) <500 ppmluo all'evaporazione - 100 ppm

consumi di b. negli USA, divisi sei)pi di prodotti, sono riportati neli VII! per il periodo dal 1963 ala tabella IX appaiono i dati r<ìuropa Occidentale; in questa tabe!incile riportate la capacità, la prodiconsumo,a capacità produttiva totale di b. del

BUTANI
II «-butano (I) e l'isobutano (o msecondo la nomenclatura IUPACdue idrocarburi saturi isomeri a qidi carbonio, QH10, p.m. 58,124:
CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 3 CH3
(I)

;', ccc). 1 b. provenienti da gas di rali sono generalmente accompagnati da 1: qualora i gas provengano da impianacking termico ad alta temperaturaesenti anche il butadiene ed altri cot:nti molto insaturi quali alleni ed aceti?as provenienti dai singoli procedimentidiverse operazioni previste in una certa:ria, non avendo caratteristiche adattesere venduti, sono avviati a imnianti di

emperatura ambiente ad eccezioritanolo che, in conseguenza del suofusione (25°), può essere anche sj-butanolo mostra il punto di ebcpiù alto, mentre l'isomero più raril ?-butanolo, presenta il punto di ine più basso. I b. hanno tutti unitteristico e sono parzialmente m:i acqua (fìgg. 1 e 2) ad eccezione del /

iu>molcc<>l;uc «.li i l i N i d r a l a / i o n c peDicl ine r i spc l l i ) a q u e l l a h i m o l c c o l u im a r e c l e r i bn l i l i c i . Su s u p p o r t i a bsiilo di /inco, invece, a temperaturetra i 350 e i 450" la reazione di de/.ione è competitiva con quella dizione ottenendosi così miscele conaldeidi (o chetoni) e di buteni.

i tutto in metiletilchetone (MEJimo composto è impiegato largai10 sia necessario un solvente a11 quello dell'acetone. La propriianolo di sciogliere sia l'acqua seso questo alcool un componenioso in preparazioni adatte per>ianti industriali, in preparatii, ecc. Lo xantato del 2-butanoIcome agente flottante; questo e

che l'1-butene a basse temperature risivorito termodinamicamente rispetto aini ed all'isobutene, ma che a temperaivate esso è favorito rispetto ai 2-butspare inoltre evidente che l'isobutenetemperature considerate, il più stabi
Benché sia teoricamente e praticarnesibile realizzare le reazioni (1), (2) e (;mente per via termica, la velocità consi instaura auesto insieme di eauilib

almente da gas di raffineria. La coirione dei gas di cracking dipende da rrtori quali il materiale di partenza, la t-atura, la pressione, il tempo di reazioipo di catalizzatore usato. Tipiche compini delle frazioni Q provenienti da variimpianti sono riportate nella tabellali frazioni Q provengono dal debutaore della benzina di cracking: la figu:jstra schematicamente l'impianto perlimento di tali frazioni.Dalla frazione Q (fig. 2) si separa l'isc

l'iti. I Sistema di recupero dei gas pilo di cracking catalitico. Le teste dalprincipale dell'impianto di cracking vrate nell'accumulatore in una fase '.una fase gassosa che sono alimentimente all'assorbitore; in testa all'assiinviata benzina pesante come assortaLe code dell'assorbitore vengono dislbutanizzatore per separare in coda litesta la frazioneC3+C4che viene sueinviata siila rpttifirn npr nttfpnprp In

li deidrogenazione catalitica è assai mli quella riscontrata nel processo terrrn è più consistente formazione di cc;as di cracking.
La deidrogenazione dell'isobutano ;ene è stata impiegata industrialmen'hillips Petroleum fino al 1945. L'isc'eniva sottoposto a cracking in un)50° circa e a 2,3-3 atm, con convers>0-30% per passaggio; le rese in pesavano del 50% in isobutene e delpropilene (Arnold, 1945; Seres, 196!

ne, è insolubile in H,SO4, uno dei più grossiproblemi che si sono dovuti risolvere è statoquello del contatto dell'isobutano con i b.onde ridurre al minimo la formazione di po-limeri. Si è però constatato che le proprietàdegli alchilati crescono col crescere della con-centrazione dell'isobutano nella carica. Laconcentrazione di olefina, difficilmente deter-minabile nel catalizzatore acido, viene espres-sa come volume di olefina per ora per volumedi catalizzatore. Il numero di ottano aumenta(non linearmente) col crescere del reciprocodi tale espressione, cioè del rapporto volumedel catalizzatore su volume di olefina per ora.

Il processo ò slato messo a punto dFrancis du Petrole (IFP); esso èmente utile ove esista una notevobilità di b. Il vantaggio di tali proce:di non richiedere esclusivamentetazione di isobutene puro, ma ancisomeri dei b.
Processo oxo. La reazione oxo èindustrialmente per la sintesi di aalcoli da 3 a 18 atomi di carbonio,scono facilmente con una miscela er:arhnnir>-idroereno sotto nressioni

300 e a pressione moderala; gli isono usali per copolimerjzzare ;scele di b. a triisobutilene.
L'acido fosforico liquido, inv'solido supportato su farina fossiza i b. e copolimerizza b. ed i:processo industriale è realizzatvron (« Hydr. Proc. », 47, (1968L'acido solforico da solo forn70°/ in polimero liquido open

anfetamina e il comportamento sponConcentrazioni molto alte interferì
:on i centri autonomi noradrenergici, j:endo ipotensione ortostatica e ipoti
L'effetto antipsicotico di questi farmadazione con il blocco dei recettori dop;liei, mentre gli effetti sedativo e auto:o con il blocco dei recettori noradren
Questi effetti negli animali e la loroazione, consentono di prevedere le nittività, antipsicotica, neurologica e ainica, l'assorbimento per via orale, i d

CACAO
II nome cacao viene usipianta della famiglia d<Theobroma cacao, e nelledotto che si ottiene lavorpianta e che costituisce 1l'industria del cioccolati
L'albero del e. era esino da tempi molto ree Maya : essi usavano il sanche come mezzo di se

peratura di ca. 250 con uria surriscalda:pure a fuoco diretto. La durata dell'opene viene regolata dallo svilupparsi del e;ristico aroma. A questo punto vengonci gusci, resi fragili dal trattamento terrdisidratante. Qualunque possa essere icessivo impiego dei semi tostati, segutorrefazione una miscelazione di quadiversa provenienza (come per il caffè <allo scopo di ottenere un prodotto me di caratteristiche organolettiche costa
II e. in polvere viene adibito per lo p

zione di una massa viscosa. La successiva ra;filiazione, per il cioccolato fine e per quellal latte, avviene in macchine munite di cilindmolto duri e pesanti (in granito, acciaioporcellana), dove la massa acquista una pelfetta omogeneità (fig. 2). La rifinitura percioccolati speciali (al latte, fondente, alla fruta secca, gianduia, ecc.) prosegue nelle coiches, vasche riscaldate munite di pale, dove 1

Stato naturale
II Cd è un metallo relapresente nella crosta tentrazione media di 0,1-0,5comune è la greenockite,trova associato alla bleriquest'ultimo può conteniUn altro minerale di Cd,otavite, contiene il 61,5°nockite che la otavite soi

teriormente purificata.Fusione di minerali di rame o piombo. Ilrecuperato dalle polveri provenienti da qoperazioni sfruttando, ancora una voltmaggior volatilità dell'elemento o delcloruro. La polvere viene di solito sciolacido cloridrico o acido solforico e irecuperato dalle soluzioni di cloruro ofato, per aggiunta di zinco in polvere,cessivamente la spugna può essere ancoririficata. Tuttavia, molte polveri che proveno dalla fusione del piombo necessitaruno stadio di purificazione in più. In qcasi la polvere, che può contenere ever

to di grandi quantità di zinco dal Cd può esere realizzato per distillazione frazionata,quanto fra questi metalli non si forma alciazeotropo o composto stabile. Il processo piessere eseguito in maniera continua per dazinco puro e Cd impuro per piccole quantidi zinco. Quest'ultimo può essere allontanaper trattamento con idrossido di sodio.Purificazione e deposizione per elettrolisi. 1produzione elettrolitica del Cd è molto meisensibile alla presenza di impurezze di quan

2 presenta una considerevole soprafusionon sono introdotti germi, e fonde a 621 °.\dmio-antimonio (fig. 2). Si formano <mposti, CdSb (p.f. 456°, struttura cristalltorombica, a0 = 6,47 À, b0 = 8,25 À, c(8,53 À) e Cd3Sb2 composto metastabile (]0°). All'equilibrio ci sono eutettici a 23 atomi% di Cd) e a 445° (43 atomi % di Cidmio-metalli alcalini. Le fasi intermedie fite in questi sistemi sono in genere più s

\pplicazioni delle leghe di cadmio. Leghlenenti Cd sono impiegate, in genera!ino di questi scopi : leghe per cuscinettiser saldatori, leghe bassofondenti per !i spruzzo, ecc, leghe di ottone.
Le proprietà utili che il Cd conferiseghe sono il basso punto di fusionidurezza.
Le leghe del Cd per cuscinetti, con j

durre uno strato omogeneo e splenderte volte sulla cadmiatura viene applicstrato ricoprente sottile di nichel oNella placcatura, la densità di correnda 17 a 43 mA/cm2 a seconda del codi Cd nel bagno elettrolitico. I bagnon danno un buon deposito serditivi.
Nelle batterie di accumulatori alil catodo è costituito da una griglia dr\ Hi fprrn QII pm ci HpnnQÌta la emioni

ìplessi sono presenti anche iìtrutture simili a quelle degli alstrate dagli idrossoalogenuri,stati descritti Cd(OH)Cl, Cd(;OH\,I0i,eCd(OH)MBr0,,. Il:o composto mostrano la stru[2 mentre l'ultimo ha la strutCl2. In queste strutture gli icridono il posto degli ioni a];OH)C1 ciascun atomo di Cdledricamente da tre gruppi OCI..e soluzioni moderatamente cicrpnlìri Hi OH snnn nifi H^hnimf

diluito il cadmio metallico (adatto come ossido, nitratosi evapora la soluzione a seè costituito da una miscela dII cloruro anidro si ottiene eluzione acquosa in correnidrogeno gassoso o trattaneloro elementare. La relazicdro e gli idrati può essere r;
100°

i solfati sono facilmente solubiliilda o fredda e, a temperatura amsluzione satura contiene 70,7 g/1Non sorprende, considerando la Ìletria, che la struttura del 3CdSO4Dito complessa, con due tipi di airutturalmente differenti e quattrci acqua non-equivalenti ; il tutto iun compromesso fra i requisiti de H?O. Alcune proprietà fisicD di Cd sono mostrate nella tabs

he si trasforma nell'esagonale per riscalento a 700-800° in vapori di zolfo. Aleroprietà fisiche del solfuro di Cd sono rijite nella tabella XII.Il solfuro di Cd viene usato come pigiru
giallo cadmio) per colorare una grande qi
TAB. XIII ALCUNE PROPRIETÀ FISICI

phora, nota anche col nome di Coffea )coltivata in Africa Occidentale e Indola Coffea liberica, meno diffusa.
La pianta del e. cresceva in origistato selvatico soprattutto in Etiopi!regione degli altipiani, al di sopra deid'altitudine. Una leggenda racconta distore del VI secolo d.C. il quale osseisue capre farsi più vivaci dopo avere 1le bacche di certi arbusti. Assaggiar)
frutt i si nrr.rir<zp. con stn

azotate, grassi, sali minerali e naturalmenteacqua. Sono inoltre presenti alcuni compo-nenti specifici, fortemente aromatici, dotatiper lo più di qualche azione farmacologica;oltre alla caffeina (v. XANTINE), che agisce sulcervello e sul sistema nervoso centrale, in-fondendo un piacevole senso di benessere,all'acido caffetannico (sostanza di composi-zione non ben definita), che contribuisce alsapore astringente del preparato, sono da ci-tare l'acido clorogenico, la trigonellina e l'aci-do nicotinico:

calcantite è un solfato idrato diuSO4 • 5H2O) con composizione tipo : Cu31,87%, SO3 = 36,07%, H2O = 36,07^i può essere parzialmente sostituito da) Zn.La e. è triclina ninacoidale e la sua s

v a r i e t à uiiloctonc o //; siiti e t i jtritici); ovviamente c'è una sturale continua di varietà mdue gruppi principali. I e. aicomposizione chimica e mine]flette le condizioni chimiche, fibiologiche del particolare amisono formati. Il materiale deiviene in larga parte dall'esterndeposizione (chiamato in ingleper questo motivo i e. allocton

•eo oppure il suo eqckstone. È un e. in cui istrutturalmente in mengono da sé, e tuttavia <fango calcareo come iI fango la roccia vienei granuli costituiscono iissa della roccia questajgliera. Struttura erett;uttori o che trattengoinpo della deposizione ]

caverne, e come incrostazionisuoli, ecc, ed ha colori marrone ie bianco.Tufo calcareo (Tufo). Tipo spugtforma un sottile deposito superia sorgenti e corsi d'acqua, o pua forme spesse, bulbose, o prcqualche altro tipo nei laghi, sopìle rive. Ha una struttura reticolae semifriabile. Il travertino, almolto denso e con bande di caleWackestone. E un e. fangoso, ccdel 10 % di granuli (tra il 10 % ec

icati, che si trovano nella parte destre:cola scogliera, si sono probabilmenteulati nel fianco di questa configurazio'grafica. Alcuni dei e. algali sopra 1:iera sono di accumulo drupe-like.Questi carbonati si sono accumulatile marine relativamente basse (ambierale o neritico) in seguito a trasgress

no ad indicare acque calde, mentre quelcitici indicano acque più fredde. Di eguenza anche il rapporto stronzio/calcipende dalla temperatura, poiché lo strè concentrato negli scheletri aragonitici

cite povera in Mg. Ciò ;cite ricca in magnesio e 1'bili nella massa d'acquamentre la calcite a bassè la più stabile, resta ccminante.

dono aau aito, alternato con sidi antracite. Il materiale che sceipreriscaldamento da parte deibustione caldi che salgono lungopera a tiraggio (fìg. 2).
Man mano che scende, il catemperature sempre più elevaticentrale del forno avviene la co

estraendo il cestello contenente la caiLa produzione di calce spenta i
viene fatta in tamburi ruotanti dovevare l'acqua sotto forma di pioggia sla quantità strettamente necessaria izione di idratazione.
Impieghi nelle costruzioniLa calce è usata principalmente cortante aereo; le caratteristiche di uni

i.a percemuaie ni argina necessariasformare una calce normale in una calolica va dal 5-6% (debole idraulicità) a(calci di tipo nettamente idraulico). 1prietà di idraulicità di una calce sonoda un rapporto detto indice di idraulich
. . . . , . . , , . -t, SiO2+Al2O3i = indice di idraulicità = — _, A.

ire le acque di rifiuto, sia uriastriali.
nalisi della calce per uso chinirgicotenore in Ca può essere ottenuetneamente sia, con più facilicamente.Nella determinazione gravimetta l'ossalato di Ca che è praticibile in acqua contenente ossaleo. L'ossalato di Ca è filtrato, la'Suzione bollente di ossalato d

Un tipi di quarzo cnptocn:n'Ie da parte delle soluzioni"equentemente colorato ilnpregnazione con una soli3 di potassio e successi1
Juesto materiale può ancbare per crisoprasio o gia<rasio deve il suo colore alpettro di assorbimento div. colorato con il procedimJn'altra colorazione comu

tema anulare mentre quellodovuto al doppio legame ti
tensa banda a 895 cirr1 è dovujame presente all'esterno del se. Il gruppo idrossilico in posriale è responsabile delle barn3500 e a 1050 cm1 , mentre
-970 cm~4 viene attribuita al sipi legami Zi5-7. L'ergocalciferoe una banda a 970 c m 1 che vieidoppio legame della catena 1

:l* ili 4: I. li preferibile che ilme e lu vitamina campitine ut:a la slessa potenza e venganoli in un'unica somministrazic: siano tra di loro in rapporIla prova della linea, dopo un j.) di 10 giorni, gli animali ve[uindi si asporta la metà prò:ia oppure la metà distale delIna. Dopo aver liberato l'ossepratica una sezione longitudir

olonna e stata impiegaidei diidrossi-derivati <
:he in questo caso il su]i Celite mentre CH3O]iH'80%in CHCl3rappionaria e la fase mobrafia gas-liquido. Teorie3be essere il metodo dia della vitamina D, datiite procedimento di puun sensibile sistema dibisogna tener conto delD va incontro ad unaella camera di vaporizii, dando luogo alla foarolo e di isopirocalcifeimodificazione si prodiÈ stato dimostrato ch(ne è quantitativa e perti per dosare la vitaminui essa si trova allo stat1 colesterolo. che snessi

I N C I I M O I I I O I I l a C I I I I I S I I I U t U I I U
pica dell'infanzia; il rachitismo eIra in soggetti più anziani, cosìresistente degli adolescenti e deglpresenta probabilmente la consejIre alterazioni metaboliche: un'renale cronica ad es., può detennigenza del rachitismo in seguito ;1,25-DHCC.
L'osteomalacia si può risconzienti sottoposti a gastrectomia, Tanziane, nelle monache e nelle diservano il purdah (parola di ori

a corpo centrato) ed i600°, con un reticolo esa
:llo del magnesio; questia non è molto ben carai
prietà fisiche del Ca son:lla ILnatura come una miscela (96,97%), *2Ca(0,64%(2,06%), 46Ca (0,00033 %:sistono molti altri isotoje cui caratteristiche son«Ila TTT

esso ha un numero di coordirvuto principalmente al suo ra
Lo ione Ca'JI ha la strutturun gas inerte come tutti gli ialcalino-terrosi e, a differenzae Mg2 ', ha un tipico comportimico che fisico di ione dei rrterrosi.
Questo comportamento dijporto carica/raggio che, nel esio, e particolarmente del ber

nissione sia per assorbirneII calcio si determina di se
ga d'emissione a 4227 À o)rgente di eccitazione si urimo caso, o l'eccitazione)ndo. La fiamma è prefsl'analisi di campioni liquii>ettroscopia d'assorbimenissorbimento a 4227 À edmetilene.Il Ca può essere determ
;r via complessometricaone con EDTA.

Le applicazioni più importatallico si basano sulle sue pròPer calciotermia si possonopoco comuni come zirconio,torio, uranio e quasi tutti i
Ca metallico di elevatissimitre usato per la preparazione eciò CaH2 che è ancora impiejzione di ossidi come UO2,

idro è un ottimo agente essiccanteluro e lo ioduro di calcio hanno ca:he del tutto analoghe al cloruroinfatti sia il sale anidro sia il sai(CaBr2 ha p.f. 760° e densità 3,4
).f. 740° e densità 4,9) ed ambeduenotevolmente solubili in acqua,uro di calcio, CaF2, ha invece caratnotevolmente differenti da quelle de5 degli altri alogenuri. Il CaF2 snatura come minerale (la fluoriteillizza in un reticolo cubico a faro

amorali) iciracaicico, ua4tj1(1i.boralo dicalcico, Ca2BcHu«H.2monocalcico, CaB6O10 • «H2(idrati, alcuni dei quali si tronei depositi naturali (v. BORO)tenere in laboratorio per azioìrico su una soluzione di calereazione di scambio tra il cor

Idrossido ed ossido
Questi composti, di formula Ca(Ohanno importantissime applicazicpreparazione e le loro proprietàdescritte altrove (v. CALCE).
Idruro
L'idruro di calcio, di formula CaH2

come 11 perossido ai magnesio, psperossido di idrogeno concentratsido di calcio:
Ca(OH)2+H2O2^ CaO2 +
II perossido di calcio si ottiene soottaidrato che perde a 130° l'acqilizzazione trasformandosi nel peroche si decompone nell'ossido edsolo al calor rosso.
Il CaO2, che è isomorfo con ilbario, è un composto ionico cheione O|~. Esso reagisce lentam

Infine, il ciclo del calcio neconsiderato come se avvenissetotalmente chiuso. Attualmenisalti (->), andesiti ed altre roc<biscono l'erosione. Esse conte:10% di CaO sotto forma di spalmente plagioclasi e pirosseinerali reagiscono abbastanza raspetto ai tempi geologici) con 1rali, di modo che in molte foimentane essi sono completarne!

importante nelle malattie sterizzate da una eccessiva d«I progressi nella conoscen:chimica della e. isolata dalspecie animali sono state estse si considera che questo oiperto solo recentemente e e.enHnrrina non p «tata anrr

à MRC/mg (v. il capitolo sul dosaggio), fr£umenta ad ogni tappa successiva. sei
La purificazione della e. umana presenta di'leune difficoltà a causa dei bassi livelli ormo- drtali che si riscontrano nella tiroide umana scilormale e a causa della labilità all'ossidazione. sei<inora la e. non è stata purificata da tessuti coimani normali. Il gruppo di ricerca della Ciba re!stato tuttavia capace di isolare una e. umana zi<
la un carcinoma midol lare della t i roide. neQuesto o rmone è infatti presente in concen- te.
razione elevata nei tumori di questo tipo che ci;

nnone sono stali riportati nella hgur;Più recentemente sono stati messi a pi
ei metodi molto sensibili per l'analisi e;quenza degli amminoacidi delle e. Qirocedimenti comprendono l'uso della deazione di Edman (v. PROTEINE) effettisn apparecchi automatici su quantitàeptide inferiori a un milligrammo. Sono snpiegate anche altre tecniche, quali la deazione di Edman manuale accelerata e tene di analisi sequenziale su miscele peptidon frazionate (Potts). Questi metodi sati applicati per l'analisi della sequ<

una nuova biosintesi ormonalitevoli scorte di ormone preforino che la velocità di secrezicmolto rispetto ai livelli basali pstimolazione di tipo ipercalcemo, tuttavia, la concentrazionghiandola tiroidea è, in conigiche, molto più bassa rispetimali.
Per il significato di questa osuoi rapporti col ruolo fisiolog

varie specie ili salmone. Da noiasalmone le concentra/ioni perifericisentano una variabilità superiore <altre specie. In questi pesci sono sriscontrate concentrazioni plasmaivariabili tra 400 e 10000 pg/cm3. Uldi sono necessari per stabilire l'effitori come la migrazione ionica, lazione salina e del calcio nell'ambiosulla secrezione di e. nei pesci (Poti
L'importanza fisiologica della e.

mente sensione e preciso, basato sulrenipocalcemizzante di questo ormone è risuldi grande utilità per l'isolamento dell'orrre per studi endocrinologi comparativiestratti ghiandolari grezzi di molte speciemali. La maggior parte dei dosaggi biokvengono eseguiti nel ratto e si basano scapacità della e. di abbassare la concentrane ematica del calcio. L'impiego di questitodi non richiede una paratiroidectomiaventiva e, per quanto concerne le modaliiesecuzione la e. min essere iniettata npi

;ccamsmi, gli organi di entrata e ui viene dato il nome di hardwarinimi che ne rendono possibile il:nto, che vengono globalmente deme di software.Costituiscono Vhardware:a) l'unità centrale, costituita da cimici che effettuano le operaziomentati (fig. 3);b) la memoria interna, costituit;nte da nuclei magnetici, che riceFormazioni trattate dal e. e. (fig.ratterizzata dalla capacità (che deantità di informazioni che possiittate) e dal tempo di accesso (ehnpo necessario per trasferire l'inf

iiune ui somma logica o uiNel circuito NOT, infine, li
iscita B è sempre il contrario in entrata A (funzione di negi
Con questi circuiti dementa:ostruire circuiti più complessi:ompito di eseguire le varie ope
Un e. e. deve essere naturali™in insieme di elementi logici fi:ompleto, nel senso che qualsiiogica possa essere eseguita me

1_W.">UIUIM_VIIUbio da parte degli specialisti.
Esempi di tali programmi sono i siprogrammi percalcoli di integrali quaninici ; altri programmi basati sull'energienica; programmi per calcoli relativi a sismici (dati spettrali (fig. IO), cinetici, ec<grammi per calcoli relativi alla chimic

metri da determinare, si impiegano rispivamente metodi di stima lineare o non linePer le applicazioni di questi metodi sonoscritti in letteratura e sono disponibili ]grammi in diverse varianti. C'è da osservaquesto proposito che proprio la diffusionee. e. numerici di grandi dimensioni ha ]possibile l'uso dei metodi di stima non linealtrimenti troppo complessi, e di conseguel'adozione di modelli semiteorici, solitaminon lineari, che presentano, rispetto ai moiempirici, migliori caratteristiche di affidabe di estrapolabilità.
Un altro tipo di applicazioni è costitdalla determinazione delle condizioni ottii

irti di impianti (ad es., dimensionar)mgc, verifiche di stabilità, calcolo <oni, calcolo di diaframmi, calcoli di iverifica di apparecchiature, come eambiatori, ecc), i e. e. trovano nìpieghi, nonostante che si tratti genedi calcoli relativamente semplici,
:ll'elevata ripetitività dei calcoli stessttimazione. L'ottimazione degli ilimici (V. AUTOMAZIONE E OTTIMa globale che relativa alle singole inature, è stata resa possibile dalì;ll'uso corrente dei e. e. di graensioni.

dei diversi numeri di rilevanza.Nelle tecniche di tipo matriciale, infine, che
permettono di mettere in evidenza le interre-lazioni fra attività di tipo scientifico e tecno-logico e i diversi settori della tecnologia, i e. e.permettono di quantificare le matrici e di va-lutare gli effetti delle variazioni dei parametriche compaiono nelle matrici stesse.
Nella ricerca applicata, orientata verso pro-dotti o processi, uno dei problemi più impor-

zn/.ionc manuale del relicolo.Sistemi informativi per le direzioni di riie sviluppo. Di questo tipo di sistemi ilillativi, che richiedono come strumentoaventi grandi dimensioni, esistono esemr.meno parziali in alcune grandi societàchim
Un sistema informativo completamenttegrato dovrebbe contenere informazioncilmente accessibili da parte della direz:eventualmente mediante l'impiego di tenali collegati al e. e. Tali informazioni ri|Hnnn apnpralmpnfp" la rPCTit*trfl7irmp e* 1'

vaiile clic nei nuli si uuvcuiu aliene ili icaJ
grassi e succhi cellulari della pianta. Si estrgono, volendo lasciarli in forma di glucoscon diversi solventi come acqua e acido ehdrico, metanolo ed acqua, butanolo e acacetico, curando la distruzione degli enzche possono provocare idrolisi anche a batemperature. La purificazione delle miseviene effettuata con l'uso di metodi cromagrafici comuni anche ad altre classi di giù

La possibilità che l'unità cinnamica si/j-ossicinnamico o il caffeico e derivatuenti normali delle piante, spiega ;posizioni preferenziali degli ossidrimetossili nell'anello B dei calconi.
Per quanto riguarda l'azione farmadei e. questa verrà descritta in mesteso a proposito dei vari composti 1dici (v. CROMANI; CUMARINA; FLAVOÌ

sfrutta il fatto che il berkelio si può ossidaabbastanza facilmente allo stato di ossidazine +4, mentre gli altri elementi pesanti delserie degli attinidi e gli elementi dei lantanicformatisi per fissione, preferiscono lo statoossidazione +3. Si lascia quindi in riposofrazione di 219BkIV per un certo periodo oniconsentire la formazione di 249Cf per emissine p. Successivi cicli di ossidazione e riduzine, con procedimenti intermedi dì estrazio:con solventi, cromatografia estrattiva o scaibio ionico, consentono dì ottenere una fr

lunga vita, come i -*"Am o 11 -*-i_m.,mativamente lo 0,3 % del 239Pu origiivenire trasformato in teoria in 252Cil resto va perduto per fissione neidell'addizione successiva di neutrontica la resa è inferiore a questo vaiotamenti di irradiazione vengono seguserie di processi chimici (estrazionevente e scambio ionico), che vengctuti a distanza con apparecchiatumate.

II calore specifico di una sostanza sicome il limite del rapporto tra la qu;calore fornita o sottratta a 1 g di :e la variazione di temperatura osserformule si ha:
dove dg è il calore scambiato per v;

sto, e tenendo conio che per u{dEldV)T =-• 0, si ha Cy -Cv =che si tratta di calori molari p<riferiti ad una mole di gas. Quesvale per i gas perfetti mentresolo approssimativamente ad uril quale si ottengono per le difllori molari a pressione e a vovalori maggiori di 1,987 cal/mvalore di R. Tale differenzagrande quanto più il gas si discportamento ideale. L'assunzionun gas perfetto l'energia internate dal suo volume non è valida

Il coefficiente di scambio termicciente globale
Per i calcoli tecnici è vantaggiopiuttosto che le informazioni suilocali, una proprietà media le)stessi. Il coefficiente di scambiofluido viene definito dalla relas
h = q/AT

Comludliililik Irrmiai dei lic|iiuli. Lune molecolare di calore nei lii/nidi nodato il relativo stato di addensalimolecole, avviene prevalentementesusseguente eccitazione dei gradi diterni se le molecole sono poliatonun meccanismo abbastanza analojanche la trasmissione del suono,possibile intuire una giustiflcazioesnressione nronosta da Bridsmar

dove ATè una differenza di temperatura licaratteristica. Così è anche possibile deducoefficiente medio dalla quantità totale dlore scambiato.
Quando, come accade nei problemi contorni a geometria complessa o con moto e:zialmente tridimensionale (e quindi pervasta gamma di situazioni importantipunto di vista applicativo) non è possibiltenere soluzioni analitiche o numeriche,

Convezione forzata con flusso normdri isolati. Al variare del numero dvaria l'esponente della correlazionetutti i fluidi per i quali Pr> 0,7:
Nu = CRenPri
Si ha pertanto il seguente prospetè il coefficiente di forma:
Re n

aminare (Gr< IO9) l'esponente « del numeiii Grashof nelle espressioni monomie:
Nu = C-(GrPr)H
b pari ad 1/4; in regime turbolento (GrPr> IO9) n è pari ad 1/3.Convezione naturale lungo pareti verticali pine o cilindriche. Per la parete piana indefini1 problema è stato risolto teoricamente <

omagnetichc; la produzione e l'assetraverso processi atomici e moleci3 quantistico. La distribuzione didiante attraverso lo spettro di friscritta dalla meccanica statistica
teoria della produzione e trasmdorè per irraggiamento è un pun;1 quale confluiscono varie discipII tema nei suoi dettagli è dei più <ci sembra il caso di rifarci alle leg:iri e ad alcune delle considerazio

schleioer J. u., (Jurtiss U. t., bira K. B., A/o/ular Theory of Gases and Liquids, New Yorahn Wiley & Sons, 1954.tei H .C . , Sarofim A. F. , Radiative Transftlew York, McGraw-HM, 1967.ob M., Heat Transfer I, II, New York, Jolrtley & Sons, 1949.n D. Q., Process Heat Transfer, New Yor4cGraw-Hill, 1950.udsen J. G., Katz D. L., Fluid Dynamics aleat Transfer, New York, McGraw-Hill, 195Adams W. H., Heat Transmission, New Yor4cGraw-Hill, 1954.

l'ampolla e la camicia e avremmo un sistemaudiabatico. Nel calorimetro in questione sigenererà invece una differenza di temperaturae così ci sarà uno scambio di calore che deveessere determinato e del quale è necessariotener conto nel calcolo. Dato che il principiodel calorimetro isoperibolico è usato moltocomunemente, daremo una breve descrizionedei metodi di calcolo dello scambio di calore.La figura 2 mostra una curva tempo-tempe-

metrici cne prevede misure ai piccole quantidi calore o effetti termici, spesso in procesdi lunga durata.
Calorimetro a pompaggio termoelettrico dcalore. Precedentemente abbiamo descritto cime l'assorbimento di calore in un processendotermico può venire compensato dal e;lore liberato da una resistenza elettrica. È nitevolmente più difficile compensare la vari;zione di temperatura in un processo esotemico. Comunaue. è Dossibile norrmare via

no registrate come variazioni di eniAH =AE + pAV
Calorimetri a mescolamento e a flusso.una misura calorimetrica due o più ccnenti sono mescolati insieme di solito eè fatto in una ampolla.
In alcuni casi si mescolano i contendue compartimenti separati dell'amporeazione. Queste tecniche sono di solitomate tecniche di mescolamento. È anchsibile unire i componenti di reazione per i

irata con un potenziometro) e dal temporefissato con un temporizzatore elettronico).i reazione da studiare viene innescataitomaticamente, a un valore prefissato dellasistenza del termistore, da un meccanismoionato da un motorino che rompe le paretiittili della fiala del campione contro unaicchetta dalla punta di zaffiro assicurata alndo dell'ampolla di reazione.La precisione per reazioni brevi e variazionicirca 0,3° di temperatura è dello 0,01%.
Con altri dispositivi simili a quello della;ura 7 è possibile titolare un campione iniluzione: titolazione entalpica.In questo caso il campione liquido passa in

nella fìf>ur;i 9. Il calorimetro è del tidoppio a schermo adiabatico. Le ampolle (lori metriche sono di metallo (tantalio) e somantenute automaticamente alla stessa teiperatura della camicia adiabatica circostanLe ampolle gemelle sono munite di riscaldairi elettrici e di termometri a resistenza. I t<mometri formano rami adiacenti di un pordi Wheatstone, il cui responso indica la dferenza di temperatura fra i due calorimetII segnale in uscita viene amplificato e rivela

cioè il caiore generalo nena cena netempo sarà uguale al calore traspcdalla cella e questo effetto termicomente proporzionale al voltaggio delpila osservato.
In altri recenti microcalorimetrisono stati impiegati il principio delleadiabatico (Stoesser e Gill, 1969) e ilisoperibolico (Picker et al., 1969). (timi hanno recentemente descritto ìmetro a flusso isotermico simile irprincipio al calorimetro a labirinto (

Le determinazioni di capacità tercondotte su solidi, liquidi o gas e ipò di temperature estremamentetemperature vicine allo zero asso!3000°. Le capacità termiche possimisurate a volume costante (CJ oa pressione costante (Q).
Le misure di capacità termica siimportanti per diverse ragioni. L>

:r misure di capacità termica :d es., il calorimetro riportatocapace di una precisione s31 % se si prendono particolairante la misura. In questo casipacità termica consiste in untaratura fatta sul calorimetro>sta una quantità nota m di :rispettivamente, di soluzionejre è tarato in unità di tempeile calcolare la capacità termiidia calorimetrica, dell'agitatesperienza fatta con il solver

La tecnologia è attualmente in fasdo sviluppo in quei campi dove si ricondizioni estreme di temperatura e ]Possiamo, perciò, prevedere notevoramenti degli strumenti impiegatialle alte pressioni ed alle alte terr
Fig.18 Schema di funzionamento di un etro a schermo adiabatico per misure dif!innrÌ77!i7Ìiiiip a rii farvipìtcì tt^rminhf H

ìieme e come, per questa sua prerogatidebba essere prelevato con tecniche beminate al fine di rispettare tale caratiAnche quando il campione serva co)di una contrattazione, la fornitura <gola, controllata su di un secondo aprelevato da questa e i risultati del edebbono essere uguali a quelli ottesampione base della contrattazione si
Le tecniche di e. sono diverse a secc

il tubo interno è diviso in caselledi 1,20 m e dieci per sonde emodo che ogni casella contengprelevato in un certo punto d<ffig. 7).
Per prodotti in pani, se semisiparticolari succhielli che trattengre porzioni corrispondenti ai vamassa (fig. 8); se solidi (metalli,

sntre per la seconda formula, con nenti lo stesso significato del caso:nte, si ha:
a le due formule vi è una forte <inza; infatti da un lotto di 1000 contiin la prima formula se ne campionaicon la seconda appena 23. La primula appare quindi adatta per un nimplessivo di contenitori che non s:riore a 100.Naturalmente da ogni contenitore 1•"\i-n rii r\rr\r\r\+tr\ r or1 1 a fnrtna TIAUO ria

| > | > | > | >orbitali dxy, d,/z e dxz,la specie t2g. Dal punria dei gruppi risulta cid2i e dxt-y: hanno la stedegeneri, come pure i

o, avremo 1 due livelli "E e 1E con ilondamentale (i livelli a maggiore mita di spin derivanti dalla stessa soigurazione sono sempre a minore eix sottoconfigurazioni b\, a\ e b\ inveono dar luogo solo al livello XAX p«[uadrato di qualsiasi specie di simmetilodimensionale da solo la specie total

lato prima, ma questa voltanmelria si ha che A2 correla si;n B2. Siccome abbiamo vistosere di singoletto, il livello 3
rrelare con quello sA2(Civ). Sinto il diagramma:

Operando in questa manie:nuti i valori di energia che :tali d in campi di varia siibella IV sono riportati alciocedimento del tutto analeilcolare la scissione degli (lea di principio, p, g, ecc).alcolo per configurazioni dn.à visto una configurazioneattata secondo lo schema demi la rprmlsinnf* plpftrnnir

degli atomi donatori), indica che l'orgrandezza delle due configurazioni è loPer eseguire i calcoli con perturbaziccessive si ricorre ad un metodo di pezione su sistemi quasi-degeneri. La sperturbazione agisce sul sistema comefosse lasciato degenere dalla prima pezione (quindi si scrive il determinant

dapprima qualitativamente e poicenni di calcolo. Prendiamo, ad es.3d legato a sei atomi donatori (siiciascuno dei quali capace di formme CT (con due elettroni da doilegami TI (fig. 5); le specie di sirrcombinazioni di orbitali che nebase sono riportate nella tabella Vche essendo l'operatore hamiltosimmetrirn »;nln pii orbitali (n ci

iilliii'iUirc lo studio spcllriilc dal momento: sono considerati anche gli orbitali dei le-ìli. Nella figura 8 sono riportati anchelenii OM per complessi a simmetria Dih.}er eseguire il calcolo con l'usuale metodoiazionale occorre risolvere il determinanteolare \Hfi—S,-jE\ = 0 per ogni rappresen-ione irriducibile e perciò determinare i va-i di:
Hl(= Jv*HV( dr , Hu = J>*/fy, drS;* = [WÌWÌ àx

Come abbiamo visto, nelteoria del campo cristallinelettronici è funzione deldovuto alla repulsione inilore di questo parametronoto sperimentalmente. Seatomo donatore è parzialrme in genere avviene), gli elizzati anche sul legante einterelettronica è minore eCome conseguenza, nel civalore B' minore di B. B' \al fine di ottenere un buo;calcolati e spettri sperin

orbitali d del metallo (centrosibitali s e p (i secondi non-ceidellegante. Il coefficiente di esiem (1 • crrr1 • mol"1) delle banmento nei complessi non-centrpende perciò dal grado di cogame metallo—atomo donatodine di 100.
Per i complessi centrosimmd-d sono sempre proibite peresemnre centrosimmetriche e il

rovano considerando il momento di sne un momento angolare qualsiasi (coiere della matrice di rotazione: sen[(5sen (a/2), dove a corrisponde all'anjotazione). L'unica differenza è che ìli S possono essere anche seminteri. Tnaso la rotazione di 2TC non corrispoiIla identità (usando la relazione dataira si vede che il carattere di una roe = 0 (identità) è uguale a meno il e;li una rotazione a = 2TI), ma ad unaiperazione R. La rotazione 4n corrispìuovo all'identità. Il numero di opera:immetria del gruppo perciò raddopp

cato è —?>EjSH. Il momento magnetictale per grammoione M (uguale al monmagnetico totale per ione moltiplicato ;numero di Avogadro N) è dato dalla rstatistica dei momenti magnetici di ogngolo stato, cioè di ogni singola fundel tipo \LMlSMs} dei livelli popolati aperatura T. Supponendo una distribu

CANADA, BALSAMO DEL
Prende questo nome una oleoresintiene per incisione del tronco di uticolare di conifere canadesi {AbiesSi presenta come un liquido viscosete, leggermente colorato in giallocon un gradevole odore di pino. Hdi rifrazione (1,518-1,522) che è ma quello del vetro. Per prolungata <all'aria si rapprende in una massa '

irodotti, si possono ricondurre essenzialmderivati dell'acido diamminostilbendisc
lieo, dei dibenzotiofen-S-diossido, degli zmono e bisazoli), della cumarina, e dì alomposti eterociclici con anello a 6 at<Juesta suddivisione, da tutti comunem

no, ecc).Non tutte le strutture idonee apj
a questa classe sono riconducibili itura generale (II). Sostituendo ad esedei due gruppi solfonici dello stilun gruppo elettron-donatore (alcosssi ottengono effetti di fluorescenza rsastri che conducono ad un biancotro di quello ottenuto con i compostrici, e pertanto alcuni monosolfoninn imnipoafi in micppln mr\ altri

applica/ioni a causa della loro scarsa sosiUvità; si vide presto che le 7-amminocu]rine, specialmente se 3-fenilsostituite, pòdevano ottime proprietà sbiancanti uniteuna buona affinità per la lana e per le fsintetiche (Ciba: U.S.P. 2.610.152, U.!2.791.564, F.P. 1.025.467).
Attualmente i più importanti candeggidi questa serie sono essenzialmente ricoricibili alla struttura (XV) :

candele di cera trovarono impiego rzioni religiose; a questo scopo furscritte le candele di cera d'api la custione da luogo a minori quantità di ;il cui odore è molto sgradevole. Peimestico le e. più impiegate erano isego che in genere venivano preparcsa; queste e. avevano un costo inquelle di cera, ma si consumavancmente.
Le prime cererie di tipo industria

i più allo p.f., bruciano con dillicollù. Liunta ili acido stearico alla paraffina pernii ottenere e. che bruciano con fiammatante e dall'aspetto attraente. Paraffinacido stearico vengono impiegati di solitos seguenti percentuali: 67 e 33, 75 e 25: 15, 95 e 5.
Sono molto impiegate anche miscele diaffina, acido stearico e cera d'api con leentuali: 60, 35 e 5; 70, 20 e 10; 60, 30 e^a cera d'api è appiccicaticcia e fonde n'aa le e. ottenute con essa hanno una t

Proprietà fisiche. Il cunl'ene (p.f. 47-48,5"; p.c158,5° a 760Torr; Dr{}," 0,8421; //{," 1,4564)
è un prodotto solido incoloro con un deboleodore simile a quello della canfora, moltevolatile. È facilmente solubile nei solventi or-ganici, viene cristallizzato da alcool etilicoII (+)canfene presenta [a]g +104° (etere)+ 108° (benzene), +99° (alcool). L'idrocarbu-ro racemico presenta le stesse costanti al dfuori del potere rotatorio.
Proprietà chimiche. L'ossidazione con permanganato Hi nntassio rnnHnre attraverso i

ir uusposi/.iom molecolari ;i cui v;i soggeicanlcne hanno un notevole interesse siarico che preparativo.
L'addizione a freddo dell'acido cloridporta dal canfene al cloridrato di canfinstabile, che a temperatura ambiente è spre in equilibrio con l'acido cloridrico ecanfene. L'acido cloridrico catalizza la tra<sizione del cloridrato di canfene a clorurisobornile, che molto lentamente si isomer

La formazione di un anidride, per nmento dell'acido canforico con anidriitica, indicava che fra i due carbossiliinseriti, come nell'acido glutarico, tredi carbonio. In base alla regola diBlanc (v. BTCARBOSSILICI ACIDI ALIFATICtre dall'acido glutarico per riscaldamottiene un'anidride, dagli acidi bicartcon un numero di atomi superiore a ciottengono i chetoni. Pertanto la canfcveva contenere un anello ciclopentar

pinene viene trasformato in acetato dinile per riscaldamento con acido acepresenza di acido borico.
Infine il p-cimene viene trasformatcanfora per riscaldamento con sali ecurio.
Analisi. La determinazione quantitathcanfora può essere eseguita sia tramittma, sia tramite il 2,4-dinitrofenilid
TI Hosia^mn Hella ranfnra npr via m

Acidi solfonici. L'acido 10-(to)-canfosolfonip.f. 193-195°, [x]D + 21,6° (acqua), si otti<per azione dell'acido solforico concentrateanidride acetica sulla canfora. Trattandocanfora con acido clorosolfonico o con ac:solforico fumante si ottiene, con racemizzione, l'acido (±)canfo-7i-solfonico, p.f. 5
CH2SO3HV V

Epiborneolo e epiisoborneolo
La riduzione della epicanfora con socalcool etilico porta ad una miscela dialcoli, l'epiborneolo e Fepiisoborneolcrapporti 75:25:

casi molto semplicemente, e cioè agitando 1'deide in una soluzione concentrata acqueo alcolica di alcali, senza riscaldamento.
Meccanismo della reazioneNel 1940 Hammet, sulla scorta delle corscenze di quel tempo, propose il meccanisrseguente. In un primo tempo il carboniledeidico subisce l'attacco dell'ione ossidrile tgenerare l'intermedio (I) o (II):

Anche l.i /j-uimcliliimminobcnzuldciuu e le aldeidi con un gruppo ossidrilico in orto o parenon danno la r. di C. in condizioni normaliSi può tuttavia condurre per queste sostanz(la dismutazione, sia normale che incrociatacon buone rese sfruttando Fazione cataliticidell'argento : tale catalisi è stata applicata coisuccesso alla vanillina, alla 5-clorovanillinaalla salicilaldeide e alla p-idrossibenzaldeide
Anche le aldeidi eterocicliche aromatichi

ilchilazione. Il e. reagisce con quantità ste-:hiometriche di solfati dialchilici per dare;li esteri di caprolattime (Benson, 1948). Ad:s., il dimetilsolfato da l'O-metil-6-caprolat-ime (2-metossiesametilenimmina) :
OCH3
\\N + CH.HSO.

Nel ciclo classico (Taverna, 1970)esanonc viene condensato con sol:ossilammina per dare la cicloesanonf. 89°); sì opera a 85°, mantenende7 per aggiunta di ammoniaca:
O

La produzione di idrossilammin;r ossidazione di NH3 con aria e si <0 e NO2 che sono assorbiti in Eni nitrato sono ridotti cataliticame
NOr+2H++3H 2 ^ NH3OH++
1 reazione è condotta in ambiemito con un acido, in fase eterogjuido ed in presenza di metallo n

on un solvente ed inviata aNel processo Techni-Chem il
ie acilato con chetene a cicloesiene nitrato in anidride acetic-nitrocicloesanone. Questo vion acqua ad acido 6-nitrocapiidotto ad acido 6-amminocaà il lattarne per ciclizzazioncquosa.

ie precauzioni necessane percne nonl'umidità atmosferica.Basi volatili. Questo termine non è eesatto in quanto presuppone la presimpurezze di natura basica libere ed a Idi vapore elevata. In realtà con talesi definiscono in meq/kg le ammidi nche che, previa idrolisi su NaOH, melibertà le corrispondenti basi.

e. visli sopra vengono preponili per aci Fosgene sul derivato diolico e succimmonolisi del clorocarbonato corrispos, secondo lo schema di reazione segt
:H2OH CH2OCOCI CH2OCC
nteresse ancora maggiore hanno acquioprattutto per merito di Berger et al.,ivati dicarbammici di l,3-propandioli-2

La separazione del e. dagli altri componidell'olio di antracene (antracene, fenantreparaffina, ecc.) si realizza facilmente. Per diìlazione a pressione ridotta, in presenzaK.OH, si allontanano gli altri componenti, mtre il potassiocarbazolo formatosi nondistiPer idrolisi di quest'ultimo si ottiene il e.può venir purificato per distillazione o crislizzazione. Un metodo dì separazione dicente impiego si basa invece sulla cristalzazione da piridina dell'olio di antrace
II e. si recupera dalla soluzione piridire viene successivamente purificato per crisIi77a7ione da cinrnhenzene.

wsizione 2 con un gruppo contenenteLa pirolisi o la fotolisi di o-azidot
:onduce al e. e ai suoi derivati con resealmente buone. Un esempio di questrione è la ciclizzazione dell'o-azidofeni:sano a esaidrocarbazolo, con una re

:lorurazione del e. con cloruro di tii;ome abbiamo già detto, dal 3-amna reazione di Sandmeyer. Il 2-clt-cloro- si possono preparare soltantesi, mentre il 3,6-dìcloro- si ottieilandò il e. con cloruro di tionile o di
Per trattamento del e. con Cl2 inli CCI4, o per azione di SbCl5, si 0>olialogenocarbazoli di struttura :lifficilmente determinabile.

>gc- CARBOCHIMICAxlo-
La carbochimica riguarda la conversioìcarbone in combustibili (solidi, liquidi i
-Cl2 sosi) e in prodotti chimici (idrocarburi aitici, gas di sintesi, ammoniaca, coloranti,
es., ma ha perso, però, moltissimo della suturi portanza con lo sviluppo della petrolchiipe- oggi il petrolio ed il gas naturale han
gran parte sostituito il carbone come foprodotti chimici.
,„ Genesi e composizione del carbone

assa (500-750°), a media (750-i temperatura (900-1175°).: ottenuto dal procedimento atura è particolarmente adatto pL'industria siderurgica ne è il
.limatore accanto a quelle per leli carburo di calcio e di gas di sittoprodotti del procedimento aiura si ottengono catrame, uni«natica (benzene, toluene e xilcica, oltre ad altri prodotti ganel procedimento a bassa terr
ì cui viene ottenuto il semicok

uà ai i i/a ai caroone. 11 caroato e miscelato con olio di ricicpressoché uguali veniva idrogeiza di catalizzatori a base di ossi00 atm e 480° con tempi di (a 2 h. Le rese erano del 40-4510% di residuo e circa il 20^dotto del processo Bergius oravia di qualità scadente, con alili ossigeno, azoto e zolfo e comilmente da idrocarburi ad altoire. Anche variando le condiziìe la quantità di prodotti be1 aumentava

e dell'acetilene stessa,i alle utilizzazioni sopra ci':azioni chimiche del carbisnti, vi sono altri impiegrrietà fisiche del carbone core trattato. Tipici esempi soni carbone attivo (—>-), di gìli grafite e di carbone arrLRTIFICIALI).
ipieghi del carbone comeprodotti chimici riferisconiose, Batchelder, West ch<ie l'evoluzione della e. neg

e. hanno una struttura che ricorda molto iella dei cheteni, R2C=C=O, edegliisocia- ili, R N -C=O, e, in effetti, anche il com-rtamento chimico è abbastanza simile (v. :ETENi; CIANATI E ISOCIANATi). (Va ricordata però in modo particolare la imone fra le e. e gli acidi, non tanto perché iestà conduce alle uree, ma perché consen-di ottenere le anidridi degli acidi in condì- ]•ni particolarmente blande:
O
R-N=C=N-R+HO—C—CH3

compresa fra 0,3 e 0,6 g/cm3
della particella, che varia frae con la densità reale del malso, che è pari a 1,9-2,1 g/crriparticelle sono compresi fra
La più importante propriesuo potere adsorbente, in germe la quantità adsorbita pcarbone di un'appropriatabenzene, iodio, carbonio tetriblu di metilene, sotto condnormalizzate.

'uria .illcv/^i: il liquido, che deveilicato, viene ulimeiilalu ;illa colon
velocità lineare apparente varia10 m/s.
pecialmente nell'industria dello zuc)one esausto è rigenerato in un f</azione.arbone granulare è inoltre usatoeco, come supporto di catalizzatoresi del vinilacetato e del vinilcloruesolforazione di gas, nell'addolcim

sia per il consumo nazionzione, mentre l'industria eira in fase di grande espa:ilcuna fonte nazionale dimiche e doveva importar. Si può dire che l'utilizzazi'ottoprodotti da parte delldato un notevole contrib
iell'industria chimica tedesjrima guerra mondiale.;liorati dei forni a coke a:3tto, Hoffmann, Semet, Sie hanno portato alla realiz;moderno del forno per so

:nto. I j',as caldi, generali per comò'a base e ei condotti, ascendono quesiin cima alla camera passano in una.sversale, che li convoglia in discesa•so i condotti opposti ed i rigeneratii di arrivare al camino. Questi gasno così gli impilaggi di mattoni. Ognnuti è invertito il flusso dei gas si

Darazione dell ammoniaca, dove soncn acqua in torri riempite di griglie ddi coke in frammenti; da queste tor»uono all'unità di recupero benzoloinità di depurazione dei gas.Il catrame e l'acqua ammoniacale riendensano nel bariletto umido soncti, e la fase acquosa, in seguito a dilin acqua povera, è riciclato agli spru1 bariletto umido. Il catrame e l'acqindensano nei collettori primari e neitatore elettrostatico, sono separati•Ita; il catrame passa nel serbatoio

saturatore questo sistema è analogocesso diretto.
Prodotti di distillazione1 prodotti principali della distillazionibone sono quindi : coke, gas, catramibenzolo grezzo e solfato d'ammonioacqua ammoniacale. Le rese di questisecondo il processo di distillazione ume illustra la tabella I.

grezzi di carbonizzazione, questi devonsere trattati allo scopo di togliere l'idresolforato e l'acido cianidrico, prima di edistribuiti come combustibile di uso domeo industriale.Rimozione di H2S e HCN con ossido difermetodo normalmente impiegato a questepò è quello delle casse di depurazione. Qsono camere o torri di acciaio di granemensioni che contengono letti porosi di odi ferro idrato in forma attiva; sono conmpntc nti1Ì77ati pii ossidi naturali tuffar

rene ed antracene, anch'essi prominenti. Itil- e dimetilderivati di questi idrocarburimatici ed i corrispondenti composti eterocsono presenti in quantità minori. I comiossigenati, con l'ossigeno in un anello aque termini, sono i più comuni compostirociclici, seguiti da basi aventi l'azoto e=N— in un anello a sei termini, oppunme —NH— in un anello a cinque terr

mie un LUIILI;IIIUIIU ui iiuiiuiciiL. il rcsr
di questa terza colonna e Folio di lavagella seconda colonna passano nella quarlonna di frazionamento, che opera sottcD, dalla quale una frazione ricca di fluoe di acenaftene è ottenuta come prodottesta. Le altre colonne, che operano sottca, sono usate per separare dalla pece re-i un taglio stretto di una frazione di an-ne e fenantrene e di una frazione di car-io grezzo.separazione del catrame grezzo in pece
rame di base, ed in una serie di olii distil-; quindi il processo primario nella raffi-ine del catrame. I processi secondari con-io npllV^trayinnp rii cnctan-z** nfiimiVFif

Himpata in una centrifuga, e doione dell'olio è lavata con una suita e calda di soda caustica. Iìaftalene lavati sono trasferiti in ili fusione dove avviene la separaziua trattenuta. Il naftalene fuso <ita adatta per la produzione di iica. Gli olii separati dai cristalli iuga contengono ancora il 30% e:d è uso comune separare questidone di nafta, in un concentrato•iriHatn ai serbatoi di alimentazioi

ripe, in « *_nem. ana ina. », (IVb'i), 44.^handler D., Lacy A. D., The Rise of
Industry in Great Britain, London, BITCouncil, 1949.
^harlton F. R., Chemically Modified Coal Tar <in « Corrosion », 15, (1959), (9), 90.
^herkasova L. M. et al., Operation of aPlant, in « Koks i Khim. », 8, (1956), 41
riifton R. V., Webb W. H. A., The Designration of Continuous Tar Acid Plants, in <•Chemist», 32, (1956), 526.
^ooper L. S., Johnson R M., The Vacuum Cand Contaci Acid Plants at Beckton, Londof Gas Engineers, Publication N° 556, 1
Continuous Tar Distiìlation with thè New Wil
![Universo - Enciclopedia Einaudi [1982]](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/55a8d8241a28abae3e8b45c3/universo-enciclopedia-einaudi-1982.jpg)

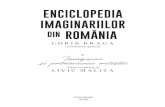


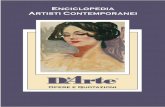


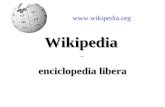

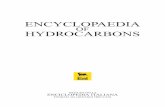
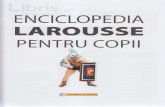
![Evoluzione - Enciclopedia Einaudi [1982]](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/55a39d051a28ab7e548b47f7/evoluzione-enciclopedia-einaudi-1982.jpg)
![Esoterico_essoterico - Enciclopedia Einaudi [1982]](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/55a7c8081a28abc4688b46dd/esotericoessoterico-enciclopedia-einaudi-1982.jpg)