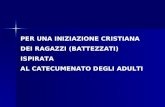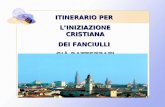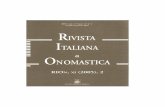PER UNA INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI (BATTEZZATI) ISPIRATA AL CATECUMENATO DEGLI ADULTI.
E COGNOMI - Internet Archive...Di nomi (li persona, o, come si dice pii1 comiinemente, di...
Transcript of E COGNOMI - Internet Archive...Di nomi (li persona, o, come si dice pii1 comiinemente, di...
-
ANGELO BONOIOANNI
l YOMI E COGNOMI Saggio d i ricerche etimologiche e stari~he
F.lli Bocca - Torino 1928
-
Se il lettore bencrolo (mi sia lecito sperare tli averne a,lnicno uno) rorrS dare iitin occhiata alla (i Eibliogrnfino di cui Iio crediito niio do- vere corredare questa operetta, osserveri che finora in Italia poclii stufiiosi hanno rivolto la loro attenziorie aUe ricerche onotnllstiche, iiieiitre altre nazioni posseggono ricchissiiiii rcl)ertorii, utili sia agli scienzinti che alle persone di n~ed ia cult,iira che, per soddisfare un% ciiriosith ilun infrcrluetite, cerchiuo l'etiinologin o le ragioni storiclie ùi un iiomc o di un cogiionie. È yero che, per quel che rigu:ird:~ i cognomi, la « Dis- sertazione » del 3Iiimtori (« Autiquit. Itnlicae r XLII ) è tuttora iin esempio insigne di itidagiiie critica, e contiene certe noririe fondamentnli, alle rliiali si atteriiicro il cibrsrio, il 5'lecliiaj e quatiti altri si occripnrono di quest.:l materji~.
Di nomi (li persona, o, come si dice pii1 comiinemente, di battesirno, anche se si pai,ln di non battezzati, abbianio qualche dizionit- rietto, con intento dirulg:ttiro, di cui noli 6 q ~ i i il c:hso di discutere i pregi ed i difetti, t:iiito piu che queste oy~erette oriiin.i ditticilniente si tro- vano nel comniercio librario. 31;~ noti c'6 iu
-
Italia un'opera parsgonahile, ad es., ;a quella del Forstemann per l'onomasticn. germanica. Mi affretto a tlichiarare che è lungi da me il teme- rario proposito di fare in rliiesto campo un'opera, per così dire, definitiva e monumentale. Il mio intento è molto modesto: partendo dal prin- cipio che il cognome è sempre. un pstronimico (in qiialche caso un matronimico), anche quando derivi da un soprannome, o (1:~ un mestiere od uficio, ecc., e che nella formazione dei cognomi la fonte più copiosa è il nome personale, ho voluto studiare e porre in luce le innumerevoli e talora in apparenza stranissime variazioni che il nome subisce neli'uso popolare dei varii dia- Irt,ti, ed i cognomi che ne derivano.
S'intende che tralascio, di regola, i cognomi di cili l'etimologia è evidente; sarebbe lavoro troppo facile, e di nessuna utiliti.
A l s quali sono i limiti dell'onomastica ita- liniia? Certi nomi. popolari e tradizionali in una partc d'Italia, nelle altre sono sconosciuti; molti sono caduti in disuso, ma sopravvivono nei cognomi; ciò vale principalmente per i nomi di origine germanica. Inoltre, neLllimposizione (lei nomi concorrono il sentimento religioso, la tradizione, il costume, la moda, le opinioni po- litiche dominanti, e l'arbitrio personale. La reli- gione 'suggerisce di imporre a1 neonato il nome del Santo o della solenniti del giorno natalizio; per tradizione, nelle dinastie regnanti o spo- destate, nelle famiglie nobili, ed in molte fa- miglie contaciine (anche questa è una aristo- crazia, !) si ripetono i nomi degli avi. I romanzi,
-
il teatro, lo sciocco esotismo dànno voga a nomi (1 distinti b) o (I signorili n: non sono da gente per bene; «Margherita io è giù di moda; una signorina (i up to date I) si chiamerà Daisy 0 .
Da romanzi, popolari :LI loro tempo, ed ( i ~ ~ i dimenticati, ci vennero « Ivanlioea, ( I Raoul 0 . ci Goritrauoi); dai libretti d'opera « Oscar e, « (.:ai.- meri )o, e Dolores ., «Sidso. La, passione pi~trio- tica sostituì ai nonii dei soliti Santi quelli i l i illustri Romani, o di niartivi della Patria; (;;L- ribaldi f u il prinio, ci,ed», che ai suoi figli i n ) . pose due cogiioiiii, i11 Eiinzione (li iioiiii piLi'sio- nali: Menotti e Ricciott,i. 111 t~niloi noil loiitniii, quando in qu:~lchc lirovincia d'Italia trionf:~v:i il so~~versivismo, sp~iiitarono i nonii di ( ~ A ~ : L I . Y ~ ) , e C,omunardo i),
-
20 Komi longol>ardi o franchi, che soprav- vivono al meno in un cognome.
30 Xuini derivati da poemi e ronianzi del ciclo cnrolingio o del ciclo di Artu.
40 'Jomi, schiettamente itaii;~iii e spccial- niente toscani, che esprinioiio un augurio od
ii:ia promessa, come (i Ueiiveriuto I>, (1 Eonaven- t,iirai), (i Aiiegranza o , ecc., od ;~lludono al mo- ment,o della nascita, ad es., a Xascinguerrs o ,
Fin iguerra a e simili. Con questa umile fatica mi lusingo di arcr
portato un piccolo contributo all'oriomastica italiana; direi « uu mattone » all'edifizio ehr altri con pii1 ingegno e dottrina saprà elevare; nia so che cosa. significa t mattone>> nel gergo dei giornaiilisti; valga a scusa la scarsa mole del mio libro.
-
Kome d i o t t o Santi , dei quali i piu noti soiio S. Ab. hondio mart i re a Ronin sot to Vsleriano, e S. Abhonilio veseo\.o
-
dbramo. Significato R alto padre n. Abbastanza f requente in Italia, sebbene dei cinque
Sant i di questo nome q u a t t r o appar tengano alla Chiesa orientale. T u t t i dei primi secoli del Cristianesimo:
Cogn. friulani Ahramo, Bram, Bramés, Brainos, .moso, Bramus, Bramezza, Brainuzzo.
S e l l a toponomastica, ricorre due volte in provincia di Cuneo, m a non i: escluso il nome gerinanico Azeranio.
Acacio. Di significato equivalente al latino Innocena, Inno-
centius. Oggi disusato; m a in altr i tempi dovet te essere frequente, essendo l 'etimo d i molti cognomi e nomi di luogo, ta lora in concorrenza con Cassio, Cassiano. Sei Santi , t u t t i della Chiesa orientale. F u usato aiiche in Francia: dqace. Aqasse.
Cogn. Agazzi, -zzini, -zzoni (Lombardia) doride pro- babilmente I'emiliano Lagasi e i lombardi Ragazzi, -zzini, -zzoni. I n Piemonte e Liguria Gazzola, Cassola, Gazzelli, Gazzino, Cassini, Gazzone, Cassone, Gazzo- lini, Cazzuliui, Cassolini; in Friuli Cassi, Cassetti; nell'Eniilia Gazzetti, Gazzotti ; nel Trentiiio Gazzoletti.
Nella topononiastica: I ' ~ ~ c q u a s ò l a (Genova), che in genovese non i? aegua sula, come dovrebbe essere s e il travestimento i taliano non fosse erroneo, m a ocas- s6ea; Agaggio (frazione d i Tnora , S. Remo), dgazza (Varallo), Agazzana (Piacenza-Siena), Agazzino (P ia - cenza), Gaggi (Sondrio), Gaggio (qua t t ro i11 Lombardia), Gaggino (Corno), donde Gaggini, cognome d i u n a fa - miglia di scultori che da l sec. XIII -XIV a l SIX lavorò in t u t t a Italia, dalla Lombardia, a l Friuli ed alla Sicilia; non so quan t i Gazzo, Gazzolo, Gazznolo - ed ancora in Lombardia Cazzago, ed il turpe, i u apparenza, Trevia de Cazz (Valcamonica); forse Gàs- siuo (Torino, in piemontese Gasso).
-
N O N I E COGNOMI 3
Per alcuni di questi toponimi, e specialmente per i liguri, si può addurre l 'etimo aeacia. I n genovese agaggio è nome di pianta. non saprei esat tamente quale. Nessun vocabolario lo registra; m a Garibaldi, che i n famiglia par lava genovese, nel testamento dispose c h e le sue ceneri fossero dapostc in luogo d a lui prescelto * presso l'agaggio n.
Accarisio.
È forsc l a preferibile t,ra le varie forine d i questo nome germauico, d i oscura etimologia: Aceris , d c h e ~ i n . Ageris , d c e r i s i u s (docum. Fnrfense 770). I n Dino Compagni d c c i e r i l o .
Cogn. Accarisi, Acciaresi, Acciarito, .4ggè, Aggeri, Cnrisio ( ? ) , Garizio ( t ) , Assereto (?) , -4ssarotti (!).
Accursio.
Un S. Accursio francescario inartire a l 3larocco 1220, 16 gennaio.
Vedi Buonaccorso, so t to Bui>'io.
'iorne di cinque Sant i dei primi secoli (Ss. Sereo ed -Ichilléo, martiri, 09. 12 maggio).
Cogn. ilchilliui (ammissibile anche Aquilino). P ro- babili Chiletti, Cliiloni (ma in concorrenza con Mi- chele). Chilesotti mi pa re procedere d a Aehil lés . Forme analoghe sono f requent i nei nostri antichi scrittori: Cleopntr i s , Diogeiiés, Empedoclés, E ~ e o l é s , Palemiilés ecc.
Martire 3i Pozzuoli con S. Gennaro, in. 300. Cogn. meridionale D'Acuzio.
-
Ada. I n ebraico: allegra, lieta. S o m e oggi non raro,
senz'altra ragione forse che la predilezione di certe famiglie per i nomi bisillabi. I Romani li preferivariu per gli schiavi.
Adilbero, Adalberone, Albero: Alherone. Radici adal = nobile e bero = orso. Due Santi. e
d u e Beati , tu t t i tedeschi; d a non confondere con Adalberto.
D a n t e (Inferno, X S I X , 109) f a menzione di i in Albero d a Siena.
Cogn. Albero, Alberini, Alberoni. P e r i piemontesi Berrini, Berruti , Beru t to è forse più probabile Bar- bara , Barbaro. Vedi a suo luogo.
Adalberto, Adelberto, Alberto, Etelberto. Radici germaniche adal, ade1 = nobile, nobiltà, e
behrt = illustre. Dodici Santi; uno vescovo di Praga, m. 597, 21 aprile; uno vescovo (li 3Iagdehurgu,m. 981. 20 giugno; ma il pii1 celebre i: il B. Alberto 31agnu vescovo di Ratisbona, m. 1280, l 5 novembre. Di t u t t i i nomi gerrnaiiici colla desinenza bert è di gran lunga il più diffuso. sia in Germania che in Italia. Perciò d a esso, anzichè d a Lnmberto, Roherfu, ecc.. è probabile che derivino gli innumerevoli Berta, Berti, .tacchi, -tacci, -tazzi, -telli, - tett i , - toni, -tatti, -tiiii. -tucci, -tuzzi, in t u t t a Italia. I n alcuni derivati di seconda o terza mano, del uoine originario non rimanc che l 'ult ima consonante, con uno o due suffissi. Così d a Bertacchi, Tacchi, Tacchetti. Tacchini. Tacconi; d a Bertacci, -tazzi, Bertaccioii, Bertaccini, Bertazzi. Ber. tazzoli, Tazzi, Tazzoli = Bertacci, -tazzi, Tucci, Tuzzi. Bertocchi, Tocchi, Bertozzi, Tozzi. D a dlbertano (Brescia. sec. X I I I ) Bertano. In composizione con
-
S O N I E COGNONI -
5 --p--p
Barlolomeo. Tuccimei. Ma per Albertario, Bertarione, Bertieri, Bértali, -Iaaai, -letti, i n , -Ioni, -lotti t d a vedere Berlarito ( B e ~ t h a r i in i Origo gentis Lango- bardorum a). Lo scambio b = p & frequente nei nomi tedeschi, ed avviene anche in cognomi italiani: di origine tedesca: Bértele, Pértile (Sette Comuni).
Beito, per una mutazione di consonanti che ~ i o u mi pare contraria alle leggi glottologiehe, può dive- nire Verde. Abbiamo cosi una serie parallela: Verdi = Berti; Verdelli = Bertelli; Verdesi = Bertesi; Ver- doia = Bertoia; Verdolini = Bertolini; Verdoni = Bertoni.
Vedi esempio analogo sotto Berl~ando.
Adalgiso, ddelgiso, Adelchi. Dn ad111 = nobile, e gts = ostaggio, oppure kis =
lancia. Adelchis in « Chron. Got,han. ;l
-
Varianti Adelasia, Alagia (Dante , Purgatorio, X I X . 142). Alasia, Adele. Adiletta (anche cognome) Diletta.
I n Piemonte, cogn. Ala, Allasia. Allason, Alasonatti (proprio di Ala d i S tu ra , dove circa un quar to della popolazione è di questo casato). I n Lombardia Alesin3, Allasina, e più vicini a l nome gcrmanico, Deleidi, Leidi. Di patria non determinata Alazetta, Alzetta. I n Friuli Alsoiia, Alzona, Aita, Léita.
Esiste pure in Savoia, se non erro, il cogn. Aleyson. Delle ra r i e San te d i questo nonie l a più venerata
in Italia è Adelaide nioglie di Ot tone I , 16 diceiiihre.
.\delardo, Alardo, Aleardo.
Geriiianico dda lar , : ldnlhu~t, femiiiinile ~lda lh ,~rdn; dalle radici adal = nobile ed hart = forti!, ardito. S. Adelardo aba te d i Corbia, m. 827, 2 gennaio.
Cogs. Adelardi, Adilardi, Alardi, Aleardi, Allara, Agliardi, Leardi.
Ade, Adimaro.
Geriiianico .4udomar; dalle radici nud, O11 = patr i - monio. schiatta e mar, mdrs, m i r i = celebre. S. Ali- doiiiaro ( in francese SI. Omer) VI1 secolo, 9 settembre.
Se l l a formazione di cognomi concorre con r a r i noiiii di uguale desinenza (Valdemaro, Folmaro, Guai- maro, ecc . ) .
Cogri. Jlarin, -ni, -nett i , -noni, -ne t t i (concorre iii questi il latino ~Ilar inus) , J lara t t i , hlarazio, Marazzi, a r e l Alaroni, Xaroncelli, .1Iaracchi, Marucchi, De Mari, Mari. I1 nome femminile alarozia fu , non ricordu d a chi, in terpreta to per 3lariuccia; il Briickner registra, sulla fede di documenti Farfensi, l laroza. I'er il facile scambio a = o, d a Amari: Amaret t i , Amoretti. Dal francese d y m a r il piemontese Ajmale e d a Omar, Omer (S t . Omrr = S . Audomaro) il novarese Omar.
-
Ala per quest'ultimo & d a tener presente un Odemarus vescovo d i Novara, 1235.50.
Xolti sono i toponimi: Ambro in Caruia (i11 rilla de Adamaro 1291, doc. Glossario Prampero). I1 Alaro (donde il cogn. Ligure-piemontese Marco), Borgomaro. (Genova); Borgomale (Alessandria); 3Iarbs (frazione di Sospiralo - donde i cogn. veiieti blarbs, hlaras- sato -), l\Iai.eue, l larone, Etnarésc (Aosta); donde il cogit. piemontese Irnarisio, il Bosco òlareugo (Adimrl- r ingas), Ruh Marencs (frazione di Alontaldo-3Iondovi). donde i cogn. Alarenco. blsrengo, llarcngliini. Ni i cogn. liguri-nizzardi .\lcrello, JIercu concorre Anielio. il??icrio (vedi a suo luogo).
.ideodato. Vcdi Diodato.
Germanico .4lhn?iul/, . ~ < I P ) I Z L ~ / . Da albits = ;tiin
-
ddone.
C'& u n S. Adone vescovo di Vienna, sec. IS. 16 di- cembre; m a il nome è germanico, var iante d i Atto, Attone, Azzo, Azzone.
Cogn. Adoni (meridionale), Dorii, Doniui (toscani).
D a Adria, c i t tà antichissima che diede il iiome al I lare i\driatico.
' loine [li dieci Santi. S. Adriauo papa , se i . IY , 8 luglio. I n qualche dialetto, . I i ,dr ia~~o , dndreano, di renu to cognome.
Agamennone.
Greco, d i etimologia incerta. Secoiido il Pape, signi- ficherebbe stabile, costante. È il cognome del Direttore dell'Osservatorio di Rocca di Papa. Xon saprei darne u n a spiegazione. Si t rova in qualclie genealogia di famiglie nobili.
Agapito, dgapeto, Agahito.
In greco = amabile, diletto. Pe r l ' I talia bauno speciale importanza S. Agapito
papa (il a benedetto Agapito n di Dan te ) e I'oliionimo Patr iarca di Aquileja, successore di S. Erinagora. Agapit era ancora in uso in Friuli a l tempo dello Zorutti . Di qui una lunga serie di cognomi: Pit, Pi t t , Pitacco. Pitassi, Piticco, Pitocco, -cchino, Pitott i , P i t - tini, Pi t t i s , Pittoiii, Pituello, Pettoello, Petovel (si t rova anche a Yeucliitel, m a mi pare evidente l'origini: friu- lana). JIeno frequente, in Friuli, Agabilo, donde Gabos, Bit, Bitt i , Bittolo, e forse il veneto B u t t o ('.47a7116s). D a Agapitianus, Pit t iani, Pi t taua, Peteaui (slavo?). Fuori del Friuli Agapito (famiglia nobile Trieste). P e t -
-
haezi (piemontese), Pet tazzoui (loinbardo) e forse P i . Lenion- tuzzi (veronese) e per contrazione hpp io t t i ( p '
tese). .\la fuor i
-
«g. rigi, lat ino acies, acutus, e wulf = lupo, guerriero. Var iante di Ayilulfo.
C:ogf~. Aghinolfi. tinghinolfi, Anolfi, Ghinolfi.
dgilmondo, Agirnondo.
2 il primo nella serie dei re longobardi. Vedi norigo geutis 1.angoh.n t c Chronic. Gothan. ,n, Paolo Diacono. Dn. U I , . ngil = lat ino ucies, uculzis, e mund = difesa. protezione. In docuin. Farfensi i 4 5 :lcirnz~ndus. i5?- l i? Hisem?cr~dz
-
vano anche i cogri. analoghi Paternostro, -noster. e perfino Kyrieleison.
I i i greco, pura , casta, S" martire 304, 21 gennaio. Il cogn. friulano-cadorino Dell'Anése renderebbe
verosiiiiilc anche I'etiinologia d i Danesi, -sini. \Ia ii il Danese P (Uggieri) f u nii eroe molto pollolare. Da Aqnesc il friulano Gnesutta, rn:i non Cncsotto (in Valsugana, d a Agnedo .il. d . 1 . ) .
Derivato d a Augusto. S. Agostino. P a d r e ilella Cliiesa. ni. 430, 2 i agosto. Coinuiic iu Toscana Gesto (che ]>uò anche esscre ;luguslo).
Coyir. veneti-trentini Ostini. -nelli, -noni. Iii Fr iul i Agosti, U ~ t i r i i t , Ustinon, St inat . l'er
quest'ultimo. ammissibile anche S t i ? ~ = S!C/CLIIO, accolto nella toponomastica ufficiale (S. Stino d i Li- venza). I1 composto Boneguzio (friolono) prohabil- mente eqiiivale a Bon Bgust. yus = Buonagostino.
I l lonibardo Agostbo mi pare di origiiic berganinsc:~ o bresciana (9gosfi . -si i) .
Agricola. È l 'equivalente latino di Cheorghios. In Francia è venerato col nome di Saint S r t ~ l e o
S . Arille un vescovo d i Chilons-sur-Saune, del V secolo. In I ta l ia S. Agricola, niartire con S. Vitale 3, Bologiin sotto Diocleziano, 4 novenibre. In Friuli Sas Crical i: il patrono dei contadini c h e rii.ono sul proprio.
Cogli. Grigoletti, Grigolon (non k d a escludere Gre- gorio). I n Agricola (nobiltà recente) il Poiiia ravvisa 13 traduzione del tedesco Ackermann, o Bauer; ciò è vero pe r i vari Agricola tedeschi (vedi i dizionari biografici) ina non per il cognome friulano.
-
Agrippa, .igrippino, Agrippina.
Cognome roniano. Significa n na to coi piedi iniianzi n. Un C. Agrippino vescovo di Como. 60i-015, l i
giugno; S. :igrippina, inartire so t to Valeriaiio, pa- t rona di l l i n e ~ . Il norne t. usato in Sicilia.
Forse i cogn. loiiibarili Grippa, Crippa, Gritfini.
;Liear
-
I' n uv3 salamauua D; m a potrebbe anclie essere = Soli- mano. Non mancano esempi d i nomi arabi, e per- fino turchi, accolti nell 'ouomastica italiaun. Jfa è d s escludere il sardo 3laniio (mannu = graude) sebbene non so qiiale erudito tedesco, dedicando u n suo libro allo storico Antonio >Ianuo, almanacchi 8 ~ 1 1 , Tuistonem deum e t filium RIannum n di cui parla Tacit,o.
.ilbano.
Protornartire in Inghilterra, 286. 22 giugno Conti. Blbani. In Baiielli concorre G r h ~ i ~ i o .
Alberico, Alberigo.
Dal germsriico dlbiricli (= clie conianda ucgli Elii. od Albi). S. Alberico, venerato in Toscana, 29 agosto. I n I ta l ia subì varie trasforriiazioni.
Cogn. Albricci. Albrighi, Albrizzi, -zio, :ilbergati, Albcrghetti, Alborghetti ( u n Ser Alberghettino de' 3lau- fredi in Sacchetti , iiovella C C I I ) e forse anche Uor. ghelli, Borghctti, Borgat ta , -gatti.
Da1 francese duhry , Abrile. Alhrile cogu. piemontesi. In Brizi, .zzi e nei friirlani Llriz- Vriz concorre curi
Bri:io e E'ah~i t io . e forse ron Briqidn iu Brisiotto.
Albero, -one. Vedi Adalbero.
Alherto. Vedi Adalberto.
Dal latino albus = bianco. l lo l t i cognomi di origine evidente, in t u t t a Italia:
Alhiui. Bin, Bini, -net to , -notti .nutt i . >fa in Pie- monte Biuelli Gemelli.
-
Xome del primo re longobardo in Italia. lilbwiiii = amico degli Albi, od Elfi.
Xou f u mai popolare, sebbcnc sia iiorno di uii Santo r r s c o r o di Bressaiione, iii. 1015, 5 febbraio. Usato dagli Scnligcri.
'3. d . 1. Pralhoino (Brescia).
È probabile che in molti casi sia u n a abbrex-iazione di nonii colla desinenza -uld, iiia può anclie essere oli vero nome; Aldo~ie ( a b l a t i ~ o ) i n Paolo Diacono, .Ililo>iis (geii i t iro) iii docuiii. Riati, i 4 4 . Dirriiiiutivi ;Il
-
N O M I E COGNOXI l 5
d i Alba. B. Alerino Rambaldi, vescovo di Alba. m. 1456, 21 luglio.
Alessandro.
I n greco, sa lvatore di uomini. Xoinc di molti Saliti. S. .4lessandro, martire, 26 agosto. S. Alessandro l , papa, 3 maggio.
I cognomi che d i qui derivano sono quasi tu t t i d i etimologia evidente (Alessandri, Sandri, -ni. -droii, -ni, -ucci, eco.). D a notare in Piemonte Assandro, Asssn- dria, Sciandra (Alexnndra, Parnpareto.>londovi); ilella Venezia Zandrini, Zendrini e forse Gianderini. I1 mii- tariiento x, I, g & u o r m ~ l c .
Alessio.
I n greco, protettore, difensore Cogn. Alessi, Alessio, Lessi. Topon. Alesso! (Udine) .
I n greco, bianco. S. martiro a Léntini, sotto Decio. 10 inaggio. I l nome è frequente in Sicilia.
: ldalfe~ius. È il Santo fondatore del monastero d i Cava de' Tirreni, sec. X-SI, 12 aprile. D a athnl, adal = nobile, e jura, fera = stirpe, gruppo di f~rriiglie. All'Alfieri piacque derivare il suo cognome dal latiuo aquilifer; etimologia assurda, che tu t t av ia f u accet- t a t a , pe r comodi t i poetica, dal Carducci, e d anche da l Pét in (
-
Varianti Adal, Iclel, Ildefonso; radici germaniche alhal, adal ( = nobile) e juns, fus ( = p r o n t o , volente- roso). I n Italia, il San to più venerato è S. Blfonso de' Liguori, m. 1787, 2 agosto.
Prevale nei cognomi italiani la forma proreuzale Anfos.
Ciogu. Anfossi, -sso (piemontesi-lig.), Xaf6s ( f r iu- lani). Forse Fossarelli, Fossati.
Alfredo.
Radici germaniche alhal, adal = nobilc, oppure alt. nld = vecchio e jridu, vriede, friede (pace, sicii- rezza. ecc.). S. Alfredo, vescovo di Hildesheim. m. 869. l 5 set tembre.
Sella. formazione d i cognomi concorre con altri nonii della stessa desinenza. (Goflredo, Sigifredo, Pnl- /vedo); non c'è nessun cognome che possa derivare aiciirninente d i qui.
S e l l a toponomastica, Vicolo del I.'rediio (d'Alfredo. a Udine), Villa Fredda, ibid., che, in cuntraddizione col nome, & in situazione aprica. Xegli Annali di u'dine. 16 giugno 1355, è menzionata u n a via
-
Sarebbe, secoudo il Fumagalli , il femniinile d i Ileaaio. 313 nell'agiografia non esiste che una B. Aliz, belga. m. circa il 1300, di cu i il noiiie latino è .4delriis: I I giugno.
Credo clie il iioinc, nella sua forma i1,aliaun. d ~ r i v i d a qualche rouianzo.
S o n credo clie il le t tore ignori clie un ramo degli Elisei prese questo cognome d a Aldigliiera moglie
-
I+P~I I~M~~I : IJ . I I ~ ~ I I ~ ~ I ~ I ~ ~ , 418 11141 m. ln1i11~ t a t t t # ~ ; ~ 1. ~II H F C I . i l i l i+n. ~"~III 4-ziiitiia. Sr-lln irtai.iinda fntina. i i i~l I3njar1lti i. Il iiriiiir. dtel c.n\.alir~ti* iii:dnir iii .%npr;iiiiiii~ri: ~ l r Drlnnilri r . 1 1 ~ ai. rrib apliiriprili i'i:lmv.
r'oqii, .\liiirrinri, ~ l ~ r n i i b i l i CtJin ri*titlnrlr r . rnc.ridiir. na l(=), ~llj~tit~ntim ~ l i ~ u r u ) , Almfindth tpitr~~oi~tena-).
"Tiilirin. l.iiiinntn? ((:oiiiri).
-4 mahilc. ì'sriaiii i: .l ircnhili*. Suiiir fttnriiiiiilu t uttrirn IrprlurnPb in Pt1911. iiia I i i
altri ttnifii difliino in It,alin fid In F t a i i ¢ i ~ . iS"ogm. friulari Bi l l i~, Ililllanl: pianinntewi Bilriila,
IjlulLI; irrnccni J ta l~ i l , Slabillr, 3I~billon. I l gitnion. tcwi: Eiyliu rllicllu, lSfindfi\~l) ~iiib analie d c r i v h r ~ d& un wilbraIiiiuinc I* rorund. yitli eoine na bkju).
Ratliri gi:rinaiiiche iimcil. uml iipnrrinu, dilig~tiiili.. ilrinrli: il iiiirriv di:1I* dinbisti. nrrticii di.gli hriiati) I: h e h ~ f . bed, ptrt 1 = nli!endidtt i l l i ~ ~ t r ~ j .
I.'ogn. ..t rri mlhcrti, Ual>c:rtI; Ironiwir: ,Uuulirrf. t i 1 .q. ~ l l u ? , l # ~ ~ ~ t . I l ~ l t ~ ~ ~ ~ , ~ r i ~ ~ W!V, x 11 \1n ~ l l l i l ~ & klnlarwd.
Raitir:it a m d , nm!, v~:ili wqJra, ~ I W W i a:nglt. h l u ~ l l t ~ . blagliim~~. J1a lwr !dn~iiut~k fa. #l, l . 5l*liano, 1I1h- jsnii. r:ci:.) nii pari! chi: winuo plii prrih*liiIi altre aqi- irinlogie.
-
Amato. Etiiiiolngia evidente. San to patrnno di Saluderio
(Riniiiii), S niaggio; altro, vesco\.o e patrono di Xuaco ( ; \ ~ < . l ~ i n o ) . ni. 1003; 31 agosto.
Sn inc ahbaatsnza f requente . Cogw. Ainati. :iiiintiic
-
gobardi, nel 774. Ma di questa battaglia non c'è alciin documento storico. L a a Chanson n (edi ta d a Konrail Hof fman - Erlangen. 1882) li f a morire, iiia di morle naturale , a l l o r t a r a (~ l lo r t i e r en Lonibardie), dove erano di passaggio per siidare a l Snuto Sepolcri>.
Coqn. liguri-pieiiiontesi Arrielio, i r i .\iiieglio. D'hrnelio, .glio, Daiiierini (rt:nt:tu). D a .~I~iiilés. cov>ionie lonibarlilesi.
.imerico, Erncrico. Radici gerinaniche heim. rich = potente in patria. Cogn. aleriglii, -ggi, JIorigi, Aloriggia (concorre
Jlaurizio). Dal francese dimery il piemontese Aimerito.
.imieo. D a l poeina o roinaiizo :IIIL~CU ed rlrr~elio (vedi). .\la
può anclie essere indipendente d a qiiesta etimologia, apecialniente iiiil composto Biioriaiiiicu.
.imilearc!. D a .lfelk. knrth = il re della c i t t i , lino degli rp i te t i
del dio feiiicio I3aal. e neii'oiloiiiastica 113 t rovato posto Annibale, ci può s tare ani:he suo padre. .\la nei document i raccolti da l Troya c'k il testamento di iin longobardo Amolcari, 700.
:l>nechis in dociiiiiento Farfense, 7 0 4 . .litti;o iii ilii- cumento di Sniita Maria i11 Cairat,e. 7 4 2 .
Si t r o v i in a l t r i docuineiisi ~>icrnontrs i . loiiil>arili. veneti . Etiinologia incerta. Co~ifuso coi derivati d a u ariiico in? I n ta l caso, il sigriifii:;rto sarebbe uguale a1 cognome piemontese 11niiot.j. (4lundovi).
Cogn. Amisani, Jl isani ( lombardo) , Jlisiano. È d a tener presente la frequenza dei cogn. sopraci-
-
N O M I E COGNOMI 2 1
Lati in l.oinharilia, e specialmente nel territorio dove si aviluppb In leggenda di -4rni.s et -41niles.
L'agiografia registra due Sant i di questo uonie, l'uno patrono di Burdigbera, V secolo. 4 ottobre; l 'altro veacovo di .)lilano. eecolo 1'11, 8 febbraio.
Cogn. iiizzardi Pegiion, P
-
In greco noricritalen o nativo clcll':\sin Il inore (Anatol ia) . Poco usato in Italia.
Cogr~. niericlionale Satoli . .\In il fritilano Satnliiii. Nadalini i: d a iVal(i1r.
Ancilla.
T u t t o r a in uso in Friuli, aiiclie f a t to maucliilc (11ii- cillo). P u ò addursi come etirno possibile di alcuni co- gnomi bisillabi, ma in concorrenza con Angelo, Egidio (Gillio), ;\larcello, ecc:.
Andrea.
In greco = fortezza. Dei molti Sant,i. il più vene. r a to i: I'Apostolo, 30 noveinbre.
.\lolt'i cognonii di etiniologia evidente. In Friuli Dreun, Dreossi, Dreosti (vedi eseiiipio analogo sot to Bernnrdo). I n Driolino, Driulino, Driussi coiicorrtr Dri = Feclcrico, Enricci, ectc. (vedi a sii,, luogo).
C o g n . pi
-
Ho t rova to a Torino Angeloro. m a non ne conosco l a patria. Residuo d i genit ivo plurale, come al t r i co- gnomi colla stessa desinenza. Dalle l i t a n i e della Ver- gine: Regina Angelorun~. Anzilotti p u b anche deri- vare d a Laneilotto.
È la fornia toscana del germanico Angil-Engelhard, nome nel quale vennero a d incontrarsi Ingwi (dio gerinanico) e d Engel = Angelo.
I n Fr iul i e nel Trent ino cogn. Englaro (anche n. d. I.). I n a l t re pa r t i d 'I tal ia Angioleri, Angeleri, Anghileri, Inghileri. Ghilardi. Gilardi, -dini, -doni. ecc.
In cbraico i< benefica i). È anche nonie fenicio. che coincide casualmente col nome romano A n n a Perenna, la Dea dell'aiino. S o n i e frequente. Delle varie Sante, 13 più venerata i. 5 . Anna. niadre di Naria, 26 luglio.
I'ogn. Danna. (piemontesi.) Deana, Diana (friulano).
Sorric fiiiiicio, d i sigiiiticato analogo agli ebraici G'iot.nn>~i ed Anania.
I l 1,eopardi (Piiralipomeni I ) riprcnde il malvezzo dei iioriii
-
24 A. BONGIOANNI
en t ra to nell'onomastica romana (Anoibaliano figlio di Costantino) ed h a posto anche nell'agiografia.
Dopo Annibale, per analogia, acquistarono diri t to di cit tadinanza Amilcare ed Asdrubale.
dnnnnziata. Vedi illaria.
Germanico Anaowald, Osewalt, Oswald = polente in Dio.
Cogn. Ansaldo, -di (pieinontesi-Ligiiri) e per assimila- zione Assauto (piemontese) e col f requente mutamcnro lotubardo a = o Saldi, Saldini, Soldi, -dini (loiiihardi).
Anseario. Gerinanico Ansgar, Oskur = siiiiilc a Dio. k lo
stesso che Oscar, nome derivato dai poemi di O i ~ i a n , o più probabilmente, dal Ballo iri n i is~: l iera n del Verdi.
S. Anscario A l'apostoli> della Scandinavia (so- colo VIII-1s).
Sel12nnti
-
NOMI E COGNOMI 25
rati i n Italia: S. Anselino di Aosta. 21 aprile; S. An- aelmo d i Nonantola, 3 marzo: S. Anaelmo d i Lucca. l 8 marzo.
Oltre a i cognomi di etimologia er idente , Selmi- Solmi (lombardi), Ansermin (.4osta), Selmini, Ser- mini (toscano).
Gerrnnnico .Iliropehrl = illustre in Dio. C'ogn. Asperti, Sperti, -tini. Spirt (cndoriiio),
.liisx~ci-Lus in (locumenti Lucca 7 i " D a n ~ i s = Dio, e iwnrt = t . (la i ~ r r s i , rioriie (li J i r i - nit'i e ioin = aniico. S . Anseviiio od :inzuvino. r e - SCO\ ' f l di Cnineriiio, si:colo I S .
Ccytl. Aosiiini. Aiisuinelli. ~ \nzoi . in i , :\iizuirii. I\risr. vini (1t;rlia ceii tralt) ; Sor ini , Siirini (loiiibardi): Suiuo (pit.ni
-
Il mitico foiidatore di Padova. scampato d a Troia prima d i Enea.
Dal greco anli = coiitro. ed ani?' = uonio; coliii che s t a contro l'uomo. oseia il combattente.
Gogn. Antinori (Jlarclie).
Greco; il Fumagalli lo interpreta ,
-
N O M I E C O G N O M I 27
Tonot. -gnot, - n u t , -nu t t i . -iiis, .nissi, -nizz. -nizzo. abb iamo i cognonii Gnot , Not, Nus. N u t , Nizz.
U n caso singolare B quello del cognome Tonegutti , der ivato d a Toni per analogia con Meni, .JIenego. Passato d a l Friuli nel Trentino. d ivenne Tunicott i . ed in qualche paese bilingue, forse con inteiiziorie scherzevole o schernevole, fu t rasformato in Thu . nichtagut (buono a niilla). >la la famiglia, prohabil- niente d i uniile origine, sali nella scala sociale fino a dare nii ministro a Maria Teresa. l a quale si degni, d i concedere la modificazione del cognome in Thugu t , che forse esiste ancora in Austria.
Dalla stessa deforinazione i cogn. Tonegliini. To- nacliini ( t rova t i a Torino, m a cer tamente non piemon- tesi).
Significa n sacro a d Apollo u. Prirno vescovo di R a - venna e mart i re so t to Vespasiano; 23 luglio. Popolnre a Ravenna ( S a n Pul inkra; anche in novellieri toscani San Pollinare o Poll inari) .
Cogn. Pollonera (Alessandria). Dubb i Pollinari (perchk pollinaro d a i trecentist i i: anche usato per polla~uolo). Alinari, Linari (anrlie n . d. 1. presso Fi. r1.11zt.). Laiiari.
S o i n e di dodici Sant i , ciascuno dei quali. per r a - gioni storiche, 1in culto in qualclie luogo. A Ronia A.. ~ i inr t i re so t to Comiriodo, I 8 aprile; a Iìrescin A , , ve- 6ror0 e confessore, so t to Adriano, 7 Luglio. S a n t a Apol. loiiia o d Apollina. mar t i re , Alessandria 249, O fehhrai i~ .
Etimologia analoga a d ;l./~ollinare. C'ugn. Polonia, .nio (friulani). Ala Poloni. in ter ra
veneta, è dubbio, potendo anche essere: Pauloni.
-
Non frequente, m a pure usato. Xon essendo nome d i Santo, lo si pub considerare come equivalente a Paolo (l'Apostolo dello gent i ) , od a Giovanni (talora d e t t o N I 'z~postolo », per distinguerlo dal Bat t is ta) .
Coqn. Apostoli.
. iq~~i l ino. Et,iniologia evidente. A 3lilano C popolare S. Aqui-
lino, martire, V I secolo. patrono della corporazione dei faecliini, 20 gennaio. È nome di a l t r i cinque Santi.
P u ò competere con ~icli i l le nel eogn. Achilliui.
Arcamhaldo, -cimbaldo, Arconovaldo~ Ri- conovaldo.
C;crniauico Ercamberahl. Ercharlu.n?d. ~ l i . rn>~l>aId , cfr . il franceae Srchambaul. Radici ercan = itirjeriu~~s e. ii.
-
N O M I E COGNO31I 20
nianno, condottiero a l soldo di Firenze, secolo S I V ( H a ~ i m a n n ) . Un S. Hartemannus, vescovo d i Bressa- norie, secolo S I I , 7 luglio.
Cogn. Ardemagni, Ardemani, Ardimenti, e d in con- correnza con .4r,nando (Hermann) , ririnani, Armanino.
,Irdengo, .\rdingo. 'ioii s i trova, ch'io sappia, nell'onoinastica loii-
gobarda; probabilmente i: u n patroiiiinico franco. d3. hardu. hart = duro, for te . Xome ancora in uso in Toscana, e d in qualche famiglia nobile pieinoiilcst..
Coyn. Ardeuglii. Ardinglii, Ardinghelli.
Gcrnianico FIirrd~uin. d a hnrt = forte. e wiri = amico. I l Fumagalli registra un Arduino, arciveai:oi~o di Torino (1188-1206). E r a della famiglia arduinica dei Conti d i Valperga; nessun autore lo pone t r a i Santi. C'& un S. Arduino, di Riiuini, secolo S I . 15 agosto.
Oltre a i cognomi di etiniologia evidente, i loiiibardi Duiiia, Duviiia ( in concorrenza con Balduino.
-
Arichi. C:erinanico IIaregis, Harigis, Harichis; radici Iinri,
heri, her = esercito. C'ogri. Arici (Brescia), .4rigo (Creiiiona), Arizio (pi r -
montese), donde il n. d. 1. Viarigi (Vicus 1lrigi.9). In Fr iul i e Cadore Arecco, Recli; 11. d. L. la Ricliiri!-elda (presso Spilimbergo), Recco?
Dal la forina Aregis probabilmente il cogiioine pie- trioutese Regis. f requente a ~ I o n t a l d o AIondovi.
,Se noli i: una var iante di ALIIONDO. ALI\IOXDO, si può in te rp r i t a r r : hari = esercito, e mund = difesa, protezione. Arin~odus in documento Rieti, 764.
Cogn. picmontesc-ligure Arimondi.
Ariodante. S o m e ariostesco. noil raro iiell'ltalia centrale. .\la
che derivi dal grcco .4res ( J l s r t e ) coine propone il Fumagalli , nii pare da escludere, nè saprei trovare :in& etimologia soddisfacente ni- nell'onomastica ger. manica. nè nella francese del medio evo.
Aristide. Greco; equivale a d ottimo. È nome d i un Santo ate.
nieae del I1 secolo, 31 agosto.
Radici a r n = aquila, e walt = potenza, doininio. S. Arnaldo d a Padova. 10 febbraio.
Cogn. Arnaldi, Arnoldi ( lombardi) ; Arnaudi, -do. Arneodo, Arneudo, Arnò, Arnone (pieniontesi); Xaldi.
-
NO311 E COGNOJII 3 1
-dini, -doni, Soldi , -dini (in concorrenza con Rinaldo, Jlonaldo, ecc).
Da1 longobardo ilrnoald (docum. Benevento, i69) -4rniwald. col mutamento W = b ed a = o, cogn. loin- bardo Ariiaboldi.
Radici gernianiche a r , a r n = aquila, e wul/ = lupo, guerriero. Nome frequente nel medio evo in Toscana.
Cogn. Arnolfi, -fini, Nolfi, Xolfini ( toscani) ; Arnulfi (piemontese).
In greco, maschio, virile. S. Arsenio anacoreta in Egitto, 1x1. 349, 19 luglio. Nome non infrequente in Francia, m a raro in Italia.
Forse il cugriome Seno, frequente a d Ormea (Cuneo).
Germanico Hartwig; radici hart = duro, forte, (francese hardi) e wig = lo t t a , battaglia. F o r m e latine Harticus, Artuicus, Articus, Articius, A ~ d i c i u s . -
Xoine ancora in uso i n famiglie nobili friulane, m a erroneamente pronunziato Artico. Sopravvive come cognome, anche fuor i del FriUli (Venezia. Trieste).
S. Artico (Hartwig, Artuicus) vescovo di Snlisburgo, m. 1023, 14 giugno.
I n Lombardia Brdigo (Ardig6 = Ardigolo), Alti- cozzi, Tico (anche i n Carnia), Ticozzi, -ssi, Tigozzi, Ticci, m i , -zzoni. I n Piemonte Arditi, Tardi t i ( = d 'Ar- dito), Ardizzo, A r d i ~ e o , -mino, -sone, Ardrizzo, t u t t i appar tenent i in prevalenza al territorio di Alba. P e r contrazione, Archetti (Brescia), Arcozzi (Verona); Tarchet t i ( = D'Archetto, Alessandria). I n Toscana Arcioni, Targioni ( = D'Ardigione). Nel milanese Ar-
-
cbint i propenderei a vedere un patronimieo Arlichingus. Artichindus. Fiesso d'Artico è
-
NOMI E COGNO>II 33
(Mondavi) e cognomi: Cagni. -gno, Scagnetto. Dubbia l'etimologia di Cagnacci, -zzi, Cagnetta, Cagnoni. I l nome del fedele amico dcll'uonio i: con nianifesta ingiustizia adoperato in senso spregiativo; m a nel- l 'onomastica medioevale ci sono soprannomi anche piu oltraggiosi, d ivenut i cognomi.
Asquino. Radici germaniche ask = faggio. e per traslato,
lancia, e w i n = amico. In dociirnenti friulani Ascwinws, Asc
-
34 A. BONGIOANNI
Atto, Azzo, .4zone, Azzone.
Sono varie forme dello stesso nome germanico, che non ha nulla a che fare col latino dt tus , Appius .
Un Atto duca di Spoleto in Paolo Diacono. Ato io docum. Prata 764. Azo in docum. Verona 745. Questo ultimo secondo il Weber sarebbe un vezzeggiativo d a ddalberto. Comunque sia, credo non ammissibile l'etimologia di Azzo d a Galeazzo (Fumagalli). C'h anche in Paolo Diacono un Bdo, duca del Friuli. Per questo, il Weber propone hadu = guerra, battaglia; per gli altri, I'etimo sarebbe alha, atta = padre. È evidente che in questi nomi, come spesso avviene nei disillabi, concorrono varie etimologie, ugualmente accettabili; ma nell'uso, è facile che aia avvenuta una mescolanza, quando, pure mantenendosi nell'uso i * nomi germanici, si era perduta la nozione del loro significato.
Coyn. Adone, -ni, Atti, Azzi. Azzoni.
Atripaldo.
Da atar = celere, sagace, e pald, bald = ardito. I l Tribaldello di Dante (Inlerno, XXII, 122!, citato dal Poma, in alcune lezioni è Tibaldello, Tebaldello.
Coyn. Trihaldelli, Tribaudino, Trabaldo, Trabalza, Trabaudi (piemontesi); Triboldi (lombardo, dal quale. forse, Tribolati).
Toponomastioa: Atripalda (anche I'Alripalda, la Tripalda) .
Derivato dal latino Attus, Appius , probabilmente equivalente ad avus.
Nome divenuto frequente nel periodo del Risorgi- mento, in memoria dei fratelli Bandiera. In molte
-
N O M I E COGNOMI 35
famiglie, se d i due fratelli uno ai chiama Attilio, l'altro è Emilio.
.iugusto. Significa CC consacrato u. Ma talora si d à questo nome
ai nati nel mese di agosto. Ci sono due Santi di questo nome,di e t à incerta. uno dei quali venerato in Cam- pania, 10 settembre, ed una Sant'Augusta nella dio- ceei di Treviso, 7 marzo.
Aurelio, -a. Dalla stessa radice a n a n a di aurum, aurorn =
splendente. 27 luglio, 9 novembre, 25 settembre. C o g n . Oreglia. -riglia (1ombardi.piemontesi); Orelli
(ticineae).
duribonus in documenti Lucca 769. Secondo il Weber non è latino che in apparenza, e sarebbe il longobardo * A u ~ i b a n o , d a òr , aur = saetta, e bano =uccisore.
C o g n . lonibardi Oroboni, Riboni.
Gernianici duthari , Othere; radici aud = stirpe, pa- trimonio e hari, here = esercito.
Forme latine d u l a r i , dutaricus, -riciua, rilus. C o g n . Taricco, Tarizzo, Tarozzi (piemontesi); Tarelli.
Taroni, Teruzzi (lombardi); Trauzzi (emiliano); Odero, Dodero (liguri); Auteri (siciliano); Otero (spagnuolo).
I n qualche caso, ammissibile la concorrenza di Waller (vedi Gudl ie r i ) .
Avanzo, -zato. Di a avanzo ii nel senso di a guadagno, profitto o non
mancano esempi nei classici. Così in piemontese, per
-
36 A . B O K C I O A N N I
lo più i n aenao ironico, n a l'a iait Un bel awana (gua- dagno).
È dunque uno dei t an t i nomi di huori augurio usati nel Medio evo.
Cogn. Avanzato (Sicilia); Darnnza t i (Firenze); D'Avanzo (Carii i ;~); Vauzo, Vanzati), -zetti. -ziiii. Danzat t i ( r ene t i ) ; Avanzini (toscaiio); Arancini ( t r e n - t ino) e forse (niutuinento u = b = p ) Paucini, Panzini.
Averamo. D a questo nome (germauico) deriva cnrtameiite il
cogn. liguro Averame. Probabilmente d a nber, eber = cingliiale (Vcdi i due nomi segueriti) e 1iraba?i, hrani = corvo.
.iverrrdo? Berardo. I1 prinio toscano. il sccondo lonihardn. C d a ta luno
falsanicntc srainbiatu cori fiernnrdo. k il germanico Ebcrharl = for te come 1111 cingliiala.
L:ogn. pieniiiiitesi i ihrardi, Berardi. -do, Ueraiidi. -do, Peraldo. Peraudo, Pi!rodo (francese Perraiilt). Pera- d o ~ t o ; 1orrtb;rrdi Avcroldi, Baraldi, Varalrli, lni.t:~ rardi, Varardi. Veraldi.
In 1,'rancia E r r a r d . Erurd, e forse il proreiizale Barral . divenuti in Pienioiite Barale, Varale.
1,ongobanii il barolf, A urrolf. :l r:, .rol/?i iii ~loeuiiicriL
-
N O M I E COGNOMI 37
Baccio. Secondo il Fanfani, B Uartolomeaccio; di siffatte con-
trazioni ci sono altri esempi, in Toscana ed altrove. Ma pub derivare ariche d a a l t r i nonii, ad esempio, d a Zanobi.
C'ogn. Uscci, Baccelli, Bacciiii, in Lombardia Bazzi, Bazzini, -zzorii. Composto con buono, Bonibacci.
Bajamonte. Vedi Boemondo.
Balho, Balhino. D:rl latino bulbus = I>slbuziente. S . Balhina, vergine
e rnartire. Roma. secolo S I I , 31 marzo. Nei eogriunii che ne e r i a n o spesso arvicric il
mutamento 1 = r. Così Balbo, Barbo, Barhi, Balbini, Barbini, Balbiani. Barbiani, ed inoltrt: Barbet t i , Barboni. Barbotti , ecc. .\la iii alcuni puit ro~ icor re re I
-
Baldo. D a Rambaldo, Trobaldo, Ubaldo, ecr.. r d in Friuli
anche d a Baldassare. Cogn. d i etimol. evidente Baldi. -delli, -dini, .doni,
-dueci, ecc.
Baldovino. Germanico, d a bal = ardito. e w i n = amico. com-
pagno. S. Baldovino (Baudoin) di Laon, rri. 677 e venerato come martire. 8 gennaio.
Cogn. Baldovini, Balduiui. In Piemonte. dalla forma francese, Bodoano.
Barbara. Equivale a u straniera i,. S. Barbara. m. 235, 4 di-
cembre. Fa t t o maschile, divenne cognome illustre a Venezia,
e frequentiasimo in t u t t o il Dominio Veneto. In Friuti cogn. BarbarBs, Barbarét, Baritussio (*Oarbarit, barit. bariltis); Barbui (può essere anche una var iar~te d i bnrbrjl = balbuziente). Nell'Italia Centrale Barberiui. in Lombardia Barborini, -buriui. Burini, Burrini, Barbiellini. I n Liguria Birboro, Sbarbaro. IIolto pro- babilmente sono da riferire a questo etimo i piemon- tesi Barel, -Ili, Baretti ed i romaguoli Barotti , .rocci. -rossi, ruzzi. Aggiungerei i piemontesi Berini, Berrini, Berutti , -to, Berruti, - to, Brut to (quest'ultimo esiste a Torino).
Bardo. Secondo i l Fumagalli, d a Berardo o Uernnrdo; ma
hanno uguale probabilità altri nomi germanici. quali Isimbardo, Gabardo, ecc., e non è escluso il muta- mento 1 = r.
Cogn. d i etimologia evidente Bardi, -delli, -dellini. In Frifili Bardua, Barduz, Bardusco.
-
N O M I E COGNOMI 39 -
Toponomastica: Bar, Bard, Bardassano (Torino). Bardi (Piacenza). Bardino, Bardineto (Genova).
Barisone. Nome d i etimologia incerta; forse d a Pdrisl Quattro
giudici i n Sardegna sotto il dorninio pisano. Cogn. Barison (famiglia nobile a Padova), Barisani
(Casteifranco, Modena), Bariselli (Parma, Padova, Venezia), Barizano, -zanelii (Venezia), Barisonzo (anche n . d . 1 . Tortona). Varianti: Beiisonzo, Bellisonzo, e forse Bellisomi, pel quale è ammissibile l'etimologia: beilus homo.
Nel Vicentino, ed altrove, esiste il cogn. Parise. -si. X . d. 1. Varigione (Lecco).
Barnaba. Vuol dire
-
40 A. BONGIOANNI
por ta t i dagli invasori, e var iamente latinizzati, si afiaccia qualche nome latino, o d i fo rma in cui gih si sente il volgare. >la questo è cer tamente di e t imo germanico: baro, bnronis.
Ai cognomi Baronci, -celli, -cini, il Fle ihia aggiunge Bonci, Boniett i , Boncioni; m a questi possono deri- vare anche d a Bonizo.
Bartolomeo.
Equivale a I figlio d i Tolomeo in, nome che a &un volta significa u valoroso n. Apostolu e martire 47, 24-25 agosto.
Quasi dappfr t i i t to la fornia popolare i J l c o , iiia in Pienioiite,
-
N O M I E COGNOMI 4 1
il cognome Tarainelli), Talamonc, Talamona, ed il cognome napoletano TAlamo. per il quale si potrebbe arriechiare l'ipotesi di u n a regressione d'accento, conie in Caterina, Cat.era. Cate.
Baruch.
In ebraico equivale a Benedetto. Ala che il cognome i ì ~ u c l i , f requente nel l o 1 1 1 o i derivi d a rluesto noine. nii pa re poco probabile. L a coesistenza di
IÌaracco ii i i e l l ~ stcsaa regione. iiii iniluce a classifi- carlo sot to iìnrb~ca , il Trggbiaio ,n, ecc.; m a cc Fa r ina ta . i: rciiiprr iisato 6enz;i. articolo). %ella Cronica di 1)iiio Conipagrii . i l Ba,cr.tiicra de' Tosiriglii n . etl iii i i i i :~ piarica di Firrrizr: del -i.r:olo X I i I . r ipor ta ta ilal l)avi(lsoliii. l a . P o r t a del Uu.icliiera n, verso il .\liigiioii
-
42 A. BONGIOASNI
come in alcune parlate monferrine, l'articolo è T U . va. Per il siciliano Biscari è forse possibile qualche altra etimologia. Possono riferirsi a Bnschiera anche i cogn. piemontesi Boscaro, Boschiero. , .
Basilio. Dal greco basileus = re. S. Basilio vesc., IV secolo,
14 giugrio. Cogi~. veneti Baseggio, Beggio, Beggiato; siciliano
Basile; friulaiio Baselli; in Sello, Sili. Silli, Sillio, Sil. lani (FriGii ed Umbria) concorrono ,\la~b'ili~ e Cecilio (vedi).
Toponimi: Basaluzzo (Alessandria), Basiglio (Mi- lano), hiotnbasiglio (3londovi). Molti i derivati da baeilica. Recentemente, il comune d i Pasian Schia- vonesco (Udine) mutò il suo nome in Basiliano; mu- tamento non arbitrario, percbè nei documenti. dal 1 0 i 2 a l 1268, il noine è sempre Basilianum, Basdianum. Basaglianum, Vasilianum, e soltanto più tardi pre- valgono Paselia?~um, Pasianum.
Si t rova anche il nome Duo Brasilice. clic ioiiiprende Basiliano e la frazione d i Basagliaperita (basilica picta).
Bassano, o meglio Bassiano. Dal nome Bassus, di significato evidente. S. Bassiano. n. in Sicilia, vescovo e patrono di Lodi.
m. 413. 19 gennaio. Il nome è quasi sconosciuto fuori della sua diocesi. Bassani è anche cogn. israelitico. nia in tal caso
deriva dalla cit tà d i Bassnno.
Battista. In greco battezzatore n. Coll'Evangelista, è il più
venerato t r a i molti Santi d i nome Giovanni. 24 giugno. Norne divulgatiseinio, e niirabilmente prolifico. spe.
-
NOMI E COGNOAII 43
cialmente in Friuli, dove abbiamo: Battistella. Bat- tistel, Stella, Stel, Stelin, Steliini, Tel, Tell, Tellini, Bat- tistot, Tot , Totis (in documenti Tothisus), Battistutta, Battistut. Tu t , Tut t i , Battistat , Ta t , Tatti . Titolo (Titul) s t a d a s&, ma in altre parti d'Italia gli corrispon- dono Ti t ta , Tittoni, Tettoni. Per Tell, -]lini ammissibile anclie Pontel. Puntel, i n Carnia = Pantaleone.
Baudolino o Baudelino. S o m e usato unicamente nella diocesi d i Alessandria. Anacoreta e confessore, VII-VI11 sec., nativo d i
Villa del Foro, oggi sobborgo di Alessandria. 10 nov. Forse equivale a Baldovino.
Beatrice. I1 iiome, dal latino Reatriz, era g i i i n uso prima
che Dan t e gli desse celebrith. B. Beatrice d'Este, 19 gennaio.
Da1 vezzeggiativo Bice. cognome Bicetti (lombardo).
Belitruda, Beltruda. Nome longobardo, d a pil. bil = difesa, protezione,
e trut = fedele. Piltruda in documento d i fondazione dei inoiiasteri di Sant.3 Maria iri Cesto e Santa Maria in Salto (Friuli) , 769.
C:ogn. Belletrutti, Ueltrutti (.\Iondovi).
Bene. Talora è abbreviazione di Benedetto (Sennuccio del
Bene), nou senza influenza del germnniro Beno. Benno. Ma piu spesso i: il primo elemento nella colo- posizione d i quei nomi esprimenti buon augurio, che nel medio evo ricorrono frequenti, specialniente in Toscana, e nell'uso famigliare subirono forti contra- zioni. Così d a Beocivenisti, Cisti (il fornaio della nota
-
novella del Boccaccia), d a Bcncivenni, Cenni, Cen- nini, e fuori di Toscana (documenti bolognesi) Benze. ueninus dictus Zei;eni.nus, donde i cognonii Ce-. Zevl:. nini, Civinini. Da Beiicirenga, Benci, Henga, Benghi, Cenga, Cenglii. È singolare Beneduce ( = bene adduci?] nel quale forse i: d a ravvisare u n a reminiscenza di4 i buon re hleliadus n donde il cogn. veneto Duse.
Altri nomi e cognomi di analogrf etimologia sono: Benivieni, Urnnati , (veneto Bennassu e Benascdo), S a t i , Xatini, Nattini; Ilcntivegna (cogn. piemontese Tovegui? ) , Bentirnglio, Ilciiti, Ueiitini, Ben\.eriuti, Xuti , Xutini ( t o ~ c a i i i ) , Gnudi (? ) . I i i Friuli Vciiiili. Venuta , Vigiiud, Vignut, Giiut, Vf!giiiiliiz. Per inver- sione. Vegnab i :~~ ( ~ l o i i ~ l u r i ) . Si s r o v i iiell'onomast~ica toscana anche P
-
N O M I E COGNOMI 45
Benirmino.
I n ebraico, figlio della mano destra, o prediletto. Poco usabo dai CattoLici, frequente t r a gli I~ rae i i t i .
C o g n . toscano Begrianiini (Firerize, secolo S I I I ) e d a Z(enj
-
Berengario, Berengo, Be, Bilingo. L a forma toscana prevalente è. Berlinghieri, clie pro-
babilmente procede dalla franco-provenzale Beranger - Berenger. Radici ber = orso, e gar = lancia, giavellotto.
I n Toncana troviaino anche Bellincione, Cione (da non confondersi con Cionne, -nno = 3lelchiorre) dive- nuti cognomi. In Piemonte Berengario o Balangero (nei marchesi di Busca).
Berengario divenne in Francia Blanchard, Blancard, donde i nostri Biancardi, Bianciardi, Biancheri.
In Piemonte e Liguria cogn. Beiingardi, Bellagarda. Bellingeri, Baloncieri, Belangione, Bellingini. Blen- gini, Blangini e forse anche il savoiardo o valdostano Blanchin. A Treviso Berengo; forse d a *Berengone il romagnolo Rangoni. Boringhieri (Torino) è il ladino Buergna italianizzato, non saprei con quale criterio.
N. d . 1 . in Piemonte: Balangero, Ballangero, Po- longaro, Polongliera.
Noto, per curiosità, che a Torino halengo equivale a C citrullo n ; ma forse i. vocabolo di gergo, di oscura etimologia.
Berenice. Vedi Veronica.
Bernardo. Erroneamente identificato con Berardo, Eberardo
(Vedi AVERAKIIO). Da1 germanico ber, bern = orso, e hard = ardito. S . Bernardo di Mentone, 15 giugno; S. Bernardo di Chiaravalle, 20 agosto.
Forme popolari in Liguria Bedin, ed in Friuli Bidin. Cogn. liguri Bedini, Bedinello; friulani Bidin, Bi-
dinos, Bidinbt, e per un singolare accoppiamento dei due suffissi, Bidinost (cfr. Dreosti, sotto Andrea), Be- deschi, Bidischini (cfr. Baldeschi, ecc.). Non si trova più in Friuli Bidernnccio, il cognome del capitano che con quaranta Venzonesi difese nel l509 il passo della
-
9 0 M I E COGNOMI 47
Chiusa, sot to Pontebba. F a t t o celebrato d a una can- zone popolare contemporanea, monumeiito dell'ita- lianita del Friuli, e recentemente dal D'.4iinuuzio ('1.
Berta, Berto. Per lo piu sono abbreviazioni di nomi di cui ber1
è il aecondo elemento (vedi Alberto). Ma il femminile può anche s tare d a sè; di questo nome ci sono due Sante e due Beate; venerata i n Italia la B. Berta de' Bardi abbadessa di Vallombrosa, m. 1163, 24 marzo.
I1 mutamento ber1 = vert. verd, avviene anche i n nomi composti: un Rauertus de Porta Ticinensi teste nell'atto d'alleanza t r a Lodi ed altre c i t t i lornbarde. 1167. Cogn. Reverdino (piemontese). A Cremona do- cumento 902 Anzevertus. id. 909. Redevedus, id. 1014. Aldeuertus. Udevertus.
Bertarito. Germanico Bert, Perthari; dalle radici ber1 = illustre,
e hari, her = esercito. Bedhari in Paolo Diacono. S o m e longobardo. al quale, meglio che ad Alberto, Lnmberto. ecc., ricondurrei i cogn. BBrtoli ( reueto- friulano); Bertolini (anche piemoutese); Bertolazzi, Bertolotti, Bertarelli, Bertieri (francese Berthier). Albertario si spiega per l'analogia con Alberto.
A'. d . 1. Bertorella (Borgotaro), Perterano (Lecco).
Bertoldo.
Radici germaniche bert, per2 = illustre, ed old va- riante d i aud, ald patrimonio, stirpe. I i i Friuli prevale la radice pert.
i') Della canzone, edita ed illustrata da Vincenzo Ioppi. cito sol- tanto due versi: . Su. fedeli c bmi Furiani
Su. lrgillimi italiani l i.
-
Cogn. Pertoldi. Pertoldéo. Toldo. Frequeute in do- cument i friulani il nome composto Wnllerpsrloldo.
A Udine Via Bertaldia. nclla q u a r t a c e r ~ l i i s delle mura (principio del secolo S I V ) .
Bertrando. Berlrnnio, U r l t ~ a n ~ u . l?erlernrno ( raro) , licrlnmo (id.). Anclie in t rd r s ro rlurstn noiiie si prrscnta in varie
forme, a clii rorrispoiidono diverse etimologie. Il primo elerneiito piiò esscc.o bnll , pnll = ardito. auducc, oppure il frrquentissimo hrrl, per! = illiistrc; il scc:ondo ram, var ini i t .~ di hrnbnn. rnhnu = i~orvo (u
Ia
-
Uiio dei var i nomi d a cui può derivare il comunissimli Gino in concorrenza con Anibrogio, Luigi, ecc. I co- gnomi che n e dcrivano sono per lo più evidenti.
I n F r i i l i , per influenza veneta. insieinc con Blasi. Blasini, -soni, -sutt i , si t rovano Biasoni. Biasiiii, Ciu- sioli, .sutt i . Foririi: slaviezate Blssetig, Blasutig. Po5- sono der ivare d a Biagio (Blas) come d a Tornmaso, Gervasio. ~ : o . i c.ognorni Su t , Del Siit, Sut to , Sut t iua .
Bianca.
Xon h nonie (li Santa. m a è abbastaiiza f requeutr . Forsit allusivo nori t an to alla carnagione, quanto a1 canclore bstti:sinialc. k considerato coiiic onomastirn il 5 aposto. fcsta ~ I r l l a >ladonna della Seve.
I L . o ! / ~ . Bianclii. ecc. più prohabilmeote r l a l l ' ag~e t - t i r o che noil dal noine. eccet,tiiat.o forse il friiilaii
-
Bellotti; Blengini = Bellengiui, ecc. >la C'S in Bra . ban te S. Bellanda (Berelindis), m. 702. Gogn. Ber. lendia ( ? l .
Blarasino.
Nome che occorre uon di rado in documeiiti friul3iii. Etimologia oscura.
C:oqn. Blarasini, -no. Blarzino.
Boemondo.
Variante vcneta Bajamonte. C:rniianico Uor»r?~nt; radici mulrt, »ru??
-
NOXI E COGNOMI 5 1
Bonuald i n documenti Lucca, i 13 . E uno di quei nomi ibridi, nei quali il prirno eleniento, god = gut, e sostitiiito dal latino honus. Il secondo elemento pu6 essere walt = potente, o hart = forte; ma nella for- mazione dei nomi spesso si confondouo. Bnnardo, coi cognomi Bonardi. .delli, -dini, Bonaudi, Banaudi. ecc.. equivale dunque a Gottardo. Altri esempi: Bonari (documenti I,uccs, 746), doude i cognonii Bonari, -relli, -retti, -rini, a Godari: cogn. Gottarelli, Cottarelìi: Bouechis, Bonichis (Lucea, 742); Godegis (Sieua, 71:) (per i cognomi vedi Eonizo), Bo~riJrid, Bonfrirl (Lucc i . 745.774); Gudofrid (Garfagnana, 723): Bo?iipergn ( i 6 5 ) : Godeberga, Houiperl, Bonibert (Chiusi, 771); Gi~crtur (Rieti. 744); Bonuald, Guduald (S. Benedetto iri Campolo, i 6 1 ) .
I1 Ponia citn, aggiungendovi un piinto d'esclama- zione. un autore inglese ( * ) che da un Bonipertus dc Bonipertis, secolo S I V , deriva il
-
(:ug7~. Bonturi , Bot tura , Botturini (veiieti); Veutura, .ri, Venturini; d a *Bonturblo (form;, lombarda), in Fr iul i cognomi Turalo, Sturolo (ctfetto della siii- gelare predilezione di certe parlate friulane per la s impura). Turale (prodot to da1 frcqueiit.c seanihio a , o e viceversa). e per falsa aualogia coli Berlblu, I3ri.- toldo. Tiiroldo, clie uon 113 clic fare col Turuldus della Chanson dc Ilolalid. Turazzs ( rene to ) , Turollo, -11s ( t rent ini ) e forse. con un raddoppiamento dell:r l iqu id ;~ , Turri , Turrini . I n Pieiiionte Turiii, T u r i n ; ~ . Tiiriiirtti. I l primo i! Cognome di fniiiiglia valdc~r. . chc: si ritiene originaria di Sali), col cognorue Turirii. T:& aliliciio t I'opinioiie di ilil riiiiiistro ralilrtsi~.
Bonfante. Inteso a f a n t e r nel sigiiiticato daiitesco di CI iionio
(Purga to~ iu , S S V , 6 l ) equivsrrebbi: a l i o ~ ~ o n i u , O n ~ o b o ~ ~ o . C O ~ I L . Faiiti, -tini. - toni, -tiizzi. Iii Friiili I:% fori i i :~
Iatiiiizzats Fnnzio. e d a qiiesta b'nnziitti.
Ronifacio, -zio. Etimologia evideiite. S. Bonifucio iiiartirr. 14 iiiaggio.
S. Bonifario papa. 25 maggio. F o r m a popolarr veneta, i: cogrioiiie. Uoiifli, dondr
Bouf i J io , Boniadiui: Fadiui, Faitelli, Boiiifi, Boni- fa t t i . -fett i . Fa t t i , Fnttiiii. U;L -jaeir~. Faciiii. Faeciui. Faccioli, Faccioh, Facciolati: d a - /: iriiilaiio 1,'az- ziitti. D a Bonifctti il a al se si ai io C;iiiiecti.
Pe r qualcuno dei cogn. 3ol>raruiii111:r;iti i. ;ii.cetta- bilr :~ncbe I'etimc, E Biioiinfr
-
Cogn. Bonicbi (to$cano); Boiiizzi, Bonicelli (1011- bardo); Bunico (Frabosa. Nondovi); Bonecco (friu. lano); Bongi (toacario); Boiighi (meridionale). Iii Bo. nizzardi (di cui forsa Paiiizzardo i: una o,=, i , I'iirzcl, abhrrvinzioni ,li uouii avent i corni: radice 1iir1.g. baurgs, ~ I C ~ C (lo stesso ctimo di . hoigo l ) ) , i:ol sigiiificato di K difcsa, protezioiic r .
Borso (: nome freqiiontc iiegli Ikt,ensi. Cogii. Dorsi, Biirsiiii, Borsit:ri : i Ilurziiit~
(ligure); B6rsari ( rcroncse) : Horsaii:lli (di Bringlia presso l\loudori, paeac uiiicaineutc agricolo.
-
54 A . B O N G I O A S S I
nome germanico d i significato odioso. Si potrebbe proporre l'ipotesi di u n a modificazione della radice l o i s , weise = saggio, esperto: m a forse in contrasto colle leggi glottologiclie.
Gogn. Bosi, -selli, -setti, -sini, Bosio, -sia, Bosoliiii. Boggio, -gia. Bogetti , Bogino, Bozino e per oscurn- mento ~ l e l l o , i r ene t i Busato. .setto. Businelli, Bu- solini.
Bovo, Buovo. Gcrnianico,
-
Brunamonte. I n varie forme, si t rova in parecchi poemi francesi. a & sempre norne d i personaggi saraieni. Cogri. Brunainont i (Umbria) .
Bruno, Brunone. Radici: geriiianica brunju. brunja. brunrie = CI). z23, Oppure hruu - bruno. S. Bruno foiidntore dei :rtosiiii. G ottobrc. (.'og,i. Bruiii. -nacci. -nelli, -net t i , noni, ecc., di eti- ologia avidente. E n t r a in molti composti. Cori gnrd- iiiiio. recinto Brunqard, Rvaungardl; i:ogiiomc Brii- cari1 i ( tosrnno). Cuu har i = i:;it:rcito, o hart = forte: liruiihnri:
rrf. E r u n h e r i . S o m e italiaiio B T L C ~ V T O . Cogn0111i ruliari, -neri, -nero (pienioiitcsi). Coii icall, wnlcl = 3tente: IIruiietcnllatteo. ecc.) coli noiiii od aggettivi avent i significato di augurio.
aluto, proincssa. Sif fa t t i composti abbondano in To- t a l i ~ . r soiio indizio di gentilezza di costume e di 3rte sentimento della solidarieti famigliare.
r1bOin1110 casi: Buoriinsegirn = hona ericaenia. ossia uon principio, vocabolo del latino ecclesiastico, t u t - ora. in uso nel territorio dell 'antico Patr iarcato
-
zione di u n a nuova cliiesa, o di un iiltarr. Cfr. il verbo toscano «incignarex. È il noine del primogenito.
Cogn. Buoninsegui (un raino di questa famiglia assunse poi il cognome a i : l i Segni. Per gli iiltrogeuiti, c'era da scegliere: Ili~otr
-
Biiondelmonte. Ha t u t t a l 'apparenza d i uii nome gerrnanicili deriva 113 uoiui grriiianici col sutiisso I ) I .UIL~, rnu111 (cfr. in Pie~iont(! . >londino, .\Ioiitiii
-
58 A. BONGIOASNI
Cacciaguida. Che sia un nome di battesimo i,. noi1 uii soprannome,
6 fuor di dubbio. 11 trisavolo d i Dan te (Pnrodiso. S V ) lo dice espressamente: ii Insierile fui cristiano e Caccia- guida .. JIa nè di questo, n& di a l t r i nonli non meno ijtrani che si trovano in Toscana nei secoli X I I e S I 1 I . nessuno h a da to finora u n a etimologia soddisfacente. Sopraiinonie d i qualche antenato , divenuto poi nome ~ ~ e r s o n a l e ! Traduzione d i un nome coniposto germ:i. iiico? Sell 'onomastica del tempo troviamo anclie Cacciaconte, Cacciucompagno. Cacciaeontr. Caccia. lostc. Caccinlupi, Cacciaporci, Cacciavillani, ecc.
Sel l ' I taI ia merid. eogn. Cacciapuoti. UI quale scnihr:i rispondere il francese Cliassepot.
Cadilo, Cadolio. Etimologia incerta, probabilmente germanica. Xoi!
esiste alcun Santo d i questo nome. Un Cadulus o Grr-
-
centrale); Gaiìieri, Caffieri, Cafiero, Cifariello (Puglia); Gafurio (Bergaino); Gafori (Lodi); Gaffuri, -rini (Ber- gariio, Cr rmona) ; Gaffori, Gafferi, Giafferri (Corsica). Vornie singolari Goffa (lonib.4) e Gaffodio (Vicoforie, l u i i l o i , nel dialetto locale Gufo). D e Guaiferiis, Forli, secolo X I I I (Poma) .
A'. l L : a Veueaia, Ponte, Rio, Fondamenta dcI Gaffaro a i Tolentiiii; Caffari , Caffarena (Genova); C:atl'araccia (Uorgotaro); il CatTaro (Trentino, luogo 1iol.o 1)"' U L L ~or i iba t t in icn to ivi a v r c n u t o nel 1866); dii l~hiu Cafriolii (Pa(1ova).
111 greco, cquivale a l iiostro I;uo?igiorno. S. Cali- mero vescovo di IIilano, 3 ottobre.
Antica cliieso a >lilaiio. Cog~i. Carimali ( lombardo) ; Callomaro (piemontese)
e coi1 inolta probabilitb, Caramelliiio (Ca l im~r ino) . Caraniello. -iiiella (piemontesi e liguri).
Callisto. I n greco, bellissiino. Dci cinque San t i di questo
nome il più venerato è S. Callisto, Papa e martire, 2'72. 14 ottobre.
Calogero. Iu greco (r bel vecchio in. I n greco moderno, è titolo
che si d h a i sacerdoti. S. Calogero, I V secolo, 18 giugno. Antica chiesa a Jlilano ( S a n Galdss). I n Sicilia
;. Calabria cogn. Calogiuro. In Piemonte Calosso (cog~i. e ?i . d . 1.. Asti); forse Lossa, Losio (lombardi-pie- montesi).
C'nnlilli, Gamillae, erano giovinetti ingenui, cioè di nascita libera, che assistevano i sacerdot,i. Etimologia
-
incerta. I n Italia i: venerato S. t:ainillo dc' L e l l i ~ , jecolo S V I I , 17 luglio. >li paiono ,li etimologia evi- dente \lilli (abruzzese); 1Iillo (picinoiitesc): C:riiiilleri ( I ta l ia centrale); nii pare invece iin iiome g~ririaii ico travestito: Gnmalheri ( regis t r l~to ila Heintzv): radici 9 ~ , ~ r ~ n 1 = vecchio a heri, h
-
(del teiiil)o di Diocleziano) furono auiriprr. in grande venerazione in t i i t ta l a Venezia orient,ale e nelle fini. time regioni transnlpinc; se ne lia testimonianza anc:Iifi nella topomastica (San Canziaiio; S. Cocein. frequcii. tissinii iiella Venezia Giiilia).
Coqtr. Cian. Ciani. D e Ciniii, Deiiaiii (friulaiii, il primo aiirhe veneto); Canziani. Zisni, Zian (veueti) . T r a gli slavi Coccio, Coci.aiicig italianizzato iii Coceani, tedcscliizzato in I
-
In I ta l ia invece gode maggior venerazionr S. Carlo Borromco, 4 novembre.
Carmela, Carmine. Vedi Haria.
Carnevale. Uno dei niolti iionii allusivi UI tciiil>o della iinscita. Cogn. Cariicvn.li, Carlevuri, .ris, Carlcvcri. I n documeiiti lombnrdi C p i e m o n t ~ s i Cwiioi-rili~,
C'nrncvnrius, Cavn~2cz.ariur .
Cassio, Cassiano. I1 secondo, in Toscana, per lo più è Caseiano ( 11 . c i . 2 . .
Casciaiia, Sau Casciano). San Cassiano rnartirc sot tu Decio o sot to Valcriano, è il pat rono di Imola ( 2 6 inarzo). -4 Venezia S a n u'ussa?~. Xei eogn. Cassi. Cm. sett i , Cassini. ecc. concorre :Le
-
Sante d i questo nome, nella agiografia greca B Aiea. lerina, nome del quale nessun lessicografo dà. u n a e t i - mologia soddisfacente, e nella russa Iecaterina.
Forme popolari Calera (toscano); Cate, Calinu (ve - neto) ; Catare, Calarine, Calarusse (friulano).
Cogn. Cattarossi, -rozzo, -ruzzi, Tarussio (friulani; escludo Ca t ta ro e l'eresia C a t i r a ) , Catini, Catiiielli.
I n Friuli , i l comunissimo Rossi può anche essere l 'ultima riduzione di Cattarossi.
Cavalcante.
Cognome divenuto nome d i persona; caso non raro. Dall'abbreviazione Canle coln. Cantelli, Canti, Can to~ i i .
Catullo.
DU catulus = cagnolino, o diminutivo d i rufo, eatus = astuto .
È cognome veneto; se i: origiiiario d i qualche l u o , ~ o della sponda veronese del Garda, non è d a esclu~lerv il latino Catullus. Questione d a proporrc ai (:oiioiciti,ri del folk-lore della regione.
Ceccardo.
tiecardus. Vescovo di Luni, fine dell 'VIII secolo e patrono della diocesi. I1 corpo i? conservato a Car- rara. Equivalente a Siccnrdo?
L'ogn. Ceccardi, Ceccherini, Ceccaroni (Toscaiia): Ceccaldi, Ciaccaldi (Corsica).
Ceeilio, -1ia.
' lome d i u n a ant ica gente romana, che si dice%.:i discendente d a Coeculus, figlio di Vulcano. S.
-
Cogn. frinlani De Cilia, D e Cillia, Ceciliot. I n a l t r i cognonii (Sili. Sillio, Ziliotto) concorrono Egidin (Gillio), MarsiLio, ecc.
Celeste, &no. Etimologia evidente. S. Ce1es:ino I, papa. G aprile.
S. Celestino V, papa (quello del sgrai i rifiiitov). 19 maggio.
c : o g i ~ . friulano Lcstuzzi. D a Cclrslia~iua, cnqii. Lc. st:~iii. -V. d. I. Lestans. Ala Lestizza ( C n i l r o i ~ ~ o ) i. nonlt: slavo.
Celso. In latino, alto. S . Celso, martire a .\lilano rircu il FY
roii S. Nazaro. 28 luglio.
Cesare. Cognome di u n a famiglia della gente Giuli:~. clic
l'adiilazione dei poeti fece disceiidere d a Ju lo od Ascaiiio figlio ili Enca. Sia che 10 s i derivi d a rueso i ;~nlris centre (taglio cesareo) o lu s i nietta in rela- zione con caesaries = zazzera, I'ctiniologiu i! seinpr? dalla radice. caed, vcrbo caedere = tagliare. Xell'ono. mastica la t ina c'è aiiclie il nonle Cueso.
i'og~i. di etiniologia evidente Cesari, -riiii, -roiii, I!
-
NOMI E COGNOMI 65
una teata di vitello alata, poi sostituita d a una testa umana.
Cogn. veneti-friulani Rubini, -binato, Ciribino; que- st'ultimo d a non confondere con Ciribiri, nomignolo col quale talora sono designati i Cici del Carso triestino.
Chiara. La sorella spirituale d i S. Francesco d3Assisi. 12
agosto. Xome usato in Toscana anche al maschile. Cogn. Chiarella, -rini, -rotti. I n Piemonte Clara,
-rotti ; in Friuli Claricini, d a Clarice o Clarissa, nome che si t rova in varie Chansons dc geste.
Cipriano.
Dall'isola di Cipro. S. Cipriano vescovo di Carta. gine, secolo 111. 16 settembre.
Cogn. veneti-friulani Civran, Cevran; friulano Ze- vrain. Forse, per contrazione, d a questo nome, o da Ciro, Cirillo, cogn. Cirio (piemontese-friulano).
Dal greco Ryrios = signore. Nome d i diciannove Santi, dei quali il più venerato
in Italia è i l vescovo d'Aucona, mart. a Gerusalemme circa il 362. 4 maggio.
Diminutivo di Ciro. Dei quindici Santi di questo nome, basti ricordare S. Cirillo, patriarca di Ales- sandria e dottore della Chiesa, m. 444, 28 gennaio; e S. Cirillo, fratello di S. Metodio, sec. IX, ed apostolo degli Slavi. che da lui ebbero l'alfabeto.
Cogn. Cirilli. Cerilli.
5 - A. BONGIOANNI. Nai e co
-
66 A. BONGIOANNI
Ciro.
È nome peraiano; mi pare dunque arbitrario in- terpretarlo come se fosse greco (Eyr ios ) .
Dei vari S. di questo nome è specialmente venerato S. Ciro d'Alessandria, mart . 311, 31 gennaio; patrono dei medici.
I n qualche luogo (Genova e Pav ia ) si confonde Giro con Siro.
Clemente, -menzio, -menza.
Etimologia evidente. Tra i Santi i più venerati aono S. Clemente d i Alessandria (4 dicembre) e S. Cle- mente, papa (23 novembre).
Forme popolari toecane: Chimenti, Chimienti, dive- nu t e cognomi. Il cognome carnico Cimenti, in re. gione dove permane il nesso latino cl, pare una anomalia, m a non e. L a forma locale, indicatami dal mio consulente per la Carnia, D. Antonio Roja, 2 Ciuménl, del carinziano Ement = Clemente. Altro cognome, schietto friulano. è Clementel. In Piemonte (Chieri), d a Clemenzio (cfr. Prudente, -zio, Innocente, -20, Coatante, .zo, ecc.), coglt. Xena, Menzio, Mensio. Nella genealogia della famiglia chierese Ascheri si t rova il nome femminile Menzia. Mentessi (lombardo) par- rebbe d i origine friulana. In hlentasti (piemontese) fenomeno analogo ai friulaui Bidinost, Dreosti (vedi Andrea e Bernardo).
Clodoveo. Vedi Lodovico.
Clotilde. Nome franco, d a hlod illustre ,o, e hill n battaglia 1. Santa Clotilde. moglie d i Clodoveo. molto contribuì
alla conversione dei Franchi; 3 giugno. Dalla Casa di Francia il nome passò nella Casa di Savoia; da lungo
-
NOMI E COGNOMI 67
tempo è i n corso la causa di beatificazione della V. Haria Clotilde, sorella di Luigi XVI e moglie d i Carlo Emanuele IV, m. a Napoli, 1802.
Colomba, Colombo. Significato evidente, essendo la colomba un simbolo
già in uso prima del Cristianesimo. San Colomba, irlandese, apostolo della Caledonia,
sec. VI; 13 dicembre. I1 cogn. Colombo si t rova anche t r a gli Israeliti,
ed è la traduzione di Jona .
Colombano. Santo irlandese. 543.615, fondatore d i molti conventi,
t r a i quali il più celebre è quello di Bobbio. dove mori. I1 nome h a apparenza latina, m a non è escluso che sia un traveatirnento di qualche nome celtico; 21 novembre.
Contardo. Germanici Gunthavt, Gvnther; radici gimt = bat-
taglia e harl = forte: spesso scambiato con Golhurdt. S. Contardo estense, secolo YIII, 26 aprile.
Cogn. Contardi, -do (frequenti i n Friuli), Conta- rini (veneto; è notevole la frequenza d i cognomi d i origine germanica nel patriziato veneziano); molto probabilmente i friulani Cantarini, Cantarutti , per i quali, se derivassero d a a cantore D, sarebbe d a aspet- tarsi una forma parallela Chimi, come, a d esempio, Candotti, Cbiandotti. ecc., ed in Piemonte Cantore, Chiantor, Cliiantore. Derivare questi cognomi d a canter = pitale, mi pare oltraggioso, nebbene non manchino esempi analoghi, un po' dappertutto. D i un n magister Gontherius in, muratore, forse di origine tedesca, è menzione i n s Acta publ. Civit. Utini r , agosto 1332. Per la preùilezione friulana della s im- pura, cogn. Sciintaro, Scuntero.
-
Conte. Vedi Bnonconte, sotto Buono.
Contesa. Vedi Matilde.
Cornelio. Cognome di una illustre gente romana. probabil-
mente non d a cornus, m a dalla c i t t à di Corne. S. Cornelio, P a p a e martire, 252; 16 setteiiihre.
S. Cornelio. centurioiie, converti to d a S. Pietro, e mart i re sotto Tiberio; 2 febbraio.
Nome non molto usato; esiste in Piemonte il cognome Cornelio.
Corrado. Radici germaniche liuon, k«7~ = ardito. audace. e
vat = consiglio. Equivale esat tamente , per aignifi. ca to , a l greco Trasibulo. S. Corrado di Piaeenzii, sec. XIV, 19 aprile; B. Corrado, Molfetta, 9 aprile.
Cogn. Corrado, -di (frequente in Liguria); Raddi, Radini, -no, Conrotto (piemontese; 6 il L'uon.rotuo del t< Codex Astensis n); Curetti (Mondavi): Curreno (nel c i ta to codice Conradeiigus. Currengus, E u n patro. nirnico); Cor r i (Trieste); Corrarini (veneto); Corridoni (niarchigiano); Ridoni, Currò (Trieste); Curotto (li- gure); Corrao, Rao ( I ta l ia meridionale). Xella Ve- nezia ed in Frifili: Coradazzi. Corazza. -zzi, Cornzzin. Corretto.
Cosimo, Cosma, Cosimato. F o r m a popolare veneto.lombarda Cosrné. Equivale a l latino Ornatus. S. Cosma, martire col fratello Daniiano, 303.
2 i settembre. Cogn. Gusmitta (lombardo, p i ù . probabilmente che
d a Goldachmidt, cognome di Ebrei tedeschi = Ore-
-
NONI E COGNOMI 69
fice); Gusmai, Gusumai, Gusmini (veneti); Cosmacln (slavo, a S. Pietro a l Natisone, con grafia tedesca Xosmatschin).
Costante, -tino, Costanza. Cogn. friulani Tant in , Tintin (Tinl inue più volte
nel ci Thesaurus Eccl. Aquilej..). Innumerevoli iii Friuli, principalmente a Tricesimo, i Costantini.
È f requente nella proviiicia (li Cuneo il nome Co- stanza. Dodici Santi .
Cogn. Tanz i (lomb.), Constnntianus, Stanzani ( e ) .
Crescenzio. Dal participio del verbo crescere. È nome di dodici
t r a Sant i e Beati. I n Toscana è venerato. col nome di S. Cresci, un martire del I V secolo, 10 aprile.
Cogn. Cresci, Crescini.
Crispolto. Xome di un Santo veoerato a Bet tona (Assisi). Jla
11 P6tiu (voll. 42-43 della N Eocyclopédie ecclésia- b t i q u e ~ del Jlignc). che lo registra anche col nome francese di C h ~ ~ p o l d . non dà. a l t ra indicazione.
Cogn. Crisliolti (Uiiibria), e forse. dalla forma fran- cese, Crepaldi.
Cristiano. Cogn. veneti-friulani Crestan, Cristante; ladino
Crastan. I n Toscana Cristiani e Buoncristiani.
Cristina. S. Cristina di Bolsena, martire. 24 luglio. I1 nome d i Cristo, per reverenza, non è mai iisato
dai Cattolici, raramente da i Greci. Cristina, -no ne tengono il luogo.
Cogn. Cristini.
-
Cristoforo. I n greco a portatore di Cristo s. .\[artire, 250,
25 luglio. Nella leggenda di S. Cristoforo c'è forse qual
-
N O M I E COGNOXI 71
ed in una iscrizione sepolcrale del tempo del re Cuni- berto. È lo stesso nome che Umberto. 12 dicembre.
Cogn. Cuniberti, frequente nella provincia di Cuneo, dove abbondano i cognomi di origine longobarda; Comberti, Gomberti.
Toponomastica: Caste1 Gomberto. I nomi germanici di cui il primo elemento è kun,
e specialmente Cunibe.rto e Corrado, sono apeaao ah- breviati: Kuno, Cuno, Cuons, Conz, Chunizo, Kunit t , Kunze.
Nome femminile Cunizza. Cogn. C6ncina (Clsuzetto, Vito d'Asio); Conz (friulano) e forse il meridionale D'Acunzo.
I1 toscano Conci, Concini è da Acconcio; m8 non 8 d a escludere la coincidenza fortuita col nome ger- manico.
Cunirnondo.
Radici germaniche kun = audace, ardito, e mund = difesa, protezione. I1 nome del re dei Gepidi, padre di Roamunda, sopravvive forae, ma in concorrenza con altri nomi di uguale desinenza, in qualche cognome bisillabo.
-
. Ddmatio, -riio. D d i Dalmania. Vsiiaavo di Padh IIY snnnlo,
5 dieambrt. N. d. 1. ìmquenti noliti pravinds di C U U ~ e di
Torba (Borp S. Dalmiiso, Srn Delmoria di Nma, Rnsialo) i! nvW&ntioa C U D ~ di Nizfia (8, D ~ ~ I C B I C I di Tenda, S. Dslmriau il Sslvrt l~a): ma d brovm uishs iii altra regioni (Y, D d m d o di Monfmiitino, Modsila, S. Dilmunin di Pomarwnne, Luooa). 1.a dlihiiionw dnl nome mi fa r ikucr~ ohe, n grnfmmtr da1 gcrmeuiou Muf8a, dIaaa. wno *i& l'etirnn di M a t l n ì , Muoni l (liquti); Mssiolr, -noli, -iolmiil. .soleal (lombiirai) e dai to iuad Marirami, M ~ d n g l i i * hieeinghi. M* il prlmfi, in genorew Aiariirr, pub s n h e cmiem - ds Mmsr; !a fo. ndgiie M. tira a r l g i n d s ùi Oliisvaii. Rimano. nioura il friulmo balmunon, Tulmmnn ( T J m ~ r o n s B annha nome di luogo), 11 mia uoneulants prol. Dddneuon, guridaiio, al 6uIcnre nhs 1s ous fomfglii B @m- neria di 8. I'ictra al Nausane; ma Il migaome non psrr davo.
Damiano. Rtimologia cinawra. S. m d r s anl irif~l10 Cnnmb 308.
27 ielttrriibri:. C'ogn, ' Miuni (nmrniidbiJs RmiMmu).
B I'cquivslaiitti ai WgglerA (ij U~nirie). Iis arduo ~ P S E dunque nei ctqnami Dxnsd, .mini Is pioweni6nta ddla Danitnueril, PluttouLo, B smniidbilc l i concor. reara di Agnnis [a fr . I)dl*Anhe), od in Donmini, di 7iioaioin.
-
In ebrdoo i U n B iI m10 @iiPioo m. O l e s t 1 ProiPiLi, a% um tuihndo mutire, 3 gwin+a.
Non frsquende fuori ddI& Y m d r . U n e . Dipndn, -loil, -lur, Dmfn, Dandli (vmeti-
Miilad): Dainel1 (T ) Waano.
Darla. NO& poiai*no, ahs uccondu r4rodat.o signiGshrirs2iba
i ~ C ~ T ~ Y O P Q W.
Duci Rhntl mwtM, ddlo Chiearr greca, r.d una BmCa Dada, mnrt. a Roma iotbo Vderiiwia; 26 cittmbre.
I n cbreicu s ambto u. SQ dicuiiihrc. Non B Iroyiiente, mh s i trova uii po' clopperh~t~io. Cap. vitnato.fririlullo Devi$. MR nella forina Da ViE
b piti yrubabilmentm a da Vitu d'Ad0 ( P ~ P H ~ ~ IOP~B Spl l imb~r~o) .
-
Defendente. Etimologia ovvia. Santo martire in Provenza sot to
Jlassiniiano; 2 gennaio. Usato, ma di rado, nei dintorni di Cuneo, dove esiste
una chiesa dedicata a1 Santo.
Delilno, -a. Intorno a questo cetaceo la fantasia degli antichi
creò molte belle favole, alcune delle quali sono riferite d a PLinio. Divenne anche un simbolo cristiano. Ma per i cognomi Delfino (piemontese-ligure) e Dolfin (veneziano) vedi Sdolfo.
Demetrio. D a Deméler, Dea corrispondente alla romana Cerere.
Molti Santi; perciò l'onomastico varia secondo i luoghi. Ma è nome raro t ra i Cattolici; frequente invece nelle Cliiese orieutali. I n Friuli, Mitri, divenuto cognome.
Desiderio. L a serie dei Re Longobardi si chiude con un nome
che forse è latino soltanto in apparenza. La forma francese Didier mi induce a ritenere non inverosimile clie sia un nome germanico. dalle radici Ihiud = po- polo e hari, her = esercito.
Cogn. Didero (piemontese); Deideri, Desderi (liguri- nizzardi).
S. Desiderio (in Piemonte S. Didéro). 33 maggio.
Desio. Qual più bel nome per un bambino lungamente desi-
derato 1 Cogn. toscano Desii.
Detalmo. Germanico Diethelm, Dielhalm; radici Ihiud, dial,
diet = popolo, e helm, halm = difesa, protezione.
-
YOMI E COGNOMI 76
.incora in uso in qualche famiglia nobile friulana. Cogn. piemontese Talmone, m a in concorrenza con
Jnlelmo. Lantelmo, Guilelmo.
Devota. Santa martire, secolo IV, patrona della Corsica e
del Principato di Honaco. C'ugn. ìigure Devoto.
Diamante. Nome per lo più femminile, oggi di uso non frequente.
Diana. Sebbene sia nome di una Dea romana, non è raro
nell'onomastica italiana del medio evo. I n Toscana è venerata l a B. Diana Giuntini; forse il nome è una abbreviazione di Verdiana o Veridiana, altra Beata, toscana. m. 1242; l o febbraio.
I n Friuli i l cogn. Diana equivale a Di Anna.
Diego. Nome d i u n Santo spagnuolo, m. 1463; 13 novembre.
È t radot to in latino Didacus o Diduciua; m a forse l& traduzione è arbitraria.
Diodato, Dcodato, Adeodato. In latino Deusdedit. Significato evidente. Forse in
qualcbe caso si confonde col gotico Seodalo. Cogn. Diodati, Dati, Datini. Con intenzione analoga. cioè d i ringrsziomento o di
invocazione, i nomi Diotallevi (cogn. Allevi, Allievi, Diotajuti, Dioliguardi (cogn. Guardi), Diotisalvi
(cogn. Salvi, Salvini, ecc.. ma in concorrenza con Silvio). L'Olivieri, acutamente, classifica t r a questi nomi il padovano l lantegnz ( = Dio le muntegnu). H a
-
significato analogo il toscano Vacondio. T ra gli Israeliti sono i n uso Servsdio (nome e cognome) e Graziadio, accetti anche dai Cristiani.
Dionisio, Dionigi. D a Dàonysos, nome greco di Bacco. Tra i molti
Santi, specialmente venerato S. Dionigi l 'dreopagita, convertito d a S. Paolo ed Apostolo delle Gallie, 9 ottobre.
Cogn. piemontesi Dionisio, -8otti. Nisio. hmiiiissi- bile come etimo dei cognonii Danesi, -8ino.
Disma. Secondo alcuni agiografi è il nome del buon ladrone,
clie la Chiesa Romana onora il 25 marzo. Somt. usato, m a non frequente, in Loinbardia.
Latino Dominicus = consacrato al Signore. Priii- vipalinente venerato, come fondatore d~!ll'Ortliii t r a i nomi personali. Tralasciaiido i cognomi nei quali al,- pare nella sua integrità (Doineiiiclii, ecc.) o solt.an1.t) decapitato (Menichetti, Meneghelli. ecc.), dalla fo rma dialettale Domini. Dumini abbianio Domini, De Do- niinis (reneti.friulani) che per lo pii1 si pronuneiaiio come se derivassero d a dbminns. Dumini (toscano. i.fr. il francese Duminy); Doininioni (lombardo); Do- ininissini, 1\Iinisini (friulano); Dominato (veneto); Dominetti, Dominuto, Diminuto, Minato, hlinatel (friulani). Da Dominut è probabile che derivi il curioso cognome carnico D eli' Ominut e dalla erronea pronuncia D6mini, Degli Uomini (Valle del Fella). D a Menego, Mengo. Mingo: Mengazzi, -gazzini, -negbelli, .ghelli,
-
.ghetti, -ghini, -goni, -gatti. -gutti , -guzzi, hfinghetti.
.ghini, -goni, -gatti, -guzzi, Mincin (veneti) ed il friulano Negozzi, e con altri suffissi diminutivi, llengarelli. Nen- carelli, Mencarini, Xlengarini. D a Xeco, .Ilico: Mechi. .cacci, Necherini, Jlich (friulaui), 3lecchia (carnico); Michetti, -cotti, Jiigone, -gat t i (ammissibile la coiicor- renza di Buonamico, Amico); dal toscano Beco: Becbi, Becherini, -cherucci; dubbi i piemontesi Bechis. Becchia, -cchio; do1 veneto-friulano Xeni , Xenis, Ale. nato, -natti , .nazzi, -nini. -noni, -notti, -nozzi. È evi. dente che per taluni di questi cognomi bisillabi, nou si può escludere la concorrenza di dnselmo, Guglielnio. ecc. e di drr igo, Ugo, ecc. in Ghelli, Ghetti, Ghezzi, Ghini. Gon. Gozzi, Gotti, ecc. La filastrocca forse non 6 completa: m a si t r a t t a d i cognomi di cui l'etimologia è chiara e lampante.
Donato.
Si sottintende. « d a Dio u. Nome frequente nelle diocesi d i Arezzo, I\londovi e Pinerolo, d i cui S. Do- nato è patrono. 7 agosto. AL femminile, in Piemonte. Donnlilla.
Cogn. Donati, Sat i . Natiiii. Natti, Nattini. Dubbio il piemontese-ligure Xat ta .
Donizo. Donizone.
Xome germanico di oscura etimologia. Cogn. Donizetti, Douizoni, Donzelli (lonibardi)
Donnino.
Latino Domninus, d a dominus. Santo martire. 304. pregso il Borgo che d a lui prese il nome.
Cogn. Donini, Donnini, Sandonnini.
-
Doroteo, dea.
La stessa etimologia di TEODORO. -RA. S. Dorotea martire, 6 febbraio.
Cogn. Tea, Teja (piemontesi), ma in concorrenza cou Matteo. -lea.
Drusiano, -na.
Probabilmente celtico, di ignota etimologia. Del poemetto n Drusian del Leone r si fecero molte
edizioni, a Venezia ed a Bassano. Ciò attesta la sua popolarità.
Cogn. veneti-friulani Drusian, -ui; piemontese Rus- siano ( P ) .
Durante.
Participio del verbo n durare o. Equivale a u Co. stante D; contratto, Dante, secondo la concorde opi- nione dei dantiati.
Cogn. Duranti; i piemontesi Durando, Dorando pro- babilmente dal francese Durand.
-
N O M I E COGNOMI i9
Ehremondo. È una forma italiana ipotetica del germanico
Ebermund (francese Ecremonl) da eber, ebur = cin- ghiale, e d anche principe, e mund = difesa, protezione. Hebremundus, Farfa , 772.
Cogn. Bermonti, Bremonti, Relmondo.
Edgardo. Nome anglosassone (Eadgar) equivalente al germa-
nico Olker, Oiger, al francese Augier, Ogier, ed al nostro Oggero, Uggieri. Nell'onomastica italiana è uno degli ultimi venuti. Radici ot, aud = patrimonio, e gar, ger = lancia, e per traslato, difesa.
Edmondo. Anche questo è di introduzione recente (francese
Edmond) e di significato poco dissimile d a Edgardo: il secondo elemento di esso ( m u n d ) significa difesa, protezione. L'uno e l'altro repugnano alla fonetica italiana, che non ammet te i nessi consonantici dg, dni. Secondo il Fumagalli, il femminile sarebbe Edmeu. S. Edmondo, 20 novembre.
Edoardo, Eduardo, Odoardo; nei nostri sn- tichi scrittori Adovardo.
Germanico d d w a r t , -warta, Hadwart; anglosassone Edwart, Edward. Radici ad (adal, adel) = nobile, oppure had = guerra, e wari, wnrd = custodia, difesa. guardia.
S. Edoardo 111, re d'Inghilterra, m. 1066, 13 ottobre. Formo popolari, divenute cognomi, Dardo (pie-
-
80 A. BONGIOANSI
montese); Dardi (veneziano; un Dardi Bembo, se.. colo XVII I , traduttore d i Platone): Dardin, Darduin (friulano, ammissibile D'Arduin); Dardaurlli (piemon- tese, cfr. I'ariostesco Dardinello), Dadone.
Edvige. Germanico, ma d i oscura etimologia. I l primo ele-
mento & lo stesso che nei nomi precedenti; il secondo, wig, significa combattimento, o combattente. Sarebbe più conforme alla fonetica italiana Eduvige, come vo- leva Iaidoro Del Lungo.
S. Edvige, di >[erano, secolo S I I I , in seguito alle annessione dell'Alto Adige ha acquistato la cit tadi- nanza italiana; 1.5 ottobre.
Efisio, Efflsio. Etimologia incerta. I1 nome B frequente in Sar -
degna. È: uii Santo sardo, martire a Cagliari. 111 secolo, 13 febbraio.
Egidio. Probabilmente 6 un patronimico. dal nome greco
Egeo. l? specialmente venerato in Italia il B. Egidio, uno dei primi seguaci di S. Francesco d7Aaòid, 22 aprile. Prevalse i n qualche par te d'Italia la forma francese Gilles. Toponomastica: San Gillio (Torino).
Cogn. piemonteai Giletti, Giletta (forse anche d a Gilardo. per contrazione). Nei toscani Gigli, Giglioli, Giiioli, Gioli, e nei veneti Ziiio, Zilli, Ziliotto non e e6clos;l la concorrenza di altri nomi
Eginardo, Ainardo, Einardo. È il nome del celebre cronista di Carlomagno; radici
ag, agin (cfr. il latino ac, acies, acutus, ecc.) = taglio, spada, e hart = forte. Frequente in famiglie della
-
piii ant ica nobiltii picniontcse; i'ultimo dei Benso (li Caroiir f u appiiiito u n Ainardo. Nella nob i l t i as t i - ginna Isiiardi. '\sinarili, hs iuar i . L' idrnti tk d i questi, cogournr con E ~ i ~ ~ a r d o 6 messa in dubbio d o uu autc!- rcvoìissimo glottologn mio amico; nia uella serie dezii ; ~ b a t i dclla ?iovnlttsn t rovo u n Asenarizls ( ~ l i s n i c i . ) che il cronista (lice di s t i rpe carolingin. E rerosiniil- clie costui fosse uii x nsiuaio m 9 F. d a iiotare a11coi.:~ clie il (lialctto ~~ ian iou t , c sc non ho iin derivato (1x1 latini> rini~iarius.
Altri c o y i ~ . picrni~ntesi: Einaiidi, Iriaudi. 11i:ll~ii. Isnac.
-
Cogn. piemontese Ellcna, veneto Santaléna (Santa Elena). Dubbio il friulano Elini (ammissibile Elia) . Il vezzeggiativo friulauo d i Elena i: Leni. mentre per Maddalena si usa per lo più rVeiie.
Cogn. Leuisa.
Poco probabile l'etimologia dal greco eleaino = avere compassione. Il iiome pare germanico, di incerta etimologia.
S. Leonono vescovo bretone, V I secolo, lo luglio. Cogn. Eleouoris. Leiioris, Soris (anche trentino).
Xurisso. Nurisio, tu t t i della Valle di Siisa, forse re- nuti di Francia.
Eleuterio. Nome greco, equivalente al latino Liberius. IJn
Santo, papa e martire 193, ?O febbraio. Poco usato; non di cognomi, ma in qualche caso
può essere s ta to confiiso col germanico Leuthari, Liuthari, t. col niessine~e Jletteriu, Litterio, che nulla ha a c11c far*? ni: col nome greco, i ik (:»l germaiiiro. Vedi dlnria.
Elia. I n ebraici) " i l mio gran Dio D. S. Elia, profeta,
20 liiglio. S . Eiia aba te in Calabria, 20 febbraio. PIotne divenuto cogiiome. Nel friulauo Eliui com-
pete cou Elivin.
Eligio. Credo, col Fumagalli, che sia d a escludere il latino
cligere e che, con somma probabilità, questo nome sia iina variante di Luigi. S. Eligio vescovo di Soyon ,
-
VI secolo, 10 dicembre. È il Santo patrono degli orefici r
-
Forme popolari Lepidio, Lupidio (vedi Sacchetti, novclla S L I S ) . Anclic in francese S. Lupèdo.
Goq?~ . Lepidi, Lupidi (Toscana e Marche); Lepido (Sacile, erroneamente T.
-
D a Fmil iano (S. Emiliano vescovo d i Faenza. 6 novembre; altro, pa t rono degli speziali, 6 dicembre). Miliani, i a n i ( I a r c l ) . I,a forma popolare friulana 31io = Emilio, conaente d i porre questo nome t r a i possibili (:timi del cognome blion, -ni , nia con r a r i competitoi.i. dei quali il piu qiiotato i: Simeone, vene. zii~rio Simion.
Vezzeggiativo gr,i.iiiniiico I m n ~ n , I
-
Enrico, Errico, Arrigo.
Germanico Heim, iieinrich: per etimologia equivale a d Americo, Emerico = potente in casa, in patr ia .
I1 nesso nr repugiia alla fonetica i taliana, alla quale sono più conformi Arrigo (toscano), Errico (mendio- iiale), Endrico, -go (veneto) . Oltre a i derivati evi- den t i (Arrighi, -ghetti. -ghini, -goni, -gucci) i cognomi Andngo, hndr i , Eridrigo, Endri , Indrigo. Indri, Vendri (veneti-friulaiii); Endrici, Endrizzi (tr
-
Erasmo. Dal greco crasmios = amabile. Forme popolari venete Rasemo, Risnio. Sspo le -
.ano Ermo, Elmo ( 5 . Elmo). Cogn. Résimi, Resimini. Raselnini, Rassemini, Ro-
,mini.
Ercole, Ercolano. Dio latino. d i cui la, funziorie in origine i?ra la difesa
le i confini della proprieth (dal verbo hcrce~e = chili- l e re ) ; piii t a rd i f u identificato coll'Hcraklés greve. È uiio di quei nomi che negli antichi scrittori trovioiiiu ie l ls forrria ilel iinmin:~tiv
-
l\licola, Uicu la , Yaculati (