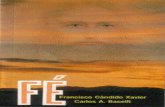Dumse da fé - Rivista Savej
Transcript of Dumse da fé - Rivista Savej


1
DIRETTORE RESPONSABILELidia Brero
REDAZIONE E COORDINAMENTO EDITORIALEFondazione Enrico Eandi
ILLUSTRAZIONI Ginger Berry Design
PROGETTO GRAFICOFondazione Enrico Eandi
STAMPAL’Artistica Savigliano s.r.l.Savigliano (CN)
EDITOREFondazione Enrico Eandi Via G. B. Bricherasio 8, 10128 – [email protected]
ABBONAMENTI
Informazioni e modalità di abbona-
mento sul sito www.edizionisavej.it
Disponibile anche online al seguente indirizzo: www.rivistasavej.it
Seguici su:
FondazioneEnricoEandi
fEnricoEandi
ISSN 2611-8335
Registrazione del Tribunale di Torino
n. 55 del 13-07-2018.
© 2018 Fondazione Enrico Eandi
Tutti i diritti riservati.
Sommario2 Editoriale
4 Conversazione con Giovanni TesioDa Primo Levi alla letteratura contemporanea // Michela Del Savio
8 Matteo OliveroIl pittore della luce // Lidia Brero Eandi
14 Il Villaggio LeumannUna città nella città // Davide Mana
21 Maria Adriana ProloL’archeologa della settima arte // Manuela Vetrano
26 Quando i piemontesi conquistarono l'Unione SovieticaL’avventura di Marco Datrino, scopritore dell’arte rossa dei Soviet // Roberto Coaloa
32 Sognando la “Merica”Storie fortunate e non di emigrati piemontesi // Andrea Raimondi
36 Francesco Cirio, pomodori (e non solo) in Val PadanaLa famosa conserva di pomodoro nasce in Piemonte // Matteo Migheli
40 Il Cimitero Monumentale di TorinoUn museo a cielo aperto tra le vie della città dormiente // Manuela Vetrano
46 Il linguaggio della letteratura: specchio di una società che cambiaDa “La chiave a stella” di Levi a “La straniera” di Tawfik // Andrea Raimondi
50 Primo Levi e il piemonteseLa lingua de "La chiave a stella" // Michela Del Savio
56 Guido Martina, il Disney italianoUna vita da sceneggiatore per Topolino // Felice Pozzo
60 L’Associazione Geronimo CarbonòIl Tanaro, il cuneese (o la Tanària) // Michela Del Savio
64 Umberto Cagni, l'eroe di due desertiL’astigiano che si avventurò nelle terre estreme del Polo Nord su una slitta // Davide Mana
68 Amedeo VIII Storia ‘d n’antipapa // Pino Perrone
76 Luigi Menabrea e la macchina differenzialeIl Primo Ministro che sognava l’informatizzazione dello Stato // Davide Mana
80 La lingua walser, l’antico tesoro delle AlpiIntervista ad Anna Maria Bacher, la po etessa in titsch // Andrea Raimondi
86 Gli atlanti linguistici del PiemonteALI, ATPM e ALEPO: un patrimonio da salvaguardare // Michela Del Savio
94 Le nostre firme
96 Fondazione Enrico Eandi

2
Dumse da féMentre stiamo chiudendo il secondo numero cartaceo di Rivista Savej, stiamo anche lavoran-
do in parallelo alla presentazione del libro che Edizioni Savej ha ripubblicato ad aprile di
quest’anno — il testo di Bruno Villata Primo Levi e il piemontese. La lingua de "La chiave a
stella". Un saggio dove Villata evidenzia e spiega la chiara origine piemontese dell’italiano par-
lato da Libertino Faussone, inusuale figura letteraria di operaio specializzato che gira il mondo
di cantiere in cantiere, “con la chiave a stella appesa alla vita, perché quella è per noi come la
spada per i cavalieri di una volta”. Preparare una presentazione pubblica di un libro è anche
occasione per scavargli un po’ attorno, ragionare su rimandi e riferimenti, rileggersi articoli
apparsi magari cinquant’anni prima oppure — ed è questo il caso — rivedersi vecchi servizi tele-
visivi che si pensava seppelliti nelle teche RAI. E invece… santo YouTube.
Uno di questi è datato 1963, c’è Luigi Silori — anche lui ex deportato in Germania, nel campo di
prigionia di Fullen — che intervista un giovane Primo Levi senza barba. Silori e Levi fanno finta
(beata ingenuità televisiva di quegli anni) di incontrarsi per caso: l’intervista si apre su Levi che
sta aggiustando una macchinina del figlio, e Silori chiede: “possiamo fare due chiacchiere?”. A
quel tempo era da poco uscito La tregua, il secondo romanzo; Primo Levi faceva il chimico a
tempo pieno e nulla era più lontano da lui dal definirsi scrittore. “Sono un impiegato”, spiega
con naturalezza a Silori. Understatement piemontese. La tregua aveva appena vinto il Premio
Campiello.
Un altro servizio è di quasi vent’anni più tardi, del 1981: la trasmissione ha l’improbabile titolo
di Very Important Piemontesi, l’ideatore è Bruno Gambarotta, negli studi RAI di Torino inter-
vistano Primo Levi una giovane Marinella Venegoni (poi firma storica de La Stampa) e il prof.
Claudio Gorlier. Con una domanda che sa un po’ di lusinga, la Venegoni chiede a Levi: “Che
cos’è per lei la piemontesità?”. Risponde Levi, non senza un certo imbarazzo: “La piemonte-
sità è un mito… almeno per due terzi”. Che è una risposta molto sabauda, molto esageruma
nen, perfettamente coerente con l’altro terzo: che è fatto, dice Levi, di costanza, di serietà,
di volontà nel portare a termine le imprese che si avviano ed evitare “i passi più lunghi
della gamba”.
Del 1978 è invece un servizio del TG2: Levi viene intervistato a casa sua, dopo la pubblicazione
de La chiave a stella. Perfettamente figlio del suo tempo, il giornalista RAI chiede quasi giusti-
ficazione a Levi del perché Faussone, nonostante l’appartenenza esplicita alla classe operaia,
non si faccia portatore, o almeno interprete di alcuna istanza politica: cosa inconcepibile in
quegli anni, in cui pareva impossibile parlare di lavoro senza dotarlo, come per un riflesso pa-
vloviano, di opportune connotazioni negative: lavoro alienante, lavoro schiavizzante, lavoro

3
Rivista Savej
come sfruttamento. Ma Levi se la cava egregiamente: Faussone è sempre in giro per il mondo,
risponde, e quindi non ha modo nè tempo di occuparsi di politica. E poi la morale è un’altra
(“una morale sommessa, non sbandierata”): “esiste pure questa possibilità, quella di trovare
gratificazione nel proprio lavoro”. D’altra parte è proprio ne La chiave a stella che Levi scrive
quello che è quasi un lascito morale:
Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l'amare il proprio
lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la migliore approssimazione con-
creta alla felicità sulla terra: ma questa è una verità che non molti conoscono.
E anche:
Si può e si deve combattere perché il frutto del lavoro rimanga nelle mani di chi lo fa, e
perché il lavoro stesso non sia una pena, ma l'amore o rispettivamente l'odio per l'opera
sono un dato interno, originario, che dipende molto dalla storia dell'individuo, e meno di
quanto si creda dalle strutture produttive entro cui il lavoro si svolge.
L’amore per il lavoro anche come “dato interno”, dice Levi; se ci è permesso esprimerlo in
altri termini: un fattore culturale.
Anche da queste vecchie interviste emerge tutta la “felice inattualità” (per dirla con le paro-
le dell’occhialuto giornalista che chiede conto del disimpegno politico di Tino Faussone) del
messaggio di Primo Levi. Costanza, serietà, volontà come antitesi culturali — e morali — all’igno-
ranza rivendicata con orgoglio, all’incompetenza malcelata quando non esibita, alla retorica
spompa da fine (o da inizio) regime. L’umiltà contro la tracotanza. La responsabilità del proprio
agire contro la ricerca globale di sempre nuovi colpevoli. La cultura del lavoro contro quella
dell’assistenzialismo.
Dumse da fé.

4
Giovanni Tesio è conosciuto come critico di arte letteraria, noto da tempo per i suoi studi sulla letteratura dialettale e sugli autori emergenti in questo ambito e, più recentemente, anche come poeta e come professore universitario; ultimamente lo abbiamo letto in corsivo, come interlocutore di Primo Levi nel libro Io che vi parlo (2016) e poco tempo prima nelle righe mozze della raccolta poetica di sonetti in piemontese Stantesèt sonèt [Set-tantasette sonetti] (2015).
CONVERSAZIONE CON GIOVANNI TESIODa Primo Levi alla letteratura contemporaneadi Michela Del Savio
Una mattina con l’autore
L’altra mattina il professor Tesio ha accettato di ricevermi in casa sua, a
Torino, a due passi dal parco del Valentino. “Venga per le 11 per piacere,
perché prima sarò fuori per la corsa”, leggo nella mail. Mi accoglie sul-
la porta e mi accompagna in una grande sala pressoché vuota di qua-
lunque mobilio ma rivestita di libri su tutte le pareti, dal pavimento al
soffitto. Si siede su una poltrona vicino alla finestra, accanto ad alcuni
libri che probabilmente stava sfogliando prima di ricevermi; accanto,
un tavolo tondo al quale mi accomodo io.
Inizio timidamente un discorso, perché non sono una giornalista e il
mio lavoro non è intervistare le persone. Sono una chiacchierona e
sono una persona che legge facendosi senza sosta domande e imma-
ginandosi di poterle porre all’autore. Avere il privilegio di incontra-
re gli autori è qualcosa che cambia tutto, anche il senso dei libri
stessi. Non è vero che i libri vivono da soli, o meglio: i libri vivono di
vita propria, godendo talvolta anche di ottima salute; ma quando un
autore è presente e vigile accanto alle sue opere e può anche parlare
per raccontare se stesso e il suo pensiero, là le cose sono un po’ diverse,
almeno per me.
Mi presento come allieva del professor Alessandro Vitale-Brovarone,
filologo romanzo quasi coetaneo del professor Tesio, immaginando si
conoscano. Mi conferma di sì, e noto una vena di affetto affiorare dai
ricordi: mi racconta che si conoscono perché entrambi allievi, anche
se con percorsi diversi, del padre gesuita Giuliano Gasca Queirazza
(entrambi alla facoltà di magistero, Sandro allievo di padre Gasca da
inizio a fine del suo percorso, Giovanni allievo di alcuni corsi). Giovanni
ricorda padre Gasca con affetto e grandissima stima, sebbene poi lui, a
differenza del padre gesuita filologo e linguista tout court, avesse deciso
di imboccare la strada del critico; Gasca fu tra gli studiosi che per primi Giovanni Tesio

5

8
MATTEO OLIVEROIL PITTORE DELLA LUCEdi Lidia Brero Eandi
Lo chiamavano "il pittore della neve", un'espressione riduttiva perché Matteo Olivero è piuttosto un pittore della luce, avendo fatto della ricerca luministica la ragione della sua arte. Certo la neve è presente in molti dei suoi qua-dri: la montagna rappresenterà per tutta la vita il suo rifugio perché in montagna sono le sue radici.
Gli anni della formazione
Nasce nel 1879 vicino ad Acceglio, nell'Alta Valle Maira.
La madre, rimasta presto vedova, decide di vendere tutti i
suoi beni ad Acceglio per poter far studiare il figlio prima
a Dronero e poi a Torino perché il giovane Matteo intende
frequentare l'Accademia Albertina. Si rivela presto un bra-
vo allievo di bravi maestri come Giacomo Grosso e Andrea
Tavernier e non gli mancheranno le menzioni d'onore.
Una borsa di studio della scuola gli consente un ambìto
viaggio a Parigi in occasione della Grande Esposizione
Universale del 1900. È l'affacciarsi del giovane pittore,
che ancora non ha finito gli studi, sul panorama dell'arte
d'oltralpe. Suggestioni e stimoli derivanti anche da questa
esperienza col tempo lo aiuteranno a trovare la sua strada.
È affascinato dal fenomeno della luce. La ricerca co-
stante di una tecnica luministica sin dai primi anni
dell'Accademia lo porterà verso il divisionismo. Scrive:
Il divisionismo consiste nel dipingere con colori scompo-
sti invece di mescolarli sulla tavolozza e formare la tinta
voluta. […] Con questa tecnica è innegabile che si ottenga
maggior trasparenza dell'aria, maggior intensità di luce,
maggiore verità e colore e vita specialmente nei paesaggi
e negli ambienti. […] Nel paesaggio il mio occhio vede più distin-
tamente i colori scomposti specialmente nei cieli luminosi e negli
effetti di sole. […] Con questa scuola e con la mia speciale tecnica
giungo maggiormente ad approssimarmi ai colori e alle luci più
vibranti che ci dà la natura. Così ho ottenuto l'effetto abbaglian-
te della neve al sole.
È quanto realizza in Solitudine, il suo primo capolavoro.
La poesia della natura
Siamo nell'inverno del 1902 e Matteo è al penultimo anno dell'Acca-
demia. Solitudine è un grande quadro di due metri e, nonostante
il titolo, l'ampia distesa innevata inondata dalla luce comunica un
senso di pace e di sereno raccoglimento davanti alla poesia della
natura. "Un effetto di sole sulla neve, ove superai non lievi difficoltà"
dice laconico l'artista di questa sua opera.
In realtà ne è molto orgoglioso perché sappiamo che verrà ripetuta-
mente esposta nelle più importanti mostre successive. Un lungo stec-
cato che costeggia un sentiero divide la distesa dei prati sepolti da una
coltre di neve abbagliante. Oltre lo steccato, in alto, una baita che pare
disabitata, lungo i pendii, esili tronchi spogli e sterpi irrigiditi dal gelo;
sullo sfondo, le creste dei monti lontani contro un cielo dalla luce can-
giante; in basso le ombre violette dello steccato e dei lievi avvallamenti
modellati dalla neve. Un'osservazione della natura che diventa con-
templazione lirica, in un'atmosfera sospesa di silenzio e di quiete.
"Solitudine", 1907, olio su tela, 150 x 200 cm.

9
Un divisionista innato
È questa una prova ormai matura della tecnica divisionista dell'artista:
brevi tratti di colori puri affiancati — "scomposti" — in punta di pennello
che si ricompongono fondendosi in un insieme armonico di luce.
"Non ebbi maestri di detta scuola" — scrive — "né cercai di imitare
le tecniche di altri divisionisti".
Sappiamo che tra gli "altri divisionisti" ammirava molto Segantini,
cui viene paragonato proprio a proposito di Solitudine, e poi Pelliz-
za da Volpedo, che considerò un maestro oltre che un amico. Ci
è rimasto un loro carteggio molto interessante in cui l'artista più an-
ziano, Pellizza, incoraggia quello più giovane con riflessioni e consigli
specifici, e Matteo lo ricambia con affettuosa ammirazione. Del famo-
so Quarto Stato di Pellizza scrive che "si avanza convinto, organizzato,
a testa alta, verso un avvenire di giustizia e di pace" rimarcando con
convinzione l'ideologia socialista che sottende. L'affinità di origini e di
interessi artistici ha sicuramente cementato quest'amicizia purtroppo
destinata a finire dopo pochi anni: Pellizza nel 1907 mette fine alla sua
vita in seguito alla morte della moglie. Un colpo durissimo per Matteo.
Olivero-Rigadin
Ormai abita a Saluzzo. Ha abbandonato Torino. Non faceva per lui
quell'ambiente artistico che giudicava condizionato da invidie, rivalità
e amicizie di convenienza. È troppo sincero e diretto e probabilmente
anche ingenuo per riuscire a districarsi nel mondo insidioso dell'arte.
Abita con la madre nella parte vecchia della città e poco lontano, su per
la salita al castello, ha il suo studio in un vecchio palazzo. Si trova bene
a Saluzzo, fa numerose amicizie e in tutte le manifestazioni, specie nel-
le feste di Carnevale, la sua presenza è insostituibile. Inventa car-
ri fantasiosi, ad esempio un dirigibile sollevato da un enorme pesce
volante con le ali al posto delle pinne, progetto prima dipinto su tela e
poi effettivamente realizzato come dimostrano alcune fotografie. E fu
guidando questo carro che si prese una polmonite che quasi lo ridusse
in fin di vita.
Anche nella maschera di Rigadin, il suo alter ego carnevalesco,
rivela l'aspetto allegro e burlone del suo carattere. Rigadin ha un
gran cappellone da pievano, un paio di occhialini e il suo bel viso di
artista con i capelli arruffati, gli occhi azzurri e la barbetta bionda. In-
dossa una casacca decorata da medaglie e onorificenze varie sopra un
paio di pantaloni a quadri come una tovaglia ed è a quadri anche il
borsone da viaggio e, visto che è in viaggio, si porta appresso anche il
bastone da passeggio e l'ombrello. Le calze gli scendono a fisarmonica
sugli zoccoli di legno e così zoccolando se ne va in giro improvvisando
comiche orazioni che attirano capanelli di curiosi.
Naturalmente questi sono giorni di solenni libagioni con gli amici e
certo il vino contribuisce a rendere Rigadin ancora più brillante. Pur-
troppo Matteo non è sempre Rigadin: è soggetto ad alterne fasi de-
pressive che lo rendono inquieto, dubbioso, disanimato. Il rimedio
consueto allora consiste nel tornare alle radici, cioè alle sue montagne,
la fonte della sua ispirazione.
Le montagne come rifugio
Mattino: alta Valle Macra (1909). Abbiamo di fronte una tela di cir-
ca 8 metri quadrati, quasi a rendere la vastità del panorama che
l'artista vuole rappresentare. Bisogna effettivamente spostarsi via
via davanti al quadro per riuscire ad osservarne i particolari e come
questi si sviluppino nel contesto di una composizione armonica, per-
fettamente equilibrata. A sinistra un giro di "lose" di pietra conficcate a
terra delimita una sorta di recinto (ah la fatica dei nostri vecchi!); più in
alto, sotto il cielo che va illuminandosi dell'oro rosato del primo matti-
no, ecco un campo di grano o di orzo che già sta imbiondendo; più in
basso, sul crinale di una conca ancora invasa da una nebbia azzurrina,
"Mattino: alta Valle Macra", 1909, olio su tela, 200 x 385 cm.

26
Quando i PIEMONTESI
conquistarono L’UNIONE
SOVIETICA

“Che cos’è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d’esecuzione”, dice il Perozzi, interpretato da Philippe Noiret, in Amici Miei di Mario Monicelli.
Quando penso a Marco Datrino, antiquario tra i più conosciuti al mondo e collezionista d’opere d’arte, ricordo questa battuta e sorrido. La storia di Marco me-riterebbe un film: sono così numerose le sue scoperte di capolavori assoluti dell’arte, e le conseguenti peripe-zie per assicurarseli, da meritare un grande sceneggia-tore e regista.
27
Un museo en plein air a Torre Canavese
Non sto scherzando. Lo scorso anno, discutendo a Roma con un esper-
to d’arte (di cui posso fare il nome: Claudio Strinati) e a Mosca con alcu-
ni artisti russi (di cui non posso dare il nominativo), la fama di Datrino
era tale che non si poteva fare a meno di citarlo nei nostri racconti,
enfatizzando le sue imprese, che, davvero, hanno ormai un’aura di leg-
genda.
A Roma, si parla ancora del suo colpaccio: aver acquistato nel 1984 un
capolavoro di Taddeo Zuccari, La Pietà degli angeli, reso celebre anche
da un volume di Kristina Hermann Fiore.
A Mosca, Marco Datrino è conosciuto come un esperto e collezioni-
sta di arte russa e sovietica, studiosi ne raccontano i meriti e il suo fiu-
to nell’aver acquistato, tra gli altri, le opere dei pittori Viktor Semënovic
Zinov e Ivan Aleksandrovic Naduev. Ma il suo capolavoro è stato un
altro e riguarda il luogo in cui da anni risiede, Torre Canavese (a 35
chilometri a nord di Torino), paese che attualmente conta 605 abitan-
ti. Nel 1993 diventò il centro più importante del mondo dell’arte,
ospitando la prima mostra dei tesori del Cremlino al di fuori della
Russia. Merito dell’antiquario che aveva trasformato il castello di Torre
Canavese, in cui vive, in un museo.
Una passione di famiglia
Il soggetto e i dialoghi delle avventure di Marco Datrino ci sono stati
recentemente offerti dallo stesso antiquario, che ha pubblicato tre anni
fa un volume di memorie familiari, che radunano le sue e quelle di suo
padre Carlo, per tutti detto Chetu. Carlo diventò antiquario subito dopo
la Seconda guerra mondiale; morì nel 1986, lasciando un indelebile ri-
cordo come scopritore di diversi quadri di Pier Francesco Guala.
Marco è nato a Trino Vercellese nel 1941. È un autodidatta che si è
nutrito dei testi di Roberto Longhi. Da Trino Vercellese, la famiglia Da-
trino scelse Torre Canavese come residenza. Oggi, se il piccolo paese
piemontese è adorno di opere d’arte, lo si deve a lui. Negli anni,
gli abitanti hanno apprezzato il lavoro di Marco Datrino, la sua lunga
storia d’amore e d’atavismo per l’arte e il gusto per la cultura e la sua
diffusione che sono tipicamente italiani. Se oggi possiamo ammirare al-
cuni capolavori assoluti provenienti da vari Paesi, dalla Russia a Israele,
dalla Siria alla Cina, dobbiamo anche essere riconoscenti alla generosi-
tà, all’amore di donne e uomini che, in tempi diversi, hanno realizzato
e oggi conservano questo unico tesoro d’arte che è la collezione Pit-
tori per la pace di Torre Canavese. Si tratta di più di cinquecento
opere d’arte conservate nel Comune.
La riscoperta di un tesoro
Il Comune sta riportando all’attenzione generale questo suo te-
soro proponendo alcune esposizioni. Ne è un esempio la recente
duplice mostra Oltre lo sguardo. Sguardi che parlano / Terre che
accolgono organizzata tra Torino (Palazzo Lascaris, Galleria Carla Spa-
gnuolo) e Torre Canavese (Pinacoteca Comunale Raissa Gorbaciova),
curata da Paola Zola, che ha scelto alcune opere di valore assoluto. Tra
queste spiccano un autoritratto e Femme Fatale di due artiste lettoni. Il
primo è di Liela Dace, il secondo di Franceska Kirke. Entrambe hanno
studiato a Riga all’Accademia d’Arte e poi hanno svolto un praticantato
nell’Accademia d’Arte dell’Unione Sovietica. Più della metà delle opere
L’avventura di Marco Datrino, scopritore dell’arte rossa dei Sovietdi Roberto Coaloa
Marco Datrino

Tomba Sada: un puttino si sdraia annoiato sui progetti dell’architetto del Re.
40
IL CIMITERO MONUMENTALE
DI TORINOUn museo a cielo aperto tra le
vie della città dormientedi Manuela Vetrano

41
Correva il 12 giugno 1804 quando
Napoleone Bonaparte, affiancato dal
segretario di Stato Hugues Maret, ap-
pose la sua firma al Dècret Impèrial
sur les Sépultures, meglio noto con il nome di
Editto di Saint-Cloud.
Il documento fu vergato nei pressi di Parigi
all’interno della residenza favorita dall’imperatore, il non più esistente
castello di Saint-Cloud. Con le disposizioni elencate nel decreto, Na-
poleone riprendeva l’antica legge romana delle XII Tavole e sanciva
il divieto di continuare a seppellire i defunti all’interno delle cit-
tà, pratica entrata in voga con la diffusione del culto cristiano legato
alle reliquie dei santi e dei martiri. Queste ultime venivano conservate
dentro le chiese e accanto ad esse i devoti ambivano a farsi tumulare.
Ben presto l’usanza di seppellire nei templi e nelle aree limitrofe risul-
tò assai perniciosa per l’igiene e la salute pubbliche. L’editto napole-
onico stabiliva perciò la costruzione di apposite strutture per il
ricovero dei cadaveri situate in aree extraurbane. Fu così che, in
cima a una collina all’epoca molto lontana da Parigi, venne edificato il
cimitero di Père-Lachaise, l’antesignano dei camposanti moderni.
In breve tempo il Père-Lachaise si riempì delle numerose tombe illustri
per le quali è diventato celebre in tutto il mondo e viene visitato ogni
anno da migliaia di persone. Con l’Editto di Saint-Cloud le città dei
morti venivano allontanate e separate definitivamente da quelle
dei vivi, con cui per secoli avevano convissuto. Ciò innescò un mecca-
nismo di rimozione dalla quotidianità del pensiero della morte che ha
reso la gente sempre più incline a considerare i cimiteri come luoghi
inquietanti e macabri, dai quali tenersi alla larga. Nulla di più sbagliato.
A Torino l’antesignano di Père-Lachaise
Ma veniamo a Torino. È noto che l’indole pionieristica degli abitanti
subalpini si manifesti in molti campi e così è stato anche per quanto
riguarda la costruzione dei cimiteri. Infatti, con il Decreto Regio ema-
nato dal castello di Moncalieri il 25 novembre 1777, il re di Sarde-
gna Vittorio Amedeo III di Savoia anticipava di
svariati anni l’editto francese. L’estate molto afosa
del 1776 aveva aggravato la già precaria situazio-
ne igienica di Torino, alimentan-
do il terrore di un’ondata di
pestilenze. Per porvi rimedio,
il sovrano si risolse a met-
tere fine alla malsana con-
suetudine di stipare uno
sull’altro i corpi dei defunti
nelle fosse presenti sotto i pavi-
menti delle chiese della capitale
sabauda. Queste “cisterne” erano
riservate ai cittadini comuni, men-
tre i nobili venivano sì sepolti
in chiesa, ma all’interno dei
sepolcreti di famiglia. Fu così
che vennero costruiti due
cimiteri, San Pietro in Vincoli e San Lazzaro, situati rispettivamen-
te nei sobborghi di Porta Palazzo e di Po, ben distanti dalle mura
di fortificazione che ancora cingevano Torino in quel periodo. Dopo
soli cinquant’anni però, questi cimiteri risultarono insufficienti
per contenere i morti di una popolazione che di anno in anno diven-
tava sempre più numerosa. Inoltre, l’abitato in continua espansione li
avrebbe presto inglobati. La loro soppressione si rese necessaria e
nel 1826 si ideò un cimitero più ampio, il cosiddetto Generale.
Nasce il cimitero Generale
Una commissione di specialisti istituita dal Comune individuò l’area
adatta alla nuova costruzione nella zona della città denominata
Regio Parco, oltre il fiume Dora Riparia. A fronte di un preventivo
di spesa ammontante a 350.000 lire, il marchese Carlo Tancredi
Falletti di Barolo, grande benefattore e sindaco di Torino tra 1826 e
1827, donò alla città la quasi totalità della somma.
Con questi fondi si acquistarono i terreni sui quali realizzare la necro-
poli torinese, che fu progettata in stile neoclassico dall’architetto
Gaetano Lombardi prendendo ispirazione dal cimitero parmense
della Villetta. Dopo la cerimonia della posa della prima pietra te-
nutasi il 17 maggio 1828, e in seguito alla solenne benedizione impar-
tita dall’arcivescovo Colombano Chiaveroti, il cimitero Generale fu
aperto alle funzioni il 5 novembre 1829. La differenza con i due più
piccoli cimiteri precedenti risiedeva nell’assenza di fosse per le inu-
mazioni comuni. Se in San Pietro in Vincoli e in San Lazzaro soltanto
i nobili venivano sepolti in tombe individuali, nel neonato cimitero
tutti i defunti, ricchi o poveri che fossero, avrebbero avuto una di-
gnitosa sepoltura, ciascuno nella propria tomba.
Una bellezza “Monumentale”
Sin da subito il cimitero si ar-
ricchì di pregevoli sculture
poste a ornamento delle
tombe private e realizzate
da rinomati artisti locali se-
guaci della purezza classicista di
Antonio Canova e Bertel Thord-
valsen, come Giuseppe Bogliani,
Giuseppe Dini e Giacomo Spalla.
Negli anni Quaranta dell’Ot-
tocento il cimitero Generale
venne ingrandito la prima
Cosa bella mortal passa, et non dura.Francesco Petrarca — Canzoniere, sonetto n. 248

50
PRIMO LEVIE IL PIEMONTESE
La lingua de La chiave a stella
Nel 1978 Primo Levi pubblica “La chiave a stella”, in
cui, attraverso la voce diretta del protagonista Tino
Faussone, racconta la storia di un operaio specializ-
zato che si reca in vari paesi per montare gru, pon-
ti, strutture metalliche per impianti petroliferi. A quarant’anni
esatti dalla pubblicazione di quella che è considerata l’opera più
ottimista di Levi, Fondazione Enrico Eandi attraverso la sua
casa editrice Edizione Savej, sceglie di omaggiare uno dei più
grandi scrittori piemontesi pubblicando una nuova edizione
del saggio di Bruno Villata “Primo Levi e il piemontese.
La lingua de «La chiave a stella»” .
Un testo che ha il merito di aver messo in luce un aspet-
to poco analizzato di quest’opera di Levi che suona come
una vera e propria dichiarazione d’amore verso il pro-
prio dialetto.
di Michela Del Savio
INVITO ALLA LETTURA

Dare conto di cosa racchiudano un racconto, un romanzo, un’opera
d’arte in generale è un’operazione quasi sempre parziale: si può ap-
procciare un’opera dal punto di vista delle sue radici, cioè i fili che la
legano alla storia che l’ha preceduta, tentando di indagarne le fonti che
l’hanno ispirata e che in qualche misura sono entrate a farne parte (di
letture fatte dall’autore, di cronaca a lui contemporanea, di esperienze
di vita vissuta in prima persona o per sentito dire); si può affrontare
un discorso che miri invece a identificarne i legami con il resto della
produzione artistica dell’autore che l’ha creata, notandone variazioni
di stile oppure conferme; si può indagarne la valenza politica, la porta-
ta, l’incisività che questa può aver avuto sul mondo in cui si affacciava;
se ne può indagare l’estetica, l’aderenza a qualche corrente artistica, la
letterarietà o invece la tendenza alla saggistica; si può riflettere sulle
parole che impiega, i nomi propri, i nomi di luogo; si può anche cercare
di descriverne la lingua nel suo complesso.
Una scrittura quasi scientifica
La chiave a stella, come è accaduto per tutti gli altri capolavori di Levi,
ha dato e continua a dare ai lettori e agli studiosi la possibilità di avvici-
narlo da ognuno di questi punti di vista. Si tratta di materiale comples-
so, approcciato e poi elaborato in maniera scientifica, quindi restituito
con grande semplicità, chiarezza e bellezza (gli scienziati sanno fare
questo, partire dal caos che è la vita, che è la materia, e semplificare,
rendere lineare, sintetizzare, parola cara ai chimici; lo scrittore può poi
aggiungere la “poesia”).
La curiosità di Primo Levi scienziato e studioso — una volta pensio-
nato era quasi quotidianamente presente in Biblioteca Nazionale, a To-
rino — è parte fondante anche di questo romanzo, in cui la necessità
e passione per il narrare non risparmiano al lettore giochi, allusioni,
riferimenti dotti, spiegazioni di questioni tecniche farcite di termini
settoriali; sono tante poi le strade e i sentieri sfiziosi per la mente del
lettore e dello studioso, quasi delle prove di abilità, sottigliezza, serra-
ture a combinazione che giacciono nel testo con l’implicita richiesta di
essere aperte, la combinazione trovata.
Narratore vs. ascoltatore
La chiave a stella è un romanzo che si compone di tante storie bre-
vi, in cui il narratore-personaggio Primo Levi è l’ascoltatore delle
storie di Faussone, un operaio torinese specializzato nel montag-
gio di infrastrutture, amante dell’avventura e del viaggio, purché siano
motivati dalla necessità della sua insostituibile manodopera ed espe-
rienza di tecnico montatore. Nei rari e brevi periodi in cui Faussone
non è impegnato in qualche cantiere in giro per il mondo, staziona in-
sofferente a Torino, ospite di due anziane zie che tanto vorrebbero che
il nipote si sposasse.
Primo Levi invece veste i panni appunto dell’ascoltatore delle av-
venture di Faussone, dicendo di sé di essere un chimico, scritto-
re nel tempo libero; a questo proposito esprime più volte nel corso
dell’opera il desiderio di trasformare le storie dell’operaio specializzato
in una raccolta di racconti — non a caso il mestiere di Primo Levi nella
realtà storica fu proprio il chimico, lavoro abbandonato poi solo per la-
sciare il posto a quello dello scrittore, già in sé indizio del realismo che
l’opera intende mettere in scena; i due si incontrano in una fabbrica
dell’Unione Sovietica, entrambi lontani dall’Italia e da Torino per
via dei loro rispettivi lavori.
Ciò che fa di quest’opera un romanzo è l’unione dei racconti di Fausso-
ne (uno anche di Levi, in verità) tramite una cornice, che appare qua
e là nelle puntualizzazioni fuori campo di Primo Levi personaggio e
narratore. “Faussone, a cui in altre sere io ho raccontato tutte le mie
storie…”: Faussone, la pagina bianca dello scrittore, a cui tutto si può
dire, a cui poter far dire qualunque cosa.
Il contesto storico
L’opera appare in un momento storico che risentiva fortemente
dell’ideologia nata negli anni Sessanta per la quale il dialetto era
avvertito come sintomo di ignoranza dell’italiano, di impoverimen-
to intellettuale, mentre l’italiano era inteso come il mezzo per riscattar-
51
Primo Levi — La Stampa, 13 luglio 1986
Amo questo dialetto…
è il mio, quello della mia infanzia,
che mio padre usava con mia madre
e mia madre con i bottegai.

56
Guido Martina, il Disney italianoNel 1948 fu abolito in Italia il razionamento della carne e del latte e a Torino nacque La Gazzetta del Popolo; l’anno successivo fu abolito il razionamento del pane e della pasta e avvenne la tragedia di Superga. Non sono che alcuni fatti, tra i tanti di quel biennio, utili a capire meglio quanto tempo è trascorso da allora e dunque in quale contesto, precario e disorientato, Guido Martina affrontò nel mondo dei fumetti, un’attività che lo avrebbe portato lontano e che qui diremo in sintesi.
di Felice Pozzo

57
Una vita da sceneggiatore per Topolino
Un talento versatile
Iniziò in posizione di vantaggio rispetto ad
altri, è vero, essendo sul libro paga di Monda-
dori. Il suo Pecos Bill, ad esempio, subito ac-
clamato a furor di popolo, arrivò in edicola
circa un anno dopo il Tex di Bonelli, nato
nel 1948 e oggi il più famoso fumetto western
da decenni, ma allora sconosciuto e con vita
stentata. Il primo, cioè, uscì subito in ottima
veste editoriale negli Albi d’Oro mondado-
riani, mentre Tex uscì in formato striscia da
una piccolissima casa editrice, senza preve-
dere il più che roseo futuro che lo attendeva.
Vero anche, peraltro, che Martina presentò da
subito un personaggio ancora oggi ricordato
con nostalgia, utilizzando la propria versatile
cultura, un ricco bagaglio di ricerche sul fol-
clore e la storia del West, nonché precedenti
esperienze nel mondo della carta stampata e
una fantasia di alto livello. Si è visto infatti che
il Pecos Bill apocrifo, ossia utilizzato da altri
dopo il 1955, quando Mondadori ne decretò
la prematura morte (salvo una discutibile ma
acclamata ristampa successiva), è stato facil-
mente surclassato dalla concorrenza.
La passione per la scrittura
Nato a Carmagnola il 9 febbraio 1906,
Guido Martina si trasferisce nel 1922 con la
famiglia a Torino, dove il padre Ermenegildo
ha ottenuto una cattedra liceale, e nel 1925
si iscrive alla facoltà di Lettere e Filosofia
per conseguire la laurea nel 1930.
La passione per la scrittura è tale da fargli
abbandonare dopo poco tempo l’attivi-
tà di insegnante iniziata dopo la laurea ad
imitazione del padre, per dedicarsi esclusi-
vamente a vari settori dello scrivere. Ottiene
così interessanti esperienze nel mondo
radiofonico e cinematografico, in veste di
sceneggiatore, e nell’ambito giornalistico,
per poi trasferirsi a Milano dove, nel 1937, ini-
zia la collaborazione con Mondadori che
da circa due anni è il nuovo editore degli
albi di Topolino, prima pubblicati dal fioren-
tino Nerbini.
Sono di quel periodo incontri e sodalizi in
ambito lavorativo con illustri personaggi qua-
li Cesare Zavattini, il celebre regista in veste di
soggettista di fumetti, e il torinese nonché co-
etaneo Angelo Bioletto, egregio illustratore. Il
suo incarico presso Mondadori è quello di
tradurre le strisce americane di Topolino
e Paperino, appunto, e di scrivere qualche
racconto in prosa per la gioventù, qualche
sceneggiatura per fumetti e persino per fo-
toromanzi da pubblicare su Le Grandi Firme
dello stesso editore.
La Seconda guerra mondiale interrompe
bruscamente la sua attività che può ri-
prendere soltanto nel 1945, quando pub-
blica un romanzo sulle vicissitudini belliche e
lavora per il giornale satirico Fradiavolo diret-
to da Riccardo Manzi, ma soprattutto quan-
do ottiene il rinnovo del proprio lavoro per
Mondadori, riprendendo la traduzione delle
storie americane della Disney e l’attività col-
laterale precedente accanto a Mario Gentilini,
fumettista noto per essere stato il più longevo
direttore del settimanale Topolino (dal 1948 al
1980).
Le sceneggiature italiane di Topolino
La prima sceneggiatura di Martina per
Disney risale al 1948, quando, a corto di
materiale originale sufficiente a riempire
Topolino, Mondadori ottiene finalmente
dall’America il permesso di far realizzare
in Italia nuove storie riferite ai protago-
nisti principali. In precedenza il nulla osta
era stato concesso soltanto per Paperino e
Biancaneve, coinvolgendo artisti quali Fe-
derico Pedrocchi. Nell’impossibilità di utiliz-
zare ancora quei collaboratori (Pedrocchi,
ad esempio, era mancato nel 1945), la scelta
cadde dunque sul poliedrico Martina, noto
nell’ambiente come “il professore”, ormai più
che pratico nel creare storie utilizzando le im-
magini, anche per l’attività svolta nell’ambito
dei fotoromanzi.
Quella prima sceneggiatura, molto nota
agli appassionati, ha per titolo Topolino
e il Cobra Bianco, storia disegnata dal già
citato Angelo Bioletto. La prima puntata è
apparsa su Topolino del 16 ottobre 1948 per
concludersi l’anno successivo sul nuovo To-
polino in formato tascabile (aprile 1949).
Caricatura di Guido Martina eseguita da Carlo Limido.
Copertina di “Topolino e il Cobra Bianco”.

La spedizione, come era stata ideata, aveva per compito principale la marcia sui ghiacci dell’Oceano Artico, perciò si doveva par-
ticolarmente pensare alla scelta delle persone ad essa desti-nate. Occorreva fra queste avere intelligenti di astronomia nautica,
per far uso degli strumenti e dei calcoli per ritrovare la terra. Inoltre, in
occasioni difficili era necessario che queste persone avessero l’auto-rità che solo possiede chi è abituato a comandare.
Coloro che potevano meglio riunire queste due qualità erano
certamente gli ufficiali della Regia Marina, ed a loro mi ri-
volsi col gentile consenso del Regio Governo. Il secondo della spedizione era già stato scelto, sin dall’e-
state del 1898, nella persona del capitano di corvetta
Umberto Cagni. Egli volle incaricarsi delle osserva-
zioni scientifiche.
Luigi Amedeo di Savoia - Aosta — La Stella Polare nel mare Artico
64
UMBERTO CAGNIl’eroe di due deserti
Umberto Cagni

Nato ad Asti il 26 Febbraio 1863, Umberto Cagni fu un altro dei tanti piemontesi affascinati dal mare tra il XIX ed il XX secolo. O forse il fascino delle onde ebbe poco a che vedere con la carriera militare di Cagni, che a 14 anni venne iscritto dal padre Manfredi Cagni, generale nell’esercito sabaudo, all’Accademia Navale di Napoli.Non gli venne lasciata molta scelta.
L’astigiano che si avventurò nelle terre estreme del Polo Nord su una slittadi Davide Mana
Due giri del mondo
Da guardiamarina, Cagni partecipò a due
giri del mondo, uno della durata di tre anni
sulla pirocorvetta Vettor Pisani, e successi-
vamente sulla Cristoforo Colombo. Entram-
bi i vascelli svolgevano funzioni di nave scuola,
ed erano al contempo impegnati nella raccol-
ta di dati di natura scientifica e geografica.
Sulla Cristoforo Colombo era pure imbar-
cato il Duca degli Abruzzi, Luigi Amedeo di
Savoia — Aosta, impegnato nella sua prima cir-
cumnavigazione del globo.
Dall’Himalaya all’Alaska
Nel 1893 Cagni divenne aiutante di campo
del Duca degli Abruzzi, col quale strinse
amicizia e che non tardò a coinvolgerlo
nelle proprie imprese — il Duca e Cagni,
insieme con un terzo ufficiale della Cristofo-
ro Colombo, Filippo de Filippi, durante una
licenza a terra, attraversarono l’India fino
alle pendici dell’Himalaya.
Durante la crociera della Cristoforo Co-
lombo, il Duca, appassionato alpinista, ave-
va saputo dell’esistenza in Alaska del Monte
Saint Elias, una vetta fino ad allora inviolata.
Organizzò quindi una spedizione coinvol-
gendo nuovamente Cagni e De Filippi, e il
primo agosto del 1897, la bandiera italiana
venne piantata sulla cima del Saint Elias.
Era solo l’inizio.
La marcia verso nord
Nel 1899, Cagni venne nuovamente coin-
volto in una spedizione voluta dal Duca
degli Abruzzi. La grande epoca delle esplo-
razioni stava volgendo al termine, e solo i poli
restavano a stimolare la fantasia di viaggiatori
ed avventurieri.
A bordo di una baleniera norvegese ri-
battezzata “Stella Polare”, il Duca e Cagni,
insieme ad una ventina di marinai italiani e
norvegesi, lasciarono il porto di quella che
oggi è Oslo alla volta del Polo Nord. Duran-
te una sosta nelle estreme propaggini setten-
trionali del territorio russo, la spedizione
acquistò un centinaio di cani da slitta. La
spedizione svernò nella baia di Teplitz sull’i-
sola di Rudolf, nell’arcipelago Francesco Giu-
seppe. Sebbene la baia fosse stata scelta per-
ché protetta dal vento e dai rigori del clima, la
Stella Polare rimase incastrata nei ghiacci,
e subì una falla. L’equipaggio dovette trasfe-
rirsi a terra in un accampamento di fortuna,
dove il Duca degli Abruzzi soffrì di un caso di
65

80
La ricchezza linguistica, e pertanto anche culturale e umana, del Piemonte non viene mai ab-bastanza evidenziata. Favorita dalla propria posizione geografica, dalla propria morfologia e storia, la regione vanta oggi una varietà linguistica unica. Oltre, naturalmente, all’italiano, in Piemonte esistono anche numerosi dialetti, molti dei quali sono da considerarsi, dal punto di vista strettamente linguistico, parlate extraregionali, influenzate cioè dai dialetti di altre regio-ni. Inoltre, la legge n. 482 del dicembre 1999 ha riconosciuto quattro minoranze lingui-stiche storiche presenti sul suolo regionale — escludendo, però, la koiné piemontese. Tra queste, la più diffusa è l’occitano, seguita dal francoprovenzale, dal francese e dalla lingua wal-ser. La lingua meno conosciuta in Piemonte è appunto quella walser, e forse proprio per questo merita un’attenzione particolare.
LA LINGUA WALSER, L’ANTICO TESORO DELLE ALPIINTERVISTA AD ANNA MARIA BACHER, LA PO ETESSA IN TITSCHdi Andrea Raimondi

Chi erano i Walser?
I Walser, dicono gli storici, erano un’antica popolazione di origine
germanica e altissimo alemanno era il loro idioma originario. Cer-
tamente prima del 1000 si insediarono nella Valle di Goms, nell’at-
tuale Canton Vallese. Fu proprio qui, a oltre mille metri di altezza, che
affinarono la speciale capacità di adattamento alla montagna prima di
spostarsi ulteriormente lungo tre direttrici. Forse favoriti da condizioni
climatiche benevole, tra il XIII e il XV secolo i Walser attraversaro-
no le Alpi e diedero vita a vere e proprie colonie. Una parte si stabilì
proprio in Piemonte — in Val Formazza, a Macugnaga e giù fino a Or-
navasso, e poi nell’attuale Valsesia, sulle pendici del Monte Rosa.
Nello stesso arco di tempo altre comunità si spinsero in direzione della
Val d’Aosta e dell’Alta Savoia, mentre altre ancora si mossero verso est,
nei Grigioni e addirittura nel Vorarlberg austriaco.
Che provenissero dal Vallese dovrebbe garantirlo l’etimologia del
nome con cui oggi sono conosciuti. Walser è infatti contrazione di
walliser, ossia “vallesano”, termine usato per la prima volta nel
1319 in una pergamena di Galtür, in Tirolo, nella quale un giudice
del luogo iscrisse la dicitura “homines dicti Walser”. In altri casi veni-
vano adoperati titsch, ticci o titzschu, appellattivi con cui ancora
oggi si indicano gli idiomi parlati nelle vallate walser.
Cosa o chi fu a spingere questo popolo a migrare verso sud nessuno
può invece dirlo con precisione. Furono persecuzioni, oppure siccità
e caldo insoliti, o fu colpa della sovrappopolazione? L’ossolano Enri-
co Rizzi, tra i più autorevoli studiosi della storia walser, ritiene che fu-
rono soprattutto alcuni monasteri e signori feudali piemontesi a
promuovere gli spostamenti e a permettere così l’insediamento di
questi formidabili agricoltori e allevatori in posti comunemente
inaccessibili e poco sfruttati. Ai coloni di lingua germanica in molti
luoghi venivano inoltre accordati alcuni diritti, come la libertà perso-
nale e l’affitto ereditario della terra, in cambio di un canone e dell’obbli-
go di prestare servizio militare in caso di guerra.
La poetica al servizio dei walser
Anna Maria Bacher è tra le figure più attente e operose nella con-
servazione e divulgazione della cultura e lingua walser.
Nata a Grovella, in Val Formazza, è stata insegnante elementare, col-
labora con lo sportello linguistico del posto ed è soprattutto una delle
poche poetesse in titsch, attività grazie alla quale ha ottenuto diversi
riconoscimenti. Vive, insieme al marito Luigi, in una graziosa abitazio-
ne di legno nella minuscola frazione Brendo di Formazza, località più
antica tra le colonie walser al sud delle Alpi e l’unica confinante con il
luogo d’origine di questo popolo. Per chi non vi è abituato, l’assoluto
raccoglimento del posto, l’incombenza delle pareti rocciose e la pre-
senza di boschi intorno possono destare un certo smarrimento. Smar-
rimento che, nel mio caso, viene subito allontanato dal calore della
casa e dalla cordialità della signora Bacher, alla quale brillano gli occhi
a parlare dei walser e della propria attività poetica.
81









![Rivista di Medicina, Psicologia e Pedagogia - ortofonologia.it75].pdf · Rivista di Medicina, Psicologia e Pedagogia Fondata nel 1999 da Federico Bianchi di Castelbianco Rivista quadrimestrale](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5e1756d62fec236d490ffc07/rivista-di-medicina-psicologia-e-pedagogia-75pdf-rivista-di-medicina-psicologia.jpg)