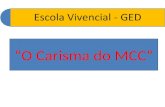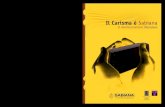Due Donne un carisma 2 - 2015
-
Upload
centro-studi-internazionali -
Category
Documents
-
view
213 -
download
1
description
Transcript of Due Donne un carisma 2 - 2015
g s hg s hSommario
1) La cura della casa comune ..........................pag. 3
2) Il buon lievito di Cristo ...............................pag. 4
3) La carità quotidiana .....................................pag. 5
4) Giovanni Paolo II Dalla “Centesimus annus” ..................................pag. 7
5) Benedetto XVI Il governo responsabile del creato ......................pag. 8
6) Laudato sii, mio Signore ................................pag. 10
7) Papa Francesco Laudato sii, mio Signore .....................................pag. 11
8) Paolo VI Contemplazione dell’universo ............................pag. 14
9) Buon Natale con il giovane Montini ..................................pag. 15
2
Pubblicazione sulla spiritualità delle sorelle Girelli - Anno XX, 2015, n. 2a cura della Compagnia S. Orsola
Via F. Crispi, 23 - 25121 BresciaTel. 030 295675 - 030 3757965
Direttore Responsabile: D. Antonio Fappani
g s h
3
La cura della casa comune
Nella sua enciclica “Laudato sii” papa Francesco parla in maniera dif-fusa e particolareggiata della cura che all’uomo compete della casa comune, spesso trascurata, devastata e saccheggiata dall’egoismo, dalla brama di pos-sedere e di dominare. C’è una vasta materia di riflessione: vogliamo fermar-ci qui sul paragrafo quarto del primo capitolo con qualche considerazione.
Il paragrafo si intitola: “Deterioramento della qualità della vita umana e degradazione sociale”; il papa denuncia alcuni fattori di degrado, che mi-nacciano la nostra stessa civiltà, come la crescita “smisurata e disordinata di molte città”, la mancanza di spazi verdi a disposizione di tutti, la disugua-glianza nella disponibilità dei servizi, la negativa influenza di un eccessivo e indiscriminato uso dei media e del mondo digitale, che finisce con il far perdere il contatto con il mondo dei sentimenti e dei rapporti reali. L’uomo si trova così povero di relazioni interpersonali, in un dannoso isolamento.
Invece “anche l’essere umano è una creatura di questo mondo, che ha diritto a vivere ed essere felice, e inoltre ha una speciale dignità: non pos-siamo - quindi - tralasciare di considerare gli effetti del degrado ambientale dell’attuale modello di sviluppo e della cultura dello scarto sulla vita delle persone”. Le considerazioni del papa spaziano su tutti i grandi problemi del-la società attuale, dal mondo politico a quello sociale a quello ambientale. A una prima lettura può sembrare che il discorso voli alto, molto al di sopra delle effettive possibilità di intervento delle singole persone come noi, che poco contano in una società tanto complessa.
Ma non è così: tutti siamo chiamati a collaborare alla restaurazione di tanti equilibri compromessi, ognuno con il suo carico di responsabilità, grandi o piccole che siano. Non dimentichiamo che il papa ha voluto come esemplare nella sua attività apostolica la figura di san Francesco, che divenne strumento di rinascita per la Chiesa non come ricco figlio di ser Bernardone, ma come umile fraticello, spogliato di ogni segno di ricchezza e di potere. La sua parola, preceduta e accompagnata dall’esempio (ricordiamo che egli usa-va dire che, se necessario, i frati devono “anche” predicare), riusciva a essere incisiva e convincente perché riportava l’uomo alla sua natura di figlio di Dio e fratello di ogni creatura, di cui si scopriva la provvidenziale presenza.
g s hg s h
4
g s h g s hLa lode degli essere creati culminava con la beatitudine di coloro “che
perdonano per lo tuo amore”: si ricostruiva in questo modo un’ armoniosa coesione in una società che era dilaniata, come la nostra, da tanti odi e con-tese.
Irma Bonini Valetti
VWXIl buon lievito di CristoMaddalena ed Elisabetta Girelli hanno lasciato il loro esempio di cristia-
ne impegnate nella società accanto alle più diverse persone, nelle più diffe-renti circostanze, a seconda delle necessità del momento. Esse hanno inteso nel modo più aperto e disponibile l’invito di sant’Angela alle sue figlie con-sacrate a Dio nel mondo a santificare il loro ambiente, a praticare le opere di misericordia adoperandosi in tutti i modi con l’esempio e il consiglio a pro-muovere il bene spirituale del prossimo. In modo particolare esse avvertirono l’importanza dell’educazione delle giovani, a cui dedicarono tante iniziative con un impegno personale costante e senza riserve.
Fondamentale fu per loro l’attività di catechiste a cui si dedicarono per tutta la vita con un’attenzione viva alle ragazze e alle loro famiglie e la possi-bilità, quindi, di essere di aiuto in situazioni difficili. Anche nelle molteplici opere rivolte al mondo operaio ebbero sempre la preoccupazione di curare l’educazione e l’istruzione delle giovani, secondo il più autentico spirito me-riciano. Questa attenzione educativa è il presupposto di tutte le esortazioni del papa, soprattutto di quella che invita a far sì che le persone si realizzino il più possibile in quanto tali.
Singolare è poi la decisione costante di Maddalena e di Elisabetta di ge-stire il loro patrimonio, le loro attività, l’impostazione della spiritualità della Compagnia in modo diretto e personale. Dotate di una consistente ricchez-za, la amministrarono con saggezza, per dispensare poi a tante iniziative di carità quanto serviva perché l’opera potesse fiorire. Questo aspetto della loro vita è molto vicino allo spirito animatore dell’enciclica “Laudato sii” che in-vita a impegnarsi in prima persona, a farsi carico, ad assumersi responsabilità
g s h
5
g s hprecise. Le Girelli che vanno personalmente a portare un’offerta agli operai in sciopero, che accolgono nella loro casa le bambine del catechismo e le ope-raie della “Società di mutuo soccorso” da loro fondata, che aiutano in modo concreto padre Piamarta e mons. Zammarchi , che rispondono prontamente anche alle richieste di aiuto di tanta povera gente, realizzano l’ideale del cri-stiano impegnato a essere un esempio fatto di opere e di affettuosa partecipa-zione, più che di parole.
Attente a quanto accade intorno a loro, Maddalena ed Elisabetta seguo-no le tribolate vicende dell’inizio del Regno d’Italia, con le dispute sul po-tere temporale che divisero persino molti sacerdoti, con un anticlericalismo accanito, con gli emergenti problemi del mondo operaio: dal loro angolo appartato dimostrarono di seguire con apertura di spirito i tanti aspetti con-trastanti del mondo italiano. Cercarono sempre di essere informate e di fare in modo che fossero informate anche le loro figlie, le operaie, le studenti. E pregarono molto.
Diedero così un esempio coerente e costante di cristiane autentiche, quelle che il papa sollecita a crescere nello spirito del Vangelo.
Irma Bonini Valetti
VWXLa carità quotidiana
Maddalena Girelli, nel settembre del 1866, fece alcuni giorni di ritiro spirituale nella sua casa. Da poco era stata approvata la ripristinata Com-pagnia di S. Orsola (giugno 1866) dal vescovo Girolamo. Attorno a Mad-dalena e alla sorella Elisabetta cominciavano a radunarsi parecchie giovani, col proposito di diventare Figlie di S. Angela. Maddalena si rendeva conto che l’opera che stava iniziando non richiedeva solo capacità di organizza-zione, ma soprattutto atteggiamento interiore di carità e di accoglienza. Perciò esaminava il proprio carattere e scopriva i punti che richiedevano
g s hg s h
6
correzione, per assumere comportamenti più amabili, e un tratto più cor-tese nel modo di conversare e di atteggiarsi verso gli altri.
Oggi,la carità, quando viene esercitata, è identificata con le opere di beneficenza; è una carità fattiva, ordinata dal Vangelo e corrispondente alle necessità di tanti poveri che reclamano assistenza. Ma c’è un’altra carità, che è quella dei rapporti reciproci, della convivenza quotidiana, che richie-de autocontrollo, pazienza, apprezzamento dell’altro, sensibilità, simpatia. La carità è farsi prossimo verso chi viene da lontano, ma anche verso chi è di casa. La carità non è solo quella dell’efficienza operativa, ma anche quel-la dello confidenza simpatica e spirituale tra persone: la carità come virtù, non solo come opera.
Maddalena Girelli aveva capito questa urgenza e l’aveva presa sul se-rio, tanto da stabilire, d’accordo con il suo direttore spirituale, p. Giusep-pe Chiarini, una promessa o voto di carità, sulla quale si esaminava ogni giorno.
Così dunque scriveva Maddalena Girelli, nelle sue memorie, nel set-tembre 1866, riprendendo considerazione di un autore spirituale, p. Jean Crasset:
“L’amore scambievole è il più dolce comandamento, è il più facile, ed è il contrassegno più certo dell’amore di Dio, e del vero cristiano. S. Ber-nardo dice che i servi del diavolo possono fare ogni cosa, fuorché l’amarsi.
Anche qui mi sono esaminata riguardo al mio voto di carità; e temo di mancare in due punti: l’uno coll’usar talvolta moti, atti e parole un po’ tronche e dure; l’altro col mancare di compatimento per i difetti del pros-simo, e mostrarne talora impazienza e noia. Anche temo che provenga da poca carità quella intolleranza e quel certo dispetto che qualche volta mi sento, in dover trattare col prossimo; poiché dice il Kempis (Imitazione di Cristo) che l’amore è tranquillo, pio, giocondo ed uguale, che tutto sostiene, tutto soffre, tutto supera! Ho proposto di attendere in questo specialmente ad emendarmi colla grazia di Dio.
Oh! Gesù che amaste l’anima mia fino a morire per essa, fate che io per amor vostro ami il mio prossimo con vero e puro amore!”
(M. GIRELLI, Memorie)
g s h
7
Giovanni Paolo IIDalla “Centesimus annus”
Sulla questione ecologica ha trattato San Giovanni Paolo II nella sua enci-clica “Centesimus annus”, pubblicata in occasione del centenario della “Rerum Novarum”.
«Del pari preoccupante, accanto al problema del consumismo e con es-so strettamente connessa, è la questione ecologica.
L’uomo, preso dal desiderio di avere e di godere, più che di essere e di crescere, consuma in maniera eccessiva e disordinata le risorse della terra e la sua stessa vita. Alla radice dell’insensata distruzione dell’ambiente naturale c’è un errore antropologico, purtroppo diffuso nel nostro tempo. L’uomo, che scopre la sua capacità di trasformare e, in un certo senso, di creare il mondo col proprio lavoro, dimentica che questo si svolge sempre sulla base della prima originaria donazione delle cose da parte di Dio. Egli pensa di poter disporre arbitrariamente della terra, assoggettandola senza riserve alla sua volontà, come se essa non avesse una propria forma ed una destinazione anteriore datale da Dio, che l’uomo può, sì, sviluppare, ma non deve tradire. Invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell’opera della cre-azione, l’uomo si sostituisce a Dio e così finisce col provocare la ribellione della natura, piuttosto tiranneggiata che governata da lui.
Si avverte in ciò, prima di tutto, una povertà o meschinità dello sguar-do dell’uomo, animato dal desiderio di possedere le cose anziché di riferirle alla verità, e privo di quell’atteggiamento disinteressato, gratuito, estetico che nasce dallo stupore per l’essere e per la bellezza, il quale fa leggere nelle cose visibili il messaggio del Dio invisibile che le ha create. Al riguardo, l’u-manità di oggi deve essere conscia dei suoi doveri e compiti verso le genera-zioni future.
Oltre all’irrazionale distruzione dell’ambiente naturale è qui da ri-cordare quella, ancor più grave, dell’ambiente umano, a cui peraltro si è lon-tani dal prestare la necessaria attenzione. Mentre ci si preoccupa giustamen-te, anche se molto meno del necessario, di preservare gli «habitat» naturali delle diverse specie animali minacciate di estinzione, perché ci si rende conto
g s hg s h
8
VWX
che ciascuna di esse apporta un particolare contributo all’equilibrio generale della terra, ci si impegna troppo poco per salvaguardare le condizioni morali di un’autentica «ecologia umana».
Non solo la terra è stata data da Dio all’uomo, che deve usarla rispet-tando l’intenzione originaria di bene, secondo la quale gli è stata donata; ma l’uomo è donato a se stesso da Dio e deve, perciò, rispettare la struttu-ra naturale e morale, di cui è stato dotato. Sono da menzionare, in questo contesto, i gravi problemi della moderna urbanizzazione, la necessità di un urbanesimo preoccupato della vita delle persone, come anche la debita at-tenzione ad un’«ecologia sociale» del lavoro. L’uomo riceve da Dio la sua es-senziale dignità e con essa la capacità di trascendere ogni ordinamento della società verso la verità ed il bene. Egli, tuttavia, è anche condizionato dalla struttura sociale in cui vive, dall’educazione ricevuta e dall’ambiente. Questi elementi possono facilitare oppure ostacolare il suo vivere secondo verità. Le decisioni, grazie alle quali si costituisce un ambiente umano, possono creare specifiche strutture di peccato, impedendo la piena realizzazione di coloro che da esse sono variamente oppressi. Demolire tali strutture e sostituirle con più autentiche forme di convivenza è un compito che esige coraggio e pazienza».
Benedetto XVIIl governo responsabile del creato
Nell’ udienza generale a Castelgandolfo, 6 agosto 2015, il papa Benedetto XVI, svolse preziose considerazioni sull’utilizzo del creato in modo conveniente, secondo una azione responsabile verso Dio e le generazioni future.
«La terra è dono prezioso del Creatore, il quale ne ha disegnato gli ordina-menti intrinseci, dandoci così i segnali orientativi a cui attenerci come ammi-nistratori della sua creazione. È proprio a partire da questa consapevolezza, che la Chiesa considera le questioni legate all’ambiente e alla sua salvaguardia inti-mamente connesse con il tema dello sviluppo umano integrale. A tali questioni ho fatto più volte riferimento nella mia ultima Enciclica “Caritas in veritate”,
g s h
9
richiamando “l’urgente necessità morale di una rinnovata solidarietà” non solo nei rapporti tra i Paesi, ma anche tra i singoli uomini, poiché l’ambiente na-turale è dato da Dio per tutti, e il suo uso comporta una nostra personale re-sponsabilità verso l’intera umanità, in particolare verso i poveri e le generazioni future. Avvertendo la comune responsabilità per il creato, la Chiesa non solo è impegnata a promuovere la difesa della terra, dell’acqua e dell’aria, donate dal Creatore a tutti, ma soprattutto si adopera per proteggere l’uomo contro la di-struzione di se stesso. Infatti, “quando l’ecologia umana è rispettata dentro la società, anche l’ecologia ambientale ne trae beneficio”.
Non è forse vero che l’uso sconsiderato della creazione inizia laddove Dio è emarginato o addirittura se ne nega l’esistenza? Se viene meno il rapporto della creatura umana con il Creatore, la materia è ridotta a possesso egoistico, l’uomo ne diventa “l’ultima istanza” e lo scopo dell’esistenza si riduce ad essere un’affannata corsa a possedere il più possibile.
Il creato, materia strutturata in modo intelligente da Dio, è affidato dun-que alla responsabilità dell’uomo, il quale è in grado di interpretarlo e di rimo-dellarlo attivamente, senza considerarsene padrone assoluto. L’uomo è chiama-to piuttosto ad esercitare un governo responsabile per custodirlo, metterlo a profitto e coltivarlo, trovando le risorse necessarie per una esistenza dignitosa di tutti. Con l’aiuto della stessa natura e con l’impegno del proprio lavoro e della propria inventiva, l’umanità è veramente in grado di assolvere al grave do-vere di consegnare alle nuove generazioni una terra che anch’esse, a loro volta, potranno abitare degnamente e coltivare ulteriormente. Perché ciò si realizzi, è indispensabile lo sviluppo di “quell’alleanza tra essere umano e ambiente, che deve essere specchio dell’amore creatore di Dio”, riconoscendo che noi tutti proveniamo da Dio e verso Lui siamo tutti in cammino. Quanto è importante allora che la comunità internazionale e i singoli governi sappiano dare i giusti segnali ai propri cittadini per contrastare in modo efficace le modalità d’uti-lizzo dell’ambiente che risultino ad esso dannose! I costi economici e socia-li, derivanti dall’uso delle risorse ambientali comuni, riconosciuti in maniera trasparente, vanno supportati da coloro che ne usufruiscono, e non da altre popolazioni o dalle generazioni future. La protezione dell’ambiente, la tutela delle risorse e del clima richiedono che i responsabili internazionali agiscano congiuntamente nel rispetto della legge e della solidarietà, soprattutto nei con-fronti delle regioni più deboli della terra. Insieme possiamo costruire uno svi-
g s hg s h
10
Laudato sii, mio SignoreAltissimo, onnipotente, buon Signore,
tue sono le lodi, la gloria e l’onore e ogni benedizione.A te solo, Altissimo, si confanno,
e nessun uomo è degno di te mentovare.Lodato sii, mio Signore, con tutte le tue creature,
specialmente messer fratello sole, il quale è giorno, e allumini noi per lui.
E esso è bello e raggiante con grande splendore: di te, Altissimo, porta significazione.
Lodato sii, mio Signore, per sorella luna e le stelle:
in cielo le hai formate chiarite e preziose e belle.Lodato sii, mio Signore,
per fratello vento e per aere e nubilo e sereno e ogni tempo, per il quale alle tue creature dai sostentamento.
Lodato sii, mio Signore, per sorella acqua,
la quale è molto utile e umile e preziosa e casta.Lodato sii, mio Signore,
VWX
luppo umano integrale a beneficio dei popoli, presenti e futuri, uno sviluppo ispirato ai valori della carità nella verità. Perché ciò avvenga è indispensabile convertire l’attuale modello di sviluppo globale verso una più grande e con-divisa assunzione di responsabilità nei confronti del creato: lo richiedono non solo le emergenze ambientali, ma anche lo scandalo della fame e della miseria.
Cari fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore e facciamo nostre le parole di san Francesco nel Cantico delle creature:
“Altissimo, onnipotente, bon Signore, tue so’ le laude, la gloria e l’honore et omne benedictione … Laudato si’, mi’ Signore, cum tucte le tue creature”.
Così san Francesco. Anche noi vogliamo pregare e vivere nello spirito di queste parole».
g s h
11
VWX
per fratello fuoco, per il quale illumini la notte:
e esso è bello e giocondo e robustoso e forte.Lodato sii, mio Signore,
per sora nostra madre terra, la quale ci sostenta e governa,
e produce diversi frutti con coloriti fiori e erba.Lodato sii, mio Signore,
per quelli che perdonano per il tuo amore e sostengono infermità e tribolazione.Beati quelli che lo sosterranno in pace,
ché da te, Altissimo, saranno incoronati.Lodato sii, mio Signore,
per sorella nostra morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scappare: guai a quelli che morranno nei peccati mortali;
beati quelli che troverà nelle tue santissime volontà, ché la morte seconda non farà loro male.
Lodate e benedicete il mio Signore e ringraziate e servitegli con grande umiltà
(San Francesco)
Papa FrancescoLaudato sii, mio Signore
Papa Francesco ha dedicato una intera enciclica al dono del creato. Nelle pagine introduttive parla di S. Francesco, riportando la propria testimonianza sul Santo di Assisi, come esempio di giusto rapporto dell’uomo con la natura.
«S. Francesco d’AssisiNon voglio procedere in questa Enciclica senza ricorrere a un esempio bel-
lo e motivante. Ho preso il suo nome come guida e come ispirazione nel mo-mento della mia elezione a Vescovo di Roma. Credo che Francesco sia l’esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità. È il santo patrono di tutti quelli che studiano e lavorano
g s hg s h
1212
nel campo dell’ecologia, amato anche da molti che non sono cristiani. Egli ma-nifestò un’attenzione particolare verso la creazione di Dio e verso i più poveri e abbandonati. Amava ed era amato per la sua gioia, la sua dedizione generosa, il suo cuore universale. Era un mistico e un pellegrino che viveva con semplicità e in una meravigliosa armonia con Dio, con gli altri, con la natura e con se stes-so. In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore.
La sua testimonianza ci mostra anche che l’ecologia integrale richiede apertura verso categorie che trascendono il linguaggio delle scienze esatte o del-la biologia e ci collegano con l’essenza dell’umano. Così come succede quando ci innamoriamo di una persona, ogni volta che Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era cantare, coinvolgendo nella sua lode tutte le altre creature. Egli entrava in comunicazione con tutto il creato, e predicava persino ai fiori e «li invitava a lodare e amare Iddio, come esseri do-tati di ragione».
La sua reazione era molto più che un apprezzamento intellettuale o un cal-colo economico, perché per lui qualsiasi creatura era una sorella, unita a lui con vincoli di affetto. Per questo si sentiva chiamato a prendersi cura di tutto ciò che esiste. Il suo discepolo san Bonaventura narrava che lui, «considerando che tut-te le cose hanno un’origine comune, si sentiva ricolmo di pietà ancora maggiore e chiamava le creature, per quanto piccole, con il nome di fratello o sorella».
Questa convinzione non può essere disprezzata come un romanticismo irrazionale, perché influisce sulle scelte che determinano il nostro comporta-mento. Se noi ci accostiamo alla natura e all’ambiente senza questa apertura allo stupore e alla meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della fraternità e della bellezza nella nostra relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti saran-no quelli del dominatore, del consumatore o del mero sfruttatore delle risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi immediati. Viceversa, se noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in maniera spontanea.
La povertà e l’austerità di san Francesco non erano un ascetismo solamen-te esteriore, ma qualcosa di più radicale: una rinuncia a fare della realtà un mero oggetto di uso e di dominio.
D’altra parte, san Francesco, fedele alla Scrittura, ci propone di ricono-scere la natura come uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua bontà:
“Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia si contempla
g s h
13
il loro autore” (Sap 13,5) e “la sua eterna potenza e divinità vengono contem-plate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute” (Rm 1,20). Per questo chiedeva che nel convento si lasciasse sempre una par-te dell’orto non coltivata, perché vi crescessero le erbe selvatiche, in modo che quanti le avrebbero ammirate potessero elevare il pensiero a Dio, autore di tanta bellezza. Il mondo è qualcosa di più che un problema da risolvere, è un mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lode.
Il mio appelloLa sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoc-
cupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo soste-nibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare. Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di amore, non si pente di averci creato.
L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra ca-sa comune. Desidero esprimere riconoscenza, incoraggiare e ringraziare tutti coloro che, nei più svariati settori dell’attività umana, stanno lavorando per garantire la protezione della casa che condividiamo. Meritano una gratitudine speciale quanti lottano con vigore per risolvere le drammatiche conseguenze del degrado ambientale nella vita dei più poveri del mondo. I giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano com’è possibile che si pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi.
Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci uni-sca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci ri-guardano e ci toccano tutti. Il movimento ecologico mondiale ha già percorso un lungo e ricco cammino, e ha dato vita a numerose aggregazioni di cittadini che hanno favorito una presa di coscienza. Purtroppo, molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale sono spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche dal disinteresse degli altri. Gli atteggiamenti che ostacola-no le vie di soluzione, anche fra i credenti, vanno dalla negazione del problema all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di nuova solidarietà universale. Come hanno detto i Vescovi del Sudafrica, «i talenti e il coinvolgimento di tutti sono necessari per riparare il danno causato dagli umani sulla creazione di Dio». Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno con la propria cultura ed esperienza».
14
g s hg s hPaolo VI
Contemplazione dell’universo
All’epoca di Paolo VI non era ancora esploso il problema ecologico. In occasione dello sbarco sulla luna di alcuni astronauti egli espresse queste rifles-sioni (Udienza generale, mercoledì 16 luglio 1969).
«Ascoltate, come una voce profonda che sorga dagli abissi degli spazi e dei secoli: “In principio Iddio creò il cielo e la terra!” (Gen. 1, 1). Osserva-te il panorama del cielo e del mondo; misurate, se potete, la vastità; fatevi un concetto della densità di reale, di vero, di nascosto che vi è contenuta; provate un brivido di meraviglia alla grandezza sconfinata, che abbiamo davanti; affermate la distinzione irriducibile fra Dio Creatore e il mondo creato, e insieme riconoscete, confessate, celebrate l’inscindibile necessità, che unisce la creazione al suo Creatore (come potrebbe essere un solo istan-te senza di Lui?); e ricordate quest’altra stupenda e ripetuta parola della Bibbia, sempre al primo capitolo della Genesi (vv. 12, 18, 21, 25, 31): Dio vide che l’opera sua era buona; perciò era bella, era degna d’essere da noi conosciuta, posseduta, lavorata, goduta...
Questa scoperta nuova del mondo creato è assai importante per la nostra vita spirituale. Vedere Dio nel mondo, e il mondo in Dio: che cosa v’è di più estasiante? Non è questo il lume amico e stimolante che deve sorreggere la veglia scientifica dello studioso? Non è così che fugge il terrore del vuoto, che il tempo smisurato e lo spazio sconfinato producono intorno al microcosmo, che noi siamo? la nostra insondabile solitudine, cioè il mistero dei nostri de-stini, non è così colmata da un’ondata di Bontà viva e d’amore? Non vengono alle nostre labbra le familiari, ma sempre superlative parole, insegnate a noi da Cristo: “Padre nostro, che sei nei cieli”?».
VWX
15
g s hBuon Natale
con il giovane Montini
Si avvicina il Natale. Lasciamoci guidare dai seguenti pensieri del giovane G. Battista Montini, scritti per gli studenti della FUCI, nei quali la natura è associata al grande evento della Incarnazione (1930).
«Nel tenue palpito della canzone, che non so se vicina o lontana, mi par di sorprendere il linguaggio delle cose tra loro; bisbiglio sommesso, che appena si concede all’aria notturna, diventa gentile cadenza; e cresce, senza sforzo e sicuro, sino a pervadere il cielo, e poi ne ritorna con eguale motivo, ma infinitamente più dolce e profondo, come una risposta amica delle stelle.
La natura respira in questa notte, e tutta sembra viva e tranquilla. Respira e l’alito è canzone idilliaca.
Ma come mai tanta poesia e tanta pace è entrata nel mondo? Donde questo Spirito, donde quest’Amore; d’onde questa Pace sovrana?
Un brivido di gioia corre per le vene della natura, e qualche cosa si desta in lei.
Qualcuno nasce in lei che le dà di rinascere. La vita, si celebra questa notte. Una nuova vita, una nuova natura, una nascita che consola ogni mor-
tale. L’infanzia d’un secolo eterno s’inaugura questa notte; e dovunque l’annuncio perviene “l’Evangelo” che arriva, e apre a chi ha fede nel Dio vivo nel tabernacolo della carne del Fanciullo Gesù; a chi ha il sogno, po-vero pietoso sogno d’una alba di vita ignota e novella; a tutti l’invito ad interpretare la natura come un sacramento, la vita come un segreto celeste, l’infanzia come un’immagine divina. L’incarnazione di Dio è il misterolatente in questa notte e della meraviglia».
a cura di don Mario Trebeschi
16
g s hg s h
O SS. Trinità,sorgente di ogni bene,
profondamente Vi adoroe, con la massima fiducia,Vi supplico di glorificare
le vostre fedeli ServeVenerabili Maddalena ed Elisabetta Girelli
e di concedermiper loro intercessione
la grazia...Padre nostro, Ave Maria e Gloria
N.B.: 1) Chi si rivolge al Signore con la suddetta preghiera, specie in caso di novena, affidi la propria intenzione all’intercessione di entrambe le venerabili sorelle.
2) Ottenendo grazie per intercessione delle Venerabili Serve di Dio Maddalena ed Elisabetta si prega darne sollecita comunicazione a: Compagnia S. Orsola - Figlie di S. Angela - Via Crispi, 23 - 25121 Brescia.
Chi desiderasse avere questo inserto da distribuire in Parrocchia, può richiederlo telefonando allo 030.295675.
Preghiera alle VenerabiliSorelle Girelli
per ottenere grazie!
Supplemento a “la Voce della compagnia di S. angela. BreScia”, dicemBre 2015, n. 2
Elisabetta Girelli Maddalena Girelli