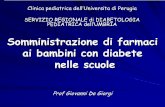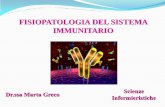diabete.pdf
-
Upload
paolo68audisio -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of diabete.pdf

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 1/28
Il diabeteIl diabete
Il Diabete Mellito è un disordine cronico del metabolismo dei carboidrati, lipidi e proteine. Circa il 3% della popolazione mondiale (100 mil. di individui) soffre diquesta patologia.
Elementi caratteristici della malattia sono:
Insufficiente o difettosa risposta secretoria dell’insulina
Compromissione del metabolismo dei carboidrati
• Iperglicemia a digiuno (v.n. 100 mg/dL)
• Poliuria (emissione di una maggiore quantità di urina)
• Glicosuria (glicemia > 180 mg/dL)
Le diverse forme di diabete mellito si distinguono in:
Primitivo – che comprende le forme più comuni.
• Diabete mellito di Tipo 1
• Diabete mellito di Tipo 2
Secondario – dipendente da altre patologie che incidono sulla funzione delpancreas endocrino.
Le alterazioni metaboliche indotte dal diabete determinano, nel lungo periodo,complicanze a carico del s. cardiocircolatorio, del SNC, dei reni e degli occhi. Lapatologia risulta quindi notevolmente invalidante e di elevato impatto sociale.

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 2/28
Pancreas EndocrinoPancreas Endocrino
Il pancreas endocrino è costituito dalle isole di Langerhans, agglomerati di cellule
endocrine presenti nel contesto del parenchima ghiandolare.
Cellule A (20%) – producono glucagone
Cellule B (68%) – producono insulina Cellule D (10%) – producono somatostina
Cellule PP (2%) _ producono l’ormone PP (polipeptide pancreatico).
L’insulina (insieme al glucagone) ha un ruolo centrale nell’omeostasi del glucosio: è
uno dei più importanti ormoni anabolici, necessario per
Trasporto transmembrana di glucosio e aminoacidi Sintesi del glicogeno a livello epatico e muscolare
Conversione del glucosio in trigliceridi
Sintesi acidi nucleici e proteine

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 3/28

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 4/28
Anato m ia delle iso le di Langerh ans. Le ce llu le beta, produtt ric i d i in sulina (in d icate
in blu) sono s ituate al centro, in imm ediata vicinanza dei vas i sanguigni e sono
circondate dalle cellule alfa, produttrici di glucagone (indicate in arancione).
A ll ’e ste rn o si tro vano le ce llu le delta (in gia llo; pro ducono som atostatina) e le cellule
PP (in verde; produc ono po lipeptide pancreatico).
Cellule B (68%)Producono
Insulina
Cellule A (20%)
Producono GlucagoneInduce iperglicemia
attività glicogenolitica epatica
Cellule D (10%)
Producono
SomatostatinaInibisce secrezione
Insulina e Glucagone
Cellule PP (2%)
Producono Polipeptide
pancreaticoSvariate azioni a livello
gastointesinale

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 5/28
Regolazione della glicemia
Glicemia = concentrazione plasmatica di glucosio
Variazioni fisiologiche della glicemia
Aumento post-prandiale
Diminuzione con lo sforzo fisico e il digiuno Un solo ormone ipoglicemizzante: l’INSULINA
• Secreta dalle cellule -pancreatiche
• Una secrezione basale continua consente l’utilizzo periferico delglucosio
• Picchi di secrezione post-prandiali Numerosi ormoni iperglicemizzanti
• Consentono di evitare o compensare l’ipoglicemia
• Esempi: glucagone, catecolamine, GH, cortisolo..
• Il glucagone favorisce in particolare il rilascio epatico di glucosiodurante il digiuno

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 6/28
Insulina
Ormone peptidico (pre-proinsulina)
• Proinsulina = pro-ormone insulina (catene A+B) + peptide C (Connecting peptide)
PRO-INSULINAPeptide C
INSULINA

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 7/28
Effetti metabolici dell’insulina
L’insulina è un’ ormone IPOGLICEMIZZANTE e ANABOLIZZANTE
Metabolismo glicidico:
• favorisce ingresso cellulare del glucosio (non nel sistema
nervoso)• favorisce glicogenogenesi epatica e trasformazione di glucosio in
acidi grassi
• inibisce glicogenolisi
Metabolismo lipidico:
• favorisce sintesi epatica di trigliceridi
• a livello del tessuto adiposo sintesi e accumulo di acidi grassi,effetto anti-chetogeno e anti-lipolitico
Metabolismo proteico:
• favorisce ingresso cellulare di aminoacidi e sintesi proteica
• inibisce il catabolismo proteico

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 8/28
Fegato
Aumenta il
glucosio
ematico
Diminuisce il
glucosio
ematico
Glicolisi
Gluconeogenesi
InsulinaGlucagone
Glicolisi
Gluconeogenesi
Pancreas
CelluleCellule
Glucosio
Glicogeno
Glucosio
Glicogeno
Ormoni pancreatici: insulina e
glucagone

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 9/28
Fisiologia dell’insulina (1)Fisiologia dell’insulina (1)
La normale omeostasi del glucosio è strettamente regolata da tre processiinterconnesi:
Produzione di glucosio nel fegato
Utilizzazione del glucosio da parte dei tessuti periferici
Secrezione dell’insulina
Lo stimolo più grande alla sintesi e rilascio d’insulina da parte delle cellule B delleisole pancreatiche è costituito dal glucosio (mediato dai recettori GLUT-2, insulinaindipendenti).
La funzione metabolica fondamentale è aumentare il tasso di trasporto del glucosio in determinate cellule del corpo (epatociti, cell. muscolari, adipociti). L’azione èmediata dallo specifico recettore esposto sulla superficie delle cellule bersaglio.
Effetto precoce è la traslocazione delle unità di trasporto del glucosio GLUTs(insulina dipendenti) dal golgi alla membrana, che facilita l’ingresso del glucosionella cellula. GLUT-4 (presente nel muscolo e negli adipociti) è il più importantetrasportatore
GLUT-4 (presente nel muscolo e negli adipociti) è il più importante trasportatorea regolazione insulinica
GLUT-2 (presente negli epatociti e nelle cellule B) è insulina indipendente efacilita il riequilibrio dei livelli intra ed extracellulari del glucosio

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 10/28
Fisiologia dell’insulina (2)Fisiologia dell’insulina (2)
CellulaCellula BetaBeta CellulaCellula BersaglioBersaglio

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 11/28
Fisiologia dell’insulinaFisiologia dell’insulina (3)(3)

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 12/28
I markers del metabolismo
glicidico Glicemia
Variazioni fisiologiche (a digiuno 70-110 mg/dl; aumento post-prandiale, generalmente < 140 mg/dl; diminuzione con l’eserciziofisico)
Glicosuria
Definizione: presenza di glucosio nelle urine
Generalmente patologica, si verifica quando viene superata la sogliadi riassorbimento renale del glucosio (circa 180 mg/dl)
Se abbondante determina aumento del volume urinario poliuria(diuresi > 2500 cc/24h circa )
Emoglobina glicata (HbA1c)
Frazione dell’emoglobina capace di legare il glucosio, utilizzata
come marker dei valori medi di glicemia nelle ultime settimane

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 13/28
I corpi chetonici
Gli acidi grassi rappresentano una forma di energia alternativa alglucosio
il glucagone favorisce la beta-ossidazione degli acidi grassi alivello epatico → produzione di corpi chetonici (aceto-acetato
→ acetone, acido -idrossibutirico) che vengono liberati nellacircolazione sanguigna (chetosi) e eliminati nelle urine(chetonuria)
La formazione di corpi chetonici si può verificare in 2 tipi disituazioni, totalmente diverse
Digiuno prolungato o ipoglicemia nelle urine presenza dichetonuria isolata
Carenza insulinica profonda nelle urine presenza diglicosuria abbondante + chetonuria

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 14/28
Definizione del diabete
mellito
Il diabete mellito viene definito dalla presenza di unaiperglicemia cronica, secondaria a un difetto di produzionee/o di azione dell’insulina.
L’iperglicemia cronica induce una serie di complicanzesistemiche che interessano in particolare occhi, reni,sistema cardiovascolare e sistema nervoso.
I criteri diagnostici sono stati rivalutati nel 1997 (ADA: American Diabetes Association)

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 15/28
Criteri diagnostici (ADA, 1997)
Il diabete mellito (DM) può essere definito da uno deiseguenti criteri:
In base alla glicemia Glicemia a digiuno > 126 mg/dl
Oppure: in presenza di sintomatologia tipica qualsiasivalore di glicemia > 200 mg/dl
In base al test di carico orale con glucosio 75 gr (= OGTTo “curva glicemica” con misurazione della glicemia ogni 30’per 2 ore)
Glicemia 2 ore dopo carico orale > 200 mg/dl

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 16/28
Altre definizioni (ADA, 1997)
Normale tolleranza ai carboidrati (NT) Glicemia a digiuno < 100 mg/dl
OGTT: glicemia 2 ore dopo carico orale <140 mg/dl
Intolleranza ai carboidrati (IGT) OGTT: glicemia 2 ore dopo carico orale >
140 mg/dl e < 200 mg/dl
Alterata glicemia a digiuno (IFG) Glicemia a digiuno > 100 mg/dl e < 126
mg/dl
100
126
Glicemia
a digiuno
Glicemia
2 ore post-
carico orale
140
200
(mg/dl) (mg/dl)
DM
N
IFG
DM
IGT
NT

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 17/28
Classificazione del diabete
mellito Diabete di tipo 1
una malattia tipicamente AUTO-IMMUNE, anche se esistono
forme “idiopatiche”
il meccanismo principale è la profonda carenza insulinica
interessa essenzialmente bambini e adolescenti
Diabete di tipo 2
iperglicemia legata a insulino-resistenza (= difetto di azione
dell’insulina) + carenza insulinica relativa e progressiva.
interessa essenzialmente l’adulto e rappresenta la forma didiabete PIU’ FREQUENTE
comune associazione con obesità e altre malattie
metaboliche

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 18/28

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 19/28
Altre forme di diabete mellito
Diabete secondario Malattie endocrine,patologie pancreatiche, farmaci..
Alcune forme sono reversibili
Malattie genetiche Difetti genetici della secrezione o dell’azione dell’insulina
Sindrome genetiche complesse con diabete
Diabete gestazionale > 30 % sviluppano diabete di tipo 2 nel corso della vita

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 20/28
Curva da carico del GlucosioCurva da carico del Glucosio
Un aspetto caratteristico del diabetemellito è la ridotta tolleranza al glucosio.
Nel test da carico del glucosio (CGTT75 gr. di glucosio per os)
Nei soggetti normali la glicemia
aumenta di poco ed il rapidorilascio dell’insulina consente ilritorno a valori normali entro un’ora
Nei soggetti diabetici la glicemiasale a livelli molto elevati e tende arimanere elevata per un periodo ditempo prolungato
Tale risultato è espressione di:
Assoluta mancanza di secrezioned’insulina
Alterata risposta dei tessutibersaglio all’ormone
La presenza di entrambe lecondizioni

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 21/28

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 22/28
Patogenesi del diabete di tipoPatogenesi del diabete di tipo 11
E’ espressione di una grave eassoluta mancanza di insulina,dovuta alla riduzione globale dellecellule beta del pancreasendocrino.
Il diabete di tipo 1 insorge ingenere nell’infanzia e divienemanifesto e grave nellapubertà.
I pazienti dipendonodall’insulina per la loro
sopravvivenzaEsistono tre meccanismi, tra lorointerdipendenti, responsabili delladistruzione delle cellule beta:
Suscettibilità genetica
Autoimmunità
Fattori ambientali

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 23/28
Il diabete mellito di tipo 1
Malattia auto-immune caratterizzata da infiltrazione linfocitaria
(linfociti T) delle isole di Langherans pancreatiche, seguita da
progressiva distruzione delle cellule -pancreatiche e profonda
carenza di produzione insulinica
Fattori di rischio
Aplotipo HLA (classe II, in particolare DR3/4)
Familiarità: 5-15 %
Possibile associazione con altre malattie auto-immuni(ipotiroidismo, morbo celiaco…)
Possibili fattori scatenanti (infezioni virali, agenti tossici..)

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 24/28
I markers biologici del diabete mellito
di tipo 1
L’auto-immunità nel diabete di tipo 1 induce laproduzione di anticorpi specifici, che precedonol’insorgenza della malattia (valore predittivo) e ne
confermano la patogenesi.
Trattasi essenzialmente di Anticorpi anti-isole pancreatiche (ICA)
Anticorpi anti-insulina (IAA)
Altri (anti-GAD anticorpi anti decarbossilasi dell’acido glutammico,anti-proinsulina, …)

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 25/28
Storia naturale del diabete di tipo 1
Devendra D et al. BMJ 328:752,2004

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 26/28
Presentazione clinica del diabete di
tipo 1
Rappresenta < 10 % dei casi di diabete
Una patologia dell’ età evolutiva essenzialmente
bambini e adolescenti, più raramente adulti giovani (90 %< 20 anni) Tipicamente magri
Con l’aumento dell’obesità infantile, fino a 20-25 % dei nuovi casisono obesi
Esordio tipicamente subacuto/acuto Subacuto: poliurodipsia, dimagrimento
Acuto: cheto-acidosi

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 27/28
Fisiopatologia del diabete mellito
di tipo 1
La carenza insulinica determina l’incapacità dellecellule (in particolare adipose e muscolari) di utilizzare ilglucosio, con 2 conseguenze immediate:
1. Accumulo di glucosio nel plasma iperglicemia marcata superamento della soglia renale di riassorbimento glicosuria poliuria polidipsia
2. Utilizzo di fonti alternative di energia• Riserve lipidiche perdità di massa grassa
• Riserve proteiche perdità di massa magra(muscolare)
Nella cheto-acidosi diabetica si associano carenzainsulinica e iperproduzione di glucagone
dimagrimento

8/14/2019 diabete.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/diabetepdf 28/28
La cheto-acidosi diabetica
Se la situazione precedente continua ad evolvereperché non diagnosticata in tempo si verificano:
1. Disidratazione severa per poliuria
ipotensione, tachicardia, torpore..
2. Produzione massiccia di corpi chetonici
acidosi metabolica (cheto-acidosi) con iperventilazionesecondaria e turbe digestive (vomito..) che peggiorano la
disidratazione.
La cheto-acidosi è una complicanza spontaneamentefatale del diabete di tipo 1