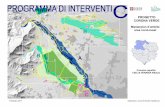Corona Mauro - Il Volo Della Martora
description
Transcript of Corona Mauro - Il Volo Della Martora
-
Mauro Corona,IL VOLO DELLA MARTORA.
Copyright 1997 Vivalda Editori, Torino.Edizione su licenza.I edizione I Miti settembre 2003.
9 ottobre 1963, ore 22.39. 270 milioni di metri cu-bi di terra e roccia si staccano dal monte Toc e preci-pitano nel lago artificiale formato dalla diga del Vajont,sollevando un'onda alta pi di 70 metri che spazza lavalle, travolgendo boschi, case, vite umane. I morti fu-rono quasi duemila: insieme alle loro esistenze andoperduto un intero mondo. Grazie all'inconfondibilevoce di Mauro Corona, che all'epoca della tragedia erapoco pi che un bambino, in queste pagine quel mon-do torna a vivere. Ventisei racconti che, come in ungrande affresco, raffigurano le vicende di uomini e don-ne semplici, ma anche di animali, di alberi e di rocce.Storie di fatica e di sofferenza, il ritratto di un uni-verso scomparso, custodito con amore nella memoriadell'autore, perch la forza dei ricordi e una falce chetaglia i tristi fieni dell'oblio.
A Marisa,che un giorno mi disse:Scrivi.
PREFAZIONE.
Mi chiedo quale sar la prossima sorpresa che mi farMauro Corona. La prima avvenuta pochi secondi dopo
-
il nostro primo incontro. Ero ad Andreis, insieme aMarisa, a Paolo Bozzi e a Margareta, sua moglie; gira-vamo per la Valcellina, volevo conoscere un po' di pidella terra dei miei avi e pensavo che da quella scorri-banda avrebbe potuto forse nascere, come altre volteinsieme a quegli stessi compagni di cammino, un viag-gio-racconto, uno dei miei microcosmi. Un paio di giorniprima, Mauro mi aveva telefonato a Malnisio, dicendoche gli sarebbe piaciuto incontrarmi. Non sapevo chifosse, ho una conoscenza assai superficiale e soprattuttoirregolare, da ignorante, delle arti figurative contempo-ranee, come di altri fenomeni dell'attualit culturale, e lemie lacune sono vistose.Non avevo dunque alcuna idea particolare di lui.L'appuntamento era ad Andreis. Era un giorno umido epiovoso, lui arriv a piedi da Erto, di corsa, bagnato esudato, arruffato, con quel suo fazzoletto da pirata intesta. Avrebbe potuto essere un qualsiasi tipo eccentrico,come tanti. Pensai che avremmo bevuto un caff e chepoi ci saremmo salutati, proseguendo ognuno per la pro-pria strada. Dopo le strette di mano, prima ancora dientrare nel bar, Mauro tir fuori un foglio da una cartel-la che teneva sotto il braccio. Ricordo gli sguardi che ciscambiammo noi quattro, un attimo dopo aver visto ildisegno: la sorpresa, lo stupore, l'incanto che ci leggeva-mo negli occhi. In quelli miopi e ironici di Paolo Bozzi,dietro le lenti, c'era un'espressione di meravigliata e mali-ziosa gratitudine per rimprevedibilit del mondo che, purcos bislacco e spietato, concede ogni tanto una graziacome quella.Era una crocifissione: essenziale, possente, dolorosa,inconfutabile. Mandato all'aria ogni altro programma,siamo saliti con Mauro a Erto, abbiamo visto il suo stu-dio, le sue sculture. Un'esperienza radicata, indimenti-cabile. Mauro Corona un grande scultore, forse ancoranon del tutto consapevole di esserlo, un artista colquale bisogner fare i conti a fondo. Le sue figure dilegno hanno l'incredibile forza e insieme la dolorosa fria-bilit della vita. Corpi di donna, volti assoluti di vecchi,animali, amanti, crocifissioni, un tronco d'ulivo trasfor-mato in un torso tragico, in una Nike di queste valli,antica e aspramente contemporanea. Una poesia sempli-ce e profonda, che scende al cuore della vita.Da quel momento ho saputo che quella poesia avreb-be fatto parte della mia esistenza. Alcune di quelle figuresono a casa mia, in molte di esse Marisa e io ci siamoriconosciuti, abbiamo trovato un'immagine di noi e delnostro essere e Mauro lo sapeva benissimo, perch nonsceglieva a caso le sculture che ci regalava.Quel giorno nata anche una solidariet profonda,
-
una congenialit di sentire che ha fatto di Mauro, perMarisa e per me, un amico fraterno e necessario, colquale camminare sulla strada che conduce allo scaccofinale ma consente anche un forte ed intenso cammino, eanche tante amabili soste, amabili e incantevoli grazie aquel senso epico di strada condivisa, all'intensit san-guigna e picaresca degli affetti.Mauro ha anche nella vita questa epicit, questosentimento di una fraternit che abbraccia pure gli ani-mali, le piante - il suo legno vivo e doloroso - e le cose eche pervade quella che Saba chiamava la calda vita. Ilvalore, il senso della vita, che trascende la vita stessa,nascono dal dialogo amoroso che unisce le singole esi-stenze separate e supera la loro separazione. L'arte diMauro, che ascolta la voce segreta delle cose e le fa parla-re, intessuta di questo sentimento e lo anche la suapersona. Per questo anche la sua amicizia qualcosa diessenziale, come la sua arte.Quella prima sorpresa non mi aveva tuttavia scossosufficientemente dal pigro automatismo, che tende aimprigionarci nello stereotipo e a irrigidire le cose.Quando Mauro mi ha chiesto di farmi leggere alcunisuoi racconti, li ho accolti con diffidenza. Legittima e,anzi, sana. Eccellere in un campo non implica necessa-riamente alcuna perizia in un altro, Kafka o ThomasMann, se avessero scolpito, avrebbero potuto produrredelle sculture dozzinali - che peraltro probabilmente nonavrebbero esibito. L'esercizio, anche magistrale, di un'ar-te pu essere perfino un ostacolo alla creazione in un'al-tra sfera artistica, perch pu indurre a separare un pro-prio mondo fantastico, che in realt non esiste separatodall'espressione che gli da forma, da quella stessa espres-sione e a credere di poterlo riversare in un'altra forma,di poterlo tradurre ed esprimere in un altro modo. I ri-sultati possono essere patetici; l'intenso mondo fantasticodi una scrittura pu appiattirsi in un acquerello di pocospessore, e viceversa.Quando ho ricevuto i primi racconti di Mauro, miattendevo dei testi certamente ricchi di umanit, di di-gnit e di suggestioni, ma sostanzialmente ancillaririspetto alla sua opera figurativa, privi di reale autono-mia letteraria. Non mi pento di quella diffidenza, perchpenso che il sospetto sia un buon filtro per vagliare laqualit di un'opera, certamente migliore del facile e pre-concetto entusiasmo, pronto ad esaltare a priori un'o-pera in base a sentimenti esterni alla sua reale consisten-za. Solo la resistenza a una seduzione pu farla emergerenella sua autentica portata; solo se viene passato al va-glio della critica e della negazione un valore si affermanella sua autenticit. Ci vale a tutti i livelli: Joseph
-
Roth poteva dire che soltanto per essersi ribellato da gio-vane contro l'impero asburgico aveva il diritto di provar-ne nostalgia e di celebrarlo. Tutto ci ancora pi veronei riguardi di un amico, le cui opere potrebbero correreil rischio di venire sopravvalutate per affetto, o per affi-nit di sentire.Ho letto quindi con una utile sfumatura di precon-cetta diffidenza i racconti di Mauro Corona. Ne sonostato conquistato: certamente Corona non un grandein letteratura, come lo nell'arte figurativa, ma unvero, autonomo scrittore. Scarno e asciutto, e insiememagico nell'essenzialit con cui narra storie fiabesche einsieme di brusca, elementare realt. I suoi raccontihanno l'autorit della favola, in cui il meraviglioso siimpone con assoluta semplicit, con l'evidenza del quoti-diano. In essi c' comunione con la natura, col fluirenascosto e incessante della vita, e un'infinita, intrepidasolitudine. Tutto vicino e insieme lontano. Personaggiarrivano da lontananze remote della terra e del passato,dello spazio e del tempo e anche del sogno; restano stra-nieri a tutto, brevi e irriducibili ospiti, come vagabondiai margini del villaggio. Ma la casa, la patria, il radica-mento - che sembrano impossibili o inesistenti - sonoanche sempre accanto, a portata di mano: nelle figure enelle barbe di antichi tronchi d'albero, familiari compa-gni di vita e di cammino, esperti - non meno degli uomi-ni - di freschezza aurorale, stanchezza e aspro dolore.Un mondo meraviglioso, inesauribile e generoso, maanche dolente, si apre d'ogni parte, fa sentire la sua vocefraterna e minacciosa, lascia intravedere il suo voltoinafferrabile e cangiante, talora l'insondabile sorrisodella vita, talora la sua infinita desolazione. Anche lecose, specialmente gli alberi, hanno una loro vita, unaloro personalit, che s'impone con naturalezza; pure inquesti racconti Mauro Corona poeta del legno, del suomistero doloroso e appassionato. Ma soprattutto nellostile che si afferma la forza di questi racconti. Uno stilelineare, scarno; la lingua viene scolpita come un tronco,la mano sapiente sbalza via l'inutile e il superfluo edemergono i connotati, i volti, i corpi, le storie.Storie brevi, in cui il tempo e lo spazio si dilatano,sino ad abbracciare lontananze remote, odissee di questipersonaggi sanguigni e irregolari, nomadi dell'animaeppure tenacemente fedeli al ricordo di un luogo, a undettaglio, a un gesto, a un sentimento, provato una voltae per sempre. Malinconia, ma anche senso forte del vive-re e del percorrere fortemente insieme, pur ognuno conla sua solitudine, la strada attraverso la terra. Lo scena-rio di queste storie spesso circoscritto, ma percorso dalvento di grandi orizzonti; le vicende sono piccole vicissi-
-
tudini, di piccola gente, ma un senso dell'eterno leavvolge, cos come i tempi lunghi della natura e del pae-saggio avvolgono il respiro breve di un fiore o di unuomo che vi affondano la loro radice.Anche questi racconti sono la voce di uno schietto,intenso artista, e insegnano un giusto modo di vivere.Mauro Corona - il quale fa/ora cede troppo alla tentazio-ne di atteggiarsi a personaggio e ad originale, divenendoimprovvido e ingiusto verso se stesso -ha un corpo di fildi ferro, un'intelligenza sottile e agguerrita - invanomascherata da ingenuit eccentrica -e un cuore di poeta,di vero poeta. Corona ha la semplicit della colomba, dicui parla il Vangelo. Quest'ultimo dice anche che biso-gna essere scaltri come serpenti, esperti della malvagitdel mondo e consapevoli di quanta malizia occorra avereper non esserne distrutti. Chiss se la testa, il cuore e lemani che creano quelle figure e raccontano queste storiepossono fare a meno della prudenza del serpente.
Claudio Magris.
Mio NONNO.
Il mio primo maestro d'arte stato il nonno pater-no. Era nato nel 1879 e portava i baffi alla Fran-cesco Giuseppe. In giovent aveva corso la primaMilano-Sanremo, ma non faceva il ciclista di pro-fessione: era un venditore ambulante e si trovavada quelle parti per commerciare gli oggetti in legnoche lui stesso intagliava. Da Erto andava fino a Mi-lano con una bicicletta molto robusta e munita, da-vanti e dietro, di portapacchi su cui stavano fissatidue cassettoni contenenti le cose da vendere. Ilnonno era allenato e concluse la gara. Non mi dissemai con quale piazzamento, forse non lo ricordava.Partiva in primavera al primo canto del cuculoe tornava quando le foglie iniziavano a cadere. Isacchi con la merce li spediva via treno da Longa-rone e teneva il suo deposito merci presso una fa-miglia di Gallarate. Durante i lunghi e silenziosi in-verni lavorava ai manufatti: scolpiva cucchiai, for-chette, setacci, pale da fornai, mestoli e ciotole. Iospiavo i suoi gesti mentre un gran fuoco riscaldavala casa ingombra di legni. Sopra il fuoco, appesa al-la catena del camino, bolliva eternamente una pen-tola di fagioli.Mio nonno capiva gli alberi come nessun bota-
-
nico saprebbe. Di certo non conosceva i nomi in la-tino, ma conosceva il loro carattere. Ogni piantapossiede un suo temperamento, diceva, e in base aquesto reagisce all'uomo che la tocca. C' il legnodolce, quello malinconico, quello astioso, quellotenace, quello egoista e via di seguito; come negliesseri umani, del resto. Lui lo sapeva e mi insegna-va queste cose un po' alla volta, con calma e sag-gezza.Imparai che i denti dei rastrelli si fanno con ilcarpino. Il carpino cocciuto e resiste nel tempo al-lo sfregamento. L'asta invece deve essere di pinogiovane che, essendo buono e tenero, non provocale vesciche alle mani. Tutti gli altri legni spellano lemani, soprattutto l'acacia. Quasi subito reputaisuperfluo preoccuparmi della qualit del legno perl'asta del rastrello: avevo scoperto che lavorando siformano i calli e non si sente pi alcun dolore.Le spine delle botti devono essere di maggio-ciondolo poich, a differenza degli uomini, quel le-gno resiste al vino per molti anni.Con il cirmolo si costruiscono le credenze. Senon viene soffocato da inutili vernici, il suo effluvioprofumer la casa di resina per sempre.L'acero adatto a fare i mestoli da polenta.Bianco, pulito, rispettoso del cibo, proprio un granlegno. per alquanto cattivello e si diverte unmondo a sbrecciare gli utensili all'artigiano.Il tasso un albero altezzoso e pieno di s. Du-rissimo, sfida gli attrezzi ridendo. Ha un colore ros-so sangue con fiammature stupende. Non accettaruoli umili e vorrebbe essere sempre trasformato inoggetto d'arte. I tornitori lo impiegavano per faregli arcolai da filare la lana.Il manico della scure deve essere di faggio per-che sopporta benissimo le torsioni. Pure di faggiole ciotole e i cucchiai. Lo si deve lavorare quando ancora fresco a causa del suo pessimo carattere:non sopporta il tempo che passa e a un certo puntodella stagionatura si chiude in se stesso diventandoinattaccabile. Esistono legni tristi che piangonoappena li sfiori. Ad esempio il giunco, o la vite sel-vatica. Con quelli si costruivano le culle ai neonati.Forse perch la vita stessa un lungo pianto.Dei tronchi da lavoro si adopera solo il primopezzo, quello che esce dalla terra. Non pi di unmetro e mezzo.Ero ancora bambino quando apprendevo que-sti segreti da un vecchio alto e taciturno. Potrei an-dare avanti per ore a descrivere l'anima delle pian-
-
te. In seguito, quella conoscenza torn utilissima almio lavoro di scultore. Augusto Murer, che guid imiei primi tentativi, espresse pi volte la sua am-mirazione per la competenza in materia di legnoche dimostravo quando andavo in autostop nel suostudio di Falcade a rubargli il mestiere. Rubai dal'75 all'85, anno in cui mor.Il nonno amava i boschi e tutto ci che essi re-galavano. Aveva allevato la famiglia adoperando iprodotti delle selve. Sempre con grande rispetto. Inprimavera mi portava con s quando andava a faregli innesti sugli alberi da frutta. Durante l'opera-zione esigeva che io compissi sempre un particola-re rito: mentre incideva col temperino il fusto perinnestarvi la nuova gemma, io dovevo tenere lemani serrate attorno alla pianta madre che, secon-do il suo pensiero, si sarebbe in qualche modo sen-tita protetta.Nel momento in cui la taglio - mi spiegava -ha dolore e le viene la febbre. Le tue mani l'aiute-ranno a superare la paura.Parlava con una tale convinzione che a voltemi impaurivo credendolo matto. Oggi provo lastessa impressione ai discorsi di certi protezionisti.Quando lavoro nel bosco mi piace ancora strin-gere le cortecce degli alberi con le mani.Anche all'acqua il nonno dava una sua conno-tazione. Non vero che l'acqua inodore e insapo-re: l'ho imparato da lui. L'acqua del rio Valdenerela definiva cruda. In quella sorgente mettevamo abagno i bastoni di nocciolo in modo da poterli fa-cilmente ridurre in strisce sottili per fare le gerle. un'acqua che rende il legno flessibile pi di tutte lealtre.Quando falciavamo i fieni sui prati delle Fon-tanelle, bevevamo un'acqua tenera che sgorgava daun cuscino di muschi. Scorrendo non faceva alcunrumore, sembrava olio. Quella era dolce.Non senti che quasi dolce?, ripeteva ognivolta.L'acqua della Cogara, sul monte Buscada, lasentiva amara. un'acqua freschissima.Fa digerire, affermava.Quella di Settefontane, invece, era medicinale.Sanava, secondo lui, i malesseri causati dalle sbor-nie. Doveva andare spesso a dissetarsi in quellafonte. La valle di Rodisegre offriva un'acqua bian-castra che guariva le distorsioni.Mio nonno sapeva dare vita a tutte le cose sem-plici. Una roccia qualsiasi, ad esempio, la definiva
-
a pasta tenera o dura. Pu sembrare ridicolo pensa-re a una pietra fatta di pasta tenera. Eppure, quan-do costruivamo i muretti che dovevano sostenerela terra dei ripidi campi, adoperava per i sassi que-gli aggettivi.Lui era cos. Durante il lavoro non parlava mai.Aveva fede ma non rispettava le feste, Pasqua oNatale per lui era lo stesso.Stava sempre chino sul banchetto ciccando iltoscano e mugugnando ogni tanto qualcosa di in-decifrabile. Usava l'ascia indifferentemente sia conla mano destra che con la sinistra.Mi insegn presto l'arte di intagliare oggettinel legno, ma io non mi accontentavo e fin da allo-ra cercavo di riprodurre la figura umana. Sulla par-te convessa dei cucchiai intagliavo con la sgorbianasi, bocche e occhi per farli assomigliare a dei vol-ti. Lui sorrideva e sottraeva dal mucchio comunequelle mie prime sculture. All'inizio mi istru nel-l'uso corretto della manera onde evitarmi il rischiodi lasciare le dita sul ceppo. Non si arrabbiava maimentre insegnava. Ricordo il suo viso buono, quasiingenuo.Poi il tempo pass e port nella sua scia l'eradella plastica. Correva l'anno 1962 e la testa delnonno cominci a non funzionare pi molto bene.Arteriosclerosi, dissero. In quel periodo noi tre fra-telli eravamo abbandonati a noi stessi e campava-mo assieme a lui e alla nonna. Una strana zia sor-domuta e nubile lavava i panni di tutti e pregava.Finch il nonno rimase in vita, la vecchia casa diErto era sempre intasata da montagne di truciolidentro ai quali ci infilavamo a dormire.Un giorno di quel '62 - era la vigilia di San Bar-tolomeo, patrono del paese - mio nonno part in di-rezione di Longarone con un grosso zaino sullespalle. Voleva andare a racimolare qualche soldoper la festa. Mosso forse da un oscuro presentimen-to, io lo rincorsi fino alla curva delle Spesse e lo ti-rai per la giacca nel tentativo di farlo desistere daquel viaggio. Per la prima volta mi maltratt: ilmale cominciava a incattivirlo. Con uno strattone siliber di me e riprese il cammino.Lo seguii con lo sguardo. Camminava deciso.L'indomani lo aspettavamo per la sagra del pa-trono. Era agosto, qualcuno ci aveva regalatoun'anguria e non volevamo spaccarla senza di lui.Vennero i carabinieri e ci comunicarono che eramorto. A Belluno un'automobile lo aveva investitomentre attraversava la strada.
-
Nel tascone della cacciatora, accuratamenteavvolto nella carta, gli trovarono il regalo che ci a-vrebbe portato: un pollo fritto da mangiare nel gior-no della ricorrenza. Era arrivato fin laggi a piedinell'illusione di vendere ancora una volta i suoi pro-dotti e nonostante la quieta follia che piano piano lostava prendendo non s'era dimenticato di noi.Aveva ottantatr anni. Sull'asfalto uno zainosfasciato, sparsi intorno cucchiai e mestoli di legno.
IL FAGGIO.
Il boscaiolo Santo Corona, detto Santo della Val,aveva sessantaquattro anni quando decise di ta-gliare il grande faggio. E il faggio di anni ne avevapi di trecento.Il padre e il nonno di Santo e forse anche ilbisnonno si erano riposati sotto la sua ombra.Il faggio regnava sull'intero bosco. Nessunoaveva mai osato abbatterlo per un motivo moltosemplice: l'albero stava sull'orlo di un profondo pre-cipizio che segna il confine orientale dell'aspra Valda Dach e i boscaioli temevano che segandolo sa-rebbe precipitato nel sottostante burrone arrecandoall'incauto taglialegna lo scherno dei colleghi, non-ch una grave perdita di legname per la famiglia.Ma questi rischi non costituivano un problemaper Santo della Val che nutriva cieca fiducia nellasua arte appresa fin dall'infanzia. Aveva incomin-ciato giovanissimo, quando aveva dieci anni, atagliare mughi nei boschi di Val Zemola assieme alpadre e al nonno e il genitore, intuita l'indole delragazzo, era sceso a Maniago dai famosi battiferroper farsi forgiare una piccola manera adatta alle gio-vani braccia del figlio. Da quei giorni lontani l'uni-co mestiere di Santo e il solo che sapesse fare, fuquello del boscaiolo.Era anche emigrato all'estero e aveva trascorsoparecchi anni a tagliar piante in Francia e in Au-stria. Si racconta che in Austria, il primo giorno dilavoro, qualcuno mise in dubbio la sua perizia conla scure. Lui non apr bocca. Lo videro affilare l'a-scia con pietra di Candia. Aspett la sera e, quandotutti i boscaioli furono radunati nel cortile della ba-racca-mensa, attir la loro attenzione con un richia-mo. Si rimbocc la parte inferiore dei pantalonifino sopra al ginocchio e, con un deciso, tremendo
-
colpo, diresse a piena forza la manera contro lagamba. Quando i boscaioli atterriti riaprirono gliocchi, convinti di vederlo senza l'arto, scoprironostupefatti che la micidiale rasoiata aveva asportatosolamente i peli del polpaccio. Una precisione cosdiabolica non si era vista, e da allora Santo vennerispettato. Forse solo una leggenda, ma da noi siama crederla vera.Rientrato al paese si mise in proprio, a lavorarda solo. Non volle mai fare societ con altri taglia-boschi: asseriva che in due si gi troppi, trannenel caso in cui il secondo sia una bella donna.Negli ultimi anni non tagliava pi legna perdenaro, ma l'amore verso i boschi teneva accesa inlui la passione per quell'antico mestiere.Si accontentava di procurarsi la scorta utileall'inverno e donava la legna in esubero a qualchevecchio bisognoso.Verso la met di un novembre freddo e limpi-do, prese la decisione di tagliare l'enorme faggio.Due motivi lo convincevano a farlo. Il primo eraun'idea che covava da anni: accettare quella sfidache nessun boscaiolo aveva mai osato raccogliere.L'albero stava sul precipizio e farlo cadere versomonte era impresa assai difficile. L'altro motivo,pi importante, era quello di abbreviare l'agoniadella pianta. Il faggio era stato visitato dal picchioche ne aveva bucato la corteccia aprendovi forigrossi quanto un bicchiere. Quando il picchio simette a bucare una pianta significa che questa alla fine: nelle fibre la vita malata e al centro il mi-dollo gi spento. Anche se in primavera l'alberometter nuove foglie sar solo per sorridere a quel-lo che gli rimane di vita: ancora qualche anno e poimorir. Nessuno sapr mai per quali misteriosepercezioni il picchio capisce quando una pianta staper morire. Lui la morte la vede in anticipo, quan-do non c' ancora nessun segno all'esterno. Inizia ascavare perch sa di trovare all'interno il legnomolle e marcito. Cos potr infilarsi facilmente neltronco e deporvi il nido.Santo della Val voleva abbreviare la sofferenzadella pianta, e cos decise. Spese la prima giornataa sistemare gli attrezzi. Affil la lunga sega munitadi maniglie alle estremit. Poi affil la manera, lamia manera: la mitica Mller che aveva acquistatoin Carinzia.Sono le manere pi buone del mondo - diceva.Hanno fusa all'interno una lamina d'argento perdissipare le vibrazioni.
-
Prepar anche dieci cunei usando un legnoduro e tenace: il maggiociondolo. Mise nel sacco lamanera di ferro. Quando tutto fu pronto, un mattinodi novembre - era il quattordici - si rec con gli ar-diti sul posto. Le foglie erano ormai quasi tutte ca-dute e i boschi, diventati trasparenti e puliti comu-nicavano l'idea di un quieto riposo. Il freddo, gisensibile, pungeva e nell'aria circolavano respiri diinverno imminente.Impieg mezza giornata a studiare l'albero. Sisedette a una decina di metri dal tronco e lo osser-v. Stim che alla base il diametro fosse di almenoun metro. Si accorse per la prima volta che il faggiopendeva leggermente verso il vuoto. Brutta fac-cenda - pens -, dovr usare il paranco.A circa un metro e mezzo d'altezza la cortecciarecava impressi dei segni. Erano il ricordo di vian-danti passati che con il temperino avevano inciso iloro messaggi. La linfa aveva guarito presto quelleferite e la pianta crescendo le aveva assorbite in s,rendendole quasi indecifrabili. Ma in mezzo a quel-la confusione di geroglifici, unico scampato allaforza del tempo spiccava netto e leggibile il segnodi un cuore con al centro due lettere: una M e unaF. And con la mente a cercare i due sconosciuti lecui iniziali stavano scolpite in quell'annuncio d'a-more da chiss quanti anni.Dove saranno finiti? - si chiese - Forse hannosmesso di amarsi, forse uno dei due morto, o en-trambi, o, se sono vivi, saranno comunque moltovecchi.Lo prese la nostalgia al pensiero che la vita nelsuo fluire consuma il corpo e spegne i sentimenti.Anch'egli una volta aveva inciso due lettere su unalbero nei boschi della Stiria, ma la cosa era finitamale e lui era rimasto solo.Accese la pipa e guard ancora il faggio. Que-sti a sua volta lo fissava solenne. La cima altissimanel cielo di metallo si muoveva lentamente all'alitodi una brezza leggera. Quel faggio secolare avevavisto camminare sotto di s generazioni di boscaio-li, passare file di montanari che andavano a falciarei fieni a casera Galvana o alle cime Centenere. Maiper un bambino s'era fermato a giocare con luiperch c'era il pericolo del burrone sottostante. Diquesto il faggio aveva sempre sofferto e non se laprese pi di tanto quando il picchio cominci apercuoterlo. A volte la vita ci colloca in posizioniche non abbiamo scelto noi, ma che ci costringono,nostro malgrado, all'isolamento perch costituiamo
-
un rischio per chi ci avvicina.A mezzogiorno Santo della Val, non senza unpo' di emozione, inizi il primo taglio. La luna dinovembre rimpiccioliva nella fase calante: il perio-do pi bello per il lavoro nel bosco. Con la sega amano, Santo pratic un taglio nell'albero dal latoverso il dirupo, facendo entrare la lama fino oltre lamet del tronco. Quest'operazione gli cost parec-chie ore di sforzi e quando sollev il capo s'accorseche il cielo imbruniva. Nascose gli attrezzi e si av-vi verso casa. Domani sar il giorno buono - pen-sava mentre scendeva dal costone -. Dovr staremolto attento: un abbattimento difficile. Se mainessuno si azzardato a tentarlo, significa che ilrischio di fallire grande. Basta un minimo errore emi andr gi nell'abisso. Ma io so come prenderlo.Ne ricaver pi di quaranta quintali di legna.Dorm poco quella notte. Il faggio lass lotormentava, vecchio e malato, ma ancora forte epronto a combattere. Quella torre ferma e silenzio-sa gli procurava una sottile angoscia. Sarebbe statomeglio vedersela con esseri in movimento cos dapoter tentare di intuirne i gesti o le reazioni. Chi stazitto e immobile guardando fisso senza reagiredisorienta alquanto, perch non lascia capire comeo quando far partire la mossa.L'indomani port su il paranco. Imbrag l'albe-ro a met altezza con le funi e fiss i capi attorno aun grosso ciocco. Dopodich, azionando la leva delmarchingegno, mise le corde in tiro. Piazz otto cu-nei nel taglio prodotto il giorno prima e con lamazza li picchi finch furono entrati bene. L'albe-ro tranquillo lasciava fare. Finalmente attacc conla Mller a battere colpi precisi e ritmati dal latoopposto al taglio della sega. Picchi molte ore, tan-to che la manera quasi scottava. Quando la presasull'attrezzo veniva meno, inumidiva con la saliva ipalmi delle mani e riprendeva con lena. Grosseschegge frullavano nell'aria e dopo un breve volosparivano nel baratro come stelle cadenti. Nellepause, asciugando il sudore, si concedeva una pi-pata e un sorso di vino.Mano a mano che la breccia si avvicinava al-l'ultimo diaframma la tensione in lui cresceva. Eracosciente che la sua azione stava per liberare l'im-mota potenza del tronco. Ogni tanto si allontanavauna ventina di metri per scrutare da distante se vifossero movimenti nel bestione. Nulla. L'albero erasempre fermo. Allora muoveva la leva del parancoa tendere maggiormente le funi per costringere il
-
tronco a inclinarsi verso monte, poi con la mazzapicchiava sui cunei in modo da non perdere nulladell'esilissimo spostamento guadagnato. Taglia,tira e batti, and avanti tutto il giorno. Verso l'im-brunire avrebbe potuto concludere, ma prefer ri-mandare all'indomani.Per oggi basta, pens.Quella notte dorm. Ormai era sicuro di averela vittoria. Gi sentiva i commenti ammirati dellagente perch era riuscito a fare tutto da solo.Il giorno successivo - era il sedici novembre -sal al bosco un po' pi tardi del solito. Mentre bat-teva i primi colpi, l'ansia venne a infastidirlo. Neaveva tirate gi di piante nella sua carriera, maancora non si era abituato alla visione di un alberoche cade. Quando comincia a inclinarsi si ha l'im-pressione di aver compiuto un delitto, di aver pas-sato il punto di non ritorno, la sensazione di qual-cosa di irreparabile. E si prova paura. Poi, dopo loschianto, tutto rientra nel silenzio.Gli ultimi colpi di manera scandivano il mezzo-giorno assieme alla campana del paese quandol'enorme faggio dette segno di vita e per la primavolta parl. Ebbe un sussulto che lo scosse fino allacima mentre dal ceppo alla base del taglio uscivaun tremendo scricchiolio. Pass qualche secondo etutto torn immobile. Dopo un po' per l'aria fil untenue lamento. Erano le funi del paranco che si ten-devano all'inverosimile. Santo della Val le fissesterrefatto.Ma come? - pens - se l'albero sta per cadere amonte le funi dovrebbero allentarsi, non tendersi!Invece le funi urlavano sempre di pi.-Maledizione! - imprec (anzi, per la veritpronunci una bestemmia) - Il vento! Non ho tenu-to conto del vento!Una brezza gagliarda infatti scivolava in quelmomento dai bastioni del Lodina ad accarezzare lavalle. Santo cap che la partita era perduta e inquell'istante si rese conto di essere vecchio e solo.Maledetto vento, sibil.Con le braccia protese verso l'alto si lanci con-tro la pianta nell'istintiva illusione di fermarne lacaduta contraria. Le funi scoppiarono liberandonuvolette di polvere che si dispersero nell'aria. Icanapi impazziti si lanciarono con guizzi da serpen-ti irritati a ghermire il boscaiolo. I cunei, schiacciatidall'enorme pressione, schizzarono fuori dal loroalveo come proiettili. Il bisonte del bosco ebbe unasbandata, si ferm un attimo, quasi ghignante, poi,
-
muovendosi come un'immagine ripresa al rallenta-tore, rovin nell'abisso con un boato assordante.Lo trovarono il giorno dopo, ancora abbraccia-to al tronco, avvolto in un groviglio di corde comeil capitano Achab alla balena bianca.Da quel giorno ogni anno a novembre, nellenotti di luna calante, in fondo alla Val da Dach, sisente picchiare la scure d'argento di Santo Coronaalle prese con il suo faggio per l'eternit.
LA MINA.
Ogni autunno si effettuava il taglio del bosco. Oc-correva procurare il combustibile per scaldare lecase nei lunghi inverni montani. Neppure oggi, cheil calore viene prodotto dal gasolio, i montanarihanno tradito la sana abitudine del riscaldamento alegna.Si tagliano prevalentemente faggi e carpini, maanche vecchi larici, ciliegi uccisi dalle gelate o altritipi di alberi. La raccolta non mai rapina selvag-gia e senza scrupoli, ma si effettua rispettando ilbosco quanto pi possibile. Si ha cura di abbatterele piante vecchie, quelle che mostrano segni inequi-vocabili di malattia - perch anche gli alberi s'am-malano e muoiono come noi - e quelle storte, incur-vate dall'ira dei venti. Oppure, dove la famiglia troppo numerosa, la si sfoltisce lasciando viveresolo tre o quattro fusti. Operando in modo intelli-gente e affettuoso i boschi crescono nello splendorerigoglioso della salute e regalano ogni anno unadignitosa raccolta di legna.Gli abitatori dei monti per, notoriamente abiliad 'usare quel cervello fino che s'accompagna allamano grossa, avevano intuito che il taglio compor-tava anche uno spreco. Segata la pianta, una partedi essa, il ceppo, rimaneva occultata sotto terra. Edil ceppo un materiale eccezionale: duro, compat-to, di forte resa calorica. Era un peccato lasciarlo lsotto. Il problema era come strapparlo all'abbracciodella natura, perch non poca la profondit in cuisi nasconde il nucleo originale dell'albero. La cep-paia si espande nel sottosuolo per qualche metroprima di dividersi in grosse radici che vagano incerca di cibo. Ai montanari, oculati risparmiatori edepositari di un senso pratico del vivere, non gar-bava che la terra si tenesse quel prezioso tesoro.
-
S'ingegnarono allora nel recupero degli enormiciocchi per cavarne legna da ardere e incominciaro-no a scavare per liberarli e trarli fuori dal loroalveo. Era un lavoro paziente e faticoso; quando ilterreno gelava, picconare diventava un gesto daforzati. Ad ogni colpo l'attrezzo rimbalzava irrita-to, mentre rabbiose schegge di terra e ghiacciosprizzavano sul viso. Per questa ragione era prefe-ribile scavare a primavera, col disgelo.Il ceppo non abbandonava la madre terra fin-ch l'ultima radice non veniva recisa. Una voltaestirpato occorreva pulirlo dai sassi incastrati pernon rovinare il filo degli attrezzi. Infine, con la segaa mano, tirandola uno di qua e uno di l, si riduce-va il mostro dai lunghi tentacoli in pezzi del pesogiusto per essere trasportati a spalle. Tutta l'opera-zione comportava un lavoro improbo che esigevatempo e fatica, e se di tempo c'era abbondante di-sponibilit, per la fatica non correva molta simpa-tia, allora come oggi.Il nome di colui che ebbe il colpo di genio diusare le maniere forti rimasto nel mistero. Io ho a-vuto la fortuna di aver zappato poco attorno aiceppi grazie a questo sconosciuto, inventore di unmetodo che fece lavorare la dinamite al posto no-stro. Durante la costruzione della diga era facileper i boscaioli, trasformatisi in solerti operai, farsparire qualche cassa di esplosivo. Credo che aquell'epoca quasi ogni famiglia ne tenesse unascorta come teneva la farina per la polenta. Proba-bilmente fu uno di questi lavoranti che applic perprimo l'uso degli esplosivi per divellere senza fati-ca le testarde radici dalla terra.Prima di raccontare questa storia di ingegno al-pestre, per il quale l'undicesimo comandamentoera "arrangiarsi", mi sono informato da un amicomagistrato per sapere se, a pi di trent'anni di di-stanza, quei lontani reati fossero caduti in prescri-zione. Avuta conferma positiva e dissipato il timoredi vedere un vecchio varcare la soglia della galera efinire dietro le sbarre, ho deciso di ricordare.Qualche giorno prima dell'"attentato dinami-tardo" effettuavamo un giro di ispezione per censi-re i luoghi dove le ceppaie da far brillare dormiva-no, strette nell'abbraccio del suolo. Curavamo discegliere quelle isolate per non danneggiare altrepiante nello scoppio. Scoperte le pi grosse, quelleche a prima stima promettevano di rendere un belpo' di legna, tornavamo a casa a preparare l'occor-rente.
-
Mio padre deponeva la quantit di dinamiteche riteneva necessaria in una borsa di tela da por-tarsi- a tracolla. Nella vita aveva fatto carriera comeminatore fuochino e sapeva con precisione quantomateriale serviva a dilaniare il ciocco prescelto.Molte volte bastava anche un solo candelotto ripar-tito in pi pezzetti. Insieme alla dinamite, riponevanella borsa anche un rotolo di miccia. I detonatori,che dovevano stare assolutamente separatidall'esplosivo, li metteva nel taschino interno dellacacciatora per proteggerli da urti accidentali.Io prendevo la trivella da tronchi. Era un at-trezzo speciale modificato appositamente per noida un fabbro del paese che vi aveva aggiunto, sal-dandolo per bene, un pezzo di asta d'acciaio, ren-dendo cos l'utensile pi lungo di quello che era inorigine, in modo da poter praticare fori molto pro-fondi. Io mi sentivo importante per essere chiama-to a far parte di quel gioco dalla potenza devastan-te. Anche se il mio compito era solamente quello difar girare la trivella, mi ritenevo un vero duro,rispetto ai miei coetanei.A turno ruotavamo l'attrezzo che s'infilava len-tamente nella polpa del tronco e, poco per volta,penetrava gi verso il cuore. Praticavamo dai tre aicinque buchi che sondavano le viscere del ceppofino a un metro di profondit. A quel punto, miopadre valutava la carica da impiegare e incomin-ciava a spezzare i candelotti. All'interno contene-vano una mistura gelatinosa simile per densit ecolore alla marmellata di ciliege. Le prime voltemio padre mi avvert di non respirarne l'odore perevitare forti mal di testa o addirittura leggere epi-stassi. Non ci credevo e volli provare: il malannoarriv, puntuale.Mio padre preparava quindi i detonatori, infi-lava la miccia nei piccoli tubicini d'alluminio grossiquanto una biro e lunghi circa cinque centimetri, ela bloccava schiacciando con i canini, che allorapossedeva, il bordo del detonatore stesso. Il tuttoveniva poi premuto dentro la pasta del candelottoche a sua volta scompariva, spinto da un bastonci-no, nel foro della ceppaia. I buchi si tappavano conl'argilla o con terra fina, avendo cura di non pic-chiare troppo forte col bastone. La lunghezza dellamiccia e quindi la sua durata veniva calcolata sullabase della distanza dal punto pi sicuro per ripa-rarci: la miccia era lunga se il posto sicuro era lon-tano, corta se vicino.Dopo aver collegato assieme tutte le cariche,
-
mio padre estraeva l'opinel, il temperino franceseoggi pi che mai in voga, e incideva nel capo dellamiccia un taglio per lungo, necessario per accen-derla meglio. A questo punto c'era il cenno d'intesaper fuocare. Prima per, per avvertire qualche even-tuale ignaro passante, lui lanciava a piena voce, al-lungandolo nel finale, il grido:La minaaaa...!Se nessuno rispondeva, dopo un po' accendevala polvere. Con uno scatto di serpe stizzita la cordas'inarcava e, con un sibilo inquietante, il fuoco par-tiva velocissimo all'interno del cavo, per andare araggiungere il centro dell'inferno. In quegli attimisospesi nella paura che qualcosa potesse andarestorto, in me scattava prepotente l'istinto di conser-vazione che mi faceva volare verso il luogo di ripa-ro. Mio padre invece, esperto conoscitore di esplo-sivi e affini, avanzava piano, arrotolandosi l'insepa-rabile sigaretta (non l'ha mollata neanche adesso,dopo due interventi alla gola per cancro da fumo).Non capivo dove trovasse tanta calma e tranquilli-t. Le prime volte, spaventato, lo incitavo a muo-versi urlandogli di fare presto.Lui non mutava il passo e arrivava da me lenta-mente, sorridendo sicuro.Invidiavo il suo coraggio che coraggio non era,ma sicurezza nella sua esperienza di minatore.Questo lo capii pi tardi. Col tempo e dopo parec-chie esplosioni precedute da precipitose fughe,cominciai a prendere confidenza con l'arte di PietroMicca. Un po' alla volta cominciai a fuggire sempremeno dalla miccia che bruciava. Volevo riuscire adominare l'affanno e a pormi in salvo senza correretutto agitato. Cercavo di resistere il pi possibilesfidando il tempo di combustione che scorreva ine-sorabile, ma ad un certo punto non reggevo pi al-l'angoscia e scattavo verso il riparo. Mio padresghignazzava beffandosi delle mie paure e a volte,per terrorizzarmi, mi teneva bloccato per i polsi vi-cino a s, impedendomi di scappare fino a quandonon gridavo per lo spavento.Acquisita un po' d'esperienza, imparai a gui-dare i cavalli dell'ansia e della paura, imponendo-mi di sostare ogni volta un attimo in pi nell'attesadella deflagrazione. Mio padre se ne accorse e in-nesc una sottile sfida, sempre nei limiti della sicu-rezza, per allenarmi all'esercizio della calma.Non devi agitarti, - ripeteva - non devi agitar-ti, neanche se stai per crepare, capito?Non era facile, ma dopo parecchie esplosioni
-
ragionate arrivai a scappare dopo di lui, se pureancora con qualche tremore. Negli ultimi periodi,difficilmente mi batteva e se ci capitava era per-ch astutamente avanzava dei dubbi sulla bontdelle micce, insinuando in me un sospetto di peri-colo che mi faceva perdere il confronto. In seguitoimparai a valutare da me l'efficacia dei materiali enon mi freg pi. Infatti a parit di coraggio io pos-sedevo maggiore velocit di gambe e lui dovevapartire prima se non voleva essere dilaniato. Unavolta lo umiliai dicendogli che se proprio insistevami sarei seduto sul ciocco innescato e vi sarei rima-sto fino all'esplosione. Non diger quella arroganteprovocazione e mi prese a calci. O forse si spaventcredendomi capace di farlo.Mentre eravamo al riparo attendevo trepidantel'esplosione che ogni volta mi prendeva di sorpresa.Nei minuti che la precedevano, la mente cercava disincronizzarsi con l'istante del botto ma non vi riu-sciva mai e la deflagrazione avveniva sempre im-provvisa e violenta da fermare il cuore.Nel cielo compariva un grande cerchio di fumoazzurro, mentre tutt'attorno si udivano i tonfi deipezzi di legno che ricadevano al suolo dopo esserestati sbriciolati e lanciati in aria a centinaia di metri.Il boato rimbombava a lungo per le valli. Nel luogodel vecchio ceppo scomparso si formava un cratereprofondo quanto una persona. Le schegge di legnosbrindellato giacevano sparse su un vasto raggio diterreno: per la prima volta dalla loro nascita eranoemerse nel fragore a vedere la luce del mondo.Sembravano brandelli di carne biancastra sputatadalle fauci di un mostro infernale.Il vecchio ed io radunavamo i pezzi in una ca-tasta provvisoria. Il compito di portarli a casa eraaffidato a noi ragazzi: l'artista della mina aveva or-mai esaurito il suo gesto creativo e non si degnavadi fare altro. Raccoglievamo le grosse schegge aduna ad una, caricandole nelle gerle e, un viaggiodopo l'altro, le trasportavamo a casa affastellando-le in ordine contro la parete rivolta a sud. Quando ipezzi di legno si erano asciugati, li spostavamo nel-la legnaia, liberando il posto per i morti dell'incur-sione successiva. Era un combustibile eccezionaleche sprigionava due volte tanto il calore delle pian-te in superficie.Questa attivit rumorosa si estinse silenziosa-mente dopo la tragedia del Vajont. Eravamo al cen-tro dell'attenzione universale e non era prudenteprovocare detonazioni. Riprendemmo il lavoro do-
-
po qualche anno di assistenza sociale: intanto era-no comparse le motoseghe e quasi tutto si adeguall'ordine legale. Personalmente non ho rimpiantiper quel metodo di lavoro, ma devo convenire chea quei tempi fu un'idea davvero esplosiva. Ognitanto, quando la fantasia tende al masochismo,provo a immaginarmi quella pratica applicata aigiorni nostri. Che effetto farebbe sentire, in un tie-pido meriggio d'aprile, la quiete della valle squas-sata da un boato impressionante? Scatterebbe laDigos per verificare di che cosa si tratta. E quandonoi, candidamente, le braccia penzoloni, confessas-simo agli agenti che stavamo facendo legna, forsesarebbero mossi a piet e molto solertemente, sen-za indugi, ci verrebbero in aiuto come ai tempi del-l'assistenza...
IL PERO E IL MELO.
Quando venne deciso di abbattere il pero e il melo,ci rimasi male. Per pi giorni tentai di convinceremio padre a lasciarli stare. Ma lui, mentre aspetta-va il calar della luna con la scure affilata, si ostina-va a ripetere che erano secchi in piedi e che nonservivano pi a niente.Era vero. I due alberi che segnavano il confinedel cortile erano morti da mesi. Anche se le radicicercavano ancora vita sotto la terra, sui rami noncresceva pi nulla. Le radici sono come le mammeche insistono fino alla morte nell'aiutare i figli indifficolt, ma il cocciuto senso materno non basta-va a far tornare i frutti sui rami rinsecchiti, e il ver-de del fogliame non ombreggiava pi la casa neigiorni d'estate. Solo il melo, a tarda primavera, riu-sciva a mettere ancora tre foglioline su un ramo av-vizzito, ma era una vita in apnea, di breve durata, ele foglie cadevano dopo pochi giorni.Avevano incominciato a lasciarsi andare quan-do fummo costretti dagli eventi a chiudere la casa epartire. Dopo il disastro del Vajont i superstiti furo-no sfollati in altri paesi, lasciandosi morire ancheloro un po' alla volta. Senza pi le voci della gente,viva, le mucche che si grattavano contro la cortec-cia, senza i volti della contrada, senza i bambiniche montassero sui rami a cogliere i frutti, il pero eil melo decisero che era meglio farla finita. E vennela malinconia ad ucciderli.
-
Quando tornammo dopo quattro anni, il cancroaveva gi le sue metastasi, ma sembrarono felici divederci. Si accorsero che uno di noi tre mancava e siintristirono un po'. Nei giorni che seguirono il no-stro ritorno ebbi l'impressione che volessero ripren-dersi, ma fu un breve guizzo di vita in quell'ultimaprimavera.Sono anche brutti a vedersi diceva mio padrementre gi stabiliva il giorno del taglio.Evidentemente la decadenza cancella l'affettonelle persone, altrimenti non saprei spiegare per-ch si portano i vecchi a spegnersi nella tristezzadegli ospizi. E perch si decide che un albero mortonon pi bello. Che non pi utile. Se la vecchiaiaabbruttisce il corpo umano, nelle piante diverso:un tronco secco, con lo scheletro fermo nel vento e irami che graffiano l'aria, una scultura bella e in-quietante, che fa riflettere. Inoltre pu ancora ospi-tare la sosta degli uccellini in volo. Eppure nei cor-tili, negli orti e nei giardini, gli alberi morti vengo-no abbattuti. Forse perch sta scritto da qualcheparte: l'albero che non da frutti va tagliato.Questo non avviene nei boschi dove il tempoche riduce in polvere le piante, piano piano, un po'alla volta, rispettandone la dignit.Ne pianteremo altri due, insisteva mio pa-dre, fermo nella convinzione che gli amici scom-parsi si possono rimpiazzare con altri nuovi.Per me il pero e il melo erano due vecchi e caricompagni. Si diventa amici di qualcuno o di qual-cosa prima di tutto per iniziale simpatia. Poi il sen-timento cresce nutrendosi col pane della vita. Di-venter forte dopo aver scambiato gioie, dolori, an-sie, paure, odio, amore, ovvero emozioni. Peccatoche con i nostri simili non duri molto: solo nella na-tura ho trovato l'intesa perenne, poich la naturaperdona sempre e sorride ai deleteri mutamentidell'animo umano.Assieme ai due alberi del cortile, ora minacciatidalla logica dell'uomo, avevo trascorso quel perio-do di tempo fondamentale che va dall'infanzia al-l'adolescenza. Per me non erano morti. Erano nudie malridotti ma non morti e mi parlavano ancoracon voce che esprimeva una lingua misteriosa edolce, sconosciuta alla moltitudine.Correva un mese che portava nel cuore le festepasquali quando il genitore decise che era ora ditirarli via. Tutti gli alberi l intorno avevano inizia-to la fioritura e solo i due sfortunati si mostravanomiseramente spogli: sembravano barboni in mezzo
-
a una folla di signori vestiti a festa. Nel tranquillo eordinato branco sociale i "diversi" si notano imme-diatamente e irritano l'acuto senso estetico dei vigi-li custodi dell'armonia del mondo. Allora si prov-vede ad emarginarli, isolarli, abbatterli poich essiemergono come fastidiose protuberanze nel piattomondo degli arrivati. E cos l'uomo, orrendo esserepensante e malvagio, s'arroga il diritto di deciderevita e morte su tutto il creato.Il primo colpo d'accetta tocc al melo. Era unVenerd Santo, una di quelle magiche giornate diprimavera in cui tutto prende vita e l'eterno pessi-mismo s'addormenta, mentre ti convinci che val lapena di restare. La scure, guidata dalla mano av-vezza a troncare, entrava decisa nei corpi senzavita delle piante.Mio padre mi chiese di aiutarlo nell'opera maio rifiutai. Ormai ero cresciuto, non lo temevo pi equindi potevo decidere con la mia testa.Quando caddero, le fragili ossa rinsecchite sifrantumarono liberando i ricordi rimasti impigliatifra i rami. Io nutrivo particolare affetto verso il me-lo. Da bambino ero stato letteralmente legato a lui:nell'adolescenza era il mio palo della tortura perso-nale. A mio fratello era stato assegnato il pero.Da ragazzi eravamo alquanto discoli e pergiunta la sorte ci aveva affibbiato un padre che cre-deva in folli metodi disciplinari. Ad ogni nostramarachella ci propinava una buona dose di olio diricino e, mentre avevamo ancora in bocca il saporeripugnante della purga, ci legava, uno al melo el'altro al pero, con le mani dietro la schiena. Ri-cordo l'odiosa boccettina piatta, dal bordo solleva-to, contenente due once dell'orribile bevanda. Erammento la disgustosa densit di quel liquidoche, ironia della sorte, non si poteva trangugiaretutto d'un fiato perch fluiva dalla boccetta al pala-to con una lentezza esasperante miscelando la tor-tura con la beffa.Credo che il nostro si possa annoverare fra gliultimi casi di gente costretta a ingurgitare olio di ri-cino per forza. A seconda del guaio combinato va-riavano i tempi di permanenza legati all'albero. Ladose di purgante invece rimaneva sempre la stessa.C'erano mancanze classificate gravi, come la di-menticanza di mungere le mucche, che comporta-vano fino a cinque o sei ore di prigionia. L'orologiodei fratelli Solari, alto sul campanile, distante unadecina di metri da casa nostra, scandiva il tempo dipenitenza. A volte cadevano improvvise dall'aria le
-
voci dei bambini che andavano a dottrina. Alloramio fratello, che si vergognava della sua umiliantesituazione di prigioniero, abbassava la testa finchnon erano passati tutti i monelli. Qualcuno di loro,approfittando della nostra impotenza, ci prendevain giro con sarcasmo o ci tirava sassolini - a volte ibambini, considerati il simbolo dell'innocenza, so-no capaci di una cattiveria disumana - guadagnan-dosi in cambio la promessa che appena fossimostati liberi l'avrebbero pagata cara.Un giorno, una vecchina di nome Angelica, cheabitava l accanto, usc armata di forbici, decisa aliberarci. Mio padre la affront malamente, conurlacci che la spaventarono, impedendole di agire.Si ritir sconfitta, ma prima di richiudere la portagli bisbigli un vergognati! che lo inchiod.C'erano stati anche momenti felici trascorsi frale braccia di quegli alberi. D'estate davano moltifrutti. Al momento giusto ci arrampicavamo d'unbalzo sui rami a cogliere pere e mele minuscole, madal sapore squisito. Capivamo a colpo d'occhioquali erano gi mature e con incursioni ripetuteogni due o tre giorni, non lasciavamo cadere un so-lo frutto.Arrancando su quelle cortecce, sbrindellando-mi la pelle delle gambe, ho compiuto da fanciullole mie prime arrampicate.Salivamo d'autunno, d'inverno, d'estate, quasitutti i giorni, per il puro piacere di trovarci in alto,sospesi nell'aria. Solo in primavera, durante la fio-ritura, ci veniva proibito di scalare gli alberi pernon rovinare il futuro raccolto.Sono sicuro che ogni alpinista ha iniziato la suaattivit da piccolo, inconsciamente, arrampicandosisugli alberi. E fra quei rami mi rifugiavo inseguitodalle ire di un vecchio del paese che, ronchetto allamano, cercava di farmi pagare salato il colpo fulmi-neo che gli aveva fatto schizzare via la pipa dallabocca sdentata.Tutti gli anni un cardellino costruiva il nido sulpero. Quando non spuntarono pi le foglie, l'uccel-lino se ne and.Un giorno pretesi troppo dalla resistenza di unramo, ma il bel colore giallo della pera lontana eratroppo invitante. Mi spinsi in fuori oltre i limiti del-l'incoscienza. Le dita sfiorarono il frutto. A queitempi credevo ancora nella fortuna: quel giornocapii che non dovevo. Realizzai per l'antico sognodell'uomo di volare. Atterrai malamente nella sot-tostante strada di S. Rocco slogandomi entrambe le
-
caviglie. Venni adagiato sulla panca del caminetto.Mio padre non mi chiese se stavo male ma mi rifiluna sonora dose di ceffoni per aver rotto il ramo.Queste visioni vagavano nel cortile ingombrodi rami quel Venerd Santo quando il pero e il me-lo, compagni di giochi e di pena, vennero abbattuti.Giacevano distesi sulla vecchia terra nutrice, ridottiin pezzi sparpagliati alla rinfusa. Per me erano staticasa, cibo, montagna, volo, aria, gioco, freschezza,fatica, gioia, dolore, affetto, pioggia, vento. Tutta laterra sta rinchiusa in un albero.Vibravano i tamburi della sera che annunciava-no la via Crucis vivente. Nel paese si perpetua dasecoli il rito che rievoca la morte di Cristo: all'im-brunire un uomo viene inchiodato su due tronchid'albero incrociati. Quel giorno fu costruita unacroce con legno di pero e di melo.
I TIRA-TAIE.
Dalla creazione del mondo, anno dopo anno, sonotrascorsi millenni e millenni, durante i quali si sviluppato sempre pi il progresso tecnologico.L'uomo ha spremuto dal suo cervello le idee percostruire marchingegni atti a risparmiargli la fatica:dall'invenzione della ruota ai giorni nostri statoun continuo susseguirsi di soluzioni tecniche teseverso l'ideale supremo di eliminare nell'uomo ognisforzo muscolare. E non sar mai finita. Oggi, sem-pre pi la ricerca continua, e riesce a produrre nuo-vi sofisticati macchinari anti-fatica.Si potrebbero citare moltissimi esempi, ma sa-rebbe noioso e anche inutile, perch la gente li co-nosce gi. Uno di questi splendidi lussi spianafati-che per mi impression alquanto quando lo vidiproposto dalla tiv, qualche anno fa. Si trattava diuna moderna abitazione, guarda caso americana,di non so quale miliardario di turno. In quella casa,l'occupante veniva prelevato sull'uscio da servito-ri-robot, lavato, imbeccato, coccolato, portato da-vanti al televisore, accudito come un bambino pic-colo, e infine messo a letto senza che mai dovessetogliere le mani di tasca.Nel caso si fosse trattato di un "single" afflittoda solitudine, bastava premere un pulsante - anzilo premeva il robot - e dalla parete usciva come perincanto una splendida bionda di plastica. Non si
-
specificava per se il fruitore si dovesse muovereda solo o essere tirato su e gi da qualche marchin-gegno.Meraviglioso progresso! Intendiamoci, non so-no contro il progresso, io. Anzi, piacerebbe anche ame avere una casa di quel tipo. Ma credo che la ro-vinerei in breve tempo perch ho la presunzione disaperne pi di chi l'ha inventata. Ad esempio sosti-tuirei subito la signora di plastica con una in carneed ossa, dando prova lampante di non aver ancoracapito niente di evoluzione e tranquillit.Comunque, di questo passo, a furia di studiareper inventare comodit, braccia e gambe serviran-no sempre meno nei secoli a venire, fino a scompa-rire del tutto, atrofizzate e assorbite dal tronco.Vivr allora sulla Terra una nuova specie di uo-mini priva di arti e fornita di teste rotonde smisu-ratamente sviluppate. Per spostarsi, quegli esseridovranno rotolare sulle loro stesse teste come fos-sero palle da bowling; rotolando pensieri e idee simischieranno in una paurosa confusione.Cos, una volta giunti a destinazione, questiuomini-testa non ricorderanno pi il motivo percui sono arrivati fin l.Scherzi a parte, il mondo s' tuffato da secolinel fiume vorticoso della tecnologia e non vuolepi uscirne. Ogni tanto per da quel fiume si di-vidono lateralmente dei rigagnoli pazienti e testar-di che intendono seguire una strada tutta loro.Questi ruscelli sono alimentati da quegli uomininon dico contrari al progresso, ma che cercano disopravvivere limitando al massimo l'uso di mezziartificiali. Costoro fanno parte della categoria deicocciuti e si possono trovare ancora in molti campiprofessionali. Conosco personalmente un discretonumero di questi dannati della fatica, di questisterratori di Platonov, di taglialegna con l'accetta(la motosega entrata ormai anche nei film dell'or-rore), di scrittori a mano, di camminatori a piedi, diamanti di donne normali. Ma quelli che prevalgo-no su tutti per volont, testardaggine, fatica, pa-zienza e senso artistico del tribolare, sono i boscaio-li trascina-tronchi, chiamati in gergo tira-taie. Sonoveri e propri cavalli umani: nell'esercizio del lorolavoro usano solamente la scure e un appositochiodo con anello da piantare in testa al tronco,una volta abbattuto e sfrondato, per poterlo trasci-nare a valle.Tirare tronchi dannatamente difficile. comecondurre l'esistenza prevedendone il futuro ed
-
quindi un'arte non da tutti. Occorre essere adde-strati a soffrire fin da piccoli. La pianta, mentre sci-vola dietro al tuo passo, viva e bene intenzionata,ma non pu evitare tutti gli ostacoli del percorso, equando non scorre pi, bisogna trascinarla. A voltetutto va bene e il tronco fila veloce e senza intoppi,ma pi spesso si impunta, si pianta col naso nel ter-reno, si ferma, si blocca di colpo segandoti la vo-lont nello strappo della frenata.Il tira-taie legato alla sua pianta dall'animadella corda di traino che gli trasmette tutte le vibra-zioni e quindi le reazioni del legno. Serve per unasensibilit finissima per sentire i messaggi del tron-co trascinato onde evitare le sue impennate e le suerabbiose reazioni. Pu succedere ad esempio cheun impedimento improvviso blocchi la corsa del-l'albero. Guai allora a tirare come forsennati, per-ch il tronco ceder di colpo mandando l'incautoschiavo con la faccia nella polvere. Senza conside-rare il rischio per il conducente di venire travolto.Una corda troppo corta far in modo che talloni ecaviglie del tira-taie vengano presto scorticati. Seinvece troppo lunga, funzioner da dissipatoredella forza impressa e la pianta coricata non si spo-ster di un millimetro.Tirare tronchi, come vivere, uno dei pochi la-vori in cui occorre impiegare le energie imprimen-do forza e togliendola allo stesso tempo. Questapratica paziente, faticosa e tenace ha modificato neltempo il viso dei boscaioli. Sui loro volti non appa-re mai la fretta, l'ansia di far presto, la rabbia ol'impazienza; vi si legge invece una pacata rasse-gnazione ed allo stesso tempo una determinazioneinfinita.Vedere un trascinatore di tronchi in azione pro-voca nello spettatore ignaro un particolare sensod'angoscia. L'immaginazione va agli schiavi dellepiramidi; si stenta a credere che alle soglie del Due-mila esista ancora una speciale razza di cavalliumani. Per semplificare tutto basterebbero la moto-slitta, il trattore, il filo a sbalzo, la teleferica o altrediavolerie.Ma proprio qui sta il senso del loro viaggio aimmenso. I salmoni per sopravvivere devono nuotarecontro le cascate e il saltatore in lungo per fare unimmane balzo deve andare indietro a prendere la rin-corsa. Il boscaiolo tira-taie cammina all'inverso pernon dimenticarsi che la vita sta nelle sue mani. In-tuisce che la pianta enormemente pi forte di lui,ma vuole condurla in porto con mezzi leali. Per
-
sentirsi vivo, ancora valido, ancora forte, non anco-ra vecchio, curioso sempre di sapere come andr afinire. Solo cos pu accettare sereno che la linfadegli anni gli scorra fra le dita.E quando la corda gli segher la spalla non sa-r troppo triste. Col tempo e con la pratica, ho im-parato molte verit dai trascinatori di tronchi ed hocercato di applicare nel vivere quotidiano la loro fi-losofia diventando a mia volta un tira-taie. In ungiorno lontano, uno di questi faticatori dell'inutile,che aveva letto molti libri e che odiava le storie do-ve si parlava di patate, mi disse citando un raccon-to di Borges:Vedi, noi camminiamo nella realt come quel-l'uccello della leggenda, caro ai boscaioli canadesi,che vola all'indietro perch non gli interessa vederedove va, ma ricordare da dove partito.
LE FOGLIE.
Ad ogni ritorno dell'autunno gli alberi lasciano ca-dere le foglie. Sono stanchi, sfiniti, disorientati dal-le carezze di bizzarre primavere e torride estati.Hanno sopportato pazienti, temporali, uragani,venti improvvisi e violenti e il sole di luglio che habrunito le loro chiome di un bel verde bronzo an-tico. Ora hanno voglia di riposare, riflettere e ap-prestarsi al sonno dell'inverno.In questa fase preparativa devono essere soli,perci lasciano cadere le loro foglie sulla terra. Pri-ma per di abbandonarle ai venti dell'autunno levestono con abiti splendidi, tinti di mille colori, cal-di e accesi. il loro ultimo regalo di genitori primache esse si disperdano, ognuna nel proprio ignotoviaggio. Ma alla nascita ogni foglia eredita geneti-camente le peculiarit del padre albero, cos che,all'avvicendarsi della morte autunnale, si pu capi-re, dal modo in cui le foglie cadono, il carattere diogni famiglia chiomata.Per rendersene conto basta andare nei boschi ilquindici di novembre, sedersi e ascoltare. Il fenomenoIncuriosir l'orecchio di tutti.Il larice solitario e malinconico, re dei costoniripidi, lascia cadere i suoi aghi silenziosamente, alminimo tocco di mano o alito di vento. Gli aghi nonvolano via ma si depositano ai suoi piedi con bru-sio lieve di finissima pioggia. Sono riconoscenti
-
verso il genitore e non vogliono morire lontano dalui.Vi poi diritto, liscio, bianco e bello, l'acero al-tezzoso. Le sue foglie, quando cadono, devono far-si notare, come il padre. Allora nel silenzio delbosco si udranno rumori secchi come di cartoccipesanti che piombano in terra. Da l le foglie vor-rebbero andarsene subito a farsi vedere anche al-trove, ma i giovani venti non le degnano di un sof-fio. Solo qualche vecchio refolo stanco e brontolonele muove un po' qua e l, per non sentirsi inutile.Il duro, contorto, stentato e ossuto carpino unessere timido e triste. Si vergogna della sua formasenza grazia e se ne sta in disparte, in luoghi im-pervi e pietrosi. Le sue foglie non fanno rumore amorire; cadono in silenzio e lo fanno anche di not-te. Quando sono sul terreno si nascondono tra isassi che danno vita allo sfortunato genitore.Il faggio, invece, da incosciente pazzerellone acui tutto va bene e non si scompone in nessunasituazione, si separa dalle sue chiome cos come vi-ve, con allegria e noncuranza. Le manda via riden-do, a sciami interi, leggere e chiassose, fluttuantinell'abito marrone scuro. Le foglie si sparpaglianodappertutto, senza il minimo rimpianto del luogonatio. Giocano coi venti capricciosi e preferisconoquelli bizzarri e violenti che le portano in ogni do-ve. Irridono alla morte, le foglie di faggio, e stannomolto unite al momento del distacco. Infatti quan-do Eolo si riposa nelle grotte di Bozza, si possonoincontrare nei luoghi pi strani cumuli enormi difoglie di faggio, gi pronte a ripartire.Il frassino, bello, elegante e pieno di classe, nonama la monotonia dei luoghi comuni e odia la linearetta. Cresce alto e sinuoso e nelle sue curve si pos-sono intravvedere forme umane. Non si separadalle foglie prima di aver insegnato loro la danza,ed esse, quando giunto il momento di andarsene,lo fanno con arte e senza rimpianti, scendendo interra girando e piroettando con grazia come virtuo-se ballerine. E non si fermano nel punto di cadutama vanno lontano, incontro al loro destino, sempreruotando armoniosamente.Ma se una di esse, mentre stai nel bosco, si po-sa per caso vicino a te osservala: noterai nel suo vi-so cartaceo la malinconia.Vi sono anche alberi egoisti, cinici, possessivi edominatori. Quelli che non vorrebbero mai invec-chiare e che, come certi genitori, esigono e preten-dono che i loro figli siano i pi bravi e i pi belli, e
-
che mai si allontanino da loro. Un esempio, fra itanti, l'agrifoglio. Sempre pulito, perfetto e inordine, eclatante nel contrasto tra le bacche rossosangue e le foglie sempre verdi. Il genitore le tienefissate a se stesso, estate e inverno, e si vanta dellasu splendida famiglia. Ma quelle foglie hanno ad-dosso la rabbia e il rancore di non potersi mai muo-vere, di non conoscere altre foglie e confrontarsicon loro. Sono diventate acide e scontrose comevecchie zitelle; il loro corpo si fatto ostile e ha pre-so linee nervose e cattive con il bordo dentato e spi-goloso. Sul loro viso non vi tristezza o malinconiama solo odio e invidia per le fortunate sorelle chepossono morire volando via.Le foglie del pioppo fanno parte della vasta ca-tegoria dei figli sfortunati. Il loro padre un alberodisgraziato: non ha nessun pregio, viene evitato datutti e non buono nemmeno per fare fuoco. Luitenta di consolarsi dicendo che dalle sue fibre nascela carta per i libri, ma dentro di s sa benissimo che una magra consolazione. Quando cadono, le fogliedel pioppo sono quasi gi morte. Vogliono farla fini-ta presto, ancora prima di staccarsi dai rami. Scen-dono molto veloci perch l'aria non le regge pi acausa dei buchi che una vita infelice ha aperto nelloro tessuto. Scompaiono presto nell'humus, e nelloro mesto volo non hanno pi alcun colore.Il maggiociondolo un albero nobile, fiero eduro. Non superbo come il noce o il tasso mamolto riservato: un genitore premuroso e fatalistache abbandona le sue foglie con decisione e le con-cede ai venti autunnali senza rimpianti. Esse ab-bracciano il terreno con dolcezza in gruppi di treper volta, tenendosi per mano come buone so-relle. Resteranno attaccate assieme per molto tem-po fino a quando il gelo della terra non verr a se-pararle. Nel frattempo il maggiociondolo si saraddormentato con la coscienza tranquilla.Il noce il pi antipatico, arrogante, superbo epieno di boria di tutti gli alberi che conosco. Nelmio lavoro devo vedermela spesso con lui e gli hochiesto il perch di tanta tracotanza. colpa vostra - ha risposto. - Siete stati voi,uomini incauti, a concedermi potere attribuendomitutti quei pregi che forse non ho. Come fate, del re-sto, con molte altre cose inutili. Assegnate valorisupremi e irrinunciabili a mille cretinerie per com-plicarvi la vita. Volete mobili in noce, pavimenti innoce, scale in noce, cruscotti di auto in noce, e per-fino la cassa da morto in noce. Con la vostra igno-
-
ranza e stupidit mi avete reso potente e ora ne pa-gate le conseguenze.Non risposi.Le foglie del noce scendono gi con clamore,sprezzanti e fracassone. Nemmeno morendo rinun-ciano a farsi una sfacciata pubblicit. Volano unitein rametti composti di nove sorelle attirando l'at-tenzione come per dire:Attenti tutti, stiamo crepando ma siamo fogliedi noce!Per si spengono con coraggio consolandosinella convinzione che tutto prima o poi deve mori-re. Una di loro, un giorno che si discuteva di morte,intu il mio timore e ghign:Non te la prendere, che anche la morte muore,perch quando si muore, muore con noi anche lamorte.Le foglie di noce non sono pi utilizzabili nem-meno nei lavori dei contadini a causa di una vec-chia storia.Una volta, il capostipite di tutti i noci del mon-do ebbe un diverbio con una mucca che si grattavacon le corna su per la sua corteccia. Volarono paro-le grosse perch neanche la mucca scherzava. Allora ilnoce stizzito decise di non concedere mai pi le suefoglie per fare il letto alle bestie. Da quel giorno seun contadino s'azzarda a usare come strame le fo-glie di noce, in poche ore le mucche che vengono acontatto con esse non danno pi latte.Non qui possibile, per ovvie ragioni di spazioe di conoscenza analizzare i momenti ultimi di tut-te le foglie della Terra. L'osservare questa realt pe-r mi ha fatto riflettere. Ho notato come sempre innatura esistano esseri fortunati e altri disgraziati,oppure brutti, potenti, miseri, simpatici, meschini ecos via. Anche nel regno vegetale, come in quellodegli uomini e in tutto ci che ha vita, c' chi muo-re in silenzio e chi se ne va con clamore di trombe.Ma so anche per esperienza che quando quest'in-verno andr a camminare nei boschi ormai spogli,di tutte quelle foglie non vi sar pi traccia. Colori,profumi, brusii, silenzi saranno scomparsi inun'unico, informe strato incolore. E verr allora laprima neve a coprire col suo bianco velo pietosoquei miliardi di morti diversi, diventati ora tuttiuguali.
-
ANIMALI.
IL CUCULO.
Il vecchio amico tornato. Quello che attendi ognianno con affetto riapparso. S' fatto vivo improv-visamente e, come al solito, ha ripreso a cantarenella selva.Il primo cuculo non manca mai all'appunta-mento. Ce ne sono tanti di cuculi nei boschi ma siha l'impressione che a cantare sia sempre uno solo.Che piova o nevichi, o scenda il vento dalle cresterocciose, lui puntuale. Un mattino d'aprile ti alzi,esci a prendere la legna per la stufa ed eccola,improvvisa, la voce del suo canto che apre il cuorealla gioia. Cuc, cuc. l'annuncio della nuova pri-mavera, dei germogli in fiore, dei nidi, del sole ra-dente, delle api, dei galli forcelli in amore, della vi-ta che rinasce.L'inizio dell'anno non cade il primo gennaio,ma nel mese d'aprile. Anche il ruscello riprende amutare scrollandosi di dosso gli ultimi frammentidi vetro, i cristalli ghiacciati dell'inverno che soffo-cano la sua voce.Un giorno mi trovavo sul passo Sant'Osvaldo,fra i paesi di Erto e Cimolais; dovevo salire il mon-te Lodina. Con me c'era un amico di Milano, cin-quantatreenne, ingegnere, a volte anche cliente d'arte edi roccia. Un sole nascente spintonava il MonteCornetto, voleva uscire fuori dal costone che lo na-scondeva. Il cuculo cant molte volte. Cant con lasua voce malinconica e un po' triste, con quella vo-ce dal suono vicino e dall'armonia cos lontana dasembrare un addio. Quella voce che pare ammo-nirci con dolcezza a non sprecare i giorni poich laprimavera dura poco.L'ingegnere non lo sentiva. Dovetti attirare lasua attenzione su quel canto. Allora lui, invece diascoltare, si impegn in una dotta e noiosa descri-zione del cuculo e delle sue abitudini. Mi fece pen-sare allo zelo di quegli aridi compilatori di guidealpinistiche che per spiegarti come salire sulla cimadi un monte cominciano col descriverti minuziosa-mente la sua composizione geologica. Se non lo
-
avessi fermato avrei finito col conoscere anche ilnumero delle piume che coprivano il volatile. Nonriuscii a evitare per di apprendere dall'erudito chela bestiola un parassita.Tutto ci non mi interessava; a me dava alle-gria udire il suo canto e basta. Al termine della gitail mio cliente non offr nemmeno una birra alla po-vera guida abusiva. E dire che parlava di parassiti.L'escursione si rivel diversa da come l'avevopensata.Il cuculo ritenuto un lazzarone perch depo-ne le uova nei nidi degli altri uccelli e poi scappa.La sua non una colpa: stato creato cos dal gran-de architetto cosmico. E se stato creato cos vi un motivo ben preciso. Perch scervellarsi per sco-prirlo? Forse il mondo troppo pieno di sapienzainutile: si impiegano anni di studi per capire comemai la formica si muove in un certo modo e intantosi perde la sensibilit nei confronti di quel piccoloinsetto quale parte del creato. Contemplare la for-mica semplicemente, sapere che esiste, vivere inarmonia il breve tempo che ci dato in questa vita.L'erudizione dell'ingegnere, oltretutto, si ac-compagnava a ridicole superstizioni. Alle Buse diLodina, si lev da un arbusto una civetta. L'amicoimpallid e dopo un po' sentenzi che ci aspettava-no giorni di disgrazie e di morte. A impressionarloin modo particolare fu il fatto che fosse apparsa digiorno. Io credevo che queste sciocchezze allog-giassero solo nella testa antica di qualche montana-ro. Ma andiamo! La civetta un'amica silenziosa eleggera, compagna discreta del camminatore not-turno. Vive ai confini della notte col giorno, guar-diano invisibile della vita e della morte. Dissi all'in-gegnere che io ero pronto a morire sempre e ovun-que, cantassero o meno le civette.Cercai di spiegare a quell'uomo sapiente e insi-curo che la primavera una stagione bella e diffici-le: una stagione di partenza.Ma pi gli anni passano e pi diventa arduoiniziare daccapo. Certi giorni di primavera il pessi-mismo vince su tutti i fronti. Arriva lo sconforto esi incomincia a fissare l'orizzonte. Perch in prima-vera siamo nuovi, siamo deboli, stiamo per partire.Giova allora sedersi in una radura, luogo magicodelle selve, dove il tempo si ferma sospeso; sedersie aspettare. Aspettare con calma, pazienti, magariassieme a un libro. Lui arriver presto. Cuc, cuc. una voce che scende gi, in fondo all'anima. Pro-prio gi, lontano, dove rare volte si viene visitati.
-
un sito non logorato dai tradimenti della vita, unangolino pulito in cui trovano salvezza i sentimentiche noi rincorriamo per uccidere. E in quei momen-ti capisci che val la pena insistere, che esiste ancoraqualcosa di buono, che si pu ancora restare.Il cuculo un vero amico. Uno che arriva sem-pre al momento giusto. Uno che con la sua malin-conia ti tira fuori dalla tua malinconia. Tutto il crea-to in simbiosi con noi nel semplice grande fine didarci una mano. Purtroppo va perdendosi sempredi pi l'antica istintiva capacit di percepire le vocie i colori della terra, e farne medicina. Basterebbeun geranio sul davanzale di casa per sentire il can-to del cuculo anche in citt. Ma occorre fermarsi eascoltare, magari solo pochi minuti al giorno. Pucapitare allora che all'improvviso si ritorni indie-tro, come al tempo in cui eravamo bambini e tuttoci sembrava bello. il canto del cuore che rispondeal richiamo del cuculo. il segnale che qualcosa andato gi, in quel luogo remoto dell'anima. Levoci di primavera sono il diluente che impediscealle scorie dei fallimenti, delle delusioni, del pessi-mismo di occludere il minuscolo passaggio versoquel magico luogo, verso quella terra lontana e an-cora pulita, sempre cos difficile da raggiungere,dove trovano rifugio i sentimenti buoni quando noili rincorriamo per ucciderli. Una di queste voci ilcanto del cuculo.
IL GALLO FORCELLO.
Quand'ero bambino, mio padre mi portava a cacciasui monti. D'autunno s'andava a camosci e caprio-li, d'inverno con le fiale di cianuro si uccidevanomartore e volpi, che lui chiamava con seria pro-nuncia i "nocivi". Nocivi a chi? - mi chiedo oggi.Quelle timide presenze, sempre furtive e discrete,batuffoli leggeri sulla neve, non nuocevano a nes-suno.A primavera invece, nei mesi di aprile e mag-gio, andavamo a galli forcelli. In questa dolce sta-gione i maschi vivono il periodo dell'amore ed quindi pi facile avvicinarli e colpirli. Una voltacresciuto e capita la bestialit di tale pratica hosmesso senza rimpianti; allora per era quasi d'ob-bligo raccogliere l'eredit dei padri, cacciatori o be-vitori che fossero, e guai a colui che, consigliato da
-
qualche favilla di sensibilit, osava rifiutarsi.Crescendo cos a dosi di brutalit, veniva alte-randosi nel codice genetico l'istinto buono di con-vivere con la natura. Ogni pratica malvagia diven-tava, dopo un certo rodaggio, cosa normale: da faree basta. Ma l'animo di un bambino come una la-vagna, e i segni strisciati sopra dal chiodo dell'espe-rienza non si cancellano pi. Anche se lo strofinac-cio del tempo li attenua un po', i solchi rimangonoper sempre. cos che nell'imminenza di ogni pri-mavera, come lupi mannari con la luna, i ricordi diquei tempi tornano a farmi visita, ironici e beffardi,e vorrebbero rimettermi il fucile tra le mani. Ma so-no spintoni che durano poco. I diavoli se ne vannopresto, lasciando il posto a memorie che riportanoa quei giorni lontani.Lunghe camminate al buio nelle notti ancorafredde d'aprile, che gi liberavano profumi di pri-mavera vicina. Mio padre mi diceva di parlare pia-no, ma la sua raccomandazione non era necessariaperch io avevo paura anche della mia voce. Misembrava che dal buio mille strani personaggi mispiassero, e non riuscivo a capire se erano buoni ocattivi. Pi tardi li avrei conosciuti: sono i gentilispiriti dei boschi diventati ormai la mia costantecompagnia. A quel tempo per mi mettevano unastrana inquietudine che non potevo comunicare amio padre, uomo pratico e rude.Nelle pause del cammino mio padre si accen-deva una sigaretta. Nel buio non vedevo il suo vi-so, ma solo il lumicino della brace che andava e ve-niva dalle sue labbra: lui non esisteva, era solo om-bra. Qualche volta, mentre fumava, mi raccontavaepisodi della sua infanzia, di come i cacciatorianziani fossero burberi con lui giovinetto alle pri-me armi e mi faceva capire che, in fondo, io potevoritenermi fortunato perch stavo con mio padre enon dovevo temere nulla. Non sapeva, e io nongliel'ho mai detto, la fatica e le paure che mi pren-devano durante quei percorsi notturni. Il pensieroandava al caldo lettino nella casa gi al paese dovedormivano, beati loro, i miei fratelli pi piccoli. Ioero il primogenito, perci toccava a me trovarmi l.Ogni tanto mio padre accennava alla mamma,ma sempre senza affetto. Prima che ci prendesse ilfreddo ci rimettevamo in marcia. Non si cammina-va mai veloci, per non arrivare alle poste troppopresto e dover aspettare l'alba nel gelo. Una voltagiunti sul posto, i preparativi si ripetevano sempreuguali. Mio padre approntava una trincea con rami
-
di mugo che piantava a semicerchio nella neve. Erail nostro nascondiglio per non essere individuatidal forcello. Io mi ingegnavo affinch questa opera-zione durasse a lungo poich sapevo che, una voltafinito il lavoro, bisognava sedersi e aspettare im-mobili fino alla nascita del giorno l'arrivo dei for-celli. Qualche volta per si arrivava alla posta trop-po veloci. Valutato l'anticipo, mio padre si arrotola-va ancora una sigaretta e poi, per ore, si stava ferminel gelo e nel silenzio. Quando si accorgeva cheincominciavo a tremare mi domandava ironico:Non avrai mica freddo?Gi sapeva che io non gli avrei mai risposto dis. Era il frutto dei suoi insegnamenti: non lamen-tarsi mai. Allora lui si toglieva la giacca e me lametteva attorno alle spalle, e in quel nuovo, brevetepore mi addormentavo.A volte nel buio lo sentivo come una personaestranea e malvagia, e lo odiavo. Ma quando la lu-ce del primo mattino illuminava il suo viso sempli-ce, tornavo a volergli bene.Un tenue chiarore annunciava la fine della not-te. Si udivano i primi cinguettii: le bestie si sveglia-vano. Voli di gufi sembravano aliti di fiato vicinis-simi. Versi strani, rumori secchi, come caduti dal-l'alto; poi, improvviso, possente da mettere paura,si udiva il soffio del forcello che sfida il rivale. unmomento intenso ed emozionante: sembra di senti-re un essere umano che lancia un roco ghigno. Lapresenza fredda e guardinga di mio padre mi rassi-curava. Poi lui imitava il verso di un rivale. Brevispazi di tensione, e il gallo si lanciava con tutta lasua furia verso di noi. Era questione di attimi e ilbotto assordante della fucilata rompeva il magicosilenzio dell'alba. Per me era un momento dram-matico: il boato si ripeteva nelle valli e mi sembra-va che tutto il mondo ci avesse scoperti e localizza-ti per via di quel colpo. Mi assaliva un'agitazioneincontenibile: immaginavo guardiacaccia e carabi-nieri venire verso di noi, e qualche volta capit perdavvero. Come un razzo mi precipitavo a racco-gliere il povero gallo forcello - le sue piume vibra-vano ancora nell'aria del mattino - e correvo piche potevo verso un punto sicuro e lontano dalluogo del misfatto.Mio padre mi raggiungeva lentamente, soddi-sfatto, fumando la sua sigaretta. Sollevava il forcel-lo per il becco e, tenendolo sospeso, gli sistemava ilpiumaggio lisciandolo dall'alto verso il basso. Seera un vecchio esemplare con cinque penne storte
-
nella coda, mio padre appariva molto contento. Iorimanevo triste per qualche tempo.Dopo la caccia avevamo tutto il giorno a dispo-sizione e mio padre mi portava sulle cime pi facilidei monti circostanti.Lass - mi diceva - il sole arriva prima e pos-siamo vedere dall'altra parte.Infatti, una volta saliti, noi eravamo gi in pie-no sole mentre sulle lontane pianure friulane co-minciava appena a sorgere l'alba.Quando il giorno era ormai pieno ci calavamonel bosco per accendere il fuoco.Mio padre era un mago in quest'operazione.Affermava che bisogna essere capaci di accendereun fuoco anche sulla neve. Andava a rovistare sot-to giganteschi pini, intrufolandosi tra la neve e i ra-mi come un topo e ne usciva con un pugno di stec-chini bianchi non pi grandi di un fiammifero; poitornava ancora con dei pezzetti pi consistenti.Tutto veniva disposto con ordine: alla base i pisottili, quasi dei fili di legno, poi quelli medi e viavia quelli pi grossi. Nella costruzione a castellolasciava aperto un buco per infilarvi la carta. Poidalla giacca alla cacciatora tirava fuori un giornalee ne strappava solo un lembo.Mai sprecare! diceva.La sua giacca di fustagno scuro era un magaz-zino: spago, carta, temperino, cartucce, binocolo,formaggio, pane: tutto stava l dentro. Col fiammi-fero incendiava la carta sotto i legnetti: comparivaprima un sottile filo di fumo azzurrino che duravaqualche attimo, poi la fiamma amica prendeva for-za sempre pi velocemente.Accanto al fuoco mangiavamo un boccone e ciscaldavamo, non prima di aver nascosto accurata-mente fucili e prede. Io tentavo di non incrociaremai lo sguardo di mio padre, perch sapevo checercava di capire le mie emozioni, e guai se questegli rivelavano un segno di debolezza o di piet perla bestia uccisa. La sua reazione era dura e beffarda:Sei una trapala, un buono a nulla - diceva.Devi lasciare perdere i rimorsi, senn quandosarai grande farai una povera vita. Rimorsi e rim-pianti sono come rami che intralciano un sentiero -replicava - se non li spezzi quando ripasserai di l tiintrigheranno di nuovo.Ma sui sentieri i rami ricrescono e i sentimentismarriti ritornano. Altrimenti non saprei spiegare ilsuo sguardo triste e lontano di questi ultimi anni.Sotto la guida di quel maestro inconsapevolmente
-
cinico e duro, ho fatto cos, a otto, nove anni, le mieprime esperienze sulle montagne. Spesso, nei ricor-di di quei giorni, ritornano prepotenti le visioni deigiganti di pietra dorati dal sole del mattino. Pochianni dopo ho incominciato a scalare quei monti chemio padre, alpinista limitato, non aveva potuto far-mi salire. In seguito la padronanza della tecnica el'allenamento mi hanno portato a raggiungere tuttele vette che ho voluto. Ma la conoscenza ha ir-rimediabilmente dissolto il fascino di mistero e lon-tananza che aleggiava tra quei picchi un tempospiati dalla valle, e su cui avrei voluto rifugiarmidopo aver ucciso il gallo forcello.
LA VOLPE.
Gennaio e febbraio erano i mesi della volpe. Neglianni difficili la caccia ha avuto un ruolo fondamen-tale nell'apporto di alimenti ricchi di proteine perla parca mensa dei montanari. Oltre alle prede chefornivano carne, ve ne erano altre fonte di essenzia-li guadagni in moneta.Si cacciava tutto l'anno e le stagioni decideva-no quale tipo di selvaggina concedere. Aprile emaggio offrivano, al prezzo di sacrifici, galli forcel-li, cedroni e lepri bianche. Nei mesi estivi vi era unpo' di stanca ma qualche capriolo, coturnice, fran-colino o pernice non mancava. In novembre e di-cembre era tempo esclusivamente di camosci. Gen-naio e febbraio invece esigevano infinita pazienzanella cattura, con le fiale al cianuro, dei nocivi ed inparticolare delle volpi.La carne di questi animali non si mangiava,anche se c'era qualcuno pi affamato degli altri chelo faceva. Prima di cibarsene per immergeva lacarogna della volpe o della martora nell'acqua delVajont, e ve la lasciava per almeno due giorni a sba-tacchiare nella corrente, trattenuta da un filo diferro, in modo che si frollasse. Solo cos diventavapassabilmente commestibile. Ma questi "mangiatoridell'impossibile" erano rari: il motivo principaleper cui si cacciavano le volpi era la loro pelliccia.Quando avevamo raccolto una decina di pelli,mio padre le portava a Longarone da Checo Franzche le pagava assai bene. Non dovevano avere pernessun buco, nemmeno piccolissimo, n traccia diferita, altrimenti la loro quotazione precipitava, con
-
nostro disappunto, a meno della met del loroprezzo. Per questa ragione si faceva uso delle infal-libili fiale al cianuro. Venivano fabbricate in Austriae arrivavano racchiuse in confezioni di sei, in unascatolina molto sicura, sistemate ciascuna in un ap-posito foro e protette dagli urti con batuffoli di co-tone. Erano ampolle di vetro delicatissime, grandicome un fagiolo, con le estremit appuntite. L den-tro c'era il liquido mortale. Ce le procurava un me-dico che, in virt della sua professione, le potevaavere con facilit.La preparazione dei bocconi avvelenati avveni-va di giorno. Le micidiali leccornie si confezionava-no con scarti di carne fresca, in questo modo: ac-canto al fuoco del camino, mio padre faceva scalda-re del sego e prima che incominciasse a fondere,quando era appena pastoso, vi infilava con estremacautela la fiala, pizzicandola tra pollice e indice.Era il momento pericoloso dell'operazione. Il vec-chio si concentrava al massimo mentre manovravala morte. Io mi tiravo indietro di qualche passo perassecondare la saggia regola del "non si sa mai". Seper un qualsiasi motivo la fiala si fosse spezzata, ivapori sprigionati sarebbero stati letali per entram-bi. Allontanandomi mi assicuravo qualche speran-za e, rispettando l'anzianit, concedevo al genitorel'onore di cacciare le volpi nell'oltretomba.Vederlo maneggiare con disinvoltura, anche secon prudenza, quello strumento di morte mi affa-scinava. Durante l'operazione il suo volto diventa-va tirato e le palpebre restavano immobili: sembra-va un uomo di legno. Operava seduto, muovendosolamente gli snodi dei polsi con le braccia appog-giate alle ginocchia e il busto perfettamente immo-bile. Dopo la mossa cruciale, forse per scaricare latensione, raccontava ogni volta sempre la stessastoria, di un cacciatore suo amico, scampato permiracolo all'accidentale rottura di una fiala. Pro-babilmente era una balla, perch al cianuro non siscampa.Con il sego contenente il liquido avvelenato for-mava una pallottola grande quanto una noce chepoi avvolgeva in un pezzo di carne dalle di-mensioni di un pugno. Il primo boccone era pronto.Ne confezionava una decina, a volte anche di pi.Quando la sera era prossima controllavamo ilfunzionamento delle lampade a carburo, le stesseche usavamo nelle notti di marzo per andare a ra-ne. Partivamo al buio proteggendoci dal gelo conindumenti pesanti. Io mi infilavo il "pastrano da
-
volpi", un tabarro di mio nonno che mi avvolgevafino alle caviglie.Il mio compito consisteva nel portare la pertica.Era un bastone lungo quattro-cinque metri all'e-stremit del quale stava fissato con alcuni giri dispago un vecchio mestolo. Percorrevamo tutto ilgreto del Vajont e a volte ci spingevamo fin nellavalle omonima dove, come un filo d'argento, pren-de vita il torrente. Un tragitto che durava a voltetutta la notte. Nei punti stabiliti, mio padre depo-neva il boccone traditore nel mestolo dell'asta cheio tenevo orizzontale, ed io, piano piano per nondanneggiarlo, lo scodellavo con delicatezza sullaneve.La lunghezza del bastone teneva le nostre trac-ce a discreta distanza dalla terribile trappola ali-mentare, facendoci guadagnare qualche punto sul-la proverbiale furberia della bolp, come noi chiama-vamo la volpe.Finito il giro tornavamo a casa che era quasil'alba. La nonna aveva gi acceso il fuoco sul larin,il focolare, ravvivando le braci nascoste sotto la ce-nere. Fino al mattino dopo potevo stare in pace. Maa partire dal giorno successivo alla deposizione deibocconi, incominciava una snervante odissea chepoteva durare anche dieci, quindici giorni.Occorreva partire prestissimo, sul filo dell'al-ba diceva mio padre. Muniti di binocolo rifaceva-mo tutto il percorso ispezionando da lontano lespecialit al cianuro, una ad una. In fondo alla val-le, il Vajont respirava tranquillo emettendo dalleanse leggeri vapori di nebbie che a contatto col ge-lo dell'inverno formavano un delicato giardino dicristalli e piume ghiacciate, ricamando i ciottoli diincredibili arabeschi. I cespugli decorati dalle bru-me congelate apparivano in lontananza come pic-coli ciuffi di nubi sospese, e su tutto regnava un si-lenzio incantato.Il nonno mi raccomandava di trovargli, in queiluoghi, le pietre per affilare gli utensili. Mi avevaspiegato di individuare quelle, peraltro rarissime,su cui non s'attaccava mai la brina e che, una voltabagnate nell'acqua, assumevano una tinta colorfegato. Qualche volta ne trovavo.Muovendoci gli scarponi frantumavano i fanta-stici fiori di neve, polverizzandoli con un glacialecroc-croc che trasmetteva il freddo in tutto il corpo.In prossimit di ogni trappola mio padre alza-va il binocolo puntandolo sul sito. Guatando dalbasso verso l'alto io potevo studiare il suo volto
-
senza che lui se ne accorgesse. Parlava a boccachiusa e solo dalle smorfie capivo che la preda nonera stata fulminata, che lo aveva beffato ancora unavolta.Prima di riprendere il cammino a ispezionare ilboccone successivo, abbassava le lenti dello stru-mento e lanciava verso la furba bestiola lontana ti-toli irripetibili come vengono usati di solito per ledonne di malaffare. In genere concludevamo il con-trollo verso mezzogiorno e poi, piano piano, torna-vamo verso casa scornati, avanzando taciturni nel-l'ovattato silenzio dell'inverno, ciascuno immersonei propri pensieri.Questo gioco a chi era pi furbo poteva durareintere settimane e caricava mio padre di una rabbiae di un'impotenza tali che cominciavo a temere perla mia sorte. Dovevo stare attento a non sbagliarenulla di ci che mi ordinava; mi toccava prevederetutte le sue possibili reazioni alle mie mosse e quin-di inventare subito contromosse di salvataggio co-me in una goffa e per me pericolosa partita a scac-chi, al fine di evitare il pi possibile la posta ingioco: formidabili calci nel sedere. A volte permio padre non s'atteneva alle regole e, rovesciandola scacchiera, tirava la ragione dalla sua parte, no-nostante la mia mossa vincente. I suoi fallimenti, lesue frustrazioni, la sua rabbia repressa contro ilfurbo animale che ci faceva sfacchinare tutte lemattine a vuoto, contagiavano anche me, e un po'alla volta cominciavo a travisare la realt. La volpecessava di essere l'umile e discreta bestiola che difatto , per diventare un'astuta, cinica e imprendi-bile nemica. Pi collezionavamo giorni infruttuosie sconfitte brucianti, pi la bestia assumeva contor-ni misteriosi e lontani e, come in un sogno fantasti-co, cominciava a prendere forma umana. Si accu-mulava allora prepotente in me la voglia di vederlastesa, di poterle mettere le mani addosso, di sentireaffermata finalmente l'abilit di mio padre derisacontinuamente, giorno dopo giorno.Le volpi sono come le donne diceva cinico ilvecchio, che allora non era tanto vecchio, ma che ame sembrava molto vecchio, ma prima o dopo cicascano.Io ancora non capivo, ma qualcosa sospettavo,ascoltando quei beffardi riferimenti.Finalmente, dopo appostamenti interminabili epazienti ispezioni condotte giornalmente in com-pagnia del freddo, e ronde notturne illuminate dal-la luna di gennaio, che si diceva facesse muovere le
-
bestie, qualc