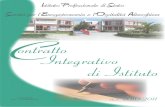contratto
description
Transcript of contratto
SALVATORE MONTICELLI
Rescissione per lesione e transazione (*)• Sommario: 1. Contratto soggetto a rescissione per lesione e transazione: individuazione delle
problematiche emergenti. - 2. La tesi dell'inammissibilità della transazione, analisi delle argomentazioni a sostegno e confutazione. - 3. L'offerta di reductio ad aequitatem del contratto rescindibile come proposta di transazione: limiti e necessarie puntualizzazioni idonee a fondare un sostanziale distinguo. Posizione ed analisi del problema connesso relativo all'entità dell'offerta ed alla tutela del contraente leso. - 4. Segue: prospettazione analoga in ordine all'ammontare delle reciproche concessioni oggetto dell'accordo transattivo sul contratto lesionario e differenti conclusioni.
1. - La sensazione che si prova nello scorrere le disposizioni che regolano l'istituto della rescissione del contratto è quella di trovarsi dinanzi ad un puzzle mal riuscito i cui singoli pezzetti siano stati combinati insieme da un bimbo che, stanco di pensare, abbia deciso di finire in ogni caso il quadro rassegnandosi a che, in una sia pur piccola parte di esso, i prospetti e i panorami si confondano, ma sicuro che questa disarmonia non turberà la buona armonia dell'insieme. La sensazione si rafforza se poi si riflette sulla collocazione sistematica della rescissione alla fine della parte dedicata alla patologia del contratto, dopo la trattazione della nullità e della annullabilità di esso, laddove il legislatore, superando l'ambiguità della codificazione preunitaria, ha trasfuso nell'impianto normativo dei due istituti una scelta precisa fra l'atto nullo e quello annullabile preoccupandosi di tracciare dei confini che, sebbene come da molti si osserva (1), qua e là si assottigliano, trovano nella sussistenza e reciprocamente nell'assenza di talune norme punti assolutamente fermi.
D'altra parte non è senza significato la sola monografia (2) che ex professo si occupa d'indagare l'istituto della rescissione, operandone anche un'assai informata ricostruzione storica, apra e chiuda la trattazione con una sconfortante proposizione negativa: la rescissione «non si sa come sia nata, non si sa cosa sia, non si sa cosa ci stia a fare» (3) e, ancora, rileva, essa «non è seconda a nessun altro istituto come generatrice di problemi» (4).
Questa dura sentenza, invero, si mostra veritiera anche relativamente al limitato oggetto delle brevi note che seguono, dedicate alla possibilità o meno di transigere la lite instaurata o da instaurarsi in dipendenza di un contratto soggetto a rescissione per lesione.
Sia dato anticipare che la questione è stata perlopiú affrontata sia alla luce del disposto dell'art. 1451 c.c. che esclude l'ammissibilità della convalida dell'atto rescindibile sia dell'art. 1450 c.c. che invece ne permette il recupero attraverso una offerta di modificazione lo riconduca ad equità; i termini del contrasto in ordine all'ammissibilità o meno della transazione riflettono, come si vedrà, la maggiore enfatizzazione della portata dell'una o dell'altra norma richiamata. Va, però, sottolineato che se quella appena accennata è certamente la questione da cui occorre partire, si delineano poi a catena un'altra congerie di problematiche succedanee, meritevoli di tale aggettivo solo in quanto danno per presupposta l'ammissibilità della transazione: c'è da interrogarsi, ad esempio, sul se la transazione relativa al contratto rescindibile e la modificazione conclusasi in via stragiudiziale di quest'ultimo a seguito dell'accettazione dell'offerta di reductio ad aequitatem siano due vicende sostanzialmente analoghe tanto da poter qualificare l'offerta di modificazione come una proposta di transazione.
Che la questione sia niente affatto solo teorica ed ossequiosa ad un mero intento classificatorio si evince, a tacer d'altro, dal diverso orientamento, specie della giurisprudenza (5), in ordine alla entità dell'offerta di integrazione della prestazione (tale che quest'ultima pareggi l'altra) richiesta per paralizzare il rimedio rescissorio rispetto, invece, alla possibilità di determinare nella piú assoluta libertà le reciproche concessioni oggetto della transazione che investe il contratto rescindibile. C'è ulteriormente da chiedersi, poi, se la transazione in oggetto debba, come accade per altre ipotesi in cui sia relativa ad una
negoziazione viziata (ex art. 1972 c.c.), essere necessariamente novativa o, piuttosto, sia possibile effettuare, rispetto al contratto rescindibile, anche una transazione semplice; in tal caso, però, poiché il rapporto conserverà pur sempre il suo fondamento nel contratto rescindibile stante l'inidoneità fondante del negozio transattivo, ci si dovrà chiedere se possa sempre completamente prescindersi dalla valutazione delle reciproche concessioni rispetto all'antecedente assetto delle prestazioni a carico delle parti cosí come sancito nel contratto rescindibile.
È chiaro, allora, che il panorama dei problemi emergenti circa la possibilità di transigere sulla negoziazione rescindibile è tutt'altro che esiguo; allo studio di essi nelle notazioni che seguono vorrei dare un contributo.
2. - Si è detto che l'ostacolo normativo che si oppone, da taluna dottrina, alla possibilità di transigere in merito ad un contratto rescindibile, sarebbe dato dalla impossibilità di convalidarlo sancita dall'art. 1451 c.c. (6). Con tale norma, infatti, il legislatore avrebbe escluso ogni diritto di disporre della rescissione del contratto che, pertanto, non potrebbe essere oggetto né di rinuncia né di transazione che, come è noto, può solo coinvolgere diritti non sottratti alla disponibilità delle parti (art. 1966, comma 2°, c.c.). Da altri (7) si fa notare poi che l'ammettere la possibilità di transigere è affermazione pericolosa tenuto conto che la transazione conclusa non sarà a sua volta impugnabile per rescissione, con la facile conseguenza che il contraente leso, versando in stato di bisogno, potrebbe essere costretto anche all'accordo transattivo perdendo, cosí, pure la tutela rescissoria.
Tralasciando, per il momento, ogni commento sulla osservazione da ultimo riferita che, a parere di chi scrive, denuncia una fondatissima preoccupazione che conferma la natura «infida» dell'istituto della rescissione, si dissente invece, senz'altro, dalle argomentazioni teoriche portate a sostegno della tesi dell'inammissibilità, peraltro pressoché isolata in dottrina e in giurisprudenza.
La prima forte argomentazione a sostegno dell'ammissibilità della transazione si rinviene nella considerazione che la ratio del divieto enunciato dall'art. 1451 c.c. non soccorre per l'ipotesi in cui la controversia relativa alla rescissione divenga oggetto di transazione: infatti con la convalida, ed indipendentemente dalla natura che variamente la dottrina le attribuisce (8), rimane del tutto inalterato quello squilibrio fra le prestazioni oggetto del contratto a cui il legislatore permette di porre rimedio conferendo al contraente leso l'azione rescissoria o, in alternativa, attribuendo all'altro contraente la possibilità di impedire la rescissione attraverso l'offerta di modificazione equitativa della propria prestazione tale da ricondurre il rapporto ad equità. L'idoneità della convalida a «fissare» e non certo a modificare l'iniquo rapporto fra le prestazioni spiega facilmente la ratio del divieto, cosí come di esso giustifica, nonostante il silenzio del legislatore, l'estensione alla rinuncia puramente abdicativa dell'azione di rescissione.
Le riferite considerazioni non soccorrono per la transazione non tanto, però, come da alcuni si sostiene (9), per il motivo che essa necessariamente interverrebbe a modificare la situazione preesistente, «aliquo dato seu retento seu promisso», per il che la prestazione data o promessa al contraente leso in corrispettivo alla rinuncia alla domanda di rescissione finirebbe per comportare necessariamente quantomeno una riduzione dello squilibrio che connota le prestazioni del contratto rescindibile, quanto piuttosto per la funzione che esplica la transazione di comporre la lite attuale o potenziale; ciò, come opportunamente si sottolinea dalla Cassazione, avviene «non attraverso un regolamento il piú possibile congruente con la situazione giuridica controversa (perché in tal caso si avrebbe un negozio giuridico di accertamento)» (10) bensí con la costituzione di un regolamento negoziale nuovo «nel quale non gioca solo la considerazione di quella che è stata la rispettiva posizione economica delle parti nel contratto rescindibile, bensí anche la previsione di quello che possa essere l'esito della lite» (11). In altri termini, la ragione dell'ammissibilità della transazione non va individuata nella idoneità di essa a ridurre ad equità l'assetto di interessi come regolamentato dal contratto rescindibile, evento che al piú potrà essere un effetto indiretto della transazione (12), quanto nella idoneità a comporre la lite innovando il rapporto preesistente. Sulla misura di tale innovazione e sulla necessità o meno che la transazione sostituisca appieno un nuovo rapporto a quello antecedente è poi questione ulteriore sulla quale sia dato per ora soprassedere.
D'altra parte se la convalida come la rinuncia all'azione di rescissione comporterebbero, la seconda quale conseguenza diretta la prima indirettamente, una dismissione del rimedio rescissorio non cosí accade per la transazione ove vi è, all'opposto, un'attuazione del rimedio suddetto sia pure attraverso la composizione della lite (13).
Dalle argomentazioni esposte, dunque, non può che negarsi un'estensione del divieto comminato dall'art. 1451 c.c. alla transazione per l'insussistenza di una identità di ratio.
Neppure fondata, d'altronde, è l'argomentazione che porterebbe ad escludere l'ammissibilità della transazione per una presunta indisponibilità del diritto all'azione di rescissione (14). Si è al riguardo opportunamente osservato che l'azione in questione non è affatto indisponibile: va considerata, infatti, l'indole patrimoniale che la connota confermata dal rilievo che il diritto ad impugnare la negoziazione rescindibile si estingue per prescrizione, vicenda estintiva inoperante, invece, per i diritti indisponibili (art. 2934, n. 2, c.c.); inoltre, la possibilità della riduzione ad equità del contratto mediante accettazione dell'offerta comporta necessariamente che sia in facoltà delle parti il transigere in ordine all'ammontare necessario a riportare in equilibrio il rapporto tra le prestazioni contrattuali, dal che conseguirebbe, altresí, «la possibilità di transigere in ordine al presupposto di riconduzione del contratto ad equità, e quindi all'an debeatur» (15).
Un'argomentazione ulteriore, infine, a favore dell'ammissibilità della transazione si ricava dal disposto dell'art. 764, comma 2°, c.c. che, nell'escludere l'azione di rescissione avverso la transazione con la quale si è posto fine ad una lite insorta a causa della divisione od atto ad essa equiparato (16), implicitamente afferma la transigibilità della divisione lesionaria (17).
Non può dunque, allora, che concludersi per l'ammissibilità della transazione che componga la controversia relativa alla rescindibilità anche se, esulando poi da ogni valutazione strettamente tecnica, non può che convenirsi con chi (18) sottolinea che il ricorso alla transazione può divenire un ottimo strumento nelle mani di chi ha già approfittato dello stato di bisogno della controparte che, subito dopo la conclusione del contratto lesionario, potrebbe vedersi imporre anche la transazione che non risolve affatto la predetta iniquità ma che, invece, diventerà ostativa alla proposizione dell'azione di rescissione mentre, a sua volta, non sarà suscettibile di impugnazione per causa di lesione (art. 1970 c.c.).
3. - Sembrerebbe rinvenirsi, nelle argomentazioni di taluni autori, l'opinione che l'offerta di modificazione del contratto atto a ricondurlo ad equità altro non sia che una proposta di transazione.
Nel paragrafo introduttivo a queste brevi note si è rilevato che la questione non è meramente qualificatoria considerato il diffuso orientamento, specie della giurisprudenza, che vuole l'offerta di ammontare tale da eliminare del tutto lo squilibrio fra le prestazioni del contratto. In altri termini si esclude che per impedire la rescissione basti un'offerta atta a ridurre la lesione al di sotto della metà; infatti, si sostiene «non si può parlare di riconduzione del negozio ad equità, ove manchi un rapporto di equivalenza obbiettiva fra le prestazioni e vi sia una parte avvantaggiata ed un'altra danneggiata» (19). C'è da chiedersi, allora, se una volta qualificata l'offerta di modificazione del contratto come una proposta di transazione (20) quest'ultima non debba necessariamente avere un contenuto tale da ricondurre ad equità il contratto nei termini indicati. Appare chiaro che cosí argomentando si esclude ogni autonomia fra il negozio rescindibile e il susseguente atto transattivo con salvezza della sola ipotesi in cui le parti siano addivenute ad una transazione c.d. novativa idonea di per sé a fondare autonomamente un rapporto che in tutto e per tutto si sostituisce al precedente.
La questione merita alcune puntualizzazioni: infatti, a parere di chi scrive, è necessario distinguere ai fini della qualificazione o meno dell'offerta di riduzione ed equità come proposta di transazione a seconda che la stima sia stata formulata o meno in giudizio, ipotesi quest'ultima cui allude esclusivamente l'art. 1450 c.c. con la frase «Il contraente contro il quale è domandata la rescissione ...». Ebbene, nel caso di offerta formulata in sede giudiziale vi è un fatto nuovo che non coinvolge esclusivamente le parti private bensí, indipendentemente dalla natura sostanziale (21) o meramente processuale (22) che ad essa si voglia attribuire, volge necessariamente il giudice, deputato, posto che l'azione sia stata legittimamente proposta, a decidere se l'offerta sia in grado di modificare la situazione di fatto dedotta in giudizio da cui l'attore ha
tratto il diritto potestativo all'esercizio dell'azione. Infatti, laddove l'attore ritenga non conveniente la modificazione proposta, l'offerta avrà il valore di istanza rivolta al giudicante che dovrà pronunciarsi sul se la modificazione prospettata dal convenuto sia sufficiente correttivo allo squilibrio fra le prestazioni del contratto, tale da rendere evitabile la rescissione (23). Ciò premesso appare evidente che se la valutazione sulla congruità dell'offerta è rimessa, nel disaccordo delle parti, all'apprezzamento del giudice che deciderà contemporaneamente sulla rescindibilità del contratto e sulla sufficienza della modificazione, non si potrebbe giustificare che questi ritenga equa un'offerta di modificazione del contratto che, sia pure in forma attenuata, faccia permanere lo squilibrio delle prestazioni determinato dall'approfittamento dello stato di bisogno; altrimenti, come bene evidenziano le corti di legittimità (24), «si accorderebbe, (...), al convenuto senza giustificazione alcuna, un trattamento migliore di quello a lui riservato in conseguenza della pronuncia di rescissione»; nel contempo all'attore verrebbe negato il conseguimento di un risultato economico identico a quello che otterrebbe per effetto dell'accoglimento della domanda. Neppure può, d'altra parte, condividersi l'argomentazione che traspone per il contratto rescindibile la soluzione generalmente accolta in tema di riduzione ad equità del contratto risolubile (25): si evidenzia, infatti, che in questa ultima ipotesi la modifica deve essere di tale entità da eliminare la eccessiva onerosità della prestazione ma non necessariamente da ristabilire l'equilibrio contrattuale in modo da assicurare alla parte gravata «il profitto che si riprometteva, giacché la perdita del lucro rientra nell'alea normale dei contratti e non nel concetto di eccessiva onerosità» (26); parimenti per il contratto rescindibile sarebbe sufficiente, e dovrebbe quindi senz'altro essere accolta dal giudice, un'offerta di modificazione che valga solo a ridurre la sproporzione fra le prestazioni riconducendola in termini tollerabili.
Il dato che farebbe dunque propendere per una soluzione analoga nelle due ipotesi sarebbe fornito dalla considerazione che comunque l'offerta di riduzione ad equità non deve necessariamente eliminare l'alea normale del contratto altrimenti tanto la parte legittimata a chiedere la risoluzione quanto quella legittimata ad agire in rescissione eluderebbero la sopportazione di quel rischio che è proprio di ogni contrattazione.
La tesi, invero, non può condividersi: i motivi del dissenso, a parere dello scrivente, nascono dalla erroneità dell'avvicinamento prospettato fra le due ipotesi di riduzione ad equità disciplinate rispettivamente dagli artt. 1450 e 1467, comma 3°, c.c. senza che si tenga nella debita considerazione il ruolo che, nel caso del contratto rescindibile, svolge non solo l'elemento obiettivo rappresentato dallo squilibrio fra le prestazioni, ma, altresí, il ricorrere degli altri due elementi richiesti dall'art. 1448 c.c.: stato di bisogno ed approfittamento.
Ben si sottolinea, infatti, che «il concetto di approfittamento sembra presupporre necessariamente una determinazione volitiva di trarre vantaggio dall'altrui bisogno» (27) e, in particolare, si pone in evidenza che la locuzione «approfittare per trarne vantaggio», contenuta nell'art. 1448 c.c., sia a significare uno sfruttamento nel senso di un adoperarsi di una delle parti per ottenere condizioni contrattuali iugulatorie. Vi è, dunque, nella costruzione della fattispecie rescissoria il compenetrarsi di elementi obiettivi e subiettivi,mentre questi ultimi non soccorrono nell'ipotesi di risoluzione per sopravvenuta onerosità. Ciò premesso non può con facilità escludersi che tale diversità strutturale finisca inevitabilmente per riverberarsi su una diversa posizione che il giudice deve assumere nel valutare l'offerta di modificazione del contratto lesionario rispetto all'altra ipotesi relativa al contratto risolubile. Nella rescissione, infatti, il ricorrere di elementi subiettivi, accanto a quello obiettivo della lesione, condiziona la proponibilità dell'azione investendo il giudice della questione - normalmente irrilevante nei contratti onerosi per il principio della equivalenza soggettiva delle prestazioni - della sproporzione fra i valori di queste ultime. Pari questione è sottoposta al giudicante laddove venga formulata l'offerta di modificazione del contratto: anche in tal caso, infatti, la sua valutazione positiva, tale da fargli denegare la pronuncia di rescissione, dovrà tener conto non solo dell'elemento obiettivo della ridotta sproporzione tra le prestazioni ma dell'idoneità dell'offerta a far sí che il contenuto del contratto sia variato tanto da far variare la situazione di fatto su cui verte il processo e, dunque, in tal modo da annullare quella posizione di svantaggio del contraente sfruttato dall'approfittamento del suo stato di bisogno.
In altri termini, se appare congruente con le scelte del legislatore escludere la risoluzione del contratto laddove sussista un'offerta di modificazione sufficiente ad eliminare l'eccessiva onerosità della
prestazione anche senza che sia necessario ristabilire appieno l'equilibrio contrattuale, per la considerazione che il contraente ha liberamente accettato la stipulazione dello stesso e quindi l'alea normale che ne deriva, lo stesso non può dirsi per il contratto rescindibile: qui la scelta del contraente leso ad addivenire alla negoziazione non è libera ma nasce condizionata dallo stato di bisogno di cui l'altra parte ha maliziosamente approfittato. Il sussistere di questi due elementi caratterizzanti la fattispecie rescissoria condiziona irrimediabilmente il giudice imponendogli di far conseguire al contraente leso che abbia fondatamente esperito l'azione un risultato economicamente identico e ciò sia nel caso venga accolta la pronuncia di rescissione sia nel caso che essa venga respinta perché superata dall'offerta prevista dall'art. 1450 c.c.; è indubitabile, infatti, che non può la tutela giuridica riconosciuta a chi ha diritto alla rescissione essere piú o meno ampia a seconda che il convenuto offra o meno la reductio ad aequitatem del contratto.
Riterrei, in definitiva, che se la necessità di un pieno riequilibrio delle prestazioni nel contratto rescindibile si giustifica nella considerazione che il giudice nel decidere sull'accoglimento o meno dell'offerta di modificazione è chiamato a sanare una situazione di fatto nata squilibrata per il concorso dell'approfittamento del contraente lesionario, tutto ciò non soccorre nell'offerta modificativa di cui all'art. 1467 c.c. ove lo squilibrio è conseguenza di eventi esclusivamente oggettivi la cui incidenza, sia pure molto ridotta a seguito dell'offerta di reductio, costituisce pur sempre quell'elemento di alea proprio di ogni contrattazione.
Giunti a questo punto della trattazione riterrei che, sulla base delle argomentazioni svolte, debba senz'altro darsi risposta negativa alla ipotizzata configurazione quale proposta di transazione attribuita da taluna dottrina alla offerta di reductio ad aequitatem del contratto rescindibile laddove essa sia formulata in sede giudiziale e non sia accolta dal contraente leso (28).
A differenti conclusioni dovrà invece pervenirsi per il caso in cui l'offerta sia piuttosto formulata al di fuori del giudizio, o, comunque, benché effettuata in sede giudiziale, venga senz'altro accettata dall'altra parte. In tali circostanze il giudice non viene investito della questione e l'offerta rientra nell'usuale schema di trattativa preliminare alla conclusione di una negoziazione bilaterale che questa volta, però, potrà con fondamento qualificarsi transazione: va, infatti, considerato che il contraente leso con l'accettare l'offerta e la conseguente modificazione delle condizioni del contratto, eviterà anch'egli l'alea comunque connessa all'esito del giudizio rescissorio.
4. - Si prospettano, a questo punto, ulteriori interrogativi: c'è da chiedersi se anche la proposta di transazione estrinsecantesi nell'offerta di modifica del contenuto del contratto formulata in sede stragiudiziale o, comunque, accettata dal contraente leso debba essere di ammontare tale da ridurre ad equità il contratto nel senso del pieno riequilibrio delle prestazioni oppure sia sufficiente che il quantum offerto sia idoneo a ricondurre la sproporzione in termini tollerabili, oppure ancora sia del tutto irrilevante ogni esigenza di riequilibrio delle prestazioni a carico delle parti in quanto, come si è sottolineato (29), «nulla può vietare al contraente leso di concordare con l'altra parte l'ammontare del supplemento dovutogli» dal momento che la transazione non è a sua volta impugnabile per rescissione.
C'è da chiedersi, infine, se la eventuale irrilevanza in ordine al riequilibrio delle prestazioni possa conseguire solo ad una transazione novativa.
La risposta ai quesiti indicati non può che essere nel senso della completa irrilevanza dell'ammontare dell'offerta di modificazione sia che si estrinsechi in una proposta di transazione novativa sia che si estrinsechi in una proposta di transazione semplice.
Nel primo caso, infatti, l'idoneità dell'accordo transattivo a sostituirsi in pieno, accantonandola, alla fonte della situazione originaria relativamente alla quale è sorta o sta per sorgere la controversia comporta che, qualsivoglia siano le condizioni pattuite dalle parti, la realtà preesistente, rappresentata dall'iniquo regolamento negoziale effetto del contratto rescindibile verrà completamente eliminata dalla regola nuova posta dalla transazione, non rilevando neppure come oggetto di quest'ultima né tantomeno come fonte concorrente nella regolamentazione degli interessi in gioco. Sarà dunque sufficiente che le parti, nel rispetto del carattere commutativo della transazione (30), raggiungano una linea di intesa che non dovrà
necessariamente comportare equivalenza nelle reciproche concessioni considerato che queste ultime hanno come parametro non già la situazione sostanziale, in certa misura occultata dalla lite, ma devono valutarsi relativamente al modo in cui si prospetta il contrasto. Come all'uopo ben si evidenzia dalla Cassazione, a seguito dell'accordo transattivo «non è piú possibile alcun riferimento alla situazione giuridica preesistente, per condizionare la validità del nuovo regolamento negoziale alla sua congruenza con tale situazione, appunto perché tale congruenza non rientra nell'intento delle parti preoccupate solo di trovare un punto mediano di incontro alle reciproche pretese» e si aggiunge «nella nuova sistemazione, la transazione non è piú fonte di apprezzamento del rapporto preesistente, ma diventa fonte autonoma del rapporto transatto e ciò importa (...) che la sua validità debba ricercarsi nella disciplina che le è propria e non nel richiamo di principi relativi al rapporto preesistente, del tutto scomparso dietro il nuovo regolamento che gli si è sostituito» (31).
Cosí dimostrata l'irrilevanza del quantum offerto per la modificazione del rapporto rescindibile che si traduca in una transazione novativa dello stesso, a conclusioni non diverse credo debba però giungersi anche nell'ipotesi in cui con l'accordo transattivo, pur non innovandosi appieno il rapporto preesistente (ponendolo da canto definitivamente per costituirne uno nuovo) questo venga semplicemente modificato ed integrato da un comando complementare che concorra con la fonte del rapporto originario a regolamentare gli interessi delle parti. Si è giustamente affermato che nell'ipotesi di transazione non novativa il vizio del titolo originario può rendere la transazione inutile «in quanto mancante della base su cui essa è diretta ad operare» (32); il riferimento appropriatamente cade sul caso di transazione relativa a titolo nullo (33) ma, anche, per l'ipotesi del titolo annullabile laddove la parte legittimata all'esercizio della relativa azione non abbia inteso, con la transazione, provvedere alla convalida. Pari conclusioni ritengo non possano, però, trarsi per il contratto rescindibile: già in altra sede si è cercato di dimostrare che relativamente al contratto viziato da nullità non può che ipotizzarsi il sopravvenire di una transazione «appieno innovativa» (34) altrimenti, nel caso di transazione non novativa, l'accordo transattivo finirebbe necessariamente per fondersi con il contenuto dettato dalla fonte preesistente la cui invalidità renderebbe inutile la transazione postasi, appunto, come fonte complementare. Pertanto qualora la controversia da comporre attenga alla validità del fondamento del rapporto e le parti non chiariscono se, attraverso la transazione abbiano inteso operare una sostituzione o una mera modificazione di esso sarà, comunque, necessario che l'accordo transattivo conclusosi abbia potenzialmente capacità creatrice del rapporto, altrimenti qualora la fonte originaria fosse inidonea alla produzione di tale efficacia sarà nella transazione che il rapporto ad essa successivo dovrà trovare la sua origine (35).
Discorso analogo può ben farsi per la transazione relativa al contratto annullabile per il caso in cui attraverso quest'ultima non si sia inteso superare proprio la questione dell'annullabilità; fatta salva questa ipotesi non può non concordarsi con chi sostiene che «dalla mancanza dell'effetto novativo consegue (...) che le azioni presidianti il titolo originario, (...) sopravvivono ad essa (transazione) e potranno esperirsi autonomamente» (36).
Le suddette considerazioni non soccorrono, invece, per il contratto soggetto a rescissione a cui acceda una offerta di modificazione del contenuto in senso sí migliorativo per il contraente leso ma comunque inidonea a ridurre il contratto ad equità. Ritengo che in tale ipotesi è necessario distinguere il caso in cui l'accettazione dell'offerta comporti una modificazione del rapporto fra le prestazioni tanto da ridurre la lesione al di sotto della metà del valore effettivo della prestazione in obbligo al contraente leso da quello in cui, nonostante l'accettazione dell'offerta di modificazione, permanga comunque la lesione ultra dimidium. Nel primo caso, indipendentemente dalla qualificazione operata dai contraenti relativamente alla natura transattiva o meno dell'accordo concluso, gli effetti della transazione si produrranno comunque: infatti, al venir meno della lesione conseguirà in ogni caso per il contraente leso la perdita dell'azione di rescissione posto che, ai sensi dell'art. 1448, comma 3°, c.c., «La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta». A maggior ragione le suddette conseguenze si verificheranno se dalla interpretazione dell'accordo ne sarà desumibile la natura transattiva considerato che, in tale ipotesi, l'esclusione dell'azione di rescissione conseguirà al disposto dell'art. 1970 c.c. che esclude l'impugnativa per lesione della transazione in coerenza del principio che vieta di insorgere contro il fatto proprio (37).
Nella diversa ipotesi in cui invece in seguito all'accordo transattivo si attribuisca al contraente leso un
quid assolutamente irrisorio o addirittura inidoneo a superare la lesione ultra dimidium riterrei impugnabile la transazione, non già perché viziata da lesione, stante il divieto sopra indicato, ma, piuttosto, in quanto le parti avrebbero concluso una negoziazione nulla perché viziata nella causa per l'assenza delle reciproche concessioni o perché in frode al disposto dell'art. 1450 c.c.
Solo successivamente alla dichiarazione di nullità dell'accordo transattivo sarà fruttuosamente esperibile l'azione di rescissione del contratto lesionario.
*. Scritto destinato agli Studi in onore di Gustavo Minervini.
1. La deriva reciproca tra i rimedi della nullità e della annullabilità specie nella legislazione speciale è sottolineata da pressoché tutti gli autori che si sono occupati del rapporto tra autonomia privata ed i limiti ad essa relativi. A titolo puramente indicativo cfr., tra gli altri, Iudica, Impugnative contrattuali e pluralità di interessati, Padova, 1973, p. 89 ss. che, nel porre in evidenza il progressivo avvicinamento dei rimedi della nullità e della annullabilità ad opera di continue deroghe legislative che rendono incerti i confini tra i due istituti, afferma l'opportunità d'individuare in luogo di due categorie logico sistematiche ben distinte piú statuti dell'invalidità (op. ult. cit., p. 91). Analogamente già il Messineo, voce Annullabilità e annullamento, in Enc. dir., vol. II, s.d. ma Milano, 1958, p. 474 ss., sottolineava l'abbondanza nel nostro sistema normativo di casi di annullabilità assoluta tali da fare dubitare fortemente dell'eccezionalità delle previsioni ad essi relative. Perentoriamente Alpa, Condono edilizio e categorie civilistiche, in Riv. it. leasing, 1985, 2, p. 335, dichiara che «siamo ormai abituati a considerare incerti e confusi i confini della nullità, mobili i suoi fondamenti dogmatici, relativi i suoi limiti». Anche Roppo, Il controllo sugli atti di autonomia privata, in Riv. crit. dir. priv., 1985, n. 3-4, p. 485 ss., evidenzia una «soggettivizzazione strisciante» del rimedio della nullità in contrasto con l'ideale dicotomia che affidava la considerazione e tutela degli interessi particolari delle parti non già al rimedio della nullità (concimata in una dimensione tutta oggettiva), ma ad altre figure di difettosità del contratto.
Si consideri, inoltre, che il progressivo avvicinamento tra i due istituti è per di piú anche favorito da una diffusa quanto discutibile tendenza della magistratura volta a limitare fortemente la portata del disposto dell'art. 1421 c.c. laddove conferisce al giudice il potere di rilevare d'ufficio la nullità del contratto: sull'argomento e sulla centralità della norma in questione nel conseguimento della tutela degli interessi sottesi alla comminatoria della nullità nonché nel costituire la piú forte discriminante disciplinare tra le due categorie dell'invalidità sia consentito rinviare a Monticelli, Fondamento e funzione della rilevabilità d'ufficio della nullità negoziale, in Riv. dir. civ., 1990, I, p. 669 ss.; Id., Contratto nullo e fattispecie giuridica, Padova, 1995, p. 238 ss.
2. Mirabelli, La rescissione del contratto, Napoli, 1962. Dello stesso autore cfr., anche Rescissione (Diritto civile), in Noviss. Dig. it., vol. XV, Torino, 1968, p. 579 ss. Sull'argomento della rescissione per lesione cfr., oltre alle trattazioni contenute in contributi sul contratto in generale (tra i quali in particolare cfr. Scognamiglio, Contratti in generale³, rist., in Tratt. Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1977, p. 262 ss.), tra i lavori di piú ampio respiro Mazza, L'azione generale di rescissione per lesione, in Giur. compl. cass. civ., 1947, p. 969 ss.; Ferri, Compravendita e rescissione per lesione, in Riv. trim., 1947, p. 682 ss.; Montel, Della rescissione del contratto, in Comm. cod. civ., D'Amelio e Finzi, I, Firenze, 1948; Scherillo, In tema di usura e lesione, in Giur. it., 1948, I, 1, c. 49 ss.; Scalfi, Il fondamento dell'azione di rescissione, in Temi, 1949, p. 39 ss.; Carresi, La fattispecie della rescissione per lesione, in Studi in onore di Greco, Padova, 1965, p. 115 ss.; Comporti, Fondamento e natura giuridica della rescissione del contratto per lesione, in Studi senesi, 1956-57, p. 7 ss.; Scozzafava, Il problema dell'adeguatezza degli scambi e la rescissione del contratto per lesione, in Riv. trim., 1978, p. 309 ss.; Lanzillo, Regole del mercato e congruità dello scambio contrattuale, in questa rivista, 1985, p. 309 ss.; Marini, Rescissione (Dir. vig.), in Enc. dir., vol. XXXIX, s.d. ma Milano, 1988, p.966 ss.; Sesta, Comunione dei diritti, scioglimento, lesione, Milano, 1988; Id., La rescissione del contratto, in Giur. sist. di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, I contratti in generale, diretto da Alpa e Bessone, vol. IV, t. 2, Torino, 1990, p. 809 ss.; Carresi, Rescissione. 1) Diritto civile, in Enc. giur. Treccani, vol. XXVI, Roma, 1991. Per una rassegna aggiornata della giurisprudenza cfr. Terruggia, La rescissione del contratto nella giurisprudenza, Milano, 1994.
3. Mirabelli, La rescissione del contratto, cit., pp. 1 e 413.
4. A. ed op. ult. cit., p. 1.
5. Significativamente sul punto cfr. Cass. 22 novembre 1978, n. 5458, in Giust. civ., 1979, I, p. 1086 ss., ove si legge nella massima: «Affinché il convenuto possa impedire la pronunzia di rescissione per lesione ultra dimidium attraverso l'offerta di riduzione ad equità del contratto, occorre che detta offerta abbia un valore identico a quello del bene che dovrebbe essere restituito all'attore in seguito all'accoglimento della domanda di rescissione: ne consegue che nell'ipotesi di una vendita il supplemento di prezzo a carico del convenuto deve essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore accertato del bene e il corrispettivo pattuito, e non in misura minore, tale da eliminare semplicemente la sproporzione tra le due prestazioni». Nello stesso senso Cass. 9 ottobre 1954, n. 3514, in Giust. civ., 1954, p. 2318 ss.; Cass. 6 marzo 1969, n. 711, in Foro it., 1969, I, c. 1124; piú di recente Cass. 8 febbraio 1983, n. 1046, in Rep. Foro it., 1983, voce Contratto in genere, n. 307. In senso conforme anche numerose decisioni della giurisprudenza di merito.
6. Per tale orientamento cfr. Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, Milano, 1984, p. 653. Per la giurisprudenza esclusivamente, a quanto consta, Trib. Napoli 16 febbraio 1948, n. 427, riportata per esteso nella raccolta curata da Terruggia, La rescissione del contratto nella giurisprudenza, cit., p. 109.
7. Mirabelli, Dei contratti in generale, in Tratt. Utet, Milano, 1980, p. 597. L'autore, pur favorevole all'ammissibilità di transigere relativamente ad un contratto impugnabile per rescissione, opportunamente sottolinea i pericoli derivabili dalla transazione in ordine al possibile riprospettarsi di una situazione di abuso che, proprio in seguito al sopravvenuto accordo transattivo, diverrebbe del tutto inattaccabile.
8. Per un'accurata ed aggiornata panoramica delle varie tesi prospettate al riguardo si rinvia a Piazza, Convalida. 1) Convalida del negozio giuridico, in Enc. giur. Treccani, vol. IX, Roma, 1988.
9. Stolfi, Transazione ed azione di rescissione, in Foro pad., 1959, I, c. 1086.
10. Cass. 4 ottobre 1955, n. 2791, in Foro it., 1956, I, c. 1330.
11. Cass. 15 aprile 1959, n. 1110, in Foro pad., 1959, I, c. 1087.
12. Sul punto analogamente Schizzerotto, Dell'arbitrato³, Milano, 1988, p.106; ma vedi, anche, Capotosti, Transazione e riduzione ad equità del contratto rescindibile, in Foro it., 1959, I, c. 1305 ss.
13. Cfr. anche Mirabelli, La rescissione del contratto, cit., p. 335.
14. Su queste posizioni, invece, Bianca, op. cit., p. 653 e Trib. Napoli 16 febbraio 1948, n. 427, cit.
15. Sesta, La rescissione del contratto, cit., p. 823. Analogamente Sacco, Obbligazioni e contratti, in Tratt. di Dir. priv. diretto da Rescigno, II, 10, Torino, 1982, p. 496; Mirabelli, op. ult. cit., p. 335; Stolfi, Transazione ed azione di rescissione, cit., c. 1087 ss.
16. Sull'argomento da ultimo Minervini, Divisione contrattuale e atti equiparati, Napoli, 1990.
17. Sesta, op. e loc. ult. cit.
18. Mirabelli, Dei contratti in generale, cit., p. 597.
19. Cass. 22 novembre 1978, n. 5458, cit. e le decisioni citate in nota 5: In questo senso per la dottrina tra gli altri: Costanza, Sulla «reductio ad aequitatem» del contratto rescindibile, in Giust. civ., 1979, p. 1091 ss.; Mirabelli, La rescissione del contratto, cit., p. 343 ss.; Sacco, Il contratto, in Tratt. Rescigno, vol. X, Torino, 1982, p. 180; Marini, Rescissione (dir. vig.), cit., p. 972. In senso contrario sia pure con varie graduazioni cfr.: Scognamiglio, Contratti in generale, cit., p. 268 che considera sufficiente «una
modificazione delle condizioni contrattuali che valga a ricondurre la sproporzione in termini tollerabili». Su questa scia Lucarelli, Lesioni d'interesse e annullamento del contratto, Milano, 1964, p. 92 nota 140 che sottolinea: «l'attuale ordinamento non persegue la tutela dell'equilibrio assoluto delle prestazioni, ma assume ad oggetto l'equo contemperamento degli interessi in gioco»; Quadri, La rettifica del contratto, Milano, 1973, p. 130. Nel senso che sia sufficiente una offerta di riconduzione ad equità che elimini la sproporzione oltre la metà del valore. Sul punto cfr., ultimamente, Scognamiglio, op. cit., p. 268; ma anche Ferri, Compravendita e rescissione per lesione, cit., p. 682.
20. Carresi, Rescissione, cit., p. 9.
21. Cfr. in tal senso per tutti, Redenti, L'offerta di riduzione ad equità, in Riv. trim., 1947, p. 576 ss.; Costanza, op. ult. cit., p. 1091 e ss.; Scognamiglio, Contratti in generale, cit., p. 267; Carresi, op. ult. cit., p. 8; Quadri, op. cit., p. 132 ss.
22. In tal senso soprattutto Mirabelli, op. ult. cit., p. 343. Sulla natura dell'offerta di reductio ad aequitatem cfr., però, utilmente anche Cass. 18 settembre. 1972, n. 2748, in Temi, 1973, p. 5 ed in Giur. it., 1973, I, 1, c. 855 che distingue a seconda che essa avvenga in via giudiziale o stragiudiziale; solo in quest'ultima ipotesi l'offerta costituirebbe una proposta contrattuale atta, laddove sia accettata, a dar luogo alla formazione di un contratto modificativo di quello rescindibile; diversamente nella prima ipotesi ove si tratterebbe di una vera e propria domanda giudiziale di un provvedimento costitutivo avente l'effetto sostanziale di modificare il contratto rescindibile riconducendolo ad equità.
23. Mirabelli, La rescissione del contratto, cit., p. 355.
24. Cfr., per tutte, Cass. 22 novembre 1978, n. 5458, cit. Sul punto, significativamente, Sacco, Il contratto, cit., p. 180 sottolinea: «Il 3° comma dell'art. 1448 non deve essere esaminato isolatamente. L'art. 1450 prevede un istituto, la cui ragione d'essere è analoga; ivi la riduzione ad equità come fatto estintivo della lesione, deve essere totale; non basta, cioè che la lesione sia ridotta sotto la metà: un discorso simile deve farsi per l'art. 1448, comma 3°».
25. Cosí, invece, Quadri, op. cit., p. 130 ss.
26. App. Genova, 22 febbraio l951, in Rep. Foro it., voce Obbligazioni e contratti, n. 535.
27. Sesta, La rescissione del contratto, cit., p. 815.
28. Giunge ad analoghe conclusioni sia pure percorrendo un diverso iter argomentativo: Capotosti, Transazione e riduzione ad equità del contratto rescindibile, cit., c. 1305 ss.
29. Stolfi, Transazione ed azione di rescissione, cit., c. 1089.
30. In tal senso, da ultimo, Del Prato, Transazione (dir. priv.), in Enc. dir., vol. XLIV, s.d. ma Milano, 1992, p. 824, ma in senso contrario: Carresi, La transazione, in Tratt. di dir. civ. italiano diretto da Vassalli, vol. IX, t. 3, rist. Torino 1966, p. 68 ss. coerentemente con la concezione dichiarativa che attribuisce all'accordo transattivo.
31. Cass. 4 ottobre 1955, n. 2791, cit., in motivazione.
32. Del Prato, op. cit., p. 831.
33. Sul punto si rinvia a Monticelli, Contratto nullo e fattispecie giuridica, cit., p. 108 ss.
34. L'espressione è di Del Prato, op. cit., p. 830 che condivisibilmente la ritiene piú consona di quella tradizionale «transazione novativa» in quanto maggiormente idonea a marcare le differenze fra la fattispecie in questione e la novazione. Sul distinguo fra i due istituti cfr. per tutti Santoro-Passarelli, La transazione, II rist., Napoli, 1963, p. 84 ss.; Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi
dall'adempimento, in Comm. del cod. civ. a cura di Scialoja e Branca artt. 1230-1259, Bologna-Roma, 1975, p. 101 ss.
35. Segni, Natura della transazione e disciplina dell'errore e della risoluzione, in Riv. dir. civ., 1982, I, p. 270.
36. Del Prato, op. cit., p. 832; anche Segni, op. cit., p. 275 ss.
37. Per una interessante riflessione critica sulle ragioni che hanno indotto il legislatore ad escludere l'applicabilità del rimedio della rescissione all'accordo transattivo cfr. Scozzafava, Il problema dell'adeguatezza negli scambi e la rescissione del contratto per lesione, cit., p. 335 ss. Sul punto cfr. anche Marini, Rescissione, cit., p. 982.














![Contratto di assicurazione corpi veicoli terrestri – In ... · [Digitare il testo] Contratto di assicurazione corpi veicoli terrestri – In abbinamento al contratto di finanziamento](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5b827ca37f8b9a32738eb274/contratto-di-assicurazione-corpi-veicoli-terrestri-in-digitare-il-testo.jpg)