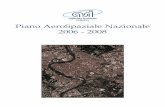Relatore: Prof. Antonio Margoni / Correlatore: Prof. Maurizio Maccarini
Conferenza2 Prof Ruspanti
-
Upload
italoungherese -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
description
Transcript of Conferenza2 Prof Ruspanti
-
Il 56 ungherese fra storia e letteratura1
Come a tutti noto, gi prima della fine della seconda guerra mondiale le sorti
di gran parte dei paesi dellEuropa orientale erano gi state decise. Nellaccordo o spartizione di Jalta anche lUngheria era stata assegnata alla sfera dinfluenza sovietica. Dopo una breve quanto illusoria stagione di libert caratterizzata da un
sistema democratico e pluripartitico, sia pure condizionato e vigilato dalla presenza
delle forze militari doccupazione sovietiche, il Paese dei magiari allindomani del cosiddetto fordulat ve, cio lanno della svolta a cavallo fra il 1947 e il 1948, si avvi inesorabilmente verso la dittatura attraverso un vero e proprio colpo di stato da parte del partito comunista ungherese impossessatosi dei gangli vitali dello stato
controllati dal ministero degli interni saldamente tenuto in mano comunista. A
prenderne atto in maniera definitiva ed inequivocabile fu, al pari di altri importanti
intellettuali e uomini politici ungheresi, Mihly Krolyi, lex primo presidente della Repubblica democratica dUngheria nata nellautunno del 1918 sulle ceneri dellimpero austro-ungarico. Lex conte, inviato nel 1949 a Parigi come ambasciatore della neonata repubblica popolare ungherese, si rese perfettamente conto che in
Ungheria non cera pi spazio per quella democrazia, per la quale aveva vissuto e combattuto lintera sua vita, e non potendo fare altrimenti, di l a poco scelse definitivamente la via dellesilio. Un feroce potere dittatoriale si instaurava in Ungheria, dove divennero di
norma il sequestro di persona, la privazione ingiustificata dei beni e la rovina
economica dei singoli e del Paese - come riconosceva la storica ungherese, di
estrazione socialista, Mria Ormos, in un convegno sulla rivoluzione ungherese del
1956 tenutosi nellUniversit di Udine nel 19932 - dove gli stessi sentimenti personali, la morale quotidiana, la dignit umana venivano sottoposti allattenzione a volte perfino morbosa, se non addirittura alla repressione, da parte dellapparato statale identificato con quello del partito (come il regista Pl Gbor ha ben
rappresentato nel suo film intitolato Angi Vera del 1978), dove una politica
economica dissennata poneva in essere la distruzione del tessuto agricolo del Paese e
lo sradicamento di masse enormi di popolazione dalle proprie radici sociali e
culturali, nel nome e nel mito del forzoso potenziamento dellindustria pesante che avrebbe portato alla realizzazione di vere cattedrali nel deserto, oggi in rovina o
1 Conferenza tenuta a Udine in data 11 marzo 2015 presso lauditorium di Palazzo Garzolini di Toppo-
Wassermann, nellambito del progetto scientifico-didattico LUngheria vicina!, dal prof. Roberto Ruspanti, professore ordinario di Lingua e letteratura ungherese, nonch direttore del Centro
Interuniversitario di Studi Ungheresi e sullEuropa Centro-Orientale, in sigla CISUECO (http://host.uniroma3.it/associazioni/cisueco/ ). 2 Cfr.: M. Ormos, Dal primo al secondo governo Imre Nagy, in R. Ruspanti (a cura di), Ungheria 1956: la
cultura si interroga, Rubbettino, Soveria Mannelli 1996, p. 88.
-
abbandonate (se non riconvertite in musei, centri-congressi o altro). Nei primi anni
Cinquanta la dittatura di Mtys Rkosi (1892-1971), lomologo magiaro di Stalin, con il corollario del culto della personalit, poneva in essere un sistema grottesco e
assurdo - cito sempre da Mria Ormos3 - che cozzava contro la stessa idea della
razionalit e dellumanesimo. In questo contesto quale fu il ruolo che gli intellettuali ungheresi, filosofi,
sociologhi, scrittori, poeti (e via dicendo), svolsero nellUngheria comunista prima, durante e dopo la rivoluzione democratica e patriottica del 1956 nei confronti del
potere totalitario? Vediamo di andare per ordine, facendo anche alcune importanti
puntualizzazioni.
Finita la seconda guerra mondiale, nel periodo compreso fra il 1945 e il 1948 la
maggioranza degli intellettuali ungheresi era piena di aspettative, di voglia di
cambiamento e di tante illusioni. Per questo motivo nel momento della presa del
potere da parte del partito comunista e della proclamazione della Repubblica
Popolare Ungherese nel 1949, gli intellettuali o, quanto meno, la maggioranza di loro
si schierarono apertamente dalla parte del nuovo regime. Questo lo affermo anche a
costo di provocare qualche mugugno di dissenso e forse di sorpresa e per sgombrare
subito il campo da equivoci.
Certamente non manc chi, fra gli intellettuali, si schier su posizioni di
compromesso, celando dietro questo atteggiamento la propria posizione di dissenso,
o, se si preferisce, di parziale assenso, o chi, pur non opponendosi al partito
comunista salito al potere, ma non condividendone la linea politica in generale e
quella culturale in particolare, si rifiut di collaborare, spesso riducendosi alla fame,
trincerandosi dietro uno sdegnoso silenzio ( il caso del poeta Lajos Kassk, 1887-
1967, fondatore, negli anni Dieci del Novecento, dellavanguardia culturale magiara, il quale, pur essendo comunista non produsse o, per meglio dire, non pubblic alcuna
opera per tutta lera stalinista, sdegnosamente arroccato sul principio che larte non pu sottostare a nessun condizionamento politico fossanche quello condiviso dallartista), o chi, infine, si ribell apertamente al partito comunista salito al potere, finendo per scontare duramente il proprio atteggiamento (spesso con il carcere), a
meno che non scegliesse la via dura e dolorosa del volontario esilio manifestando il
proprio dissenso nei confronti del regime lavorando e pubblicando le proprie opere
allestero. Il pi famoso di tutti fra questi ultimi senza ombra di dubbio Sndor Mrai (1900-1989), assurto solo in tempi recenti, ma purtroppo per lui, dopo la sua
morte, a grande fama internazionale. Riscoperto o forse, sarebbe meglio dire scoperto, dopo la caduta del muro di Berlino, prima in Italia e poi in tutto il mondo e
nella sua stessa patria, dovera proibito fino alla met degli anni Ottanta, Mrai in piena era kdriana veniva descritto a pagina 722 del volume VI (anno 1966) dello
Spenot (Spinacio: questo lappellativo che gli studenti universitari ungheresi davano alla Storia della letteratura ungherese, edita dalla casa editrice dellAccademia Ungherese delle Scienze, per via del colore verde delle copertine) come uno scrittore introverso e borghese che disegna nei suoi romanzi situazioni
3 Cfr. Ibidem, p. 88.
-
intimiste diseducative per le masse e che per di pi, nel suo esilio dorato in paesi
capitalisti, denigra la propria patria socialista in scritti e pamphlet di pessimo gusto
vomitando ingiurie sul mondo aldil della cortina di ferro al prezzo del maggior
offerente dellOccidente. Memorabile un passo significativo del suo Diario 1945-19574, nel quale il grande scrittore ungherese, che visse alcuni anni in Italia, ricorda il
colloquio, da lui avuto a Napoli ai primi di febbraio del 1949 con Benedetto Croce.
Nel corso di quel colloquio Sndor Mrai che solo un anno prima in patria era stato pesantemente attaccato da Gyrgy Lukcs (1885-1971), il noto ed ondivago filosofo
marxista ungherese, nel suo saggio intitolato j magyar kultrrt (Per una nuova
cultura ungherese, 1948), dove questi lo additava agli intellettuali magiari come un
pernicioso simbolo di borghesit indic chiaramente al grande filosofo italiano quale sarebbe stata la sorte degli intellettuali ungheresi dopo la presa del potere da
parte dei comunisti in Ungheria.
I comunisti aveva esordito Benedetto Croce rispondendo ad alcune osservazioni di
Mrai non possono volere la libert; ed naturale. Sono despoti, non socialisti. Vede, Mussolini fu un tiranno. I fascisti non mi hanno perseguitato per il solo motivo che volevano
far credere al mondo di non essere cos barbari, quali in realt erano. Ma io allepoca del Fascismo ho vissuto, qui, in questa stanza, lavorando per me stesso. Cosa pensa, in un Paese
comunista me lo permetterebbero? .
No rispose Mrai I comunisti non le permetterebbero di stare in silenzio. La costringerebbero a parlare: a parlare secondo il loro punto di vista. Benedetto Croce annu con il capo. Cosa pensa? chiese allora il filosofo allautore di Braci Che ne sar dei liberali ungheresi? Delllite spirituale, sociale del Paese?. Se i comunisti ne avranno il tempo, allora li atrofizzeranno, li intimoriranno fu la risposta di Sndor Mrai. S, cos
concluse Benedetto Croce ammiccando, rivolto allo scrittore ungherese.
Tra parentesi ricorder qui che nel 1953, ancora in piena era stalinista, proprio
Gyrgy Lukcs, che avrebbe poi, tre anni dopo, nel 1956, fatto parte del governo di
Imre Nagy (1896-1958) durante le brevi e gloriose giornate rivoluzionarie e che
sarebbe successivamente diventato, alla fine degli anni 60, lidolo della giovent contestatrice dellOccidente, Italia inclusa, si rese protagonista di una sconcertante presa di posizione appoggiando la decisione del partito comunista di proibire la
messa in scena dellottocentesca Az ember tragdija (La tragedia delluomo, 1861), il pi famoso dramma del teatro ungherese5, di Imre Madch (1823-1864), che
4 S. Mrai, Napl 1945-1957 [Diario 1945-1957], Washington 1968, pp. 92-93.
5 Il filo conduttore del dramma costituito da un lungo sogno, nel quale luomo-Adamo, guidato da Lucifero
attraverso i vari periodi della storia dellumanit e nel futuro, ne rivive romanticamente i diversi momenti, ricercando con laiuto sottile della filosofia le cause dellesistenza umana. Il dramma dagli alti toni, che poggia essenzialmente sul conflitto fra il bene e il male, fra il divino e il diabolico non poteva piacere ai
difensori dellideologia marxista-leninista sia per il contenuto - in cui, fra le altre, spicca la scena del falansterio, immaginato dai socialisti-utopisti francesi del XIX secolo come una societ nella quale tutti gli
uomini sono ridotti in condizioni grottesche di assoluta uguaglianza e le creativit individuali vengono
represse, tanto che Michelangelo vi appare come un modesto falegname - sia per il messaggio indiretto che il
grande autore ottocentesco trasmetteva, a cento anni di distanza, al popolo magiaro: infatti, dopo la tragedia
della guerra dindipendenza antiaustriaca del 1849, Madch si era rifugiato in silenzio nellimmensit della sua poesia, componendo il suo grande dramma filosofico alla ricerca del significato dellesistenza umana,
-
un po come se in Italia si proibisse la lettura de I promessi sposi nelle scuole, una proibizione, che incrinando le illusioni degli scrittori ungheresi che avevano creduto
nel socialismo, segner una svolta nel loro atteggiamento nei confronti del partito
comunista al potere rigidamente controllato da Rkosi.
questo il periodo in cui strumenti della politica culturale del partito
comunista ungherese erano, da un lato, lUnione degli Scrittori Ungheresi (Magyar rk Szvetsge) fondata nel 1945, costituita, sul modello sovietico, per unificare e meglio controllare le tendenze ed il pensiero degli scrittori magiari, e, dallaltro lato, la Gazzetta Letteraria (Irodalmi jsg), fondata alla fine del 1950, di fatto
lorgano dellUnione degli Scrittori Ungheresi. Asservita alle direttive culturali del partito, la Gazzetta Letteraria sar gestita in modo autoritario da due intellettuali
marxisti, Jzsef Rvai e Mrton Horvth, il primo dei quali sar anche il cervello e
lartefice dellintera politica culturale dellUngheria comunista. Anche il cinema ungherese nellera stalinista e, pi in generale, negli anni 50
fino alla rivoluzione del 1956 svolge una funzione didattica di indottrinamento delle
masse finanche nelle forme pi leggere della sua produzione quale la commedia o
loperetta. A tale funzione si piegano anche bravi registi, pur di poter lavorare. In questi films il cattivo sempre il reazionario di turno, mentre il buono il solerte funzionario che segue le direttive del partito o spinge in avanti esemplarmente la
produzione dellistituzione da lui diretta, oppure, se si tratta di contadini il primo sempre un kulako e il secondo un bravo giovane che vuole adottare sistemi produttivi moderni che favoriscano i contadini e una sana collettivizzazione. I cattivi sono normalmente brutti, grassi e pelati o comunque antipatici, i buoni sono aitanti e affascinanti e, naturalmente, vincenti anche nelle storie damore morigeratamente castigate. Emblematici in questo senso sono films come llami
ruhz (Magazzini di Stato, 1952) di Viktor Gertler con un grande comico del calibro di Klmn Ltabr (una via di mezzo fra Tot e Alberto Sordi) e un
bravissimo ed affascinante attore teatrale, Gbor Mikls, divenuto anche un divo del
cinema, forse suo malgrado; oppure Krhinta (Carosello, 1955) di Zoltn Fbri con Imre Sos e una giovanissima Mari Trcsik, che denota gi le sue grandi doti di
attrice di cinema e di teatro. (Spesso in Ungheria, almeno fino ad alcuni anni fa, i
grandi attori del cinema eccellevano anche nella recitazione teatrale e viceversa).
Ci premesso, per, ribadisco che nella fase iniziale della trasformazione
dellUngheria post-bellica in un regime di tipo socialista che culminer con la ricordata proclamazione della Repubblica popolare nel 1949 per poi trasformarsi
abbastanza rapidamente in una durissima dittatura totalitaria guidata dai vessilliferi di
Stalin, gli scrittori, i poeti, i filosofi, gli artisti, i letterati, gli storici e via dicendo, cio
gli intellettuali nel senso pieno del termine, quelli che producono lopera intellettuale, assunsero un ruolo sostanzialmente di assenso e di appoggio al regime,
mentre gli scrittori cosiddetti borghesi o non ricevettero spazio o, come nel caso di Mrai, si autoesclusero. Certamente gli scrittori dovevano sottostare alle direttive
cos facendo aveva dato con il suo comportamento dignitoso un esempio a tutta la nazione ungherese di
come anche con larte ci si possa opporre alla repressione e alla soppressione della libert.
-
culturali ed ideologiche del partito comunista o quanto meno non contrastarle, pena
lesclusione dalla pubblicazione dei loro scritti e, talvolta, perfino larresto; ma ripeto la maggioranza di loro assecond il regime comunista, anche in presenza di tutti quei difetti che questo non manc presto di manifestare, dallideologismo eccessivo al culto della personalit. Potrei citare diversi nomi di autori e titoli di
opere dellinizio dellera stalinista che vanno proprio in questa direzione. Mi limiter a ricordare, a titolo desempio, il romanzo Felelet (Risposta) di Tibor Dry (1894-1977) scritto addirittura secondo i canoni di un rigido realismo (tanto che lideologo del regime Jzsef Rvai, ritenendolo troppo spinto a sinistra, chiese al famoso scrittore di modificarne alcune parti, se non limpostazione) o lode a Stalin e quella in onore di Rkosi, scritte rispettivamente per il 72 compleanno del dittatore russo e
per il 60 genetliaco del dittatore ungherese dal poeta Zoltn Zelk (1906-1981): dei
versi dogmatici non privi soprattutto quelli in onore di Stalin anche di una certa bellezza estetica. Per non parlare fra gli altri - di un importante poeta come Gyrgy Somly (1920-2006), che al pari di altri meno noti pubblicava dei versi di vera e
propria propaganda inneggiante al regime nellimportante e rappresentativa rivista letteraria Csillag (Stella). Penso qui alla lirica intitolata Mindenki (Tutti).
vero che in quegli anni anche in Ungheria non manc quel tipo di
intellettuale-studioso che si trasformava in un vero e proprio funzionario
dellapparato del partito comunista con compiti di indottrinamento ideologico delle masse e della loro educazione culturale secondo i sacri principi del marxismo-
leninismo rivisitati da Stalin, finendo anche per svolgere funzioni di controllo della
vita culturale nazionale, ma questa funzione fu per lo pi volontaria, seppure non sempre disinteressata.
Negli anni 50 solo la met degli iscritti allUnione degli Scrittori Ungheresi era iscritta anche al partito comunista. Tuttavia, se di opposizione al regime stalinista
si pu parlare, essa fu paradossalmente unopposizione che si potrebbe definire da sinistra. Lepisodio prima ricordato della proibizione e poi della successiva autorizzazione della rappresentazione teatrale de La Tragedia delluomo di Madch fu uno dei segnali pi eclatanti della disillusione degli intellettuali ungheresi seguita
alla grande illusione che essi nella seconda met e verso la fine degli anni 40 avevano riposto nella nuova societ socialista, rivelatasi per quello che realmente era:
unimpalcatura burocratica ed autoritaria, ben lontana da quel socialismo che essi avevano sognato. Appariva ormai chiaro agli intellettuali ungheresi che il sistema, pi
che socialista, era divenuto sostanzialmente stalinista, cio dittatoriale con il
connesso odioso orpello del culto della personalit. Un segnale del cambiamento
dovuto allo scontento degli intellettuali sar dato dal fatto che lUnione degli Scrittori Ungheresi verr assumendo un ruolo autonomo finendo per divenire il centro
dellopposizione al regime. Gli scrittori e i poeti che ne fanno parte, da Illys a Zelk, da Gyula Hay a Tibor Dry, prenderanno a criticare e ad attaccare pi o meno
apertamente il regime. A loro si uniranno i giornalisti che facevano capo al
progressista Imre Nagy, il dirigente comunista che aveva attuato la tanto agognata
riforma agraria del dopoguerra (la fine del latifondo magnatizio che era stato il sogno
inattuato della rivoluzione bolscevica di Bla Kun nei 133 giorni della Repubblica dei
-
Consigli del 1919), e che poi troveranno in lui il loro punto di riferimento per il
cambiamento (penso qui uno per tutti al giornalista Mikls Vsrhelyi dorigine fiumana). Voglio tuttavia precisare che gli intellettuali in genere e gli scrittori
ungheresi nel 1953 non vogliono il ritorno alla vecchia Ungheria aristocratica danteguerra ma unUngheria dal socialismo umanitario o, come si sarebbe detto durante la primavera praghese del 1968, dal volto umano. E non vogliono neppure il ritorno ad uneconomia di tipo capitalistico o di mercato, o almeno non ci pensano in modo esplicito. La parentesi del governo di Imre Nagy fra lestate del 1953 e la primavera del 1955 sembrer aprire un filo di speranza verso il cambiamento in
questa direzione che avrebbe dovuto trasformare e porre fine ad un regime
sostanzialmente illiberale e dittatoriale, mentre sul piano strettamente economico
rilanciava i consumi di una popolazione stremata e riconsiderava lindustria pesante, i cui profitti erano per altro serviti a risarcire i danni di guerra rivendicati dallUnione Sovietica, il potente alleato colonnizzatore. Si pu dire che la rivoluzione del 1956 nascer in gran parte anche dal seno dellUnione degli Scrittori Ungheresi nello sviluppo e nella piega che, dopo lestromissione del primo ministro riformista Imre Nagy nellaprile del 1955, assumer il movimento di opposizione ad un regime che appariva definitivamente inemendabile.
Un ruolo fondamentale, poco conosciuto fuori dallUngheria, dellopposizione degli intellettuali ungheresi al regime comunista, dopo lestromissione forzata di Imre Nagy dal governo e poi perfino dal partito comunista da parte degli stalinisti
momentaneamente ritornati al potere, verr svolto fra il 1955 e il 1956 dalla rivista
j hang (Voce nuova) diretta da Andrs Simonyi. La rivista fiutava e
ritrasmetteva ai suoi lettori la nuova energia che fra il 1955 e il 1956 si respirava non solo nel Paese ma anche fra gli intellettuali. j hang divenne un forum della
giovane intellighenzia ungherese: vi si pubblicavano i versi del poeta Lszl Nagy
(1925-1978), lautore dellindimenticabile e splendida Ki viszi t a szerelmet? (Chi porter lamore sullaltra riva?), le liriche di Gyula Illys (1902-1983), lautore di Egy mondat a zsarnoksgrl (Una frase sulla tirannia), di cui dir tra poco, e di altri
poeti, veniva dato spazio al romanzo Niki di Tibor Dry facendolo conoscere ai
lettori: unoperazione questultima non esente da rischi politici e personali. Un tentativo di censurare una lirica di Lszl Nagy, punta di diamante della voglia e
della richiesta, da parte degli intellettuali, di cambiare rotta, venne fatto abortire dalla
redazione della rivista. I giovani intellettuali e gli studenti universitari nella
primavera del 1956 consideravano la rivista come portavoce delle tendenze
innovatrici nella letteratura e nella politica ungherese.
Senza ombra alcuna di dubbio la pi nota istituzione politico-intellettuale
protagonista degli antefatti della rivoluzione e che ebbe un ruolo determinante in essi
fu il Circolo Petfi (Petfi Kr). Nato alla fine del 1954 con il nome di Circolo Bessenyei (Bessenyei Kr), il Circolo Petfi doveva allinizio svolgere una funzione di controllo dei giovani ungheresi da parte del partito comunista ungherese
che vi stendeva sopra la sua longa manus. Ma lentamente e, in particolare, a partire
dalla primavera del 1956 il Circolo si sottrasse al protettorato del partito divenendo
-
teatro di liberi dibattiti fra i giovani intellettuali, per estendersi poi ad ampie fasce del
mondo intellettuale ungherese. Nei mesi precedenti la rivoluzione i dibattiti presero a
spaziare anche su temi politici ed economici fino a denunciare direttamente la politica
stalinista del partito al potere. Intellettuali dai nomi illustri quali Pter Kuczka,
Ferenc Snta, Tibor Kardos, Tibor Mray, Sndor Fekete, Lajos Tamsi, Gyula Hy,
ron Tamsi, il poeta Sndor Csori e tanti altri ancora parteciparono a dibattiti
memorabili come quelli che ebbero per protagonisti Gyrgy Lukcs, la vedova di
Lszl Rajk e lo scrittore Tibor Dry. Cassa di risonanza di questi dibattiti fu la gi
menzionata Gazzetta Letteraria (Irodalmi jsg), che puntualmente li pubblic
portandoli a conoscenza di un pubblico formato non solo da intellettuali.
Eppure, ancora allinizio dellautunno del 1956 neppure il pi radicale degli scrittori ungheresi pensava ad un cambiamento di sistema politico e sociale o
addirittura ad una sua trasformazione in senso capitalistico. Alla vigilia della
rivoluzione, nel mese di settembre del 1956 il partito comunista ormai non poteva pi
influenzare n lUnione degli Scrittori Ungheresi n lelezione dei suoi dirigenti. Anzi, al contrario, nella seduta del 28 settembre lUnione interveniva apertamente per sostenere la riabilitazione di Imre Nagy nel partito e nel Paese. La critica al regime
nel seno dellUnione degli Scrittori Ungheresi certamente contribuir a creare il terreno ideale da cui germoglier grazie al decisivo contributo degli studenti universitari la manifestazione pacifica del 23 ottobre che poi si trasformer in rivoluzione a causa dellottusa reazione repressiva della classe dirigente stalinista del partito reinsediatasi al potere dopo il defenestramento di Nagy, la quale, incapace di
controllare la situazione creatasi, anche per via di una serie di ordini e contrordini
sballati degli apparati del partito e dello stato, permetter la violenta reazione armata
della polizia segreta (che sparer sulla folla: episodi della radio e di piazza Kossuth),
arrivando a richiedere lo sciagurato intervento militare sovietico per ripristinare
lordine. LUnione degli Scrittori Ungheresi non avr tuttavia un ruolo specifico nello scoppio della rivoluzione e poi negli scontri armati tra i patrioti magiari da un
lato e la polizia ungherese e lesercito sovietico invasore dallaltro, ma svolger la funzione di cassa di risonanza degli avvenimenti rivoluzionari facendo conoscere ci
che accadeva in quelle giornate e schierandosi apertamente con la rivoluzione solo
nella seduta del 4 novembre, quando per la rivoluzione sar gi troppo tardi.
Gli ungheresi hanno una grande cultura teatrale: chi conosce Budapest sa
quanti e di quale livello siano quotidianamente gli spettacoli teatrali messi in scena
nella capitale magiara, una delle poche citt al mondo, se non lunica, ad avere due teatri lirici. Cos, anche nel campo teatrale, ben prima della rivoluzione del 1956,
alcuni drammaturghi diedero il loro contributo nel denunciare le aberrit e le
assurdit del regime totalitario e burocratico ungherese ricorrendo, nella messa in
scena dei loro drammi, alla rappresentazione di situazione grottesche e paradossali,
nelle quali il pubblico facilmente individuava la realt che esisteva fuori delle sale dei
teatri. Ricorder unopera per tutte: Szabadsg hegy (Monte della Libert), un dramma dal titolo emblematico, scritto da Jzsef Gli (1930-1981) fra il 1954 e il
1955 e rappresentato a Budapest un mese e mezzo prima dello scoppio della
-
rivoluzione, il 6 ottobre 1956, nello stesso giorno in cui avvenne il funerale-
riabilitazione dellex Ministro degli Interni Lszl Rajk (il comunista tradito da Kdr fatto condannare a morte tre anni prima dagli stalinisti, dopo un processo-
farsa) con la ritumulazione della sua salma. Un dramma sullalcoolismo che anticipa, come in una visione da vaticinio lincendio della rivoluzione, nellallegorica visione dellaria, della pioggia e del Danubio trasformati in alcool che prende fuoco e si propaga ovunque. In esso si respira quellatmosfera e quello stato danimo che permeavano la societ colta e non solo quella colta - ungherese in quel biennio di insoddisfazione e di grandi attese, di illusioni e di disillusioni succeduto alla morte di
Stalin, con la caduta del detestato Rkosi, la parentesi piena di speranze che fu il
primo governo di Imre Nagy e il ritorno al potere degli stalinisti. Condannato a morte
per aver preso attivamente parte alla rivoluzione del 56, Jzsef Gli, unico sopravvissuto di una famiglia ebrea sterminata ad Auschwitz, si salv dallesecuzione grazie alle veementi proteste dellopinione pubblica internazionale, ma si spegner ben presto di tubercolosi.
Anche nella prima giornata della rivoluzione ungherese del 1956 il mondo
dellarte e della cultura ungherese parteciper allentusiasmo generale che avrebbe preso lUngheria. La sera del 23 ottobre, nellintervallo della recita del dramma Galilei di Lszl Nmeth (1901-1975) che andava in scena nel Teatro Katona Jzsef
di Budapest, lattore Ferenc Bessenyei che interpretava il ruolo del protagonista, si affacci sul proscenio e rivolto al pubblico esclam con voce forte e concitata Eppur si muove!, al che esplodeva un applauso fragoroso da far venir gi il teatro. In quegli stessi momenti Imre Nagy, richiamato dal partito comunista ungherese a
ricoprire il ruolo di primo ministro, pi che altro per calmare le acque della protesta
montante del popolo che ne acclamava il ritorno al potere, teneva il suo discorso alla
folla radunatasi davanti al Parlamento e poco dopo, in unaltra parte ancora della citt, davanti alla sede della Radio ungherese unaltra folla inneggiava alla Libera Radio Ungherese (Szabad Magyar Rdi).
Dunque, la rivolta degli intellettuali ungheresi contro quella che essi
consideravano una degenerazione burocratico-autoritaria del socialismo era
incominciata ben prima degli avvenimenti rivoluzionari del 56, che io non esitai a definire rivoluzione patriottica e democratica gi alla fine degli anni 80 e che sono compresi ufficialmente tra il 23 ottobre e il 4 novembre 1956, anche se poi limpari lotta dei patrioti magiari contro linvasore sovietico durer ancora nelle settimane successive fino al suo completo soffocamento da parte di questultimo. Gi nei primi anni Cinquanta il pi grande poeta e scrittore vivente dellUngheria di allora, Gyula Illys, il poeta del popolo per antonomasia, lindimenticato autore della bella biografia di Sndor Petfi e del celebre romanzo Pusztk npe (Popolo delle puszte), il poeta che aveva fatto sentire la sua voce contro le ingiustizie sociali nellera Horthy, contro linvio dei soldati magiari al fronte russo durante la seconda guerra mondiale, contro la separazione dei connazionali oltre le frontiere post-belliche, e sia
pure in forme velate di protesta contro la progressiva trasformazione della
democrazia popolare nella dittatura stalinista post-1948, aveva innalzato il suo canto
-
contro la tirannide con la celebre ode Egy mondat a zsarnoksgrl (Una frase sulla
tirannia), una dura requisitoria continua e senza tregua, come la defin Pl
Ruzicska6 - espressa in ununica, lunghissima frase di 46 strofe di quattro versi ciascuna, non segnate da punteggiatura, ma intervallate dal verso doppio ripetuto
dov' la tirannia / l c' tirannia - contro tutte le forme attraverso le quali da sempre
si manifesta la tirannide. Lode suscit unenorme emozione allorch Gyula Illys, prima con voce tremante, ma poi sempre pi ferma e sicura, la lesse personalmente il
2 novembre 1956 alla radio Kossuth ribattezzata per loccasione Szabad Kossuth Rdi (Radio Kossuth Libera) nel pieno degli avvenimenti rivoluzionari. Pubblicata
lo stesso giorno nella rivista Gazzetta Letteraria, lode era per stata da lui scritta nei primissimi anni 50 (il 1950 o il 1951), in piena era stalinista, e non potendo pubblicarla laveva tenuta ben chiusa nel cassetto per oltre cinque lunghi anni. (Per amore di completezza devo qui ricordare che alcuni studiosi ungheresi ritengono
tuttavia che Una frase sulla tirannia fosse stata scritta da Gyula Illys senza un
preciso intento di denuncia del regime stalinista ungherese con il quale il grande
poeta pur conviveva strettamente, simpatizzando apertamente per il regime comunista
e, soprattutto, nel senso che le sue frequentazioni con il dittatore Rkosi, il gi
ricordato Stalin ungherese, suo grande ammiratore, mal si concilierebbero con il
contenuto della famosissima ode che egli andava scrivendo contemporaneamente a
quelle cattive frequentazioni. Per lo stesso amore di completezza, devo altres ricordare che altri studiosi e scrittori ungheresi, tra cui il mio amico drammaturgo
Mikls Hubay, scomparso nel 2011, hanno dichiarato per aver conosciuto personalmente Gyula Illys o, quanto meno, per averne conosciuta da vicino lindole che il grande poeta avrebbe volentieri sputato nel piatto di minestra che gli veniva offerto alla tavola di Rkosi dovera invitato a pranzo come commensale del dittatore).
Comunque sia, lode Una frase sulla tirannia, scritta contro ogni forma di tirannide, si rivel e appare tuttora come un durissimo ed evidentissimo jaccuse contro lo stalinismo e latmosfera di sospetto che esso aveva creato. Unaccusa contro la tirannia che dovette attendere, prima di poter essere resa pubblica, la parentesi di
libert che caratterizz le fulgide giornate di quel prodigioso autunno ungherese: sei
lunghi anni di dittatura durante i quali il regime comunista si macchi, in nome di
unaberrante utopia, paravento spesso di squallidi giochi di potere, anche di efferati delitti in spregio del pi elementare rispetto della dignit umana. Scheletri illustri
(quello del comunista Lszl Rajk) e meno illustri (inermi cittadini privati della
libert in seguito ad accuse false ed infamanti mosse col pi vile dei modi, la
denunzia anonima) penzolavano ancora negli armadi degli alti gerarchi del partito
comunista ungherese: Rkosi, Ger e lo stesso Kdr, quando si ud alla radio la voce di Illys che condannava senza possibilit di appello quella tirannide che aveva
tenuto sotto il suo giogo nove milioni di ungheresi e che nelle altre parti del mondo,
dove parimenti imperava, aveva privato dei pi elementari diritti milioni e milioni di
uomini. Una condanna senza appello dunque, dura e definitiva.
6 Cfr. P. Ruzicska, Storia della letteratura ungherese, Milano, 1963, p. 739.
-
Nellode di Illys la tirannide viene considerata sotto tutte le forme e gli aspetti possibili con cui pu manifestarsi e mascherarsi, ivi compresi quelli per cos dire
sottilmente psicologici, cari allo stalinismo che aveva imperversato in Ungheria
durante gli anni 50 allepoca degli arresti e delle esecuzioni indiscriminate. Il grande poeta, strappandone di dosso la maschera accattivante fatta di slogan e di canti,
mostra agli ungheresi la falsa ideologia con il suo vero volto inequivocabilmente
sanguinario. Lode potrebbe fungere da simbolo di denunzia di tutti i totalitarismi e tutte le tirannie possibili e immaginabili:
Una frase sulla tirannia (Egy mondat a zsarnoksgrl)
Dov la tirannia l c tirannia non solo nella canna del fucile
non solo dentro il carcere
non solo nella camera della tortura
non solo nel richiamo del secondino
urlato nella notte,
la tirannia l
nella veemente requisitoria
che incalza nel buio denso di fumo,
nella confessione, nel picchiettar dei carcerati
segnali morse sul muro,
non solo nella sentenza gelida
del giudice: colpevole!, la tirannia l
non solo nell attenti!
fatto scattar militarmente,
nel grido fuoco!, nel rullo del tamburo e nel modo di trascinare la salma
dentro la fossa,
non solo nelle notizie
bisbigliate in segreto
con timore
attraverso la porta socchiusa,
nel dito della mano portato alla bocca
in segno di silenzio: sssst!, la tirannia l
non solo nelle pieghe del viso
-
rigide come sbarre
e nel grido lamentoso che si dimena
ormai senza parole
dietro di queste,
nello scrosciare delle lacrime mute
che accresce il silenzio,
nelle pupille dilatate,
la tirannia l:
non solo negli evviva
gridati a squarciagola ritti in piedi,
negli hurr, nei canti,
dov la tirannia la tirannia l:
non solo nel palmo delle mani
meccanicamente plaudenti,
negli ottoni, nellOpera, nella pietra delle statue
che parimenti risuonano di falso,
nei colori, nelle gallerie di quadri,
in ogni singola cornice,
gi fin dentro il pennello,
non solo nel rombar dellautomobile che scivola silenziosa nella notte
e nel suo arrestarsi
davanti al portone di casa,
dov la tirannia, la tirannia presente
in ogni cosa, come neppure lo fu
quel dio un tempo da te idolatrato,
la tirannia l:
negli asili nido
nel consiglio dato dal padre
nel sorriso della madre
nel modo di rispondere del bimbo
al forestiero,
non solo nel filo spinato
non solo nelle file di libri
nelle parole vuote che pi del filo spinato
abbrutiscono,
-
la tirannia l
nel bacio di congedo
quando la moglie chiede
quando rincasi, caro
nel come stai tanto di consueto ripetuto per strada,
nella stretta di mano
che saffloscia allimprovviso
nel raggelarsi repentino
del volto di chi tama nel momento
dellappuntamento,
non solo nellinterrogatorio, l nella dichiarazione d amore nella dolce ebbrezza con cui ne pronunci la parola,
come la mosca che ti rovina il vino,
e poich neppure nei sogni
sei solo con te stesso
l nel talamo nuziale
e prima ancora nel desiderio
e poich ritieni bello soltanto quello
che un tempo le gi appartenuto
con lei che hai fatto lamore credendo damare,
la tirannia l nel tuo piatto e nel bicchiere
nel naso e nella bocca
nel freddo e nella penombra
allaperto e nel chiuso della stanza
come se attraverso la finestra aperta
vi penetrasse un puzzo di carogna
come se dentro casa
vi fosse una perdita di gas,
quando dialoghi con te stesso
la tirannia che ti fa domande,
neppure nel fantasticare
sei indipendente,
perfino la Via Lattea, lass, ormai diversa:
una striscia di frontiera scrutata da riflettori
un terreno ricoperto di mine
con le stelle ridotte a spioncini
-
la volta brulicante del cielo
un unico campo di lavori forzati
perch la tirannia si esprime tramite la febbre
tramite il suono di campane
tramite il prete al quale ti confessi
tramite la predica,
e chiesa, parlamento, patibolo
ne sono altrettanti palcoscenici,
sia che tu chiuda o apra le pupille
sempre l a fissarti,
come la malattia
tinsegue come il ricordo,
senti la ruota del treno?
schiavo, schiavo non fa che ripetere, in montagna e lungo il mare
lei che respiri,
il fulmine guizza? La tirannia
in ogni rumore inatteso
nella luce
in ogni spasmo del cuore
nella quiete
in questo tedio di catene
nello scrosciar dellacquazzone nelle sbarre alte fino al cielo
nella nevicata che ti rinchiude
come fra bianche pareti di cella,
l che ti guarda
attraverso gli occhi del tuo cane,
e poich in ogni scopo
l nel tuo domani
nei tuoi pensieri
in ogni tuo movimento,
come lacqua lalveo tu la segui e la crei,
guardi fuori furtivo da questo cerchio?
lei che ti guarda dallo specchio
lei a spiarti: inutilmente scapperesti
sei carcerato e al tempo stesso carceriere,
la tirannia penetra nellaroma del tuo tabacco nel tessuto dei tuoi vestiti
-
limbeve fino alle midolla, tu ragioneresti
ma a venirti in mente
sono soltanto le sue idee,
tu guarderesti, ma quel che vedi
solo ci che lei ti fa balenare,
e gi tutto dintorno divampa un incendio di bosco da un cerino
perch quando lhai gettato non lhai calpestato, e cos lei ormai a vigilare anche su te
nelle officine, nei campi, presso casa
e non senti pi cosa sia vivere
cosa siano pane e carne
cosa sia amare, desiderare
spalancare le braccia
come lo schiavo che in tal modo
porta le catene da lui stesso fabbricate,
se mangi, lei che fai crescere
per lei che procrei tuo figlio,
dov la tirannia ognuno non che un anello della catena,
sorge e se ne sprigiona il fetore pure da te:
anche tu sei tirannia,
come talpe in pieno sole
brancoliamo nel buio pesto
e ci dimeniamo nellangustia quasi fossimo nel Sahara,
perch dove c la tirannia tutto vano:
anche il canto, qualsiasi opera
anche unopera fedele come questa,
perch la tirannia sta fin da principio
accanto alla tua tomba
sar lei a dire chi fosti
pure delle tue ceneri si servir7.
7 Versione italiana di Roberto Ruspanti. Una frase sulla tirannia, letta in italiano dal suo traduttore,
risuonata in diretta alla radio ungherese (Radio Petfi) il giorno di Ferragosto del 2002 in occasione della serata finale del Convegno annuale dei poeti e degli scrittori ungheresi dedicato al poeta Gyula Illys nel
centenario della sua nascita e svoltosi a Tokaj in Ungheria tra il 14 e il 16 agosto 2002.
-
Il ritmo martellante e incalzante, impossibile da riprodurre in italiano, del testo
originale richiama con lossessivo e cupo susseguirsi dei suffissi ungheresi ban, ben, n e del verbo van (=, presente indicativo di lenni=essere) quello del suono di una campana a morte. Ecco qui di seguito il testo ungherese in cui viene evidenziata
la parte finale delle parole che ne sottolinea il suddetto suono:
Egy mondat a zsarnoksgrl
Hol zsarnoksg van,
ott zsarnoksg van
nemcsak a puskacsben, nemcsak a brtnkben,
nemcsak a vallat szobkban,
nemcsak az jszakban
kilt r szavban, ott zsarnoksg van
nemcsak a fst-stten
lobog vdbeszdben,
beismersben,
rabok fal-morse-jben,
nemcsak a br hvs tletben: bns! ott zsarnoksg van
nemcsak a katonsan
pattogtatott vigyzz!-ban, tz!-ben, a dobolsban, s abban, ahogy a hullt
gdrbe hzzk,
nemcsak a titkon
flignylt ajtn
ijedten
besuttogott hrekben,
a szj el hulltan
pisszt jelz ujjban, ott zsarnoksg van
nemcsak a rcs-szilrdan
flrakott arcvonsban
s e rcsban mr sztlan
vergd jajsikolyban, a csndet
-
nvel nma knnyek zuhatagban,
kimeredt szembogrban,
ott zsarnoksg van
nemcsak a talpralltan
harsogott ljenekben,
hurrkban, nekekben,
hol zsarnoksg van,
ott zsarnoksg van
nemcsak az ernyedetlen
tapsol tenyerekben,
krtben, az operban,
pp oly hazug-harsnyan
zeng szoborkvekben, sznekben, kpteremben,
kln minden keretben,
mr az ecsetben;
nemcsak az jben halkan
sikl gpkocsizajban
s abban,
megllt a kapualjban;
hol zsarnoksg van, ott van
jelenvalan
mindenekben,
ahogy rg istened sem;
ott zsarnoksg van
az vodkban,
az apai tancsban,
az anya mosolyban,
abban, ahogy a gyermek
idegennek felelget;
nemcsak a szgesdrtban,
nemcsak a knyvsorokban
szgesdrtnl jobban
butt szlamokban;
az ott van
a bcscskban,
ahogy gy szl a hitves:
mikor jssz haza, kedves;
-
az utcn oly szokottan
ismtelt hogy-vagy-okban,
a hirtelen puhbban
szortott kzfogsban,
ahogy egyszercsak
szerelmed arca megfagy,
mert ott van
a lgyottban,
nemcsak a vallatsban,
ott van a vallomsban,
az des sz-mmorban,
mint lgy a borban,
mert lmaidban
sem vagy magadban,
ott van a nszi gyban,
eltte mr a vgyban,
mert szpnek csak azt vled,
mi egyszer mr v lett;
vele hevertl,
ha azt hitted, szerettl,
tnyrban s pohrban,
az ott van az orrban, szjban,
hidegben s homlyban,
szabadban s szobdban,
mintha nyitva az ablak,
s bedl a dgszag, mintha a hzban
valahol gzfolys van,
ha magadban beszlgetsz,
, a zsarnoksg krdez, kpzeletedben
se vagy fggetlen,
fnt a Tejt is mr ms:
hatrsv, hol fny psztz,
aknamez; a csillag: kmlel ablak,
a nyzsg gi stor: egyetlen munkatbor;
mert zsarnoksg szl
lzbl, harangozsbl,
-
a papbl, kinek gynol,
a prdikcibl,
templom, parlament, knpad:
megannyi sznpad;
hunyod-nyitod a pilld,
mind az tekint rd;
mint a betegsg,
veled megy, mint az emlk;
vonat kereke, hallod,
rab vagy, rab, erre kattog;
hegyen s tenger mellett
be ezt lehelled;
cikz a villm, az van
minden vratlan
zrejben, fnyben,
a szv-hkkensben;
a nyugalomban,
e bilincs-unalomban,
a zpor-zuhogsban,
az gigr rcsban,
a cellafal-fehren
bezr hessben;
az nz rd
kutyd szemn t,
s mert minden clban ott van,
ott van a holnapodban,
gondolatodban,
minden mozdulatodban;
mint vz a medret,
kveted s teremted;
kmleldsz ki e krbl? nz rd a tkrbl,
les, hiba futnl, fogoly vagy s egyben foglr;
dohnyod zamatba,
ruhid anyagba,
beivdik, evdik veldig; eszmlnl, de eszme
csak v jut eszedbe,
-
nznl, de csak azt ltod,
mit eld varzsolt, s mr krbe lngol
erdtz gyufaszlbl,
mert amikor ledobtad,
el nem tiportad;
s gy rd is vigyz mr, gyrban, mezn, a hznl,
s nem rzed mr, mi lni,
hs s kenyr mi,
mi szeretni, kvnni,
karod kitrni,
bilincseit a szolga
maga gy gyrtja s hordja;
ha eszel, t nveszted, gyermeked neki nemzed,
hol zsarnoksg van,
mindenki szem a lncban;
belled bzlik, rad, magad is zsarnoksg vagy;
vakondknt napstsben,
gy jrunk vaksttben,
s feszengnk kamarban,
akr a Szaharban;
mert ahol zsarnoksg van,
minden hiban,
a dal is, az ilyen h, akrmilyen m,
mert ott ll
eleve srodnl,
mondja meg, ki voltl, porod is neki szolgl.
Negli anni successivi seguiti alla repressione violenta della rivoluzione lode contro la tirannia finir sotto la mannaia della censura kdriana e per poterla di
nuovo leggere ed ascoltare pubblicamente bisogner attendere il 1988, alla vigilia del
1989, lanno dellimplosione del regime comunista in Ungheria e negli altri paesi socialisti.
-
Oltre alla Frase sulla tirannia di Illys, la Gazzetta Letteraria pubblicher in
quelle luminose giornate la lirica Piros a vr a pesti utcn ( rosso il sangue sulle strade di Pest) di Lajos Tamsi: entrambe saranno le prime liriche a documentare in modo duraturo la rivoluzione.
rosso il sangue sulle strade di Pest
Ci muoviamo, un qualche invisibile
flusso sospinge i nostri cuori,
inceppandosi in gola vola alto il canto,
ma sono nostre ormai le strade di Pest!
//
rosso il sangue sulle strade di Pest,
sangue di operai, di giovani questo,
rosso il sangue sulle strade di Pest,
ministro degli interni8, su chi stai sparando?
//
rosso il sangue sulle strade di Pest. Cade la pioggia e sferza, lava
il sangue, ma le macchie restano
sul selciato delle strade di Pest.
rosso il sangue sulle strade di Pest,
scorre sangue di operai, di giovani,
accanto alle bandiere tricolori
ponete il vessillo nero del lutto.
Accanto alle bandiere tricolori
proferite tre giuramenti:
una lacrima pura di pianto,
odio alla tirannia
ed un voto, piccola nazione:
non dimentichi chi vive
che la libert sorta perch
scorse sangue sulle strade di Pest.9
8 Il riferimento al ministro degli interni Lszl Piros.
9 Lajos Tamsi, Piros a vr a pesti utcn ( rosso il sangue nelle strade di Pest), I, V, VIII, IX, X e XI
strofa. (Traduzione personale). Testo originale:
Piros a vr a pesti utcn
Megynk, valami lthatatlan
ramls szvnket befutja,
akadozva szll mg az nek,
de mr mienk a pesti utca.
-
Lanelito di libert degli ungheresi venne spento nel sangue alle prime ore del freddo mattino del 4 novembre 1956. I carri armati sovietici, chiamati in soccorso dai
Giuda, traditori del loro stesso popolo, soffocarono quellaspirazione proibita dei magiari, seppellendone per sempre lillusione che quellutopia che li aveva tiranneggiati fino ad allora fosse emendabile e potesse assumere quellaspetto che stato poi comunemente ed impropriamente definito socialismo dal volto umano, impropriamente perch mai realizzato e comunque privo delle elementari regole della
democrazia liberale. Gli ungheresi avrebbero dovuto aspettare oltre trentanni per rivedere lalba della luce della libert che in quei giorni gloriosi poterono solo intravvedere. Quel livido mattino del 4 novembre 1956 lUngheria periva nella stessa indifferenza del mondo che poco pi di centanni prima, nel 1849, aveva visto altri Ungheresi soccombere sotto i colpi delle armate russe zariste chiamate in soccorso
dagli Asburgo dAustria per domare lUngheria anche allora ribelle. Ora nel 1956 nuovi zar, i Kruscev, i Kdr, i Togliatti, depositari della verit di un nuovo
assolutismo ideologico, il totalitarismo comunista, soffocavano il nuovo anelito di
libert e di indipendenza degli ungheresi.
Il mondo della cultura ungherese, in generale, e, nellambito di questa, i letterati in particolare, non solo fu tra i pi presenti durante la rivoluzione con cui si
concretizz la lotta degli ungheresi contro il totalitarismo per la libert, la democrazia
e lindipendenza nazionale, ma ne fu uno dei pi importanti promotori. Molti degli scrittori rivestirono un ruolo di primo piano in quegli avvenimenti, solo nel 1989
assurti ufficialmente in Ungheria a dignit storica come rivoluzione, dopo essere stati per oltre trentanni rimossi dalla storia ufficiale - ma non dalla coscienza - della
// Piros a vr a pesti utcn,
munksok, ifjak vre ez,
piros a vr a pesti utcn,
belgyminiszter, kit lvetsz?
// ...Piros a vr a pesti utcn.
Es esik s elveri, mossa a vrt, de megmaradnak
a pesti utca kvein.
Piros a vr a pesti utcn,
munksok - ifjak vre folyt,
- a hromszn-lobogk mell
tegyetek ki gyszlobogt.
A hromszn-lobog mell
tegyetek hrom eskvst:
srsbl egynek tiszta knnyet,
s a zsarnoksg gyllett,
-
nazione ungherese e bollati col marchio di controrivoluzione dal regime del socialismo cosiddetto reale di Jnos Kdr (1912-1989).
Il lamento che i poeti magiari elevarono prima, durante e dopo le gloriose
giornate del 56 rimane una delle pi belle e commoventi pagine non solo della letteratura ungherese, ma dellintera coscienza nazionale magiara. Si tratta di sensazioni che sotto forma di poesia hanno riempito quella che il popolo magiaro nel
suo intimo - negli oltre tre decenni trascorsi dalla rivoluzione del 56 fino al 1989 - e apertamente - da questa data in poi - ha sempre considerato e pu oggi a buon diritto
considerare una delle pagine pi luminose della sua storia.
E sensazione di eternit, idea di libert che vince la morte, quella che si prova
leggendo la bella ed intensa Commemorazione che il poeta Blint Tth ha pubblicato
nel 199110 in ricordo del suo amico coetaneo, il poeta Attila Grecz (1929-1956),
morto eroicamente il 7 novembre 1956 (come recita il sottotitolo della poesia), uno dei tanti intellettuali magiari fatti sacrificare dal potere comunista e sacrificatisi in
nome della libert.
Commemorazione
In ricordo del mio amico poeta Attila Grecz
morto eroicamente il 7 novembre 1956 11
Adesso che
la sera dellaprile inonda coi suoi raggi la cerchia dei colli, il vento tenue che schiude le foglie increspa la corona dei tigli,
e la citt svincolandosi dal suolo si solleva nella luce fino al cielo,
come fumo che nasconde il proprio pennacchio, ma no! sboccia
il giacinto: non fumo solleva, ma profumo -
adesso ti vedo che sulla strada di fronte
talzi in volo fischiettando, ai due lati del capo a guisa di ali / ti svolazzano i capelli,
con un fascello di raggi leggeri ti avvolge fra le sue braccia
/ il Fuoco, che
gi ti ha divorato, ma tu voli in alto, gli sorridi soltanto, e danzi
con sua Sorella, la Luce;
attimo e
tomba rimangono di te qui in mezzo a noi:
soltanto una tomba sotto rami ricoperti di neve e licheni,
/ sotto la pioggia
lacrimosa di novembre, sotto una lacrima di volti belli -
eppure io
non ti commisero: tu, ormai, ti elevi e cresci nei tempi,
con contorni sempre pi netti nella luce, cos da non poter pi
/ cambiare,
risplenderai sempre di pi e ancor pi nitido.
10
B. Tth, Krisztinavrosi krmenet (Processione nel quartiere Krisztina), Budapest, 1991, p. 242. 11
Titolo originale: SIRAT - Grecz Attila 1956. november 7-n hsi hallt halt klt bartom emlekre. Versione italiana di Roberto Ruspanti.
-
Non ci sei pi, eppure hai fatto della tua morte bella e leggera
/ un esempio
e a me, che ti piango, concedi d'innalzare
a scudo contro lorrore il sorriso del tuo volto.
Attila Grecz era uno degli autori del Fveskert (Il giardino erboso), titolo che
alcuni poeti magiari rinchiusi in carcere nel pieno dello stalinismo degli anni
Cinquanta, alcuni dei quali poi morti durante gli scontri con i cingolati sovietici o
costretti ad un esilio doloroso, avevano voluto dare alla loro raccolta clandestina di
poesie, poi pubblicata a Vienna nel 1956, perch - come ricordava il poeta Tibor
Tollas (1920-1997) introducendo la raccolta tradotta in italiano e pubblicata a Firenze
nel 1959 a cura di Imre Vrady - il giardino erboso il pi bel simbolo ungherese
della vita che si nutre di terra e di luce... il giardino, il giardino dei Transilvani, della
gente di Debrecen, dove non erano ignoti i fiori odorosi delle terre lontane. Ma forse -
proseguiva il Tollas - questo giardino sta a significare anche il giardino interiore.12 E
certamente anche dietro le mura alte e opprimenti del duro carcere stalinista questi
poeti clandestini magiari si erano ritagliati per s un piccolo pezzo di terra, quello
spazio ideale di libert che nessuna tirannide potr mai soffocare. I versi di Attila
Grecz ce ne danno la pi realistica e sofferta testimonianza:
A pane e acqua13
Giaccio sul pavimento lurido
con la schiena appoggiata al muro.
Il dolore ... potrai, mia poesia,
vincerlo?
12
E. (Imre) Vrady (a cura di), Il giardino erboso, Fussi-Sansoni, Firenze 1959, pp. 20-21. 13
A. Gerecz, Kenyren s vzen (A pane e acqua). Nuova versione italiana di Roberto Ruspanti. Il testo
originale inserito nel volumetto Il giardino erboso, ibidem, p. 84:
A mocskos padln fekszem,
htam vetem a falnak.
A fjdalom... lehet-e versem hatalmad?
Prblgatom Anym mosolyt.
Lelkre mg dalaim szrnm...
Knnyeket, mik mr nem fagynak t
a formn.
Msom sincs, Uram. Berem
azzal, hogy arcodat viszem;
csak gy brtam mg el: kenyren
s vizen.
-
Provo e riprovo il sorriso di mia madre,
spargerei ancora sul suo cuore i miei canti...
le lacrime che ormai non rompono
la forma.
Altro non ho, mio Signore.
Mi contento di recare il tuo volto.
Solo cos ho potuto resistere ancora:
a pane e acqua.
Il giardino erboso ebbe, purtroppo, poca risonanza presso la critica italiana,
ammontando soltanto a due le recensioni ottenute, tra l'altro luna a firma del fondatore-direttore della collana Il Melagrano (di cui la raccolta fa parte) Guido
Manacorda14, e laltra ad opera di Paolo Santarcangeli15, traduttore e poeta, nonch illustre storico della letteratura ungherese, originario di Fiume, che uno dei
traduttori delle poesie inserite nel volumetto. Il primo mette soprattutto in rilievo che
il maggior pregio dellantologia va ricercato nellespressione di una sofferenza tragica degli spiriti, presi tra indomita fierezza e umanit profonda, fra famiglia
schiantata e patria perduta, tra fede e preghiera ardenti, e brame di sogno e di
evasione... e in parte, nel richiamo degli affetti familiari. Il secondo rileva
onestamente che le poesie de Il giardino erboso per lo pi sono lontane da canoni
estetici tradizionali e troppo legate alloccasione, pur riconoscendo che daltra parte nelle condizioni disumane del carcere esse erano figlie della sofferenza, senza
dimenticare inoltre che molti dei loro autori erano semplici studenti, soldati e
lavoratori. Rileggendole oggi queste poesie rievocano in noi soprattutto il tormento di
chi le scrisse, le cui sensazioni amare e sofferte si confermano pregne di una dignit
che nessun carceriere, nemmeno il pi abietto, pot e potr mai cancellare.
Fra le pi commoventi sicuramente una lirica che ha reso immortale il
sacrificio di una giovanissima ragazza, una bambina di appena dodici anni, uccisa a
Budapest mentre faceva la staffetta tra la fontana, che ancora nel 1956 esisteva in
piazza Klvin, e le retrovie dei rivoluzionari poco distanti. Consentitemi di introdurla
con un brano che la ricorda tratto dal mio romanzo Quel treno per Budapest:
La piazza Klvin un nodo stradale importante di Budapest. [] Qui si
incontrano il cosiddetto piccolo Corso, che conduce da un lato, con il nome di corso del
Museo, verso il centro e dallaltro, con il nome, allora, di corso Maresciallo Tolbuhin, verso Buda aldil del Danubio, e la via lli che porta allaeroporto e verso la periferia sud di Pest, doverano concentrati i mezzi corazzati sovietici. Per raggiungere Buda o il centro della citt questi dovevano percorrere in tutta la sua lunghezza la via lli e, una volta attraversata la piazza, dirigersi a sinistra sul corso Tolbuhin, verso piazza Dimitrov e il
ponte della Libert, lantico ponte Francesco Giuseppe, oppure a destra verso il Museo
14
G. Manacorda, Letteratura sotterranea. Nel carcere ungherese spunt facile la poesia, in L'Avvenire dItalia, 22 luglio 1959. 15
P. Santarcangeli, Recensione a Il giardino erboso, in Il Ponte, numero speciale dedicato allUngheria, Firenze 196O, pp. 778-782.
-
Nazionale e il viale Stalin16
, pi in l. Probabilmente i russi si saranno sentiti a loro agio in
queste vie e piazze intestate a liberatori, eroi e politici sovietici o filosovietici di vario genere dallevidente nome slavo che nulla avevano a che fare con la storia e il sentire nazionale ungherese!... Dimitrov: chi era costui? avrebbe detto il Manzoni, se fosse stato
ungherese. Cos piazza Klvin il cui nome si era salvato, sebbene la religione fosse considerata ufficialmente una sovrastruttura, probabilmente perch, a suo modo, anche
Calvino aveva fatto una rivoluzione contro la fede dominante fu attraversata per lintera giornata del 4 novembre dai blindati sovietici. Uno dei nidi di resistenza si era asserragliato
allangolo fra la piazza e la via lli, da dove provenivano i carri, tentando di danneggiarne quanti pi fosse possibile con le bombe a mano o le rudimentali bombe
Molotov. Il gruppo di patrioti era formato soprattutto da operai, ma anche da comuni
cittadini e da qualche studente. Pi volte ma invano invitati ad andarsene, anche alcuni
giovanissimi ragazzi si erano uniti al gruppo con compiti di raccordo con gli altri gruppi
sparsi per le vie della citt: fra loro una bambina, Anik, si era assunta il compito di
supportare i combattenti con viveri e acqua. Nella piazza, non lontano dal Museo
Nazionale, cera una fontana, oggi scomparsa. Nella tarda mattinata, Anik, approfittando di un attimo di tregua fra il passaggio di un carro e laltro, vi si diresse per approvvigionare dacqua i combattenti. Tenendo stretta fra le dita la brocca che era quasi pi grande di lei, Anik con le sue treccine bionde fermate da due fiocchi rossi correva inconsapevolmente
verso la morte.
Allimprovviso, nascosta da un enorme carro Josif Stalin, sbuc una camionetta da cui due soldati russi presero a mitragliare allimpazzata in direzione della fontana. Uno dei due gridava Fascist! Fascist!, mentre i colpi a ripetizione dei mitra si conficcavano
sullasfalto, sugli alberi intorno e sul muretto decorato della fontana da dove usciva il cannello dellacqua. Anik fu falciata dalle pallottole e cadde a terra colpita a morte, con le treccine bionde sparse sullasfalto. Ebbe appena il tempo di sussurrare mamma! con un esile filo di voce. Dalla brocca riversa, miracolosamente intatta, lacqua usciva lentamente tingendo di rosa la pozza rossa del suo sangue. Fascist! Fascist! continu a gridare come
un ossesso il soldato russo, mentre la camionetta spariva svoltando verso il Museo
Nazionale, sul cui frontone ottocentesco in stile neoclassico spiccava beffarda unenorme stella rossa posticcia. Anik non aveva che dodici anni: forse, a causa dei lunghi calzettoni
grigi che indossava, lavevano scambiata per uno dei partigiani ai quali stava portando lacqua. Un poeta patriota, Jzsef Rth jr, morto anchegli durante la rivoluzione, le dedic la sua ultima commovente poesia.17
La lirica, che si intitola Leny, a Klvin-tri ktnl (Fanciulla alla fontana di piazza Klvin), lascia un nodo alla gola anche nei cuori pi induriti.
Se l portata via lautunno, oh tremenda, tremenda ora!
Dal cielo cadeva sangue, ferro e fuoco,
piedi lordi di fango calpestavano la neve...
Laggi nello scantinato lacqua era finita, e le lacrime, come il siero freddo del latte,
avevano perduto gi da tempo il dolce sapore,
e intanto sibilava il vento Oh tremenda, tremenda ora!
16
In ungherese Sztlin t. 17
Roberto Ruspanti, Quel treno per Budapest, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, pp. 137-138.
-
Stava nella piazza la disadorna e malinconica fontana
e sulla portatrice dacqua il cielo rivers la morte, sebbene fosse il percorso di soli venti passi in tutto Vedo la camicetta bianca rimboccata,
oh tremenda, tremenda ora!...
Dalla corta gonnellina le spuntavano
simili a due pulcini le piccole ginocchia lalba stava appena per spuntare, oh tremenda, tremenda ora!...
Tenendo due secchi nelle mani andava verso la fontana,
il sonno laveva a malapena abbandonata, gli altri ancora sbuffavano laggi nella cantina i due secchi stavano l gi colmi dacqua cadde in mezzo ad essi come fiore appassito sulla neve
con la delicata e bella testolina ripiegata sopra il petto
e se l portata via lautunno oh tremenda, tremenda ora!
1 novembre 195618
18
Jzsef Rth jr, Leny, a Klvin-tri ktnl. Testo originale ungherese:
Elvitte t az sz, szrny, szrny ra! Az gbl hullt a vr, a vas a tz, sros lbak tiportak r a hra.
A pincemlyben elfogyott a vz,
s a knny, akr a tej hvs savja, elfedte rgen mr az des zt,
s kzben ftylt a szl ...
szrny, szrny ra...!
A tren llt a lompos, mla kt,
s az g hallt nttt a vzhozra,
br hsz lps volt mindssze az t ...
Ltom a feltrt, fehr ingt,
- szrny, szrny ra ... a szoknyja rvid volt s
alla kibujtak trdei, mint kis csibk ...
Hajnal derengett csak,
szrny, szrny ra ...
Kezben kt vdrrel ktra ment,
az lom mg alig suhant le rla,
a tbbiek szuszogtak odalent,
a kt vdr ott llt, vzzel tele,
kztk halott virgknt hullt a hra,
mellre csuklott szp, finom feje
s elvitte t az sz szrny, szrny ra ..
-
Come accennato nel romanzo, il giovane poeta Jzsef Rth jr, che lautore della commovente lirica, mor durante le giornate della rivoluzione. Mor anchegli, come la fanciulla da lui cantata, entrambi vittime sacrificali della tirannide. Il
menzionato poeta traduttore Paolo Santarcangeli ne piange la tragica morte
accomunandoli in un unico commosso ricordo nella sua lirica dal titolo LAraldo:
E la fanciulla ignara
venne falciata dalla mitraglia.
Andava, dice il poeta ucciso,
andava con magre gambette e scarpine consunte,
le treccioline pendenti come codine di topo,
una vecchia secchia in mano,
ricolma di acqua di fonte.19
Fra il 23 ottobre e il 4 novembre gli intellettuali ungheresi assisteranno
sgomenti ed impotenti alla battaglia. La parola pass alle armi, a quelle dei coraggiosi
patrioti ungheresi che assaltando i cingolati sovietici con le rudimentali bombe
molotov, i mitra e i fucili distribuiti da alcuni soldati dellesercito degli Honvd contrasteranno larmata rossa sovietica, il pi potente esercito di terra del mondo dotato di carri armati e di armi ben pi numerose ed efficienti di quelle degli insorti.
Allindomani del soffocamento della rivolta popolare, una cappa di tetro ed assordante silenzio si stese sullUngheria. Processi, condanne e impiccagioni caratterizzarono il regime controrivoluzionario di Kdr nei primi quattro anni
succeduti alla rivoluzione, che il dittatore magiaro ebbe la faccia tosta di bollare
come controrivoluzione (quando erano stati il suo fraudolento tradimento ed il suo colpo di stato supportato dai carri armati sovietici ad essere controrivoluzionari!),
definizione che rester tale fino alla caduta del regime comunista. Il momento pi
tragico ed emblematico della feroce repressione, con risvolti a volte sadici si ebbe
con il processo farsa, la condanna a morte e limpiccagione, nel 1958, di Imre Nagy, il primo ministro dellUngheria rivoluzionaria, il comunista che fra la fedelt al partito e la fedelt alla nazione non esit un solo istante e scelse la sua nazione.
Fra il 1957 e il 1961 non esiste una vera eco della rivoluzione nella letteratura e
nella cultura ungherese allinterno del Paese, per via della feroce e spietata censura che rimuoveva qualsiasi espressione, anche in forma di semplici e limitati riferimenti,
relativa a quellavvenimento. Per tale ragione limmediato post 56, che vede il consolidamento del potere dellambiguo Jnos Kdr, rientrato a Budapest al riparo dei carri armati sovietici, dopo aver tradito il legittimo primo ministro dellUngheria, Imre Nagy, del cui governo pure faceva parte, viene definito da alcuni studiosi
ungheresi bna idszak (periodo dellimmobilismo), caratterizzato dalla repressione, dallincarceramento e dallintimidazione degli intellettuali che avevano favorito la rivoluzione del 1956 o apertamente parteggiato per essa, tanto che fino ai 19
Paolo Santarcangeli, LAraldo. In memoria dei caduti della rivoluzione ungherese, IV strofa, vv. 24-30. In Il Ponte, numero unico dedicato allUngheria, aprile-maggio 1960, Firenze, pp. 727-731.
-
primi anni 60 non si pu parlare di una vera e propria letteratura anti-regime. Come pi volte rilevato, molti di quegli intellettuali avevano partecipato alla rivoluzione
rivendicando un socialismo sburocratizzato e pi aderente ai bisogni del popolo
magiaro: non un caso se il pi importante e famoso di loro, Tibor Dry, condannato
a morte dal regime kdriano, verr salvato dallesecuzione della condanna grazie allintervento di numerosi e famosi intellettuali di sinistra europei, ivi compresi quelli iscritti o vicini al Partito comunista italiano che pure, come noto, assunse una
posizione assolutamente contraria alla rivoluzione ungherese e ad Imre Nagy, che di
fatto, pur non volendolo almeno inizialmente, ne era divenuto il leader assumendo
legittimamente, vale a dire secondo le regole vigenti nellUngheria comunista di allora, lincarico di primo ministro del governo ungherese.
Diversa, naturalmente, la situazione e la produzione di quegli intellettuali
ungheresi che avevano scelto la via del volontario esilio gi da tempo, allaffermarsi della dittatura comunista di tipo sovietico alla fine degli anni 40 ( il caso del grande scrittore Sndor Mrai, riscoperto alla fine degli anni 90 in Italia e in Ungheria, e del grande critico letterario Lszl Cs. Szab) o si videro costretti a sceglierla dopo la
repressione della rivoluzione del 56, come il sopra menzionato poeta Tibor Tollas, rifugiatosi a Vienna, dove nel 1957 diede alle stampe il volumetto di poesie Il giardino erboso), prima ricordato. La poesia, pi che la narrativa o la filosofia, rester nellimmediato indomani del 56 lunica arma seppure spuntata nelle mani degli intellettuali ungheresi per gridare tutta la loro rabbia, il loro dolore per il sangue
versato, per la libert momentaneamente assaporata e poi perduta, per la patria
abbandonata forse per sempre. Ma in quei versi, in quelle parole c ancora tutto lentusiasmo, tutto lardore della giovent di Budapest che sapeva di lottare per la dignit delluomo e per qualcosa che non aveva mai provato: la libert. Sndor Mrai, che nei giorni della rivoluzione aveva pensato di fare rientro in patria da Monaco di
Baviera, dove collaborava come redattore alla Radio Europa Libera, ma raggiunto
dalla notizia dellinvasione sovietica dellUngheria, aveva dovuto desistere riprendendo invece la via dellesilio, nel triste Natale di quellanno scrive a New York una splendida ed indimenticabile lirica, Mennybl az angyal (Angelo dal ciel), dedicata al martirio del suo Paese. Ne cito la prima e la terza strofa:
I
Angelo dal ciel affrettati a scendere
sulla gelida Budapest in fiamme,
l dove in mezzo ai cingolati russi
tacciono le campane,
l dove non risplende il Natale,
non pendono dallalbero noci dorate e non c altro che gelo, brividi e fame. Rivolgiti a loro, in modo che comprendano,
parla a voce alta nella notte,
reca, angelo, notizia del prodigio.
-
//
III
Spiega perch questo un prodigio del mondo:
lalbero natalizio dun povero popolo ha preso ad ardere nella Notte Santa.
E molti si son fatti il segno della Croce,
da ogni angolo della terra i popoli guardano, guardano,
alcuni comprendono, altri non comprendono.
Scuotono il capo, questo troppo per molti.
Pregano oppure aborriscono,
perch non caramelle ma altro pende dallalbero: Cristo dei popoli, il Paese dei Magiari.
20
Un allentamento delle briglie poliziesche e censorie si ebbe a partire dal 1961
ma fortemente condizionato. Infatti tutta la cultura ungherese, e quindi anche le opere
artistiche (dalla poesia alla narrativa, dal cinema al teatro) che volevano affrontare e
quelle che poterono effettivamente affrontare anche il tema della rivoluzione del 56 saranno sottoposte alla regola censoria sottintesa delle tre T: Tiltott, Trt, Tmogatott (proibito, sopportato, appoggiato) che sar applicata per tutta lera kdriana. In particolare, le condizioni imposte dalla censura del regime kdriano
alla cultura ungherese, affinch questa potesse esprimersi in qualche maniera su
20
Mrai S.: Mennybl az angyal... (Angelo dal ciel...), I e III strofa, in Mrai S.: sszegyjttt versek, Helikon, Budapest 2000, pp. 325-327. (Traduzione personale). Testo originale:
Mennybl az angyal...
Az szks, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Kztt hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karcsony.
Nincsen aranydi a fkon,
Nincs ms, csak fagy, didergs, hsg.
Mondd el nekik, gy, hogy megrtsk.
Szlj hangosan az jszakbl:
Angyal, vigyl hrt a csodrl.
Mondd el, mert ez vilg csodja:
Egy szegny np karcsonyfja
A Csendes jben gni kezdett s sokan vetnek most keresztet.
Fldrszek npe nzi, nzi,
Egyik rti, msik nem rti.
Fejk csvljk, sok ez, soknak.
Imdkoznak vagy iszonyodnak,
Mert ms lg a fn, nem cukorkk:
Npek Krisztusa, Magyarorszg.
-
quella che, comunque, rimaneva e rimarr fino al 1988 una controrivoluzione e che, nel migliore dei casi, il regime definiva avvenimenti del 56, furono sostanzialmente due:
1) la prima era che si potevano affrontare quegli avvenimenti soltanto nellottica di una rivisitazione critica dellera stalinista del periodo 1949-1953 ponendo laccento piuttosto, se non esclusivamente, su questultima e rinunciando del tutto ad una ricostruzione storica o cronachistica della rivoluzione in quanto tale;
2) la seconda era che non si facesse mai, neppure di sfuggita, il nome del
morto insepolto (appellativo che ricavo dal titolo di un film di Mrta Mszros), cio Imre Nagy, linnominato e linnominabile del regime, il vero grande tab che accompagner il regime kdriano fino al suo epilogo e la stessa coscienza sporca
del dittatore magiaro.
Per quanto riguarda la prima condizione, interessante notare come la
rivisitazione critica dellera stalinista fosse auspicata e favorita dallo stesso Kdr, che in qualche modo voleva purificare la propria coscienza da molte macchie, alcune
delle quali erano davvero molto sporche. La denuncia della prassi e dei metodi
stalinisti, di cui anche Kdr era stato al tempo stesso vittima ed esecutore, mirava ad
una specie di autoassoluzione per le malefatte da lui, assieme ad altri, compiute in
una situazione di costrizione psicologica che nella rivisitazione posteriore diveniva
un alibi giustificativo e assolutorio. Nel permettere che lartista (scrittore o regista cinematografico) si avviasse lungo questo percorso di rivisitazione di una delle
pagine pi buie della storia ungherese, si arrivava anche a concedere che egli potesse
direttamente collegare lo stalinismo con i sommovimenti del 56 in un processo di causa-effetto, senza per mai giustificarli del tutto e, soprattutto, senza che venisse
confutata la versione ufficiale su quegli avvenimenti e sui loro istigatori, pur sempre definiti controrivoluzionari i primi e fascisti e provocatori al servizio dellimperialismo i secondi. Le opere di narrativa e, soprattutto, i films degli anni sessanta e settanta seguono tutti, grosso modo, questo canovaccio e possono essere
definiti riflessioni della dittatura cosiddetta morbida dellera kdriana sulla dittatura dura dellera stalinista.
In questa fase, nel campo teatrale, ferma restando la possibilit di rappresentare
drammi e commedie del repertorio classico ungherese, domina il teatro leggero, ad
esempio di Mikls Hubay, uno dei migliori drammaturghi ungheresi del Novecento,
con la delicata e raffinata commedia k tudjk mi a szerelem (Loro lo sanno cos lamore), un atto unico del 1959, lopera o operetta Cest la guerre, che del 1958 ma messa in scena la prima volta tre anni dopo, nel 1961, musica di Emil Petrovics, e
la commedia musicale di grande successo Egy szerelem hrom jszakja (Tre notti di un amore) del 1961. Un genere ammesso dalla censura in quanto evidentemente le tematiche di queste opere teatrali, costruite sul filo di sottili trame psicologiche di
tipo borghese di certo non in linea con i canoni marxisti-leninisti di una sana societ proletaria, servivano a distrarre il pubblico perfino dal ricordo della rivoluzione/controrivoluzione del 56 rimuovendo anche dalla coscienza del potere comunista kdriano i sensi di colpa per quella tragedia.
-
Nel campo cinematografico ricorderei il film Szerelem (Amore), che per gi del 1970, al cui autore, il regista Kroly Makk, fu concessa una libert di
espressione inconsueta, probabilmente perch gli avvenimenti rivoluzionari del 56 sinseriscono solamente in sottofondo e in modo molto sfumato nella narrazione della vicenda. La sceneggiatura del film si basa su due novelle di Tibor Dry Szerelem
(Amore, 1956) e Kt asszony (Due donne, 1962) e fu realizzata dallo stesso grande scrittore. Pi che un film sul 56 Szerelem la ricostruzione, soprattutto nella parte finale, della drammatica atmosfera dellepoca degli anni 50 rivissuta attraverso la vicenda psicologica e affettiva dei tre protagonisti e rientra in quel tipo di critica
retrospettiva e di riflessioni di quella che ho definito la dittatura morbida kdriana sulla dittatura dura dellera stalinista.
Per quanto invece riguarda laltra condizione imposta dalla censura, non nominare mai Imre Nagy, il primo ministro martire del governo rivoluzionario del
1956, fatto impiccare nel 1958 da Kdr, che era pur stato suo ministro, salvo poi
tradirlo per opportunismo e ambizione di potere, essa non verr mai meno e si dovr
aspettare la caduta del regime per portare a conoscenza della nazione magiara questa
ignominia di cui si era reso responsabile il dittatore. Far eccezione, ma solo nei
primi anni 80, il poeta Gspr Nagy (1949-2007) che dedicher una poesia alla pi illustre delle vittime del 56. (Ne accenno pi in l).
Negli anni sessanta lunica valvola di sfogo delle tensioni accumulate nellUngheria repressa da Kdr dopo il 56 sar lestrema liberalizzazione dei costumi sessuali degli ungheresi favorita dal regime, come ha molto ben testimoniato
e dimostrato, nellambito di una interessantissima rassegna fotografica e cinematografica sul 56 intitolata Graffiti ungheresi, tenutasi nel Teatro Miela di Trieste nel 2002 (28 ottobre-3 novembre), il regista cinematografico ungherese Pter
Gothr con un collage di spezzoni di filmini in 8 millimetri girati da comuni cittadini
dove abbondano i nudi femminili che ritrae la societ ungherese dellepoca in un privato un po boccaccesco Come a dire: fate sesso, non fate opposizione. Una nota di costume e di colore che rispecchia il desiderio degli ungheresi di quegli anni
di voler rimuovere in qualsiasi modo la tragedia del 56, perduta ogni speranza di libert che a quellevento si riconduceva.
Solo a partire dalla seconda met degli anni 60 si assiste in Ungheria ad un relativo allentamento della morsa da parte della dittatura kdriana. Nasce il mito del
cosiddetto socialismo del goulash (goulash, variante tedesca dellungherese gulys
21, la nota zuppa classica della cucina magiara), caratterizzato dal noto slogan
kdriano Chi non contro di noi con noi e che fa dellUngheria la pi allegra baracca nel campo del socialismo reale, anche se dentro il famoso minestrone
nazionale ungherese si celavano ancora bocconi indigesti di carne avvelenata, residui
dello stalinismo.
In questo periodo si affaccia timidamente alla ribalta una nuova letteratura
critica antiregime, piuttosto di tipo sociologico, che ha negli scrittori Lajos Galambos
e Endre Fejes, fra gli altri, e nel sociologo Andrs Hegeds, lex primo ministro che 21
Nel suo significato originario il termine gulys significa in realt mandriano, pastore che bada alle mandrie, anticamente anche al gregge.
-
nei primi giorni della Rivoluzione del 56 aveva chiesto il primo intervento dei sovietici e che poi aveva abbandonato la politica, nonch nella studiosa di filosofia
gnes Heller i nomi di punta. In particolare, lo scrittore Endre Fejes nel suo romanzo
Rozsdatemet (letteralmente Discarica, tradotto e pubblicato in Italia con il titolo di Cimitero della ruggine, 1962) manda al macero tutta la societ socialista cos come si andava realizzando in Ungheria nellera kdriana con tutti gli orpelli di burocraticismo e di socialismo pi di facciata che reale. Lo stesso Fejes realizza nel 1969 il dramma a tinte gialle di denuncia sociale J estt nyr, j estt szerelem
(Buonasera estate, buonasera amore) che mette alla berlina alcune distorsioni create nella societ comunista dal confronto che il cittadino medio ungherese faceva con gli
standard di vita occidentali e dallo scimmiottamento dei suoi modelli. Questi intellettuali, educati al marxismo e al leninismo, che conoscevano profondamente,
prendevano atto che il regime kdriano non corrispondeva affatto ai canoni del
marxismo. Di nuovo, ancora unaltra volta, la critica e lopposizione degli intellettuali ungheresi al regime comunista che si era realizzato in Ungheria partiva in
gran parte da sinistra: essi non criticavano il monopartitismo, ma contestavano il burocraticismo con i suoi risvolti operettistici. Lopposizione democratica ungherese, esauritasi nella fiammata rivoluzionaria del 56, viveva ormai sfiduciata e priva di speranze in gran parte allestero.
Controcorrente sembr invece andare uno scrittore molto popolare
nellUngheria kdriana degli anni 60-70, Gyrgy Moldova, che per primo defin la rivoluzione del 56 rivolta. Attenzione, per! rivolta e non rivoluzione. In realt lopposizione di Moldova al regime era solo di facciata e finiva per fare il gioco del dittatore Kdr saldamente al potere avvalorando la tesi che il socialismo
reale in salsa kdriana era comunque un comunismo democratico rispetto a quello non democratico dellepoca buia dello stalinismo che ora veniva anche ufficialmente condannato. Come ha giustamente sostenuto in un convegno
dellIstituto Letterario dellAccademia Ungherese delle Scienze su Gli scrittori e il 1956 svoltosi qualche anno fa a Budapest lo scrittore transilvano Gza Szcs, in questi romanzi le figure rivoluzionarie sono a livello caricaturale e il ruolo
pseudostorico che vi viene attribuito alle figure del conte Mihly Krolyi e del
filosofo Gyrgy Lukcs nascondono in realt una diminutio della rivoluzione. Ne
costituisce, in anni recenti, la prova provata la controversa biografia di Jnos Kdr
realizzata da Gyrgy Moldova, che leccentrico e ormai anziano scrittore ha fatto uscire provocatoriamente alla vigilia del 50 anniversario della rivoluzione che si
celebrava nel 2006, togliendosi definitivamente quella maschera di
pseudorivoluzionario che aveva indossato negli anni 60. Una biografia che ha suscitato in Ungheria alla sua uscita un certo sconcerto accompagnato per anche da
riconoscimenti positivi dovuti ad una sorta di sentimento nostalgico di parte degli
ungheresi schiacciati dalla crisi economica verso il passato regime. Questa biografia e
lesaltazione di Jnos Kdr che vi si irradia da ogni pagina stata definita da alcuni reduci e parenti delle vittime del 1956 un insulto alla memoria della rivoluzione e di
coloro che morirono, furono incarcerati o costretti allesilio per unaspirazione di libert. Per chi abbia un minimo di conoscenza della storia ungherese dagli anni 50
-
al 1989 lappassionata difesa, direi lammirazione-amore smodato che Moldova mostra nei confronti del dittatore ungherese, definito dallo scrittore il pi grande statista ungherese del Novecento, appare incomprensibile. Lunico paragone che a me, italiano, viene in mente lanalogo atteggiamento che ebbero in Italia dopo il 1945 gli ex-fascisti o post-fascisti nei confronti della figura e delloperato di Mussolini. Definire Kdr il pi grande politico ungherese del XX secolo non solo
aberrante, ma offensivo del popolo ungherese che di quella dittatura ne fu vittima. Il
fatto casuale che un uomo mediocre e meschino, gi protagonista in passato di atti
aberranti e di tradimenti dei suoi amici e compagni, come in realt umanamente fu
Kdr, divenisse per trentadue anni il padrone dellUngheria con il tradimento del suo popolo, del suo Paese, in cui rientr allombra dei carri armati di una potenza nemica, e del suo legittimo primo ministro, nelle cui mani aveva giurato fedelt, non ne fa n
un grande uomo, n, soprattutto, un grande politico. Giustificare loperato di questo personaggio solo per il fatto che non si sporc fisicamente le mani con il sangue di
coloro che aveva tradito e fatto condannare a morte, demandando questo compito ai
suoi pseudotribunali popolari, ai suoi inquisitori spietati e crudeli e ai suoi boia, da
un punto di vista morale inaccettabile, ma anche incomprensibile da un punto di
vista psicologico.
Alla fine degli anni Sessanta, fra gli intellettuali, il movimento sotterraneo di
contestazione al regime comincia a muovere i primi passi, anche se non si pu parlare
di una vera e propria organizzazione. Cos nel 1969 nascevano i seminari segreti della Lukcs iskola (Scuola Lukcs), mentre nel 1970 prendevano avvio, per protrarsi
fino al 1973, le cosiddette Kpolnatrlatok (Esposizioni o mostre in cappella) cos chiamate perch allestite in una cappella sconsacrata di Balatonboglr, unamena localit balneare sulla riva meridionale del Lago Balaton, il mare dUngheria, come lo chiamano gli stessi ungheresi mostre artistiche (soprattutto di arti visive) fuori dalle righe e dagli schemi, intorno a cui si svolgevano cenacoli di intellettuali.
Fra la fine degli anni Sessanta e linizio dei Settanta si forma intorno allo scrittore Gyrgy Konrd una cerchia di scrittori e di intellettuali la cui critica andava
oltre il socialismo: non pi, dunque, una critica per modificare dallinterno o, come si disse, da sinistra, il socialismo reale per come si era vento realizzando, ma tout court, una critica al regime o, se si preferisce, al sistema del socialismo reale in
quanto tale. Fanno parte di questa cerchia Ivn Szelnyi e Jnos Kis. Nome di spicco
fra gli intellettuali che si oppongono al regime comunista il filosofo e sociologo
Mikls Haraszti, che da studente (1970) era stato cacciato via dalluniversit per le sue posizioni poco ortodosse verso il regime di Kdr e costretto ad andare a lavorare
in una fabbrica di trattori. Lavorando come operaio si forma in lui la convinzione che
il socialismo reale schiaccia i lavoratori n pi n meno del capitalismo. Le conclusioni, frutto di questa sua esperienza in fabbrica, formeranno il contenuto del
suo saggio pi famoso e senza ombra di dubbio lopera pi significativa del periodo: Darabbr (Salario a cottimo), in cui attacca frontalmente il regime kdriano
identificando il socialismo con il capitalismo.
-
Nel 1973 si svolge a Budapest il cosiddetto Filozfusper (Processo ai filosofi)
che ebbe per conseguenza il licenziamento dei membri della Lukcs iskola dal posto
di lavoro e la loro espulsione dal partito. Nel mese di ottobre, lo stesso Mikls
Haraszti viene arrestato per aver diffuso illegalmente il manoscritto del suo saggio
Salario a cottimo. In seguito a ci lo scrittore perder pure il proprio posto di lavoro
in fabbrica. Invisi al regime, molti intellettuali ungheresi verranno costretti al silenzio
e privati del lavoro. Sempre nel 1973, a malapena tollerata dal regime, si tiene a
Budapest la prima Mostra del Club dei Giovani artisti, autori di arte alternativa.
Perfino nel campo della musica leggera, che pu essere assegnata, sia pure in
senso lato alla sfera degli intellettuali nel senso proprio del termine, vi fu in Ungheria
durante lera del kdrismo post-56, unopposizione sotterranea alla dittatura comunista. Diversi cantanti lespressero in maniera figurata mascherandola con sottintesi pi o meno intuibili nelle proprie composizioni o in quelle scritte da altri
autori e da loro cantate. Un esempio emblematico che mi viene in mente una
canzone assai popolare negli anni Settanta, Ha n rzsa volnk (Se io fossi una
rosa), una splendida canzone scritta da Jnos Brdy nel 1973 e interpretata dalla cantante Zsuzsa Koncz, cos popolare in Ungheria, a partire dalla fine degli anni
Sessanta fino ai nostri giorni, da essere tuttora definita la signora della musica leggera
ungherese. Sebbene proibita dalla censura kdriana, che ne imped la diffusione via
radio fino al 1983, la canzone, dotata di una musica e di parole che prendono
lascoltatore, veniva cantata nei club studenteschi e in tutti i luoghi, pi o meno raccolti, dove si ritrovavano i giovani ungheresi, finendo per divenire un simbolo
della protesta giovanile al totalitarismo. Si pu parlare di un vero e proprio caso di
samizdat nel campo della musica leggera. In particolare, nel crescendo emotivo e
trascina