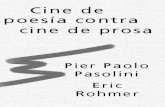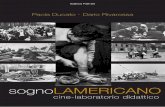Cine Forum 501
-
Upload
greg-voltron -
Category
Documents
-
view
116 -
download
0
Transcript of Cine Forum 501
-
Speciale Hereafter
Leigh, Villeneuve, Frears, Mendes, Hooper
Focus Vallanzasca Lisetta Carmi, unanima in cammino Cinema e Risorgimento Il cinema e il suo doppioTorino Film Festival
cineforum 501ci
nefo
rum
501
TRA I FILM NEL PROSSIMO NUMEROIL GRINTA LE STELLE INQUIETE UN GELIDO INVERNO
SPE
CIA
LI H
EREA
FTER
5
SC
HED
E V
ALL
AN
ZA
SC
A
LIS
ETTA
CA
RM
I C
INEM
A E
RIS
OR
GIM
ENTO
TO
RIN
O F
ILM
FES
TIV
AL
CineforumVia Pignolo, 12324121 BergamoAnno 51 - N. 1 Gennaio/Febbraio 2011Spedizione in abbonamento postale DL 353/2003 (conv.in L.27/2/2004 n. 46) art. 1, comma 1 - DCBPoste Italiane S.p.a.
8,00977
0009
7030
04
01501
Copertina_501.ai 25-03-2011 17:23:23Copertina_501.ai 25-03-2011 17:23:23
-
Ci si potrebbe domandare com che Cineforumnon riesce a fare a meno di dedicare regolarmenteuno speciale a ogni nuovo film di Clint Eastwood,quasi fosse una sorta di riflesso condizionato, unapropensione al tributo automatico che qualcunopotrebbe ritenere dettato dal timore di non omag-giare a sufficienza un regista troppo a lungo trascu-rato o sottovalutato (molto tempo fa, a dire il vero).Il fatto che negli ultimi ventanni Eastwood riu-scito a trattare soggetti ogni volta talmente diversida provocare sollecitazioni intellettuali culturali estoriche nuove e appassionanti in ciascuna occasio-ne. Al di l della valutazione sui risultati estetici deisingoli film (e comunque pur in presenza delle ine-vitabili sfumature ad avercene sempre, di cos),Eastwood sta delineando con maestria stupefacente,a partire da Gli spietati, una sorta di scaletta perso-nale degli argomenti sui quali intende dire qualco-sa, non di definitivo ma di importante s: qualcosache non pu non attirare lattenzione di chi pensache il cinema sia ancora uno degli strumenti espres-sivi indispensabili per comprendere il mondo in cuioggi viviamo. E il paradosso-Hereafter proprio que-sto si propone: mostrarci come ci deve essere neces-sario non perdere di vista ci che siamo, qui e ora,per vivere questa vita (lunica che abbiamo a nostradisposizione) in modo da non perderla.
E tanto per ribadire che la nostra vita fattaanche della nostra storia, individuale e collettiva,Cineforum non poteva dimenticarsi, in un momen-to come questo, di verificare come il cinema nazio-nale si sia occupato, nel corso degli anni, del nostroRisorgimento: evento senza dubbio complesso chein molti oggi sono per interessati a rendere contro-verso non sempre per motivi di chiarezza storica
Il discorso era gi iniziato sul n. 500 con lo specia-le dedicato a Noi credevamo, ma ci sembra giustoallargarlo a una considerazione, motivata e appro-fondita, su quale rappresentazione delRisorgimento viene data dai film: film che hannoscandito la storia del nostro Paese e del suo cinemadurante il XX secolo, stabilendo con il loro tempo econ il tema in questione un rapporto di volta involta definibile in funzione dellimmaginario chia-mato in causa e dellapproccio ideologico a essorelativo. Provocando di conseguenza diverse moda-lit di accoglienza da parte di pubblici diversi percollocazione cronologica. Non dunque un semplicecatalogo di titoli ma una ricognizione che, muo-vendo dai film, li travalica alla ricerca degli elemen-ti profondi che li fanno produttori di senso: e delmodo in cui tale senso si configura, a partire dalcontesto di riferimento.
Il Mondo e la Storia come il cinema sono fatti dimovimento incessante e di tempo che scorre.Entrambi non esistono veramente se non nella nar-razione. Entrambi sono proiettati probabilmenteverso qualcosa che assomiglia a una fine, ma nes-suno ne pu avere la certezza. Quando perciEjzenstejn innalza il suo canto al moto continuo eprogressivo della macchina destinato a strappareper sempre luniverso contadino dalla sua inerziaoblomoviana, sa benissimo di scrivere con le sueimmagini un inno al cinema stesso, senza il qualelebbrezza del rapimento nella dimensione colletti-va della Storia non potrebbe essere raccontata.Questo numero di Cineforum si misura dunquecon le categorie che costituiscono il cuore pulsantedel nostro esserci, complici il cinema e i film, comesempre.
Adriano Piccardi
PRESENTE STORICO
500_01-03_Editoriale1.qxd 23-03-2011 22:43 Pagina 1
-
Mentre in corso la cinquantesima stagione delLaboratorio 80, gi cineforum di Bergamo e a suo tempouno dei membri fondatori della Fic, a pochi giorni dal-luscita del numero 500 della rivista Cineforum, scom-pare Piercarlo Nolli. Improvvisamente, inaspettatamen-te, se ne andato un personaggio importante per lazio-ne che ha svolto tra la fine degli anni Sessanta e i tredecenni successivi, prima di dedicarsi completamenteallesercizio cinematografico, anche qui con scelte auda-ci e lungimiranti. Preferiamo collocare la figura diPiercarlo in un contesto che coinvolge aspetti umani,politici, culturali, perch pensiamo che il suo percorso sisia dipanato attraverso una complessit di relazioni edespressioni, che vanno dallamicizia, dalle espressioni delcarattere, dalle contrapposizioni ambientali, alla capaci-t intuitiva, alla sensibilit ai cambiamenti e allinsoffe-renza per le regole, per la routine, per il conformismo.
Gi nei primi anni Settanta si lavora con lui a unprogetto di associazione nuovo, pi versatile, pi aper-to, pi vivace: non solo cinema, ma anche teatro, musi-ca, fumetto, grafica, video. Il Lab 80, insomma: forsela sua invenzione pi importante e dirompente, un lie-vito madre che porter alla creazione della Lab 80film, la cooperativa di distribuzione nata nel 1975,votata a far conoscere in Italia il cinema censuratodalla distribuzione commerciale. Ma Lab 80 volevadire, per le persone coinvolte nel progetto, soprattuttouna scelta di vita: il lavoro a tempo pieno e labbando-no del volontariato, lacquisizione di competenze sulcampo, lo studio delle ambiguit linguistiche insite neimeccanismi rappresentativi, lassunzione di un vero eproprio impegno politico per far conoscere le culture
alternative, opere e autori maledetti, lo scavo nelleideologie e il disvelamento degli apparati di potere.Questa azione ininterrotta di scoperta era accompa-gnata dallattenzione ai fermenti, ai conflitti, alle ribel-lioni, alle contestazioni che agitavano i gruppi e leclassi sociali in Europa e nelle altre parti del mondo.Era una scuola e un esercizio di libert, da cui veniva-no quasi per conseguenza logica la voglia, per non direil bisogno, di rischiare, di non guardare in faccia a nes-suno, di non accettare compromessi, di non acconten-tarsi mai del lavoro fatto ma di tentare sempre stradenuove, mettendo in gioco se stessi. Lostinazione chederivava dallentusiasmo, lincoscienza che crescevacon il desiderio, leccitazione che accelerava il raggiun-gimento del sogno, linvestimento di pensieri e di ener-gie che relegava sullo sfondo qualsiasi preoccupazioneeconomica.
Piercarlo stato regista e attore di una storia entu-siasmante, in anni difficili di eventi laceranti, ma digrandi appetiti culturali, di voglia di conoscere e disperimentare. Nella rivista ha portato elementi graficiinnovativi e inserito collaboratori giovani, quando diventato esercente ha sfidato con successo i multiplexcreando una multisala di qualit in pieno centro citta-dino, forse il primo in Italia a capire che la partitaandava giocata sul terreno dellintelligenza e non dellasemplice concorrenza, che sarebbe certo risultata per-dente. Ora che le acque ristagnano e le menti pure, chesi sta diffondendo lepidemia della rassegnazione, nelnostro piccolo e consapevoli della nostra debolezza,preferiamo mantenerci liberi, incoscienti e assoluta-mente marginali. (a.s.)
IL CINEMA, CON ENTUSIASMO E INTELLIGENZA
Un autore, uninterprete, un film molto amati da Piercarlo:Luis Buuel, Jeanne Moreau sul set di Il diario di una cameriera,1964
500_01-03_Editoriale1.qxd 23-03-2011 22:43 Pagina 2
-
3cine
foru
m50
1
SOMMARIOEDITORIALEAdriano Piccardi/Presente storico 1Il cinema, con entusiasmo e intelligenza (a.s.) 2
SPECIALE HEREAFTERAlberto Pezzotta/Andare oltre 4Anton Giulio Mancino/LAldiqu 7Pietro Bianchi/Una verit estranea a questo mondo 11Pier Maria Bocchi/Il nuovo capolavoro di Clint Eastwood 14
I FILMPasquale Cicchetti, Fabrizio Tassi/Another Year di Mike Leigh 17Roberto Manassero/La donna che canta di Denis Villeneuve 22Roberto Chiesi/Tamara Drewe di Stephen Frears 25Simone Emiliani/American Life di Sam Mendes 28Paola Brunetta/Il discorso del Re di Tom Hooper 31
Simone Emiliani, Paola Brunetta, Lorenzo Leone, Nicola Rossello, AlbertoPezzotta, Elisa Baldini, Giacomo Calzoni, Federico Pedroni/Parto col folle - Gianni e le donne - Kill Me Please - Vento di primavera - Il truffacuori - Qualunquemente - La versione di Barney - Biutiful - I fantastici viaggi di Gulliver - The Green Hornet 34
FOCUS VALLANZASCAAnton Giulio Mancino/Fotoromanzo criminale 44
FOCUS LISETTA CARMI, UNANIMA IN CAMMINOTullio Masoni/Interrogarsi sullumanit 48
I MIGLIORI DEL 2010secondo i collaboratori di Cineforum 51
SAGGI CINEMA E RISORGIMENTOGiuseppe Ghigi/Viva lItalia 53
IL CINEMA E IL SUO DOPPIOSergio Arecco/Larchitetto, il pittore e la centrifuga 63
TORINO FILM FESTIVALAlberto Morsiani/Concorso 70Giampiero Frasca/Festa mobile Figure nel paesaggio 73Chiara Borroni/Festa mobile Paesaggio con figure 75Lorenzo Donghi, Attilio Palmieri/Onde 77Lorenzo Rossi/Rapporto confidenziale 78Paolo Vecchi/Retrospettiva John Huston 80Gianluigi Bozza/Retrospettiva Vitalij Kanevskij 82Chiara Zingariello/Figli e amanti 84
FESTIVALBruno Fornara/Cinema Ritrovato: Ford! Ford! Ford! 86
DVD a cura di Roberto Chiesi e Tullio Masoni 88LE LUNE DEL CINEMA a cura di Nuccio Lodato 91LIBRI E SOUNDTRACKS a cura di Ermanno Comuzio 96IINNFFOO dal luned al venerd - 9.30/13.30 - Tel. 035 361361 - [email protected]
cciinneeffoorruummrriivviissttaa mmeennssiilleeddii ccuullttuurraa cciinneemmaattooggrraaffiiccaa
aannnnoo 5511 -- nn.. 11 -- GGeennnnaaiioo // FFeebbbbrraaiioo 22001111
Edita dallaFFeeddeerraazziioonnee IIttaalliiaannaa CCiinneeffoorruumm
DDiirreettttoorree rreessppoonnssaabbiillee::Adriano Piccardi [email protected]
CCoommiittaattoo ddii rreeddaazziioonnee::Chiara Borroni, Gianluigi Bozza (direttoreeditoriale), Roberto Chiesi, Bruno Fornara,Luca Malavasi, Emanuela Martini, AngeloSignorelli, Fabrizio TassiGGrruuppppoo ddii llaavvoorroo:: Francesco Cattaneo, Jonny Costantino, Giuseppe Imperatore,Arturo Invernici
CCoollllaabboorraattoorrii::Sergio Arecco, Alberto Barbera, AlessandroBertani, Paolo Bertolin, Marco Bertolino,Francesca Betteni-Barnes D., Matteo Bittanti,Pier Maria Bocchi, Andrea Bordoni, MassimoCauso, Rinaldo Censi, Carlo Chatrian, ErmannoComuzio, Emilio Cozzi, Giorgio Cremonini,Alberto Crespi, Lorenzo Donghi, SimoneEmiliani, Michele Fadda, Davide Ferrario,Andrea Frambrosi, Giampiero Frasca, LeonardoGandini, Cristina Gastaldi, Federico Gironi,Fabrizio Liberti, Nuccio Lodato, PierpaoloLoffreda, Anton Giulio Mancino, GiacomoManzoli, Michele Marangi, Matteo Marino,Mattia Mariotti, Tullio Masoni, EmilianoMorreale, Alberto Morsiani, Umberto Mosca,Luca Mosso, Lorenzo Pellizzari, AlbertoPezzotta, Francesco Pitassio, Piergiorgio Rauzi,Giorgio Rinaldi, Nicola Rossello, Lorenzo Rossi,Alberto Soncini, Antonio Termenini, DarioTomasi, Paolo Vecchi, Alberto Zanetti.
PPrrooggeettttoo ggrraaffiiccoo ee iimmppaaggiinnaazziioonnee::Paolo Formenti - PiEFFE Grafica*
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee::Cristina Lilli, Sergio Zampogna
RReeddaazziioonnee ee aammmmiinniissttrraazziioonnee::VViiaa PPiiggnnoolloo,, 112233IITT--2244112211 BBeerrggaammootel. 035.36.13.61 - fax 035.34.12.55e-mail: [email protected]://www.cineforum.it
AAbbbboonnaammeennttoo aannnnuuaallee ((1100 nnuummeerrii))::Italia: 60,00 EuroEstero: 80,00 EuroExtra Europa via aerea: 95,00 EuroVersamenti sul c.c.p. n. 11231248intestato a Federazione Italiana Cineforum, via Pignolo, 123 - 24121 Bergamoe-mail: [email protected]
ssppeeddiizziioonnee iinn aabbbboonnaammeennttoo ppoossttaalleeDDLL 335533//22000033 ((ccoonnvv.. iinn LL.. 2277//0022//22000044 nn.. 4466)) aarrtt..11,, ccoommmmaa 11,, DDCCBB -- BBeerrggaammoo
stampato presso la SSttaammppeerriiaa SStteeffaannoonniiBergamo - via dellAgro, 10
DDiissttrriibbuuzziioonnee iinn lliibbrreerriiaa::Joo Distribuzione - via F. Argelati 3520143 Milano - tel. 028375671 - fax 0258112324 e-mail: [email protected]
Iscritto nel registro del Tribunale diVenezia al n. 307 del 25-5-1961
associato allUSPIUnione Stampa PeriodicaItaliana
IInn ccooppeerrttiinnaa:: Another Yeardi Mike Leigh
501_01-03_Editoriale1.qxd 25-03-2011 22:29 Pagina 3
-
4cine
forum
501
Come Invictus (id., 2009), Hereafter manifesta linten-zione di Eastwood di fare i conti con la storia recente.Lo tsunami che ha devastato il Sud Est asiatico alla finedel 2004 e gli attentati terroristi a Londra nel luglio2005 non sono il centro del film, ma non sono nemme-no un pretesto: attraversano la vita dei personaggi, e invaria misura la cambiano. Sono lo sfondo su cuiEastwood imposta un discorso che, come dice eloquen-temente il titolo inglese (non cos immediatamente deco-dificabile per lo spettatore italiano), si riferisce allaldi-l. La strategia della sceneggiatura di Peter Morgan chiara: partire dalle tragedie contemporanee, che sianocausate dalla natura o dalluomo, per riflettere su ciche ci aspetta dopo la morte.
Analogamente allitaliano al di l, linglese hereaf-ter nasce come avverbio prima di diventare nome. Ecome avverbio, non ha un significato metafisico: signifi-ca solo da qui in poi. Il concetto ancora pi laico chein italiano, dove lespressione al di l, prima di diven-tare un sostantivo, allude comunque a un superamento,a qualcosa di ulteriore. Hereafter, invece, da qui inpoi, o dora in poi, qualcosa di molto pi prosaico.In effetti, nel film, lo stesso medium George, che comu-nica da anni con i defunti, dice di non saperne molto suci che effettivamente ci aspetta dopo. C un dopo, macosa lo riempia non si sa.
Malgrado ci, il rischio di una deriva new age, usiamopure questo termine sintomo di obbrobrio, era certo
HEREAFTER Clint EastwoodSPECIALE
ANDARE OLTREAlberto Pezzotta
501_04-15_eastwood 23-03-2011 22:41 Pagina 4
-
5cine
forum
501
possibile, nel momento in cui le tragedie contingentidella Storia fossero state messe nella prospettiva del-leternit che tutto relativizza. Merito di Morgan, diEastwood o di entrambi, ci nel film non avviene. Il rap-porto tra aldiqu e dopo, se non altro, sempre fil-trato da una prospettiva strettamente individuale e indi-vidualista, mai trascendente. Qui si vede molto bene(come si vedeva in Invictus) la mentalit americana, cheesalta leccezionalit del singolo che emerge dallaStoria. Ma questa scelta di umanesimo radicale, antisto-rico e a-sociale, trae valore etico nel fatto che del singo-lo Eastwood sottolinea la fragilit e la finitezza. Il singo-lo (che anche solitario: George da tempo solo, Mariee Marcus lo diventano), posto sul crinale tra la Storia eci che c dopo, rivela la sua vulnerabilit, la suamancanza di difese. Hereafter, pi che un film su ci che designato dal titolo, un film sul dolore, sulla finitez-za. In questo senso coerente e necessario nellevoluzio-ne del cinema di Eastwood, e aggiunge anche qualcosadi bello e di toccante ai suoi ultimi film che, come GranTorino (id., 2008), sembrano vette oltre le quali diffi-cile immaginare un seguito.
A chi segue da anni la filmografia di questo regista, fin troppo facile analizzare Hereafter alla luce delleopere precedenti, per trovare la coerenza di uno svilup-po tematico, e magari bearsi di rinvenire temi metafisi-cifin dagli anni Settanta. Daccordo, il pistolero di HighPlains Drifter (Lo straniero senza nome, 1973) proba-bilmente era un fantasma, e magari anche il giustiziereapocalittico di Pale Rider (Il cavaliere pallido, 1985).Eastwood ha gi girato un breve film di fantasmi, nel1985: Vanessa in the Garden, episodio della serie televi-siva Amazing Stories ideata da Steven Spielberg (chedi Hereafter uno dei produttori esecutivi), dove ladonna amata torna nella realt evocata dal pittore chela dipinge. E allora? Lanalisi autorialista rinviene ricor-renze, e in ci si autogiustifica; mentre sarebbe piimportante sottolineare le differenze tra il lato fantasti-co dellEastwood passato e quello odierno. Ci che sem-bra emergere, invece, film dopo film, a almeno a partireda Honkytonk Man (id., 1982), una riflessione sullafragilit della vita e limpotenza delluomo. In questaprospettiva, la celebre frase pronunciata da Eastwoodattore in A Perfect World (Un mondo perfetto, 1993),Io non so niente, e che nel contesto di quel film sem-brava unautoassoluzione e una dichiarazione program-matica un po facile, si arricchisce, di film in film, di unasostanza umana pi profonda.
Ovvio sottolineare come il mlo, a partire da un certopunto, e prima ancora di The Bridges of MadisonCounty (I ponti di Madison County, 1995), abbia gioca-to un ruolo importante nel cinema eastwoodiano, for-nendogli la gabbia di genere e larmamentario retoricoper parlare di temi come la perdita e la morte, evidente-mente da lui sentiti come rilevanti. In Hereafter il mlo
affrontato direttamente e nel modo pi rischioso, nelsegmento in cui il piccolo Jason viene travolto da unau-to mentre sta fuggendo da alcuni teppisti. La morte diun bambino il peggio, in termini di ricatto emotivo. Maa differenza che in tanti film precedenti di Eastwood,dove la morte lacrimevole avveniva alla fine, qui avvie-ne allinizio. Non che questo sia una novit, certo, ma dun senso pi pregnante al titolo: hereafter, da questomomento in poi, sei solo e te la devi vedere tu. E il fattoche il personaggio in questione sia un ragazzino, evitaogni eroicizzazione.
Con Hereafter il cinema di Eastwood sembra fare ameno del personaggio eroico, sacrificale e comunqueeccezionale indispensabile nel suo cinema. WaltKowalski di Gran Torino stato lultimo di una lungaschiera che comprende il cantante country Red Stovall,Charlie Parker e donne come la pugile di Million DollarBaby (id., 2004) e la madre ostinata di Changeling (id.,2008), che dei film di Eastwood recenti forse il menocompreso e pi sottovalutato. Forse solo Letters fromIwo Jima (Lettere da Iwo Jima, 2006) faceva a meno dieroi. Certo, si pu obiettare, il medium George porta sudi s le stimmate dellunico. Ma lo stesso non si pu diredi Marie e di Marcus: sono individui, ma non unici.Della prima, in realt, possiamo anche dire che non esi-ste come personaggio, che di lei non ci importa molto, eche nella sceneggiatura ha solo un ruolo di servizio,quello di favorire lincontro tra Marcus e Jason. Colpadella sceneggiatura, probabilmente, e di unattrice il cuitalento ed empatia non sono folgoranti. Ma importan-te, allinterno del film, la mediet e normalit del perso-naggio, che si trova eco anche nelle altri parti. Che lexmedium George sia licenziato da una fabbrica per esu-bero di personale e sia tentato di riprendere il suo vec-chio lavoro, non solo un tocco di realismo sociale con-temporaneo, ma un modo intelligente di abbassare, ditogliere enfasi alla comunicazione con laldil. E ilragazzino (Eastwood un grande direttore di ragazzini) semplicemente perfetto e normale, senza smancerie.
Non un film privo di difetti, Hereafter. Soprattuttonellepisodio francese, la sceneggiatura infila una seriedi scivoloni abbastanza imperdonabili, come la cial-tronissima discussione su luci e ombre nella vita diMitterrand. E cos come i francesi avranno da lamen-tarsi di quella torre Eiffel che spunta ovunque perchiarire che siamo a Parigi, gli italiani non possonodigerire il cuoco del corso di cucina (doppiato in quelmodo, poi), che affetta pomodori con Puccini in sotto-fondo. Cos come non un granch il finalino in cuiMarcus sembra improvvisamente dotato non solo dicapacit medianiche, ma anche del dono della preveg-genza, e sembra vedersi in flash forward baciare holly-woodianamente lanima gemella infine ritrovata.Eastwood ci ha abituato a ben altri finali, penso soloalla solitudine di Frankie Dunn alla fine di Million
501_04-15_eastwood 23-03-2011 22:41 Pagina 5
-
6cine
forum
501
Dollar Baby. Ma per una volta si pu anche vedereoltre, al di l.
Hereafter la risposta di Eastwood alla domanda sucome si possa e si debba continuare a fare film dopoavere raccolto tanti allori. A Eastwood fare film, pare dicapire, sembra necessario in un mondo devasto dallafollia e dal dolore. Ed commovente che un regista diottantanni voglia occuparsi del mondo presente, e conpudore estremo parli delle tragedie che hanno sconvoltoil suo Paese. In Invictus laereo che sorvola lo stadioinnesca unombra di minaccia subito dissolta: non vuoleschiantarsi su migliaia di persone, ma solo fare gli augu-
ri alla nazionale di rugby. E innesca una nostalgia strug-gente per un mondo, quello del 1995, in cui non si con-cepiva che gli aerei di linea potessero essere usati comearmi distruzione di massa.
In Hereafter, levocazione di sguincio degli attentati diLondra del 2005 un passo in pi verso lirrappresen-tabile, l11 settembre 2001. Non a caso Eastwood sce-glie di rappresentare lo tsunami iniziale con tutto il rea-lismo allucinante permesso oggi dagli effetti digitali(realizzando, tra parentesi, una sequenza emozionante eimpressionante, sobria per lassenza di musica se nonalla fine, e terribilmente bella da vedere). Al contrario, larappresentazione dellattentato terrorista ridotto a unbotto e a una fiammata che esce da una galleria. Lorroredella natura appartiene pur sempre alla sfera del subli-me che, kantianamente, ribadisce la nostra finitezza.Mentre la morte inflitta dalluomo alluomo va oltreogni logica ed molto meno rappresentabile. Per questola sequenza il cui il piccolo Marcus rincorre il suo ber-retto tra le gambe della folla un momento di grandeetica della visione: solo alla fine capiamo che in questomodo evita di morire, solo alla fine ci ricordiamo che il 7 luglio 2005 (e solo oltre sapremo che stato ilgemello morto a intervenire facendogli cadere il berret-to). Per rappresentare una tragedia, bisogna attaccarsi aqualcosa di molto piccolo e marginale, come un bambi-no che si preoccupa solo di cercare il suo cappello.
Titolo originale: id. Regia e musica: Clint Eastwood.Sceneggiatura: Peter Morgan. Fotografia: Tom Stern.Montaggio: Joel Cox, Gary D. Roach. Scenografia: JamesJ. Murakami. Costumi: Deborah Hopper. Interpreti: MattDamon (George Lonegan), Ccile de France (MarieLelay), Frankie McLaren (Marcus), George McLaren(Jason), Thierry Neuvic (Didier), Jay Mohr (Billy),Richard Kind (Christos), Lyndsey Marshal (Jackie),Bryce Dallas Howard (Melanie), Marthe Keller (la dotto-ressa Rousseau), Tom Beard (il prete), Jenifer Lewis(Candace), Annette Georgiou (linfermiera June), JackBence (Ricky), Derek Jacobi (se stesso), Steve Schirripa(Carlo), Mylne Jampano (Jasmine), Niamh Cusak (lamadre di Foster), George Costigan (il padre di Foster),Paul Anthony-Barber (Nigel), Selina Cadell (la signoraJoyce), Sean Buckley (il dottor Meredith). Produzione:Clint Eastwood, Kathleen Kennedy, Robert Lorenz perMalpaso Productions/Amblin Enetertainment/TheKennedy-Marshall Company. Distribuzione: WarnerBros. Durata: 129. Origine: Usa, 2010.
Dicembre 2004. La giornalista televisiva franceseMarie, travolta dallo tsunami in Thailandia, sopravvi-ve dopo avere avuto una breve esperienza dellaldil.
Decide di scrivere un libro sullargomento, incontrandoscetticismo e perdendo il sostegno di chi la circonda.ASan Francisco George ha smesso di fare il medium.Essere tramite di persone in cerca di messaggi da partedei loro cari defunti era troppo doloroso. Lincontrocon una ragazza che frequenta con lui un corso di cuci-na lo conferma che il suo non un dono, ma una con-danna che lo porta inevitabilmente alla solitudine.Dopo essere stato licenziato dalla fabbrica in cui lavo-ra, George quasi convinto dal fratello a riprendere lasua attivit di medium, ma alla fine molla tutto e parte.A Londra il piccolo Marcus ha perso il fratello gemelloJason in un incidente. Dato che la madre tossicodi-pendente, viene affidato a una famiglia. Ma Marcus nonsi d pace, ruba soldi e fugge di casa per chiedere a variciarlatani di mettersi in contatto con Jason. I destini deitre si incrociano alla London Bookfair, dove Marie pre-senta il libro che ha scritto. Marcus convince George amettersi in contatto con il fratellino defunto, che glirivela di averlo salvato in occasione dellattentato allametropolitana del 7 luglio 2005. Ma dora in poi, dice,dovr affrontare la vita da solo. George, colpito dallibro di Marie, fissa un appuntamento con lei. Si potrfinalmente innamorare.
HEREAFTER Clint Eastwood
501_04-15_eastwood 23-03-2011 22:41 Pagina 6
-
7cine
forum
501
Perch mai un cineasta oltremodo maturo, consape-vole dei propri mezzi, dovrebbe imbarcarsi in un filmsullaldil? Probabilmente perch aveva in mente dicapovolgere lassunto oltremondano, fare un film sul-laldiqu, ribadire come non esista strada che nonconduca al presente, al tempo e al luogo presente. Hicet nunc, qui e ora. Non c altro dopo, n si pu vive-re sepolti nel passato, dipendenti dal passato, incapa-ci di cambiare, comprendere, vivere il presente, nelpresente. Nessuno indispensabile, e nello stessotempo tutti lo sono come anelli di una catena di rap-porti che di volta in volta si rinnova, si estende, proce-de. Come si pu notare, quella di Hereafter una pro-spettiva concreta, pragmatica, sostenibile. Si pu pren-dere il film in blocco, dal principio alla fine, o passare
in rassegna ogni scena o sequenza, e risultato sar sor-prendente. possibile rileggerlo alla luce di questaconcezione immanente dellesistenza che non ammet-te scorciatoie mistiche, religiose, pseudo-scientifiche dinessun tipo. Non ammette insomma nessuna religionedella Storia, nessun dover essere in funzione di unobiettivo trascendente, nessuna teleologia. Soltantouna visione responsabile del proprio stare al mondo,del costruire rapporti realistici e ragionevoli, sapendoindividuare uno spazio di comunicazione e di convi-venza semplice, diretto, sensato. Al di fuori o al di l il caso di dire di questo spazio relazionale effettivoe tangibile nulla assume un valore praticabile, spendi-bile, godibile nella vita quotidiana.
Cominciamo dalla lunga sequenza iniziale dello tsu-
LALDIQUAnton Giulio Mancino
501_04-15_eastwood 23-03-2011 22:41 Pagina 7
-
8cine
forum
501
nami. Emozionante, efficace, grazie allequilibrio inec-cepibile dellumano e del digitale. Ma di quale valoreaggiunto, coerente con lintero film, si fa portatrice?Siccome questa sequenza avvia il film, ne connota lalogica sistematica, tocca al film stesso pi in l, versola fine provvedere a decodificarla, siglando cos unaorganizzazione interna, una sorta di mutuo soccorsotra rappresentazione e interpretazione. Marie rimpro-vera infatti al suo ex compagno non tanto di aversmesso di amarla e rimpiazzata con una nuova giorna-lista televisiva, bens di non aver condiviso con leilesperienza pi importante, determinante, drammati-ca: non si trovato con lei, paradossalmente, almomento giusto, al posto giusto e per la ragione giu-sta: in strada durante lo tsunami per comprare unregalo ai figli. Pertanto il loro rapporto viene spazzatovia non tanto dalla catastrofe naturale, che in quantonaturale svolge pur tragicamente una funzione preci-sa, coerente, riequilibrante, ma dalla mancanza del-luomo di uscire dal letto per i propri figli. E affronta-re in strada il proprio destino, lo tsunami, in quantopadre. Marie, alla resa dei conti, nel comprendere espiegare il senso fallimentare della relazione sentimen-
tale pregressa, restituisce a valle il significato simboli-co della sequenza chiave a monte del film.
I rapporti umani nel film riflettono i rapporticostringenti del film. Sono questi stessi rapporti,strutturali (per quanto riguarda il film), interpersona-li (per quanto riguarda i personaggi) a costituire las-se portante delloperazione Hereafter, la logica pro-fonda sottesa. Proprio come tra di loro tutti i perso-naggi, soprattutto i tre protagonisti, elaborano sulpiano strettamente narrativo un rapporto transnazio-nale, globale, assurgendo al ruolo di famiglia idealedislocata su scena planetaria: padre (George), madre(Marie), figlio (Marcus). Non un caso che il nomedella donna, Marie, e quello del ragazzino, Marcus,abbiano la stessa iniziale. Cos come quello delluo-mo, George, fonicamente sia equivalente al nome delfratello gemello e alternativo di Marcus, Jason. QuelJason che proprio George con i suoi poteri veri opresunti, terapeutici e traumatizzanti, a evocare.Magari a impersonare a fin di bene. Una famiglia checontiene, esemplifica, sintetizza al suo interno unmodello di societ in cui i membri sono intercambia-bili, presenti/assenti, ubiqui ma perfettamente com-patibili, possibili, auspicabili. Compresa la strategiache assimila il principio spettacolare ed emotivo delfilm senza esserne subissata (e qui bisogna ammetter-lo: la simbologia dello tsunami coincide con il suocontenuto letterale), si rende percorribile la vicendanel suo complesso, dove appunto non conta tanto cre-dere nellaldil, credere alle facolt paranormali diGeorge, credere a ci che il film mostra con i suoistrumenti tradizionali, codificati, pertinenti (le visionidi George le cui modalit espressive, anticipatedurante lesperienza di Marie, quindi da Marie stessache ne cronologicamente la precorritrice, obbedisco-no ai consueti canoni del film fantastico).
Il punto, per Clint Eastwood, che beneficia di unasceneggiatura sobria, poco melodrammatica e ancormeno mistica di Peter Morgan, farsi carico del pre-sente, credere a ci che c, adoperando il buon senso.Anche attraverso laldil, servendosi dellaldil, confi-dando persino nellaldil come mezzo, non come fine.Del resto, per un fuoriclasse del suo stampo, il para-normale di cui parla la dottoressa tedesca diventaanche il fronte su cui il sapere non istituzionale, mar-ginale ed emarginato sfida lestablishment della cono-scenza ufficiale, consolidata. Laldil su cui operano iricercatori trasgressivi il sintomo del sentirsi,dichiararsi indipendenti: diventa loggetto di contrap-posizione eroica, minoritaria sul piano accademico mamaggioritaria sul piano umano e societario, antagoni-sta rispetto a un potere elitario che viene a essere eser-citato, mediante il sapere, sul mondo reale, sui suoimeccanismi interpretativi, sulla sua effettivit. Ma anche una dimensione in cui si gioca la partita diffici-
501_04-15_eastwood 23-03-2011 22:41 Pagina 8
-
le e mai risolutiva della costruzione dei rapportiumani. Laldil pi inaccessibile la stabilit di talirapporti, la sicurezza di poterli mantenere, far vivere,resistere senza incomprensioni, sensi di colpa poten-ziali che successivamente si trasformerebbero in fatto-ri destabilizzanti permanenti. George non sa granchdella vita, ma sa tutto questo, e tanto basta. Lo sasulla propria pelle, sul proprio vissuto, sulla propriaquotidianit in cui il licenziamento giunge come unfulmine a ciel sereno, ma non per questo rinuncia aitentativi timidi, volenterosi, pacifici di approccio affet-tivo. Tentativi normali sconvolti puntualmente dalparanormale. Conosce, sconta il prezzo suo malgradodel precariato lavorativo e della precariet di ognirelazione allorizzonte, che deve fare i conti con il pas-sato: da un lato il suo passato di medium che sciupaogni equilibrio paritario con le partner; dallaltro ilpassato di ogni sua partner destinato prima o poi aergersi a muro implacabile.
In buona sostanza la pericolosa partita si gioca suquesta terra, in questo mondo. Partita che lautore diChangeling (id., 2008), Gran Torino (id., 2008) eInvictus (id., 2009) insiste nellesplorare cominciando
dai pi piccoli, i bambini, figure provvidenziali, risolu-te eppur fragili, alloccorrenza risolutive, premesse diun progetto comunitario allargato, transcontinentalecome la vicenda medesima del film. Sono i bambini, ifigli lontani, lontani dalla Francia, ai quali luomo nelletto dalbergo non pensa, la bambina asiatica chediventa subito per Marie la creatura pi importante dasalvare, bambini chiamati in causa non esclusivamen-te sul/dal piano simbolico, a generare leffetto tsunamiche dalla prima sequenza si abbatte sul resto del film.La storia di Marcus e Jason, altrove, in Inghilterra,riproduce su un versante sociale pi disagiato un iden-tico, insospettabile ambito problematico, in cui unal-tra madre, pur debilitata dalla tossicodipendenza(come Marie a sua volta un prodotto della tv, unateledipendenteprivilegiata, davanti alla telecamera eai riflettori, sui manifesti per strada), riesce a stare e afarsi amare, amandoli, dai figli, che per lei si ribellanoallistituzione sociale, obbedendo al prototipo chapli-niano (Charlie Chaplin era infatti, come Marcus eJason, nato a Londra e apparteneva alla classe bassa)che gi in Changeling era stato esplorato con i richia-mi allusivi alla figura di Jackie Coogan di The Kid (Il
9
cine
forum
501
501_04-15_eastwood 23-03-2011 22:41 Pagina 9
-
monello, 1921) e alla contestuale pericolosit autorita-ria congiunta della polizia e dei servizi sociali.Premessa fondamentale perch impone a Marcus, conla sua ostinazione a cercare, ad andare oltre, a rifiuta-re di conseguenza, sistematicamente, le grandi rispo-ste, le mistificazioni ideologiche e religiose, i massimisistemi contemporanei, il cattolicesimo come lislami-smo, le performance dei sensitivi da palcoscenicotanto quanto la generosa e comprensiva ma disarma-ta famiglia ospitante.
Donde la necessit di immettere nel sistema rela-zionale il terzo tassello che sigla, con lingresso delloscenario statunitense, il racconto tripartito: quello diGeorge, personaggio dotato di poteri straordinari etuttavia schiacciato da questi, addirittura infortuna-to, poich egli non un supereroe, non un giustizie-re n un risolutore di problemi, problemi altrui ntantomeno di propri. Si presenta nelle vesti di perso-na disponibile al cambiamento di status sociale (ilchangeling ispira il suo modus vivendi), sottotono,pronto a rendere accettabile la presenza degli spiritidei defunti grazie alle sue infauste possibilit di veg-gente. In questo egli lemblema stesso del cinema,
sin dalle origini: un cinema griffithiano, perci per lostoryteller classico Eastwood assolutamente paradig-matico, che pu far coesistere epoche diverse, ricon-giungere presenti distanti, ricomporre dimensionireali e fantastiche.
Attraverso Marie, Marcus, George si riflette il pre-sente, lunico ragionevole, concepibile, dicibile in tuttele sue componenti e i suoi limiti endemici a livello sto-rico, politico, sociale, culturale, scientifico, che conver-gono in un unico alveo, quello esistenziale, coinvolgen-do il privato, il familiare, il quotidiano. Da questo pre-sente cos riconfigurato, riassunto, essenzializzato siricava una misura sostenibile, concreta, fattiva diintervento. Dove i defunti o i fantasmi dicono attra-verso George, forse colui che parla non soltanto perloro ma anche con loro cose dettate dal buon sensopi che dalla eccezionalit fantastica, mistica, immagi-nifica della situazione: parole che riavvicinano genito-ri e figli, nonostante tutto, mariti e mogli, fratelli.Insomma, dove tutto viene ricondotto a un principioispiratore fondamentale, quello della riconversione(ancora: changeling), che ha gi segnato la svoltaeastwoodiana da decenni. E che viene quindi ribaditoda George quando, minimizzando sulla genesi doloro-sa dei suoi poteri, precisa di aver allora scoperto lepriorit della vita. Non per niente, quando indicaDickens come scrittore preferito, chiama in causa con-temporaneamente sia la priorit della condizioneinfantile ingrata e nondimeno forte, resistente, sia unlibro, inevitabilmente Racconto di Natale, dove ifantasmi spaventosi dellaldil sono al servizio dellal-diqu: del bilancio esistenziale del vecchio, tremendoScrooge e del suo cambio di rotta esistenziale, non inquello ma in questo mondo.
Come non dar ragione al vecchio Clint, al suo filmdeliberatamente antifrastico, quando confuta leaspettative del tipico, convenzionale e a senso unicofilm hollywoodiano alla Shyamalan? Fa dire allo spi-rito di Jason di aver fatto saltare il suo cappellinodalla testa del gemello Marcus non per salvarlo dal-lattentato nella metropolitana londinese (effetto col-laterale positivo, comunque, le cui origini violente eprofonde sono comunque da ricercare altrove, reli-giose, ideologiche, politiche), di cui forse non sapeva(George, come lui, al posto suo, non sapeva), ma per-ch stanco di vederglielo ancora indossare, senzainvece imboccare una strada indipendente. Marcusdal canto suo restituisce il favore a George adoperan-do il solito buon senso per scoprire e segnalargli lho-tel di Marie. Cosicch a George, non luomo che sape-va troppo ma quello che sapeva e sa troppo poco,non resta che (pre)vedere lunica soluzione deside-rabile, auto-augurabile per lincontro con Marie: lin-sorgenza di un amore. Nella speranza che sia labuona volta. Quella giusta.
10
cine
forum
501
501_04-15_eastwood 23-03-2011 22:41 Pagina 10
-
noto che quando si ha a che fare con le traduzio-ni non ci si possa mai limitare solamente al transito diuna parola da una lingua a unaltra lasciandone inal-terato il significato. Si dice sempre qualcosa di pi,qualcosa di diverso, qualcosa di inavvertito. indica-tivo, e in qualche modo ironico, che quello che in ita-liano chiamiamo aldil si traduca in inglese con here-after. Non l (aldi-l) dunque nello spazio, ma quasilopposto: qui (here) e dopo (after). Laldil non altrove, ma qui. Non in un altro luogo, ce labbiamodi fronte, quando solca e definisce lo spazio e il tempodelloggi, della vita che viviamo: non di quella che sup-poniamo ci attenda dopo la morte. Se non si conside-ra materialisticamente Hereafter come un film sullavita e sulla sua irriducibilit alla banale biologia della
materia corporea (e dunque sullincontro con unaverit che sovverte il proprio stare al mondo), sirischia di fraintenderne il problema e lasciare che ilfilm derivi verso una suggestivit newage conservatri-ce e di dubbio interesse (1). Hereafter invece ci parladellincontro, smisurato, estremo e drammatico, conuna verit, e di come dopo questo evento non si possa
11
cine
forum
501
UNA VERIT ESTRANEA A QUESTO MONDOPietro Bianchi
(1) Ci pare questo lerrore di una lettura, come quella che propo-ne Luca Doninelli (che per altro rimane un pensatore e narratoredi straordinario interesse e rigore) il quale colloca il senso di giu-stizia eastwoodiano fuori dalla storia e dai suoi conflitti perchmisurato sullestremo individualismo tipicamente americano delGiustiziere Solitario. Secondo Doninelli starebbe in questo erroredi sottovalutazione del ruolo della redenzione nella storia la gene-si di quella sorta di ingenuo misticismo e di melassa buonistache spingerebbe il film di Eastwood in una direzione conservatri-ce. Luca Doninelli, Melassa per il duro Clint, in tysm n. 1, dicem-bre 2010, http://tysm.org/?p=6083.
501_04-15_eastwood 23-03-2011 22:41 Pagina 11
-
che stare al mondo come degli estranei: stare qui comese si fosse gi in un altro tempo.
NON CI SONO NIENTALTRO CHE CORPI E LINGUAGGI
Il filosofo Alain Badiou, uno dei pensatori che negliultimi anni con pi forza ha proposto una teoria mate-rialistica della verit, ha definito lideologia del pre-sente come quella di un materialismo democraticopost-moderno: Non ci sono nientaltro che corpi e lin-guaggi, sembra dirci il filisteismo dellideologo lapage. Ovvero non pi possibile immaginare una veri-t che trascenda la limitatezza e finitezza del tempoparticolare che viviamo. Ci sono soltanto corpi e paro-le che si incontrano e si confrontano in unorizzontali-t dove tutto uguale a tutto. La parola chiave opi-nione: tutti hanno opinioni e sono legittimati e invita-ti ad averle ed esibirle. Ma guai a controbattere a que-sta religione del relativo la parola verit! Si entrereb-be a pieno diritto nel campo dellortodossia, del tota-litarismo, perfino del terrorismo. Sulla centralit delcorpo invece non c neanche bisogno di spenderemolte parole, talmente la riduzione del soggetto amera materialit biologica (il corpo lunica verit e
autenticit: siamo coestensivi al corpo che ci portiamoappresso) pervasiva e dominante.
Badiou contrappone a questa sentenza di liquidarassegnazione lassioma: Non ci sono nientaltro checorpi e linguaggi, se non che ci sono delle verit. possibile dunque rompere il circuito delle particolari-t e dellindifferenza attraverso lincontro con unaverit che scompagina le carte in tavola: che rende unavita degna dessere vissuta come soggetti, elevandosidalla deteriore materialit che vorrebbe ridurre lesse-re umano a mera oggettualit bio-fisiologica.Eastwood ci accompagna in questo film attraverso treincontri con tre momenti di verit che sconvolgonouna vita. O meglio, che rendono una vita degna des-sere vissuta. Che rendono una vita se stessa in quan-to tale. E poco importa che si parli di sensitivi o di pre-sunti contatti con laldil, perch nulla ci viene dettodi questo aldil se non del modo attraverso cui rendedimprovviso questa vita (here) come estranea a que-sto mondo (qualcosa di pi della riduzione del mondoa corpi e linguaggi).
Lincontro con una verit, a differenza dellideologiadominante che promette sempre maggiore benessere emaggiori egoistici vantaggi, non promette di staremeglio: promette piuttosto di sconvolgere unesisten-za. Come quella di George Lonnegan (Matt Damon)
12
cine
forum
501
501_04-15_eastwood 23-03-2011 22:41 Pagina 12
-
che non riuscir ad avere una relazione normale con ladonna che incontra nel corso di cucina perch la suaabilit di connettersi con la anime dei defunti lo rendeinadattabile a una qualsivoglia relazione normale(Non un dono, una maledizione, dir al fratello).O quella di Marie LeLay che, dopo la sconvolgenteesperienza di essere stata a un passo dalla mortedurante lo Tsumani nel Sud-Est asiatico, metter arepentaglio la sua carriera per la volont di pubblica-re un libro sulla sua esperienza estrema invece chequello di sicuro successo che le era stato commissiona-to sulla vita di Mitterand.
Chi fa esperienza di questo totale sconvolgimentosembra non essere pi completamente in questomondo, sembra guardare alla normalit con locchiodi chi non riesce pi a farne parte: come quando il pic-colo Marcus fa il giro dei vari sensitivi che non fannoaltro che rivolgersi a lui con le parole del falso, o comequando Marie va alle riunioni della sua televisione,tutte prese nei finti problemi della quotidianit delmercato dei media. La verit rompe qualcosa delleconnessioni di questo mondo, le mette in crisi, le de-completa sottraendosi a esse.
QUI OLTRE QUESTO MONDO
Il problema di Hereafter, quindi, non quello delmondo e del suo aldil, come se ci fosse qualcosa chevada oltre i confini di quello che c. Il problema semmai comprendere se il mondo in cui viviamo possaessere ridotto a una aggregazione di corpi e niental-tro, secondo lingenuo materialismo delle scienzecognitive pi ideologiche e ingenue (che vorrebberoridurre il soggetto alla materialit dei suoi processibiochimici), o se ci sia qualcosa che pur rimanendoqui (here) rappresenti unulteriorit: qualcosa cherompa la piatta riproduzione del tempo del quotidia-no. Qualcosa che renda il mondo che viviamo nonbastante a se stesso (2). soltanto in questo modo chequalcosa come il cambiamento di una scelta possaessere compreso, oltre al puro meccanicismo dellin-contro di corpi e materialit necessitate.
Tuttavia Clint Eastwood, in film come MillionDollar Baby (id., 2004) o Gran Torino (id., 2008),articolava latto capace di cambiamento sempre sullasoglia della vita e della morte quasi come se vi fosseunintrinseca impossibilit e paradossalit nella sfidaalla necessit di questo mondo. Proprio in Hereafter,invece, dove la posta in palio proprio la soglia travita e morte, vediamo allopera una delicatezza quasiminimale nel raccontarci lesperienza dincontro conla verit e dunque del cambiamento. Quasi come seintegrare questo sconvolgimento soggettivo fosse inqualche modo possibile. Lo vediamo nellultimissima
scena dove Marie e George si incontrano.Vediamo unbacio immaginato diventare una carezza, e poi unastretta di mano. In che luogo di questo mondo dovreb-be stare un bacio che finisce per avere lapparenza didue mani che si sfiorano? In un sogno? Nella realt?In entrambi?
Ci pare stia in questo luogo interstiziale il pensierodi Eastwood sullincontro con una verit che cambiala vita. Che cosa infatti una verit, se non qualcosache pur facendo parte di questo mondo, non pu esse-re ridotta a corpi e linguaggi? Qualcosa che pur esi-stendo non riesce a essere ridotta allapparenza ditutte le altre cose e oggetti che ci stanno attorno?Qualcosa che pur stando qui tra noi, non si riesce apalesare se non tramite un atto di fede. Forse questalessenza di un materialismo che non sia n religiosoma neanche schiavo dellillusione che tutto si possaridurre alla trasparenza della materia bruta. Un mate-rialismo che dunque non possa fare a meno di un sog-getto che prenda la responsabilit del cambiamento.
13
cine
forum
501(2) In un intervista sul settimanale LA Weekly Eastwood dice: C
un certo aspetto ciarlatano nellaldil, di quelli che pregano nellaconvinzione che ci sia un aldil. Lessere umano sembra non essere ingrado di accettare il fatto che questa vita lunica e devi farne ilmeglio che riesci, godertela finch sei qui senza troppi problemi e far-tela bastare. Scott Foundas, Eastwood on the Pitch, LA Weekly, 10dicembre 2009.
501_04-15_eastwood 23-03-2011 22:41 Pagina 13
-
Ho sempre pensato che scrivere del cinema di ClintEastwood fosse come fargli un torto. Minimizzarlo.Spiegare levidenza, e dunque, con le parole, banalizzar-la inevitabilmente. Non ho mai scritto su nessuno deisuoi film, temendo confesso, in maniera reverenziale lovviet. Negli ultimi anni, daltronde, mi sono chiestocosa ci fosse ancora da scrivere sul cinema di ClintEastwood. E come dire qualcosa di nuovo, qualcosa dioriginale. E soprattutto, alla luce di certe pagine di criti-ca pi o meno illuminate, perch continuare a scriverecose ormai chiare, certe (e accertate), indiscutibili. Contutti i rischi dellautorialit imperitura, per giunta. Inoccasione di Hereafter, per, faccio uneccezione. Perchquello che mi sembra il pi brutto e sbagliato film diClint Eastwood (di brutti e sbagliati film di ClintEastwood ne conto neanche cinque in tutta la sua filmo-grafia da regista) mi fa riflettere anche sui metodi di rice-zione critica che nel nostro paese assumono talvolta con-torni confusi e, nel peggiore dei casi, ben poco lucidi.
I percorsi critici sono imponderabili, alla faccia di chi siassume la responsabilit dellobiettivit. Sono gli stessipercorsi critici che da noi hanno fatto generalmente stor-cere il naso di fronte a Invictus e applaudire inveceHereafter. Cio: va bene mettere a posto i patimenti del-lanimo umano e i rapporti con il proprio passato (in par-ticolare se defunto), va meno bene celebrare lurgenza diun discorso di avvicinamento degli opposti sotto forma difilm sportivo (e dunque con tutta la grancassa nota delgenere). Eppure, al di l delle solite iperboli che da piparti trovano ormai spazio con cadenza ridicola (in aper-tura di alcune recensioni quotidianistiche di Hereaftertroneggiava liscrizione pomposa Clint Eastwood ilmiglior regista vivente, prontamente ripresa dai flani, eben sappiamo quanti miglior registi viventi ci sono nelmondo per la nostra critica), non riesco a capire perch,ad esempio, lottimismo contagioso e al passo coi tempi diInvictus incontri il rifiuto, mentre quello vagamente newage di Hereafter no.
14
cine
forum
501
IL NUOVO CAPOLAVORO DI CLINT EASTWOODPier Maria Bocchi
501_04-15_eastwood 23-03-2011 22:41 Pagina 14
-
Se in un film un personaggio legge Dickens, il filmdiventa automaticamente dickensiano? Per alcune firme,s. Tanto che Hereafter s trasformato improvvisamentenella pi bella favola dickensiana degli ultimi anni. Hoqualche dubbio. Perch dickensiana? Forse perch sifanno i conti coi fantasmi, le responsabilit, le colpe?Allora dickensiano anche Inception, dove di conti colpassato Di Caprio ne fa un bel po. Ma sfido chiunque adefinire cos il film di Nolan. Alla critica piace il cinemache elabora il lutto, che torna a dare senso alla vita: se Clint Eastwood a farlo, i valori sono immediati e semprei medesimi, la pulizia dimpaginazione, la semplicit clas-sica (ma su questo benedetto concetto di classico applica-to a Eastwood dovremo prima o poi ragionare per bene),il rigore morale. Per queste ragioni, che sono le solite disempre, Hereafter il nuovo capolavoro di ClintEastwood. Poco importa che la sceneggiatura sia sche-matica: bastano la pulizia, la semplicit e il rigore di Clinta mettere daccordo la nostra critica. Che, daltro canto,riguardo al cinema di Eastwood usa queste tre categoriedi giudizio da almeno ventanni, senza mai cambiare unavirgola e, cosa ancor pi grave, senza mai sentire il biso-gno una volta tanto di cambiarla, la virgola.
No, le virgole previste rimangono al loro posto: e per lacritica integralista Hereafter il capolavoro definitivo diClint Eastwood. Dunque, pi definitivo di Gran Torino, diChangeling, di Million Dollar Baby, di Mystic River, di Iponti di Madison County, di Un mondo perfetto, di Glispietati, che gi erano definitivi di loro. Si celebra laldi-qua scendendo a patti con laldil: e se le visioni di que-stultimo sono a met strada tra un film di Fred Olen Raye lo Steven Spielberg meno apprezzabile, non c proble-ma, perch il fine nobile giustifica i mezzi, e lo stileeastwoodiano fa perdonare tutto, non soltanto i morti.Figuriamoci, se una giornalista sostiene di aver visto lal-dil e pensa bene di mettere tutto nero su bianco speran-do di cambiar vita e di risolvere le proprie inquietudini,perch non rispettarla? Perch non crederle? Alzi la manochi non ha mai deriso ogni presunto veggente di questomondo che si sbriga a scrivere il bestseller della propriaesperienza per la massa ignorante e boccalona, presen-ziando poi in ogni salotto che conta: per in Hereaftertutto ci in qualche modo giusto e condivisibile, la gior-nalista francese scrive il suo libro, il quale diventa un suc-cesso e le permette di trovare casualmente lamore.
Che amore sia, allora. Per guai a tentare di accomuna-re i contrari: con abbondanza di clich esotico-afrodisiaci,non ce la fa nemmeno un corso di cucina italiana, coi suoiprodotti doc pomodori, vino rosso e una spruzzata dimusica lirica e lo chef tondo e di buonumore come damanuale. Tra i meriti veramente pregevoli del cinema diEastwood, e degli ultimi dieci/quindici anni in particola-re, c la straordinaria, spettacolare prova recidivaa inte-grare gli opposti, a farli vivere assieme, anche a costo delsacrificio dellesistenza stessa, e assolutamente senza sna-
turarli o eguagliarli. Gran Torino e Invictus ne erano degliesempi trascinanti e per di pi necessari alla contempora-neit. Hereafter lascia che gli uguali si cerchino e si trovi-no nella solitudine pi completa: invece di sostenere lapratica delleccezionalit nel mondo, questo film la anni-chilisce a fenomeno destinato allesilio; invece di promuo-vere la comprensione della diversit, questo film la bandi-sce, ne fa un prodigio da piazza (molto opportunamente,la giornalista francese legge pagine del suo bestseller a unpubblico beato di una fiera del libro), condannandola avivere con i propri simili. Ricordate il finale di MillionDollar Baby, con il confino che sinfligge il protagonistaFrankie Dunn? Ma in un film che la maggior parte dellanostra critica decanta come un inno alla vita e alla possi-bilit per luomo di ritrovare la serenit, quindi ben lonta-no dal nichilismo senza speranza del film di sette anni fa,lincontro in galleria tra numeri primi che concludeHereafter mi lascia pi perplesso che commosso.
Cosa resta, allora, di Hereafter? I primi quindici minu-ti dellepisodio inglese dei due fratelli: qui che la pulizia,la semplicit e il rigore eastwoodiani trovano vero svilup-po; questo cinema adulto, profondamente maturo eintelligente nello sguardo su due generazioni dipendentivicendevolmente (figli e madri). Peccato che poco dopoarrivi la sequenza del berretto e dellesplosione nel metr,che sembra giungere dritta da Ghost: niente di male, percarit, basti ricordare gli elogi sperticati che il fantasy diZucker riscosse allepoca da certa critica; ma bisogna ridi-mensionare lo sguardo, senza appellarsi ogni sacrosantavolta alla laicit eastwoodiana (quarto valore abusato perincensare il cinema di Eastwood, da sommare ai prece-denti tre). La critica pigra, sia che si tratti dello scribac-chino pi grigio o al contrario del cinefilo pi agguerrito.Non sede per lennesima frustata al culto dei totemautoriali; per non mai troppo tardi per invocare il buonsenso e la misura delle parole.
15
cine
forum
501
501_04-15_eastwood 23-03-2011 22:41 Pagina 15
-
16
cine
foru
m50
1
I F I L M
Tamara Drewedi Stephen Frears
501_16_33 SCHEDE 24-03-2011 16:34 Pagina 16
-
17
cine
forum
501
Unimpietosa coerenza sembra muovere il cinema diMike Leigh. Di storia in storia si rincorrono le tracce diuno sguardo discreto, sottilmente impegnato in una con-tinua sfida di precisione: una lotta, direbbe Bazin, tralimmagine e il reale. Sullo sfondo mobile dei suoi inter-ni londinesi si accumulano, film dopo film, le stesse con-versazioni, il fitto intreccio di parole quotidiane, corpi,tazze di t, le fughe in auto, il dolore e i pochi spiragli disofferta redenzione.
Another Year, realizzato a tre anni di distanza daHappy Go Lucky, si collega saldamente al filone che hacaratterizzato lultimo decennio del regista britannico.Un filone che unisce un quartetto di titoli (All orNothing, Vera Drake e il gi citato predecessore) in uncorpo comune di riflessioni, motivi e problemi. In comu-ne c anche e occorre ricordarla la tecnica registicadi Leigh, fondata su un meticoloso lavoro di ricercaattoriale. A preparare il film stato infatti il consuetometodo di improvvisazioni non pianificate: nel corso deicinque mesi di preparazione, Leigh ha lasciato immer-gere gli attori nei personaggi, allestendo loro intorno unmicrocosmo fittizio e domestico, per poi attendere che ladurata facesse il suo corso, portando gli accenti del realeallinterno della narrazione.
proprio da questo esercizio di immersione attorialeche deriva la formidabile impressione di realt che river-bera sulla pellicola. Ancora una volta, grazie anche allalunga familiarit coi suoi interpreti, Leigh ha saputo,cio, allestire una sorta di macchina ibrida, un comples-so esercizio attoriale in cui attori, ambienti e storie inte-ragiscono fino a generare un lessico familiare, un idiolet-to riconoscibile nelle sue connotazioni di classe e nazio-nalit, ma al contempo dotato di una sostanza umanapropria e peculiare.
Della medesima riconoscibilit si circonda limmagi-ne. Di fronte al dispiegarsi di quel respiro di realt cheessa stessa ha saputo suscitare, la regia leighiana simuove su una sorta di doppio binario. Uno sguardodiscreto, come si diceva in apertura. Attento a catturareogni riflesso del quadro mobile che ha voluto mettere inscena. Un quadro su cui la macchina da presa si muove
Titolo originale: id. Regia e sceneggiatura: Mike Leigh.Fotografia: Dick Pope. Montaggio: Jon Gregory. Musica:Gary Yershon. Scenografia: Simon Beresford. Costumi:Jacqueline Durran. Interpreti: Jim Broadbent (Tom),Ruth Sheen (Gerri), Oliver Maltman (Joe), LesleyManville (Mary), Peter Wright (Ken), David Bradley(Ronnie), Martin Savage (Carl), Karina Fernandez(Katie), Michele Austin (Tanya), Philip Davis (Jack),Imelda Staunton (Janet), Stuart McQuarrie (il collega diTom), David Hobbs (il vicario), Badi Uzzaman (il signorGupta), Meneka Das (lamico del signor Gupta).Produzione: Georgina Lowe per Thin Man Films/SimonChanning Williams Productions/Film4/Untitled 09Ltd./Uk Film Council. Distribuzione: Bim. Durata: 129.Origine: Gran Bretagna, 2010.
In primavera, Gerri, moglie felice e psicologa, e suomarito Tom, geologo, coltivano con amore il loro lottodi terra. Si prendono cura anche di Mary, una collegadi Gerri che beve troppo e si lamenta della sua disa-strosa vita sentimentale. Gerri e Tom hanno un figliotrentenne, Joe, insoddisfatto perch non ha ancora tro-vato una compagna. In estate, da Londra arriva Ken,un amico di infanzia di Tom cresciuto come lui aDerby. Si ubriaca spesso, e si lamenta della sua vitadisperata e solitaria. Mary arriva tardi e agitata. geli-da con Ken, che le fa una corte innocente e romantica,mentre flirta con Joe. In autunno, tornando dallorto,Gerri e Tom trovano una gradita sorpresa di Joe, che liaspetta a casa con la sua nuova compagna, Katie.Mary si mostra subito gelosa e ostile verso la ragazza.In inverno, Gerri, Tom e Joe vanno a Derby al funera-le della moglie del fratello maggiore di Tom, Ronnie,che ha un atteggiamento aggressivo e ostile. Gerri eTom tornano con Ronnie a Londra. Intorno al tavolodella cena, Gerri e Tom rievocano i vecchi tempi,quando erano giovani e giravano il mondo in sacco apelo, Joe e Katie non vedono lora di partire per il loroprossimo viaggio a Parigi, Ronnie si gode in silenzio labirra e la cena, e Mary fa i conti con il vuoto e la tri-stezza della vita che passa.
ANOTHER YEAR Mike Leigh
Il fascino crudele della felicitPasquale Cicchetti
501_16_33 SCHEDE 23-03-2011 23:01 Pagina 17
-
con lubiqua leggerezza di un kammerspiel, avvolgendogli spazi nella loro tessitura organica, vissuta. AnotherYear rifugge la coralit e il suo correlativo, quella coun-cil estate su cui si dipanava il mondo di All or Nothing:la sua dimensione la casa borghese, i suoi ambienti e iritmi che la abitano. Dopo aver introdotto ciascuno deiquattro protagonisti sul proprio posto di lavoro, la nar-rativa procede a redistribuirli allinterno del fulcrodomestico, instaurando una sorta di scala in cui lappar-tenenza allo spazio della casa (ai suoi riti, ai suoi lin-guaggi) si fa insieme misura e codice della felicit perso-nale. Formidabile, a questo riguardo, la sequenza in cuiMary, per dimostrare a Jack di essere effettivamenteunamica di famiglia, descrive a memoria gli spazi del-labitazione: come a voler sconfessare attraverso levoca-zione verbale dei luoghi il fantasma della propria evi-dente estraneit emotiva.
Uno sguardo discreto: ma anche e lo dimostra ine-quivocabilmente limpietosit di certi piani ravvicinati uno sguardo rapace, capace di muoversi sul marginedella crudelt e catturare ogni tic, ogni accento grotte-sco o violento, nel segno di una stilizzazione documen-taria del reale che suona cos stranamente in contrastocon quella gentilezza affettuosa che, allapparenza,costituisce la pars costruens della narrazione. Ma la sen-sazione che al di sotto dellesibita comprensione di Tome Gerri ci sia un qualcosa di stridente sottolineataanche altrove. Dai parallelismi del montaggio, ad esem-pio, che enfatizzano una densa trama di contrappunti
ironici, di antonimie, di prese di distanza. Vengono inmente le due sequenze speculari in cui Tom e Gerri rien-trano in casa e trovano ad attenderli ospiti inaspettati:Joe e la sua nuova compagna, giocosamente accolti nellaprima sequenza, e in unamarissima sequenza paralle-la in apertura dellultimo atto Mary, ormai sullorlodella nevrosi. Ma questa sensazione di freddezza traspa-re anche dalla struttura complessiva: supportato dellec-cellente fotografia di Dick Pope, collaboratore storico diLeigh, limpianto narrativo racchiude le vicende in ungiro di stagioni, in una ciclicit da tempo folklorico,naturale. Epper, pi che il sentimento tragico propriodella sua matrice greca, questa circolarit sembra evo-care una classicit raffinata, di superficie, vicina a uncerto manierismo winkelmaniano.
Ecco, appunto. In questo contrasto tra una gentilezzatrattenuta, tutta buone maniere e understatement, elevocazione di un umanesimo pi vibrante e partecipe(verrebbe da dire alcaico) ci sembra racchiuso il noccio-lo problematico di questo filone del cinema di Leigh. Ilmondo di Tom e Gerri un giardino protetto, ispirato aun modello di saper vivere dai tratti mediterranei, fon-dato sul buon cibo, una certa dose di leggerezza e diconversazione brillante. Una sintesi, insomma, di quellaextraordinary too-muchness at the heart of the ordina-ry che Garry Watson (1) riconosceva nella poetica diLeigh come forma privilegiata della redenzione, sevogliamo concederci il termine, o comunque della possi-bilit di essere un poco felici. Una forma peraltro emble-
18
cine
forum
501
501_16_33 SCHEDE 23-03-2011 23:01 Pagina 18
-
maticamente incarnata dalla stessa Ruth Sheen, che aquesto modello di vita aveva gi prestato sguardi emovenze in All or Nothing, tanto che al di l dellanetta demarcazione di classe sociale che separa i duepersonaggi sembra quasi di ritrovare in Gerri qualco-sa della sua Maureen. Ma c qualcosa in questo model-lo che ostinatamente ritorna, e disturba: un fuoricampo,unombra rimossa. Qualcosa di connaturato al modellostesso, una chiusura allesterno che inevitabilmente necondiziona la praticabilit e la tenitura morale. Marychiede platealmente aiuto, ma Gerri, fino alla fine, sem-bra ignorare la gravit della sua situazione. Pensiamoanche a Happy Go Lucky, altro esempio di felice realiz-zazione del paradigma: felice, s, ma che dire del poveroScott, istruttore di guida e tormentato sociopatico, eppu-re sinceramente innamorato di Sally Hawkins, coscome lo era stato il giovane Craig nel gi citato All orNothing?
La magistrale sequenza finale di Another Year ci for-nisce, a questo punto, una potente chiave di lettura. Lamacchina da presa, in una lentissima panoramica circo-lare, abbraccia e ricompone lunit simbolica della fami-glia attorno alla tavola imbandita, per poi fermarsi edescludere attraverso il sonoro proprio Mary, che pi ditutti di quella ricomprensione sembra avere bisogno.Ora, la colpa di Mary se di colpa possiamo parlare non consiste nellaver offeso o tradito lamicizia di Gerri(la quale, peraltro, dimostra in pi occasioni di essereperfettamente cosciente della disperata proiezioneromantica dellamica sul figlio Joe, senza curarsi n diagire n di parlare per tempo). No, la colpa di Mary specificamente linguistica: la donna andata oltre lerighe, ha frainteso la sua posizione nei confronti diKatie, e, attaccando il nuovo membro della famiglia, hainfranto la tessitura di gentilezza verbale con la qualeTom e Gerri proteggono accuratamente se stessi e la cer-chia dei pauci beati che ammettono presso di loro. Diqui lespulsione. Quanto a Katie, la giovane dimostra findallinizio di conoscere le regole del gioco, mostrandosiimpermeabile alle cattiverie della rivale e, seguitando acinguettare amabilmente, secondo gli standard dellacasa. Anche perch, intuiamo, non si sente per nullaminacciata nella sua posizione di nuovo membro dellacomunit domestica. Eppure Mary, al contrario di lei, une abitu, una vecchia amica di famiglia (quasi unazia, come rimarca Gerri). Da dove viene tanta sicurez-za? In altre parole, perch Katie, perfetta sconosciuta,conosce le regole di quel linguaggio che Mary pur dopotanto tempo non ha saputo o potuto apprendere?
Si sarebbe tentati di leggere il tutto in termini di clas-se, come pure stato fatto. Ma una tale riduzione dellaquestione in termini vetero-marxisti sarebbe pretestuo-so e poco illuminante. Da un lato, infatti, si gi nota-to come Leigh abbia proposto lo stesso modello attra-verso personaggi di classi sociali e perfino periodidiversi (pensiamo a Vera Drake). Dallaltro, la divisio-ne sociale che pure traspare in queste storie frutto diquella ricerca del reale cui abbiamo gi accennato. Non
sar inutile ricordare qui che ancora oggi la societ bri-tannica vive e si pensa allinterno di un sistema rigida-mente e francamente classista, con buona pace di(quasi) tutti.
Resta per da capire perch questo modello, che pure intelligentemente non vuol darsi una connotazionedi classe, sembra fallire proprio nellattraversare i confi-ni del cerchio che ne garantisce la sopravvivenza.Limpressione che a impedire questo allargamento siaprecisamente un difetto di comunicazione, e cio, daultimo, il problema dellindicibilit del dolore, della ine-ludibile solitudine umana, a cui il linguaggio oppone lapropria autonoma surrettizia dimensione di codice, disistema sociale (e, per inciso, non si d linguaggio al difuori della classe: si pensi a Naked). Di qui la teoria dipersonaggi salvifici che la cinematografia leighiana hasempre accostato ai suoi derelitti. Giovani dottori, mae-stre di scuola materna, assistenti sociali, avvocati attivi-sti: personaggi positivi, emanazioni di un civismo lumi-noso e solidale, ma anche riprova di come solo dal-lesterno si possa tendere una mano. Di qui, infine, tuttala fulminante icasticit della sequenza di apertura, conla Stanton (Vera Drake) che di fronte alle reiterate eprofessionali profferte daiuto di Gerri, protesta di vole-re, lei, soltanto dormire.
(1) Garry Watson, The Cinema of Mike Leigh: A Sense of the Real,Wallflower, Londra 2004.
19
cine
forum
501
501_16_33 SCHEDE 23-03-2011 23:01 Pagina 19
-
Ma quanto bravo Mike Leigh?Questo lhanno pensato tutti (tutti in fondo lo
pensavano gi) fin dalla prima visione di Cannes2010. Direzione degli attori impressionante, regiapulita e arguta, dialoghi che sembrano zampillaredalla vita vera di quelle persone che sono i perso-naggi del film.
In molti, per (quasi tutti), si sono fermati l. Allanaturalezza. Alla sensibilit. A quella splendidacoppia in l con gli anni che ti fa venire voglia diinnamorarti e di credere nella vita, qualsiasi cosaaccada, nella gioia e nel dolore, finch non ci separila fine del secondo tempo (per il terzo, rivolgersi aHereafter).
Eppure, se osservi bene (se gratti via il primo stra-to di parole, se stai attento ai gesti e agli sguardi sottolineati dagli stacchi o camuffati dentro linqua-dratura se di il giusto peso alla solitudine in cuisono fisicamente confinati gli amici infelici e iparenti perdenti anche e soprattutto quando sono ingruppo), ti accorgi di quanto sia complessa e raffi-nata e ambigua questa apparente lineare semplicit.
Another Year non un apologo dolceamaro sullafatica e la gioia di vivere, con due protagonisti sola-ri in cui identificarsi (per consolarsi) e una selvalunare di personaggi minori a cui spetta stratificareil racconto e moltiplicare le tonalit. Non cosbanale. Tom e Gerri, nella loro sincera generosit,con la loro intelligenza sociale e apertura mentale,oltre a essere gli amorevoli-ammirevoli protagoni-sti, la pietra angolare della storia, sono anche lapietra dello scandalo, il termine di paragone del-linfelicit altrui, la dimostrazione di quanto siainfame la vita quando distribuisce fortune e talenti.Viene il fondato sospetto che la loro felicit abbiabisogno delle disgrazie degli altri. Non una perfi-dia evidente, una cattiveria tematizzata dal film. unumanissima debolezza, che non hanno il corag-gio di confessarsi, di cui probabilmente non sononeppure consapevoli, e che scorre sottotraccia nelfilm, emergendo pi chiaramente negli snodi narra-tivi. Eccoli abbracciati su un letto o in cucina, nellaloro grande e bella casa, dopo che hanno incontratoe consolato, dopo che hanno coltivato il loro orticel-lo, in pace con se stessi. Simpatici. Dolci. Spietati?Perch mai dovrebbero fare pi di cos? Come pos-sono cambiare la vita di quella segretaria che faticaa comprarsi unauto e non ha nessuna possibilit ditrovare luomo che desidera? Cosa fare con lamico
anziano, depresso e sovrappeso, se non qualchebevuta in ricordo dei vecchi tempi e un barbecue ingiardino? E il fratello di Tom? In che modo lhannoaiutato fino a ieri? (compare allimprovviso, dopoun lutto). Daltra parte come pu lui, rinfacciareloro qualcosa, visto che sono cos magnificamentedisponibili? I due piccioncini se ne stanno l adispensare consigli, attenzioni e affetti dallaltodella loro soddisfatta felicit, vampirizzando le sfi-ghe altrui, evitando accuratamente che le nevrosidegli altri, i dolori insanabili, le precarie identit,arrivino a minare le fondamenta della loro serenavita familiare, faticosamente costruita negli anni,meritatissima.
Quanto bravo un regista che riesce a racconta-re questa ambiguit, senza bisogno di dirla omostrarla? Che sembra parlare di una coppiameravigliosa, esempio di calorosa benevolenza,mentre in realt sta parlando degli ultimi, dei per-denti, di quel brutale darwinismo sociale di cuisiamo vittime e carnefici spesso inconsapevoli (s,proprio noi, progressisti, acculturati, sensibili). Lui geologo e lei psicologa, la natura li ha fatti intel-ligenti e dotati, il loro benessere guadagnato sulcampo, ma perch, alla fine, ci appare cos ingiusto,perfido, contraddittorio? Allinizio una questionedi dettagli e di sfumature. Leigh ci porta abilmentea identificarci con i sorrisi e gli sguardi di intesa fraTom e Gerri, che compatiscono la segretaria nevro-tica: proprio una disgraziata, come si fa a nonridere di lei? Intanto ci mostra (chiss perch) ilfiglio illuminato di cotanta famiglia, che accoglie allavoro una coppia di immigrati con un tono fasti-diosamente ironico e paternalistico. Ma c anchelaspirante nuora, con la sua parlantina torrenzialee la sua gentilezza esagerata, che a babbo e mammapiace tanto, e a noi suona cos stonata (anche allasegretaria pazza, che per non ha gli strumenti perrendere esplicito il suo disagio, e la cosa si risolvein una grottesca gelosia).
Dobbiamo aspettare la fine, perch ci diventiesplicito. Quelle scene in cui i perdenti hannofinalmente delle inquadrature tutte per loro, ecominciano ad acquisire la consapevolezza dellapropria realt di sfigati vampirizzati, mendicanti diaffetto e considerazione, ma in un certo senso uma-namente pi veri. La sequenza dellepilogo ildisvelamento finale: la famigliola felice parla deisuoi viaggi in giro per il Mondo con totale mancan-
20
cine
forum
501
Amorevoli vampiriFabrizio Tassi
501_16_33 SCHEDE 25-03-2011 21:55 Pagina 20
-
za di tatto (nei confronti di chi uscito a malapenadal suo quartiere) e un buonumore che supera ladecenza, mentre la macchina da presa coglie unosguardo di intesa fra la nevrotica diventata silenzio-sa e il fratello vedovo, che ha capito tutto senza averbisogno di parlare. Solo allora ti capita di ripensarealla donna, impersonata da Imelda Staunton, cheappare nel prologo e poi sparisce per sempre, nellanebbia informe della vita e della non-storia, con ilsuo inguaribile dolore, che la brava Gerri ascolta eaccoglie per il tempo di una consulenza psicologica,e magari aspira pure a guarirla, mentre lei vorreb-be solamente dormire.
Intanto le stagioni scorrono e arriva un altro anno.Grande film davvero.C la realt, in cui ognuno di noi interpreta il suo
ruolo come meglio pu. Incasinata. Tragica. Buffa.Anche un po ridicola. Una messinscena in cui gliattori non hanno un copione e il regista ha abban-donato il lavoro a met (rimangono i produttori,quelli che pagano e vanno allincasso, e una stermi-nata platea di spettatori consumatori).
C il cinema, che elabora, documenta, dramma-tizza, esplicita, che trasforma la realt in spettacolo
o la riduce al suo archetipo, che sta allegramente insuperficie o si immerge in pensose profondit. Ciriesce e non ci riesce. Per lo pi preferisce divagare.
Poi ci sono i film di Mike Leigh (i migliori film diMike Leigh). Un luogo reale e cinematografico, incui il cinema rinuncia a una parte di s per avvera-re la realt (non si tratta di capirla o afferrarla, madi darle consistenza), e la realt si specchia nel cine-ma senza bisogno di scorciatoie poetiche o ansiedimostrative, messa come in rilievo dalla dramma-turgia rigorosa, che non il discorso ma lo sfon-do su cui emerge la vita. In una pellicola comeAnother Year la realt ha una sua evidenza cristal-lina, che la riscatta dallopaca astrazione a cui soli-tamente la riduciamo per abitudine. Qui i personag-gi sono pi reali delle persone vere, la vita coscome la vedi o non la vedi (ambiguit comprese) ela verit una questione di punti di vista (non unadecisione presa in sede di sceneggiatura). Non uncinema che idolatra limmagine e il suo potere sal-vifico. Non ha bisogno di usare il bianco e nero, oincantarsi davanti alla camera fissa, o balbettare unpo di retro-avanguardia, per vedere e far vederecosa c dietro la superficie delle cose.
21
cine
forum
501
501_16_33 SCHEDE 23-03-2011 23:01 Pagina 21
-
22
cine
forum
501
strano che in pochi labbiano notato, ma Ladonna che canta ha il medesimo incipit e, soprattutto,la medesima impostazione di I ponti di MadisonCounty. Due fratelli, una lettera-testamento, una lettu-ra che fa precipitare nel vuoto di una storia che dapersonale potrebbe diventare collettiva. Uno dei gran-di melodrammi del cinema contemporaneo, il pipopolare, non il pi noto, tra i capolavori eastwoodia-ni, che fa da modello, non si sa quanto voluto, aunanaloga storia damore e di scoperta che richiedeanchessa una fiduciosa adesione a unidea di cinemaclassico e simbolicamente intelligibile.
Il film di Denis Villeneuve non chiede nulla in pirispetto a quello di Eastwood: emozione, partecipazio-ne, identificazione. Se laccoglienza stata pi tiepidao semplicemente pi sbadata, certo perch il giovaneregista canadese non ha la classe di Clint, e ci manche-rebbe pure, ma anche perch non sempre lodiernospettatore medio disposto ad accettare le regole notema poco frequentate del romanzo dappendice.
La donna che canta non chiede nulla in pi di esse-re considerato come un mlo puro e semplice, unastoria di agnizione da feuilleton ottocentesco traspor-tata nel Novecento e nella sua tragica realt storica.Del melodramma sentimentale una versione piampia e avventurosa di quello familiare a cui appar-tengono I ponti di Madison County e i pi grandimelodrammi hollywoodiani, da Griffith a Sirk hatutte le caratteristiche: la scoperta iniziale, il fla-shback rivelatore, il salto geografico in un altro con-tinente, la risoluzione del trauma nel tempo presen-te, la vicenda individuale intrecciata a quella collet-tiva, linsegnamento morale che porta a uno sciogli-mento dei conflitti. Sembra un manuale. E se pren-dessimo un qualsiasi mlo hollywoodiano di metanni Cinquanta, uno a caso, se possibile tra i menoconsapevoli e belli, magari tratto da un romanzo diHemingway e ambientato in Europa o in Africa, tro-veremmo la stessa struttura, la stessa traiettoria cheda un iniziale disequilibrio conduce a una soluzionedelle storture da cui sono nati gli eventi.
Titolo originale: Incendies. Regia: Denis Villeneuve.Soggetto: dal lavoro teatrale omonimo di WajdiMouawad. Sceneggiatura: Denis Villeneuve, ValrieBeaugrand-Champagne. Fotografia: Andr Turpin.Montaggio: Monique Dartonne. Musica: GrgoireHetzel. Scenografia: Andr-Line Beauparlant. Costumi:Sophie Lefebvre. Interpreti: Lubdna Azabal (NawalMarwan), Mlissa Dsormeaux-Poulin (JeanneMarwan), Maxim Gaudette (Simon Marwan), RmyGirard (il notaio Jean Lebel), Abdelghafour Elaaziz(Abou Tarek), Allen Altman (il notaio Maddad),Mohamed Majd (Chamseddine), Nabil Sawalha (Fahim),Baya Belal (Maika), Bader Alami (Nicolas), YousefShweihat (Sharif), Karim Babin, Anthony Ecclissi (leguardie del corpo di Chamseddine). Produzione: LucDry, Kim McCraw, Stephen Traynor, Sylvie Trudelle permicroscope/Ts Productions. Distribuzione: LuckyRed. Durata: 130. Origine: Canada/Francia, 2010.
Quando il notaio Lebel legge a Jeanne e SimonMarwan il testamento della loro madre Nawal, i gemel-li restano scioccati nel vedersi porgere due buste, unadestinata a un padre che credevano morto e laltra a unfratello di cui ignoravano lesistenza. Jeanne vede, inquesto lascito enigmatico, la chiave del silenzio diNawal, chiusa in un mutismo inesplicabile durante leultime settimane precedenti la sua morte. Decide dipartire subito per il Medio Oriente per riesumare il pas-sato di questa famiglia di cui non sa quasi nulla.Simon, per quanto lo riguarda, non ha bisogno deicapricci postumi di quella madre che sempre statalontana e avara di affetto, ma il suo amore per la sorel-la lo spinger presto a unirsi a Jeanne per setacciareinsieme la terra dei loro antenati sulle tracce di unaNawal ben lontana dalla madre che conoscevano.Spalleggiati dal notaio Lebel, i gemelli risalgono il filodella storia di colei che ha dato loro la vita, scoprendoun destino tragico marchiato a fuoco dalla guerra edallodio e il coraggio di una donna eccezionale.
(dal pressbook del film)
LA DONNA CHE CANTA Denis Villeneuve
Una morale dellorroreRoberto Manassero
501_16_33 SCHEDE 25-03-2011 21:56 Pagina 22
-
In pi, rispetto a un film vecchio pi di mezzo seco-lo, non pu che esserci la consapevolezza della preca-riet di ogni narrazione, una distanza critica di cuioggigiorno nessun regista o sceneggiatore pu dimen-ticarsi e, soprattutto, di cui ogni spettatore deve pre-munirsi nel momento in cui accetta di prestare atten-zione a una storia. Colpa o merito del postmoderno,certo, dellinibizione del cinema di fronte alleccessivaevidenza della finzione o della ritrosia del pubblico difronte allemozione senza freni: ma nulla vieta che perun attimo la distanza critica venga messa da parte e sirecuperi lo spirito di una primigenia affabulazione.
Ci di cui Villeneuve, e prima ancora lautore dellapice originaria, Wadji Mouawad, vanno in cerca proprio questa resa volontaria e gratuita; una sorta disalto temporale allindietro, che non riguarda sola-mente i protagonisti della vicenda ma tutti gli spetta-tori del film. Se per gli uni si tratta di scoprire lorigi-ne della propria identit, per gli altri il compito ritro-vare uninnocenza dello sguardo e dellemozione cheoggigiorno il cinema non richiede pi. O meglio, chevorrebbe richiedere, ma sa di non potersi permettere.
La donna che canta, invece, un film fiducioso nelpotere immaginifico del suo racconto, che prova consa-pevolmente a recuperare unemozione di sapore sia vin-tage, come di storia sentita raccontare e non vissuta dipersona, sia salvifico, quasi che il cinema cercasse unaredenzione attraverso la sospensione dellincredulit.Lo si capisce da come lincipit non tergiversa nei pianidambientazione ma entra subito nel vivo, gettando per-
sonaggi e spettatore nella discesa verso la conoscenzadelle rispettive radici. Prima scena, tutti in campo: duegemelli, due testamenti, una sola madre dalla vita dop-pia, perch in fondo ogni vita ha il suo lato oscuro, sco-nosciuto anche da chi ne padrone. I due ragazzi chesaranno protagonisti del film sono scioccati e lo spetta-tore costretto fin da subito a negoziare la propria ade-sione: si capisce che la storia potrebbe portare lontano,che potrebbe celare un mistero come lamore impossibi-le nella Madison County o magari ancora di meglio, dipi impensabile e profondo. Se non si accetta il gioco,per, meglio mollare fin da subito.
Lapparizione stessa del flashback, cos come il neu-trale andirivieni temporale tra presente e passato,senza rimescolamenti che rischiano di gettare fumonegli occhi dello spettatore, non sono per una volta iframmenti di racconto impossibile, le schegge libere diuna trama mlo fuori tempo massimo, bens i binariper una volta paralleli di un tragitto che porter allarisoluzione del mistero. Ancora una volta una que-stione di attesa e fiducia: bisogna essere certi che cisar una fine, altrimenti, ripetiamo, tanto vale non cre-derci fin da subito.
Perch ci che La donna che canta chiama in causa,a volerla sparare un po grossa, la nostra stessa fidu-cia nel cinema, o pi ancora nellarte del racconto.Non un film perfetto, non dosa gli elementi in manie-ra equilibrata e non giustifica in modo realistico glisnodi cruciali della trama: proprio per questo, per,per una forza che incanala i mille rivoli della Storia in
23
cine
forum
501
501_16_33 SCHEDE 25-03-2011 21:56 Pagina 23
-
un unico luogo, per una ragione che pu solo risiede-re nella gratuit di ogni fabula, mostra la pervicaciadel suo meccanismo, la seduzione che mette in campo,la sincerit di unonesta autorizzazione a manipolarela realt e dunque lemozione dello spettatore.
Il racconto una calamita, attira i protagonisti versoun centro sconosciuto dove scoprire la verit sullori-gine della vita. Doppi squilibrati e perci archetipici,opposti nel sesso, nellaspetto e nel carattere, lei picomprensiva e curiosa, lui pi chiuso spaventato, i duegemelli del film sono versioni moderne della favola diPollicino: seguendo le briciole della storia personaledella loro madre, entrano di volta in volta in unadimensione sempre pi ampia, storicizzata e universa-le, e al tempo stesso si avvicinano al nodo crucialedelle loro esistenze individuali. Spettatori inermi deldestino altrui, fratello e sorella imparano lentamente aprendere parte al gioco, arrivano a scambiarsi quandonon possono pi tirarsi indietro, quando hanno ormaicapito il senso ultimo della lezione morale che lamadre, vittima e carnefice inconsapevole, ha volutoimpartire loro.
Il transfert di identificazione con il pubblico evi-dente (fin troppo, a dirla tutta: ma proprio qui, inquesto eccesso, il rapporto di fiducia che il film preten-de), essendo il viaggio dei due fratelli, come sempre
nella narrazione popolare, un viaggio simbolico epalingenetico, prima distante e poi prossimo, vicino alcuore dei protagonisti e per questo universale. Il dop-pio piano della storia individuale e collettiva si faesplicito nel momento in cui la verit getta le vite deisingoli individui nella tragedia della Storia delNovecento, nel corto circuito inumano che ha portatoin quasi ogni decennio alle violenze etniche e agli olo-causti culturali.
Si parla della guerra del Libano, degli scontri tramusulmani e cristiani maroniti: ma il riferimentopotrebbe essere ad altre tragedie storiche e altre guer-re fratricide. A contare, purtroppo, sono labominiodellincesto e della violenza che scorre obliqua tra ilegami di sangue. La scoperta finale, oltre a generareun probabile ululato di stupore nel pubblico, segna ilcongiungimento delle forze che spingono il film versoil proprio compimento: lapprodo a un punto di nonritorno in cui il male della Storia macchia la dimensio-ne individuale con il sangue dellirreparabilit.
antropologica la dimensione del male racconta-ta dal film. Il dramma storico che porta un bambi-no a diventare un torturatore infatti secondarioallindifferenza con cui la natura umana pratica laviolenza e alla negazione di un imprinting identita-rio che distinguerebbe gli uomini dagli animali. Lastoria del Novecento, in fondo, un campionarioricchissimo di tragedie che fanno piazza pulita diqualsiasi illusione al proposito: ma se Villeneuvenon ci va per il sottile nellillustrare il coinvolgimen-to di ogni individuo in questa tragedia, lunione tra-gica del particolare con luniversale, il caos chemischia il sangue e disperde lordine delle cose, altempo stesso dichiara una cieca fiducia nella poten-za salvifica del melodramma
La donna che canta, come scriverebbe Roth, tra-sforma il quotidiano in epopea, accetta il lato oscu-ro dellumanit ma lo forza a tal punto da trasfigu-rarlo in una forza generatrice di vita: la Storia cheinvade la vita dei personaggi del film quella reale,lorrore e lodio anche, ma la strada che si fa imboc-care al racconto porta volutamente da un abominioa un paradosso, da un male assoluto a un amore diuguale intensit.
Sei una donna gloriosa e vittoriosa, dice in unacanzone il cantante Sufjan Stevens alla sorellaabbandonata dal marito; Sei la madre del cuore delmondo, le ricorda. Ogni donna Villeneuve lo riba-disce si ritrova proprio l, in una dimensione doveessere madre e padrona delle chiavi del mondo. E sein tale dimensione lamore pu sconfiggere final-mente il Novecento, come in Tarantino il cinema haucciso Hitler dopo anni di tentennamenti, alloraanche il melodramma pu prendersi la sua inutilerivincita sul postmoderno e per una volta ridareordine alla storia individuale e collettiva di tutti noi,che siamo da sempre figli e potremmo un giornoessere padri o madri.
24
cine
forum
501
501_16_33 SCHEDE 23-03-2011 23:01 Pagina 24
-
25
cine
forum
501
Tamara Drewe un graphic novel (romanzo afumetti) pubblicato inizialmente a puntate su TheGuardian dal 2005 al 2006 e nel 2007 in volume(in Italia edito da Nottetempo). opera di unadelle migliori autrici e disegnatrici britanniche,Posy Simmonds (classe 1945), che firma celebristrisce per The Guardian da oltre trentanni eaveva gi ottenuto un notevole successo col prece-dente graphic novel, Gemma Bovery (1999),pastiche di Madame Bovary. Anche TamaraDrewe nasce ispirandosi a un grande romanzo,Via dalla pazza folla (1874) di Thomas Hardy, dacui mutua con ironia alcuni motivi (il ruolo dellanatura e del paesaggio) e ne rovescia altri (la miso-ginia). Il segno della Simmonds morbido ed essen-ziale e la sua scrittura attenta ai dettagli psicologicie animata da un umorismo tipicamente britannicoche prende di mira le convenzioni e le ipocrisie dellasociet borghese.
Stephen Frears, dopo lesito deludente di Chri(2009), ha subito riconosciuto nella storia di PosySimmonds un universo congeniale e loccasione diritornare alla commedia pura, che non frequentavadai tempi di Alta fedelt (2000). Un divertissement,realizzato con la volont ludica di divertire. Tra ilromanzo e il film, che rispetta la scansione in quat-tro stagioni del testo, un ruolo essenziale lha avutoladattamento della commediografa Moira Buffini,inviato a Frears quando ancora non aveva terminatoChri. Il regista si ispirato ad alcune tavole come sefossero il dcoupage (adottando talvolta lo split scre-en) e ha conferito un respiro spedito a una narrazio-ne che si basa sul gioco espressivo degli sguardi, sullebattute salaci e su azioni beffarde e repentine.
Ma Frears si anche allontanato dal libro per svi-luppare delle soluzioni originali, come la sequenzadella morte tragicomica dello scrittore NicholasHardiment (investito da una mandria di vacche ter-rorizzate da un cane), che assume nel film una cru-dele, caustica concretezza assente nel libro dellaSimmonds, dove cade nel fuori campo di unellissi.
Titolo originale: Tamara Drewe. Regia: Stephen Frears.Soggetto: dal romanzo a fumetti omonimo di PosySimmonds. Sceneggiatura: Moira Buffini. Fotografia: BenDavis. Montaggio: Mick Audsley. Musica: AlexandreDesplat. Scenografia: Alan MacDonald. Costumi:Consolata Boyle. Interpreti: Gemma Arterton (TamaraDrewe), Roger Allam (Nicholas Hardiment), Bill Camp(Glen McCreavy), Dominic Cooper (Ben Sergeant), LukeEvans (Andy Cobb), Tamsin Greig (Beth Hardiment),Jessica Barden (Jody Long), Charlotte Christie (CaseyShaw), John Bett (Diggory), Josie Taylor (Zoe), BronaghGallagher (Eustacia), Pippa Haywood (Tess), SusanWooldridge (Penny Upminster), Amanda Lawrence(Mary), Zahra Ahmadi (Nadia Patel), Cheryl Campbell(Lucetta), Alex Kelly (la madre di Jody), Emily Bruni(Caitlin), Lola Frears (Poppy Hardiment). Produzione:Tracey Seaward, Allison Owen, Paul Trijbits per RubyFilms/Notting Hill Films/WestEnd Films/BBC Films/UKFilm Council. Distribuzione: Bim. Durata: 109. Origine:Gran Bretagna, 2010.
Nel piccolo paese di Ewedon, nel Dorset, vive un cele-bre scrittore di gialli, Nicholas Hardiment, che con ladevota moglie Beth gestisce una pensione per scritto-ri. Ospitano Glen McCreavy, uno studioso statuniten-se che sta faticosamente lavorando a una biografia diThomas Hardy (originario della regione) e sono aiu-tati dal prestante giardiniere Andy Cobb. La paciosavita a Ewedon turbata dal ritorno di Tamara Drewe,una giovane donna originaria del paese, affermatasicome giornalista, che vuole ristrutturare e vendere lacasa di famiglia. Diventata bellissima grazie a unope-razione di chirurgia estetica che le ha ritoccato ilnaso, Tamara animata da un desiderio di rivincitasulla cittadina e i suoi abitanti. Inizia una relazionecon una celebre rock star, Ben Sergeant, attirandosilinvidia di Jody e Casey, due adolescenti fan del can-tante, che iniziano a tramare contro di lei. Quando ledue ragazzine riescono ad avere accesso alla mail diTamara, provocano una lunga catena di eq