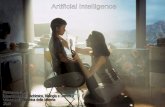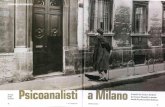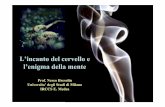Cervello + Algoritmo + Mente Processore Hardware Software + = Applicazione (task)
"Cervello, mente, linguaggio"_Recensione su Rivista di Psichiatria
-
Upload
cartman-edizioni -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of "Cervello, mente, linguaggio"_Recensione su Rivista di Psichiatria

Recensioni
Rivista di psichiatria, 2010, 45, 4
263
Rocco PitittoCervello, mente, linguaggio.Una introduzione alle scienze cognitiveCartman Edizioni, Torino 2009, pagine160, €€ 18
L’uomo deve essere considerato fra tut-ti gli esseri viventi un soggetto “specia-le” e “singolare” in virtù dell’evoluzio-ne del cervello. La quale ha “creato”(Frith) l’attività mentale ed è stata al-l’origine dello sviluppo del linguaggio,che “appare la proprietà più grande,nobile e indispensabile” della coscienza(Grimm).Le acquisizioni più recenti delle neuro-scienze e delle scienze cognitive mo-strano che i processi cognitivi hannouna duplice valenza - mentale e lingui-stica - e che l’essere dell’uomo si com-prende nella sua duplice dimensionepiù profonda come “unità di pensiero elinguaggio”. Mente e cervello sono ledue condizioni perché ci sia un uomo,qual è diventato nel corso dell’evolu-zione.Nell’esperienza umana si pone e si spe-rimenta la relazione originaria tra men-te e coscienza. L’esperienza vissuta inprima persona, fondamento della vitacosciente degli individui, rappresentaun particolare campo di fenomeni, “ir-riducibili a qualsiasi altra cosa”. Il rilie-vo accordato al fenomeno degli statid’animo soggettivi e personali ha datovita alla nascita di una nuova disciplina- la neuro fenomenologia - con lo scopodi rendere possibile un approccio di-verso ai problemi della mente e del cer-vello, allargando lo spazio della menteben oltre i confini tradizionali del-l’umano, avendo rintracciato indizi divita cosciente in esseri appartenenti almondo animale non umano (Varela).Rimane insoluto il problema fonda-mentale della coscienza. Considerare lacoscienza come un semplice “ammassodi neuroni” è certamente assai ridutti-vo. La coscienza - afferma Searle - è“l’essenza stessa della mente e della no-stra esistenza”. Oggi, le neuroscienzestanno valutando il rilevante ruolo as-
sunto dall’identità dell’uomo dalla co-scienza, la cui apparizione costituisceun evento decisivo nell’evoluzione del-l’uomo. Solo con l’emergere della co-scienza, questo fenomeno straordinarioe misterioso del mondo vivente, risulta-to di processi cerebrali, una vera e pro-pria qualità mentale superiore, si dà ini-zio all’essere dell’Homo Sapiens.I percorsi e le tappe del suo sviluppo,come e quando avviene la nascita diquesto fenomeno unico e quasi inaffer-rabile che è la coscienza, rimangonosconosciuti. Così come rimane un “mi-stero” il cervello stesso, che le ricerche,anche quelle più recenti e spettacolari,non hanno ancora svelato. I dati mo-strano che l’uomo non è, come si pensa-va, una specie di scimmia che si miglio-ra, bensì è tutt’altra cosa (Leroi-Gour-han). Il fatto poi che l’uomo e lo scim-panzé condividano qualcosa come il 99per cento del patrimonio genetico ren-de ancora più difficile spiegare i termi-ni dell’evoluzione di questi due esseri.La risposta sarebbe la “cognizione so-ciale”, un adattamento biologico avve-nuto prima dello sviluppo del linguag-gio.Ciò che è più arduo capire - scrive Den-nett - è come il linguaggio, quando è in-stallato in un cervello umano, porti consé “la costruzione di una nuova archi-tettura cognitiva che crea un nuovo ge-nere di coscienza e la morale”. Qui l’at-tività della mente diventa imprescindi-bile come attività che presiede al coor-dinamento tra i tanti meccanismi cheregolano e definiscono l’essere dell’uo-mo nel suo insieme. Riscontri empiricie immagini del funzionamento del cer-vello disegnano la mappa di una mentecomplessa.Sullo statuto epistemologico da dare aqueste questioni, il mondo scientifico sidivide tra chi fa riferimento a una visio-ne neurale e deterministica dell’uomo echi invece si richiama a una visione in-centrata sulla straordinaria complessitàdella mente, per invocare “l’indetermi-nazione e l’improbabilità” di gran partedelle decisioni riferite al cosiddetto “li-
bero arbitrio”, un concetto assai con-troverso, che da secoli è oggetto di ac-cese discussioni.Nel frattempo si sono registrati fonda-mentali progressi. Il cervello non è piùconsiderato un organo essenzialmenterecettivo e reattivo, ma una strutturaplastica, la cui evoluzione è stata resapossibile da una corteccia più vasta ecomplessa rispetto agli altri primati,che si materializza nella mente comeorgano centrale, cui afferisce ogni atti-vità dell’individuo. La mente è più delcervello, poiché è l’organismo umanonel suo insieme. L’attività mentale è de-terminata dai processi cognitivi, daiprocessi linguistici e dai processi rela-zionali, i quali circoscrivono insiemel’ambito della coscienza.I problemi oggi posti dallo sviluppodelle neuroscienze investono il pianodel funzionamento della mente e dellacoscienza. Solo nella relazione mente-cervello-coscienza sta la soluzione dellaquestione relativa alla comprensionedell’uomo.Una soluzione al problema della rela-zione mente-cervello-coscienza sareb-be l’affermazione di Crick che l’uomonon è altro che “un ammasso di neuro-ni” (a bunch of neurones). Parlare dimente e coscienza, rispetto a questa af-fermazione semplice e immediata, maassolutamente riduzionista, servirebbea ben poco, perché tutto si risolverebbea livello neurale. Una seconda soluzio-ne sarebbe quella di partire dall’espe-rienza vissuta dell’individuo, considera-to che l’unico legame tra mente e co-scienza è rappresentato proprio dallastruttura della stessa esperienza, perchéè in essa che si sviluppa l’autocoscien-za. Per Varela, solo nell’esperienza vis-suta di ciascuno si situa lo spazio dellamente e della coscienza. Si tratta alloradi analizzare e comprendere l’attivitàdel cervello, mettendola a confrontocon l’esperienza soggettiva della stessacoscienza. Le nuove metodiche di brain imagingconsentono di vedere insieme i due tipidi descrizioni con gli stessi strumenti.

Recensioni
Rivista di psichiatria, 2010, 45, 4
264
Compito della neurofenomenologia èpoter descrivere esperienze in primapersona, utilizzando gli strumenti delledescrizioni in terza persona. L’unico le-game dunque tra mente e coscienza èrappresentato dall’esperienza umana,dalla soggettività.Gli orientamenti sul “difficile proble-ma” della coscienza sono riconducibili,scrive Varela, “a quattro modelli” eriassumono il dibattito più recente sulconcetto della mente in ambito angloa-mericano. Le posizioni consideratevanno dal riduzionismo o eliminatori-smo rappresentato da Crick, Koch eChurchland, al funzionalismo rappre-sentato da Jackendoff, Baars, Dennett,Edelman e Calvin, passando attraversoi cosiddetti “rassegnati” di fronte al“mistero” della coscienza come Nagel eMcGinn e quelli infine per i quali, rifiu-tando ogni forma di dualismo e ognipessimismo, ritengono necessario asse-gnare un ruolo centrale ai resoconti inprima persona e alla natura irriducibiledell’esperienza. Di questo gruppo fan-no parte studiosi come Searle, Chal-mers, Johson, Lakoff, Flanagan e lostesso Varela. L’interesse comune cheunisce questi autori è il riferimento al-l’esperienza soggettiva come fatto fon-damentale che dovrebbe caratterizzareogni approccio nei riguardi della co-scienza.La nozione di coscienza, cui si giungecon la riduzione fenomenologica, è ra-dicalmente diversa rispetto a quelladell’empirismo angloamericano. Non sitratta di “un’ispezione privata”, ma diun ambito di fenomeni in cui “il sogget-tivo e l’oggettivo” emergono natural-mente. L’esperienza è certamente unevento personale del soggetto, ma nonsignifica che sia di tipo privato, poichéla “mia coscienza è inestricabilmentecollegata a quella degli altri e al mondofenomenico in un coacervo empatico”.
A sua volta, la coscienza è legata in ma-niera indissolubile al cervello, alla men-te, al mondo e agli altri. Il problema delneuronal correlate of consciousness - di-chiara Varela - è perciò “mal posto”,perché la coscienza “non risiede solonella testa”, non è cioè un “segmento dicircuiti cerebrali, ma appartiene a unorganismo incessantemente coinvoltonelle esperienze degli altri”. La co-scienza dunque si costituisce come “unflusso continuo di esperienze”.Ma è so-prattutto l’attività della mente che ren-de l’uomo un essere umano, capace diavere coscienza di sé, degli altri e delmondo, di soffrire e gioire, ricordare esperare.Nonostante tutte le acquisizioni conse-guite, riteniamo, d’accordo con altri au-tori, che la mente rimanga ancora unmistero tutto da esplorare. Contro gliscettici, finora la ricerca dimostra comesia possibile indagare un campo di stu-dio così complesso come la mente. Prio-ritario è il superamento della contrap-posizione tra autori divisi sul modo diconsiderare la espressione “avere unamente”. Per Searle, ad esempio, “avereuna mente” significa avere una coscien-za e cioè stati mentali soggettivi, i co-siddetti qualia, fenomeni non quantifi-cabili oggettivamente e non riducibili aiprocessi neurofisiologici del cervello.Per un altro autore, Dennett, invecenon si danno i qualia, e la coscienza èsolo “una serie di programmi per com-puter implementati nel cervello”. A suavolta, Fodor considera la mente costi-tuita da parti o moduli distinti, in basealle diverse funzioni della mente. Sull’idea della mente assunta comeuna forma particolare di computer, cisembra giunto il momento di afferma-re definitivamente che la nostra mentenon si comporta “mai in tutto e per tut-to” come quello di un computer (Bon-cinelli). Il cervello è “diverso” sotto
molti aspetti da un computer (Gazza-niga). Noi ci “contraddiciamo”, abbia-mo “conflitti interiori”, amiamo e odia-mo, siamo capaci di creare il Requiemdi Mozart o la cappella Sistina, ma an-che Hiroshima e Auschwitz; di com-prendere i bisogni più profondi dei no-stri figli; ci intenerisce lo sguardo amo-revole e affettuoso del nostro cuccioloKimy implorante di uscire e scorrazza-re nel parco. Il cervello poi è altamen-te interconnesso e va riguardato comeil risultato imprevedibile del “caos edella complessità” (Kurzweil). Infine,nessun computer fino a oggi è stato ingrado di rispondere al test di Turingproposto nel 1950 da Alan Turing perrispondere alla domanda: “Le macchi-ne sono in grado di pensare?”. Sonostate effettuate montagne di ricerche eaccumulate tonnellate di dati, ma nonabbiamo ancora elaborato una teoriache possa spiegare “come” (Hawkins)pensano gli esseri umani. E allora co-me possiamo creare una macchina chesia in grado di pensare come un essereumano?Nell’uomo lo sviluppo dell’attività del-la mente coincide con l’accrescimento elo sviluppo del cervello, quel “supersi-stema di sistemi” (Damasio) che si èconsolidato nel corso di un lungo pro-cesso evolutivo durato milioni di anni.Lo sviluppo del cervello e della menteè all’origine dell’affascinante avventuradell’uomo nel mondo e si pone comepunto di arrivo dell’Homo sapiens sa-piens, la cui sorte umana, iniziata circa150 mila anni fa in Africa, è passata at-traverso una transizione di passaggimorfologici e culturali. Anche in conse-guenza del progresso raggiunto dallacorteccia cerebrale, che inizia a svolger-si nell’uomo già nel terzo mese di gesta-zione.
Guido Brunetti