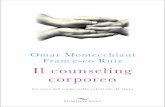CARLOS RUIZ ZAFÓN ATTO PRIMO - … · CARLOS RUIZ ZAFÓN IL GIOCO DELL'ANGELO (El Juego Del...
Transcript of CARLOS RUIZ ZAFÓN ATTO PRIMO - … · CARLOS RUIZ ZAFÓN IL GIOCO DELL'ANGELO (El Juego Del...
CARLOS RUIZ ZAFÓN
IL GIOCO DELL'ANGELO
(El Juego Del Ángel, 2008)
A MariCarmen,
"a nation of two"
ATTO PRIMO
La città dei maledetti
1
Uno scrittore non dimentica mai la primavolta che accetta qualche moneta o unelogio in cambio di una storia. Non
dimentica mai la prima volta che avvertenel sangue il dolce veleno della vanità ecrede che, se riuscirà a nascondere atutti la sua mancanza di talento, il sognodella letteratura potrà dargli un tettosulla testa, un piatto caldo alla fine dellagiornata e soprattutto quanto piùdesidera: il suo nome stampato su unmiserabile pezzo di carta che vivràsicuramente più a lungo di lui. Unoscrittore è condannato a ricordarequell'istante, perché a quel punto è giàperduto e la sua anima ha ormai unprezzo.
La mia prima volta fu un lontano giornodi dicembre del 1917. Avevo diciassetteanni e lavoravo a "La Voz de la
Industria", un giornale in rovina chelanguiva in un cavernoso edificio cheuna volta aveva ospitato una fabbrica diacido solforico e le cui paretitrasudavano ancora quel vapore checorrodeva i mobili, i vestiti, l'anima eperfino le suole delle scarpe. La sededel giornale si ergeva oltre la foresta diangeli e croci del cimitero del PuebloNuevo, e da lontano il suo profilo siconfondeva con quello delle tombe difamiglia ritagliate su un orizzonteaccoltellato da centinaia di comignoli edi edifici che intessevano un perpetuocrepuscolo nero e scarlatto sopraBarcellona.
La sera in cui sarebbe cambiato il corso
della mia vita, il vicedirettore delgiornale, don Basilio Moragas, volleconvocarmi poco prima della chiusuranell'oscuro cubicolo incassato in fondoalla redazione che funge-va da fumoir disigari e da ufficio per lui. Don Basilioera un uomo dall'aspetto feroce e daibaffi rigogliosi che andava per le spiccee sosteneva la teoria secondo la quale unuso liberale degli avverbi el'aggettivazione eccessiva erano cose dapervertiti e da persone con carenzevitaminiche. Se scopriva un redattoreincline alla prosa fiorita, lo spediva tresettimane a stilare necrologi. Se, dopo lapurga, il soggetto recidivava, donBasilio lo destinava alle pagine deilavori domestici vita natural durante. Lo
temeva-mo tutti, e lui lo sapeva.
«Don Basilio, mi ha fatto chiamare?» miaffacciai timidamente.
Il vicedirettore mi guardò di sottecchi.Entrai nell'ufficio che puzzava di sudoree di tabacco, in quest'ordine. DonBasilio ignorò la mia presenza econtinuò a rivedere uno degli articoliche aveva sulla scrivania, matita rossaalla mano. Per un paio di minutimitragliò il testo di correzioni, quandonon si trattava di amputazioni,masticando improperi come se io non cifossi. Non sapendo che fare, notai unasedia appoggiata al muro e feci peraccomodarmi.
«Chi le ha detto di sedersi?» mormoròdon Basilio senza sollevare gli occhi daltesto.
Mi alzai in fretta e furia e trattenni ilrespiro. Il vicedirettore sospirò, lasciòcadere la matita rossa e si adagiò sullapoltrona per esaminarmi come se fossiun arnese inservibile.
«Mi hanno detto che lei scrive, Martín.»
Deglutii e quando aprii la bocca ne uscìun ridicolo filo di voce.
«Un po', insomma, non so, voglio direche, be', sì, scrivo...»
«Sono sicuro che lo farà meglio di come
parla. E cosa scrive, se non sonoindiscreto?»
«Gialli. Mi riferisco a...»
«Ho afferrato l'idea.»
Lo sguardo che mi rivolse don Basilio fuimpagabile. Se gli avessi detto chemodellavo statuette del presepe con losterco fresco, gli avrei strappato il triplodell'entusiasmo. Sospirò di nuovo e sistrinse nelle spalle.
«Vidal dice che lei non se la cava male.Che si fa notare. Certo, con laconcorrenza che c'è da queste parti, nonbisogna nemmeno correre troppo.
Ma se lo dice Vidal.»
Pedro Vidal era la firma più prestigiosadi "La Voz de la Industria". Aveva unarubrica settimanale di cronaca checostituiva l'unico pezzo meri-tevole diessere letto in tutto il giornale, ed eraautore di una dozzina di romanzid'avventura che avevano ottenuto unamodesta popolarità, incen-trati sugangster del Raval coinvolti in intrighid'alcova con signore dell'al-ta società.Sempre infilato in impeccabili completidi seta e lustri mocassi-ni italiani, Vidalaveva l'aria e l'atteggiamento da attored'avanspettacolo, con i capelli biondisempre ben pettinati, i baffetti a matita eil sorriso faci-
le e generoso di chi si sente a suo agionella propria pelle e nel mondo.
Proveniva da una famiglia di "indiani"che avevano fatto fortuna nelleAmeriche con il commercio di zuccheroe che al ritorno avevano affondato identi nella succulenta tortadell'elettrificazione della città. Suopadre, il patriarca del clan, era unodegli azionisti di maggioranza delgiornale, e don Pedro utilizzava laredazione come un parco giochi perammazzare la noia di non aver dovutolavorare un solo giorno per necessità intutta la vita. Poco importava che ilquotidiano perdesse soldi allo stessomodo in cui perdevano olio le nuove
automobili che cominciavano ascorrazzare per Barcellona: carica dititoli nobiliari, la dinastia dei Vidaladesso si dedicava a collezionarenell'Ensanche banche e terreni estesicome piccoli princi-pati.
Pedro Vidal era stato il primo a cuiavevo mostrato gli abbozzi che scrivevoquando ero appena un bambino elavoravo portando caffè e sigarette inredazione. Aveva sempre trovato tempoper me, per leggere i miei scritti e darmibuoni consigli. A poco a poco mi avevatrasformato nel suo aiu-tante e mi avevapermesso di battere a macchina i suoitesti. Era stato lui a dirmi che, se volevogiocarmi il destino alla roulette russa
della letteratura, era disposto adaiutarmi e a guidare i miei primi passi.Fedele alla parola, mi gettava adesso tragli artigli di don Basilio, il cerbero delgiornale.
«Vidal è un sentimentale che credeancora a leggende profondamenteantispagnole come la meritocrazia o ilconcedere opportunità a chi le merita enon al raccomandato di turno. Riccosfondato com'è, può permettersi di fareil poeta in giro per il mondo. Se ioavessi la centesima parte dei soldi che alui avanzano, mi sarei messo a scriveresonetti e gli uccellini verrebbero amangiare dalle mie mani, incantati dallamia bontà e dal mio fascino.»
«Il signor Vidal è un grand'uomo»protestai.
«Di più. È un santo perché, nonostante lafaccia da morto di fame che lei siritrova, da settimane mi tormentadicendomi quanto è lavoratore e pienodi talento il beniamino della redazione.Lui sa che in fondo sono un mol-laccione, e poi mi ha assicurato che sele concedo questa opportunità mi regalauna scatola di Cohiba. E se lo diceVidal, per me è come se Mosè scendessedalla montagna con il suo pezzo di pietrain mano e la verità rivelata che glialeggia sulla testa. Perciò, perconcludere, perché è Natale, e per zittireil suo amico una volta per tutte, le offro
di debuttare come gli eroi: contro ogniostacolo, a dispetto del mondo.»
«Grazie infinite, don Basilio. Legarantisco che non si pentirà di...»
«Non parta in quarta, ragazzino.Vediamo: cosa ne pensa dell'usogeneroso e indiscriminato di avverbi eaggettivi?»
«Che è una vergogna e che dovrebbeessere contemplato dal codice penale»risposi con la convinzione del convertitomilitante.
Don Basilio annuì con approvazione.
«Va bene, Martín. Ha chiare le priorità.
A sopravvivere in questo mestiere sonoquelli che hanno priorità e non princìpi.Ecco il piano. Si sieda e si beva tuttoperché non lo ripeterò due volte.»
Il piano era questo: per ragioni che donBasilio non ritenne opportunoapprofondire, la controcopertinadell'edizione domenicale,tradizionalmen-te riservata a un raccontoo a un reportage di viaggio, era venuta amancare all'ultimo momento. Eraprevista una narrazione dalla venapatriottica e dall'acceso lirismo sullegesta degli almogaveri, in cui questiultimi, tra una cosa e l'altra, salvavanola cristianità e tutto quanto c'era didegno sotto il cielo, a cominciare dalla
Terra Santa per finire al delta delLlobregat.
Purtroppo, il testo non era arrivato intempo oppure, sospettavo io, a donBasilio non andava di pubblicarlo. Ecosì, a sei ore dalla chiusura non c'eranocandidati a sostituire il racconto, se nonuna pubblicità a pagina intera di unbusto di stecche di balena cheprometteva fianchi da sogno e immu-nitàai cannelloni. Di fronte al dilemma,l'ufficio centrale aveva deliberato chebisognava fare di necessità virtù eindividuare i talenti letterari nascosti inredazione, al fine di riempire il buco euscire a quattro colonne con un articolodi taglio umanistico per lo svago del
nostro affezionato pubblico familiare. Lalista di comprovati talenti a cui farericorso era composta da dieci nomi,nessuno dei quali, naturalmente, era ilmio.
«Martín, amico mio, le circostanzehanno cospirato per far sì che nemmenouno dei paladini che abbiamo inorganico risulti presente o sia loca-lizzabile entro un margine di tempoprudenziale. Di fronte all'imminentedisastro, ho deciso di concedere a leil'onore.»
«Conti su di me.»
«Conto su cinque cartelle a spaziodoppio entro sei ore, signor Edgar Allan
Poe. Mi porti una storia, non undiscorso. Se voglio sermoni, vado allamessa di mezzanotte. Mi porti una storiache non ho mai letto prima e, se l'ho giàletta, me la porti scritta e raccontata cosìbene che non me ne accorga neanche.»
Mi preparavo a uscire di corsa quandodon Basilio si alzò, fece il giro dellascrivania e mi posò sulla spalla unamanona del volume e del peso diun'incudine. Solo allora, vedendolo davicino, mi accorsi che gli sorride-
vano gli occhi.
«Se la storia è decente, gliela pagheròdieci pesetas. E se è più che decente epiace ai lettori, gliene pubblicherò
altre.»
«Qualche indicazione particolare, donBasilio?» domandai.
«Sì: non mi deluda.»
Le sei ore successive le passai in trance.Mi sistemai al tavolo al centro dellaredazione, che era riservato a Vidal neigiorni in cui gli girava di venire inufficio a perdere un po' di tempo. Lasala era deserta e immersa in unatenebra intessuta del fumo di diecimilasigarette. Chiusi gli occhi un istante edevocai un'immagine, un manto di nubinere che si rovesciavano in forma dipioggia sulla città, un uomo checamminava in cerca di ombre con le
mani insanguinate e un segreto nellosguardo. Non sapevo chi era né da checosa fuggiva, ma nelle successive seiore sarebbe diventato il mio miglioramico. Infilai un foglio nel rullo e, senzaconcedermi un attimo di tregua,cominciai a spremere quanto avevodentro. Lottai con ogni parola, ognifrase, ogni espressione, ogni immagine eogni lettera come se fossero le ultimeche avrei scritto. Scrissi e riscrissi ognirigo come se ne andasse della mia vita epoi lo riscrissi di nuovo. La mia unicacompagnia furono l'eco del ticchettioincessante della tastiera che si perdevanella sala in penombra e il grandeorologio a muro che esauriva i minutiche mancavano all'alba.
Poco prima delle sei del mattinostrappai l'ultima cartella dal rullo esospirai sopraffatto, con la sensazione diavere un vespaio in testa. Sentii i passilenti e pesanti di don Basilio, che eraemerso da uno dei suoi sonnel-linicontrollati e si avvicinava concircospezione. Presi i fogli e glieliconsegnai, senza osare sostenere il suosguardo. Don Basilio si sedette al tavoloaccanto e accese la lampada. I suoiocchi scivolarono su e giù per il testosenza tradire alcuna espressione. Poilasciò per un istante la sigaretta sulbordo del tavolo e, guardandomi, lessead alta voce il primo rigo.
«"Cade la notte sulla città e le strade
odorano di polvere da sparo come ilrespiro di una maledizione."»
Don Basilio mi guardò di sottecchi e iomi feci scudo di un sorriso che nonlasciò al riparo nemmeno un dente.Senza dire altro, si alzò e partì con ilmio racconto tra le mani. Lo vidiallontanarsi verso il suo ufficio echiudersi la porta alle spalle. Rimasipietrificato, senza sapere se mettermi acorrere o aspettare la sentenza di morte.Dopo dieci minuti che mi sembraronodieci anni, la porta dell'ufficio si aprì ela voce tonante di don Basilio si fecesentire in tutta la redazione.
«Martín. Mi faccia il favore di venire.»
Mi trascinai il più lentamente possibile,accorciando ogni volta il passo diqualche centimetro, finché non ebbi altrascelta che affacciarmi nell'ufficio esollevare lo sguardo. Don Basilio, conla temibile matita rossa in mano, miguardava freddamente. Cercai dideglutire, ma avevo la bocca secca. DonBasilio raccolse i fogli e me li restituì.Li presi e mi girai verso la porta più infretta che potei, dicendo a me stesso checi sarebbe sempre stato posto per unaltro lustrascarpe nella hall dell'hotelColón.
«Lo porti in tipografia e lo faccia andarein macchina» disse la voce alle miespalle.
Mi voltai, credendo di essere oggetto diuno scherzo crudele. Don Basilio aprì ilcassetto della scrivania, contò diecipesetas e le mise sul tavolo.
«Queste sono sue. Le suggerisco dicomprarcisi un altro modellino perchésono quattro anni che la vedo semprecon lo stesso completo, e le sta sempresei taglie più grande. Se vuole, vada atrovare il signor Pantaloni nella suasartoria in calle Escudellers e gli dicache la mando io. La tratterà bene.»
«Molte grazie, don Basilio. Farò così.»
«E intanto mi prepari un altro di queiracconti. Stavolta le do una settimana.Ma non mi si addormenti. E vediamo se
in questo ci sono meno morti, perché allettore di oggi piace il finale sdolcinatoin cui trionfa la grandezza dello spiritoumano e tutte quelle stupidaggini.»
«Sì, don Basilio.»
Il vicedirettore annuì, poi mi tese lamano. Gliela strinsi.
«Buon lavoro, Martín. Lunedì vogliovederla alla scrivania che era diJunceda, che adesso è sua. La metto incronaca.»
«Non la deluderò, don Basilio.»
«No, non mi deluderà. Mi mollerà,prima o poi. E farà bene, perché lei non
è un giornalista e non lo sarà mai. Manon è nemmeno ancora uno scrittore digialli, anche se crede di esserlo. Restiqui per un po' e le inse-gneremo un paiodi cose che non guastano mai.»
In quel momento, con la guardia bassa,mi invase un tale senso di gratitudineche mi venne voglia di abbracciarequell'omaccione. Don Basilio, lamaschera feroce di nuovo al suo posto,mi inchiodò con uno sguardo d'acciaio emi indicò la porta.
«Niente scene, per favore. Chiudaquando esce. E buon Natale.»
«Buon Natale.»
Il lunedì successivo, quando arrivai inredazione pronto a occupare per laprima volta la mia scrivania personale,trovai una busta di carta da pacchi conun fiocco e il mio nome scritto con icaratteri che per anni avevo battuto amacchina. La aprii. All'interno trovai lacontrocopertina della domenica con lamia storia incorniciata e un messaggioche diceva:
"Questo è solo l'inizio. Fra dieci anni iosarò l'apprendista e tu il maestro. Il tuoamico e collega, Pedro Vidal."
2
Il mio debutto letterario sopravvisse albattesimo del fuoco e don Basilio,
fedele alla parola data, mi offrìl'opportunità di pubblicare un altro paiodi racconti più o meno dello stessotenore. Ben presto la direzione deciseche la mia folgorante carriera avrebbeavuto periodicità settimanale, sem-preché continuassi a svolgerepuntualmente i miei compiti in redazioneallo stesso prezzo. Avvelenato dallavanità e dalla stanchezza, passavo legiornate a rivedere i testi dei mieicolleghi e a redigere di corsa articoli dicronaca nera con orrori indescrivibili,per poter poi dedicare le notti a scrivereda solo nella sala della redazione unracconto a puntate bizantino e operisticoche accarezzavo da tempo nella miaimmaginazione e che, sotto il titolo I
misteri di Barcellona, mescolava senzapudore Dumas e Bram Stoker, passandoper Sue e Féval. Dormivo più o menotre ore al giorno e sfoggiavo l'aspettoche avrei avuto se le avessi trascorse inuna bara. Vidal, che non aveva maiconosciuto quella fame che non ha nientea che vedere con lo stomaco e che timangia dal di dentro, era dell'opinioneche mi stessi bruciando il cervello e chedi quel passo avrei celebrato il miofunerale prima dei vent'anni. DonBasilio, che non si scandalizzava per lamia labo-riosità, aveva altre riserve. Mipubblicava ogni capitolo malvolentieri,infastidito da quello che riteneva uneccesso di morbosità e un malauguratosperpero del mio talento al servizio di
soggetti e trame di dubbio gusto.
Ben presto I misteri di Barcellonaportarono alla luce una piccola star deiromanzi d'appendice, un'eroina cheavevo immaginato come soltanto adiciassette anni si può immaginare unafemme fatale. Chloé Permanyer era ladark lady delle vampire. Troppointelligente e ancor più contorta eambigua, Chloé Permanyer indossavasempre le più incendiarie novità dilingerie raffinata e officiava da amante ebraccio destro dell'enigmatico BaltasarMorel, cervello dell'inframondo, cheviveva in una dimora sotterra-
nea popolata da automi e macabre
reliquie la cui entrata segreta si trovavanelle gallerie scavate sotto le catacombedel Barrio Gótico. Il metodo predilettoda Chloé per far fuori le sue vittime erasedurle con una danza ipno-tica in cui siliberava degli indumenti per poibaciarle con un rossetto avvelenato cheparalizzava tutti i muscoli del corpo e lefaceva morire asfis-siate in silenziomentre lei le guardava negli occhi, dopoessersi bevuta un antidoto sciolto nelDom Perignon riserva imperiale. Chloée Baltasar avevano il loro codiced'onore: eliminavano solo la feccia eripulivano il mondo da bulli, vermi,baciapile, fanatici, sciocchi dogmatici eogni tipo di cretini che ne facevano unluogo più miserabile del dovuto per gli
altri, in nome di bandiere, dèi, lingue,razze o schifezze di ogni specie dietrocui mascherare la loro avidità e la lorogrettezza. Per me erano eroi eterodossi,come tutti i veri eroi. Per don Basilio, icui gusti letterari si erano fermatiall'epoca d'oro del verso spagnolo,quelle erano assurdità di dimensioni co-lossali, ma considerando la buonaaccoglienza ricevuta dalle storie el'affetto che, suo malgrado, provava neimiei confronti, tollerava le mie stra-vaganze e le attribuiva a un eccesso dieccitazione giovanile.
«Lei ha più mestiere che buon gusto,Martín. La patologia che l'affligge ha unnome e quel nome è Grand Guignol, che
sta al dramma come la sifi-lide allevergogne. Il suo raggiungimento forse èpiacevole, ma da lì in poi si precipita arotta di collo. Dovrebbe leggere iclassici, o almeno don Benito PérezGaldós, per elevare le sue aspirazioniletterarie.»
«Ma ai lettori i racconti piacciono»argomentavo io.
«Il merito non è suo. È dellaconcorrenza, così inetta e pedante da farprecipitare un asino in stato catatonicoin meno di un paragrafo. Vediamo seriesce a maturare, una buona volta, e acadere dall'albero del frutto proibito.»
Io annuivo fingendo contrizione, ma
segretamente accarezzavo quelle paroleproibite, Grand Guignol, e mi dicevoche ogni causa, per quanto frivola,aveva bisogno di un campione che nedifendesse l'onore.
Cominciavo a sentirmi il più fortunatodei mortali quando scoprii che ad alcunicolleghi del giornale dava fastidio che ilbeniamino e mascotte ufficiale dellaredazione avesse mosso i primi passinel mondo delle lettere, mentre le loroaspirazioni e ambizioni letterarielanguivano da anni in un grigio limbo dimiserie. Il fatto che i lettori delquotidiano leggessero con avidità eapprezzassero quei modesti racconti piùdi qualunque altro testo pubblicato negli
ultimi vent'anni peggiorava solo le cose.In pochissime settimane vidi comel'orgoglio ferito di coloro che fino apoco tempo prima avevo considerato lamia unica famiglia li trasformava in untribunale ostile che iniziava a togliermiil saluto e la parola e che si compiacevanell'af-finare il proprio risentito talentorivolgendomi alle spalle espressioni disarcasmo e disprezzo. La miaincomprensibile buona sorte venivaattribui-ta all'aiuto di Pedro Vidal,all'ignoranza e alla stupidità dei nostriabbonati, nonché al diffuso e comodoparadigma nazionale secondo il qualeottenere qualche successo in qualsiasiambito professionale costituiva, senzaeccezioni, una prova inconfutabile di
incapacità e mancanza di meriti.
Davanti a quell'inattesa e infausta piegadegli avvenimenti, Vidal cercava difarmi coraggio; ma io iniziavo asospettare che i miei giorni in redazionefossero contati.
«L'invidia è la religione dei mediocri.Li consola, risponde alle inquietudiniche li divorano e, in ultima istanza,imputridisce le loro anime e con-sentedi giustificare la loro grettezza e la loroavidità fino a credere che siano virtù eche le porte del cielo si spalancherannosolo per gli infelici come loro, cheattraversano la vita senza lasciare altratraccia se non i loro sleali tentativi di
sminuire gli altri e di escludere, e sepossibile distruggere, chi, per ilsemplice fatto di esistere e di essere ciòche è, mette in risalto la loro povertà dispirito, di mente e di fegato. Fortunatocolui al quale la-trano i cretini, perchéla sua anima non apparterrà mai a loro.»
«Amen» conveniva don Basilio. «Se leinon fosse nato ricco, avrebbe dovutofare il prete. O il rivoluzionario. Consermoni così, crolla contrito perfino unvescovo.»
«Sì, ridete pure» protestavo io. «Intanto,quello che non possono vedere nemmenodipinto sono io.»
A parte il ventaglio di inimicizie e
diffidenze che i miei sforzi mi stavanoprocurando, la triste realtà era che,nonostante le mie arie da autorepopolare, lo stipendio mi bastava astento per sopravvivere, comprare piùlibri di quelli che avevo il tempo dileggere e affittare una stanzetta in unapensione sepolta in un vicolo vicino acalle Princesa e diretta da una gali-zianadevota che rispondeva al nome di donnaCarmen. Donna Carmen pretendevadiscrezione e cambiava le lenzuola unavolta al mese, motivo per cui siconsigliava ai residenti di astenersi dalsoccombere alle tentazio-nidell'onanismo o dal mettersi a letto con ivestiti sporchi. Non era necessariolimitare la presenza di femmine nelle
stanze perché non c'era una sola donnain tutta Barcellona che avrebbeacconsentito a entrare in quel buco,nemmeno sotto minaccia di morte. Lìimparai che nella vita quasi tutto sidimentica, a cominciare dagli odori, eche se aspiravo a qualcosa nel mondoera a non morire in un posto comequello. Nei momenti tristi, che erano lamaggioranza, mi dicevo che, se qualcosami avrebbe tirato fuori di lì prima che lofacesse un attacco di tubercolosi, era laletteratura, e che se a qualcunoprudevano l'anima o le vergogne, per mepoteva grattarsele con un mattone.
Le domeniche all'ora della messa,quando donna Carmen partiva per il suo
appuntamento settimanale conl'Altissimo, gli ospiti approfittavano perriunirsi nella stanza del più veterano ditutti noi, un infelice chiamato Heliodoroche da giovane aspirava a diventarematador, ma si era poi accon-tentato difare le cronache delle corride e ilresponsabile degli orinatoi della zonadei posti al sole della plaza de torosMonumental.
«L'arte del toreo è morta» proclamava.«Ora è tutto in mano ad allevato-ri avidie toreri senz'anima. Il pubblico non sadistinguere il toreo per la massaignorante dall'arte che solo gliintenditori sanno apprezzare.»
«Ah, se le avessero dato la possibilità,don Heliodoro, sarebbe un altro paio dimaniche.»
«È che in questo paese hanno successosolo i buoni a nulla.»
«Non me lo dica...»
Dopo il sermone settimanale di donHeliodoro arrivavano i festeggiamenti.Ammucchiati come salsicce davanti allafinestrella della stanza, i residentipotevano vedere e sentire attraverso illucernario i rantoli di una vicinadell'immobile attiguo, Marujita,soprannominata Peperoncino per laparlata piccante e la generosa anatomiaa forma di peperone rosso. Marujita si
guadagnava la vita facendo le pulizie innegozi di mezza tacca, ma la domenica ele feste comandate le riservava a unfidanzato seminarista che, in incognito,arrivava in treno da Manresa es'impegnava con brio ed entusiasmonella conoscenza del peccato. I mieicompagni di alloggio se ne stavanoinsaccati alla finestra per catturare unavisione fugace delle titani-che chiappedi Marujita in uno di quegli andirivieniche le facevano lievi-tare comel'impasto del dolce di Pasqua contro ilvetro del lucernario, quando suonò ilcampanello della pensione. Di frontealla mancanza di vo-lontari per andaread aprire, rischiando così di perdere unposto con una buona vista sullo
spettacolo, desistetti dal desiderio diunirmi al coro e mi incamminai verso laporta. Quando aprii, mi imbattei in unavisione insoli-
ta e improbabile in una cornice tantomiserabile. Don Pedro Vidal in tutto ilsuo genio, la sua eleganza e il suocompleto di seta italiana sorrideva dalpianerottolo.
«E la luce fu» disse entrando senzaattendere l'invito.
Si soffermò a osservare la stanza chefaceva le funzioni di sala da pranzo eagorà di quel tugurio e sospirò condisgusto.
«Forse è meglio andare nella miastanza» suggerii.
Gli feci strada. Le urla e le ovazioni deimiei coinquilini in onore di Marujita edelle sue acrobazie veneree perforavanole pareti di esultanza.
«Che posto allegro» commentò Vidal.
«Si degni di accomodarsi nella suitepresidenziale, don Pedro» lo invitai.
Entrammo e chiusi la porta. Dopo averdato un'occhiata velocissima alla miastanza, si sedette sull'unica sedia e miguardò con freddezza. Non faticavo aimmaginare l'impressione che il miomodesto domicilio doveva avergli
provocato.
«Cosa gliene sembra?»
«Incantevole. Quasi quasi trasloco quianch'io.»
Pedro Vidal abitava a Villa Helius, unmonumentale casermone modernista ditre piani con torrione, adagiato sullependici delle colline che salivano versoPedralbes, all'incrocio tra calleAbadesa Olzet e calle Panama.
La casa era un regalo che il padre gliaveva fatto dieci anni prima con lasperanza che mettesse la testa a posto esi facesse una famiglia, impresa nellaquale Vidal aveva già qualche decennio
di ritardo. La vita aveva benedetto donPedro Vidal con molti talenti, fra i qualiquello di deludere e offendere suo padrecon ogni gesto e ogni passo che faceva.Vederlo fraternizzare con indesiderabilicome me non aiutava. Ricordo che unavolta in cui avevo fatto visita al miomentore per portargli dei documenti dalgiornale mi imbattei nel patriarca delclan Vidal in una delle sale di VillaHelius. Quando mi vide, il padre di donPedro mi ordinò di andare a pren-dergliun bicchiere di gassosa e unostrofinaccio pulito per togliergli unamacchia dalla giacca.
«Credo che si confonda, signore. Nonsono un servo...»
Mi rivolse un sorriso che metteva inchiaro l'ordine delle cose nel mondosenza bisogno di parole.
«Chi si confonde sei tu, ragazzo. Sei unservo, che tu lo sappia o no.
Come ti chiami?»
«David Martín, signore.»
Il patriarca assaporò il mio nome.
«Segui il mio consiglio, David Martín.Vattene da questa casa e torna nel postoa cui appartieni. Ti risparmierai moltiproblemi e li risparmierai a me.»
Non lo confessai mai a don Pedro, ma
filai subito in cucina a prendere lagassosa e lo strofinaccio e passai unquarto d'ora a pulire la giacca delgrand'uomo. L'ombra del clan era lunga,e per quanto a don Pedro piacesseostentare una leggiadria da bohémien,tutta la sua vita era una propaggine dellarete familiare. Villa Helius eravantaggiosamente situata a cinque minutidalla grande villa paterna che dominavail tratto superiore di avenida Pearson, unmiscuglio cattedralizio di balaustrate,scalinate e abbaini che contemplava tuttaBarcellona in lontananza come un bimbocontempla i giocattoli buttati via. Ognigiorno una spedizione di due domestici euna cuoca della casa grande, com'erachiamato il domicilio paterno nel giro
dei Vidal, si recava a Villa Helius perpulire, lucidare, stirare, cucinare e rim-boccare l'esistenza del mio facoltosoprotettore in un letto di comodità eperpetuo oblio degli incresciosi fastididella vita quotidiana. Don Pedro Vidalsi spostava per la città su una fiammanteHispano-Suiza guidata dall'autista difamiglia, Manuel Sagnier, eprobabilmente non era mai salito su untram in tutta la sua vita. Da buonacreatura di palazzo e di alto lignaggio, aVidal sfuggiva il lugubre e macilentofascino che avevano le pensionieconomiche nella Barcellona dell'epoca.
«Non si faccia scrupoli, don Pedro.»
«Questo posto sembra una cella»proclamò alla fine. «Non so come fai aviverci.»
«Con il mio stipendio, e pure a stento.»
«Se è necessario, ti do io quello chemanca per farti vivere in un posto chenon puzzi di zolfo e di piscio.»
«Non se lo sogni nemmeno.»
Vidal sospirò.
«Morì d'orgoglio e nell'asfissia piùassoluta. Ecco un epitaffio gratis.»
Per qualche istante Vidal si mise acamminare per la stanza senza aprire
bocca, fermandosi a ispezionare il miominuscolo armadio, a guardare dallafinestra con la faccia schifata, a tastarela pittura verdastra che ricopriva i murie a colpire leggermente con l'indice lalampadina nuda che pendeva dal soffitto,come se volesse verificare che la qualitàdi tutta quella roba era infima.
«Cosa la porta da queste parti, donPedro? Troppa aria pura a Pedralbes?»
«Non vengo da casa. Vengo dalgiornale.»
«E allora?»
«Ero curioso di vedere dove abiti e poiho qualcosa per te.»
Tirò fuori dalla giacca una busta dipergamena bianca e me l'allungò.
«È arrivata oggi in redazione, a nometuo.»
Presi la busta e la esaminai. Era chiusacon un sigillo di ceralacca in cui sinotava il disegno di un profilo alato. Unangelo. A parte questo, l'unica cosavisibile era il mio nomeimpeccabilmente scritto in una grafiascarlatta dai tratti raffinati.
«Chi la manda?» chiesi, intrigato.
Vidal si strinse nelle spalle.
«Qualche ammiratore. O ammiratrice.
Non lo so. Aprila.»
Aprii con cautela la busta e ne estrassiun foglio piegato in due sul quale, nellastessa grafia, si leggeva:
Caro amico,
mi permetto di scriverle per trasmetterlela mia ammirazione e i miei complimentiper il successo ottenuto di recente daiMisteri di Barcellona sulle pagine della"Voz de la Industria". In quanto lettore eamante della buona letteratura, mi fa unimmenso piacere incontrare una nuovavoce piena di talento, gioventù epromesse.
Mi consenta, dunque, in segno di
gratitudine per le belle ore che la letturadei suoi racconti mi ha regalato, diinvitarla a una piccola sorpresa checonfido sia di suo gradimento amezzanotte all'En-sueho del Raval. Laaspetteranno.
Affettuosamente
A.C.
Vidal, che aveva letto da dietro le miespalle, inarcò le sopracciglia, in-curiosito.
«Interessante» mormorò.
«In che senso?» domandai. «Che generedi posto è l'Ensueño?»
Vidal estrasse una sigaretta dalportasigarette di platino.
«Donna Carmen non lascia fumare nellapensione» lo avvertii.
«Perché? Il fumo disturba la puzza difogna?»
Vidal accese la sigaretta e l'assaporòcon doppio piacere, come si gode ditutto ciò che è proibito.
«Hai mai conosciuto una donna,David?»
«Be', certo. Un mucchio.»
«Intendo in senso biblico.»
«A messa?»
«No, a letto.»
«Ah.»
«Allora?»
La verità è che non avevo granché daraccontare che potesse impressionareuno come Vidal. Le mie avventure e imiei amorazzi da adolescente si eranocaratterizzati fino a quel momento per laloro modestia e una notevole mancanzadi originalità. Nulla nel mio brevecatalogo di pizzicotti, ca-rezze e bacirubati in portoni e sale cinematografichepoteva aspirare a meritare laconsiderazione del maestro consacrato
nelle arti e nelle scienze dei giochid'alcova della Città Comitale.
«Che c'entra questo?» protestai.
Vidal adottò un atteggiamentoprofessorale e sciorinò uno dei suoidiscorsi.
«Nella mia gioventù, la cosa normale,almeno per i signorini come me, eravenire iniziati a queste battaglie permano di una professionista. Quandoavevo la tua età, mio padre, che era ed èancora un habitué dei locali più raffinatidella città, mi portò in un posto chiamatol'Ensueño, a pochi metri da quel palazzomacabro che il nostro caro conte Güellvolle far costruire da Gaudí sulle
Ramblas. Non dirmi che non ne hai maisentito parlare.»
«Del conte o del bordello?»
«Molto divertente. L'Ensueño era unlocale elegante per una clientela se-lezionata avveduta. A dire il veropensavo avesse chiuso da anni, maimmagino che non debba essere così. Adifferenza della letteratura, certi affarisono sempre in attivo.»
«Capisco. È sua l'idea? Una specie discherzo?»
Vidal negò.
«Di qualche cretino della redazione,
allora?»
«Rilevo una certa ostilità nelle tueparole, ma dubito che qualcuno dedi-toal nobile mestiere della stampa inqualità di soldato semplice possapermettersi gli onorari di un posto comel'Ensueño, se è quello che ricordo.»
Sbuffai.
«Fa lo stesso, tanto non penso diandarci.»
Vidal inarcò le sopracciglia.
«Non venirtene fuori adesso con lastoria che non sei un miscredente comeme e che vuoi arrivare puro di cuore e
di parti basse al talamo nuziale, che seiun'anima immacolata desiderosa diattendere il momento magico in cui ilvero amore ti porterà a scoprire l'estasidella carne e dell'anima in un unisonobenedetto dallo Spirito Santo, perpopolare il mondo di creature cheabbiano il tuo cognome e gli occhi dellamadre, quella santa donna scrigno divirtù e onestà, tenendo la cui manovarcherai le porte del cielo sotto ilbenevolo e compiaciuto sguardo delBambin Gesù.»
«Non volevo dire questo.»
«Ne sono contento, perché è possibile, esottolineo possibile, che quel momento
non arrivi mai, che non ti innamori, chetu non voglia né possa affidare la tuavita a qualcuno e che, come me, tucompia un giorno quarantacinque anni eti accorga che non sei più giovane e chenon c'era per te un coro di cupidi con lelire, né un letto di rose bianche adagiatoverso l'altare, e che l'unica vendetta cheti resta è rubare alla vita il piacere diquella carne soda e ardente che evaporapiù in fretta delle buone intenzioni, lacosa più simile al cielo che troverai inquesto porco mondo dove tutto marci-sce, a cominciare dalla bellezza perfinire con la memoria.»
Lasciai fluttuare una pausa solenne a mo'di silenziosa ovazione. Vidal era un
appassionato d'opera e aveva finito peracquisire il ritmo e l'oratoria dellegrandi arie. Non mancava mai al suoappuntamento con Puccini dal palco difamiglia al Liceo. Era uno dei pochi,senza contare i poveracci ammucchiatiin piccionaia, che andavano lì adascoltare la musica che tanto amava eche tanto tendeva a influenzare i discorsisul divino e l'umano con cui a volte,come quel giorno, omaggiava le mieorecchie.
«Cosa c'è?» chiese Vidal, con aria disfida.
«Quell'ultimo paragrafo mi ricordaqualcosa.»
Sorpreso con le mani nel sacco, sospiròe annuì.
«È di Assassinio al Circolo del Liceo»ammise Vidal. «La scena finale in cuiMiranda LaFleur spara all'iniquomarchese che le ha spezzato il cuoretradendola in una notte di passione nellasuite nuziale dell'hotel Colón fra lebraccia della spia dello zar SvetlanaIvanova.»
«Mi sembrava. Non avrebbe potutoscegliere meglio. È il suo capolavoro,don Pedro.»
Vidal mi sorrise per l'elogio e valutò seaccendere un'altra sigaretta.
«Il che non toglie che ci sia della veritàin tutto questo» concluse.
Vidal si sedette sul davanzale, non senzaaverci prima messo sopra un fazzolettoper non macchiarsi i pantaloni d'altaclasse. Vidi la Hispano-Suizaparcheggiata sotto, all'angolo di callePrincesa. L'autista, Manuel, lu-
strava le cromature con un panno comese si trattasse di una scultura di Rodin.Manuel mi aveva sempre ricordato miopadre, uomini della stessa generazioneche avevano attraversato troppi giorni disventura e che avevano la propriamemoria incisa sulla faccia. Avevosentito dire da qualcuno dei domestici di
Villa Helius che Manuel Sagnier avevatrascorso un lungo periodo in carcere eche quand'era uscito aveva patito anni distenti perché nessuno gli dava lavoro senon come scaricatore di sacchi e cassesui moli, un mestiere per il quale nonaveva più l'età né la salute. Manuel,rischiando la vita, aveva salvato Vidaldal finire sotto un tram. Per ricono-scenza Pedro Vidal, venuto a saperedella penosa situazione del pover'uomo,aveva deciso di offrirgli un lavoro e lapossibilità di trasferirsi con la moglie ela figlia nel piccolo appartamento soprai garage di Villa Helius.
Gli aveva assicurato che la piccolaCristina avrebbe studiato con gli stessi
tutori che ogni giorno si recavano allacasa paterna nell'avenida Pearson perimpartire lezioni ai rampolli delladinastia Vidal, e che sua moglie avrebbepotuto svolgere il suo mestiere di sartaper la famiglia. Lui stava pensando diacquistare una delle prime automobiliche si vendevano a Barcellona e, seManuel avesse appreso l'arte della guidamotorizzata lasciandosi alle spalle lacarrozza e il calesse, Vidal avrebbeavuto bisogno di un autista, perché inquell'epoca i signorini non mettevano lemani sui motori a scoppio né suicongegni con scappamento a gas.Manuel, naturalmente, aveva accettato.Dopo questo riscatto dalla miseria, laversione ufficiale assicurava che
Manuel Sagnier e famiglia provavanouna devozione cieca nei confronti diVidal, eterno paladino dei diseredati. Ionon sapevo se credere a quella storia ose attribuirla alla sfilza di leggende fio-rite intorno al carattere da aristocraticobenevolo che coltivava Vidal, al quale avolte sembrava che mancasse solo diapparire a qualche pastorella orfanaavvolto in un alone di luce.
«Ti è venuta la faccia da mascalzone diquando ti lasci andare a pensierimaliziosi» rilevò Vidal. «Cosa staitramando?»
«Niente. Pensavo a quanto è buono lei,don Pedro.»
«Alla tua età e con la tua posizione, ilcinismo non apre nessuna porta.»
«Questo spiega tutto.»
«Su, saluta quel brav'uomo di Manuel,che chiede sempre di te.»
Mi affacciai alla finestra. Quando mivide, l'autista, che mi trattava semprecome un signorino e non come lo zoticoche ero, mi salutò da lontano.
Ricambiai il saluto. Seduta in macchinac'era sua figlia Cristina, una creaturadalla pelle candida e le labbrapennellate, più grande di me di un paiod'anni, che mi aveva tolto il fiato quandol'avevo vista la prima volta che Vidal mi
aveva invitato a Villa Helius.
«Non guardarla troppo, altrimenti larompi» mormorò Vidal alle mie spalle.
Mi girai e mi trovai di fronteall'espressione machiavellica che Vidalriservava agli affari di cuore e di altriorgani nobili.
«Non so di cosa parla.»
«Che gran verità» replicò Vidal.«Allora, cos'hai deciso per stanotte?»
Rilessi il biglietto ed esitai.
«Lei frequenta questo tipo di locali, donPedro?»
«Non pago per una donna da quandoavevo quindici anni e anche allora,tecnicamente, ha pagato mio padre»rispose Vidal senza nessuna spocchia.
«Ma a caval donato...»
«Non lo so, don Pedro...»
«Certo che lo sai.»
Vidal mi batté sulla spalla mentreandava verso la porta.
«Ti restano sette ore fino a mezzanotte»disse. «Lo dico nel caso volessischiacciare un pisolino per accumulareforze.»
Mi affacciai alla finestra e lo vidiallontanarsi verso la macchina. Manuelgli aprì la portiera e Vidal si lasciòcadere per inerzia sul sedile posteriore.Sentii il motore della Hispano-Suizadispiegare la sua sinfonia di pi-stoni estantuffi. In quell'istante la figliadell'autista, Cristina, alzò gli occhi eguardò verso la mia finestra. Le sorrisi,ma mi resi conto che lei non si ricordavadi me. Un attimo dopo distolse losguardo e la grande vettura di Vidal siallontanò per far ritorno al suo mondo.
3
A quell'epoca calle Nou de la Ramblastendeva un corridoio di lampioni e
insegne luminose fra le tenebre delRaval. Cabaret, sale da ballo e localidifficili da classificare sgomitavano suentrambi i marciapiedi con casespecializzate in malattie veneree,preservativi e lavande che rimanevanoaperte fino all'alba mentre gente di ognirisma, dai signorini di una certadistinzione ai membri degli equipaggi dinavi ancorate nel porto, si mescolavacon stravaganti personaggi che vivevanodal tramonto in poi. Su entrambi i latidella strada si aprivano vicoli angusti esepolti nella bruma che ospitavano unalitania di postriboli dal decrescentecachet.
L'Ensueño occupava la parte superiore
di un edificio che a piano terra ospitavaun music-hall e che annunciava congrandi locandine lo spettacolo di unaballerina inguainata in una diafana esuccinta toga che non faceva mistero deisuoi incanti mentre teneva tra le bracciaun serpente nero, la cui lingua bifidasembrava baciarla sulle labbra.
"Eva Montenegro e il tango della morte"recitava la locandina a caratteri cubitali."La regina della notte in sei serateesclusive e imperdibili. Con lapartecipazione straordinaria diMesmero, il lettore di menti che svelerài vostri più intimi segreti."
Accanto all'ingresso del locale c'era una
porta stretta oltre la quale si apriva unalunga scalinata con le pareti dipinte dirosso. Salii le scale e mi piazzai davantia una grande porta di rovere intagliato,il cui batacchio aveva la forma di unaninfa forgiata in bronzo con un pudicotrifoglio sul pube. Bussai un paio divolte e aspettai, rifuggendo dal mioriflesso sul grande specchio fumé cheoccupava buona parte della parete.Stavo considerando la possibilità disquagliarmela in tutta fretta quando laporta si aprì e una donna di mezza etàdai capelli completamente bianchi eimpeccabilmente acconciati a crocchiami sorrise serena.
«Lei dev'essere il signor David Martín.»
Nessuno mi aveva mai chiamato signore,e la cerimoniosità mi colse di sorpresa.
«In persona.»
«Se vuole avere la cortesia di entrare edi seguirmi...»
Le andai dietro lungo un breve corridoioche conduceva a un'ampia sala circolaredalle pareti rivestite di velluto rosso econ lampade dalla luce soffusa. Ilsoffitto formava una cupola di vetrosmaltato da cui pendeva un lampadariodi cristallo sotto il quale una tavola dimogano sosteneva un enormegrammofono che esalava un'aria d'opera.
«Gradisce qualcosa da bere?»
«Se avesse un bicchier d'acqua, glienesarei grato.»
La signora dai capelli bianchi sorrisesenza battere ciglio, imperturbabile nelsuo atteggiamento cortese e rilassato.
«Forse il signore preferisce una coppadi champagne o un liquore. O forse unbianco secco di Jerez.»
Il mio palato non andava oltre le diversevendemmie di acqua del rubinetto,perciò mi strinsi nelle spalle.
«Faccia lei.»
La signora assentì senza perdere ilsorriso e indicò una delle sontuose
poltrone sparse nella sala.
«Se il signore vuole accomodarsi, Chloéverrà subito da lei.»
Credetti di soffocare.
«Chloé?»
Indifferente alla mia perplessità, lasignora dai capelli bianchi sparìattraverso una porta che s'intravedevadietro una tenda di perline nere e milasciò da solo con il mio nervosismo e imiei inconfessabili desideri.
Camminai per la stanza per scacciare latremarella che si stava imposses-sandodi me. Eccezion fatta per la musica
soffusa e il battito del cuore alle tempie,quel posto era una tomba. Sei corridoipartivano dalla sala, fian-cheggiati daaperture ricoperte da tendaggi azzurriche conducevano a sei porte bianche adoppia anta, tutte chiuse. Mi lasciaicadere su una poltrona, uno di queglioggetti concepiti per coccolare lechiappe di principi reggenti egeneralissimi con un debole per i colpidi Stato. Dopo un po' la dama biancaritornò con una coppa di champagne suun vassoio d'argento. L'accettai e la vidiscomparire di nuovo dalla stessa porta.Bevvi lo champagne d'un sorso e mislacciai il colletto della camicia.Cominciavo a sospettare che fosse tuttouno scherzo ordito a mie spese da Vidal.
In quel momento mi accorsi di una figurache avanzava verso di me da uno deicorridoi.
Sembrava una bambina, e lo era.Camminava a testa bassa, senza che riu-scissi a vederle gli occhi. Mi alzai inpiedi.
La bambina s'inchinò in una riverentegenuflessione e mi fece cenno diseguirla. Solo allora mi resi conto cheuna delle sue mani era posticcia, comequella di un manichino. La bambina micondusse alla fine del corridoio e conuna chiave che portava appesa al colloaprì la porta e si fece da parte. La stanzaera quasi al buio. Mi ci addentrai per
qualche passo, cercando di aguzzare lavista. A quel punto sentii che la porta sichiudeva alle mie spalle e, quando mivoltai, la bambina era sparita. Sentiiscattare il meccanismo della serratura eseppi di essere chiuso dentro. Per unminuto rimasi lì, immobile. Lentamentegli occhi si abituarono alla penombra e icontorni della stanza si materializzaronointorno a me. Le pareti erano ricopertedi tela nera dal pavimento al soffitto. Suun lato si indovinava una serie di straniaggeggi che non avevo mai visto e chenon fui in grado di decidere se miparessero sinistri o tentatori. Un ampioletto circolare giaceva sotto una testierasimile a una grande ragnatela da cuipendevano due candelieri nei quali due
ceri neri ardevano sprigionando quelprofumo di cera che si annida nellecappelle e nelle camere ardenti. Accantoal letto c'era una grata dal disegnosinuoso. Rabbrividii. Quel posto eraidentico alla camera da letto che avevocreato nella finzione per la miaineffabile vampira Chloé e le sueavventure nei Misteri di Barcellona.C'era puzza di bruciato. Mi preparavo acercare di forzare la porta quando miaccorsi di non essere solo. Mi fermai,raggelato. Un profilo sì disegnava dietrola grata. Due occhi brillanti miosservavano e riuscii a distinguere ledita bianche e affusolate, con lungheunghie smaltate di nero, che spuntavanodai fori della grata. Deglutii.
«Chloé?» mormorai.
Era lei. La mia Chloé. L'operistica einsuperabile femme fatale dei mieiracconti, in carne e lingerie. Aveva lapelle più candida che avessi mai visto, ei capelli neri e lucidi tagliati ad angoloretto le incorniciavano il viso.
Le labbra sembravano dipinte di sanguefresco e nere aure d'ombra lecircondavano gli occhi verdi. Avevamovenze feline, come se quel corpo at-tillato in un corsetto rilucente comesquame fosse d'acqua e avesse imparatoa prendersi gioco della gravità. La golaslanciata e interminabile era circondatada un nastro di velluto scarlatto dal
quale pendeva un crocifisso rovesciato.La osservai avvicinarsi lentamente,incapace perfino di respirare, gli occhiinchiodati a quelle gambe disegnate contratto impossibile dentro calze di setache probabilmente costavano più diquanto io guada-gnassi in un anno esostenute da scarpe a punta annodatealle caviglie con nastri di seta. In vitamia non avevo mai visto niente di cosìbello, né di così terribile.
Mi lasciai condurre da quella creaturafino al letto, dove caddi, letteralmente,di culo. La luce delle candeleaccarezzava il profilo del suo corpo.
Il mio volto e le mie labbra rimasero
all'altezza del suo ventre nudo e senzanemmeno rendermi conto di quello chestavo facendo la baciai sotto l'om-belicoe le sfiorai la pelle con la guancia. Aquel punto mi ero dimenticato chi ero edove mi trovavo. Lei si inginocchiò difronte a me e mi prese la mano destra.Languida, come un gatto, mi leccò le ditaa una a una, poi mi fissò e cominciò aspogliarmi. Volevo aiutarla, ma sorrise eallontanò le mie mani.
«Shhhh.»
Quando ebbe finito, si accostò al mioviso e mi leccò le labbra.
«Adesso tu. Spogliami. Piano. Moltopiano.»
Seppi allora di essere sopravvissuto aun'infanzia malaticcia e spiacevole soloper vivere quei secondi. La spogliailentamente, sfogliandole la pelle finchéle restarono solo il nastro di vellutoattorno alla gola e quelle calze nere delcui ricordo tanti poveracci come meavrebbero potuto vivere cent'anni.
«Accarezzami» mi sussurrò all'orecchio.«Gioca con me.»
Accarezzai e baciai ogni centimetrodella sua pelle come se volessi me-morizzarlo per tutta la vita. Chloé nonaveva fretta e rispondeva al tocco dellemie mani e delle mie labbra con leggerigemiti che mi guidavano. Poi mi fece
stendere sul letto e mi ricoprì con il suocorpo finché sentii bruciare ogni poro.Le posai le mani sulla schiena e percorsila linea miracolosa che segnava la suacolonna vertebrale. Il suo sguardoimpenetrabile osservava il mio viso dapochi centimetri di distanza. Sentii chedovevo dirle qualcosa.
«Mi chiamo...»
«Shhhhh.»
Prima che potessi dire qualche altrastupidaggine, Chloé appoggiò le suelabbra sulle mie e, per un'ora, mi fecescomparire dal mondo. Consapevoledella mia goffaggine, ma lasciandomicredere che non la notava, Chloé an-
ticipava ogni mio movimento e guidavale mie mani lungo il suo corpo senzafretta né pudore. Non c'era fastidio néassenza nei suoi occhi. Si lasciavatoccare e assaporare con infinitapazienza e con una tenerezza che mi fecedimenticare com'ero giunto fin lì. Quellanotte, per il breve spazio di un'ora,imparai ogni piega della sua pelle comealtri imparano le preghiere o lemaledizioni. Più tardi, quando quasi nonmi restava più fiato, Chloé mi lasciòappoggiare la testa sui suoi seni e miaccarezzò i capelli durante un lungosilenzio, fino a quando mi addormentaitra le sue braccia con la mano tra le suecosce.
Quando mi svegliai, la stanza era inpenombra e Chloé se n'era andata.
La sua pelle non era più tra le mie mani.Al suo posto c'era un biglietto da visitastampato sulla stessa pergamena biancadella busta che conteneva l'invito e sulquale, sotto l'emblema dell'angelo, sileggeva: ANDREAS CORELLI
Éditeur
Éditions de la Lumière
Boulevard St.-Germain, 69. Paris
Sul retro c'era un'annotazione a mano:
Caro David,
la vita è fatta di grandi speranze.Quando sarà pronto per trasformare lesue in realtà, si metta in contatto con me.La aspetterò.
Il suo amico e lettore
A.C.
Raccolsi gli indumenti da terra e mivestii. La porta della camera non era piùchiusa a chiave. Percorsi il corridoiofino al salone, dove il grammofono siera zittito. Non c'era traccia né dellabambina né della donna dai capellibianchi che mi aveva aperto. Il silenzioera assoluto. Mentre mi dirigevoall'uscita ebbi l'impressione che le lucialle mie spalle svanissero e che corridoi
e stanze si oscurassero lentamente. Usciisul ballatoio e scesi di malavoglia lescale di ritorno al mondo. Una volta instrada mi incamminai verso le Ramblas,lasciandomi dietro la folla e laconfusione dei locali notturni. Unanebbia tenue e calda saliva dal porto e illuccichio dei finestroni dell'hotelOriente la tingeva di un giallo sporco epolveroso in cui i passanti svanivanocome volute di vapore. Mi misi acamminare mentre il profumo di Chloéiniziava a svanire dai miei pensieri e midomandai se le labbra di CristinaSagnier, la figlia dell'autista di Vidal,avessero lo stesso sapore.
4
Uno non sa cosa sia la sete fin quandonon beve per la prima volta. Tre giornidopo la mia visita all'Ensueño, ilricordo della pelle di Chloé mi bruciavaperfino i pensieri. Senza dire nulla anessuno - men che meno a Vidal - decisidi mettere insieme i pochi risparmi chemi rimanevano e di ritornarci quellasera stessa, nella speranza chebastassero per comprare anche solo unistante tra le sue braccia. Era mezzanottequando giunsi alla scalinata dalle paretirosse che portava all'Ensueño. La luceera spenta e salii lentamente,lasciandomi alle spalle la rumorosacittadella di cabaret, bar, music-hall elocali di difficile definizione che glianni della Grande guerra in Europa
avevano disseminato in calle Nou de laRambla. La luce tremula che filtrava dalportone disegnava i gradini al miopassaggio. Arrivato sul pianerottolo, mifermai e cercai con le mani il batacchio.Le mie dita sfiorarono il pesantepicchiotto di metallo. Quando losollevai, la porta cedette di qualchecentimetro e capii che era aperta. Laspinsi leggermente.
Un silenzio assoluto mi accarezzò ilvolto. Di fronte a me si apriva unapenombra azzurrata. Feci qualche passo,sconcertato. L'eco delle luci della stradapalpitava nell'aria, svelando visionifugaci delle pareti nude e del pavimentodi legno sfasciato. Arrivai alla sala che
ricordavo decorata di velluti e mobiliopulenti. Era vuota. Il manto di polvereche ricopriva il pavimento brillavacome sabbia al luccichio delle insegneluminose della strada. Avanzai lasciandouna scia di impronte sulla polvere. Nonc'erano tracce né del grammofono, nédelle poltrone, né dei quadri. Il soffittoera crepato e s'intravedevano travi dilegno annerito. La pittura delle paretipendeva a brandelli simili a pelli diserpente. Mi diressi verso il corridoioche portava alla stanza dove avevoincontrato Chloé. Attraversai quel tunneldi oscurità fino ad arrivare alla porta adoppia anta, che non era più bianca. Nonc'era il pomello, solo un buco nel legno,come se la maniglia fosse stata strappata
di colpo. Aprii ed entrai.
La stanza di Chloé era una cella dinerume. Le pareti erano carbonizzate egran parte del soffitto era crollata.Potevo scorgere la muraglia di nuvolenere che attraversavano il cielo e la lunache proiettava un alone argentato sulloscheletro metallico di quello che erastato il letto. Fu allora che sentii ilpavimento scricchiolare alle mie spallee mi voltai di scatto, accorgen-domi dinon essere solo. Una sagoma scura eaffilata, maschile, si stagliavasull'ingresso. Non potevo distinguerne ilvolto, ma avevo la certezza che mistesse osservando. Rimase lì, immobilecome un ragno, per qualche secondo, il
tempo che impiegai a reagire e a fare unpasso verso di lui. In un attimo la figurascomparve nell'ombra e quando arrivainel salone non c'era più nessuno. Unalito di luce proveniente da un'insegnaluminosa sull'altro lato della stradainondò la sala per un secondo, svelandoun mucchietto di detriti vicino al muro.Qualcosa emergeva dalla pila. Dita.Scostai la cenere che le ricopriva elentamente affiorò il contorno di unamano. La presi e, tirandola, vidi che erasegata all'altezza del polso. Lariconobbi all'istante e capii che la manodi quella bambina, che avevo creduto dilegno, era di porcellana. La lasciaicadere e mi allontanai.
Mi chiesi se non mi fossi immaginatoquell'intruso, perché non c'erano orme dipassi sulla polvere. Scesi di nuovo instrada e rimasi a contemplare dalmarciapiede le finestre del primo piano,in preda alla confusione. La gente mipassava accanto ridendo, incurante dellamia presenza. Cercai di ritrovare ilprofilo dell'intruso tra la folla. Sapevoche era lì, forse a pochi metri, e che miosservava. Dopo un po' attraversai lastrada ed entrai in un piccolo caffèzeppo di gente. Riuscii a ritagliarmi unpo' di spazio al ban-
cone e feci un cenno al cameriere.
«Dica.»
Avevo la bocca secca e sabbiosa.
«Una birra» improvvisai.
Mentre il cameriere me la versava, michinai verso di lui.
«Scusi, sa se il locale di fronte,L'Ensueño, ha chiuso?»
Il cameriere lasciò il bicchiere sulbancone e mi guardò come se fossiscemo.
«È chiuso da quindici anni» disse.
«Ne è sicuro?»
«Certo. Dopo l'incendio non ha più
riaperto. Altro?»
Feci segno di no.
«Sono quattro centesimi.»
Pagai la consumazione e me ne andaisenza toccare il bicchiere.
Il giorno dopo arrivai in anticipo inredazione e andai dritto agli archivi delpiano interrato. Con l'aiuto di Matias, ilresponsabile, e facendomi guidare daquanto mi aveva detto il cameriere,iniziai a consultare le prime pagine della"Voz de la Industria" di quindici anniprima. Ci misi una qua-rantina di minutia trovare la vicenda, appena untrafiletto. L'incendio era scoppiato
all'alba del Corpus Domini del 1903.Sei persone erano morte tra le fiamme:un cliente, quattro delle ragazze inorganico e una ragazzina che lavorava lì.La polizia e i pompieri avevanoindividuato la causa della tragedia nelguasto di una lampada, ma il patronatodi una parrocchia vicina citava lagiustizia divina e l'intervento delloSpirito Santo come fattori determinanti.
Tornato alla pensione, mi stesi a letto ecercai inutilmente di conciliare il sonno.Tirai fuori dalla tasca il biglietto davisita di quello strano benefattore che miero ritrovato fra le mani risvegliandominel letto di Chloé e rilessi nellapenombra le parole scritte sul retro.
"Grandi speranze."
5
Nel mio mondo le speranze, grandi epiccole, raramente diventavano realtà.Fino a pochi mesi prima il mio unicodesiderio ogni sera quando andavo adormire era di trovare un giornoabbastanza coraggio da rivolgere laparola alla figlia dell'autista del miomentore, Cristina, e che passassero infretta le ore che mi separavano dall'albaper poter tornare alla redazione della"Voz de la Industria". Adesso, perfinoquel rifugio stava per sfuggir-
mi di mano. Forse, se qualcuno dei mieitentativi fosse fallito miseramente, avrei
riconquistato l'affetto dei miei colleghi,mi dicevo. Forse, se avessi scrittoqualcosa di tanto mediocre e abietto danon consentire a nessun lettore disuperare il primo paragrafo, i mieipeccati di gioventù sarebbero statiperdonati. Forse non sarebbe stato unprezzo troppo alto per potermi sentire dinuovo a casa. Forse.
Ero arrivato alla "Voz de la Industria"molti anni prima accompagnato da miopadre, un uomo tormentato e senzafortuna che al ritorno dalla guerra delleFilippine aveva trovato una città chepreferiva non riconoscerlo e una moglieche l'aveva già dimenticato e che dueanni dopo aveva deciso di
abbandonarlo. Gli aveva lasciato ilcuore infranto e un figlio mai desideratocon cui non sapeva che fare. Mio padre,che a stento era capace di leggere escrivere il suo nome, non aveva arte néparte. Quello che aveva imparato inguerra era uccidere altri uomini come luiprima che fossero loro a ucciderlo,sempre in nome di cause grandiose evuote che si rivelavano tanto più assurdee meschine quanto più ci si avvicinavaalla battaglia.
Al ritorno dalla guerra mio padre, chesembrava vent'anni più vecchio diquando era partito, cercò impiego invarie industrie del Pueblo Nuevo e delquartiere di Sant Marti. I lavori gli
duravano appena qualche giorno, eprima o poi me lo vedevo tornare a casacon lo sguardo avvilito dal risentimento.Col tempo, e in mancanza di alternative,accettò un posto da sorvegliante notturnoalla "Voz de la Industria". La paga eramodesta, però i mesi passavano, e per laprima volta dal ritorno dalla guerrasembrava non mettersi nei guai. La pacefu breve. Ben presto alcuni vecchicompagni d'armi, cadaveri viventi cheerano tornati mutilati nel corpo enell'anima per constatare che chi liaveva mandati a morire in nome di Dio edella patria adesso sputava loro infaccia, lo coinvolsero in affari torbiditroppo grandi per lui e che non riuscìmai a capire davvero.
Spesso mio padre spariva per un paio digiorni e, quando tornava, le mani e ivestiti gli puzzavano di polvere da sparoe le tasche di soldi. Allora si rifugiavanella sua stanza e, credendo che io nonme ne accorgessi, s'iniet-tava quel pocoo quel tanto che era riuscito a trovare.All'inizio non chiudeva mai la porta,però un giorno mi sorprese a spiarlo emi diede uno schiaffone che mi spaccòle labbra. Poi mi abbracciò fin quandola forza nelle braccia non lo abbandonòe restò disteso a terra, l'ago ancoraconficcato nella pelle. Glielo sfilai e locoprii con uno scialle. Dopo quell'inci-
dente cominciò a chiudersi a chiave.
Abitavamo in una piccola soffittasospesa sul cantiere del nuovoauditorium del Palau de la Música del'Orfeó Català. Era un posto freddo eangusto in cui il vento e l'umiditàsembravano prendersi gioco dei muri. Iomi sedevo sul piccolo balcone con legambe penzoloni a vedere la gente chepassava e a contemplare quellascogliera di sculture e colonneimpossibili che cresceva dall'altra partedella strada e che a volte mi sembravaquasi di poter toccare con le dita, mentrealtre, la maggioranza, mi parevanolontane come la luna. Sono stato unbambino debole e malaticcio, incline afebbri e infezioni che mi trascinavano allimitare della tomba, ma che, all'ultimo
momento, si pentivano sempre epartivano alla ricerca di una preda piùimportante. Quando mi ammalavo, miopadre finiva per perdere la pazienza edopo la seconda notte di veglia milasciava alle cure di una vicina espariva di casa per qualche giorno. Coltempo cominciai a sospettare chesperasse di trovarmi morto al suoritorno per liberarsi del peso di quelfiglio dalla salute di carta che non gliserviva a nulla.
Più di una volta desiderai cheaccadesse, ma mio padre tornava e mitrovava sempre vivo, scodinzolante e unpo' più alto. Madre Natura non avevapudore nel deliziarmi con il suo esteso
codice penale di germi e miserie, manon trovò mai il modo di applicarmi deltutto la legge di gravità. Contro ognipronostico, sopravvissi a quei primianni sul filo del rasoio di un'infanziaprecedente alla penicillina. Aquell'epoca, la morte non viveva ancoranell'anonimato e la si poteva vedere eannusare dappertutto mentre divoravaanime che ancora non avevano avutonemmeno il tempo di pec-care.
Già a quei tempi i miei unici amicierano fatti di carta e inchiostro. A scuolaavevo imparato a leggere e a scriveremolto prima degli altri bambini delquartiere. Dove i miei amici vedevanotracce d'inchiostro su pagine
incomprensibili, io vedevo luce, strade,persone. Le parole e il mistero dellaloro scienza occulta mi affascinavano emi sembravano una chiave con cuiaprire un mondo infinito e al riparo daquella casa, quelle strade e quei giornitorbidi in cui perfino io potevo intuireche mi attendeva scarsa fortuna. A miopadre non piaceva vedere libri per casa.C'era qualcosa in loro, a parte le lettereche non sapeva decifrare, chel'offendeva. Mi diceva che appenaavessi avuto dieci anni mi avrebbemesso a lavorare e che era meglio se mitoglievo tutti quei grilli dalla testaperché altrimenti sarei diventato undisgraziato e un morto di fame. Ionascondevo i libri sotto il materasso e
aspettavo che lui uscisse o siaddormentasse per poter leggere.
Una volta mi sorprese di notte e montòin collera. Mi strappò il libro di mano elo buttò dalla finestra.
«Se ti trovo ancora a sprecare luceleggendo quelle stupidaggini, te nepentirai.»
Mio padre non era un taccagno e,nonostante le ristrettezze che pativa-mo,quando poteva mi mollava qualchemoneta perché mi ci comprassi deidolciumi come gli altri bambini delquartiere. Era convinto che le spendes-siin bastoncini di liquirizia, arachidi ocaramelle, ma io le conservavo in un
barattolo di caffè sotto il letto e, quandoavevo messo insieme quattro o cinquereales, correvo a comprarmi un librosenza che lui lo sapesse.
Il mio posto preferito in tutta la città erala libreria di Sempere e Figli in calleSanta Ana. Quel posto che odorava dicarta vecchia e di polvere era il miosantuario e il mio rifugio. Il libraio milasciava sedere su una sedia in unangolo e leggere a mio piacimentoqualunque libro volessi. Quasi maiSempere mi faceva pagare i libri che mimetteva in mano, ma quando non se neaccorgeva io lasciavo sul banco, primadi andarmene, le monete che avevorisparmiato. Erano solo spiccioli, e se
avessi dovuto comprare qualche librocon quella miseria l'unico che mi sareisicuramente potuto permettere sarebbestato uno di quei libriccini di cartine persigarette. Quando era ora di andar via,lo facevo strascicando i piedi e l'anima,perché se fosse di peso da me sareirimasto a vivere lì.
Un Natale, Sempere mi fece il più belregalo che abbia mai ricevuto in vitamia. Era un tomo vecchio, letto e vissutoa fondo.
« Grandi speranze, di CarlosDickens...» lessi sulla copertina.
Mi risultava che Sempere conoscessealcuni scrittori che frequentavano il suo
negozio e, per l'affetto con cuimaneggiava quel volume, pensai cheforse quel don Carlos era uno di loro.
«Un amico suo?»
«Di tutta la vita. E da oggi anche tuo.»
Quella sera, nascosto sotto i vestitiperché mio padre non lo vedesse, miportai a casa il mio nuovo amico. Fu unautunno di piogge e giorni plum-beidurante il quale lessi Grandi speranzenove volte di fila, in parte perché nonavevo altro da leggere a portata di manoe in parte perché non pensavo chepotesse esistere un libro migliore einiziavo a sospettare che don Carlosl'avesse scritto solo per me. Ben presto
ebbi la ferma convinzione che nondesideravo altro nella vita se nonimparare a fare quello che faceva queltal signor Dickens.
Una notte mi svegliai di colpo per gliscossoni di mio padre, tornato dallavoro prima del tempo. Aveva gli occhiiniettati di sangue e l'alito gli puzzava dialcol. Lo guardai terrorizzato, e lui tastòcon le dita la lampadina nuda appesa aun filo.
«È calda.»
Mi fissò e scagliò con rabbia lalampadina contro il muro. Esplose inmille pezzi di vetro che mi caddero sullafaccia, ma non osai togliermeli.
«Dov'è?» chiese mio padre, la vocefredda e serena.
Scossi la testa, tremando.
«Dov'è quel libro di merda?»
Scossi di nuovo la testa. Nellapenombra, quasi non vidi arrivare ilcolpo. Sentii che mi si annebbiava lavista e che cadevo dal letto, con labocca sanguinante e un intenso dolorecome fuoco bianco che mi bruciavadietro le labbra. Nel girare la testa vidiquelli che mi sembrarono i pezzi di unpaio di denti rotti sul pavimento. Lamano di mio padre mi afferrò per ilcollo e mi sollevò.
«Dov'è?»
«Papà, per favore...»
Con tutte le forze mi sbatté la facciacontro il muro e il colpo mi fece perderel'equilibrio e crollare come un saccod'ossa. Mi trascinai in un angolo e me nestetti lì, raggomitolato, guardando miopadre che apriva l'armadio, prendeva lequattro cose che avevo e le buttava aterra. Perquisì cassetti e bauli senzatrovare il libro finché, esausto, tornò aoccuparsi di me. Chiusi gli occhi e miaddossai al muro, aspettando altre botteche non arrivarono mai. Li riaprii e vidimio padre seduto sul letto, che piangevasoffocando per la mancanza di fiato e la
vergogna. Quando si accorse che loguardavo, si precipitò giù per le scale.Ascoltai l'eco dei suoi passi allontanarsinel silenzio dell'alba e solo quando fuisicuro che fosse lontano mi trascinaifino al letto e presi il libro dalnascondiglio sotto il materasso.
Mi vestii e uscii con il romanzo sotto ilbraccio.
Un sudario di bruma calava su calleSanta Ana quando arrivai all'ingressodella libreria. Il libraio e suo figliovivevano al primo piano dello stessoedificio. Sapevo che le sei del mattinonon è ora per bussare a casa di nessuno,ma il mio unico pensiero in quel
momento era salvare il libro. Avevo lacertezza che, se mio padre l'avessetrovato rientrando a casa, l'avrebbe fattoa pezzi con tutta la rabbia che aveva incorpo. Suonai al campanello e aspettai.Dovetti insistere due o tre volte, finchésentii aprirsi la finestra del balcone evidi il vecchio Sempere, in vestaglia epantofole, che si affaccia-
va e mi guardava attonito. Un minutodopo scese ad aprirmi e appena mi videin faccia qualsiasi accenno di rabbiasvanì. Si accovacciò davanti a me e misostenne per le braccia.
«Santo Dio. Stai bene? Chi ti ha fattouna cosa del genere?»
«Nessuno. Sono caduto.»
Gli tesi il libro.
«Sono venuto a restituirglielo, perchénon voglio che gli succeda niente...»
Sempere mi guardò senza parlare. Miprese in braccio e mi portò a casa.
Suo figlio, un ragazzino di dodici annitanto timido che non ricordavo di avermai sentito la sua voce, si era svegliatosentendo suo padre uscire e aspettavasul pianerottolo. Vedendo il sangue sullamia faccia, guardò spaventato il padre.
«Chiama il dottor Campos.»
Il ragazzo annuì e corse al telefono. Losentii parlare e verificai che non eramuto. Insieme mi fecero accomodare suuna poltrona della sala da pranzo e mipulirono il sangue delle ferite in attesache arrivasse il dottore.
«Non vuoi dirmi chi te l'ha fatto?»
Non aprii bocca. Sempere non sapevadove abitavo e non volevo fargli venirein mente certe idee.
«È stato tuo padre?»
Distolsi lo sguardo.
«No. Sono caduto.»
Il dottor Campos, che abitava a quattro ocinque portoni di distanza, arrivò incinque minuti. Mi esaminò dalla testa aipiedi, palpando i lividi e curando i taglicon tutta la delicatezza possibile. Erachiaro che gli bruciavano gli occhi perl'indignazione, ma non disse nulla.
«Non ci sono fratture, ma qualchecontusione che ti farà male per un po'
di giorni. Questi due denti bisogneràtoglierli. Sono rovinati e c'è rischiod'infezione.»
Quando il dottore se ne andò, Semperemi preparò un bicchiere di latte tiepidocon il cacao e osservò sorridendo comelo bevevo.
«Tutto questo per salvare Grandisperanze, eh?»
Mi strinsi nelle spalle. Padre e figlio siscambiarono un sorriso complice.
«La prossima volta che vuoi salvare unlibro, salvarlo davvero, non rischiare lavita. Me lo dici e ti porto in un postosegreto dove i libri non muoiono mai edove nessuno può distruggerli.»
Li guardai entrambi, intrigato.
«E che posto è?»
Sempere mi strizzò l'occhio e mi rivolsequel sorriso misterioso che sembravarubato da un feuilleton di Alexandre
Dumas e che, dicevano, era un marchiodi famiglia.
«Ogni cosa a suo tempo, amico mio.Ogni cosa a suo tempo.»
Mio padre passò tutta quella settimanacon gli occhi fissi a terra, roso dalrimorso. Comprò una lampadina nuova earrivò a dirmi che, se volevo ac-cenderla, lo facessi pure, ma non troppoa lungo, perché l'elettricità era ca-rissima. Io preferii non scherzare con ilfuoco. Il sabato di quella settimana vollecomprarmi un libro e andò in unalibreria, la prima e l'ultima in cuientrava, in calle de la Palla, di frontealle vecchie mura romane; ma non
sapeva leggere i titoli sulle coste dellecentinaia di libri esposti, e uscì a manivuote. Poi mi diede dei soldi, più delsolito, e mi disse di comprarci quelloche volevo. Mi sembrò il momentoopportuno per tirare fuori un argomentoper il quale da tempo non trovavol'occasione propizia.
«Donna Mariana, la maestra, mi hachiesto di dirle se può passare da scuolaper parlare con lei» lasciai cadere.
«Parlare di che? Cos'hai combinato?»
«Niente, papà... Vorrebbe parlare con leidella mia futura educazione.
Dice che ho delle possibilità e che crede
di potermi aiutare a ottenere una borsadi studio per entrare dagli Esculapi...»
«Chi si crede di essere quella donna perriempirti la testa di grilli e per dirti cheti farà entrare in un collegio di figli dipapà? Tu conosci quella gentaglia? Saicome ti guarderanno e come titratteranno quando sapranno da dovevieni?»
Abbassai gli occhi
«Donna Mariana vuole solo darmi unamano, papà. Nient'altro. Non si inquieti.Le dirò che non si può fare e basta.»
Mio padre mi guardò con rabbia, ma sitrattenne e respirò a fondo varie volte
con gli occhi chiusi prima di aggiungere:
«Ce la faremo, d'accordo? Tu e io.Senza l'elemosina di tutti quei figli diputtana. E a testa alta.»
«Sì, papà.»
Mi mise una mano sulla spalla e miguardò come se, per un breve istante chenon sarebbe tornato mai più, fosseorgoglioso di me, anche se eravamotanto diversi, anche se a me piacevano ilibri che lui non sapeva leggere, perfinose lei ci aveva messo l'uno control'altro. In quell'istante credetti che miopadre era l'uomo più buono del mondo eche tutti se ne sarebbero resi conto se lavita, per una volta, si fosse degnata di
dargli una buona mano di carte.
«Tutto il male che uno fa nella vitaritorna, David. E io ne ho fatto tanto.
Tanto. Ma ho pagato il prezzo. E lanostra sorte cambierà. Vedrai. Vedrai.»
Nonostante le insistenze di donnaMariana, che era più furba della fame egià immaginava come stavano andandole cose, non parlai più con mio padredella mia educazione. Quando lamaestra capì che non c'erano speranze,mi disse che ogni giorno, alla fine dellelezioni, mi avrebbe dedicato un'ora inpiù per parlarmi di libri, di storia e ditutte quelle cose che tanto spaventavanomio padre.
«Sarà il nostro segreto» disse lamaestra.
Già allora avevo cominciato a capireche mio padre si vergognava che lagente pensasse che era un ignorante, unrelitto di una guerra che, come quasitutte le guerre, veniva combattuta innome di Dio e della patria per renderepiù potenti uomini che già lo eranotroppo prima di provocarla. In quelperiodo, qualche notte cominciai adaccompagnare mio padre al lavoro.Prendevamo un tram in calle Trafalgarche ci lasciava alle porte del cimitero.Io restavo nella sua garitta, a leggerevecchie copie del giornale, e ogni tantocercavo di fare conversazione con lui,
impresa ardua. Mio padre quasi nonparlava più, né della guerra nellecolonie né della donna che l'avevaabbandonato. Una volta gli chiesi perchémia madre ci aveva lasciato.
Sospettavo che fosse stato per colpamia, per qualcosa di male che avevofatto, magari solo per essere nato.
«Tua madre mi aveva abbandonato giàprima che mi mandassero al fronte. Lostupido sono stato io, che non me nesono accorto finché non sono tornato. Lavita è così, David. Prima o poi, tutto etutti ti abbandonano.»
«Io non l'abbandonerò mai, papà.»
Mi sembrò che stesse per scoppiare apiangere e l'abbracciai per nonguardarlo in faccia.
Il giorno dopo, senza preavviso, miportò ai magazzini tessili El Indio incalle del Carmen. Non entrammo, madalle vetrate dell'ingresso mi indicò unadonna giovane e sorridente che serviva iclienti e mostrava loro stoffe e tessutipregiati.
«Quella è tua madre» mi disse. «Ungiorno di questi torno qui e l'am-mazzo.»
«Non dica così, papà.»
Mi guardò con gli occhi arrossati eseppi che l'amava ancora e che io non
l'avrei mai perdonata. Ricordo che laosservai di nascosto, senza che leisapesse che eravamo lì, e che lariconobbi solo grazie al ritratto che miopadre conservava a casa in un cassetto,accanto alla sua pistola dell'esercito cheogni notte, quando credeva che iodormissi, tirava fuori e contemplavacome se possedesse tutte le risposte, oalmeno quelle che servivano a lui.
Per anni sarei tornato davanti alle portedi quel negozio per spiarla di nascosto.Non ebbi mai il coraggio di entrare né diparlarle quando la vedevo uscire eallontanarsi giù per le Ramblas versouna vita che mi ero immaginato per lei,con una famiglia che la rendeva felice e
un figlio che meritava più di me il suoaffetto e il contatto della sua pelle. Miopadre non seppe mai che a voltescappavo per vederla, o che c'eranogiorni in cui la seguivo da vicino,sempre sul punto di prenderle la mano edi camminare accanto a lei, semprefuggendo all'ultimo momento. Nel miomondo, le grandi speranze vivevanosoltanto fra le pagine di un libro.
La buona sorte che mio padre tantodesiderava non arrivò mai. L'unicacortesia che la vita gli riservò fu di nonfarlo attendere troppo. Una notte, mentrearrivavamo alle porte del giornale periniziare il turno di lavoro, tre pistolerisbucarono dall'ombra e lo crivellarono
di colpi sotto i miei occhi.
Ricordo l'odore di zolfo e l'alonefumante che saliva dai fori bruciacchiatiaperti dalle pallottole nel suo cappotto.Uno dei pistoleri si preparava a dargli ilcolpo di grazia quando mi gettai su miopadre e un altro degli assassini lo fermò.Ricordo gli occhi del pistolero fissi neimiei, mentre si chiedeva se dovesseuccidere anche me. All'improvviso, siallontanarono a passo svelto e sparirononei vicoli stretti tra gli edifici delPueblo Nuevo.
Quella notte i suoi assassini lasciaronomio padre a dissanguarsi fra le miebraccia, e me solo al mondo. Passai
quasi due settimane dormendo nellatipografia del giornale, nascosto tralinotype che sembravano gigan-teschiragni d'acciaio, cercando di zittire quelsibilo esasperante che mi perforava itimpani al tramonto. Quando miscoprirono, avevo ancora le mani e ivestiti macchiati di sangue secco.All'inizio nessuno sapeva chi fossi,perché non parlai per quasi unasettimana e quando lo feci fu per urlareil nome di mio padre fino a perdere lavoce. Quando mi chiesero di mia madre,dissi che era morta e che non avevonessuno al mondo. La mia storia arrivòalle orecchie di Pedro Vidal, la star delgiornale e amico intimo dell'editore, chedietro sua richiesta ordinò di darmi un
lavoro da fatto-rino e di permettermi divivere fino a nuovo avviso nellemodeste stanze del portiere al pianointerrato.
Erano anni in cui il sangue e la violenzaper le strade di Barcellonacominciavano a essere pane quotidiano.Giorni di volantini e bombe chelasciavano resti di corpi tremanti efumanti per le strade del Raval, giorni dibande di figure nere che vagavano nellanotte spargendo sangue, di proces-sionie sfilate di santi e generali chepuzzavano di morte e di inganni, didiscorsi incendiari in cui tutti mentivanoe tutti avevano ragione. La rabbia el'odio che anni dopo avrebbero portato
gli uni e gli altri ad ammazzarsi in nomedi slogan magniloquenti e di straccicolorati cominciavano già ad as-saporarsi nell'aria avvelenata. La brumaperpetua delle fabbriche strisciava sullacittà e velava i suoi viali lastricati esolcati da tram e carrozze. La notteapparteneva alla luce a gas, alle ombredei vicoli spezzate dai baglio-ri deglispari e dai lampi azzurrati della polverebruciata. Erano anni in cui si cresceva infretta, e quando l'infanzia si sbriciolavatra le loro mani molti bambini avevanogià lo sguardo da vecchi.
Senza altra famiglia se non quellatenebrosa Barcellona, il giornalediventò il mio rifugio e il mio mondo
finché il mio stipendio mi permise diaffittare quella stanza nella pensione didonna Carmen. Abitavo lì da appena unasettimana quando un giorno la padronavenne nella mia camera e mi informòche un signore alla porta chiedeva dime. Sul pianerottolo trovai un uomovestito di grigio, dallo sguardo grigio edalla voce grigia che mi domandò se eroDavid Martín e, al mio assenso, miallungò un pacchetto avvolto in carta dapacchi e si perse giù per le scalelasciando la sua grigia assenza aimpestare quel mondo di miserie di cuiero entrato a far parte. Mi portai ilpacchetto in camera e chiusi la porta.Nessuno, a eccezione di due o trepersone del giornale, sapeva che vivevo
lì. Disfeci l'involto, intrigato. Era ilprimo pacchetto che ricevevo in vitamia. All'interno trovai un astuccio dilegno stagionato dall'aspetto vagamentefamiliare. L'appog-giai sulla branda e loaprii. Conteneva la vecchia pistola dimio padre, l'arma ricevuta dall'esercitoe con cui era tornato dalle Filippine perprocu-rarsi una morte precoce emiserabile. Accanto all'arma c'era unascatoletta di cartone con qualchepallottola. Presi la pistola e la soppesai.Puzzava di polvere da sparo e d'olio. Michiesi quanti uomini avesse ucciso miopadre con quell'arma, con cui avevacertamente sperato di mettere fine allapropria vita finché non l'avevanopreceduto. Riposi l'arma nell'astuccio e
lo richiusi. Il mio primo impulso fu dibuttarla nella spazzatura, ma mi resiconto che quella pistola era tutto ciò chemi restava di mio padre. Immagi-
nai che l'usuraio di turno che alla mortedi mio padre aveva confiscato il pocoche avevamo in quel vecchioappartamento di fronte al tetto del Palaude la Música, a compensazione deipropri crediti, avesse deciso dimandarmi allora quel macabropromemoria per salutare il mio ingressonell'età adulta. Nascosi l'astuccio sopral'armadio, contro il muro su cui siaccumu-lava il sudiciume e dove donnaCarmen non arrivava nemmeno con itrampoli, e non lo toccai più per anni.
Quella sera stessa tornai alla libreria diSempere e Figli e, sentendomi ormaiuomo di mondo e dotato di mezzi,manifestai al libraio la mia intenzione diacquistare quel vecchio esemplare diGrandi speranze che mi ero vistocostretto a restituirgli anni prima.
«Mi faccia il prezzo che vuole» glidissi. «Mi faccia il prezzo di tutti i libriche non le ho pagato negli ultimi diecianni.»
Ricordo che Sempere sorrise contristezza e mi posò la mano sulla spalla.
«L'ho venduto stamattina» mi confessòabbattuto.
6
Trecentosessantacinque giorni dopo averscritto il mio primo racconto per "LaVoz de la Industria" arrivai, comed'abitudine, in redazione e la trovaiquasi deserta. C'era solo un gruppo diredattori che mesi prima mi avevanodedicato soprannomi affettuosi e paroledi sostegno e che quel giorno,vedendomi entrare, ignorarono il miosaluto e si chiusero in un capannello dimormorii. In meno di un minuto avevanopreso i cappotti ed erano spariti come setemessero qualche tipo di contagio.Rimasi seduto, da solo, in quella salainsondabile, a contemplare lo stranospettacolo di decine di scrivanie vuote.
Passi lenti e contundenti alle mie spalleannun-ciarono l'approssimarsi di donBasilio.
«Buona sera, don Basilio. Cosa succedeoggi che se ne sono andati tutti?»
Don Basilio mi guardò con tristezza e sisedette alla scrivania vicina.
«C'è una cena di Natale di tutta laredazione. Al Set Portes» disse convoce tranquilla. «Immagino che non leabbiano detto nulla.»
Finsi un sorriso noncurante e feci cennodi no.
«Lei non va?» chiesi.
Don Basilio scosse la testa.
«Non ne ho più voglia.»
Ci guardammo in silenzio.
«E se la invito io?» proposi. «Dovevuole. Al Can Solé, se le va. Lei e io,per festeggiare il successo dei Misteridi Barcellona. »
Don Basilio sorrise, annuendolentamente.
«Martín» disse alla fine. «Non so comedirglielo.»
«Dirmi cosa?»
Don Basilio si schiarì la voce.
«Non le posso più pubblicare altrepuntate dei Misteri di Barcellona. »
Lo guardai senza comprendere. DonBasilio distolse lo sguardo.
«Vuole che scriva un'altra cosa?Qualcosa di più galdosiano?»
«Martín, lei sa com'è la gente. Ci sonostate lamentele. Io ho cercato disistemare la questione, però il direttoreè un uomo debole e non gli piacciono iconflitti non necessari.»
«Non la capisco, don Basilio.»
«Martín, hanno chiesto a me didirglielo.»
Finalmente mi guardò e si strinse nellespalle.
«Sono licenziato» mormorai.
Don Basilio annuì.
Sentii che, mio malgrado, gli occhi mi siriempivano di lacrime.
«Adesso le sembra la fine del mondo,ma mi creda se le dico che in fondo è lacosa migliore che poteva capitarle.Questo non è un posto per lei.»
«E qual è il posto per me?» domandai.
«Mi dispiace, Martín. Mi creda, midispiace.»
Don Basilio si alzò e mi mise la manosulla spalla con affetto.
«Buon Natale, Martín.»
Quella sera stessa svuotai la miascrivania e lasciai per sempre quellache era stata la mia casa per perderminelle vie buie e solitarie della città.
Sulla strada per la pensione passai dalleparti del ristorante Set Portes sotto gliarchi di casa Xifré. Rimasi fuori,guardando i miei colleghi ridere ebrindare dietro i vetri. Sperai che la miaassenza li rendesse felici o almeno gli
facesse dimenticare che non lo erano enon lo sarebbero mai stati.
Passai il resto di quella settimana alladeriva, rifugiandomi ogni giorno nellabiblioteca dell'Ateneo convinto che, diritorno alla pensione, avrei trovato unbiglietto del direttore del giornale chemi pregava di rientrare in redazione.Nascosto in una delle sale di lettura,tiravo fuori quel biglietto da visita chemi ero ritrovato tra le mani al risveglionell'Ensueño e iniziavo a scrivere unalettera all'anonimo benefattore, AndreasCorelli, che fini-
vo sempre per strappare e perricominciare a scrivere il giorno dopo.
Il settimo giorno, stanco di compatirmi,decisi di compiere l'inevitabilepellegrinaggio a casa del mio creatore.
In calle Pelai presi il treno per Sarrià,che allora circolava ancora insuperficie, e mi sedetti in testa al vagonea contemplare la città e le strade che sifacevano più ampie e signorili a mano amano che ci si allontanava dal centro.Scesi alla stazione di Sarrià e presi untram che portava all'ingresso delmonastero di Pedralbes. Era unagiornata di caldo insolito per quellastagione e potevo sentire nella brezza ilprofumo dei pini e delle gi-nestre chepunteggiavano i fianchi della montagna.Imboccai avenida Pearson, dove si
iniziava già a edificare, e ben prestoscorsi l'inconfondibile profilo di VillaHelius. Mentre salivo e mi avvicinavo,riuscii a scorgere Vidal che assaporavauna sigaretta seduto alla finestra del suotorrione in maniche di camicia. Sisentiva una musica che fluttuava nell'ariae ricordai che Vidal era uno dei pochiprivilegiati che possedevano unapparecchio radiofonico. Come dovevaapparire bella la vita da lassù, e chepoca cosa dovevo sembrare io.
Lo salutai con la mano e lui ricambiò ilsaluto. Arrivato alla villa mi imbatteinell'autista, Manuel, che andava verso igarage con un mucchio di stracci e unsecchio d'acqua fumante.
«È un piacere vederla da queste parti,Martín» disse. «Come va la vita?
Sempre sulla cresta dell'onda?»
«Si fa quel che si può» risposi.
«Non sia modesto, perfino mia figlia silegge quelle avventure che pubblica sulgiornale.»
Deglutii, sorpreso dal fatto che la figliadell'autista non solo sapeva della miaesistenza, ma aveva addirittura lettoqualcuna delle sciocchezze chescrivevo.
«Cristina?»
«Non ne ho altre» replicò don Manuel.«Il signore è nel suo studio, se vuolsalire.»
Ringraziai annuendo e m'infilai in casa.Salii fino al torrione del terzo piano ches'innalzava sul tetto ondulato di tegolepolicrome. Vidal era lì, in quello studioda cui si vedevano la città e il mare inlontananza. Spense la radio, un arnesedelle dimensioni di un piccolo meteoriteche aveva comprato mesi prima, quandoerano state annunciate le primetrasmissioni di Radio Barcellona daglistudi camuffati sotto la cupola dell'hotelColón.
«Mi è costata quattrocento pesetas e
adesso scopro che dice solo scioc-
chezze.»
Ci sedemmo uno di fronte all'altro, contutte le finestre aperte a quella brezzache per me, abitante della città vecchia etenebrosa, sapeva di un altro mondo. Sisentivano gli insetti svolazzare ingiardino e le foglie degli alberi frusciareal vento.
«Sembra di essere in piena estate»azzardai.
«Non svicoli parlando del tempo. Mihanno già detto quello che è successo»disse Vidal.
Mi strinsi nelle spalle e diediun'occhiata alla sua scrivania. Sapevoche erano mesi, se non anni, che il miomentore cercava di scrivere quello chechiamava un romanzo "serio", distantedalle trame leggere delle sue storiepoliziesche, per inscrivere il suo nomenelle sezioni più stantie dellebiblioteche. Non si vedevano moltifogli.
«Come va il capolavoro?»
Vidal gettò il mozzicone dalla finestra eguardò lontano.
«Non ho più niente da dire, David.»
«Sciocchezze.»
«Sono tutte sciocchezze in questa vita. Èsemplicemente una questione diprospettiva.»
«Dovrebbe metterci questo, nel libro. Ilnichilista sulla collina. Un successosicuro.»
«Chi avrà presto bisogno di un successosei tu, perché se non mi sbagliocominciano a scarseggiarti i fondi.»
«Posso sempre accettare la sua carità.»
«C'è una prima volta per tutto. Adesso tisembra la fine del mondo, però...»
«Ben presto mi renderò conto che è lacosa migliore che poteva succedermi»
completai. «Non mi dica che ora è donBasilio a scriverle i discorsi.»
Vidal rise.
«Cosa pensi di fare?»
«Non ha bisogno di un segretario?»
«Ho già la migliore segretaria che potreiavere. È più intelligente di me,infinitamente più lavoratrice e quandosorride mi sembra perfino che questoschifo di mondo abbia un po' di futuro.»
«E chi è questa meraviglia?»
«La figlia di Manuel.»
«Cristina?»
«Finalmente ti sento pronunciare il suonome.»
«Ha scelto una brutta settimana perridere di me, don Pedro.»
«Non guardarmi con quella faccia daagnello sgozzato. Credi che Pedro Vidalavrebbe permesso a quel branco dimediocri spilorci e invidiosi di buttartiin mezzo alla strada senza far nulla?»
«Una sua parola al direttore avrebbecertamente cambiato le cose.»
«Lo so. Perciò sono stato io asuggerirgli di licenziarti» disse Vidal.
Fu come se mi avesse appena dato unoschiaffo.
«Grazie per l'aiuto» improvvisai.
«Gli ho detto di licenziarti perché hoqualcosa di molto meglio per te.»
«Chiedere l'elemosina?»
«Uomo di poca fede. Proprio ieri hoparlato di te con un paio di soci chehanno appena aperto una nuova casaeditrice e cercano sangue fresco daspremere e sfruttare.»
«Sembra una meraviglia.»
«Sanno già dei Misteri di Barcellona e
sono pronti a farti un'offerta che tirenderà un uomo fatto e finito.»
«Parla sul serio?»
«Certo che parlo sul serio. Vogliono chetu scriva una serie di romanzi nella piùbarocca, sanguinosa e delirantetradizione del Grand Guignol chestracci I misteri di Barcellona. Credosia l'opportunità che stavi aspettando.
Ho detto che andrai a trovarli e che seipronto a iniziare a lavorareimmediatamente.»
Respirai a fondo. Vidal mi fecel'occhiolino e mi abbracciò.
7
Fu così che, pochi mesi prima dicompiere vent'anni, ricevetti e accettaiun'offerta per scrivere romanzi un tanto apagina con lo pseudonimo di Ignatius B.Samson. Il mio contratto mi impegnava aconsegnare ogni mese duecento paginedattiloscritte intessute di intrighi,omicidi nell'alta società, orrori senzafine nei bassifondi, amori illeciti tracrudeli possidenti dalla mascellavolitiva e damigelle dagli inconfessabilidesideri, nonché ogni tipo di contortesaghe familiari con retroscena piùsporchi e torbidi delle acque del porto.La serie, che decisi di battezzare Lacittà dei maledetti, sarebbe apparsa in
una pubblicazione mensile in edizionerilegata con copertina a colori. Incambio avrei ricevuto più soldi diquanti avessi mai pensato si potesseroguadagnare facendo qualcosa degno dirispetto. Non avrei avuto censure salvoquella imposta dall'interesse dei lettoriche avrei saputo conquistare. I terminidell'offerta mi obbligavano a scriverenell'anonimato di uno stravagantepseudonimo, ma in quel momento miparve un prezzo molto basso da pagareper potermi guadagnare da vivere con ilmestiere che avevo sempre sognato difare. Avrei rinunciato alla vanità divedere il mio nome stampato sulla miaopera, ma non a me stesso né a quelloche ero.
I miei editori erano una coppia dipittoreschi signori chiamati Barrido edEscobillas. Barrido, minuto, tarchiato esempre armato di un sorriso untuoso esibillino, era il cervello dell'operazione.Veniva dall'industria degli insaccati, esebbene non avesse letto più di tre libriin vita sua, compresi il catechismo el'elenco telefonico, era posseduto daun'audacia proverbiale per cucinarsi ilibri contabili: li falsificava per gliinvestitori con sfoggi di immaginazioneche sarebbero stati volentieri emulatidagli autori che la casa editrice, comeaveva predetto Vidal, truffava, sfruttavae infine gettava a mare quando i ventisoffiavano in direzione contraria, cosache prima o poi accadeva sempre.
Escobillas svolgeva un ruolocomplementare. Alto, allampanato e conl'aria vagamente minacciosa, si eraformato nel ramo delle pompe funebri eda sotto la soffocante acqua di coloniacon cui irrorava le vergogne sembravatrapelare un vago fetore di formalina chefaceva drizzare i capelli. Il suo compitoera essenzialmente quello di sinistrosorvegliante, frusta in mano e pronto afare il lavoro sporco per il qualeBarrido, a causa del temperamento piùallegro e dell'aspetto non tanto atletico,era meno portato. Il ménage-à-trois eracompletato dalla loro segretaria,Herminia, che li seguiva dovunque comeun cane fedele e che tutti chiamavanoVeleno perché, nonostante l'apparenza
da gatta morta, ci si poteva fidare di leicome di un serpente a sonagli in calore.
Formalità a parte, io cercavo di vederliil meno possibile. Il nostro era unrapporto esclusivamente mercantile enessuna delle parti aveva un grandesiderio di alterare il protocollostabilito. Mi ero ripromesso diapprofittare di quella opportunità e dilavorare a fondo per dimostrare a Vidal,e a me stesso, che lottavo per meritare ilsuo aiuto e la sua fiducia. Con un po' disoldi freschi in mano, decisi di lasciarela pensione di donna Carmen in cerca diorizzonti più comodi. Da tempo avevomesso gli occhi su una grande casadall'aria monumentale al 30 di calle
Flassaders, a un tiro di schioppo dalpaseo del Born: ci ero passato davantiper anni quando andavo e venivo dalgiornale alla pensione. La proprietà,completata da un tor-
rione che sorgeva da una facciatalavorata a rilievi e gargolle, era chiusada anni, il portone sprangato con catenee catenacci picchiettati di ruggine.
Nonostante l'aspetto funebre e smisurato,o forse proprio per questo, l'idea diandarci ad abitare risvegliava in me lalussuria delle intenzioni sconsi-gliabili.In altre circostanze avrei ammesso cheun posto simile andava ben oltre le miescarse possibilità, ma i lunghi anni di
abbandono e di oblio ai quali sembravacondannato mi fecero albergare lasperanza che, se nessun altro lo voleva,forse i proprietari avrebbero accettato lamia offerta.
Chiedendo nel quartiere, venni a sapereche la casa era disabitata da molti anni eche la proprietà l'aveva affidata a unamministratore chiamato Vicenç, Clavé,con gli uffici in calle Comercio, difronte al mercato. Clavé era ungentiluomo all'antica a cui piacevavestire come le statue dei sindaci e deipadri della patria che si trovavano agliingressi del Parque de la Ciudadela eche alla minima occasione si lanciava involi retorici che non ri-sparmiavano
nessuno.
«Così, lei è scrittore. Guardi, io potreiraccontarle storie da scriverci ottimilibri.»
«Ne sono certo. Perché non cominciacon quella della casa al 30 diFlassaders?»
Clavé adottò un'espressione damaschera greca.
«La casa della torre?»
«Esatto.»
«Mi dia retta, giovanotto, non vada avivere lì.»
«Perché no?»
Clavé abbassò la voce e, mormorandocome se temesse che i muri ci a-scoltassero, lasciò cadere una frase intono funebre.
«Quella casa è iellata. Io l'ho vistaquando siamo andati con il notaio amettere i sigilli e posso assicurarle chela parte vecchia del cimitero diMontjuïc è più allegra. Da allora èrimasta vuota. Custodisce brutti ricordi.
Nessuno la vuole.»
«I suoi ricordi non possono esserepeggiori dei miei, e comunque aiute-ranno sicuramente ad abbassare il
prezzo che chiedono.»
«A volte ci sono prezzi che non sipossono pagare col denaro.»
«Posso vederla?»
Visitai per la prima volta la casa dellatorre una mattina di marzo in compagniadell'amministratore, del suo segretario edi un funzionario di banca che ostentavail titolo di proprietà. A quanto pareva, lacasa era stata per anni avviluppata in unfitto labirinto di contese legali prima ditornare all'istituto di credito che avevagarantito per il suo ultimo proprietario.Se Clavé non mentiva, nessuno ci erapiù entrato da almeno vent'anni.
8
Anni dopo, leggendo il resoconto dialcuni esploratori britannici che si eranoaddentrati nelle tenebre di un millenariosepolcro egiziano con an-nessi labirintie maledizioni, avrei ricordato quellaprima visita alla casa della torre di calleFlassaders. Il segretario eraequipaggiato con una lampada a olioperché non si era mai arrivati ainstallare l'elettricità. Il funzionarioaveva un mazzo di quindici chiavi concui aprire gli innumerevoli lucchetti cheassicuravano le catene. Una volta apertoil portone, la casa esalò un alito putrido,che sapeva di tomba e di umidità. Ilfunzionario ebbe un attacco di tosse e
l'amministratore, che aveva portato consé la sua migliore espressione discetticismo e censura, si mise unfazzoletto sulla bocca.
«Prima lei» invitò.
L'androne era una specie di cortileinterno, alla moda degli antichi palazzidella zona, con un lastricato a grandipiastrelle e una scalinata di pietra chesaliva alla porta principale della casa.In alto, tremolava un lucernario di vetrocompletamente sepolto da escrementi dipiccioni e gabbiani.
«Non ci sono topi» annunciai penetrandonell'edificio.
«Qualcuno doveva pure avere un po' dibuon gusto e di senso comune»
disse l'amministratore alle mie spalle.
Procedemmo su per le scale fino alpianerottolo d'ingresso all'appartamentoprincipale, dove il funzionario ebbebisogno di dieci minuti per trovare lachiave giusta. Il meccanismo cedette conun gemito che non sembrava dibenvenuto. La porta si aprì per svelareun infinito corridoio zeppo di ragnateleche ondeggiavano nelle tenebre.
«Madre di Dio» mormoròl'amministratore.
Nessuno osò fare il primo passo, perciò
ancora una volta fui io a guidare laspedizione. Il segretario teneva lalampada in alto, osservando tutto conaria compunta.
L'amministratore e il funzionario siscambiarono uno sguardo indecifra-bile.Quando videro che li stavo osservando,il funzionario di banca sorriseplacidamente.
«Si toglie la polvere e con due ritocchidiventa un palazzo» disse.
«Il palazzo di Barbablù» commentòl'amministratore.
«Cerchiamo di essere positivi» rettificòil funzionario. «La casa è disabitata da
un certo tempo e questo comportasempre piccoli problemi.»
Io a stento gli prestavo attenzione.Avevo sognato tante volte quel postopassandoci davanti che quasi non miaccorgevo dell'aura funebre e oscura chelo possedeva. Avanzai lungo il corridoioprincipale, esplorando stanze in cui ivecchi mobili giacevano abbandonatisotto una spessa cappa di polvere. Su untavolo c'erano ancora una tovagliasfilacciata, un servizio di piatti e unvassoio con frutta e fiori pietrificati. Ibicchieri e le posate erano ancora lì,come se gli abitanti della casa si fosseroalzati a metà della cena.
Gli armadi erano ricolmi di vestitilogori, capi scoloriti e scarpe. C'eranointeri cassetti zeppi di fotografie,occhiali, penne e orologi. Ritratti velatidi polvere ci osservavano dai comò. Iletti erano rifatti e coperti da un velobianco che brillava nella penombra. Ungrammofono monumentale giaceva su untavolo di mogano. Sopra c'era un disco ela puntina era scivolata fino alla fine.Soffiai via lo strato di polvere che loricopriva e apparvero il titolo el'incisione, il Lacrimosa di Mozart.
«L'orchestra sinfonica in casa» disse ilfunzionario. «Cosa si può chiedere dipiù? Lei qui starà come un pascià.»
L'amministratore gli lanciò uno sguardoassassino, scuotendo la testa disoppiatto. Attraversammol'appartamento fino al salotto in fondo,dove un servizio da caffè giaceva sultavolino e un libro aperto continuava adattendere che qualcuno ne sfogliasse lepagine seduto in poltrona.
«Sembra che se ne siano andatiall'improvviso, senza il tempo diportarsi via niente» dissi.
Il funzionario tossicchiò.
«Forse il signore vuol vedere lostudio?»
Lo studio si trovava in cima a una sottile
torre, una peculiare struttura che avevaper anima una scala a chiocciola allaquale si accedeva dal corridoioprincipale e sulla cui facciata esterna sipotevano leggere le tracce di tutte legenerazioni che la città ricordava. Latorre disegnava un belvedere sospesosui tetti del quartiere della Ribera,completato da uno stretto tamburo dimetallo e vetro dipinto che svolgeva lafunzione di lanterna della cupola e dacui sporgeva una rosa dei venti a formadi drago.
Salimmo la scala ed entrammo nellastanza, dove il funzionario si affrettò adaprire le finestre per far entrare l'aria ela luce. Era una camera rettangolare dai
soffitti alti e i pavimenti di legno scuro.Dai quattro finestroni ad arco aperti suiquattro lati potevo contemplare labasilica di Santa Maria del Mar a sud, ilgrande mercato del Born a nord, lavecchia stazione Francia a est e versoovest il labirinto infinito di strade eviali schiaccia-ti gli uni sugli altri versola collina del Tibidabo.
«Cosa mi dice? Una meraviglia»sostenne il funzionario con entusiasmo.
L'amministratore esaminava tutto conperplessità e fastidio. Il segretarioteneva in alto la lampada, sebbene nonce ne fosse più nessun bisogno. Miavvicinai a uno dei finestroni e mi
affacciai a guardare il cielo, estasiato.
Tutta Barcellona si stendeva ai mieipiedi e volli credere che, nell'aprire lemie nuove finestre, le sue strade miavrebbero sussurrato storie alcrepuscolo e segreti all'orecchio perchéio li catturassi sulla carta e liraccontassi a chi volesse ascoltarli.Vidal aveva la sua esuberante esignorile torre d'avorio nella parte piùelevata ed elegante di Pedralbes,circondata da colline, alberi e cieli dasogno. Io avrei avuto il mio sinistrotorrione innalzato sulle strade piùantiche e tenebrose della città,circondato dai miasmi e dalle tenebre diquella necropoli che i poeti e gli
assassini avevano chiamato la "Rosa diFuoco".
A convincermi a prendere la decisionefu la scrivania che dominava il centrodello studio. Su di essa, come unagrande scultura di metallo e di luce,giaceva un'impressionante macchina perscrivere Underwood che per me valevada sola il costo dell'affitto. Mi sedettisulla poltrona da generale davanti allascrivania e accarezzai la tastiera,sorridendo.
«La prendo» dissi.
Il funzionario sospirò di sollievo el'amministratore, sbarrando gli occhi, sifece il segno della croce. Quel
pomeriggio stesso firmai un contrattod'affitto per dieci anni. Mentre gli operaidella compagnia elettrica instal-lavanola luce, mi dedicai a pulire, mettere inordine e sistemare la casa con ilcontributo di tre aiutanti mandati intruppa da Vidal senza chiedermi primase volessi assistenza o no. Ben prestoscoprii che il modus operandi di quelcommando di esperti consisteva primanel trapanare a destra e a manca e poinel chiedere. Dopo tre giorni dal lorosbarco, la casa non aveva una solalampadina in attività, ma chiunqueavrebbe detto che era infestata da tarlidivoratori di gesso e minerali nobili.
«Vuol dire che non c'era altro modo di
risolvere il problema?» chiedevo alcapo del battaglione che sistemava tuttoa martellate.
Otilio, così si chiamava quel talento, mimostrava le piantine chel'amministratore mi aveva consegnatoinsieme alle chiavi e argomentava che lacolpa era della casa, mal costruita.
«Guardi qui» diceva. «Quando le cosesono fatte male, sono fatte male.
Ecco. Qui dice che lei ha una cisternasulla terrazza. E invece no. Ce l'ha nelcortile sul retro.»
«E cosa importa? A lei la cisterna noncompete, Otilio. Si concentri sul
problema elettricità. Luce. Né rubinettiné tubature. Luce. Ho bisogno di luce.»
«Ma è tutto connesso. Cosa mi dice delsalotto?»
«Che non c'è la luce.»
«Secondo la piantina, questo dovrebbeessere un muro maestro. Be', qui il miocollega Remigio ha dato un colpetto e ciè crollata mezza parete. E
non le dico le stanze. Sempre secondo lapianta, la sala in fondo al corridoio è diquasi quaranta metri quadri. Neanche dalontano. Se arriva a venti, mi ritengosoddisfatto. C'è un muro dove non cidovrebbe essere. E dei tu-bi di scarico,
be', meglio non parlare. Non ce n'è unodove si pensa che dovrebbe essere.»
«È sicuro di saper leggere le piantine?»
«Senta, io sono un professionista. Mi diaretta, questa casa è un rompicapo. Qui ciha messo le mani chiunque.»
«Be', si dovrà arrangiare con quello chec'è. Faccia miracoli o quello che vuole,ma per venerdì voglio i muri intonacati eimbiancati e la luce che funziona.»
«Non mi metta fretta, questo è un lavorodi precisione. Bisogna agire con unacerta strategia.»
«E cosa pensate di fare?»
«Per il momento, di andare a mangiare.»
«Ma se siete arrivati mezz'ora fa.»
«Signor Martín, con questoatteggiamento non andiamo da nessunaparte.»
La via crucis di lavori e lavoretti siprolungò una settimana più del previsto,ma con buona pace di Otilio e del suosquadrone di portenti, che facevanobuchi dove non dovevano e colazioni didue ore e mezzo, l'illusio-ne di poterfinalmente abitare quella casa sognataper tanto tempo mi avrebbe permesso diviverci per anni con candele e lampadea olio, se necessario. Per fortuna ilquartiere della Ribera era una riserva
spirituale e materiale di artigiani di ognitipo e a due passi dal mio nuovodomicilio trovai chi mi avrebbeinstallato nuove serrature che nonsembrassero rubate dalla Bastiglia elampadari e rubinetteria all'uso del XXsecolo. L'idea di disporre di una lineatelefonica non mi persuadeva e, stando aquanto avevo potuto sentire alla radio diVidal, quelli che la stampa dell'epocachia-
mava i nuovi mezzi di comunicazione dimassa non mi avevano preso inconsiderazione al momento di cercare unpubblico. Decisi che la mia sarebbestata un'esistenza di libri e di silenzio.Portai con me dalla pensione solo un
cambio di vestiti e l'astuccio checonteneva la pistola di mio padre, il suounico ricordo. Divisi il resto degliindumenti e degli effetti personali fra glialtri subaffittuari. Se mi fossi potutolasciare alle spalle la pelle e lamemoria, avrei fatto anche quello.
Passai la prima notte ufficiale edelettrificata nella casa della torre ilgiorno in cui apparve la puntatainaugurale della Città dei maledetti.Avevo incentrato la trama del romanzosull'incendio dell'Ensueño nel 1903 e suuna creatura spettrale che da allorastregava le strade del Raval. Prima chel'inchiostro della prima edizione siasciugasse, già avevo iniziato a lavorare
al secondo romanzo della serie.Secondo i miei calcoli, e partendo dallabase di trenta giorni di lavoroininterrotto al mese, Ignatius B. Samsondoveva produrre una media di 6,66pagine di dattiloscritto utili al giorno perrispettare i termini del contratto, il cheera una follia, ma aveva il vantaggio dinon lasciarmi molto tempo libero perrendermene conto.
Quasi non mi accorgevo che, con ilpassare dei giorni, avevo cominciato aconsumare più caffè e sigarette cheossigeno. Amano a mano che lo av-velenavo, avevo l'impressione che ilmio cervello si stesse trasformando inuna macchina a vapore che non si
raffreddava mai. Ignatius B. Samson eragiovane e aveva resistenza. Lavoravatutta la notte e crollava esausto all'alba,in balìa di strani sogni in cui le letteresul foglio nel rullo della macchina perscrivere si staccavano dalla carta e,come ragni d'inchiostro, si trascinavanosulle sue mani e sulla sua faccia,attraversandogli la pelle e annidandosinelle vene fino a ricoprirgli il cuore dinero e ad annebbiargli le pupille inpozzanghere di oscurità. Passavo interesettimane senza uscire di casa edimenticavo che giorno della settimanao che mese dell'anno fosse.
Non prestavo attenzione ai ricorrentimal di testa che a volte mi assali-vano
all'improvviso, come se un punteruolo dimetallo mi trapanasse il cranio,bruciandomi la vista in un'esplosione diluce bianca. Mi ero abituato a viverecon nelle orecchie un sibilo costante chesolo il sussurro del vento o la pioggiariuscivano a mascherare. A volte,quando quel sudore freddo mi ricoprivail volto e sentivo che le mani mitremavano sulla tastieradell'Underwood, dicevo a me stesso cheil giorno dopo sarei andato dal dottore.Ma poi quel giorno c'era un'altra scena eun'altra storia da rac-
contare.
Si compiva il primo anno di vita di
Ignatius B. Samson quando, perfesteggiare, decisi di prendermi unagiornata libera e di ritrovare il sole, labrezza e le strade di una città che avevosmesso di percorrere per limitarmi aimmaginarla. Mi feci la barba, mi lavaie indossai il mio vestito migliore e piùpresentabile. Lasciai aperte le finestredello studio e del salotto per farprendere aria alla casa e per lasciarspargere ai quattro venti quella nebbiaspessa che era diventata il suo profumocaratteristico. Scendendo in strada,trovai una grande busta nella fessuradella cassetta delle lettere.
Dentro c'era una pergamena, sigillatacon la ceralacca con l'immagine
dell'angelo e vergata in quella raffinatagrafia, su cui si leggeva: Caro David,
volevo essere il primo a farle icomplimenti per questa nuova tappadella sua carriera. Ho apprezzatoenormemente le prime puntate dellaCittà dei maledetti. Spero che questopiccolo omaggio sia di suo gradimento.
Le rinnovo la mia ammirazione e la miavolontà che i nostri de-stini un giornos'incrocino. Sicuro che così sarà, lasaluta con affetto il suo amico e lettore
Andreas Corelli
L'omaggio era lo stesso esemplare diGrandi speranze che il signor Sempere
mi aveva regalato da bambino, lo stessoche avevo restituito prima che mio padrepotesse trovarlo e lo stesso che, quandoanni dopo avevo voluto recuperarlo aqualunque prezzo, era sparito il giornoprecedente tra le mani di unosconosciuto. Contemplai quell'ammassodi carta che un giorno non troppolontano mi era sembrato contenere tuttala magia e la luce del mondo. Sullacopertina si potevano ancora vedere letracce delle mie dita di bambinomacchiate di sangue.
«Grazie» mormorai.
9
Il signor Sempere inforcò gli occhiali di
precisione per esaminare il libro. Losistemò su un panno steso sulla scrivanianel retrobottega e abbassò la lampadaaffinché il fascio di luce fosseconcentrato sul volume. La sua periziadurò diversi minuti, durante i qualirimasi in religioso silenzio.
Lo osservai sfogliare le pagine,odorarle, accarezzare la carta e il dorso,soppesare il libro con una mano e poicon l'altra e alla fine chiuderlo edesaminare con la lente le tracce disangue secco che le mie dita vi avevanolasciato dodici o tredici anni prima.
«Incredibile» sussurrò, togliendosi gliocchiali. «È lo stesso libro. Come ha
detto di averlo recuperato?»
«Non lo so nemmeno io. SignorSempere, cosa ne sa di un editorefrancese chiamato Andreas Corelli?»
«A prima vista, suona più italiano chefrancese, anche se l'Andreas sembragreco...»
«La casa editrice è a Parigi. Éditions dela Lumière.»
Sempere restò pensieroso per qualcheistante, incerto.
«Temo che non mi risulti familiare.Chiederò a Barceló, che sa tutto, evediamo cosa mi dice.»
Gustavo Barceló era uno dei decani deilibrai antiquari di Barcellona e la suaerudizione enciclopedica eraleggendaria quanto il suo umorevagamente abrasivo e pedante. Nelmestiere, il detto consigliava, di fronte aqualunque dubbio, di chiedere aBarceló. In quel momento si affacciò ilfiglio di Sempere che, sebbene fosse dueo tre anni più anziano di me, era cosìtimido che a volte diventava invisibile,e fece un cenno a suo padre.
«Papà, vengono a ritirare un ordinativoche credo abbia preso lei.»
Il libraio annuì e mi tese un volumespesso e reduce da molte battaglie.
«Questo è l'ultimo catalogo degli editorieuropei. Se vuole, veda un po'
se trova qualcosa mentre servo ilcliente» suggerì.
Rimasi da solo nel retrobottega,cercando invano Éditions de la Lumièrementre Sempere tornava al bancone.Sfogliando il catalogo, lo sentii con-versare con una voce femminile che mirisultò familiare. Sentii che men-zionavano Pedro Vidal e, intrigato, miaffacciai a curiosare.
Cristina Sagnier, figlia dell'autista esegretaria del mio mentore, control-lavauna pila di libri che Sempere andavaannotando sul registro delle vendite.
Vedendomi, sorrise con cortesia, maebbi la certezza che non mi avevariconosciuto. Sempere alzò gli occhi enotando il mio sguardo da allocco feceuna rapida radiografia della situazione.
«Voi due già vi conoscete, vero?» disse.
Cristina sollevò le sopracciglia,sorpresa, e mi fissò di nuovo, incapacedi situarmi.
«David Martín, amico di don Pedro» levenni in soccorso.
«Ah, certo» disse. «Buongiorno.»
«Come sta suo padre?» improvvisai.
«Bene, bene. Mi aspetta in macchinaall'angolo.»
Sempere, che non ne lasciava passareuna, intervenne.
«La signorina Sagnier è venuta a ritiraredei libri ordinati da Vidal. Sono cosìpesanti che forse lei può essere tantogentile da aiutarla a portarli inmacchina...»
«Non vi preoccupate...» protestòCristina.
«Ci mancherebbe altro» mi lanciai io,lesto a sollevare la pila di libri cherisultò pesare come l'edizione di lussodell'Enciclopedia Britannica, ap-pendici
incluse.
Sentii uno scricchiolio alla schiena eCristina mi guardò allarmata.
«Sta bene?»
«Non abbia paura, signorina. L'amicoMartín qui presente, sebbene sia unletterato, è un toro» disse Sempere.«Vero, Martín?»
Cristina mi osservava poco convinta.Proposi il mio sorriso da maschioinvincibile.
«Tutti muscoli» dissi. «Questo è soloriscaldamento.»
Sempere figlio stava per offrirsi diportare la metà dei libri, ma suo padre,in uno slancio di diplomazia, lo trattenneper il braccio. Cristina mi aprì la porta emi avventurai a percorrere i quindici oventi metri che mi separavanodall'Hispano-Suiza parcheggiataall'angolo con Portal de l'Án-gel. Ciarrivai a stento, con le braccia sul puntodi prendere fuoco. Manuel, l'autista, miaiutò a scaricare i libri e mi salutòcalorosamente.
«Che combinazione vederla qui, signorMartín.»
«Piccolo, il mondo.»
Cristina mi offrì un blando sorriso di
ringraziamento e salì in macchina.
«Mi dispiace per i libri.»
«Non è niente. Un po' di eserciziosolleva il morale» dissi, ignorando ilgroppo che mi si era formato allaschiena. «Saluti a don Pedro.»
Li vidi partire verso plaza de Catalunyae quando mi voltai avvistai Semperesulla porta della libreria che miguardava con un sorriso gattesco e mifaceva dei cenni perché mi pulissi labava. Avvicinandomi a lui, non poteifare a meno di ridere di me stesso.
«Ora conosco il suo segreto, Martín. Lafacevo più esperto in queste battaglie.»
«Tutto si arrugginisce.»
«A chi lo dice. Posso tenermi il libroper qualche giorno?»
Annuii.
«Me lo tratti bene.»
10
La rividi mesi dopo, in compagnia diPedro Vidal, al tavolo che tenevasempre prenotato alla Maison Dorée.Vidal mi invitò a unirmi a loro, ma mibastò scambiare uno sguardo con lei percapire che dovevo declinare l'offerta.
«Come va il romanzo, don Pedro?»
«Con il vento in poppa.»
«Ne sono contento. Buon appetito.»
I nostri incontri erano fortuiti. A volte lavedevo nella libreria di Sempere eFigli, dove andava spesso a cercarelibri per don Pedro. Sempere, se ciriusciva, mi lasciava solo con lei, maben presto Cristina scoprì il trucco emandava uno dei garzoni di Villa Heliusa ritirare le ordinazioni.
«Lo so che non sono affari miei» dicevaSempere. «Ma forse dovrebbetogliersela dalla testa.»
«Non so di cosa stia parlando, signorSempere.»
«Martín, ci conosciamo da così tantotempo...»
I mesi passavano in controluce senza cheme ne accorgessi. Vivevo di notte,scrivendo dal tramonto all'alba edormendo durante il giorno. Barrido edEscobillas non smettevano dicongratularsi con me per il successodella Città dei maledetti e quando mivedevano sull'orlo del collasso miassicuravano che dopo un altro paio diromanzi mi avrebbero concesso un annosabbatico per riposare o per scrivereun'opera personale che avrebberopubblicato con grande strepito e con ilmio vero nome in copertina a letterecubitali. Mancavano sempre un altro
paio di romanzi. Le fitte, le nausee e imal di testa si facevano sempre piùfrequenti e più intensi, ma io liattribuivo alla fatica e li soffocavo connuove iniezioni di caffeina, sigarette epastiglie di codeina e diosacché che miforniva sottobanco un farmacista di calleArgenteria e che sapevano di polvere dasparo. Don Basilio, con il qualepranzavo un giovedì sì e uno no in unristorante della Barceloneta, mi incitavaad andare da un medico. Io dicevosempre di sì, e che avevo unappuntamento per quella settimanastessa.
A parte il mio ex capo e i Sempere, nonavevo troppo tempo per vedere altre
persone se non Vidal, e quandosuccedeva era perché lui veniva atrovarmi più che per mia iniziativa. Nongli piaceva la casa della torre e insi-
steva sempre perché andassimo a fareuna passeggiata fino al bar Almirall incalle Joaquim Costa, dove aveva ilconto aperto e un circolo letterario ilvenerdì sera, al quale non mi invitavaperché sapeva che tutti i partecipanti,poetastri frustrati e leccaculo che locompiacevano nella speranza diun'elemosina, una raccomandazione perqualche editore o una parola d'e-logiocon cui curare le ferite della vanità, midetestavano con una convinzione, unvigore e un impegno di cui erano prive
le loro imprese artistiche che il pubblicoignorante e fedifrago insisteva aignorare. Lì, a furia d'as-senzio e disigari caraibici, mi parlava del suoromanzo, che non finiva mai, dei progettidi ritirarsi dalla sua vita ritirata e daisuoi amoreggiamenti e dalle sueconquiste, che erano sempre più giovanie nubili quanto più lui diventavaanziano.
«Non mi chiedi di Cristina» diceva, avolte, malizioso.
«Cosa vuole che le chieda?»
«Se lei mi chiede di te.»
«Le chiede di me, don Pedro?»
«No.»
«Appunto.»
«A dire il vero l'altro giorno ti hanominato.»
Lo guardai negli occhi per vedere se mistesse prendendo in giro.
«E cos'ha detto?»
«Non ti piacerà.»
«Spari...»
«Non ha usato queste parole, ma mi èsembrato di intendere che non ca-pivacome fai a prostituirti scrivendo
feuilleton di mezza tacca per quellacoppia di ladri, e che stai gettando amare il tuo talento e la tua gioventù.»
Fu come se Vidal mi avesse infilato unpugnale gelido nello stomaco.
«È così che la pensa?»
Vidal fece spallucce.
«Allora per me può andarsene aldiavolo.»
Lavoravo tutti i giorni eccetto ledomeniche, che passavo in giro per lestrade e concludevo quasi sempre inqualche cantina del Paralelo, dove nonera difficile trovare compagnia e affetto
passeggero tra le braccia di un'animasolitaria e in attesa come la mia. Fino almattino successivo, quando mirisvegliavo accanto a lei e scoprivoun'estranea, non mi rendevo conto che leassomigliavano tutte, nel colore deicapelli, nel modo di camminare, in ungesto o in uno sguardo. Prima o poi, persoffocare il si-
lenzio tagliente degli addii, quellesignore di una notte mi chiedevano comemi guadagnavo da vivere, e quando lavanità mi tradiva e dicevo di essere unoscrittore mi prendevano per bugiardo,perché nessuno aveva sentito parlare diDavid Martín, anche se qualcuna, sì,sapeva chi era Ignatius B. Samson e
conosceva per sentito dire La città deimaledetti. Col tempo cominciai a direche lavoravo nel palazzo della Doganaportuale delle Ata-razanas o che ero unpraticante nello studio legale Sayrach,Muntaner e Cruells.
Ricordo un pomeriggio in cui ero sedutoal caffè dell'Ópera in compagnia di unamaestra di musica di nome Alicia che,sospettavo, stavo aiu-tando adimenticare qualcuno che non silasciava dimenticare. Stavo per baciarlaquando notai il volto di Cristina dietro ilvetro. Quando uscii in strada, si era giàperduta tra la folla delle Ramblas. Duesettimane dopo, Vidal insistette ainvitarmi alla prima della Madame
Butterfly al Liceo. La famiglia Vidal eraproprietaria di un palco al primo piano ea Vidal piaceva andarci per tutta lastagione con periodicità settimanale.Incontrandolo nella hall, scoprii cheaveva portato anche Cristina. Lei misalutò con un sorriso glaciale e non mirivolse più la parola né lo sguardo,finché Vidal, a metà del secondo atto,decise di scendere al circolo persalutare uno dei suoi cugini e ci lasciòsoli nel palco, l'uno contro l'altra, senzaaltro scudo se non Puccini e centinaia divolti nella penombra del teatro.Resistetti una decina di minuti prima digirarmi a guardarla negli occhi.
«Ho fatto qualcosa che l'ha offesa?»
domandai.
«No.»
«Allora possiamo fingere di essereamici, almeno in occasioni comequesta?»
«Io non voglio essere amica sua,David.»
«Perché no?»
«Perché neanche lei vuole essere mioamico.»
Aveva ragione, non volevo essere suoamico.
«È vero che pensa che mi prostituisco?»
«Quello che penso io non conta.L'importante è quello che pensa lei.»
Rimasi lì altri cinque minuti e poi mialzai e me ne andai senza una parola.Arrivato alla grande scalinata del Liceo,già mi ero ripromesso di non dedicarlemai più un pensiero, uno sguardo o unaparola gentile.
Il giorno dopo la incontrai di fronte allacattedrale e quando feci per evi-tarla misalutò con la mano e mi sorrise. Restaiimmobile, vedendola avvicinarsi.
«Non mi invita a bere qualcosa?»
«Sto battendo e non mi libero prima didue ore.»
«Allora lasci che la inviti io. Quantoprende per accompagnare una signoraper un'ora?»
La seguii di malavoglia fino a unacioccolateria di calle Petritxol. Ordi-nammo un paio di tazze di cioccolatacalda e ci sedemmo uno di fronteall'altra in attesa di vedere chi avrebbeaperto bocca per primo. Per una volta,vinsi io.
«Ieri non volevo offenderla, David. Nonso cosa le ha raccontato don Pedro, maio non ho mai detto quelle cose.»
«Forse le pensa soltanto, per questo donPedro me le dice.»
«Lei non ha idea di quello che penso»replicò con asprezza. «E nemmeno donPedro.»
Mi strinsi nelle spalle.
«D'accordo.»
«Ho detto qualcosa di molto diverso. Hodetto che lei non faceva quello chesentiva.»
Sorrisi, annuendo. L'unica cosa chesentivo in quel momento era il desideriodi baciarla. Cristina sostenne il miosguardo, con aria di sfida. Non allontanò
il viso quando allungai la mano e leaccarezzai le labbra, facendo scivolarele dita lungo il mento e il collo.
«Così no» disse alla fine.
Quando il cameriere ci portò le duetazze fumanti, se n'era già andata.
Passarono mesi senza che sentissi dinuovo il suo nome.
Un giorno di fine settembre in cui avevoappena terminato una nuova puntatadella Città dei maledetti, decisi diprendermi la serata libera. Intuivo che siavvicinava una di quelle tormente dinausee e pugnalate di fuoco nel cervello.Inghiottii una manciata di pastiglie di
codeina e mi stesi sul letto al buio inattesa che passassero quel sudore freddoe quel tremito alle mani. Stavo peraddormentarmi quando sentii suonarealla porta. Mi trascinai all'ingresso eaprii. Vidal, in uno dei suoi impeccabilicompleti di seta italiana, accendeva unasigaretta sotto un fascio di luce cheVermeer in persona sembrava averdipinto per lui.
«Sei vivo o parlo con un fantasma?»domandò
«Non mi dica che è venuto fin qui daVilla Helius per dirmi questo.»
«No. Sono venuto perché da mesi non soniente di te e sono preoccupato. Perché
non fai mettere il telefono in questomausoleo, come le persone normali?»
«Non mi piacciono i telefoni. Mi piacevedere la faccia delle persone quandomi parlano, e che loro vedano la mia.»
«Nel tuo caso non so se questa è unabuona idea. Ultimamente ti sei guardatoallo specchio?»
«Questa è la sua specialità, don Pedro.»
«C'è gente all'obitorio del Clinic con uncolore migliore in faccia. Su, vestiti.»
«Perché?»
«Perché lo dico io. Facciamo una
passeggiata.»
Vidal non accettò rifiuti né proteste. Mitrascinò fino alla macchina cheaspettava sul paseo del Born e fececenno a Manuel di partire.
«Dove andiamo?» chiesi.
«Sorpresa.»
Attraversammo tutta Barcellona finoall'avenida Pedralbes e iniziammo asalire lungo il fianco della collina.Qualche minuto dopo avvistammo VillaHelius, con tutti i finestroni accesi cheproiettavano una bolla d'oro rovente sulcrepuscolo. Vidal non si sbottonava e misorrideva misterioso.
Arrivati a casa, mi fece cenno diseguirlo e mi condusse nel salone. Ungruppo di persone era in attesa e,quando mi vide, applaudì. Riconobbidon Basilio, Cristina, Sempere padre efiglio, la mia ex maestra donna Mariana,alcuni autori che pubblicavano con meda Barrido ed Escobillas e con cuiavevo fatto amicizia, Manuel, che si eraunito al gruppo, e qualcuna delleconquiste di Vidal. Don Pedro mi teseuna coppa di champagne e sorrise.
«Auguri per il tuo ventottesimocompleanno, David.»
Non me ne ero ricordato.
Al termine della cena mi scusai per
uscire un istante in giardino a prenderearia. Un cielo stellato stendeva un velod'argento sugli alberi. Era trascorsoappena un minuto quando sentii dei passiche si avvicinavano e mi girai pertrovarmi di fronte l'ultima persona chemi aspettavo di vedere in quel momento,Cristina Sagnier. Mi sorrise, quasi ascusarsi per l'intrusio-ne.
«Pedro non sa che sono uscita perparlare con lei» disse.
Notai che non usava più il "don", mafeci finta di nulla.
«Mi piacerebbe parlare con lei, David»disse. «Ma non ora, non qui.»
Nemmeno la penombra del giardinoriuscì a nascondere il mio sconcerto.
«Possiamo vederci domani, da qualcheparte?» domandò. «Le prometto di nonrubarle troppo tempo.»
«A una condizione» dissi. «Che non midia più del lei. I compleanni giàinvecchiano abbastanza.»
Cristina sorrise.
«D'accordo. Le do del tu se lo fa anchelei.»
«Dare del tu è una delle mie specialità.Dove vuoi che ci vediamo?»
«Possiamo fare a casa tua? Non voglioche nessuno ci veda né che Pedro sappiache ho parlato con te.»
«Come vuoi...»
Cristina sorrise, sollevata.
«Grazie. Allora a domani? Nelpomeriggio?»
«Quando vuoi. Sai dove abito?»
«Mio padre lo sa.»
Si chinò lievemente e mi baciò sullaguancia.
«Buon compleanno, David.»
Prima che potessi dire una parola, erasvanita nel giardino. Quando tornai nelsalone, se n'era già andata. Vidal milanciò uno sguardo freddo dall'estremitàdella stanza e solo dopo essersi accortoche l'avevo visto sorrise.
Un'ora dopo Manuel, con il beneplacitodi Vidal, insistette per accompagnarmi acasa con l'Hispano-Suiza. Mi sedetti alsuo fianco, come sempre quandoviaggiavo da solo con lui, e l'autista neapprofittava per spiegarmi trucchi diguida e, senza che Vidal lo sapesse,lasciava perfino che mi mettessi un po'al volante. Quella sera l'autista era piùtaciturno del solito e non aprì bocca finoa quando non arrivammo in centro. Era
più magro dell'ultima volta che l'avevovisto e mi parve che l'età iniziasse achiedergli il conto.
«Succede qualcosa, Manuel?»domandai.
L'autista fece spallucce.
«Niente d'importante, signor Martín.»
«Se qualcosa la preoccupa...»
«Sciocchezze di salute. Alla mia età,sono tutte piccole preoccupazioni, lo sa.Ma ormai non hanno più importanza.L'importante è mia figlia.»
Non seppi bene cosa rispondere e mi
limitai ad annuire.
«So che le è affezionato, signor Martín.Alla mia Cristina. Un padre le vede,queste cose.»
Annuii di nuovo, in silenzio. Nonscambiammo più parola fin quandoManuel fermò la macchina in calleFlassaders, mi strinse la mano e miaugurò di nuovo buon compleanno.
«Se dovesse succedermi qualcosa»disse allora «lei l'aiuterebbe, verosignor Martín? Farebbe questo per me?»
«Certo, Manuel. Ma cosa dovrebbesuccederle?»
L'autista sorrise e mi salutò. Lo vidisalire in macchina e allontanarsilentamente. Non ne ebbi la certezzaassoluta, ma avrei giurato che, dopo tuttaquella strada quasi senza aprire bocca,ora stesse parlando da solo.
11
Passai tutta la mattina aggirandomi perla casa, sistemando e mettendo inordine, arieggiando e pulendo oggetti eangoli che non ricordavo nemmeno cheesistessero. Scesi di corsa da una fioraiadel mercato e quando tornai carico dimazzi di fiori mi accorsi che nonricordavo dove avevo nascosto i vasi incui metterli. Mi vestii come se dovessi
uscire in cerca di lavoro.
Provai parole e saluti che mi suonavanoridicoli. Mi guardai allo specchio e vidiche Vidal aveva ragione, sembravo unvampiro. Alla fine mi sedetti su unapoltrona in salotto ad aspettare con unlibro in mano. In due ore, non andai oltrela prima pagina. Finalmente, alle quattroin punto, sentii i passi di Cristina sullescale e mi alzai di scatto. Quando suonòalla porta, ero già lì da un'eternità.
«Ciao, David. È un brutto momento?»
«No, no. Al contrario. Prego, entra.»
Cristina sorrise cortese e si addentrò nelcorridoio. La guidai fino all'angolo di
lettura del salotto e la invitai a sedersi.Il suo sguardo esaminava tutto conattenzione.
«È un posto molto particolare» disse.«Pedro me l'aveva detto che avevi unacasa gentilizia.»
«Lui preferisce il termine "tetra", masuppongo sia questione di sfumatu-re.»
«Posso chiederti perché sei venuto adabitare qui? È una casa un po'
grande per uno che vive da solo.»
Uno che vive da solo, pensai. Si finisceper diventare ciò che si vede negli occhidi quelli che si desiderano.
«La verità?» chiesi. «Sono venuto avivere qui perché per molti anni ho vistoquesta casa tutti i giorni mentre andavo evenivo dal giornale. Era sempre chiusa ealla fine ho cominciato a pensare cheaspettasse proprio me. Ho finitoletteralmente per sognare che un giornoci sarei venuto ad abitare. E così èstato.»
«Tutti i tuoi sogni diventano realtà,David?»
Quel tono ironico mi ricordava troppoVidal.
«No» risposi. «Questo è l'unico. Ma tuvolevi parlarmi di qualcosa e io ti stointrattenendo con storie che sicuramente
non ti interessano.»
Il mio tono suonò più sulla difensiva diquanto avessi desiderato. Con ildesiderio, mi capitava come con i fiori:una volta che l'avevo tra le mani, nonsapevo dove metterlo.
«Volevo parlarti di Pedro» iniziòCristina.
«Ah.»
«Tu sei il suo migliore amico. Loconosci. Parla di te come di un figlio.
Ti vuole bene come a nessuno. Lo sai.»
«Don Pedro mi ha trattato come un
figlio» dissi. «Se non fosse stato per luie per il signor Sempere non so cosa nesarebbe stato di me.»
«Il motivo per cui volevo parlarti è chesono molto preoccupata per lui.»
«Perché?»
«Sai che da qualche anno ho cominciatoa lavorare per lui come segretaria. Laverità è che Pedro è un uomo generoso eabbiamo finito per diventare buoniamici. Si è comportato molto bene conmio padre e con me.
Perciò mi fa male vederlo così.»
«Così come?»
«È quel maledetto libro, il romanzo chevuole scrivere.»
«Sono anni che ci lavora.»
«Sono anni che lo distrugge. Io correggoe batto a macchina tutte le sue pagine.Negli anni in cui sono stata la suasegretaria ne ha distrutte non meno diduemila. Dice che non ha talento. Che èun buffone. Beve in con-tinuazione. Avolte lo trovo nel suo ufficio, là in alto,ubriaco, che piange come un bambino...»
Deglutii.
«Dice che ti invidia, che vorrebbeessere come te, che la gente mente e loelogia perché vuole qualcosa da lui,
soldi, aiuto, ma lui sa che la sua operanon ha alcun valore. Con gli altrimantiene la facciata, i vestiti e tutto ilresto, ma io lo vedo ogni giorno e si staspegnendo. A volte ho paura che facciauna stupidaggine. È così già da molto.Non ho detto nulla perché non sapevocon chi parlarne. So che se lui scoprisseche sono venuta da te si arrabbierebbe.Mi dice sempre: non scocciare Davidcon le mie cose.
Lui ha la vita davanti e io non sono piùnulla. Dice sempre cose del genere.
Scusa se ti racconto tutto questo, ma nonsapevo a chi rivolgermi...»
Sprofondammo in un lungo silenzio.
Sentii che mi invadeva un freddointenso, la certezza che mentre l'uomo alquale dovevo la vita era immerso nelladisperazione, io, rinchiuso nel miomondo, non mi ero fermato nemmeno unattimo per accorgermene.
«Forse non sarei dovuta venire.»
«No» dissi. «Hai fatto bene.»
Cristina mi guardò con un sorriso mite e,per la prima volta, ebbi l'impressione dinon essere un estraneo per lei.
«Cosa facciamo?» chiese.
«Lo aiutiamo» dissi.
«E se non vuole?»
«Allora lo faremo senza che se neaccorga.»
12
Non saprò mai se lo feci per aiutareVidal, come ripetevo a me stesso, osemplicemente al fine di avere una scusaper passare del tempo accanto aCristina. Ci incontravamo quasi tutti ipomeriggi nella casa della torre.
Cristina portava le cartelle che Vidalaveva scritto a mano il giorno prima,sempre zeppe di cancellature, interiparagrafi eliminati, annotazionidappertutto e mille e uno tentativi di
salvare l'insalvabile. Salivamo in studioe ci sedevamo a terra. Cristina leleggeva una prima volta a voce alta epoi ne discutevamo a lungo. Il miomentore stava cercando di scrivere unasorta di saga epica che abbracciava tregenerazioni di una dinastia barcellonesenon molto diversa dai Vidal. L'azioneprendeva le mosse qualche anno primadella rivoluzione industriale con l'arrivodi due fratelli orfani in città ed evolvevain una specie di parabola biblica tipoCaino e Abele. Uno dei due fratellifiniva per diventare il più ricco epotente magnate dell'epoca e l'altro sidedicava alla Chiesa e alle operecaritatevoli, per poi finire tragi-camentei suoi giorni in un episodio che alludeva
alle disavventure del sacerdote e poetadon Jacint Verdaguer. Nel corso delleloro vite, i fratelli si scontravano eun'interminabile galleria di personaggisfilava per torridi melodrammi,scandali, assassinii, amori illeciti,tragedie e altri requisiti del genere, iltutto ambientato sullo sfondo dellanascita della metropoli mo-derna e delmondo industriale e finanziario. La vocenarrante del romanzo era un nipote diuno dei due fratelli, che ricostruiva lastoria mentre contemplava la città infiamme da un palazzo di Pedralbes neigiorni della Set-
timana Tragica del 1909.
La prima cosa che mi sorprese fu chequella trama l'avevo abbozzata io aVidal un paio di anni prima, a mo' disuggerimento affinché iniziasse il suopresunto romanzo serio, quello chediceva sempre di voler scrivere ungiorno. La seconda fu che non mi avessemai detto di aver deciso di utiliz-zarlané di averci già investito due anni, e nonper mancanza di occasioni.
La terza fu che il romanzo, così com'era,era un completo e monumentale fiasco incui non funzionava nulla, a cominciaredai personaggi e dalla struttura,passando per l'ambientazione e idialoghi per finire con un linguaggio euno stile che facevano pensare agli
sforzi di un dilettante con tante pretese eun mucchio di tempo libero.
«Cosa te ne pare?» chiedeva Cristina.«Credi che si possa sistemare?»
Preferii non dirle che Vidal aveva presoin prestito da me i presupposti delromanzo e, con l'intenzione di non farlapreoccupare più di quanto già non fosse,sorrisi e annuii.
«Bisogna lavorarci un po'. Tutto qui.»
Quando iniziava ad annottare, Cristina sisedeva alla macchina e insiemeriscrivevamo il libro di Vidal lettera perlettera, rigo per rigo, scena per scena.
La trama elaborata da Vidal era cosìvaga e insulsa che scelsi di recuperarequella che avevo improvvisato nelsuggerirgli l'idea. Lentamente iniziammoa resuscitare i personaggi reinventandolidall'interno e rifacendoli dalla testa aipiedi. Non una sola scena, momento,frase o parola sopravviveva a quelprocedimento e tuttavia, a mano a manoche avanzavamo, avevo l'impressione direndere giustizia al romanzo che Vidalaveva in animo e che si era ripromessodi scrivere, ma senza sapere come.
Cristina mi diceva che, a volte, Vidal,settimane dopo aver creduto di averescritto una scena, la rileggeva nellaversione finale dattiloscritta e si
sorprendeva del proprio raffinatomestiere e della pienezza di un talentonel quale aveva smesso di credere.Cristina temeva che scoprisse quello chestavamo facendo e diceva che dovevamoessere più fedeli all'originale.
«Non sottovalutare mai la vanità di unoscrittore, specie di uno scrittoremediocre» replicavo.
«Non mi piace sentirti parlare così diPedro.»
«Nemmeno a me. Scusa.»
«Forse dovresti rallentare un po' ilritmo. Non hai un bell'aspetto. Non mipreoccupa più Pedro, adesso sei tu a
preoccuparmi.»
«Da tutto questo, qualcosa di buonodoveva pur venire.»
Col tempo mi abituai a vivere perassaporare quegli istanti che condivi-devo con lei. Il mio lavoro non tardò arisentirne. Trovavo il tempo perlavorare alla Città dei maledetti dovenon c'era, dormendo a stento tre ore algiorno e spingendo al massimo perrispettare le scadenze del mio contratto.
Barrido ed Escobillas avevano pernorma di non leggere nessun libro, néquelli pubblicati da loro né quelli dellaconcorrenza, ma la Veleno sì che lileggeva e ben presto cominciò a
sospettare che mi stesse succedendoqualcosa di strano.
«Questo non sei tu» diceva a volte.
«Certo che non sono io, cara Herminia.È Ignatius B. Samson.»
Ero consapevole del rischio che mi eroassunto, ma non m'importava.
Non m'importava svegliarmi ogni giornomadido di sudore con il cuore chebatteva come se mi stesse per spezzarele costole. Avrei pagato quel prezzo emolto di più per non rinunciare a quelcontatto lento e segreto che senzavolerlo ci trasformava in complici.Sapevo perfettamente che Cristina lo
vedeva nei miei occhi ogni volta cheveniva da me, e sapevo perfettamenteche non avrebbe mai risposto ai mieisegnali. Non c'erano futuro né grandisperanze in quella corsa verso nessunposto, e lo sapevamo entrambi.
A volte, stanchi dei tentativi di fargalleggiare quella nave che facevaacqua da tutte le parti, abbandonavamoil manoscritto di Vidal e ci arri-schiavamo a parlare di qualcosa che nonfosse quella prossimità che a furia dinascondersi cominciava a bruciare nellacoscienza. A volte mi armavo dicoraggio e le prendevo la mano. Lei milasciava fare, ma io sapevo di metterla adisagio: sentiva che quello che
facevamo non stava bene, che il debitodi gratitudine verso Vidal ci univa e ciseparava allo stesso tempo.
Una sera, poco prima che se ne andasse,le presi il viso e cercai di baciarla.
Rimase immobile e quando mi vidi allospecchio del suo sguardo non osai direnulla. Si alzò e se ne andò senza aprirebocca. Non la vidi per due settimane equando tornò mi fece promettere che nonsarebbe più successo niente del genere.
«David, voglio che tu capisca chequando avremo finito di lavorare allibro di Pedro non ci vedremo più comeadesso.»
«Perché no?»
«Lo sai, il perché.»
Le mie avances non erano l'unica cosache Cristina non vedeva di buon occhio.Iniziavo a sospettare che Vidal avesseragione quando mi aveva ri-ferito chenon le piacevano i libri che scrivevo perBarrido ed Escobillas, anche se non lodiceva. Non faticavo a immaginarlamentre pensava che il mio era unimpegno mercenario e senz'anima, chestavo vendendo la mia integrità incambio di un'elemosina per arricchirequella coppia di topi di fogna perchénon avevo il coraggio di scrivere con ilcuore, con il mio nome e i miei verisentimenti. Quello che più mi facevamale era che, in fondo, aveva ragione.Fantasticavo sull'idea di disdire ilcontratto, di scrivere un libro solo per
lei con cui guadagnarmi il suo rispetto.Se nell'unica cosa che sapevo fare nonero abbastanza bravo per lei, forse erameglio tornare ai giorni grigi emiserabili del giornale. Avrei semprepotuto vivere della carità e dei favori diVidal.
Ero uscito a passeggiare dopo una lunganotte di lavoro, incapace di prenderesonno. Senza meta prefissata, i mieipassi mi guidarono fin su al cantiere deltempio della Sagrada Familia. Dapiccolo, mio padre a volte mi ci avevaportato per contemplare quella babele disculture e porticati che non riusciva maia spiccare il volo, come se fossemaledetta. Mi piaceva tornare a vederla
e verificare che non era cambiata: lacittà non smetteva di crescerle attorno,ma la Sagrada Familia rimaneva inrovina fin dal primo giorno.
Quando arrivai, spuntava un'alba azzurrafalciata da luci rosse che profilava letorri della facciata della Nativitat. Unvento dall'est trascinava la polvere dellestrade non selciate e l'odore acido dellefabbriche che punteggiavano la frontieradel quartiere di Sant Marti. Stavoattraversando calle Mallorca quandovidi le luci di un tram che si avvicinavanella nebbiolina dell'alba. Sentii losferragliare delle ruote sui binari e ilrintocco della campana che ilconducente faceva suonare per avvisare
del suo passaggio tra le ombre. Cercaidi correre, ma non ci riuscii. Rimasipiantato lì, immobile tra i binari aguardare le luci del tram che silanciavano su di me.
Sentii le urla del conducente e vidi lascia di scintille sprigionate dalle ruotequando si bloccarono i freni. E perfinoallora, con la morte a pochi metri, nonriuscii a muovere un muscolo. Sentiil'odore di elettricità che accompagnavala luce bianca da cui venni abbagliatofinché il faro del tram non si velò. Miaccasciai a terra come un fantoccio,conservando i sensi appena per qualcheattimo, quanto bastava per vedere che laruota del tram, fumante, si fermava a una
ventina di centimetri dalla mia faccia.Poi tutto fu oscurità.
13
Aprii gli occhi. Colonne di pietra spessecome alberi salivano nella penombraverso una volta spoglia. Aghi di lucepolverosa cadevano in dia-gonale elasciavano intravedere file interminabilidi brande. Piccole gocce d'acqua sistaccavano dall'alto come lacrime scureche esplodevano risuo-nando a terra. Lapenombra odorava di muffa e di umidità.
«Benvenuto in purgatorio.»
Mi alzai e nel voltarmi scoprii un uomovestito di stracci che leggeva un giornale
alla luce di una lanterna e brandiva unsorriso a cui mancava la metà dei denti.La prima pagina del quotidiano chestava leggendo annunciava che ilgenerale Primo de Rivera assumeva ipieni poteri e inaugurava una dittatura inguanti di velluto per salvare il paesedall'imminente eca-tombe. Quel giornaleaveva almeno sei anni.
«Dove sono?»
L'uomo mi guardò da sopra il giornale,intrigato.
«All'hotel Ritz. Non lo sente nell'aria?»
«Come sono arrivato qui?»
«Come un cencio. L'hanno portatastamattina in barella e da allora stasmaltendo la sbornia.»
Mi tastai la giacca e constatai che tutti isoldi che avevo erano spariti.
«Come va il mondo» esclamò l'uomoleggendo le notizie del suo giornale. «Sisa che, nelle fasi più avanzate delcretinismo, la mancanza d'idee vienecompensata dall'eccesso di ideologie.»
«Come si esce di qui?»
«Se ha tanta fretta... Ci sono due modi,quello permanente e quello temporaneo.Quello permanente è dal tetto: un belsalto e si libera per sempre da tutta
questa schifezza. L'uscita temporanea èlì in fondo, dove c'è quel rimbambito colpugno alzato a cui cadono i pantaloni eche fa il saluto rivoluzionario a chiunquepassa. Ma se esce di là, prima o poitornerà qui.»
«È stato lei a derubarmi?»
«Il dubbio offende. Quando l'hannoportata qui, lei era già pulito come unospecchio e io accetto solo titoli quotatiin borsa.»
Lasciai quel lunatico sulla sua brandacon il suo giornale in ritardo e i suoidiscorsi in anticipo. La testa mi giravaancora e a stento ero in grado di farequattro passi in linea retta, ma riuscii ad
arrivare a una porta su uno dei lati dellagrande volta che dava su una scalinata.Un tenue chiarore sembrava filtraredalla sommità. Salii per quattro o cinquepiani finché sentii una ventata d'ariafresca che entrava da un portellone allafine delle scale. Uscii all'esterno efinalmente capii dove ero andato afinire.
Davanti a me si stendeva un lagosospeso sul bosco del Parque de laCiudadela. Il sole stava per tramontaresulla città e le acque coperte di algheondeggiavano come vino versato. IlDepósito de las Aguas aveva l'aspetto diun rozzo castello o di una prigione. Erastato costruito per riforni-re d'acqua i
padiglioni dell'Esposizione Universaledel 1888, ma col tempo il suo ventre dicattedrale laica aveva finito per servireda rifugio a mori-bondi e indigenti senzaaltri posti dove andare quandoincalzavano la notte o il freddo. Ilgrande bacino artificiale sul tetto si eratrasformato in un lago melmoso etorbido che si dissanguava lentamenteattraverso le crepe dell'edificio.
Fu allora che notai la figura appostata auna delle estremità della terrazza. Comese il semplice sfioramento del miosguardo l'avesse allertato, si giròbruscamente e mi fissò. Mi sentivoancora un po' stordito e avevo la vistaannebbiata, ma mi parve di vedere che
la figura si stava avvicinando.
Lo faceva troppo in fretta, come se ipiedi non toccassero terra mentrecamminava e si spostasse con strattonibruschi e troppo agili per essere coltidagli occhi. Potevo a stento scorgerne ilvolto in controluce, ma riuscii a vedereche si trattava di un signore dagli occhineri e brillanti che sembravano troppograndi per il suo volto. Più siavvicinava, più avevo l'impressione cheil suo profilo si allungasse e crescessedi statura. Mentre avanzava, provai unbrivido e arretrai di qualche passo senzaaccorgermi che mi stavo dirigendo versoil bordo del lago. Sentii i piedi perderela presa e stavo già per cadere di spalle
nelle acque scure quando lo sconosciutomi sostenne per il braccio. Mi tirò condelicatezza e mi guidò verso un terrenosicuro. Mi sedetti su una delle panchineche circondavano la cisterna e respirai afondo. Alzai lo sguardo e lo vidichiaramente per la prima volta. Gliocchi erano di dimensioni normali, lastatura uguale alla mia, i passi e i gestiquelli di un signore come chiunque altro.Aveva un'espressione cortese etranquillizzante.
«Grazie» dissi.
«Sta bene?»
«Sì. È solo un giramento di testa.»
Lo sconosciuto si sedette accanto a me.Indossava un vestito scuro a tre pezzi difattura raffinata e adornato da unapiccola spilla d'argento sul risvoltodella giacca, un angelo ad ali spiegateche mi risultò stranamente familiare. Mivenne in mente che la presenza di ungentiluomo dall'abbi-gliamentoimpeccabile su quel tetto era un po'inusuale. Come se potesse leggermi nelpensiero, lo sconosciuto mi sorrise.
«Spero di non averla allarmata» disse.«Immagino che non si aspettasse ditrovare qualcuno qui su.»
Lo guardai, perplesso. Vidi il riflessodel mio viso nelle sue pupille nere, che
si dilatavano come una macchiad'inchiostro sulla carta.
«Posso chiederle cosa l'ha portata qui?»
«La stessa cosa che ha portato lei:grandi speranze.»
«Andreas Corelli» mormorai.
Gli s'illuminò il viso.
«Che gran piacere poterla salutarefinalmente di persona, amico mio.»
Parlava con un leggero accento che nonseppi individuare. Il mio istinto midiceva di alzarmi e andarmene in tuttafretta prima che lo sconosciuto
pronunciasse ancora una sola parola, mac'era qualcosa nella sua voce, nel suosguardo, che trasmetteva serenità efiducia. Preferii non chiedermi comeaveva fatto a sapere che mi avrebbetrovato lì se nemmeno io sapevodov'ero. Mi confortavano il suono dellesue parole e la luce dei suoi occhi.
Mi tese la mano e gliela strinsi. Il suosorriso prometteva un paradiso perduto.
«Immagino di doverla ringraziare pertutte le gentilezze che ha avuto nei mieiriguardi nel corso degli anni, signorCorelli. Temo di essere in debito conlei.»
«Assolutamente no. Sono io a essere in
debito, amico mio, e a dovermi scusareper averla abbordata in questo modo, inun luogo e in un momento cosìsconvenienti, ma confesso che da tempovolevo parlarle e non trovavol'occasione.»
«Mi dica, allora. Cosa posso fare perlei?» domandai.
«Voglio che lavori per me.»
«Prego?»
«Voglio che scriva per me.»
«Certo. Dimenticavo che lei è uneditore.»
L'uomo rise. Aveva una risata dolce, dabambino che non ha mai rotto un piatto.
«Il migliore. L'editore che lei aspettavada una vita. L'editore che la renderàimmortale.»
Mi tese uno dei suoi biglietti da visita,identico a quello che ancora conservavoe che mi ero ritrovato fra le mani alrisveglio dal mio sogno con Chloé.
ANDREAS CORELLI
Éditeur
Éditions de la Lumière
Boulevard St.-Germain, 69. Paris
«Mi sento lusingato, signor Corelli, matemo di non poter accettare il suo invito.Ho un contratto con...»
«Barrido ed Escobillas, lo so. Gentagliacon cui, senza offesa, non dovrebbeavere alcun rapporto.»
«È un'opinione condivisa da altrepersone.»
«La signorina Sagnier, forse?»
«La conosce?»
«Di nome. Sembra il tipo di donna per ilcui rispetto e la cui ammirazione sifarebbe qualunque cosa, non è vero? Ela signorina non la spinge a lasciare
quella coppia di parassiti e a esserefedele a se stesso?»
«Non è così semplice. Ho un contrattoche mi lega in esclusiva a loro per altrisei anni.»
«Lo so, ma non dovrebbepreoccuparsene. I miei avvocati stannostudiando la questione e le assicuro checi sono diverse formule per scioglieredefinitivamente qualsiasi vincolo legale,nel caso lei volesse accettare la miaproposta.»
«E la sua proposta è?»
Corelli sorrise con aria allegra emaliziosa, come un ragazzino che gode a
svelare un segreto.
«Che mi dedichi un anno in esclusivaper lavorare a un libro su commissione,un libro la cui tematica discuteremmo leie io alla firma del contratto e per ilquale le pagherei, in anticipo, la sommadi centomila franchi.»
Lo guardai, attonito.
«Se questa somma non le sembraadeguata sono pronto a considerarequella che riterrà opportuna. Saròsincero, signor Martín: non litigherò conlei per il denaro. E, in confidenza, credoche nemmeno lei vorrà farlo, perché soche quando le spiegherò il tipo di libroche vorrei scrivesse per me, il prezzo
sarà la cosa meno importante.»
Sospirai e risi tra me e me.
«Vedo che non mi crede.»
«Signor Corelli, sono un autore diromanzi d'avventura che non firmonemmeno con il mio nome. I mieieditori, che a quanto pare lei conosce,sono una coppia di truffatori di mezzatacca che non valgono il loro peso insterco, e i miei lettori non sanno neppureche esisto. Sono anni che mi guadagno lavita con questo mestiere e ancora non hoscritto una pagina di cui mi sentasoddisfatto. La donna che amo crede chesto sprecando la vita e ha ragione. Credeanche che non ho il diritto di
desiderarla, che siamo una coppia dianime insignificanti la cui unica ragiond'essere è il debito di gratitudine versoun uomo che ci ha tolti entrambi dallamiseria, e forse ha ragione anche suquesto. Poco importa. Quando meno mel'aspetto compi-rò trent'anni e miaccorgerò che ogni giorno che passaassomiglio meno alla persona chevolevo essere quando ne avevo quindici.Se ci arrivo, perché la mia saluteultimamente è buona quasi quanto il miolavoro. Oggi come oggi, se sono ingrado di mettere insieme due o tre frasileggibili all'ora mi ritengo soddisfatto.Questa è la specie di autore e di uomoche sono. Non di quelli che ricevonovisite da editori parigini con assegni in
bianco per scrivere il libro checambierà la loro vita e trasformerà inrealtà tutte le loro speranze.»
Corelli mi osservò con aria grave,soppesando le mie parole.
«Credo che lei sia un giudice tropposevero con se stesso, e questa è sempreuna qualità che distingue le persone divalore. Mi creda se le dico che nellamia carriera ho avuto a che fare conun'infinità di personaggi che nonvalevano un suo sputo ma avevanoun'altissima considerazione di se stessi.Voglio che sappia, anche se non micrede, che so esattamente che tipo diautore e di uomo è lei. Sono anni che la
seguo, lo sa. Ho letto dal primo raccontoche ha scritto per "La Voz de laIndustria" alla serie dei Misteri diBarcellona e adesso tutte le puntatedella serie di Ignatius B.
Samson. Oserei dire che la conoscomeglio di quanto si conosca lei. Perquesto so che, alla fine, accetterà la miaofferta.»
«Cos'altro sa?»
«So che abbiamo qualcosa, o molto, incomune. So che ha perso suo padre, eanch'io. So cosa significa perdere unpadre quando ancora se ne ha bisogno. Ilsuo le è stato strappato in circostanzetragiche. Il mio, per motivi che non è il
caso di approfondire, mi ha ripudiato ecacciato di casa.
Direi quasi che questo può essere piùdoloroso. So che si sente solo, e micreda se le dico che anche questo è unsentimento che conosco in profondità.So che alberga nel cuore grandisperanze, ma che nessuna di esse si èrealizzata, e so che questo, senza che leise ne renda conto, la sta ucciden-do unpo' ogni giorno che passa.»
Alle sue parole seguì un lungo silenzio.
«Lei sa molte cose, signor Corelli.»
«Abbastanza per pensare che mipiacerebbe conoscerla meglio ed essere
suo amico. E credo che lei non abbiamolti amici. Io nemmeno. Non mi fidodella gente convinta di avere moltiamici. È segno che non conosce glialtri.»
«Ma lei non cerca un amico, cerca undipendente.»
«Cerco un socio temporaneo. Cercolei.»
«È molto sicuro di sé» azzardai.
«È un difetto congenito» replicò Corelli,alzandosi. «Un altro è la pre-veggenza.Per questo capisco che forse è troppopresto per lei e che non le bastaascoltare la verità dalle mie labbra. Ha
bisogno di vederla con i suoi occhi. Disentirla nella sua carne. E, mi creda, lasentirà.»
Mi tese la mano e non la ritrasse finchénon gliela strinsi.
«Posso almeno restare con la tranquillitàdi sapere che penserà a quello che le hodetto e che ne riparleremo?» chiese.
«Non so cosa dire, signor Corelli.»
«Non dica niente, adesso. Le promettoche la prossima volta che ciincontreremo vedrà le cose molto piùchiare.»
Con queste parole mi sorrise
cordialmente e si allontanò verso lescale.
«Ci sarà una prossima volta?»domandai.
Corelli si fermò e si voltò.
«C'è sempre.»
«Dove?»
Le ultime luci del giorno cadevano sullacittà e i suoi occhi brillavano comebraci.
Lo vidi scomparire dalla porta dellescale. Solo allora mi resi conto che, pertutta la conversazione, non l'avevo visto
nemmeno una volta sbattere le palpebre.
14
Lo studio medico si trovava a un pianoalto dal quale si vedevano il mare cheluccicava in lontananza e la discesa dicalle Muntaner punteggiata di tram chescivolavano fino all'Ensanche tra grandiville e palazzi signorili.
L'ambulatorio odorava di pulito. Lestanze erano decorate con gustoraffinato. I quadri erano tranquillizzantie pieni di paesaggi di speranza e dipace. Gli scaffali erano zeppi di libriimponenti che trasudavano autorità. Leinfermiere si muovevano come ballerinee sorridevano quando passavano.
Era un purgatorio per tasche benestanti.
«Il dottore riceve subito, signor Martín.»
Il dottor Trias era un uomo dall'ariapatrizia e dall'aspetto impeccabile chetrasmetteva serenità e fiducia con ognigesto. Occhi grigi e penetranti dietroocchiali senza montatura. Sorrisocordiale e affabile, mai frivolo. Il dottorTrias era un uomo abituato a combatterecon la morte, e più sorrideva, più facevapaura. Dal modo in cui mi fece entrare esedere ebbi l'impressione che, sebbenequalche giorno prima, quando avevoiniziato a sot-topormi alle analisi, miavesse parlato di recenti progressiscientifici e medici che permettevano di
coltivare speranze nella lotta contro isintomi che gli avevo descritto, perquanto lo riguardava non c'erano dubbi.
«Come sta?» domandò, esitante seguardare me o la cartellina sullascrivania.
«Me lo dica lei.»
Mi rivolse un sorriso lieve, da buongiocatore.
«Mi dice l'infermiera che lei è unoscrittore, anche se vedo qui che,riempiendo il questionario d'ingresso, hascritto di essere mercenario.»
«Nel mio caso non c'è nessuna
differenza.»
«Credo che qualcuno dei miei pazientisia un suo lettore.»
«Spero che il danno neurologicoprovocato non sia permanente.»
Il dottore sorrise come se il miocommento gli sembrasse spiritoso eadottò un atteggiamento più diretto chelasciava intendere che i cortesi e banaliprolegomeni della conversazione eranoterminati.
«Signor Martín, vedo che è venuto dasolo. Non ha parenti prossimi?
Moglie? Fratelli? Genitori ancora in
vita?»
«Questo suona un po' funebre» azzardai.
«Signor Martín, non le dirò bugie. Irisultati delle prime analisi non sonoincoraggianti quanto ci aspettavamo.»
Lo guardai in silenzio. Non provavopaura né inquietudine. Non provavonulla.
«Tutto fa pensare che lei abbiaun'escrescenza localizzata nel lobosinistro del cervello. I risultaticonfermano ciò che i sintomi che miaveva descritto facevano temere, e tuttosembra indicare che potrebbe trattarsi diun carcinoma.»
Per qualche secondo fui incapace di direalcunché. Non riuscii nemmeno a fingeresorpresa.
«Da quanto ce l'ho?»
«È impossibile saperlo con certezza,anche se mi spingerei a supporre che iltumore si stia sviluppando da parecchiotempo, il che spiegherebbe i sintomi chemi ha descritto e le difficoltà incontrateultimamente nel lavoro.»
Respirai a fondo, annuendo. Il dottoremi osservava con aria paziente ebenevola, lasciandomi prendere tempo.Cercai di iniziare varie frasi che nonriuscirono ad affiorarmi alle labbra.Alla fine i nostri sguardi si incontrarono.
«Suppongo di essere nelle sue mani,dottore. Mi dirà lei che cura devo fare.»
Vidi che gli occhi gli s'inondavano disconforto: in quel momento si rendevaconto che non avevo voluto capirequello che mi stava dicendo. Annuii dinuovo, combattendo contro la nausea cheiniziava ad assalirmi alla gola. Il dottoremi versò un bicchiere d'acqua da unacaraffa e me lo tese.
Lo svuotai in un sorso.
«Non c'è cura» dissi.
«C'è. Ci sono molte cose che possiamofare per alleviare il dolore e pergarantirle la massima comodità e
tranquillità...»
«Ma morirò.»
«Sì.»
«Presto.»
«Probabilmente.»
Sorrisi tra me. Perfino le peggiorinotizie sono un sollievo quando nonfanno altro che confermare ciò che si sagià senza volerlo sapere.
«Ho ventotto anni» dissi, senza saperebene perché.
«Mi dispiace, signor Martín. Vorrei
poterle dare altre notizie.»
Sentii che era come se alla fine avesseconfessato una bugia o un peccatoveniale e che si era liberato d'un colpodel peso del rimorso.
«Quanto tempo mi resta?»
«È difficile determinarlo con esattezza.Direi un anno, un anno e mezzo almassimo.»
Il tono faceva capire che si trattava diuna prognosi più che ottimista.
«E in quest'anno, o quello che sarà,quanto tempo crede che potròconservare la capacità di lavorare e
badare a me stesso?»
«Lei è uno scrittore e lavora con ilcervello. Purtroppo, però, è proprio lìche è localizzato il problema ed è lì checominceremo a trovarci di fronte a dellelimitazioni.»
«Limitazioni non è un termine medico,dottore.»
«Di solito, via via che la malattiaavanza, i sintomi già sperimentati simanifesteranno con maggior intensità efrequenza. A partire da un determinatomomento, dovrà essere ricoverato inospedale affinché possiamo prendercicura di lei.»
«Non potrò scrivere.»
«Non potrà nemmeno pensarci, ascrivere.»
«Quanto tempo?»
«Non lo so. Nove o dieci mesi. Forsepiù, forse meno. Mi dispiace molto,signor Martín.»
Annuii e mi alzai. Mi tremavano le manie mi mancava l'aria.
«Signor Martín, capisco che ha bisognodi tempo per pensare a tutto quello chele ho detto, ma è importante prendereprovvedimenti prima possibile...»
«Non posso morire, dottore. Nonancora. Ho delle cose da fare. Poi avròtutta la vita per morire.»
15
Quella notte stessa salii allo studio nellatorre e mi sedetti davanti alla macchinaper scrivere pur sapendo chel'ispirazione era esaurita. Le finestreerano spalancate, ma Barcellona nonvoleva raccontarmi più nulla e non fui ingrado di completare una sola pagina.Quello che ero capace di evocare misembrava banale e vuoto. Mi bastavarileggerle per capire che le mie parolevalevano a stento l'inchiostro con cuierano scritte. Non riuscivo più a sentire
la musica sprigionata da un brano diprosa decente. A poco a poco, come unveleno lento e piacevole, le parole diAndreas Corelli iniziarono asgocciolare nei miei pensieri.
Mi restavano almeno cento pagine perterminare l'ennesima puntata dellerocambolesche avventure che tantoavevano gonfiato le tasche di Barrido edEscobillas, ma in quello stesso istanteseppi che non l'avrei finita.
Ignatius B. Samson era rimasto steso suibinari davanti a quel tram, esausto,l'anima dissanguata in troppe pagine chenon avrebbero mai dovuto vedere laluce. Tuttavia, prima di andarsene mi
aveva lasciato le sue ultime volontà.Dovevo seppellirlo senza troppecerimonie e, per una volta nella vita,dovevo avere il coraggio di usare la miavoce. Mi lasciava in eredità il suoconsiderevole arsenale di fumo e dispecchi. E mi chiedeva di lasciarloandare, perché lui era nato per esseredimenticato.
Presi le pagine già scritte del suo ultimoromanzo e diedi loro fuoco, sentendoche una specie di lapide mi si sollevavadi dosso a ogni pagina che consegnavoalle fiamme. Una brezza calda e umidasoffiava quella sera sui tetti: quandoentrò dalle finestre, si portò via leceneri di Ignatius B.
Samson e le sparse nei vicoli della cittàvecchia da dove, per quanto le sueparole si fossero perdute per sempre e ilsuo nome fosse scivolato via dallamemoria dei suoi più devoti lettori, nonsi sarebbe mai più allontanato.
Il giorno dopo mi presentai nella sede diBarrido ed Escobillas. La segretariaall'ingresso era nuova, quasi unaragazzina, e non mi riconobbe.
«Il suo nome?»
«Hugo, Víctor.»
La ragazza sorrise e inserì lo spinottonel centralino per avvisare Herminia.
«Donna Herminia, c'è qui don HugoVíctor per il signor Barrido.»
La vidi annuire e scollegare ilcentralino.
«Dice che viene subito.»
«È da molto che lavori qui?»
«Una settimana» rispose sollecita laragazza.
Se i miei calcoli non erano errati, quellaera l'ottava segretaria di Barrido edEscobillas dall'inizio dell'anno. Gliimpiegati che dipendevano direttamentedall'astuta Herminia duravano pocoperché la Veleno, quando scopriva che
qualcuno aveva un po' più di cervello dilei e temeva che potesse farle ombra,cosa che accadeva nove volte su dieci,lo accusava di furto, rapina o di qualcheerrore assurdo e metteva su un rosariofinché Escobillas lo cacciava in strada eminacciava di mandargli qualche sicariose per caso gli si scioglieva troppo lalingua.
«Sono contenta di vederti, David» dissela Veleno. «Ti trovo più bello.
Hai un aspetto stupendo.»
«È che sono finito sotto a un tram. C'èBarrido?»
«Ma cosa dici? Per te c'è sempre. Sarà
contentissimo quando gli dico che seivenuto a trovarci.»
«Non ne hai idea.»
La Veleno mi condusse nell'ufficio diBarrido, addobbato come la stanza di unministro da operetta, con profusione ditappeti, busti di imperatori, nature mortee volumi rilegati in pelle acquistati apeso le cui pagine, a quanto potevoimmaginare, dovevano esserecompletamente bianche. Barrido mirivolse il più untuoso dei suoi sorrisi emi strinse la mano.
«Siamo tutti impazienti di ricevere lanuova puntata. Sappia che stiamoripubblicando le ultime due e che ce le
strappano di mano. Altre cinquemi-
la copie. Cosa gliene sembra?»
Mi sembrava che dovessero esserealmeno cinquantamila, ma mi limitai adannuire senza entusiasmo. Barrido edEscobillas avevano raffinato, al puntoda farne una composizione floreale,quella che fra gli editori barcellonesiera nota come doppia tiratura. Di ognititolo si stampava un'edizione ufficialedichiarando poche migliaia di copie, perle quali veniva pagata una ridicolapercentuale all'autore. Poi, se il librofunzionava, c'erano una o più edizionireali e sotterranee di decine di migliaiadi copie che non venivano mai
dichiarate e per le quali l'autore nonvedeva nemmeno una peseta. Questecopie si distinguevano dalle primeperché Barrido le faceva stamparesottobanco in una vecchia fabbrica diinsaccati di Santa Perpètua de Mogodae, se uno le sfogliava, sprigionavanoancora l'inconfondibile profumo delsalame ben stagionato.
«Temo di avere brutte notizie.»
Barrido e la Veleno si scambiaronoun'occhiata senza smorzare il sorriso. Inquel momento, Escobillas simaterializzò sulla porta e mi guardò conquell'aria dura e sgradevole con cuisembrava prenderti a occhio le misure
per la bara.
«Guarda chi è venuto a trovarci. Chebella sorpresa, vero?» chiese Barrido alsocio, che si limitò ad annuire.
«Quali brutte notizie?» domandòEscobillas.
«Ha un po' di ritardo, amico Martín?»aggiunse Barrido amichevolmente.«Sono sicuro che troveremo unasoluzione...»
«No. Niente ritardi. Semplicemente, nonci sarà il libro.»
Escobillas fece un passo avanti e inarcòle sopracciglia. Barrido si lasciò
sfuggire una risatina.
«Come sarebbe che non ci sarà illibro?» chiese Escobillas.
«Ieri gli ho dato fuoco e non resta piùnemmeno una pagina del manoscritto.»
Cadde un pesante silenzio. Barrido feceun gesto conciliante e indicò quella cheera nota come la poltrona dei visitatori,un trono nerastro e in-fossato in cuivenivano confinati autori e fornitori inmodo che si trovasse-ro all'altezza dellosguardo di Barrido.
«Martín, si sieda e mi racconti.Qualcosa la preoccupa, si vede. Con noipuò aprirsi, è in famiglia.»
La Veleno ed Escobillas annuirono conconvinzione, mostrando la portata delloro apprezzamento con uno sguardo diestatica devozione. Preferii restare inpiedi. Fecero tutti lo stesso e micontemplarono come se fossi una statuadi sale che da un momento all'altro sisarebbe messa a parlare. A Barridofacevano male le mascelle a furia disorridere.
«Allora?»
«Ignatius B. Samson si è suicidato. Halasciato un racconto inedito di ventipagine in cui muore accanto a ChloéPermanyer, abbracciati dopo averingerito un veleno.»
«L'autore muore in uno dei suoiromanzi?» chiese Herminia, confusa.
«È il suo addio d' avant-garde al mondodel romanzo a puntate. Un dettaglio cheero sicuro vi sarebbe piaciutomoltissimo.»
«E non potrebbe esserci un antidotoo...?» domandò la Veleno.
«Martín, non c'è bisogno che le ricordiche è lei, e non il presuntamente defuntoIgnatius, ad aver sottoscritto uncontratto...» disse Escobillas.
Barrido sollevò la mano per zittire ilcollega.
«Credo di sapere cosa le succede,Martín. Lei è esaurito. Da anni si spremesenza tregua le meningi, cosa che questacasa editrice apprezza e per cui le ègrata, e ha bisogno di un po' di respiro.Lo capiamo, vero?»
Barrido guardò Escobillas e la Veleno,che si affrettarono ad annuire con faccedi circostanza.
«Lei è un artista e vuol fare arte, altaletteratura, qualcosa che le sgorghi dalcuore e inscriva il suo nome a lettered'oro sui gradini della storiauniversale.»
«Come lo spiega lei, suona ridicolo»dissi.
«Perché lo è» sostenne Escobillas.
«No, non lo è» troncò Barrido. «Èumano. E noi siamo umani. Io, il miosocio e Herminia, che essendo donna ecreatura dalla sensibilità delicata è lapiù umana di tutti; non è così,Herminia?»
«Umanissima» convenne la Veleno.
«E dato che siamo umani, lacomprendiamo e vogliamo sostenerla.Perché siamo orgogliosi di lei e convintiche i suoi successi saranno i nostri eperché in questa casa editrice, dopotutto, a contare sono le persone e non inumeri.»
Alla fine del discorso, Barrido fece unapausa teatrale. Forse sperava che mimettessi ad applaudire, ma quando videche restavo fermo proseguì senza esitarenella sua esposizione.
«Perciò, ecco cosa le propongo: siprenda sei mesi, nove se ce n'è bisogno,perché un parto è un parto, e si chiudanel suo studio a scrivere il granderomanzo della sua vita. Quando l'hafinito, ce lo porta e noi lo pub-blichiamocon il suo nome, mettendo tutta la carneal fuoco e scommetten-
do il tutto per tutto. Perché siamo dallasua parte.»
Guardai Barrido e poi Escobillas. La
Veleno era sul punto di scoppiare apiangere per l'emozione.
«Naturalmente, senza anticipo»puntualizzò Escobillas.
Barrido agitò euforicamente la mano inaria.
«Cosa ne dice?»
Iniziai a lavorare quel giorno stesso. Ilmio piano era tanto semplice quantofolle. Di giorno avrei riscritto il libro diVidal e di notte avrei lavorato al mio.Sarei ricorso a tutti i trucchi che miaveva insegnato Ignatius B. Samson e liavrei messi al servizio di quel po' didignità e di decenza, se c'era, che mi
restava nel cuore. Avrei scritto pergratitudine, per disperazione e pervanità. Avrei scritto soprattutto perCristina, per dimostrarle che anch'io erocapace di pagare il mio debito con Vidale che David Martín, seppure in punto dimorte, si era guadagnato il diritto diguardarla negli occhi senza vergognarsidelle sue ridicole speranze.
Non tornai all'ambulatorio del dottorTrias. Non ne vedevo la necessità.
Il giorno in cui non avrei più potutoscrivere una parola, né immaginarla,sarei stato il primo ad accorgermene. Ilmio poco scrupoloso farmacista difiducia mi forniva senza fare domande
tutte le pastiglie di codeina che glichiedevo e, a volte, qualche altra deliziache dava fuoco alle vene e facevaesplodere il dolore e la coscienza. Nonparlai con nessuno della mia visitamedica né dei risultati delle analisi.
Le mie necessità essenziali eranosoddisfatte da una fornitura settimanaleche mi facevo arrivare da Can Gispert,un formidabile negozio di articolicoloniali in calle Mirallers, dietro lacattedrale di Santa Maria del Mar.
L'ordinazione era sempre la stessa. Disolito me la portava la figlia deiproprietari, una ragazza che restava aguardarmi come un cerbiatto spaventato
quando la invitavo a entrare e adaspettare nell'ingresso mentre andavo aprendere i soldi per pagarla.
«Questo è per tuo padre, e questo è perte.»
Le davo sempre dieci centesimi dimancia, che accettava in silenzio.
Ogni settimana la ragazza bussava dinuovo alla porta con l'ordinazione, eogni settimana pagavo e le davo diecicentesimi di mancia. Per nove mesi e ungiorno, il tempo che avrei impiegato ascrivere l'unico romanzo che sarebbeapparso con la mia firma, quellaragazza, di cui ignoravo il nome e il cuivolto dimenticavo ogni settimana fin
quando la ritrovavo sulla soglia di casa,fu la persona che vidi più spesso.
Cristina smise di venire senza preavvisoai nostri appuntamenti pomeri-diani.Cominciavo a temere che Vidal avessescoperto il nostro stratagemma quando,un pomeriggio in cui la stavo aspettandodopo quasi una settimana di assenza,aprii la porta credendo che fosse lei emi trovai davanti Pep, uno dei domesticidi Villa Helius. Mi portava da parte diCristina un pacchetto gelosamentesigillato che conteneva l'interomanoscritto di Vidal. Pep mi spiegò cheil padre di Cristina aveva avuto unaneurisma che l'aveva lasciatopraticamente invalido, e che lei l'aveva
portato in una clinica sui Pirenei, aPuigcerdà, dove, a quanto pareva, c'eraun giovane dottore specializzato nellacura di quelle malattie.
«Il signor Vidal si è fatto carico di tutto»aggiunse Pep. «Senza badare a spese.»
Vidal non dimenticava mai i suoiservitori, pensai, non senza una certaamarezza.
«Mi ha chiesto di darle questo dipersona. E di non dire niente a nessuno.»
Il domestico mi consegnò il pacchetto,sollevato per essersi liberato di quelmisterioso oggetto.
«Ti ha lasciato qualche indicazione sudove trovarla in caso di necessità?»
«No, signor Martín. Tutto quello che soè che il padre della signorina Cristina èricoverato in un posto che si chiamaVilla San Antonio.»
Giorni dopo Vidal mi fece una delle suevisite improvvise e rimase da me tutto ilpomeriggio, bevendo il mio anice,fumando le mie sigarette e parlandodella disgrazia accaduta al suo autista.
«Sembra impossibile. Un uomo fortecome una quercia che, di botto, crolla aterra e non sa più chi è.»
«Come sta Cristina?»
«Puoi immaginartelo. Sua madre è mortaanni fa e Manuel è l'unico familiare chele resta. Ha portato con sé un album difotografie e lo mostra tutti i giorni a quelpoveretto per vedere se ricordaqualcosa.»
Mentre Vidal parlava, il suo romanzo - odovrei dire il mio - giaceva in una piladi fogli a faccia in giù sul tavolo delsalotto, a mezzo metro dalle sue mani.Mi raccontò che, in assenza di Manuel,aveva sollecitato Pep -
che a quanto pare era un buon cavaliere- a impadronirsi dell'arte della guida,ma il ragazzo per il momento era undisastro.
«Ci vuole tempo. Un'automobile non èun cavallo. Il segreto è la pratica.»
«Ora che lo dici, Manuel ti ha insegnatoa guidare, vero?»
«Un poco» ammisi. «E non è facilecome sembra.»
«Se questo romanzo a cui stai lavorandonon si vende, puoi sempre diventare ilmio autista.»
«Non seppelliamo il povero Manuelprima del tempo, don Pedro.»
«Un commento di cattivo gusto» ammiseVidal. «Mi dispiace.»
«E il suo romanzo, don Pedro?»
«Sulla buona strada. Cristina si è portataa Puigcerdà il manoscritto finale perrivederlo e metterlo in bella copiamentre sta vicino al padre.»
«Sono contento di vederla allegro.»
Vidal sorrise, trionfante.
«Credo che sarà qualcosa di grande»disse. «Dopo tanti mesi che credevopersi, ho riletto le prime cinquantapagine messe in bella da Cristina e misono sorpreso di me stesso. Credo chesorprenderà anche te. Finirà che saròancora io a doverti insegnare certitrucchi.»
«Non ne ho mai dubitato, don Pedro.»
Quel pomeriggio Vidal stava bevendopiù del solito. Gli anni mi avevanoinsegnato a leggere la sua gamma diinquietudini e di dubbi, e immaginai chequella non fosse una semplice visita dicortesia. Quando ebbe li-quidato le mieriserve di anice, gli versai una generosacoppa di brandy e aspettai.
«David, ci sono cose di cui tu e io nonabbiamo mai parlato...»
«Di calcio, per esempio.»
«Parlo sul serio.»
«Allora dica, don Pedro.»
Mi guardò a lungo, esitante.
«Ho sempre cercato di essere un buonamico per te, David. Lo sai, vero?»
«Lei è stato molto più di questo, donPedro. Lo so io e lo sa lei.»
«A volte mi domando se non sareidovuto essere più onesto con te.»
«Riguardo a cosa?»
Vidal annegò lo sguardo nella coppa dibrandy.
«Ci sono cose che non ti ho mairaccontato, David. Cose di cui forseavrei dovuto parlarti anni fa...»
Lasciai passare un istante che diventòeterno. Qualunque cosa Vidal avessevoluto raccontarmi, era chiaro chenemmeno tutto il brandy del mondosarebbe riuscito a tirargliela fuori.
«Non si preoccupi, don Pedro. Se hannoaspettato per anni, potranno certoaspettare fino a domani.»
«Domani forse non avrò il coraggio didirtele.»
Mi resi conto di non averlo mai vistocosì spaventato. Qualcosa gli si eraconficcato nel cuore, e iniziava amettermi a disagio vederlo in quellasituazione.
«Facciamo una cosa, don Pedro. Quandoverranno pubblicati il suo libro e il mio,ci vediamo per brindare e mi raccontaquello che deve raccontarmi. Mi invitalei in uno di quei posti cari e raffinatidove non mi lasciano entrare se nonsono con lei e mi fa tutte le confidenzeche vuole. Le sta bene?»
All'imbrunire lo accompagnai fino alpaseo del Born dove Pep aspettavaaccanto all'Hispano-Suiza vestito conl'uniforme di Manuel, che gli stavacinque taglie più grande, proprio comel'automobile. La carrozzeria erafragrante di graffi e ammaccature chesembravano recenti e facevano male agliocchi.
«Al piccolo trotto, eh, Pep?» consigliai.«Niente galoppo. Lento ma sicuro, comese fosse un asino.»
«Sì, signor Martín. Lento ma sicuro.»
Per salutarmi, Vidal mi abbracciò conforza e quando salì in macchina miparve che portasse il peso del mondointero sulle spalle.
16
Pochi giorni dopo che avevo messo ilpunto finale ai due romanzi, quello diVidal e il mio, Pep si presentò a casasenza preavviso. Era insaccatonell'uniforme ereditata da Manuel, chegli conferiva l'aspetto di un bambino
travestito da generale. All'inizio pensaiche portasse qualche messaggio diVidal, o forse di Cristina, ma la suafaccia scura tradiva un'inquietudine chemi fece scartare quella possibilità alprimo sguardo che ci scambiammo.
«Brutte notizie, signor Martín.»
«Cos'è successo?»
«Il signor Manuel.»
Mentre mi spiegava l'accaduto gli sispezzò la voce e quando gli chiesi sevoleva un bicchier d'acqua scoppiò apiangere. Manuel Sagnier era morto tregiorni prima nella clinica di Puigcerdàdopo una lunga agonia. Per decisione
della figlia, l'avevano seppellito ilgiorno prima in un piccolo cimitero aipiedi dei Pirenei.
«Dio santo» mormorai.
Invece dell'acqua, servii a Pep unacoppa di brandy bella piena e lo par-cheggiai su una poltrona in salotto.Quando fu più calmo, Pep mi spiegò cheVidal l'aveva mandato a prendereCristina, che tornava quel pomeriggiocon il treno delle cinque.
«S'immagini come starà la signorinaCristina...» mormorò, angosciato allaprospettiva di dover essere lui adaccoglierla e a consolarla sulla stradaverso il piccolo appartamento sopra i
garage di Villa Helius dove avevavissuto con il padre da quando erabambina.
«Pep, non credo sia una buona idea chetu vada a prendere la signorina Sagnier.»
«Ordini di don Pedro.»
«Di' a don Pedro che mi assumo io laresponsabilità.»
A forza di alcol e di retorica lo convinsiad andarsene e a lasciare la cosa nellemie mani. Sarei andato io stesso aprenderla e l'avrei accompagnata a VillaHelius in taxi.
«La ringrazio, signor Martín. Lei è uomo
di lettere e saprà meglio di me cosa direa quella poverina.»
Alle cinque meno un quartom'incamminai verso la stazione Francia,da poco inaugurata. L'EsposizioneUniversale di quell'anno avevadisseminato prodigi in città, ma, fra tutti,quella volta di acciaio e vetrodall'aspetto di cattedrale era la miapreferita, magari solo perché era vicinaa casa mia e potevo vederla dallo studiodella torre. Quel pomeriggio il cielo erapunteggiato di nuvole nere chearrivavano cavalcando dal mare e siintreccia-vano sopra la città. L'eco deilampi all'orizzonte e un vento caldo chesapeva di polvere e di elettricità
facevano presagire che si avvicinava untemporale estivo di notevole intensità.Quando arrivai in stazione si iniziavanoa vedere le prime gocce, lucide epesanti come monete cadute dal cielo.
Mentre avanzavo lungo la banchina peraspettare l'arrivo del treno, la pioggiabatteva già con forza sulla volta dellastazione e la notte sembrò precipitare dicolpo, appena interrotta dalle fiammatedi luce che esplodevano sulla città elasciavano una scia di frastuono e difuria.
Il treno arrivò con quasi un'ora diritardo, un serpente a vapore che sitrascinava sotto il temporale. Aspettai ai
piedi del locomotore di veder comparireCristina tra i viaggiatori che scendevanodai vagoni. Dieci minuti dopo eranoscesi tutti e di lei non c'era ancoratraccia. Stavo per tornare a casa,credendo che alla fine Cristina nonavesse preso quel treno, quando decisidi dare un'ultima occhiata e dipercorrere tutta la banchina fino alla finecon lo sguardo attento ai finestrini degliscompartimenti. La trovai nel penultimovagone, seduta con la testa appoggiata alvetro e lo sguardo perso. Salii e mifermai sulla soglia delloscompartimento. Sentendo i miei passi,si girò e mi guardò senza stupirsi,sorridendo debolmente. Si alzò e miabbracciò in silenzio.
«Benvenuta» dissi.
Cristina aveva per bagaglio solo unapiccola valigia. Le offrii la mano escendemmo sulla banchina, ormaideserta. Percorremmo il tragitto finoall'ingresso della stazione senza aprirebocca. All'uscita ci fermammo.
L'acquazzone cadeva con violenza e lafila di taxi che c'era davanti all'ingressoal mio arrivo era svanita.
«Non voglio tornare a Villa Heliusstanotte, David. Non ancora.»
«Puoi stare da me, se vuoi, o possiamocercarti una stanza in albergo.»
«Non voglio stare sola.»
«Andiamo a casa. Se ho qualcosa inabbondanza, sono le stanze.»
Avvistai uno dei facchini che si eraaffacciato a guardare il temporale e chereggeva un enorme ombrello. Miavvicinai a lui e mi offrii di com-prarglielo per una somma cinque voltesuperiore al suo prezzo. Me lo consegnòavvolto in un servizievole sorriso.
Al riparo di quell'ombrello ciavventurammo sotto il diluvio verso lacasa della torre, dove, grazie alleraffiche di vento e alle pozzanghere,arrivammo dieci minuti più tardicompletamente zuppi. Il temporale
aveva fatto spegnere i lampioni, e lestrade erano immerse in una liquidaoscurità, punteggiata appena di lampadea olio o di candele accese proiettate dafinestre e portoni. Non ebbi dubbi che ilformidabile impianto elettrico di casamia fosse stato uno dei primi asoccombere. Fummo costretti a salire lescale a tentoni e, quando aprimmo laporta principale dell'appartamento,l'alito dei lampi ne disseppellì l'aspettopiù funebre e inospitale.
«Se hai cambiato idea e preferiscicercare un albergo...»
«No, va bene. Non preoccuparti.»
Lasciai la valigia di Cristina
nell'ingresso e andai in cucina a cercareuna scatola di candele e di ceri checonservavo nella credenza. Iniziai adac-cenderli tutti, uno per uno, fissandolisu piatti e bicchieri. Cristina miosservava dalla porta.
«Questione di un minuto» assicurai.«Ormai sono esperto.»
Cominciai a distribuire candele nellestanze, in corridoio e in ogni angolofinché tutta la casa fu immersa in unatenue tenebra dorata.
«Sembra una cattedrale» disse Cristina.
L'accompagnai in una delle camere daletto che non usavo mai, ma che tenevo
sempre pulita e in ordine da quandoVidal, una volta, troppo ubriaco pertornare al suo palazzo, si era fermato adormire da me.
«Ti porto subito gli asciugamani puliti.Se non hai da cambiarti, posso offrirti ilvario e sinistro abbigliamento stile BelleÉpoque che i vecchi proprietari hannolasciato negli armadi.»
I miei goffi tentativi di fare lo spiritosoriuscivano a stento a strapparle unsorriso e si limitò ad annuire. La lasciaiseduta sul letto mentre correvo a cercaregli asciugamani. Quando tornai eraancora lì, immobile. Misi gliasciugamani sul letto, accanto a lei, e le
avvicinai un paio di candele che avevosistemato all'ingresso perché avesse unpo' più di luce.
«Grazie» mormorò.
«Mentre ti cambi, vado a prepararti unbrodo caldo.»
«Non ho appetito.»
«Ti farà bene lo stesso. Se hai bisognodi qualunque cosa, chiamami.»
La lasciai sola e andai nella mia stanzaper sbarazzarmi delle scarpe bagnate.Misi a riscaldare dell'acqua e mi sedettiin salotto ad aspettare. La pioggiacontinuava a cadere con forza,
mitragliando rabbiosamente le finestre eformando rigagnoli, negli scarichi dellatorre e nelle grondaie, che ri-suonavanocome passi sul tetto. Più in là, ilquartiere della Ribera era immerso inun'oscurità quasi assoluta.
Dopo un po' sentii la porta della stanzadi Cristina che si apriva e i suoi passiche si avvicinavano. Aveva indossatouna vestaglia bianca e si era gettata sullespalle uno scialle di lana che non le siintonava.
«Ho preso in prestito questo da unodegli armadi» disse. «Spero che non tidispiaccia.»
«Puoi tenerlo, se vuoi.»
Si sedette su una delle poltrone e portò aspasso gli occhi per la stanza,soffermandosi sulla pila di fogli sultavolo. Mi guardò e annuii.
«L'ho finito da qualche giorno» dissi.
«E il tuo?»
A dire il vero sentivo miei entrambi imanoscritti, ma mi limitai ad annuire.
«Posso?» chiese, prendendo una paginae avvicinandola alla candela.
«Certo.»
La vidi leggere in silenzio, con untiepido sorriso sulle labbra.
«Pedro non crederà mai di averloscritto» disse.
«Abbi fiducia in me» replicai.
Cristina rimise il foglio sulla pila e miguardò a lungo.
«Mi sei mancato» disse. «Non avreivoluto, ma è stato così.»
«Anche tu.»
«C'erano giorni che, prima di andare inclinica, passavo dalla stazione e misedevo sulla banchina ad aspettare iltreno che arrivava da Barcellona,pensando che forse ti avrei visto.»
Deglutii.
«Pensavo che non volessi vedermi»dissi.
«Anch'io lo pensavo. Mio padrechiedeva spesso tue notizie, sai? Mi hachiesto di prendermi cura di te.»
«Tuo padre era un brav'uomo» dissi.«Un buon amico.»
Cristina annuì con un sorriso, ma vidiche gli occhi le si riempivano dilacrime.
«Alla fine non ricordava più niente.C'erano giorni in cui mi confondeva conmia madre e mi chiedeva di perdonarlo
per gli anni che aveva trascorso incarcere. Poi passavano settimane in cuia stento si rendeva conto che ero lì. Coltempo, la solitudine ti si intrufola dentroe non se ne va più.»
«Mi dispiace, Cristina.»
«Gli ultimi giorni ho creduto che stessemeglio. Cominciava a ricordarequalcosa. Mi ero portata un album difotografie che aveva a casa e glielemostravo ogni volta dicendogli chierano quelle persone. C'era una foto ditanti anni fa, a Villa Helius, in cui cisiete tu e lui in macchina. Tu sei alvolante e mio padre ti sta insegnando aguidare. E tutti e due state ridendo.
Vuoi vederla?»
Esitai, ma non osai rovinarequell'istante.
«Certo...»
Cristina andò a prendere l'album dallavaligia e tornò con un piccolo volumerilegato in pelle. Si sedette al mio fiancoe cominciò a sfogliare le pagine piene divecchi ritratti, ritagli e cartoline.Manuel, come mio padre, aveva a stentoimparato a leggere e scrivere, e i suoiricordi erano fatti di immagini.
«Guarda, eccovi qui.»
Esaminai la fotografia e ricordai
esattamente il giorno d'estate in cuiManuel mi aveva fatto salire sulla primaautomobile comprata da Vidal perinsegnarmi i rudimenti della guida. Poiavevamo portato l'auto fino in callePanamá e, a una velocità di cinquechilometri all'ora che a me sembrò ver-tiginosa, eravamo andati fino all'avenidaPearson ed eravamo tornati con me aicomandi.
"Lei è diventato un asso del volante"aveva sentenziato Manuel. "Se un giornonon le andasse bene con i racconti, pensia un futuro nelle corse au-tomobilistiche."
Sorrisi, ricordando quel momento che
avevo creduto perduto. Cristina mi tesel'album.
«Tienilo. A mio padre sarebbe piaciutoche l'avessi tu.»
«È tuo, Cristina. Non posso accettarlo.»
«Anch'io preferisco che lo conservi tu.»
«Rimane in deposito, allora, finché nonvuoi riprendertelo.»
Iniziai a sfogliarlo, rivisitando volti chericordavo e altri mai visti. C'era la fotodelle nozze di Manuel Sagnier e di suamoglie Marta, a cui tanto assomigliavaCristina, ritratti in studio dei suoi zii enonni, di una strada del Raval dove
passava una processione e dei bagni diSan Sebastián sulla spiaggia dellaBarceloneta. Manuel aveva collezionatovecchie cartoline e ritagli di giornale,con immagini di un Vidal giovanissimoin posa all'ingresso dell'hotel Florida incima al Tibidabo, e un'altra al braccio diuna bellezza da infarto nei saloni delcasinò della Arrabassada.
«Tuo padre venerava don Pedro.»
«Mi ha sempre detto che gli dovevamotutto» rispose Cristina.
Continuai a viaggiare nella memoria delpovero Manuel fino a imbattermi in unapagina con una fotografia che nonsembrava legare con il resto: una
bambina di otto o nove anni camminavasu un piccolo molo di legno sporgente suuna lastra luminosa di mare. Era permano a un adulto, un uomo con un abitobianco tagliato fuori dall'inquadratura.In fondo al molo si potevano notare unapiccola barca a vela e un orizzonteinfinito dove tramontava il sole. Labambina, di spalle, era Cristina.
«Questa è la mia preferita» mormoròCristina.
«Dove è stata scattata?»
«Non lo so. Non ricordo né il posto né ilgiorno. Non sono nemmeno sicura chequell'uomo sia mio padre. È come sequel momento non fosse mai esistito.
L'ho trovata anni fa nell'album di miopadre e non ho mai saputo cosasignifichi. È come se volesse dirmiqualcosa.»
Sfogliai le pagine. Cristina mi spiegavachi erano quelle persone.
«Guarda, questa sono io a quattordicianni.»
«Lo so.»
Cristina mi guardò con tristezza.
«Io non me ne accorgevo, vero?»domandò.
Mi strinsi nelle spalle.
«Non mi perdonerai mai.»
Preferii sfogliare le pagine piuttosto cheguardarla negli occhi.
«Non ho niente da perdonare.»
«Guardami, David.»
Chiusi l'album e feci quello che michiedeva.
«Non è vero» disse. «Me ne accorgevo,invece. Me ne accorgevo ogni giorno,ma credevo di non averne diritto.»
«Perché?»
«Perché le nostre vite non ci
appartengono. Né la mia, né quella dimio padre, né la tua...»
«Tutto appartiene a Vidal» dissi conamarezza.
Lentamente mi prese la mano e se laportò alle labbra.
«Oggi no» mormorò.
Sapevo che l'avrei persa non appenaquella notte fosse trascorsa e il dolore ela solitudine che la consumavano sifossero azzittiti. Sapevo che avevaragione, non perché fosse vero quelloche aveva detto, ma perché in fondo locredevamo entrambi e sarebbe semprestato così. Ci nascondem-mo come due
ladri in una delle stanze senza osareaccendere una candela, senza osarenemmeno parlare. La spogliailentamente, percorrendole la pelle conle labbra, consapevole che non l'avreimai più rifatto. Cristina si diede conrabbia e abbandono, e quando lastanchezza ci vinse si addormentò tra lemie braccia senza bisogno di dire nulla.Resistetti al sonno, assaporando ilcalore del suo corpo e pensando che seil giorno dopo la morte avesse volutovenirmi incontro l'avrei accolta in pace.Accarezzai Cristina nella penombra,sentendo oltre le pareti il temporale chesi allontanava dalla città, sapendo chel'avrei persa ma che, per qualcheminuto, eravamo appartenuti l'uno
all'altra, e a nessun altro.
Quando il primo alito dell'alba sfiorò lefinestre, aprii gli occhi e trovai il lettovuoto. Uscii in corridoio e andai versoil salotto. Cristina aveva lasciatol'album e si era portata via il romanzo diVidal. Percorsi la casa, che già odoravadella sua assenza, e spensi a una a una lecandele che avevo acceso la notteprima.
17
Nove settimane più tardi mi trovavodavanti al numero 17 di plaza deCatalunya, dove la libreria Cataloniaaveva aperto due anni prima, a guardareimbambolato una vetrina che mi sembrò
infinita e zeppa di copie di un romanzointitolato La casa delle ceneri di PedroVidal. Sorrisi tra me. Il mio mentoreaveva usato perfino il titolo che gliavevo suggerito tempo prima, quando gliavevo spiegato le premesse della storia.Mi decisi a entrare e chiesi una copia.L'aprii a caso e cominciai a rileggerepassi che conoscevo a memoria e cheavevo finito di limare da appena un paiodi mesi.
Non trovai in tutto il libro una solaparola che non ci avessi messo io,eccetto la dedica: "A Cristina Sagnier,senza la quale...".
Quando gli restituii il libro, il commesso
mi disse di non pensarci su.
«È arrivato un paio di giorni fa e l'ho giàletto tutto» aggiunse. «Un granderomanzo. Mi dia retta, lo prenda. So chetutti i giornali lo stanno incensando, eche questo è quasi sempre brutto segno,ma stavolta l'ecce-zione conferma laregola. Se non le piace, me lo riporta ele restituisco i soldi.»
«Grazie» risposi, per il consiglio esoprattutto per il resto. «Ma l'ho giàletto anch'io.»
«Allora potrebbe interessarlequalcos'altro?»
«Ha un romanzo intitolato I passi del
cielo?»
Il libraio rifletté un istante.
«È di Martín, vero, quello della Città...?»
Annuii.
«L'avevo ordinato, ma la casa editricenon me l'ha mandato. Mi lascicontrollare.»
Lo seguii verso un bancone dove siconsultò con un collega, che scosse latesta.
«Doveva arrivare ieri, ma l'editore dicedi non avere più copie. Mi dispiace. Se
vuole, glielo metto da parte quandoarriva...»
«Non si preoccupi. Ripasserò. E moltegrazie.»
«Mi dispiace, signore. Non so cosa siasuccesso, perché, come le ho detto,avrei già dovuto riceverlo...»
Uscendo dalla libreria mi avvicinai aun'edicola all'imbocco delle Ramblas.Comprai quasi tutti i quotidiani, da "LaVanguardia" a "La Voz de la Industria".Mi sedetti al caffè Canaletes e cominciaia sfogliarli. La recensione del romanzoche avevo scritto per Vidal eradovunque, a tutta pagina, con grandititoli e una foto di don Pedro in cui
appariva meditabondo e misterioso,sfoggiando un vestito nuovo eassaporando una pipa con studiatanoncuranza. Cominciai a leggere i titolie il primo e l'ultimo paragrafo dellerecensioni.
Il primo apriva così: " La casa delleceneri è un'opera matura, ricca e digrande livello che ci riconcilia con ilmeglio che ha da offrire la letteraturacontemporanea". Un altro quotidiano delmattino spiegava al lettore che
"in Spagna nessuno scrive meglio diPedro Vidal, il nostro più stimato ecelebre romanziere", e un terzosentenziava che si trattava di "un
romanzo fondamentale, di fatturamagistrale e di qualità eccellente". Unquarto quotidiano chiosava il grandesuccesso internazionale di Vidal e dellasua opera: "L'Europa si arrende almaestro" (anche se il libro era uscitosolo da due giorni in Spagna e leeventuali traduzioni non sarebbero statepubbli-cate prima di un anno). L'articolosi dilungava in un prolisso commento sulgrande riconoscimento internazionale esull'enorme rispetto che il nome di Vidalsuscitava tra "i più quotati espertiinternazionali", sebbene, che io sapessi,nessuno dei suoi libri fosse mai statotradotto in nessuna lingua, salvo unromanzo la cui traduzione francese erastata finanziata dallo stesso don Pedro e
della quale si erano vendute 126 copie.Miracoli a parte, la stampa convenivasul fatto che fosse "nato un classico" eche il romanzo segnasse "il ritorno diuno dei grandi, la migliore penna deinostri tempi: Vidal, maestroindiscutibile".
Sulla pagina a fronte di qualcuno di queigiornali, con un rilievo più modesto, auna o a due colonne, trovai anchequalche recensione del romanzo di uncerto David Martín. La più favorevoleiniziava così: "Opera prima dallo stilepedestre, I passi del cielo, deldebuttante David Martín, evidenzia findalla prima pagina la mancanza dirisorse e di talento del suo autore". Per
la seconda "il principiante Martín sisforza di imitare il maestro Pedro Vidalsenza riuscirci". L'ultima che riuscii aleggere, pubblicata dalla "Voz de laIndustria", apriva in maniera lapidariacon un sommario in neretto: "DavidMartín, un completo sconosciuto eredattore di annunci a pagamento, cisorprende con quello che è forse ilpeggiore debutto letterario dell'anno".
Lasciai sul tavolino i giornali e il caffèche avevo ordinato e m'incamminai giùper le Ramblas verso gli uffici diBarrido ed Escobillas. Lungo la stradapassai davanti a quattro o cinquelibrerie, tutte addobbate coninnumerevoli copie del romanzo di
Vidal. In nessuna trovai una sola copiadel mio. In tutte si ripeteva lo stessoepisodio che avevo vissuto allaCatalonia.
«Guardi, non so cosa sarà successo,doveva arrivarmi l'altro ieri, peròl'editore dice di aver esaurito le scorte edi non sapere quando lo ristamperà. Sevuole lasciarmi il nome e il telefono,posso avvisarla se mi arriva...
Ha chiesto alla Catalonia? Se non cel'hanno loro...»
I due soci mi accolsero con aria funebree ostile. Barrido, dietro la sua scrivania,accarezzava una stilografica, edEscobillas, in piedi alle sue spalle, mi
trapanava con lo sguardo. La Veleno sisquagliava per l'aspetta-tiva seduta suuna sedia accanto a me.
«Non sa quanto mi dispiace, Martín,amico mio» spiegò Barrido. «Ilproblema è il seguente: i librai fanno leordinazioni basandosi sulle recensionidei giornali, non mi chieda il perché. Seva nel magazzino qui di fianco, troveràtremila copie del suo romanzoabbandonate e indignate.»
«Con i costi e le perdite che neconseguono» completò Escobillas conun tono chiaramente ostile.
«Sono passato in magazzino prima divenire qui e ho verificato che c'erano
trecento copie. Il capo mi ha detto chenon ne sono state stampate altre.»
«È una bugia» proclamò Escobillas.
Barrido l'interruppe, conciliante.
«Scusi il mio socio, Martín. Capisca chesiamo indignati quanto o più di lei per ilvergognoso trattamento riservato dallastampa locale a un libro di cui tutti inquesta casa editrice siamoprofondamente innamorati, ma la pregodi comprendere che, nonostante la nostrafede entusiastica nel suo talento, inquesto caso siamo legati mani e piedidalla confusione creata da quegliarticoli maliziosi. Però non si scoraggi,Roma non è stata fatta in un giorno.
Stiamo combattendo con tutte le nostreforze per dare alla sua opera larisonanza che il suo livello letterario,altissimo, merita ...»
«Con un'edizione di trecento copie.»
Barrido sospirò, addolorato dalla miamancanza di fede.
«La tiratura è di cinquecento» precisòEscobillas. «Le altre duecento copiesono venuti a prenderle ieri Barceló eSempere di persona. Il resto partirà conla prossima spedizione perché non èentrato in questa a causa di un accumulodi novità. Se lei si prendesse la briga dicomprendere i nostri problemi e nonfosse così egoista, lo capirebbe
perfettamente.»
Guardai tutti e tre, incredulo.
«Non mi dica che non farete nient'altro.»
Barrido mi fissò, desolato.
«E cosa vuole che facciamo, amico mio?Stiamo dando il massimo. Ci aiuti un po'anche lei.»
«Se almeno avesse scritto un libro comequello del suo amico Vidal»
disse Escobillas.
«Quello sì che è un gran romanzo»confermò Barrido. «Lo dice perfino
"La Voz de la Industria".»
«Sapevo che sarebbe andata così»proseguì Escobillas. «Lei è un ingrato.»
Accanto a me, la Veleno mi guardavacon aria compunta. Mi sembrò che fossesul punto di prendermi la mano perconsolarmi e la scostai rapidamente.Barrido mi rivolse un sorriso untuoso.
«Forse non tutti i mali vengono pernuocere, Martín. Forse questo è un segnodi Nostro Signore, che nella sua infinitasaggezza vuole mostrarle il cammino delritorno al lavoro che tanta felicità haportato ai lettori della Città deimaledetti. »
Scoppiai a ridere. Barrido si unì a me e,a un suo cenno, fecero altrettantoEscobillas e la Veleno. Contemplai quelcoro di iene e mi dissi che, in altrecircostanze, quel momento mi sarebbesembrato di una raffinata ironia.
«Così mi piace, che la prendapositivamente» proclamò Barrido.«Cosa mi dice? Quando avremo laprossima puntata di Ignatius B.Samson?»
Mi guardarono tutti e tre solleciti e inattesa. Mi schiarii la voce per vo-calizzare con precisione e sorrisi.
«Andate tutti affanculo.»
18
Uscii e vagabondai per ore per le stradedi Barcellona, senza meta. Mi costavafatica respirare e sentii che qualcosa mipremeva sul petto. Un sudore freddo miricopriva la fronte e le mani. Verso sera,non sapendo più dove nascondermi,intrapresi il cammino di ritorno a casa.Passando davanti alla libreria diSempere e Figli, notai che il libraioaveva riempito la vetrina di copie delmio romanzo. Era già tardi e il negozioera chiuso, ma c'era ancora luceall'interno e quando volli affrettare ilpasso vidi che Sempere si era accortodella mia presenza e mi sorrideva conuna tristezza che non gli avevo mai visto
da quando lo conoscevo. Si avvicinòalla porta e aprì.
«Entri un momento, Martín.»
«Un altro giorno, signor Sempere.»
«Lo faccia per me.»
Mi prese per il braccio e mi trascinòdentro la libreria. Lo seguii nelretrobottega e lì mi offrì una sedia. Servìun paio di bicchieri di qualcosa che misembrò più denso del catrame e mi fececenno di berlo d'un sorso. Lui fece lastessa cosa.
«Ho sfogliato il libro di Vidal» disse.
«Il successo della stagione» suggerii.
«Lui sa che l'ha scritto lei?»
Mi strinsi nelle spalle.
«Che importa?»
Sempere mi rivolse lo stesso sguardocon cui aveva accolto quel ragazzino diotto anni un lontano giorno in cui gli siera presentato a casa pesto e con i dentirotti.
«Sta bene, Martín?»
«Perfettamente.»
Sempere scosse la testa di soppiatto e si
alzò per prendere qualcosa da unoscaffale. Vidi che si trattava di una copiadel mio romanzo. Me la tese insieme auna penna e sorrise.
«Sia così gentile da dedicarmelo.»
Una volta che gli ebbi scritto la dedica,Sempere mi prese il libro dalle mani elo consacrò alla vetrina d'onore dietro ilbancone dove conservava primeedizioni che non erano in vendita. Era ilsuo santuario privato.
«Non ce n'è bisogno, signor Sempere»mormorai.
«Lo faccio perché mi va e perchél'occasione lo merita. Questo libro è un
pezzo del suo cuore, Martín. E, per laparte che mi riguarda, anche del mio.
Lo metto tra Papà Goriot eL'educazione sentimentale. »
«Questo è un sacrilegio.»
«Stupidaggini. È uno dei migliori libriche ho venduto negli ultimi dieci anni, ene ho venduti tanti» mi disse il vecchioSempere.
Le amabili parole del libraio riuscironoa stento a scalfire quella calma fredda eimpenetrabile che iniziava a invadermi.Tornai a casa passeggian-do, senzafretta. Quando arrivai, mi versai unbicchiere d'acqua e, mentre lo bevevo in
cucina, al buio, scoppiai a ridere.
Il mattino dopo ricevetti due visite dicortesia. La prima era di Pep, il nuovoautista di Vidal. Portava un messaggiodel suo padrone che mi invitava apranzo alla Maison Dorée, senza dubbioper i festeggiamenti che mi avevapromesso tempo prima. Pep sembravateso e ansioso di andarsene primapossibile. L'aria complice che di solitoaveva con me era svanita.
Non volle entrare e preferì aspettare sulpianerottolo. Mi tese il messaggioscritto da Vidal quasi senza guardarminegli occhi e appena gli dissi che sareiandato all'appuntamento se la filò senza
salutare.
La seconda visita, mezz'ora più tardi,condusse alla mia porta i miei dueeditori accompagnati da un signore dalportamento austero e dallo sguardopenetrante che si presentò come il loroavvocato. Il formidabile trio esibivaun'espressione fra il lutto e labelligeranza che non lasciava adito adubbi sulla natura dei motivi che liavevano spinti fin là. Li invitai adaccomodarsi in salotto, dove sisedettero sul sofà allineati da sinistra adestra in ordine decrescente di altezza.
«Posso offrirvi qualcosa? Unbicchierino di cianuro?» Non mi
aspettavo un sorriso e non l'ottenni.Dopo una breve introduzione di Barridosulle terribili perdite che la débâcleprovocata dal fiasco dei Passi del cieloavrebbe causato alla casa editrice,l'avvocato procedette a un'esposizionesommaria per dirmi papale papale chese non tornavo al lavoro nella miaincarnazione di Ignatius B. Samson e nonconsegnavo un manoscritto della Cittàdei maledetti entro un mese e mezzoavrebbero proceduto a farmi causa perinadempienza contrattuale, danni e altricinque o sei capi d'accu-sa che misfuggirono perché a quel punto non stavogià più prestando attenzione. Non eranotutte cattive notizie. Nonostante idissapori causati dal mio
comportamento, Barrido ed Escobillasavevano trovato nei loro cuori una perladi generosità con cui limare asprezze esedimentare una nuova alleanza in nomedell'amicizia e del profitto.
«Se vuole, può acquistare a un prezzo difavore, con lo sconto del settanta percento, tutte le copie non distribuite deiPassi del cielo, giacché abbiamoconstatato che il titolo non vienerichiesto e non potremo includerlo nellaprossima distribuzione» spiegòEscobillas.
«Perché non mi restituite i diritti? Dopotutto, non mi avete pagato un soldo e nonintendete venderne nemmeno una copia.»
«Non possiamo farlo, amico mio»precisò Barrido. «Anche se non le sonostati corrisposti anticipi, l'edizione hacomportato un cospicuo investi-mentoper la casa editrice, e il contratto che leiha firmato ha una durata di vent'anni,automaticamente rinnovabile negli stessitermini nel caso che la casa editricedecida di esercitare i suoi legittimidiritti. Cerchi di capire che anche noiabbiamo titolo a ricevere qualcosa. Nonpuò andare tutto all'autore.»
Al termine del suo discorso, invitai i tresignori ad accomodarsi all'uscita con ipropri piedi oppure a calci, a loroscelta. Prima che sbattessi loro la portain faccia, Escobillas volle lanciarmi una
delle sue occhiate di malau-gurio.
«Esigiamo una risposta entro unasettimana, o lei è finito» borbottò.
«Tra una settimana lei e quell'imbecilledel suo socio sarete morti» re-
plicai con calma, senza sapere beneperché pronunciavo quelle parole.
Passai il resto della mattinata acontemplare i muri, finché le campane diSanta Maria mi ricordarono che siavvicinava l'ora dell'appuntamento condon Pedro Vidal.
Mi aspettava al tavolo migliore dellasala, giocherellando con un bicchiere di
vino bianco tra le mani e ascoltando ilpianista che accarezzava un brano diEnrique Granados con dita di velluto.Quando mi vide, si alzò e mi tese lamano.
«Congratulazioni» dissi.
Vidal sorrise imperturbabile e aspettòche mi fossi seduto per fare altrettanto.Lasciammo passare un minuto disilenzio al riparo della musica e deglisguardi della gente bene che salutavaVidal da lontano o che si avvicinava altavolo per fargli i complimenti per ilsuccesso, sulla bocca di tutta la città.
«David, non sai quanto mi dispiace perquello che è accaduto» cominciò.
«Non se ne dispiaccia, se lo goda.»
«Credi che questo significhi qualcosaper me? L'adulazione di quattrodisgraziati? La mia speranza più grandeera di vederti avere successo.»
«Mi dispiace averla delusa di nuovo,don Pedro.»
Vidal sospirò.
«David, non è colpa mia se ce l'hannocon te. La colpa è tua. Lo stavichiedendo a gran voce. Sei abbastanzagrande per sapere come funzionanoqueste cose.»
«Me lo dica lei.»
Vidal fece schioccare la lingua, come sela mia ingenuità l'offendesse.
«Cosa ti aspettavi? Non sei uno di loro.Non lo sarai mai. Non hai volutoesserlo, e credi che te lo perdoneranno.Ti chiudi nel tuo palazzo convinto dipoter sopravvivere senza unirti al corodi chierichetti e metterti l'uniforme. Be',ti sbagli, David. Ti sei sempre sbagliato.Il gioco non funziona così. Se vuoigiocare da solo, fai le valigie e vattenein qualche posto dove puoi esserepadrone del tuo destino, se pure esiste.Ma se rimani qui ti conviene iscriverti aqualche parrocchia, una qualunque. Èsemplicissimo.»
«È questo che fa lei, don Pedro?Iscriversi alla parrocchia?»
«Io non ne ho bisogno, David. Io gli doda mangiare. Nemmeno questo hai maicapito.»
«La sorprenderebbe sapere quantorapidamente mi sto aggiornando. Ma nonsi preoccupi, la cosa meno importantesono quelle recensioni. Nel bene o nelmale, domani nessuno se ne ricorderà,né delle mie né delle sue.»
«Qual è il problema, allora?»
«Lasci perdere.»
«Sono quei due figli di puttana? Barrido
e il ladro di cadaveri?»
«Lasci stare, don Pedro. Come dice lei,la colpa è mia. Di nessun altro.»
Il maître si avvicinò con ariainquisitoria. Non avevo guardato il menuné pensavo di farlo.
«Il solito, per tutti e due» disse donPedro.
Il maître si allontanò con un inchino.Vidal mi osservava come se fossi unanimale pericoloso rinchiuso in unagabbia.
«Cristina non è potuta venire» disse.«Ho portato questo, così le scrivi una
dedica.»
Posò sul tavolo una copia dei Passi delcielo avvolta in carta porpora con iltimbro della libreria Sempere e Figli ela spinse verso di me. Non feci il gestodi prenderlo. Vidal era impallidito. Laveemenza del discorso e il tonodifensivo battevano in ritirata. Adessoviene la stoccata, pensai.
«Mi dica una buona volta quello che hada dirmi, don Pedro. Non la mordo.»
Vidal finì il vino d'un sorso.
«Sono due le cose che volevo dirti. Nonti piaceranno.»
«Comincio ad abituarmi.»
«Una ha a che fare con tuo padre.»
Sentii che quel sorriso avvelenato mi siscioglieva sulle labbra.
«Avrei voluto dirtelo da anni, mapensavo che non ti avrebbe fatto bene.
Crederai che non te l'ho detto pervigliaccheria, ma te lo giuro, te lo giurosu quello che vuoi che...»
«Allora?» lo interruppi.
Vidal sospirò.
«La sera che tuo padre è morto...»
«Che l'hanno assassinato» lo corressi intono glaciale.
«È stato uno sbaglio. La morte di tuopadre è stata uno sbaglio.»
Lo guardai senza capire.
«Quegli uomini non cercavano lui. Sisono sbagliati.»
Ricordai lo sguardo dei tre pistolerinella nebbia, l'odore di polvere da sparoe il sangue di mio padre che sgorgavanero fra le mie mani.
«Volevano ammazzare me» disse Vidalcon un filo di voce. «Un ex socio di miopadre aveva scoperto che sua moglie e
io...»
Chiusi gli occhi e ascoltai una risataoscura salirmi da dentro. Mio padre eramorto crivellato per una questione digonne del grande Pedro Vidal.
«Di' qualcosa, per favore» supplicòVidal.
Aprii gli occhi.
«Qual è la seconda cosa che dovevadire?»
Non avevo mai visto Vidal spaventato.Gli donava.
«Ho chiesto a Cristina di sposarmi.»
Un lungo silenzio.
«Ha detto di sì.»
Vidal abbassò lo sguardo. Uno deicamerieri si avvicinò con gli antipasti.Li depositò sul tavolo augurando « Bonappétit» . Vidal non osò guardarmi dinuovo. Gli antipasti si raffreddavano neipiatti. Dopo un po' presi la copia deiPassi del cielo e me ne andai.
Quel pomeriggio, uscendo dalla MaisonDorée, mi sorpresi a camminare giù perle Ramblas con quella copia dei Passidel cielo. Via via che mi avvicinavoall'angolo da dove partiva calle delCarmen iniziarono a tremarmi le mani.Mi fermai davanti alla vetrina della
gioielleria Bagués, fingendo di guardaremedaglioni d'oro a forma di fata e fiorispruzzati di rubini. La facciata baroccaed esuberante dei magazzini El Indio eraa pochi metri e chiunque avrebbecreduto che si trattasse di un gran bazardi prodigi e meraviglie insospettateinvece che di un negozio di tele e tessuti.Mi avvicinai lentamente e avanzai nelvestibolo che conduceva alla porta.Sapevo che lei non avrebbe potutoriconoscermi, che forse nemmeno ioavrei potuto più riconoscerla, ma rimasilo stesso lì per quasi cinque minutiprima di azzardarmi a entrare. Quandolo feci, il cuore mi batteva forte e sentiiche mi sudavano le mani.
Le pareti erano coperte di scaffali pienidi grandi bobine con ogni tipo di tessutoe sui tavoli i commessi, armati di metri anastro e di forbici speciali legate allavita, mostravano a signore di altolignaggio accompagnate da domestiche esarte le stoffe pregiate, come se sitrattasse di materiale prezioso.
«Posso aiutarla, signore?»
Era un uomo corpulento e dalla vocestridula, con un vestito di flanella chesembrava sul punto di scoppiare da unmomento all'altro e di seminare ilnegozio di brandelli di stoffa fluttuanti.Mi osservava con aria condiscendente eun sorriso forzato e ostile.
«No» mormorai.
Allora la vidi. Mia madre scendeva dauna scala con un mucchio di scampoli inmano. Indossava una blusa bianca e lariconobbi all'istante. Si era un po'riempita e il viso, più indistinto,mostrava la lieve sconfitta della routinee del disinganno. Il commesso, irato,continuava a parlarmi ma io quasi nonsentivo la sua voce. Vedevo solo lei chesi avvicinava e mi passava davanti. Perun secondo mi guardò, e vedendo che lastavo osservando mi sorrise docilmente,come si sorride a un cliente o a unpadrone, e poi proseguì nel suo lavoro.Mi si formò un tale nodo alla gola che astento riuscii a spiccicare qualche
parola per zittire il commesso, e mi civolle del tempo per dirigermi all'uscitacon le lacrime agli occhi. Una volta instrada, l'attraversai ed entrai in un caffè.Mi sedetti a un tavolino accanto allafinestra da cui si vedeva la porta di ElIndio e aspettai.
Era passata quasi un'ora e mezza quandovidi il commesso che mi aveva accoltoche abbassava la serranda dell'ingresso.Dopo un po' cominciarono a spegnersi leluci e uscirono alcuni dei commessi chelavoravano lì. Mi alzai e mi affacciai instrada. Un ragazzino di una decina d'anniera seduto sulla soglia del portone difianco e mi guardava. Gli feci cenno diavvicinarsi e gli mostrai una moneta.
Sorrise da orecchio a orecchio e vidiche gli mancavano diversi denti.
«Vedi questo pacchetto? Devi darlo auna signora che sta per uscire. Le diciche te l'ha dato un signore per lei, manon dirle che sono stato io. Hai capito?»
Il ragazzino annuì. Gli diedi la moneta eil libro.
«Adesso, aspettiamo.»
Non ci fu da attendere molto. Tre minutidopo la vidi uscire. Camminava verso leRamblas.
«È quella signora. La vedi?»
Mia madre si fermò un attimo davanti alportico della chiesa di Betlem e feci uncenno al ragazzo, che corse verso di lei.Assistetti alla scena da lontano, senzapoter sentire le loro parole. Il bambinole tese il pacchetto e lei lo guardòstranita, incerta se accettarlo o no. Luiinsistette e alla fine lei prese ilpacchetto e guardò il bambino che simetteva a correre. Sconcerta-ta, si voltòda una parte e dall'altra, cercando congli occhi. Soppesò il pacchetto,esaminando la carta porpora in cui eraavvolto. Alla fine fu vinta dalla curiositàe l'aprì.
La vidi tirare fuori il libro. Lo tenne conle due mani, guardando la copertina e
poi rigirandolo per esaminare la quarta.Sentii che mi mancava il fiato. Volevoavvicinarmi, dirle qualcosa, ma non ciriuscii. Rimasi lì, a pochi metri da miamadre, spiandola senza che siaccorgesse della mia presenza finquando riprese il cammino con il libroin mano in direzione di Colón. Passandodavanti al palazzo de la Virreina siavvicinò a un cestino e lo buttò via. Lavidi scendere giù per la Rambla finchési perse tra la folla, come se non fossemai stata lì.
19
Sempere padre era solo nella sualibreria a incollare la costa di un
esemplare di Fortunata e Giacinta checadeva a pezzi quando alzò gli occhi emi vide dall'altro lato della porta. Glibastarono un paio di secondi per notarelo stato in cui mi trovavo. Mi fece cennodi entrare. Appena fui dentro, mi offrìuna sedia.
«Ha una brutta faccia, Martín. Dovrebbeandare dal medico. Se ha fifa,l'accompagno. Anche a me i dottorifanno venire i brividi, con quei camicibianchi e quelle cose appuntite in mano,ma a volte ci si è costretti.»
«È solo un mal di testa, signor Sempere.Mi sta già passando.»
Sempere mi versò un bicchiere di acqua
di Vichy.
«Tenga. Questa cura tutto, meno lastupidità, che è un'epidemia sempre piùdiffusa.»
Sorrisi svogliato alla battuta diSempere. Scolai il bicchier d'acqua esospirai. Sentivo la nausea salirmi allelabbra e una pressione intensa chepulsava dietro l'occhio sinistro. Per unattimo credetti di svenire e chiusi gliocchi. Respirai a fondo, supplicando dinon crepare lì. Il destino non potevaavere un senso dell'umorismo tantoperverso da avermi portato fino allalibreria di Sempere per lasciargli, comeringraziamento di tutto quello che aveva
fatto per me, un cadavere per mancia.Sentii una mano che mi sosteneva lafronte con delicatezza. Sempere. Apriigli occhi e trovai il libraio e suo figlio,affacciatosi dentro, che mi osservavanocon facce da veglia funebre.
«Avviso il dottore?» chiese Semperefiglio.
«Sto già meglio, grazie. Molto meglio.»
«Lei ha un modo di stare meglio che fadrizzare i capelli. È grigio.»
«Un altro po' d'acqua?»
Sempere figlio si affrettò a riempirmi dinuovo il bicchiere.
«Scusate per lo spettacolo» dissi. «Viassicuro che non era preparato.»
«Non dica sciocchezze.»
«Forse le farebbe bene mangiarequalcosa di dolce. Può essere stato uncalo di zuccheri...» propose il figlio.
«Vai al forno all'angolo e porta qualchedolce» convenne il libraio.
Quando restammo soli, Sempere mifissò.
«Le giuro che andrò dal medico»promisi.
Un paio di minuti dopo il figlio del
libraio tornò con un sacchetto di cartache conteneva le specialità dellapanetteria del quartiere. Me lo tese escelsi una brioche che, in altreoccasioni, mi avrebbe tentato come ilsedere di una ballerina di varietà.
«Morda» ordinò Sempere.
Mangiai la brioche docilmente. A poco apoco mi sentii meglio.
«Sembra riprendersi» osservò il figlio.
«Quello che non curano i dolci del fornoall'angolo...»
In quell'istante sentimmo il campanellodella porta. Un cliente era entrato nella
libreria e, a un cenno d'assenso delpadre, Sempere figlio ci lasciò perservirlo. Il libraio restò accanto a me ecercò di calcolare i battiti pre-mendomiil polso con l'indice.
«Signor Sempere, si ricorda, tanti annifa, quando mi disse che se un giornoavessi dovuto salvare un libro, salvarlodavvero, sarei dovuto venire da lei?»
Sempere diede un'occhiata al librorecuperato dal cestino dove l'avevagettato mia madre e che tenevo ancorafra le mani.
«Mi dia cinque minuti.»
Cominciava ad annottare quando
scendemmo per le Ramblas tra la follauscita a passeggio in una serata calda eumida. Soffiava un accenno di brezza,balconi e finestre erano spalancati, e lagente si affacciava a guardare sfilare lesagome sotto il cielo incendiatod'ambra. Sempere camminava a passospedito e non rallentò la marcia finchénon avvistammo il portico d'ombra chesi apriva all'imbocco di calle del Arcdel Teatre. Prima di attraversare, miguardò con solennità e disse:
«Martín, quello che ora vedrà non potràraccontarlo a nessuno, nemmeno a Vidal.A nessuno».
Annuii, intrigato dall'aria seria e
misteriosa del libraio. Lo seguii lungol'angusta stradina tra edifici tetri ecadenti che sembravano chinarsi comesalici di pietra per chiudere la linea dicielo ritagliata dai tetti. Dopo un po'
arrivammo a un grande portone di legnoche sembrava sigillare una vecchiabasilica che fosse rimasta cent'anni sulfondo di una palude. Sempere salì igradini fino al portone e afferrò ilpicchiotto di bronzo forgiato a forma didiavoletto sorridente. Bussò tre volte escese di nuovo ad aspettare accanto ame.
«Quello che vedrà ora non potràraccontarlo...»
«... a nessuno. Nemmeno a Vidal. Anessuno.»
Sempere annuì con severità.Aspettammo un paio di minuti finché sisentì un rumore come di centinaia diserrature che scattavano simultanea-mente. Il portone si socchiuse con ungemito profondo e si affacciò il volto diun uomo di mezz'età, dai capelli radi,l'espressione rapace e lo sguardopenetrante.
«Stavamo scarsi ed è arrivato Sempere,tanto per cambiare» buttò lì.
«Cosa mi porta oggi? Un altrosucchiainchiostro, uno di quelli che nonsi fanno la fidanzata perché preferiscono
vivere con mammà?»
Sempere non fece caso alla sarcasticaaccoglienza.
«Martín, questo è Isaac Monfort,guardiano di questo luogo e possessoredi una simpatia senza paragoni. Dia rettaa tutto ciò che dirà. Isaac, questo èDavid Martín, buon amico, scrittore epersona di mia fiducia.»
Isaac mi squadrò dall'alto in basso conscarso entusiasmo e poi scambiòun'occhiata con il libraio.
«Uno scrittore non è mai una persona difiducia. Vediamo, Sempere le haspiegato le regole?»
«Solo che non posso parlare a nessunodi quello che vedo qui.»
«Questa è la prima e la più importante.Se non la rispetta, verrò di persona atorcerle il collo. Si impregna dellospirito generale?»
«Al cento per cento.»
«Allora andiamo» disse Isaac,facendomi cenno di entrare.
«Io la saluto adesso, Martín, e vi lascio.Qui sarà al sicuro.»
Capii che Sempere si riferiva al libro,non a me. Mi abbracciò con forza e poisi perse nella notte. Oltrepassai la soglia
e Isaac tirò una leva sul retro delportone. Mille meccanismi intrecciati inuna ragnatela di binari e pu-legge losigillarono. Isaac prese una lanterna daterra e la sollevò all'altezza del mioviso.
«Ha una brutta faccia» sentenziò.
«Indigestione» replicai.
«Di cosa?»
«Di realtà.»
«Mi venga dietro» tagliò corto.
Avanzammo per un lungo corridoio aicui fianchi velati di penombra si
indovinavano affreschi e scalinate dimarmo. Ci addentrammo nel palazzo edopo un po' s'intravide davanti a noil'entrata di quella che pareva una grandesala.
«Che cosa porta?» domandò Isaac.
« I passi del cielo. Un romanzo.»
«Bella stupidaggine di titolo. Magari èlei l'autore?»
«Temo di sì.»
Isaac sospirò, scuotendo la testa dinascosto.
«E cos'altro ha scritto?»
« La città dei maledetti, volumi dall'unoal ventisette, tra le altre cose.»
Isaac si girò e sorrise, compiaciuto.
«Ignatius B. Samson?»
«Che riposi in pace e per servirla.»
L'enigmatico guardiano si fermò eappoggiò la lampada su quella chesembrava una balaustrata sospesa difronte a una grande volta. Sollevai losguardo e ammutolii. Un colossalelabirinto di ponti, passaggi e scaffalizeppi di centinaia di migliaia di libris'innalzava a formare una gigantescabiblioteca dalle prospettive impossibili.Un intrico di tunnel attraversava
l'immensa struttura che sembravaascendere a spirale verso una grandecupola di vetro da cui filtravano cortinedi luce e di tenebra. Riuscii a vederealcune figure isolate che percorrevanopasserelle e scale o esaminavano neldettaglio gli anditi di quella cattedraledi libri e di parole. Non riuscivo acredere ai miei occhi e guardai IsaacMonfort, attonito. Sorrideva come unavecchia volpe che assapora il suo truccopreferito.
«Ignatius B. Samson, benvenuto nelCimitero dei Libri Dimenticati.»
20
Seguii il guardiano fino alla base della
costruzione che ospitava il labirinto. Ilpavimento che calpestavamo erarappezzato di lastre e lapidi, coniscrizioni funerarie, croci e volti diluitinella pietra. Il guardiano si fermò e fecescivolare a mio beneficio la lampada agas su alcune tessere di quel macabrorompicapo.
«Resti di un'antica necropoli» spiegò.«Ma che non le vengano in mente certeidee e decida di morirmi qui.»
Proseguimmo fino a una zona di frontealla struttura centrale che sembravasvolgere le funzioni di soglia. Isaac mirecitava a memoria le regole e i doveri,rivolgendomi di tanto in tanto uno
sguardo che io cercavo di placare conun cenno di assenso mansueto.
«Articolo uno: la prima volta chequalcuno viene qui ha il diritto discegliere un libro, quello che desidera,fra tutti quelli che ci sono. Articolo due:quando si adotta un libro, si contrael'obbligo di proteggerlo e di fare ilpossibile perché non venga mai perso.Per tutta la vita. Qualche dubbiofinora?»
Sollevai gli occhi verso l'immensità dellabirinto.
«Come si fa a scegliere un solo libro fratanti?»
Isaac si strinse nelle spalle.
«C'è chi preferisce credere che sia illibro a scegliere lui... Il destino, percosì dire. Quella che lei vede qui è lasumma di secoli di libri perduti e di-menticati, libri condannati a esseredistrutti e ridotti per sempre al silenzio,libri che preservano la memoria el'anima di epoche e prodigi che nessunopiù ricorda. Nessuno di noi, nemmeno ipiù vecchi, sa esattamente quando èstato creato questo posto e da chi.Probabilmente è antico quanto la cittàstessa ed è cresciuto con lei, alla suaombra. Sappiamo che l'edificio è statoinnalzato con i resti di palazzi, chiese,prigioni e ospedali che una volta forse si
trovavano in questo luogo. L'originedella struttura principale è degli inizidel XVIII secolo e da allora non hasmesso di cambiare. In prece-denza, ilCimitero dei Libri Dimenticati eranascosto sotto le gallerie della cittàmedievale. C'è chi sostiene che ai tempidell'Inquisizione persone colte e dallamente libera nascondevano libri proibitinei sarcofaghi e li seppellivano negliossari sparsi in tutta la città perproteggerli, sperando che le generazionifuture potessero dissotterrarli. Verso lametà del secolo scorso fu trovata unalunga galleria che conduce dalle visceredel labirinto ai sot-terranei di unavecchia biblioteca oggi chiusa enascosta fra le rovine di un'antica
sinagoga del quartiere del Call. Quandocaddero le ultime mura della città, siverificò uno smottamento e la galleriavenne inondata dalle acque del torrentesotterraneo che scorre da secoli sotto leodierne Ramblas. Adesso èimpraticabile, ma supponiamo che permolto tempo quella galleria sia stata unadelle principali vie d'accesso a questoluogo. La maggior parte della strutturache lei può vedere è sorta durante il XIXsecolo.
Non più di cento persone in tutta la cittàconoscono questo luogo e spero cheSempere non abbia commesso un erroreincludendovi anche lei...»
Negai energicamente, ma Isaac miosservava con scetticismo.
«Articolo tre: può seppellire il suo librodove vuole.»
«E se mi perdo?»
«Una clausola addizionale, farina delmio sacco: cerchi di non perdersi.»
«Si è perso qualcuno qualche volta?»
Isaac si lasciò sfuggire uno sbuffo.
«Quando ho iniziato qui, anni fa,raccontavano la storia di Dario Albertide Cymerman. Immagino che Semperenon gliene avrà parlato, naturalmente...»
«Cymerman? Lo storico?»
«No, il domatore di scarafaggi. QuantiDario Alberti de Cymerman conosce? Sidà il caso che nell'inverno del 1889Cymerman si addentrò nel labirinto escomparve per una settimana. Lotrovarono nascosto in una delle gallerie,mezzo morto di terrore. Si era muratodietro varie file di testi sacri per nonessere visto.»
«Visto da chi?»
Isaac mi fissò a lungo.
«Dall'uomo vestito di nero. Sicuro cheSempere non gliel'ha raccontato?»
«Sicuro.»
Isaac abbassò la voce e adottò un tonoconfidenziale.
«Alcuni membri, nel corso degli anni,hanno visto a volte l'uomo vestito dinero nelle gallerie del labirinto. Ognunolo descrive in modo diverso.
C'è perfino chi afferma di avergliparlato. C'è stato un tempo in cui sisparse la voce che l'uomo vestito di nerofosse lo spirito di un autore maledettotradito da uno dei membri che si eraportato via un suo libro e non avevamantenuto la promessa. Il libro si perseper sempre e l'autore defunto vagaeternamente per i corridoi in cerca di
vendetta, sa, quel tipo di cose alla HenryJames che piacciono tanto alla gente.»
«Non mi dirà che lei ci crede.»
«Certo che no. Io ho un'altra teoria.Quella di Cymerman.»
«Cioè...?»
«L'uomo vestito di nero è il padrone diquesti luoghi, il padre di ogniconoscenza segreta e proibita, delsapere e della memoria, portatore dellaluce di romanzieri e scrittori da tempoimmemorabile... È il nostro angelocustode, l'angelo delle menzogne e dellanotte.»
«Mi sta prendendo in giro.»
«Ogni labirinto ha il suo minotauro»commentò il guardiano.
Isaac sorrise enigmaticamente e indicòl'ingresso del labirinto.
«È tutto suo.»
Imboccai una passerella che conducevaa una delle entrate e avanzai lentamenteper un lungo corridoio di libri chedescriveva una curva ascenden-
te. Alla fine della curva, la galleria siramificava in quattro bracci e formavaun piccolo cerchio dal quale partiva unascala a chiocciola che si perdeva in alto.
Salii i gradini finché trovai unpianerottolo da cui si diramavano tregallerie. Ne scelsi una, quella checredevo portasse al cuore della struttura,e mi ci avventurai. Passando, sfioravocon le dita i dorsi di centinaia di libri.Mi lasciai impregnare dall'odore, dallaluce che riusciva a filtrare dalle fessuree dalle lanterne di vetro incastonatenella struttura di legno e che fluttuavanegli specchi e nella penombra.Camminai senza meta per quasi trentaminuti finché giunsi in una specie dicamera chiusa dove c'erano un tavolo euna sedia. Le pareti erano fatte di libri edavano l'impressione di essere solide, aeccezione di uno spiraglio da cuisembrava che qualcuno avesse portato
via un volume. Decisi che quellasarebbe stata la nuova casa dei Passidel cielo. Guardai la copertina perl'ultima volta e rilessi il primoparagrafo, immaginando l'istante in cui,se la fortuna l'avesse voluto, e molti annidopo che io fossi morto e dimenticato,qualcuno avrebbe percorso lo stessocammino e sarebbe arrivato in quellasala per trovare un libro sconosciuto nelquale avevo messo tutto ciò che avevoda offrire. Lo lasciai lì, con lasensazione di essere io a restare sulloscaffale.
Fu allora che sentii la presenza alle miespalle, e mi girai per imbatterminell'uomo vestito di nero che mi fissava
negli occhi.
21
All'inizio non riconobbi il mio stessosguardo nello specchio, uno dei tanti cheformavano una catena di luce tenuelungo i corridoi del labirinto.
Quelli che vedevo riflessi erano il miovolto e la mia pelle, ma gli occhiappartenevano a un estraneo. Torbidi escuri e pieni di malizia. Distolsi losguardo e sentii che mi prendeva dinuovo la nausea. Mi sedetti sulla sediaaccanto al tavolo e respirai a fondo.Immaginai che perfino il dottor Trias sisarebbe divertito all'idea che l'inquilinodel mio cervello, l'escrescenza
tumorale, come a lui piaceva chiamarla,avesse pensato di darmi il colpo digrazia proprio in quel posto e diconcedermi l'onore di essere il primocittadino permanente del Cimitero deiRomanzieri Dimenticati. Seppellito incompagnia della sua ultima e penosaopera, quella che l'aveva portato allatomba. Qualcuno mi avrebbe trovato lìdentro dopo dieci mesi o dieci anni, oforse mai. Un gran finale, degno dellaCittà dei maledetti.
Credo che mi salvò quella mia risataamara, che mi snebbiò la testa e mirestituì la nozione di dove mi trovassi edi cosa fossi venuto a fare. Stavo peralzarmi dalla sedia quando lo vidi. Era
un volume rozzo, scuro e senza titolovisibile sulla costa. Era in cima a unapila di altri quattro libri all'estremità deltavolo. Lo presi fra le mani. Sembravarilegato in cuoio o in qualche tipo dipelle conciata e annerita, più dal tattoche da una tintura. Le parole del titolo,incise in copertina con quello cheimmaginai come un qualche tipo dimarchio a fuoco, erano indistinguibili,ma sulla quinta pagina si poteva leggerechiaramente lo stesso titolo.
Lux Aeterna
DM.
Supposi che le iniziali, checoincidevano con le mie,
corrispondessero al nome dell'autore,ma nel libro non c'era nessun altroindizio che lo con-fermasse. Sfogliai alvolo parecchie pagine e riconobbialmeno cinque diverse lingue che sialternavano nei testo. Castigliano,tedesco, latino, francese ed ebraico.Lessi un paragrafo a caso che mi fecepensare a un'orazio-ne che nonricordavo nella liturgia tradizionale e michiesi se quel tomo non fosse una speciedi messale o di compendio di preghiere.Il testo era punteggiato di numeri e distrofe con gli incipit sottolineati cheparevano indicare episodi o divisionitematiche. Più lo esaminavo, più mirendevo conto che mi ricordava iVangeli e i libri di catechismo di quando
andavo a scuola.
Avrei potuto uscire di lì, sceglierequalunque altro volume tra centinaia dimigliaia e abbandonare quel luogo pernon tornarci mai più. Credetti quasi diaverlo fatto quando mi resi conto diripercorrere le gallerie e i corridoi dellabirinto con il libro in mano, come sefosse un parassita appiccicato alla miapelle. Per un istante mi attraversò lamente l'idea che il libro avesse piùvoglia di me di uscire da quel posto eche, in qualche maniera, guidasse i mieipassi. Dopo aver fatto qualche giro edessere passato un paio di volte davantiallo stesso esemplare del quarto volumedelle opere complete di LeFanu, mi
ritrovai senza sapere come di fronte allascala che scendeva a spirale, e da lìriuscii a imbroccare la strada cheportava all'uscita del labirinto. Credevoche Isaac mi aspettasse sulla soglia, manon c'era traccia della sua presenza,anche se ebbi la certezza che qualcunomi stesse osservando dall'oscurità. Lagrande volta del Cimitero dei LibriDimenticati era immersa in un profondosilenzio.
«Isaac?» chiamai.
L'eco della mia voce si persenell'ombra. Attesi inutilmente qualchesecondo e m'incamminai verso l'uscita.Le tenebre azzurrate che filtravano dalla
cupola a poco a poco svanirono finchél'oscurità intorno a me fu quasi assoluta.Qualche passo più avanti scorsi una luceche palpitava all'estremità della galleriae vidi che il guardiano aveva lasciato lalanterna ai piedi del portone. Mi giraiper l'ultima volta per scrutare nel buiodella galleria. Tirai la leva che mettevain funzione il meccanismo di binari e pu-legge. Gli anelli del chiavistello siliberarono uno dopo l'altro e la portacedette di qualche centimetro. La spinsiquel tanto che bastava per passare euscii all'esterno. Dopo pochi secondi laporta iniziò a chiudersi di nuovo e sisigillò con un'eco profonda.
22
Via via che mi allontanavo da quelposto, sentivo che la sua magia miabbandonava e che m'invadevano dinuovo la nausea e il dolore. Caddibocconi un paio di volte, la prima sulleRamblas e la seconda mentre ten-tavo diattraversare via Layetana, dove unbambino mi sollevò e mi salvò da untram che stava per investirmi. Amalapena riuscii ad arrivare alla miaporta. La casa era stata chiusa tutto ilgiorno e il caldo, quel caldo umido evelenoso che ogni giorno soffocava unpo' di più la città, fluttuava all'internosotto forma di luce polverosa. Salii allostudio della torre e spalancai le finestre.C'era appena un alito di brezza sotto uncielo lapidato di nubi nere che si
muovevano lentamente in circolo sopraBarcellona. Lasciai il libro sullascrivania e mi dissi che ci sarebbe statotempo per esaminarlo con cura. O forseno. Forse il mio tempo era già finito.Ormai pareva im-portare poco.
In quegli istanti mi reggevo a stento inpiedi e avevo bisogno di stendermi albuio. Recuperai dal cassetto un flaconedi pillole di codeina e ne inghiottii tre oquattro d'un colpo. Mi misi il flacone intasca e scesi per le scale, non del tuttosicuro di poter arrivare intero allacamera da letto. In corridoio mi sembròdi vedere un palpitio nella striscia diluce sotto la porta principale, come se cifosse qualcuno dall'altro lato. Mi
avvicinai lentamente all'entrata,sostenendomi ai muri.
«Chi è?» domandai.
Non ci fu risposta né alcun suono. Esitaiun attimo e poi aprii e mi affacciai sulpianerottolo. Mi sporsi a guardare giùper le scale. I gradini scen-
devano a spirale, sfumando nelletenebre. Non c'era nessuno. Mi giraiverso la porta e notai che la piccolalampada che illuminava il pianerottolopalpitava. Entrai di nuovo in casa echiusi a chiave, cosa che molte voltedimenticavo di fare. Fu allora che lavidi. Una busta color crema con il bordosigillato. Qualcuno l'aveva fatta
scivolare sotto la porta. Mi accovacciaiper raccoglierla. Era una carta dallagrammatura pesante, porosa.
La busta era sigillata con la ceralacca erecava il mio nome. L'emblema sullaceralacca tracciava il profilo dell'angeload ali spiegate.
L'aprii.
Stimato signor Martín,
trascorrerò qualche tempo in città e mipiacerebbe molto poter godere della suacompagnia e magari dell'opportunità diriprendere il discorso della mia offerta.Le sarei molto grato se, non avendoimpegni precedenti, volesse cenare in
mia compagnia il prossimo venerdì 13di questo mese alle 22.00 in una piccolavilla che ho affittato per la miapermanenza a Barcellona. La casa sitrova all'angolo tra calle Olot e calleSan José de la Montana, accantoall'ingresso del Park Güell. Confido emi auguro che le sarà possibile venire.
Il suo amico
Andreas Corelli
Lasciai cadere il biglietto e mi trascinaiin salotto. Lì mi stesi sul divano, alriparo della penombra. Mancavano settegiorni all'appuntamento. Sorrisi tra me.Non credevo di avere altri sette giornidi vita. Chiusi gli occhi e cercai di
conciliare il sonno. Quel sibilo costantenelle orecchie mi sembrava adesso piùrumoroso che mai. Stilettate di lucebianca si accendeva-no nella mia mentea ogni battito del cuore.
Non potrà nemmeno pensarci, ascrivere.
Riaprii gli occhi e scrutai le tenebreazzurrate che velavano il salotto.
Accanto a me, sul tavolo, giacevaancora quel vecchio album di fotografielasciato da Cristina. Mi era mancato ilcoraggio di buttarlo via, e non l'avevoquasi toccato. Allungai la mano e loaprii. Sfogliai le pagine fino a trovarel'immagine che cercavo. La staccai per
esaminarla. Cristina, da bambina,camminava per mano a uno sconosciutolungo quel molo che si addentrava nelmare. Strinsi la foto al petto e miabbandonai alla stanchezza. Lentamente,l'amarezza e la rabbia di quel giorno, diquegli anni, si spensero e mi avvolseuna calda oscurità piena di voci e maniche mi stavano aspettando. Desideraiperdermici come non avevo maidesiderato nulla in tutta la vita, maqualcosa mi diede uno strattone, e unapugnalata di luce e di dolore mi strappòa quel sogno piacevole che promettevadi non avere fine.
Non ancora - sussurrò la voce - nonancora.
Seppi che passavano i giorni perché atratti mi svegliavo e mi sembrava divedere la luce del sole che attraversavale stecche delle imposte alle finestre. Indiverse occasioni credetti di sentirebussare alla porta e voci chepronunciavano il mio nome e dopo unpo' sparivano. Ore o giorni dopo mialzai e mi portai le mani alla facciascoprendo del sangue sulle labbra. Nonso se scesi in strada o se sognai di farlo,ma senza sapere come ci ero arrivato miritrovai a imboccare il paseo del Born ea camminare verso la cattedrale di SantaMaria del Mar. Le strade erano desertesotto la luna di mercurio. Alzai losguardo e credetti di vedere lo spettro diun gran temporale nero che dispiegava
le sue ali sulla città. Un soffio di lucebianca squarciò il cielo e un mantointessuto di gocce di pioggia precipitòcome uno sciame di pugnali di cristallo.Un attimo prima che le gocce sfiorasse-ro il suolo, il tempo si fermò e centinaiadi migliaia di lacrime di luce rimaserosospese nell'aria come pagliuzze dipolvere. Seppi che qualcuno o qualcosacamminava alle mie spalle e sentii il suoalito sulla nuca, freddo e impregnato delfetore della carne putrefatta e del fuoco.Sentii che le sue dita, lunghe eaffusolate, incombevano sulla mia pellee in quell'istante, attraversando lapioggia in sospensione, apparve quellabambina che viveva soltanto nel ritrattoche stringevo al petto. Mi prese per
mano e mi trascinò, guidandomi dinuovo alla casa della torre, lasciandoalle spalle quella presenza gelida chestrisciava dietro di me. Quandorecuperai la coscienza, erano passatisette giorni.
Era l'alba del 13 luglio, venerdì.
23
Pedro Vidal e Cristina Sagnier sisposarono quel pomeriggio. Lacerimonia ebbe luogo alle cinque nellacappella del monastero di Pedralbes evi partecipò solo una piccola parte delclan Vidal, mentre i membri piùimportanti della famiglia, incluso ilpadre dello sposo, brillavano per la loro
vergognosa assenza. Ci fosse stataqualche malalingua, avrebbe detto che latrovata del prediletto di contrarrematrimonio con la figlia dell'autista eracaduta come un secchio di acqua gelatasui seguaci della dinastia. Ma non c'era.In virtù di un discreto patto del silenzio,i cronisti di costume e società avevanoaltre cose da fare quel pomeriggio e nonuna sola pubblicazione parlò dellacerimonia. Nessuno era lì per raccontareche alle porte della chiesa si era riunitoun gruppo di ex amanti di don Pedro, chepiangevano in silenzio come unaconfraternita di vedove avvizzite a cuirestava da perdere soltanto l'ultimasperanza. Nessuno era lì per raccontareche Cristina aveva un mazzo di rose
bianche in mano e un vestito avorio chesi confondeva con la pelle e facevapensare che la sposa arrivasse nudaall'altare, senz'altri ornamenti se non ilvelo bianco che le copriva il volto e uncielo ambrato che sembrava raccogliersiin un mulinello di nubi sulla gu-glia delcampanile.
Nessuno era lì per ricordare comescendeva dalla macchina e come, per unistante, si fermava per alzare lo sguardosulla piazza di fronte al portale dellachiesa, finché i suoi occhi incontraronoquell'uomo moribondo a cui tremavanole mani e che mormorava, senza chenessuno potesse sentirlo, parole cheavrebbe portato con sé nella tomba.
«Siate maledetti. Siate tutti e duemaledetti.»
Due ore dopo, seduto nella poltronadello studio, aprii l'astuccio che anniprima era giunto tra le mie mani e checonteneva l'unica cosa che mi restava dimio padre. Estrassi la pistola avvoltanel panno e aprii il tamburo.
Caricai sei pallottole e richiusi l'arma.Appoggiai la canna alla tempia, ar-maiil percussore e chiusi gli occhi. Inquell'istante sentii quella raffica di ventosferzare all'improvviso la torre espalancare i finestroni dello studio, chesbatterono con forza contro i muri. Unabrezza gelida mi accarezzò la pelle,
portando con sé il soffio perduto dellegrandi speranze.
24
Il taxi saliva lentamente fino ai confinidel quartiere di Gracia verso il solitarioe cupo recinto del Park Güell. La collinaera punteggiata di ville che avevanovisto giorni migliori, immerse in unbosco che si agitava al vento comeacqua scura. Intravidi nella parte altadel pendio la grande porta del recinto.Tre anni prima, alla morte di Gaudi, glieredi del conte Güell avevano vendutoal Comune quell'area deserta che nonaveva mai avuto altro abitante se non ilsuo architetto al prezzo di una peseta.
Dimenticato e trascurato, il giardino conle colonne e le torri faceva pensareadesso a un eden maledetto. Indicaiall'autista di fermarsi davanti ai cancellidell'ingresso e gli pagai la corsa.
«Il signore è sicuro di voler scenderequi?» domandò l'autista, dubbioso.
«Se vuole, posso aspettarla qualcheminuto...»
«Non sarà necessario.»
Il mormorio del taxi si perse giù per lacollina e rimasi solo con l'eco del ventotra gli alberi. Le foglie morte sitrascinavano all'entrata del parco eformavano mulinelli ai miei piedi. Mi
avvicinai al cancello, chiuso con catenecorrose dalla ruggine, e scrutaiall'interno. La luce della luna lambiva ilprofilo del drago che presidiava lascalinata. Una forma scura scendeva igradini molto lentamente, osservandomicon occhi che brillavano come perlenell'acqua. Era un cane nero. L'animalesi fermò ai piedi delle scale e soloallora notai che non era solo. Altri dueanimali mi osservavano in silenzio. Unosi era avvicinato con cautela al riparodell'ombra proiettata dalla casa delguardiano, di fianco all'ingresso. L'altro,il più grande dei tre, si era arrampicatoin cima al muro e mi contemplava dalbordo a nemmeno un paio di metri. Labruma del suo fiato stillava tra i canini
scoperti. Arretrai molto lentamente,senza distogliere lo sguardo dai suoiocchi e senza rivolgergli le spalle.Passo dopo passo, guadagnai ilmarciapiede di fronte all'entrata. Unaltro cane era salito sul muro e miseguiva con gli occhi. Tastai il terreno incerca di qualche bastone o di una pietrada utilizzare come arma di difesa seavessero deciso di saltarmi addosso, mac'erano solo foglie secche. Sapevo che,se distoglievo lo sguardo e mi mettevo acorrere, gli animali mi avrebbero dato lacaccia e che non avrei fatto nemmenoventi metri prima che mi raggiungesseroe mi facessero a pezzi. Il più grandeavanzò qualche metro in cima al muro edebbi la certezza che stesse per saltare.
Quello che avevo visto all'inizio e cheprobabilmente faceva da escacominciava a scalare la parte bassa delmuro per unirsi agli altri due. Eccociqua, pensai.
In quell'istante un lampo si accese eilluminò i musi da lupo dei tre animali,che si fermarono di colpo. Guardai dasopra la spalla e vidi il monti-cello ches'innalzava a una cinquantina di metridall'ingresso del parco. Le luci dellacasa si erano accese, le uniche in tutta lacollina. Uno degli animali emise ungemito sordo e si ritirò verso l'internodel parco. Gli altri lo seguirono unattimo dopo.
Senza pensarci su, m'incamminai versola casa. Come aveva indicato Corelli nelsuo invito, la villa s'innalzava all'angolotra calle Olot e calle San José de laMontana. Era una struttura slanciata espigolosa di tre piani a forma di torre,coronata da mansarde, che osservavacome una sentinella la città e il parcospettrale ai suoi piedi.
La casa sorgeva alla fine di una ripidasalita e di una scalinata checonducevano alla sua porta. Aloni diluce dorata trapelavano dai finestroni.
Mentre salivo le scale di pietra, miparve di distinguere un profilo ritagliatosu una balaustrata del secondo piano,
immobile come un ragno al centro dellasua tela. Raggiunsi l'ultimo gradino e mifermai a riprendere fiato. La portaprincipale era socchiusa e una lama diluce si allungava fino ai miei piedi. Miavvicinai lentamente e mi arrestai sullasoglia. Dall'interno veniva un odore difiori morti. Bussai con le nocche allaporta e si socchiuse di qualchecentimetro. Davanti a me c'erano uningresso e un lungo corridoio che siaddentrava nella casa. Avvertii un suonosecco e ripetitivo, come quello diun'imposta sbattuta dal vento, cheproveniva da qualche luogo della casa ericordava il battito di un cuore. Avanzaipochi passi nell'ingresso e vidi alla miasinistra le scale che salivano alla torre.
Credetti di sentire dei passi leggeri,passi di bambino, sugli ultimi gradini.
«Buona sera...» chiamai.
Prima che l'eco della mia voce siperdesse lungo il corridoio, il suonopercussivo che pulsava in qualcheangolo della casa si fermò. Un silenzioassoluto calò attorno a me e una corrented'aria gelida mi accarezzò il volto.
«Signor Corelli? Sono Martín, DavidMartín...»
Non ottenendo risposta, mi avventurailungo il corridoio che portava nel cuoredella casa. Le pareti erano ricoperte diritratti fotografici in cornici di diverse
misure. Dalle pose e dai vestiti deisoggetti dedussi che la maggior parterisaliva almeno a venti o trent'anniprima. Sotto ogni cornice c'era unapiccola targa con il nome e l'anno in cuila foto era stata scattata. Stu-diai queivolti che mi osservavano da un altrotempo. Vecchi e bambini, uomini edonne. Li univa un'ombra di tristezzanello sguardo, un appello silenzioso.Tutti guardavano in macchina con unanelito che gelava il sangue.
«Le interessa la fotografia, Martín,amico mio?» disse la voce al miofianco.
Mi girai di soprassalto. Andreas Corelli
guardava le fotografie accanto a me conun sorriso che irradiava malinconia.Non l'avevo visto né sentito avvicinarsie quando mi sorrise provai un brivido.
«Credevo che non sarebbe venuto.»
«Anch'io.»
«Allora mi permetta di offrirle unbicchiere di vino per brindare ai nostrierrori.»
Lo seguii fino a una grande sala conampi finestroni orientati verso la città.Corelli mi fece cenno di accomodarmisu una poltrona e servì due bicchieri dauna bottiglia di cristallo che stava sopraun tavolo. Mi tese il bicchiere e si
sedette sulla poltrona di fronte alla mia.
Assaggiai il vino. Era eccellente. Lofinii quasi d'un sorso e ben presto sentiiche il calore che mi scendeva lungo lagola mi calmava i nervi. Corelliannusava il suo bicchiere e miosservava con un sorriso sereno eamichevole.
«Lei aveva ragione» dissi.
«Di solito ce l'ho» replicò Corelli. «Èun'abitudine che raramente mi dàqualche soddisfazione. A volte pensoche poche cose mi piacerebbero di piùdella certezza di essermi sbagliato.»
«Questo si risolve facilmente. Chieda a
me. Io mi sbaglio sempre.»
«No, non si sbaglia. Mi sembra che leiveda le cose chiaramente quanto me eche nemmeno lei ne ricavi alcunasoddisfazione.»
Ascoltandolo, mi venne in mente che inquel momento l'unica cosa in grado didarmi qualche soddisfazione sarebbestata dare fuoco al mondo intero ebruciarci dentro anch'io. Corelli, comese mi avesse letto nel pensiero, sorrisemostrando i denti e annuì.
«Io posso aiutarla, amico mio.»
Mi sorpresi a schivare il suo sguardoper concentrarmi sulla piccola spilla
con un angelo d'argento sul risvoltodella sua giacca.
«Carina, quella spilla» dissi,indicandola.
«Un ricordo di famiglia» spiegò Corelli.
Mi sembrò che ci fossimo scambiaticortesie e banalità sufficienti per tutta laserata.
«Signor Corelli, cosa ci faccio qui?»
I suoi occhi brillavano dello stessocolore del vino che ondeggiavalentamente nel suo bicchiere.
«È molto semplice. Lei è qui perché ha
finalmente capito che questo è il suoposto. È qui perché un anno fa le ho fattoun'offerta. Un'offerta che in quelmomento non era pronto ad accettare, mache non ha dimenticato. E
io sono qui perché continuo a pensareche lei sia la persona che cerco, e perquesto ho preferito aspettare dodici mesipiuttosto che soprassedere.»
«Un'offerta che non mi ha mai illustratonei dettagli» ricordai.
«In realtà, l'unica cosa che le ho fornitosono stati i dettagli.»
«Centomila franchi per lavorare un annointero per lei a scrivere un libro.»
«Esattamente. Molti avrebbero pensatoche questo era l'essenziale. Ma non lei.»
«Mi disse che quando mi avrebbespiegato che tipo di libro avrei dovutoscrivere per lei, l'avrei fatto anche senon mi pagava.»
Corelli annuì.
«Lei ha buona memoria.»
«Ho una memoria eccellente, signorCorelli, tanto che non ricordo di avervisto, letto o sentito parlare di nessunlibro pubblicato da lei.»
«Dubita della mia solvibilità?»
Negai cercando di dissimulare ildesiderio e l'avidità che mi rodevano.
Quanto più disinteresse mostravo, piùmi sentivo tentato dalle promessedell'editore.
«Semplicemente mi intrigano i suoimoventi» dichiarai.
«Com'è giusto.»
«In ogni caso le ricordo che ho uncontratto in esclusiva con Barrido edEscobillas per altri cinque anni. L'altrogiorno ho ricevuto una visita moltoeloquente da parte loro in compagnia diun avvocato dall'aria sbrigativa.
Però suppongo che faccia lo stesso,perché un lustro è un periodo di tempotroppo lungo, e se sono sicuro diqualcosa è che ciò che mi manca èproprio il tempo.»
«Non si preoccupi per gli avvocati. Imiei hanno un'aria infinitamente piùsbrigativa degli avvocati di quellacoppia di pustole e non perdono mai unacausa. Lasci a me i dettagli legali e ilitigi.»
Dal modo in cui sorrise pronunciandoquelle parole pensai che sarebbe statomeglio non avere mai un colloquio con iconsulenti legali delle Éditions de laLumière.
«Le credo. Immagino che a questo puntoresti aperta la questione degli altridettagli della sua offerta, quelliessenziali.»
«Non c'è un modo semplice di dirlo,perciò la cosa migliore sarà parlarlesenza remore.»
«La prego.»
Corelli si chinò in avanti e mi fissò.
«Martín, voglio che lei crei unareligione per me.»
All'inizio pensai di non aver sentitobene.
«Come dice?»
Continuò a fissarmi con quel suosguardo senza fondo.
«Ho detto che voglio che crei unareligione per me.»
Lo osservai per un lungo istante, muto.
«Mi sta prendendo in giro.»
Corelli negò, assaporando con gusto ilsuo vino.
«Voglio che convochi tutto il suo talentoe che si dedichi anima e corpo per unanno a lavorare alla storia più grandeche abbia mai creato: una religione.»
Non potei far altro che scoppiare aridere.
«Lei è completamente pazzo. È questa lasua offerta? È questo il libro che vuoleche scriva?»
Corelli annuì sereno.
«Ha sbagliato scrittore. Io non so nulladi religione.»
«Non si preoccupi di questo. Io sì. Noncerco un teologo. Cerco un narratore. Sacos'è una religione, Martín, amico mio?»
«A stento ricordo il Padre Nostro.»
«Una preghiera bella e ben fatta. Poesia
a parte, una religione è un codice moraleche si esprime mediante leggende, miti oqualunque tipo di arte-fatto letterario alfine di istituire un sistema di credenze,valori e norme con i quali regolare unacultura o una società.»
«Amen» replicai.
«Come per la letteratura o qualunqueatto comunicativo, a conferirle ef-ficaciaè la forma e non il contenuto» continuòCorelli.
«Mi sta dicendo che una dottrina inpratica è un racconto.»
«Tutto è racconto, Martín. Quello checrediamo, quello che conosciamo,
quello che ricordiamo e perfino quelloche sogniamo. Tutto è racconto,narrazione, una sequenza di eventi epersonaggi che comunicano un contenutoemotivo. Un atto di fede è un atto diaccettazione, accettazione di una storiache ci viene raccontata. Accettiamocome vero solo quello che può esserenarrato. Non mi dica che l'idea non latenta.»
«No.»
«Non la tenta creare una storia per laquale gli uomini siano capaci di vivere emorire, di uccidere e farsi uccidere, disacrificarsi e di condannar-si, di offrirela propria anima? Quale sfida più
grande per il suo mestiere che creareuna storia tanto potente da trascendere lafinzione e diventare verità rivelata?»
Ci guardammo in silenzio per diversisecondi.
«Credo che conosca già la mia risposta»dissi alla fine.
Corelli sorrise.
«Io sì. Credo che sia lei a nonconoscerla ancora.»
«Grazie per la compagnia, signorCorelli. E per il vino e i discorsi. Moltostimolanti. Stia attento a chi li rivolge.Le auguro di trovare il suo uomo e che il
pamphlet sia un gran successo.»
Mi alzai e mi preparai ad andarmene.
«L'aspettano da qualche parte, Martín?»
Non risposi, ma mi fermai.
«Non si prova rabbia quando si sa chepotrebbero esserci tante cose per cuivivere, ricchi e in salute, senzavincoli?» disse Corelli alle mie spalle.
«Non si prova rabbia quando glielestrappano dalle mani?»
Mi voltai lentamente.
«Cos'è un anno di lavoro di fronte alla
possibilità che tutto ciò che si desideradiventi realtà? Cos'è un anno di lavorodi fronte alla promessa di una lunga epiena esistenza?»
Niente, pensai dentro di me, miomalgrado. Niente.
«È questa la sua promessa?»
«Stabilisca lei il prezzo. Vuole darfuoco al mondo e bruciarci dentro anchelei? Facciamolo insieme. Fissi lei ilprezzo. Io sono disposto a darle quelloche più desidera.»
«Non so cos'è che desidero di più.»
«Io credo invece che lo sappia bene.»
L'editore sorrise e mi strizzò l'occhio. Sialzò e si avvicinò a un comò sul qualegiaceva una lampada. Aprì il primocassetto ed estrasse una busta di cartapergamena. Me la tese, ma nonl'accettai. La lasciò sul tavolo e sisedette di nuovo, senza dire una parola.La busta era aperta e al suo interno siintravedevano quelli che sembravanodiversi mazzetti di banconote da centofranchi. Una fortuna.
«Lei tiene tutto questo denaro in uncassetto e non chiude nemmeno laporta?» domandai.
«Può contarlo. Se le sembrainsufficiente, dica una cifra. Le ho già
detto che non avrei discusso di denarocon lei.»
Guardai quel tocco di fortuna per unlungo istante e alla fine scossi la testa.Almeno l'avevo visto. Era reale.L'offerta e la vanità che mi blandiva-noin quei momenti di miseria edisperazione erano reali.
«Non posso accettarlo» dissi.
«Crede sia denaro sporco?»
«Tutto il denaro è sporco. Se fossepulito, nessuno lo vorrebbe. Ma non èquesto il problema.»
«Allora?»
«Non posso accettarlo perché non possoaccettare la sua offerta. Non potreineanche se volessi.»
Corelli soppesò le mie parole.
«Posso chiederle perché?»
«Perché sto morendo, signor Corelli.Perché mi restano solo poche settimanedi vita, forse giorni. Perché non mirimane nulla da offrire.»
Corelli abbassò lo sguardo e sprofondòin un lungo silenzio. Sentii il ventograffiare le finestre e strisciare sopra lacasa.
«Non mi dica che non lo sapeva»
aggiunsi.
«Lo intuivo.»
Rimase seduto, senza guardarmi.
«Ci sono molti altri scrittori chepossono scrivere quel libro per lei,signor Corelli. Le sono riconoscente perla sua offerta. Più di quanto immagini.Buona notte.»
M'incamminai verso l'uscita.
«Diciamo che potrei aiutarla asconfiggere la sua malattia» disse.
Mi fermai a metà corridoio e mi voltai.Corelli era a due palmi da me e mifissava. Mi sembrò più alto di quandol'avevo visto per la prima volta nelcorridoio e che i suoi occhi fossero piùgrandi e scuri. Vidi il mio riflessorimpicciolire nelle sue pupille via viache si dilatavano.
«La inquieta il mio aspetto, amicoMartín?»
Deglutii.
«Sì» confessai.
«Per favore, torni in salotto e si sieda.Mi dia l'opportunità di spiegarle meglio.Cos'ha da perdere?»
«Nulla, credo.»
Mi mise la mano sul braccio condelicatezza. Aveva dita lunghe e pallide.
«Non ha nulla da temere da me, Martín.Sono suo amico.»
Il suo tocco era confortante. Mi lasciaiguidare di nuovo in salotto e mi sedettidocilmente, come un bambino cheaspetta le parole di un adulto.
Corelli si accovacciò accanto allapoltrona e posò lo sguardo sul mio. Mi
prese la mano e la strinse con forza.
«Lei vuole vivere?»
Volevo rispondere ma non trovai leparole. Mi resi conto di avere un nodoalla gola e gli occhi che si riempivanodi lacrime. Non avevo capito fi-
no ad allora quanto desiderassicontinuare a respirare, continuare adaprire gli occhi ogni mattina e poteruscire in strada per calpestare i ciottolie vedere il cielo e, soprattutto,continuare a ricordare.
Annuii.
«L'aiuterò, Martín, amico mio. Le
chiedo solo di avere fiducia in me.
Accetti la mia offerta. Lasci che l'aiuti.Lasci che le dia ciò che più desidera. Èquesta la mia promessa.»
Annuii di nuovo.
«Accetto.»
Corelli sorrise e si chinò su di me perbaciarmi sulla guancia. Aveva le labbrafredde come il ghiaccio.
«Io e lei, amico mio, faremo grandi coseinsieme. Vedrà» mormorò.
Mi offrì un fazzoletto per asciugarmi lelacrime. Lo feci senza provare la
vergogna muta di piangere di fronte a unestraneo, cosa che non facevo da quandoera morto mio padre.
«Lei è esausto, Martín. Resti qui per lanotte. In questa casa le stanzeabbondano. Le assicuro che domani sisentirà meglio e vedrà le cose piùchiaramente.»
Mi strinsi nelle spalle, anche se capiiche Corelli aveva ragione. A stento mireggevo in piedi e desideravo soltantodormire profondamente. Non mi civedevo a sollevarmi da quella poltrona,la più comoda e accogliente di tutte lepoltrone nella storia universale.
«Se non le dispiace, preferisco restare
qui.»
«Certo. La lascio riposare. Presto sisentirà meglio. Le do la mia parola.»
Si avvicinò al comò e spense la lampadaa gas. La stanza sprofondò in unapenombra azzurrata. Mi cadevano lepalpebre e una sensazione di u-briachezza mi inondava la testa, mariuscii a vedere il profilo di Corelliattraversare la stanza e svanirenell'ombra. Chiusi gli occhi e ascoltai ilsussurro del vento dietro i vetri.
25
Sognai che la casa affondava lentamente.All'inizio piccole lacrime d'acqua scura
iniziarono a spuntare dalle crepe dellemattonelle, dai muri, dalle increspaturedel soffitto, dai globi delle lampade, daibuchi delle serrature.
Era un liquido freddo che avanzava inmaniera lenta e pesante, come gocce dimercurio, e a poco a poco formava unmanto che ricopriva il pavimento erisaliva lungo le pareti. Sentii chel'acqua mi copriva i piedi e saliva rapi-
damente. Rimasi sulla poltrona, aosservare come il livello dell'acqua miarrivava alla gola e poi in pochi secondial soffitto. Avevo l'impressione digalleggiare e distinsi luci pallideondeggiare dietro i finestroni. Erano
figure umane sospese a loro volta inquella tenebra acquosa. Fluivanotrascina-te dalla corrente e allungavanole mani verso di me, ma io non potevoaiu-tarle e l'acqua le portava via senzarimedio. I centomila franchi di Corellifluttuavano attorno a me, oscillandocome pesci di carta. Attraversai ilsalotto e mi avvicinai a una porta chiusain fondo alla stanza. Un filo di lucetrapelava dalla serratura. Aprii la portae vidi che dava su una scalinata cheportava nelle profondità della casa.Scesi.
Alla fine delle scale si apriva una salaovale al cui centro si distingueva ungruppo di figure raccolte in circolo.
Quando avvertirono la mia presenza, sigirarono e vidi che vestivano di biancoe indossavano maschere e guanti. Intenseluci bianche ardevano su quello che miparve un lettino di sala operatoria. Unuomo il cui volto non aveva occhi nélineamenti metteva in ordine i pezzi suun vassoio di strumenti chirurgici. Unadelle figure mi tese la mano, invitandomia raggiungerla. Mi avvicinai e sentii chemi prendevano la testa e il corpo e misistemavano sul lettino. Le luci mi ac-cecavano, ma riuscii a vedere che tuttele figure erano identiche e avevano ilviso del dottor Trias. Risi in silenzio.Uno dei dottori aveva in mano unasiringa e mi fece un'iniezione nel collo.Non sentii nessuna puntura, solo una
piacevole sensazione di stordimento e dicalore che mi si spargeva per il corpo.Due dottori mi immobilizzarono la testasu un marchingegno e si-stemarono lacorona di viti che sosteneva una placcaimbottita all'estremità. Sentii che milegavano mani e piedi con delle cinghie.Non feci alcun tipo di resistenza.Quando fui completamenteimmobilizzato, uno dei dottori tese unbisturi a un suo gemello e quest'ultimo sichinò su di me. Sentii che qualcuno miafferrava la mano e me la teneva. Era unbambino che mi guardava con tenerezzae con la stessa espressione che avevoavuto io il giorno in cui avevano uccisomio padre.
Vidi la lama del bisturi discendere nellatenebra liquida e sentii che il metallo mifaceva un taglio sulla fronte. Non provaidolore. Sentii che qualcosa sisprigionava dal taglio e vidi una nubenera che sanguinava lentamente dallaferita e si spargeva nell'acqua. Il sanguesaliva a volute verso la luce, comefumo, e si contorceva in forme cangianti.Guardai il bambino, che mi sorrideva emi teneva forte la mano. Lo notai allora.Qualcosa si muoveva dentro di me.Qualcosa che appena un istante primastringeva come una tenaglia intorno allamia mente. Sentii che qualcosa siritraeva, come un ago conficcato fin nelmidollo che viene estratto con le pinze.
Provai panico e cercai di alzarmi, maero immobilizzato. Il bambino miguardava fisso e annuiva. Credetti diessere sul punto di svenire, o disvegliarmi, e allora lo vidi. Lo vidiriflesso nelle luci sopra il lettino. Unpaio di filamenti scuri spuntavano dallaferita, strisciandomi sulla pelle. Era unragno nero della grandezza di un pugno.Mi corse sulla faccia e, prima chepotesse saltare giù, uno dei chirurghil'infilzò con un bisturi. Lo sollevò allaluce perché potessi vederlo. Il ragnoagitava le zampe e sanguinava incontroluce. Una macchia candida glicopriva il carapace e suggeriva unasagoma dalle ali spiegate. Un angelo.Dopo un po', le zampe rimasero inerti e
il corpo si staccò dal bisturi. Restò afluttuare e quando il bambino alzò lamano per toccarlo si dissolse in polvere.I dottori mi sciolsero i legacci eallentarono il marchingegno che miattanagliava il cranio. Con l'aiuto deimedici, mi sollevai sul lettino e miportai la mano alla fronte. La ferita sistava richiudendo. Quando mi guardai dinuovo attorno, mi resi conto di esseresolo.
Le luci della sala operatoria si spenseroe la stanza rimase in penombra.
Tornai verso la scalinata e salii i gradiniche mi condussero di nuovo in salotto.La luce dell'alba filtrava nell'acqua e
catturava mille particelle insospensione. Ero stanco. Più stanco diquanto fossi mai stato in tutta la vita.
Mi trascinai fino alla poltrona e milasciai andare. Il mio corpo caddelentamente e quando alla fine fu a ripososulla poltrona vidi scie di piccole bolleche iniziavano a trotterellare sul soffitto.Una piccola camera d'aria si formò inalto e capii che il livello dell'acquacominciava a calare. L'acqua, densa ebrillante come gelatina, fuoriusciva afiotti dalle fessure delle finestre come sela casa fosse un sommergibile inemersione. Mi rannicchiai sullapoltrona, in preda a una sensazione dileggerezza e di pace che non avrei mai
più voluto abbandonare. Chiusi gli occhie ascoltai il mormorio dell'acqua attornoa me. Li riaprii e intravidi una pioggiadi gocce che cadevano molto lentamente,come lacrime che si potevano fermare alvolo.
Ero stanco, molto stanco e desideravosolo dormire profondamente.
Aprii gli occhi all'intenso chiarore di uncaldo mezzogiorno. La luce cadevacome polvere dai finestroni. La primacosa che notai fu che i centomila franchierano ancora sul tavolo. Mi alzai e miavvicinai alla finestra.
Feci scorrere le tende e un tentacolo dichiarore accecante invase la stanza.
Barcellona era sempre là, ondulantecome un miraggio provocato dal calore.Fu allora che mi resi conto che il sibiloalle orecchie, di solito masche-
rato dai rumori del giorno, eracompletamente scomparso. Sentii unsilenzio intenso, puro come acquacristallina, che non ricordavo di averemai sperimentato. Sentii me stessoridere. Mi portai le mani alla testa epalpai la pelle. Non avvertivo nessunapressione. La mia visione era chiara eavevo l'impressione che i cinque sensi sifossero appena risvegliati. Potei sentirenelle narici l'odore di legno vecchio delsoffitto a cassettoni. Cercai unospecchio, ma non ce n'era uno in tutta la
stanza. Uscii alla ricerca di un bagno odi un'altra stanza in cui trovare unospecchio per sincerarmi che non mi erorisvegliato nel corpo di un estraneo, chequella pelle che sentivo e quelle ossaerano mie. Tutte le porte di casa eranochiuse. Percorsi l'intero piano senzariuscire ad aprirne nemmeno una. Tornaiin salotto e verificai che dove avevosognato una porta che dava in cantinac'era solo un quadro con l'immagine diun angelo raccolto su se stesso soprauno scoglio che emergeva da un lagoinfinito. Mi diressi verso le scale chesalivano ai piani superiori, ma appenaimboccai la prima rampa mi fermai.
Un'oscurità pesante e impenetrabile
sembrava abitare al di là del punto incui il chiarore svaniva.
«Signor Corelli?» chiamai.
La mia voce si perse come se si fossescontrata con qualcosa di solido, senzaprovocare echi o riflessi. Tornai insalotto e guardai il denaro sul tavolo.Centomila franchi. Li presi e lisoppesai. La carta si lasciavaaccarezzare. Me li misi in tasca em'incamminai di nuovo per il corridoioche portava all'esterno. Le decine divolti dei ritratti continuavano aosservarmi con l'intensità di unapromessa. Preferii non affrontare queglisguardi e mi diressi all'uscita, ma
appena prima di raggiungerla notai chetra le cornici ce n'era una vuota, senzatarghetta né fotografia. Sentii un odoredolce e come di pergamena e mi resiconto che veniva dalle mie dita. Era ilprofumo dei soldi. Aprii la portaprincipale e uscii alla luce del giorno.La porta si richiuse pesantemente allemie spalle. Mi voltai per osservare lacasa, oscura e silenziosa, estranea alraggiante chiarore di quella giornata dicieli azzurri e sole splendente. Consultail'orologio e vidi che era l'una passata.
Avevo dormito più di dodici ore diseguito su una vecchia poltrona, etuttavia non mi ero mai sentito meglio intutta la vita. M'incamminai giù per la
collina di ritorno in città con il sorrisoin volto e la certezza che, per la primavolta in moltissimo tempo, forse per laprima volta nella mia vita, il mondo misorrideva.
ATTO SECONDO
Lux Aeterna
1
Festeggiai il mio ritorno nel mondo deivivi rendendo grazie in uno dei templipiù influenti della città: la sede centraledel Banco Hispano Colonial in calleFontanella. Alla vista dei centomilafranchi, il direttore, i funzionari e tuttoun esercito di cassieri e contabili
andarono in estasi e mi in-nalzarono aglialtari riservati a quei clienti cheispirano una devozione e una simpatiamolto prossime alla santità. Risoltal'incombenza della banca, decisi divedermela con un altro cavallodell'apocalisse e mi avvicinai aun'edicola di plaza Urquinaona. Apriipiù o meno alla metà una copia della
"Voz de la Industria" e cercai la sezionedi cronaca che una volta era stata la mia.La mano esperta di don Basilio siscorgeva ancora nei titoli e riconobbiquasi tutte le firme, come se il temponon fosse passato. I sei anni di blandadittatura del generale Primo de Riveraavevano regalato alla città una calma
velenosa e torbida che non faceva buongioco alle pagine di cronaca nera. Suigiornali cominciava appena a comparirequalche storia di bombe o di sparatorie.Barcellona, la temibile "Rosa di fuoco",cominciava ad assomigliare più chealtro a una pentola a pressione. Stavoper chiudere il giornale e ritirare il restoquando lo vidi. Era solo un trafiletto auna colonna con quattro notizieevidenziate nell'ultima pagina dicronaca.
UN INCENDIO A MEZZANOTTE ALRAVAL
PROVOCA UN MORTO E DUE FERITIGRAVI
Joan Marc Huguet / Redazione.Barcellona
Nella notte di venerdì si è verificato ungrave incendio al numero 6 di plaza delsAngels, nella sede della casa editriceBarrido ed Escobillas, nel quale haperso la vita il direttore dell'azienda, ilsignor José Barrido, e sono rimastigravemente feriti il suo socio, il signorJosé Luis López Escobillas, e ildipendente signor Ramón Guzmán,raggiunto dalle fiamme mentre cercavadi prestare aiuto ai due responsabilidella ditta. I pompieri ritengono che lacausa dell'incendio sia da attribuirsi allacombustione di una sostanza chimicaimpiegata per la ristrutturazione degli
uffici. Non si e-scludono per il momentoaltre cause, giacché testimoni oculari af-fermano di aver visto un uomo uscire dailocali un istante prima dello scoppiodell'incendio. Le vittime sono statetrasportate all'Hospital Clinic, dove unaè giunta cadavere e le altre due sonotuttora ricoverate con prognosi riservata.
Arrivai più in fretta che potei. La puzzadi bruciato si sentiva fin dalle Ramblas.Un gruppo di vicini e di curiosi si erariunito sulla piazza di fronte al palazzo.Fili di fumo bianco salivano da unmucchio di macerie accanto all'entrata.Riconobbi diversi impiegati della casaeditrice che cercavano di salvare tra lerovine il poco che era rimasto. Scatoloni
di libri bruciacchiati e mobili morsidalle fiamme si ammucchiavano instrada. La facciata era rimasta annerita,le finestre erano saltate per il fuoco.Attraversai il cerchio di guardoni edentrai. Un fetore intenso mi si appiccicòalla gola. Alcuni dipendenti della casaeditrice che si davano da fare perrecuperare le loro cose mi riconobberoe mi salutarono a testa bassa.
«Signor Martín... che disgrazia»mormoravano.
Attraversai quella che era stata lareception e mi diressi all'ufficio diBarrido. Le fiamme avevano divorato itappeti e ridotto i mobili a scheletri di
brace. Il soffitto a cassettoni era crollatoin un angolo, lasciando intravedere laluce che proveniva dal cortileposteriore. Un fascio intenso di cenerefluttuante attraversava la sala. Una sediaera sopravvissuta miracolo-samente alfuoco. Era al centro della stanza e visedeva la Veleno, che piangeva con losguardo sconsolato. Mi accovacciaidavanti a lei. Mi riconobbe e sorrise trale lacrime.
«Stai bene?» domandai.
Annuì.
«Mi aveva detto di andare a casa, sai?,mi aveva detto che era già tardi e chedovevo riposare perché oggi avremmo
avuto una giornata molto lunga.
Stavamo chiudendo la contabilità delmese... Se fossi rimasta un altrominuto...»
«Cos'è successo, Herminia?»
«Abbiamo lavorato fino a tardi. Eraquasi mezzanotte quando il signorBarrido mi ha detto di andarmene acasa. Gli editori stavano aspettando unsignore che doveva incontrarli...»
«A mezzanotte? Quale signore?»
«Uno straniero, credo. Aveva qualcosa ache fare con un'offerta, non so.
Sarei rimasta volentieri, ma era moltotardi e il signor Barrido mi ha detto...»
«Herminia, quel signore, ti ricordi ilnome?»
La Veleno mi guardò sorpresa.
«Tutto quello che ricordo l'ho giàraccontato all'ispettore che è venutostamattina. Mi ha chiesto di te.»
«Un ispettore? Di me?»
«Stanno parlando con tutti.»
«È chiaro.»
La Veleno mi fissava diffidente, come se
cercasse di leggermi nel pensiero.
«Non sanno se ne uscirà vivo»mormorò, riferendosi a Escobillas.«Abbiamo perso tutto, gli archivi, icontratti... Tutto. È la fine della casaeditrice.»
«Mi dispiace, Herminia.»
Un sorriso contorto e malizioso leaffiorò alle labbra.
«Ti dispiace? Non è quello che volevi?»
«Come puoi pensare una cosa delgenere?»
La Veleno mi guardò con sospetto.
«Adesso sei libero.»
Feci il gesto di toccarle il braccio, maHerminia si alzò e arretrò di un passo,come se la mia presenza le facessepaura.
«Herminia...»
«Vattene» disse.
La lasciai tra le rovine fumanti. Uscendoin strada m'imbattei in un gruppo diragazzini intenti a scavare tra i mucchidi macerie. Uno di loro avevadissotterrato un libro dalle ceneri e loesaminava con un misto di curiosità edisprezzo. La copertina era stata lambitadalle fiamme e il bordo delle pagine era
annerito, ma per il resto il libro eraintatto. Riconobbi dall'incisione suldorso che si trattava di una delle puntatedella Città dei maledetti.
«Signor Martín?»
Mi voltai e mi trovai di fronte tre uominiagghindati con vestiti in saldo inadatti alcaldo umido e appiccicoso chealeggiava nell'aria. Uno di loro, chesembrava il capo, avanzò di un passo emi rivolse un sorriso cordiale, davenditore esperto. Gli altri due, cheparevano avere la costituzione e iltemperamento di una pressa idraulica, silimitarono a fissarmi con uno sguardoapertamente ostile.
«Signor Martín, sono l'ispettore VíctorGrandes e questi sono i miei colleghi,gli agenti Marcos e Castelo. Midomando se può essere tanto cortese dadedicarci pochi minuti.»
«Naturalmente» risposi.
Il nome di Víctor Grandes lo ricordavodagli anni trascorsi in cronaca.
Vidal gli aveva dedicato qualchearticolo e me ne venne in mente inparticolare uno in cui lo definiva larivelazione della polizia, una validarisorsa che confermava l'arrivo nelleforze dell'ordine di una nuovagenerazione di professionisti d'élite conuna formazione migliore dei loro
predecessori, incorruttibili e duri comel'acciaio. Gli aggettivi e l'iperbole eranodi Vidal, non miei. Immaginai che daallora l'ispettore Grandes non avessefatto altro che scalare gerarchie nelcomando, e che la sua presenza lìrivelava che il corpo prendeva sul seriol'incendio degli uffici di Barrido edEscobillas.
«Se non le spiace, possiamo andare inun caffè per parlare senza essereinterrotti» disse Grandes senzaammainare di una virgola il sorriso diservizio.
«Come preferisce.»
Grandes mi condusse in un piccolo bar
all'angolo tra calle Doctor Dou e callePintor Fortuny. Marcos e Castelocamminavano alle nostre spalle, senzatogliermi gli occhi di dosso. Grandes mioffrì una sigaretta, che rifiutai. Rimisevia il pacchetto. Non aprì bocca finquando non arrivammo al caffè e i tre miscortarono fino a un tavolino sul fondodove si appostarono intorno a me. Se miavessero portato in una cella buia eumida, l'incontro mi sarebbe sembratopiù amichevole.
«Signor Martín, credo che sia aconoscenza di quanto è accaduto questanotte.»
«So solo quello che ho letto sul
giornale. E quello che mi ha raccontatola Veleno...»
«La Veleno?»
«Mi scusi. La signorina HerminiaDuaso, la segretaria di direzione.»
Marcos e Castelo si scambiarono unosguardo impagabile. Grandes sorrise.
«Interessante soprannome. Mi dica,signor Martín, dove si trovava ierinotte?»
Beata ingenuità, la domanda mi colse disorpresa.
«È una domanda di routine» chiarì
Grandes. «Stiamo cercando di stabiliregli spostamenti di tutte le persone chepotrebbero avere avuto rapporti con levittime negli ultimi giorni. Impiegati,fornitori, familiari, conoscen-ti...»
«Ero con un amico.»
Appena aprii bocca mi pentii dellascelta delle parole. Grandes lo notò.
«Un amico?»
«Più che di un amico, si tratta di unapersona con cui ho rapporti di lavoro.Un editore. Ieri sera avevo unappuntamento con lui.»
«Potrebbe dire fino a che ora è rimasto
con questa persona?»
«Fino a tardi. In effetti, ho finito perpassare la notte a casa sua.»
«Capisco. E la persona con cui dice diavere rapporti di lavoro si chiama?»
«Corelli. Andreas Corelli. Un editorefrancese.»
Grandes annotò il nome su un piccoloquaderno.
«Il cognome sembrerebbe italiano»commentò.
«A dire il vero non so con esattezzaquale sia la sua nazionalità.»
«È comprensibile. E questo signorCorelli, qualunque sia la sua cittadi-nanza, potrebbe confermare che ieri serasi trovava con lei?»
Mi strinsi nelle spalle.
«Suppongo di sì.»
«Lo suppone?»
«Ne sono sicuro. Perché non dovrebbefarlo?»
«Non lo so, signor Martín. C'è qualchemotivo per cui lei crede che non lofarebbe?»
«No.»
«Argomento chiuso, allora.»
Marcos e Castelo mi guardavano comese da quando ci eravamo seduti miavessero sentito pronunciare solofrottole.
«Per finire, potrebbe chiarirmi la naturadell'incontro di ieri sera tra lei e questoeditore di nazionalità imprecisata?»
«Il signor Corelli mi aveva datoappuntamento per formularmiun'offerta.»
«Che genere di offerta?»
«Professionale.»
«Capisco. Scrivere un libro, forse?»
«Esattamente.»
«Mi dica, è sua abitudine, dopo unariunione di lavoro, fermarsi a dormire incasa della, diciamo, parte contraente?»
«No.»
«Però mi ha detto che è rimasto adormire al domicilio di questo editore.»
«Mi sono fermato perché non mi sentivobene e non credevo di poter arrivare acasa.»
«Le ha forse fatto male la cena?»
«Ho avuto qualche problema di saluteultimamente.»
Grandes annuì con aria costernata.
«Nausee, mal di testa...» completai.
«Ma è ragionevole presumere cheadesso sta meglio?»
«Sì. Molto meglio.»
«Me ne rallegro. Di sicuro ha un aspettoinvidiabile. Non è così?»
Castelo e Marcos annuirono lentamente.
«Chiunque direbbe che lei si sia tolto ungran peso di dosso» osservò l'ispettore.
«Non la seguo.»
«Mi riferisco alle nausee e ai disturbi.»
Grandes conduceva quella farsa con undominio del tempo esasperante.
«Scusi la mia ignoranza riguardo aidettagli del suo ambito professionale,signor Martín, ma lei non avevasottoscritto un contratto con i due editoriche sarebbe scaduto fra sei anni?»
«Cinque.»
«E questo contratto non la legava inesclusiva, per così dire, alla casaeditrice di Barrido ed Escobillas?»
«Questi erano i termini.»
«Allora, per quale motivo lei avrebbedovuto discutere un'offerta con unconcorrente se il suo contratto leimpediva di accettarla?»
«Era una semplice conversazione.Niente di più.»
«Che tuttavia si è trasformata in unanottata nel domicilio di questo signore.»
«Il mio contratto non mi impedisce diparlare con terzi. E nemmeno di passarela notte fuori casa. Sono libero didormire dove voglio e parlare di quelloche voglio con chi voglio.»
«Certamente. Non volevo insinuare ilcontrario, ma grazie per avermi chiaritoquesto punto.»
«Posso chiarirle qualcos'altro?»
«Solo un dettaglio. Nell'ipotesi che,defunto il signor Barrido e che, Dio nonvoglia, il signor Escobillas non sirimettesse dalle ferite e morisse anchelui, la casa editrice verrebbe sciolta ecosì pure il suo contratto. Mi sbaglio?»
«Non ne sono sicuro. Non soesattamente in che regime era costituital'impresa.»
«Ma secondo lei è probabile cheandrebbe così?»
«È possibile. Dovrebbe chiederloall'avvocato degli editori.»
«Difatti gliel'ho già chiesto. E mi haconfermato che, se accadesse quello chenessuno vuole che accada e il signorEscobillas passasse a miglior vita,andrebbe proprio così.»
«Allora lei ha già la sua risposta.»
«E lei piena libertà di accettare l'offertadel signor...»
«Corelli.»
«Mi dica, l'ha già accettata?»
«Posso chiederle cosa c'entra questo con
le cause dell'incendio?» sbottai.
«Niente. Semplice curiosità.»
«È tutto?» chiesi.
Grandes guardò i suoi colleghi e poi me.
«Per parte mia, sì.»
Accennai ad alzarmi. I tre poliziottirimasero incollati ai loro posti.
«Signor Martín, prima che midimentichi» disse Grandes. «Può confer-marmi se ricorda che una settimana fa isignori Barrido ed Escobillas le hannofatto visita al suo domicilio al numero30 di calle Flassaders in compagnia del
succitato avvocato?»
«L'hanno fatto.»
«Si trattava di una visita d'affari o dicortesia?»
«Gli editori sono venuti a esprimermi illoro desiderio che ritornassi a lavorarea una serie di libri che avevoaccantonato per dedicare qualche mese aun altro progetto.»
«Definirebbe la conversazione comecordiale e distesa?»
«Non ricordo che nessuno abbia alzatola voce.»
«E ricorda di aver risposto, citotestualmente, "tra una settimana saretemorti"? Senza alzare la voce,naturalmente.»
Sospirai.
«Sì» ammisi.
«A cosa si riferiva?»
«Ero arrabbiato e ho detto la prima cosache mi è passata per la testa, ispettore.Questo non significa che parlassi sulserio. A volte si dicono cose che non sipensano.»
«Grazie per la sua sincerità, signorMartín. Ci è stato di grande aiuto.
Buona giornata.»
Me ne andai con i tre sguardi conficcaticome pugnali nella schiena e la certezzache se avessi risposto a ogni domandadell'ispettore con una men-zogna non misarei sentito così colpevole.
2
Il cattivo sapore in bocca lasciatomidall'incontro con Víctor Grandes e lacoppia di basilischi che si portavadietro come scorta durò soltanto percento metri di passeggiata al sole,mentre camminavo in un corpo che astento riconoscevo: forte, senza dolorené nausea, senza sibili alle orecchie néfitte di agonia nel cranio, senza fatica né
sudori freddi. Senza alcuna memoriadella certezza di una morte sicura che miasfissiava appena ventiquattr'ore prima.Qualcosa mi diceva che la tragediaaccaduta quella notte, inclusa la morte diBarrido e il probabile decesso diEscobillas, avrebbe dovuto riempirmi didispiacere e di angoscia, ma né io né lamia coscienza fummo in grado diprovare qualcosa che andasse oltre lapiù piacevole indifferenza. Quellamattina di luglio le Ramblas erano unafesta e io il loro principe.
Passeggiando, mi ritrovai dalle parti dicalle Santa Ana, con l'idea di fare unavisita a sorpresa al signor Sempere.Quando entrai nella libreria, Sempere
padre era dietro il bancone a cercare difar quadrare i conti mentre suo figlio siera arrampicato su una scala e stavariordinando gli scaffali. Vedendomi, illibraio mi rivolse un sorriso cordiale emi resi conto che, per un istante, non miaveva riconosciuto. Un secondo dopo glisi cancellò il sorriso dalla faccia e, abocca aperta, fece il giro del banconeper abbrac-ciarmi.
«Martín? È lei? Santa Madre di Dio...Ma è irriconoscibile! Ero preoc-cupatissimo. Siamo stati diverse volte acasa sua, ma lei non rispondeva.
Ho chiesto negli ospedali e neicommissariati.»
Il figlio restò a guardarmi dall'alto dellascala, incredulo. Dovetti ricor-darmiche appena una settimana prima miavevano visto in uno stato che non avevanulla da invidiare agli inquilinidell'obitorio del quinto distretto.
«Mi dispiace avervi fatto preoccupare.Mi sono assentato qualche giorno permotivi di lavoro.»
«Ma allora? Mi ha dato retta ed è andatodal medico, vero?»
Annuii.
«Alla fine era una sciocchezza.Problemi di pressione. Un ricostituenteper qualche giorno e sono tornato come
nuovo.»
«Poi mi dice il nome del ricostituente,magari mi ci faccio una doccia...
Che piacere e che sollievo vederlacosì!»
L'euforia si esaurì rapidamente quandopiombò tra di noi la notizia del giorno.
«Ha sentito di Barrido ed Escobillas?»chiese il libraio.
«Vengo da lì. Si fa fatica a crederci.»
«Chi l'avrebbe detto? Non che miispirassero simpatia, ma da qui a unacosa del genere... E mi dica, tutto
questo, per lei, sul piano legale, checon-seguenze ha? Scusi la brutalità delladomanda.»
«A dire il vero non lo so. Credo che idue soci fossero i titolari della società.Ci saranno eredi, immagino, ma seentrambi vengono a mancare la societàin quanto tale potrebbe essere sciolta. Eanche il mio contratto con loro. Almenocredo.»
«Vale a dire che, se anche Escobillas,che Dio mi perdoni, crepa, lei è un uomolibero.»
Annuii.
«Bel dilemma...» mormorò il libraio.
«Sia fatta la volontà di Dio» azzardai.
Sempere annuì, ma notai che qualcosa intutta quella faccenda lo inquie-tava epreferiva cambiare argomento.
«Insomma. Comunque, mi viene afagiolo che sia passato di qui perchévolevo chiederle un favore.»
«Lo consideri già fatto.»
«L'avverto che non le piacerà.»
«Se mi piacesse non sarebbe un favore,sarebbe un piacere. E se il favore è perlei, lo sarà.»
«In realtà non è per me. Glielo spiego e
lei decide. Senza impegno, d'accordo?»
Sempere si appoggiò sul bancone eadottò l'espressione affabulatoria che mirievocava tanti ricordi d'infanzia legati aquel negozio.
«È per una ragazza, Isabella. Deve averediciassette anni. Sveglia come la fame.Viene sempre qui e le presto dei libri.Mi dice che vuole diventare scrittrice.»
«La storia non mi è nuova» dissi.
«Fatto sta che una settimana fa mi halasciato uno dei suoi racconti, niente,venti o trenta pagine, e mi ha chiesto unparere.»
«E allora?»
Sempere abbassò il tono, come se miraccontasse una confidenza vinco-lata aun segreto istruttorio.
«Magistrale. Meglio del novantanoveper cento delle cose che ho vistopubblicare negli ultimi vent'anni.»
«Spero che mi conti nel rimanente unoper cento o la mia vanità si sentiràcalpestata e pugnalata a tradimento.»
«Proprio lì andavo a parare. Isabellal'adora.»
«Mi adora? Me?»
«Sì, come se fosse la Vergine diMontserrat e il Bambin Gesù allo stessotempo. Si è letta La città dei maledettidieci volte e quando le ho dato I passidel cielo mi ha detto che se lei fossecapace di scrivere un libro cosìpotrebbe morire tranquilla.»
«Questo mi sa di trappola.»
«Sapevo che avrebbe svicolato.»
«Non svicolo. Non mi ha detto in cosaconsiste il favore.»
«Se lo può immaginare.»
Sospirai. Sempere schioccò la lingua.
«Le ho detto che non le sarebbepiaciuto.»
«Mi chieda un'altra cosa.»
«Deve solo parlare con lei. Darlecoraggio, consigli... Ascoltarla, leggerequalche cosa e orientarla. Non le costeràtanto. Il cervello di quella ragazza èveloce come una pallottola. Le piaceràda matti. Diventerete amici. E puòlavorare come sua assistente.»
«Non ho bisogno di un'assistente. Emeno che mai sconosciuta.»
«Sciocchezze. E poi, conoscerla, già laconosce. O almeno, così dice lei.
Sostiene di conoscerla da anni, ma chesicuramente lei non si ricorda. A quantopare, quei due sempliciotti dei suoigenitori sono convinti che la faccendadella letteratura la condanneràall'inferno o a una zitellaggine laica esono indecisi se mandarla in convento ofarla sposare con qualche cretino che lefaccia scodellare otto figli e laseppellisca per sempre tra pento-le epadelle. Se lei non fa qualcosa persalvarla, è l'equivalente di un assas-sinio.»
«Non drammatizzi, signor Sempere.»
«Guardi, non gliel'avrei chiesto perchéso che lei è portato all'altruismo come
per ballare la sardana, però ogni voltache vedo quella ragazza entrare qui eguardarmi con quegli occhietti chesprizzano intelligenza ed entusiasmo epenso all'avvenire che l'aspetta mi sispezza il cuore. Quello che potevoinsegnarle gliel'ho già insegnato. Laragazza impara in fretta, Martín. Se miricorda qualcuno, è lei da ragazzo.»
Sospirai.
«Isabella e poi?»
«Gispert. Isabella Gispert.»
«Non la conosco. Mai sentito questonome. Le hanno raccontato una frottola.»
Il libraio scosse la testa.
«Isabella ha detto che lei avrebberisposto esattamente così.»
«Piena di talento e anche indovina. Ecos'altro le ha detto?»
«Sospetta che lei sia molto meglio comescrittore che come persona.»
«Un tesoro, questa Isabelita.»
«Posso dirle di venire a trovarla? Senzaimpegno?»
Mi arresi e annuii. Sempere sorrisetrionfante e voleva sigillare il patto conun abbraccio, ma mi diedi alla fuga
prima che il vecchio libraio potessecompletare la sua missione di cercare difarmi sentire una brava persona.
«Non se ne pentirà, Martín» gli sentiidire mentre uscivo.
3
Arrivando a casa, trovai l'ispettoreVíctor Grandes seduto sulle scalenell'atrio che si gustava con calma unasigaretta. Quando mi vide, sorrise conquella grazia da attore d'avanspettacolo,come se fosse un vecchio amico in visitadi cortesia. Mi sedetti accanto a lui e mioffrì il portasigarette aperto. Gitanes,notai. Accettai.
«E Hansel e Gretel?»
«Marcos e Castelo non sono potutivenire. Abbiamo avuto una soffiata esono andati a prendere un vecchioconoscente al Pueblo Seco cheprobabilmente aveva bisogno di un po'di persuasione per rinfrescare lamemoria.»
«Povero diavolo.»
«Se avessi detto che venivo da lei,sarebbero corsi. La trovano simpati-cissimo.»
«Un autentico colpo di fulmine, l'honotato. Cosa posso fare per lei,ispettore? Gradisce un caffè di sopra?»
«Non oserei invadere la sua intimità,signor Martín. In realtà volevo solodarle la notizia di persona prima che lasapesse da altri.»
«Che notizia?»
«Escobillas è morto nelle prime ore diquesto pomeriggio al Clinic.»
«Dio. Non lo sapevo» dissi.
Grandes si strinse nelle spalle econtinuò a fumare in silenzio.
«C'era da immaginarselo. Cosa cipossiamo fare?»
«È riuscito ad appurare qualcosa sulle
cause dell'incendio?» domandai.
L'ispettore mi guardò a lungo e poiannuì.
«Tutto sembra indicare che qualcuno haversato della benzina addosso al signorBarrido e gli ha dato fuoco. Le fiammesi sono propagate quando lui, in preda alpanico, ha cercato di fuggire dal suoufficio. Il socio e l'altro dipendenteaccorso in suo aiuto sono stati avvoltidal fuoco.»
Deglutii. Grandes sorrisetranquillizzante.
«Mi diceva poco fa l'avvocato deglieditori che, visto il vincolo personale
presente nel testo sottoscritto con loro,al decesso degli editori il contrattoviene sciolto, anche se gli eredimantengono i diritti sulla sua opera giàpubblicata. Suppongo che le scriveràuna lettera per informarla, ma ho pensatoche le sarebbe piaciuto saperlo prima,nel caso debba prendere una decisionesull'offerta di quell'editore di cui mi haparlato.»
«Grazie.»
«Di nulla.»
Grandes finì la sigaretta e gettò ilmozzicone a terra. Mi sorrise affabil-mente e si alzò. Mi diede una paccasulla spalla e si allontanò in direzione di
calle Princesa.
«Ispettore?» chiamai.
Grandes si fermò e si voltò.
«Lei non penserà...»
L'ispettore mi rivolse un sorriso triste estanco.
«Si riguardi, Martín.»
Me ne andai a dormire presto e misvegliai di colpo credendo che fosse giàil giorno successivo, per scoprire subitodopo che era da poco passatamezzanotte.
In sogno avevo visto Barrido edEscobillas imprigionati nel loro ufficio.
Le fiamme risalivano lungo i vestiti finoa ricoprire ogni centimetro dei lorocorpi. Sotto gli indumenti, la pellecadeva a brandelli e gli occhi iniettati dipanico si spaccavano a causa del fuoco.I loro corpi sussultavano in spa-smi diagonia e terrore fino ad abbattersi tra lemacerie, mentre la carne si staccavadalle ossa come cera fusa e formava aimiei piedi una pozzanghera fumante,nella quale vedevo riflesso il mio stessovolto sorridente che spegneva con unsoffio il fiammifero che avevo tra ledita.
Mi alzai per bere un bicchier d'acqua e,convinto di avere ormai perso il trenodel sonno, salii nello studio e tirai fuoridal cassetto della scrivania il librosalvato dal Cimitero dei LibriDimenticati. Accesi la lampada e neregolai il braccio per dirigere la luceesattamente sul libro. Lo aprii alla primapagina e iniziai a leggere.
Lux Aeterna
D.M.
A prima vista, il libro conteneva unaraccolta di testi e preghiere che nonaveva alcun senso. Si trattava di unoriginale, una manciata di paginedattiloscritte e rilegate in pelle senza
eccessiva cura. Continuai a leggere edopo un po' mi sembrò di intuire uncerto metodo nella sequenza di eventi,canti e riflessioni disseminati nel testo.Il linguaggio aveva una sua particolarecadenza, e quella che all'iniziosembrava una completa assenza distruttura o di stile a poco a poco svelavaun canto ipnotico che penetrava nellettore immergendolo in uno stato tra ilsopore e l'oblio. La stessa cosaaccadeva con il contenuto, il cui assecentrale non emergeva finché non ci siera ben addentrati nella prima sezione, ocanto, giacché l'opera pareva strutturataalla maniera dei vecchi poemi compostiin epoche in cui il tempo e lo spazioscorrevano a loro libero arbitrio. Mi
resi allora conto che quel Lux Aeternaera, in mancanza di altre parole, unaspecie di libro dei morti.
Passate le prime trenta o quaranta paginedi inutili giri di parole ed e-nigmi, ci siaddentrava in un preciso e stravaganterompicapo di orazioni e supplichesempre più inquietanti in cui la morte,descritta in versi dalla dubbia metrica avolte come un angelo bianco con gliocchi da rettile e altre come un bambinoluminoso, era presentata come unadivinità unica e onnipresente che simanifestava nella natura, nel desiderio enella fragilità dell'esistenza.
Chiunque fosse quell'enigmatico D.M.,
nei suoi versi la morte si dispiegavacome una forza vorace ed eterna. Unacommistione bizantina di riferimenti adistinte mitologie di paradisi e averni sidisponeva qui su un unico piano.Secondo D.M. c'erano solo un principioe una fine, un solo creatore e distruttoreche si presentava con diversi nomi perconfondere gli uomini e mettere allaprova la loro debolezza, un unico Dio ilcui vero volto era diviso in due metà:una, dolce e compassionevole; l'altra,crudele e demoniaca.
Questo è quanto riuscii a dedurre,perché al di là di tali princìpi l'autoresembrava aver perso il filo della suanarrazione e a stento era possibile
decifrare i riferimenti e le immagini chepopolavano il testo a mo' di visioniprofetiche. Tempeste di sangue e difuoco che precipitavano su città evillaggi. Eserciti di cadaveri in uniformeche percorrevano pianure infinitecancellando ogni traccia di vita al loropassaggio. Neonati impiccati conbrandelli di bandiere alle porte dellefortezze. Mari oscuri dove migliaia dianime in pena fluttuavano sospese perl'eternità in acque gelide e avvelena-te.Nubi di cenere e oceani di ossa e carnein putrefazione infestati di insetti eserpenti. La successione di immaginiinfernali e nauseabonde continuava finoalla sazietà.
A mano a mano che sfogliavo ilmanoscritto, avevo la sensazione dipercorrere passo dopo passo la mappadi una mente malata e incrinata. Rigodopo rigo, l'autore di quelle pagineaveva documentato senza saperlo la suadiscesa in un abisso di follia. La terza eultima parte del libro mi sembrò untentativo di ripercorrere il camminoall'indietro, un urlo disperato dalla celladella sua pazzia per sfuggire al labirintodi gallerie che gli aveva sca-vato nellamente. Il testo moriva a metà frase diuna supplica, una soluzione di continuitàinspiegabile.
Arrivato a quel punto, mi cadevano lepalpebre dal sonno. Dalla finestra mi
giunse una brezza leggera che veniva dalmare e spazzava via la nebbia dai tetti.Stavo per chiudere il libro quandoavvertii che qualcosa era rimastoingorgato nel filtro della mia mente,qualcosa che aveva a che fare con icaratteri tipografici di quelle pagine.Tornai all'inizio e cominciai a rie-saminare il testo. Trovai la primaoccorrenza al quinto rigo. A partire da lìlo stesso segno compariva ogni due o trerighi. Una delle lettere, la S ma-iuscola,era sempre leggermente inclinata versodestra. Presi un foglio bianco dalcassetto e lo infilai nel rullo dellaUnderwood sulla mia scrivania. Scrissiuna frase a caso.
Suonano le campane di Santa Maria delMar.
Estrassi il foglio e lo esaminai bene allaluce della lampada.
Suonano... di Santa Maria
Sospirai. Lux Aeterna era stato scrittocon quella stessa macchina per scriveree, immaginai, probabilmente a quellastessa scrivania.
4
Il mattino dopo scesi a far colazione inun bar di fronte alle porte di SantaMaria del Mar. Il quartiere del Born erazeppo di carri e persone che si recavano
al mercato e di commercianti e venditoriall'ingrosso che aprivano i negozi. Misedetti a un tavolino all'aperto e ordinaiun caffellatte. Una copia della"Vanguardia" era rimasta orfana sultavolino di fianco e la adottai. Mentregli occhi scivolavano su titoli e sommarinotai che una figura saliva la scalinatafino all'entrata della cattedrale e sisedeva sull'ultimo gradino perosservarmi senza farsi notare. Laragazza doveva avere sedici odiciassette anni e fingeva di prendereappunti su un quaderno mentre milanciava occhiate furtive. Degustai concalma il caffellatte. Dopo un po'
feci segno al cameriere di avvicinarsi.
«Vede quella signorina seduta sullaporta della chiesa? Le dica di ordinarequello che vuole, offro io.»
Il cameriere annuì e si diresse verso dilei. Vedendolo avvicinarsi, la ragazzaaffondò la testa nel quaderno e assunseun'espressione di assolutaconcentrazione che mi strappò unsorriso. Il cameriere le si fermò davantie tossicchiò. Lei alzò gli occhi dalquaderno e lo guardò. Il cameriere lespiegò la propria missione e finì perindicarmi. La ragazza, allarmata, milanciò uno sguardo. La salutai con lamano. Le si accesero le guance comebraci. Si alzò e si avvicinò al tavolo apassi corti e lo sguardo fisso sui piedi.
«Isabella?» domandai.
La ragazza alzò lo sguardo e sospirò,infastidita con se stessa.
«Come fa a saperlo?» chiese.
«Intuizione sovrannaturale» risposi.
Mi diede la mano e gliela strinsi senzaentusiasmo.
«Posso sedermi?» domandò.
Prese posto senza attendere la miarisposta. Per mezzo minuto la ragazzacambiò posizione almeno sei volte perpoi riprendere quella iniziale. Io laosservavo con calma e calcolato
disinteresse.
«Non si ricorda di me, vero, signorMartín?»
«Dovrei?»
«Per anni le ho portato la spesa da CanGispert ogni settimana.»
L'immagine della bambina che per tuttoquel tempo mi aveva portato la spesadal negozio mi tornò alla memoria e sidiluì nel viso più adulto e leggermentepiù spigoloso di quella Isabella, donnadalle forme morbide e dallo sguardod'acciaio.
«La bambina delle mance» dissi, anche
se della bambina restava poco o nulla.
Isabella annuì.
«Mi sono sempre chiesto cosa ci facevicon tutte quelle monete.»
«Compravo libri da Sempere e Figli.»
«Se l'avessi saputo...»
«Se la disturbo, me ne vado.»
«Non mi disturbi. Prendi qualcosa?»
La ragazza rifiutò.
«Il signor Sempere dice che hai talento.»
Isabella si strinse nelle spalle e mirestituì un sorriso scettico.
«Per norma generale, quanto più talentosi ha, più si dubita di averlo»
dissi. «E viceversa.»
«Allora io devo essere un prodigio»ribatté Isabella.
«Benvenuta nel club. Dimmi, cosa possofare per te?»
La ragazza inspirò a fondo.
«Il signor Sempere mi ha detto che forselei poteva leggere qualcosa di mio edarmi il suo parere e qualche
consiglio.»
La guardai negli occhi per alcunisecondi ma non risposi. Lei sostenne ilmio sguardo senza battere ciglio.
«Questo è tutto?»
«No.»
«Mi pareva. Qual è il capitolo due?»
Isabella esitò solo un istante.
«Se le piace quello che legge e credeche io abbia delle possibilità, vorreichiederle di permettermi di essere la suaassistente.»
«Cosa ti fa supporre che ho bisogno diun'assistente?»
«Posso mettere in ordine le sue carte,battere a macchina, correggere errori eimperfezioni...»
«Errori e imperfezioni?»
«Non volevo insinuare che lei commettaerrori...»
«Cosa volevi insinuare, allora?»
«Niente. Però quattro occhi vedonosempre meglio di due. E poi possooccuparmi della corrispondenza,recapitare messaggi, aiutarla a cercaredocumentazione. In più, so cucinare e
posso...»
«Mi stai chiedendo un posto daassistente o da cuoca?»
«Le sto chiedendo un'opportunità.»
Isabella abbassò lo sguardo. Non riusciia trattenere un sorriso. Quella curiosacreatura mi risultava simpatica, miomalgrado.
«Facciamo una cosa. Portami le ventipagine migliori che hai scritto, quelleche secondo te mostrano il meglio chesai fare. Non una di più, perché non cipenso nemmeno, a leggerla. Me leguardo con calma e, a seconda dei casi,ne parliamo.»
Le s'illuminò il viso e per un istante quelvelo di durezza e di tensione cheirrigidiva la sua espressione svanì.
«Non se ne pentirà» disse.
Si alzò e mi guardò nervosa.
«Va bene se gliele porto a casa?»
«Lasciamele nella cassetta della posta.È tutto?»
Annuì ripetutamente e arretrò con queipassi corti e nervosi che la sostenevano.Quando fu sul punto di girarsi e mettersia correre la chiamai.
«Isabella?»
Mi guardò sollecita, lo sguardoannuvolato da un'improvvisainquietudine.
«Perché io?» chiesi. «E non mi direperché sono il tuo autore preferito e tuttele lusinghe con cui Sempere ti haconsigliato di insaponarmi, altrimentiquesta sarà la nostra prima e ultimaconversazione.»
Isabella esitò un istante. Mi rivolse unosguardo nudo e rispose senza riguardi.
«Perché lei è l'unico scrittore checonosco.»
Mi sorrise impacciata e partì con il suoquaderno, il suo passo incerto e la sua
sincerità. La osservai girare l'angolo dicalle Mirallers e perdersi dietro lacattedrale.
5
Tornando a casa appena un'ora dopo, mela ritrovai seduta nell'atrio ad aspettarecon quello che immaginai fosse il suoracconto fra le mani.
Quando mi vide, si alzò e si sforzò disorridere.
«Ti avevo detto di lasciarmelo nellacassetta» dissi.
Isabella annuì e si strinse nelle spalle.
«Per ringraziarla, le ho portato un po' dicaffè dal negozio dei miei. Ècolombiano. Buonissimo. Non entravanella cassetta e ho pensato che erameglio aspettarla.»
Quella scusa poteva venire in mentesolo a una romanziera in erba. Sospiraie aprii la porta.
«Dentro.»
Salii le scale con Isabella che miseguiva di qualche gradino come uncagnolino.
«Ci mette sempre tanto a fare colazione?Non che mi riguardi, è chiaro, ma vistoche ero qui ad aspettare da quasi tre
quarti d'ora ho cominciato apreoccuparmi, cioè, non sarà che gli èandato qualcosa di traverso, per unavolta che incontro uno scrittore in carnee ossa, con la mia fortuna non sarebbestrano se un'oliva gli va di traverso, e lìfinisce la mia carriera letteraria»mitragliò la ragazza.
Mi fermai a metà della scala e laguardai con l'espressione più ostile cheriuscii a trovare.
«Isabella, se vogliamo far funzionare lecose tra di noi, dovremo stabilire unaserie di regole. La prima è che ledomande le faccio io e tu ti limiti arispondere. Quando non ci sono
domande da parte mia, da te nonverranno né risposte né discorsispontanei. La seconda regola è che io,per fare colazione o merenda o perguardare le ragnatele, ci metto tutto iltempo che mi gira, e questo noncostituisce oggetto di dibattito.»
«Non volevo offenderla. So che unadigestione lenta aiuta l'ispirazione.»
«La terza regola è che il sarcasmo nonlo tollero prima di mezzogiorno.
D'accordo?»
«Sì, signor Martín.»
«La quarta è che non devi chiamarmi
signor Martín nemmeno il giorno delmio funerale. A te sembrerò un fossile,ma a me piace credere di essere ancoragiovane. Anzi, lo sono e basta.»
«Come devo chiamarla?»
«Per nome: David.»
La ragazza annuì. Aprii la porta di casae le feci cenno di entrare. Isabella esitòun istante e s'infilò dentro con un saltino.
«Io credo che lei abbia ancora unaspetto abbastanza giovanile per la suaetà, David.»
La guardai, attonito.
«Quanti anni credi che abbia?»
Isabella mi squadrò dalla testa ai piedi,valutando.
«Più o meno una trentina? Ma benportati, eh?»
«Fammi il favore di stare zitta e dipreparare una caffettiera con quell'in-truglio che hai portato.»
«Dov'è la cucina?»
«Cercatela.»
Bevemmo quel delizioso caffècolombiano seduti in salotto. Isabellareggeva il suo tazzone e mi guardava di
sottecchi mentre leggevo le venti pagineche mi aveva portato. Ogni volta chegiravo una pagina e alzavo gli occhi miimbattevo nel suo sguardo pieno diaspettative.
«Se resti lì a guardarmi come unacivetta, ci vorrà un sacco di tempo.»
«Cosa vuole che faccia?»
«Non volevi diventare la mia assistente?E allora assistimi. Cerca qualcosa cheha bisogno di essere messo in ordine emettilo in ordine, per esempio.»
Isabella si guardò attorno.
«È tutto in disordine.»
«Approfitta dell'occasione.»
Annuì e partì incontro al caos e aldisordine che regnavano con rigoremilitare in casa mia. Sentii i suoi passiallontanarsi lungo il corridoio econtinuai a leggere. Il racconto che miaveva portato quasi non aveva trama.Narrava con una sensibilità affilata eparole ben articolate le sensazio-ni e leassenze che passavano per la mente diuna ragazza confinata in una stanzagelida in una soffitta del quartiere dellaRibera, da dove contemplava la città ele persone che andavano e venivano peri vicoli stretti e scuri.
La ragazza del racconto passava le ore
prigioniera del proprio mondo e, avolte, si metteva di fronte a unospecchio e si provocava tagli allebraccia e alle cosce con un vetro rotto,lasciando cicatrici come quelle che sipotevano intravedere sotto le maniche diIsabella. Stavo quasi per finire la letturaquando avvertii che mi guardava dallaporta del salotto.
«Che c'è?»
«Scusi l'interruzione, ma cosa c'è nellastanza in fondo al corridoio?»
«Niente.»
«C'è uno strano odore.»
«Umidità.»
«Se vuole posso pulirla e...»
«No. Quella stanza non si usa. E inoltretu non sei la mia cameriera e non devipulire niente.»
«Voglio solo dare una mano.»
«Dammela portandomi un'altra tazza dicaffè.»
«Perché? Il racconto le fa veniresonno?»
«Che ore sono, Isabella?»
«Devono essere le dieci.»
«E questo vuol dire?»
«Niente sarcasmo fino a mezzogiorno»replicò lei.
Sorrisi trionfante e le tesi la tazza vuota.La prese e partì verso la cucina.
Quando tornò con il caffè fumante,avevo già finito l'ultima cartella.Isabella si sedette di fronte a me. Lesorrisi e degustai con calma lo squisitocaffè. La ragazza si torceva le mani estringeva i denti, lanciando sguardifurtivi ai fogli del suo racconto cheavevo lasciato a faccia in giù sul tavolo.Resistette un paio di minuti senza aprirebocca.
«Allora?» disse alla fine.
«Superbo.»
Le si illuminò il viso.
«Il mio racconto?»
«Il caffè.»
Mi guardò, ferita, e si alzò perraccogliere i suoi fogli.
«Lasciali dove sono» ordinai.
«Perché? È chiaro che non le è piaciutoe che mi giudica una povera idiota.»
«Non ho detto questo.»
«Non ha detto niente, che è peggio.»
«Isabella, se davvero vuoi scrivere, oalmeno scrivere perché altri ti leg-gano,devi abituarti al fatto che a volte tiignorino, ti insultino, ti disprezzi-no eche quasi sempre ti dimostrinoindifferenza. È uno dei vantaggi delmestiere.»
Isabella abbassò lo sguardo e respirò afondo.
«Io non so se ho talento. So solo che mipiace scrivere. O meglio, che hobisogno di scrivere.»
«Bugiarda.»
Alzò gli occhi e mi guardò con durezza.
«Benissimo. Ho talento. E non me neimporta un'acca se lei crede che non loabbia.»
Sorrisi.
«Questo già mi piace di più. Non potreiessere più d'accordo.»
Mi guardò confusa.
«Sul fatto che ho talento o sul fatto chelei crede che non lo abbia?»
«A te cosa sembra?»
«Allora, crede che abbia qualche
possibilità?»
«Credo che tu abbia talento edentusiasmo, Isabella. Più di quanto credie meno di quello che ti aspetti. Ma cisono tante persone che hanno talento edentusiasmo, e molte di loro non arrivanomai a nulla. Questo è solo l'inizio percombinare qualcosa nella vita. Il talentonaturale è come la forza di un atleta. Sipuò nascere con maggiori o minoricapacità, però nessuno diventa un atletaperché è nato alto o forte o veloce. Afare l'atleta, o l'artista, è il lavoro, ilmestiere e la tecnica. L'intelligenza concui nasci è solo una dotazione dimunizioni. Per riuscire a farci qualcosaè necessario trasformare la tua mente in
un'arma di precisione.»
«E questo paragone bellico?»
«Ogni opera d'arte è aggressiva,Isabella. E ogni vita d'artista è unapiccola o grande guerra, a cominciare daquella con se stessi e con i propri limiti.Per raggiungere qualunque obiettivo, c'èbisogno prima di tutto dell'ambizione epoi del talento, della conoscenza e,infine, dell'opportunità.»
Isabella valutò le mie parole.
«Sciorina questo discorso a tutti o le èappena venuto in mente?»
«Non è mio. Me l'ha sciorinato, come
dici tu, qualcuno a cui feci le stessedomande che stai facendo a me. Èsuccesso molti anni fa, ma non c'è giornoin cui non mi renda conto di quantoaveva ragione.»
«Allora posso essere la sua assistente?»
«Ci penserò.»
Isabella annuì, soddisfatta. Si era sedutaa un angolo del tavolo sul quale giaceval'album di fotografie lasciato daCristina. Lo aprì a caso all'ultima paginae rimase a guardare un ritratto dellarecente signora Vidal scattatoall'ingresso di Villa Helius due o treanni prima. Deglutii. Isabella chiusel'album e fece scorrere lo sguardo sul
salotto fino a posarlo di nuovo su di me.Io l'osservavo con impazienza. Misorrise impacciata, come se l'avessisorpresa a curiosare dove non doveva.
«Ha una fidanzata molto bella» disse.
L'occhiata che le lanciai cancellò il suosorriso di colpo.
«Non è la mia fidanzata.»
«Ah.»
Ci fu un lungo silenzio.
«Immagino che la quinta regola sia nonimpicciarmi di cose che non miriguardano.»
Non risposi. Isabella annuì tra sé e sialzò.
«Allora, meglio che la lasci in pace eche per oggi non la disturbi più. Se le vabene, torno domani e cominciamo.»
Raccolse i suoi fogli e mi sorrisetimidamente. Risposi con un cenno diassenso.
Isabella si ritirò con discrezione e sparìin corridoio. Sentii i suoi passi che siallontanavano e poi il rumore dellaporta che si chiudeva. In sua assenza,notai per la prima volta il silenzio chestregava quella casa.
6
Forse fu l'eccesso di caffeina che miscorreva nelle vene, o solo la miacoscienza che cercava di tornare, comela luce dopo un blackout, però passai ilresto della mattinata girando intorno aun'idea che non era affatto consolante.Era difficile pensare che non ci fossequalche rapporto tra l'incendio a causadel quale erano deceduti Barrido edEscobillas, da un lato, l'offerta diCorelli, di cui non avevo più avutonotizie, dall'altro, e lo stranomanoscritto salvato dal Cimitero deiLibri Dimenticati che sospettavo fossestato scritto fra quelle quattro mura.
La prospettiva di ritornare, senza esserestato invitato, a casa di Andreas Corelli
per chiedergli della coincidenza tra ilnostro colloquio e l'incendio, avvenutiquasi contemporaneamente, mi risultavapoco gradita. Il mio istinto mi dicevache quando l'editore avesse deciso dirivedermi l'avrebbe fatto motu proprio,e che l'ultima cosa che quell'inevitabileincontro mi ispirava era proprio lafretta. L'indagine sull'incendio era giànelle mani dell'ispettore Víctor Grandese dei suoi due mastini, Marcos eCastelo, nella cui lista di personepreferite mi consideravo incluso conmenzione d'onore. Quanto più lontano mitenevo da loro, tanto meglio per me.L'unica alternativa percorribile restavail manoscritto e il suo rapporto con lacasa della torre. Dopo anni in cui mi ero
ripetuto che non era un caso se ero finitoad abitare lì, l'idea iniziava ora adassumere un altro significato.
Decisi di cominciare dal posto in cuiavevo confinato buona parte delle cose edegli oggetti personali lasciati daivecchi abitanti della casa della torre. Daun cassetto della cucina dove avevatrascorso anni recuperai la chiavedell'ultima stanza del corridoio. Non ciero più entrato da quando gli operaidell'azienda elettrica avevano installatol'impianto. Quando introdussi la chiavenella serratura, sentii sulle dita unacorrente d'aria fredda che fuoriuscivadal buco e constatai che Isabella avevaragione; quella stanza sprigionava uno
strano odore che faceva pensare a fiorimarci e terra smossa.
Aprii la porta e mi portai la mano allafaccia. La puzza era intensa. Tastai ilmuro cercando l'interruttore della luce,ma la lampadina spoglia che pendevadal soffitto non si accese. Il chiarore cheentrava dal corridoio permetteva diintravedere i contorni della pila discatoloni, libri e bauli che avevoconfinato in quel posto anni addietro.Contemplai tutto con ripu-gnanza. Laparete in fondo era coperta da un grandearmadio di rovere. Mi accovacciaidavanti a una cassa che contenevavecchie foto, occhiali, orologi e piccolioggetti personali. Iniziai a frugare senza
sapere bene cosa cercassi. Dopo un po'abbandonai l'impresa e sospirai. Sesperavo di scoprire qualcosa, avevobisogno di un piano. Stavo per lasciarela stanza quando sentii un'antadell'armadio aprirsi lentamente alle miespalle. Un alito di aria gelida e umidami sfiorò la nuca. Mi girai piano. L'antaera socchiusa e si potevano vedereall'interno i vecchi vestiti appesi allegrucce, rosi dal tempo, cheondeggiavano come alghe sott'acqua. Lacorrente d'aria fredda che portava quellapuzza veniva da lì. Mi alzai e miavvicinai lentamente all'armadio.Spalancai le ante e separai con le manigli indumenti appesi. Il legno sul fondoera marcio e aveva iniziato a cadere a
pezzi. Dietro, si poteva intuire un murodi gesso in cui si era aperto un buco diun paio di centimetri. Mi chinai percercare di vedere cosa c'era dall'altraparte, ma il buio era quasi assoluto. Ilchiarore tenue del corridoio filtravaattraverso il buco e proiettava dall'altrolato un filamento vaporoso di luce. Sipercepiva appena un'atmosfera pesante.Avvicinai l'occhio cercando di catturarequalche immagine di ciò che c'eradall'altra parte del muro, ma inquell'istante dal buco spuntò un ragnonero. Arretrai di colpo e il ragno siaffrettò ad arrampicarsi all'internodell'armadio e a sparire nell'ombra.
Chiusi le ante e uscii dalla stanza. Tolsi
la chiave e la misi nel primo cassettodel comò in corridoio. La puzzaimprigionata in quella camera si erasparsa per il corridoio come un veleno.Maledissi il momento in cui mi erapassato per la testa di aprire quellaporta e uscii sperando di dimenticare,sia pure per qualche ora, l'oscurità chepulsava nel cuore di quella casa.
Le cattive idee vengono sempre incoppia. Per festeggiare la scoperta diuna sorta di camera oscura nascosta incasa, andai alla libreria di Sempere eFigli con l'idea di invitare a pranzo illibraio alla Maison Dorée. Semperepadre stava leggendo una preziosaedizione del Manoscritto trovato a Sa-
ragozza di Potocki e non volle neanchesentirne parlare.
«Se voglio vedere snob e gonzi che sidanno un tono e si congratulano avicenda non ho bisogno di pagare,Martín.»
«Non faccia il brontolone. Offro io.»
Sempere scosse la testa. Suo figlio, cheaveva assistito alla conversazio-
ne dalla soglia del retrobottega, miguardava, esitante.
«E se mi porto suo figlio, che succede?Non mi rivolgerà più la parola?»
«Decidete voi come sprecare tempo edenaro. Io resto qui a leggere, perché lavita è breve.»
Sempere figlio era il paradigma dellatimidezza e della discrezione. Sebbeneci conoscessimo fin da bambini, nonricordavo di aver avuto con lui più ditre o quattro conversazioni da soli perpiù di cinque minuti. Non mi risultavache avesse vizi né peccatucci. Sapevoda fonte certa che tra le ragazze delquartiere era considerato nientemenoche il bello per antonoma-sia e loscapolo d'oro. Più d'una capitava inlibreria con una scusa qualsiasi e sifermava davanti al bancone a sospirare,ma lui, se pure se ne accorgeva, non
faceva mai un passo per incassare quellecambiali di devozione e labbrasocchiuse. Chiunque altro avrebbe fattouna carriera luminosa da li-bertino conun decimo di quel capitale. Chiunque,meno Sempere figlio, a cui a volte non sisapeva se attribuire il titolo di beato.
«Di questo passo, finirà per faresolamente tappezzeria» si lamentavaogni tanto Sempere.
«Ha provato a mettergli un po' dipeperoncino nella zuppa per stimolarel'irrigazione nei punti chiave?»domandavo io.
«Rida, rida, mascalzone, che io già vadoper i settanta e non ho nemmeno un
fottuto nipote.»
Ci accolse lo stesso maître chericordavo dall'ultima visita, ma senza ilsorriso servile né il gesto di benvenuto.Quando gli comunicai che non avevoprenotato, annuì con una smorfia didisprezzo e schioccò le dita perinvocare la presenza di un cameriere checi scortò senza troppe cerimonie aquello che immaginai fosse il peggiortavolo della sala, accanto alla portadelle cucine e seppellito in un angolobuio e rumoroso. Per i successiviventicinque minuti nessuno si avvicinòal tavolo, nemmeno per consegnar-ci ilmenu o per versarci un bicchier d'acqua.Il personale andava e veniva sbattendo
la porta della cucina e ignorandocompletamente la nostra presenza e inostri cenni per reclamare attenzione.
«Vuol dire che dovremmo andarcene?»chiese alla fine Sempere figlio.
«Io, con un panino in un posto qualsiasi,risolvo...»
Non aveva finito di pronunciare questeparole quando li vidi comparire.
Vidal e signora avanzavano verso il lorotavolo scortati dal maître e da duecamerieri che si scioglievano infelicitazioni. Dopo un paio di minuti cheavevano preso posto, iniziò laprocessione di baciamano con cui, uno
dopo l'altro, i commensali siavvicinavano a Vidal per fargli gliauguri. Lui li accoglieva con graziadivina e li congedava poco dopo.Sempere figlio, che si era reso contodella situazione, mi osservava.
«Martín, sta bene? Perché non ce neandiamo?»
Annuii lentamente. Ci alzammo e cidirigemmo all'uscita, costeggiando lasala lungo l'estremità opposta a quelladel tavolo di Vidal. Prima diabbandonare il ristorante, passammodavanti al maître, che non si presenemmeno la briga di guardarci, e mentreraggiungevamo l'uscita potei vedere
nello specchio sopra la cornice dellaporta che Vidal si chinava e ba-ciavaCristina sulle labbra. In strada, Semperemi guardò, mortificato.
«Mi dispiace, Martín.»
«Non si preoccupi. Cattiva scelta. Tuttoqui. Se permette, di questo, a suopadre...»
«Nemmeno una parola» assicurò.
«Grazie.»
«Non c'è di che. Cosa ne dice se l'invitoio in un posto più plebeo? C'è unatrattoria favolosa in calle del Carmen.»
Mi era passato l'appetito, ma accettaivolentieri.
«D'accordo.»
La trattoria era vicino alla biblioteca eserviva cibi caserecci a prezzoeconomico per la gente del quartiere.Assaggiai appena qualche pietanza, cheaveva un odore infinitamente migliore diqualunque cosa avessi annu-sato allaMaison Dorée da quando era aperta,però al dolce mi ero già sco-lato da solouna bottiglia e mezzo di rosso e la testami era entrata in orbi-ta.
«Sempere, mi dica una cosa. Cos'ha leicontro il miglioramento della razza?Come si spiega, altrimenti, che un
cittadino giovane e sano, benedettodall'Altissimo con un fisico come il suo,non abbia approfittato a man bassa ditutto quel ben di dio?»
Il figlio del libraio rise.
«Cosa le fa pensare che non l'abbiafatto?»
Mi toccai il naso con l'indice,strizzandogli l'occhio. Sempere figlioannuì.
«A rischio che mi prenda per unbacchettone, mi piace pensare che stoaspettando.»
«Cosa? Che l'armamentario non le
funzioni più?»
«Parla come mio padre.»
«Gli uomini saggi condividono pensierie parole.»
«Io dico che ci sarà qualcos'altro, no?»chiese.
«Qualcos'altro?»
Sempere annuì.
«Che ne so?» dissi.
«Invece credo che lo sappia.»
«E allora lei sa che mi sta utilizzando.»
Stavo per versarmi un altro bicchierequando Sempere mi fermò.
«Prudenza» mormorò.
«Vede che è un bacchettone?»
«Ognuno è quello che è.»
«Questo si può curare. Cosa ne dice seadesso lei e io andiamo a spas-sarcelaun po'?»
Sempere mi guardò con compassione.
«Martín, credo sia meglio che se nevada a casa a riposare. Domani è unaltro giorno.»
«Non dirà a suo padre che mi sonopreso una sbronza, vero?»
Sulla strada di casa mi fermai in nonmeno di sette bar per degustarne leriserve ad alta gradazione finché, conuna scusa o con l'altra, mi cacciava-noin strada e percorrevo altri cento oduecento metri in cerca di un nuovoporto in cui fare scalo. Non ero maistato un bevitore di fondo e alla fine delpomeriggio ero così ubriaco che non miricordavo nemmeno dove abitavo. Unpaio di camerieri della locanda AmbosMundos di plaza Real mi sollevaronociascuno per un braccio e midepositarono su una panchina di frontealla fontana, dove caddi in un sopore
spesso e scuro.
Sognai di andare al funerale di donPedro. Un cielo insanguinatoattanagliava il labirinto di croci e angeliche circondavano il grande mausoleodei Vidal nel cimitero di Montjuic. Unacomitiva silenziosa di veli neri at-torniava l'anfiteatro di marmo brunitoche formava il porticato del mausoleo.Ogni figura portava un lungo cerobianco. La luce di cento fiammellescolpiva il contorno di un grande angelodi marmo sconsolato per il dolore e laperdita su un piedistallo ai cui piedigiaceva la tomba aperta del miomentore, con all'interno un sarcofago divetro. Il corpo di Vidal, vestito di
bianco, era steso sotto il vetro a occhiaperti. Lacrime nere gli scendevanodalle guance. Dal gruppo si staccava ilprofilo della vedova, Cristina, checadeva in ginocchio davanti al feretroinzuppata di pianto. A uno a uno, imembri della comitiva sfilavano davantial defunto e depositavano rose nere sullabara di vetro fino a coprirlo tutto, aeccezione del viso. Due bec-
chini senza volto calavano il feretronella fossa, il cui fondo era inondato daun liquido denso e scuro. Il sarcofagogalleggiava su quella distesa di sangue,che lentamente filtrava tra gli spiraglidella chiusura. Pian piano, la baraveniva inondata e il sangue ricopriva il
cadavere di Vidal. Prima che il suovolto venisse sommerso del tutto, il miomentore muoveva gli occhi e miguardava. Uno stormo di uccelli neri sialzava in volo e io mi mettevo a correre,perdendomi tra i sentieri dell'infinitacittà dei morti. Solo un pianto lontanoriusciva a guidarmi verso l'uscita e mipermetteva di eludere i lamenti e lepreghiere di oscure figure d'ombra chemi venivano incontro e mi supplicavanodi portarle con me, di salvarle dalla loroeterna oscurità.
Mi svegliarono due guardie dandomi deicolpetti sulla gamba con lo sfollagente.Era già buio e mi ci volle qualchesecondo per capire se si trattava della
forza pubblica o di agenti della Parca inmissione speciale.
«Forza, giovanotto, a smaltire la sbronzaa casa, d'accordo?»
«Agli ordini, colonnello.»
«Svelto, o la sbatto in cella, e vediamose ha ancora voglia di fare battute.»
Non dovette ripetermelo due volte. Mialzai come potei e m'incamminai versocasa con la speranza di arrivarci primache i miei passi mi guidassero di nuovoin qualche postaccio. Il tragitto, che incondizioni normali mi avrebbe richiestodieci o quindici minuti, si prolungò deltriplo. Alla fine, quasi per miracolo,
arrivai alla porta di casa dove, come sesi trattasse di una maledizione, ritrovaiIsabella seduta, stavolta nell'atriointerno, che mi aspettava.
«È ubriaco» disse.
«Deve essere così, perché in pienodelirium tremens mi è sembrato ditrovarti a mezzanotte addormentata sottocasa mia.»
«Non avevo un altro posto dove andare.Ho litigato con mio padre e mi hacacciata di casa.»
Chiusi gli occhi e sospirai. Il miocervello intasato di alcol e amarezza nonera in grado di dare forma al torrente di
rifiuti e maledizioni che si af-follavanosulle mie labbra.
«Qui non puoi restare, Isabella.»
«Per favore, solo per stanotte. Domanicerco una pensione. La supplico, signorMartín.»
«Non guardarmi con quegli occhi daagnello sgozzato» minacciai.
«E poi, se sono per strada è per colpasua.»
«Per colpa mia. Questa sì che è buona.Non so se hai talento per scrive-
re, ma di immaginazione febbrile ne hai
a valanghe. Per quale infausto motivo, sesi può sapere, sarebbe colpa mia se iltuo signor padre ti ha deposi-tato sullastrada?»
«Quando è ubriaco lei parla strano.»
«Non sono ubriaco. Non sono mai statoubriaco in vita mia. Rispondi alladomanda.»
«Ho detto a mio padre che lei mi avevaassunto come assistente e che a partireda adesso mi sarei dedicata allaletteratura e non avrei più potutolavorare in negozio.»
«Cosa?»
«Possiamo entrare? Ho freddo e ilsedere mi si è pietrificato a forza didormire sulle scale.»
Sentii che la testa mi girava e che miassaliva la nausea. Alzai gli occhi versola tenue penombra che trapelava dallucernario in cima alle scale.
«È questo il castigo che mi invia il cieloper farmi pentire della mia vitadissoluta?»
Isabella seguì il mio sguardo, intrigata.
«Con chi parla?»
«Non parlo, monologo. Prerogativa delbeone. Però domattina presto vado a
dialogare con tuo padre e mettiamo finea questa assurdità.»
«Non so se è una buona idea. Ha giuratoche appena la vede l'ammazza.
Ha un fucile a due canne nascosto sottoil bancone. Lui è fatto così. Una volta ciha ammazzato un asino. Era estate,vicino ad Argentona...»
«Zitta. Nemmeno una parola in più.Silenzio.»
Isabella annuì e restò a guardarmi, inattesa. Ricominciai a cercare la chiave.In quel momento non potevo mettermi acombattere con le balle di quellaloquace adolescente. Avevo bisogno di
sprofondarmi a letto e perdere lacoscienza, preferibilmente inquest'ordine. Cercai per un paio diminuti, senza risultato. Alla fineIsabella, senza dire una parola, mi siavvicinò, frugò nella tasca della giaccadove le mie mani erano passate centovolte e trovò la chiave. Me la mostrò eio annuii, sconfitto.
Isabella aprì la porta e mi aiutò areggermi in piedi. Mi guidò fino allastanza da letto come un invalido e miaiutò a stendermi. Mi sistemò la testa suicuscini e mi tolse le scarpe. La guardaiconfuso.
«Tranquillo, i pantaloni non glieli
tolgo.»
Mi allentò i bottoni del colletto e sisedette accanto a me, osservandomi.
Mi sorrise con una malinconia che i suoianni non meritavano.
«Non l'ho mai vista tanto triste, signorMartín. È per quella donna, vero?
Quella della foto.»
Mi prese la mano e me l'accarezzò,tranquillizzandomi.
«Tutto passa, mi dia retta. Tutto passa.»
Mio malgrado, mi si riempirono gli
occhi di lacrime e girai la testa per nonfarmi vedere in viso. Isabella spense laluce sul comodino e rimase sedutaaccanto a me, nella penombra, a sentirpiangere quel miserabile ubriaco, senzafare domande né dare altro giudizio senon quello della sua compagnia e dellasua bontà, finché mi addormentai.
7
Mi svegliarono l'agonia deldoposbornia, una pressa che si chiudevasulle tempie e il profumo di caffècolombiano. Isabella aveva sistematoaccanto al letto un tavolino con unacaffettiera appena fatta e un piatto conpane, formaggio, prosciutto e una mela.
La vista del cibo mi diede la nausea, maallungai la mano verso la caffettiera.Isabella, che mi stava osservando dallasoglia senza che lo notassi, miprecedette e me ne servì una tazza,sciogliendosi in sorrisi.
«Lo prenda così, bello forte, e le faràbenissimo.»
Accettai la tazza e bevvi.
«Che ore sono?»
«L'una.»
Mi lasciai sfuggire uno sbuffo.
«Da quante ore sei sveglia?»
«Più o meno sette.»
«E cos'hai fatto?»
«Ho pulito e messo in ordine, però quic'è lavoro per diversi mesi» replicòIsabella.
Bevvi un altro lungo sorso di caffè.
«Grazie» mormorai. «Per il caffè. E peraver messo in ordine e pulito, ma non c'èmotivo per cui tu debba farlo.»
«Non lo faccio per lei, se è questo chela preoccupa. Lo faccio per me.
Se devo vivere qui, preferisco pensareche non rimarrò appiccicata a qualcosa
se per caso mi ci appoggio...»
«Vivere qui? Credevo che avessimodetto...»
Nell'alzare la voce, una fitta di doloremi spezzò le parole e i pensieri.
«Shhhh» sussurrò Isabella.
Annuii in segno di tregua. In quelmomento non potevo né volevo discu-
tere con lei. Più tardi ci sarebbe statotempo per restituirla alla sua famiglia,quando i postumi della sbronza avesserobattuto in ritirata. Svuotai la tazza alterzo sorso e mi alzai lentamente.Cinque o sei aculei di dolore mi si
conficcarono in testa. Mi lasciai sfuggireun lamento. Isabella mi sosteneva per unbraccio.
«Non sono invalido. Ce la faccio dasolo.»
Provò a lasciarmi. Feci qualche passoverso il corridoio. Lei mi seguiva davicino, come se temesse di vedermicrollare da un momento all'altro. Mifermai davanti al bagno.
«Posso orinare da solo?» domandai.
«Miri bene» mormorò la ragazza. «Lelascio la colazione in salotto.»
«Non ho fame.»
«Deve mangiare qualcosa.»
«Sei la mia apprendista o mia madre?»
«Glielo dico per il suo bene.»
Chiusi la porta del bagno e mi cirifugiai. Gli occhi ci misero un paio disecondi a adattarsi a quello che vedevo.Il bagno era irriconoscibile. Pulito ebrillante. Ogni cosa al suo posto. Unasaponetta nuova sul lavabo.Asciugamani puliti che non sapevonemmeno di avere. Odore di liscivia.
«Madonna» mormorai.
Ficcai la testa sotto il rubinetto e lasciaiscorrere l'acqua fredda un paio di
minuti. Uscii in corridoio e mi diressilentamente in salotto. Se il bagno erairriconoscibile, il salotto apparteneva aun altro mondo. Isabella aveva pulito ivetri e il pavimento e spolverato mobilie poltrone. Una luce pura e chiarairrompeva dalle vetrate e l'odore dipolvere era scomparso. La colazione miaspettava sul tavolo di fronte al sofà, sulquale la ragazza aveva messo una foderapulita. Gli scaffali zeppi di librisembravano riordinati e le cristalliereavevano ritrovato la trasparenza.Isabella mi versò un secondo tazzone dicaffè.
«So quello che stai facendo, e nonfunzionerà» dissi.
«Servire una tazza di caffè?»
Isabella aveva rimesso a posto i librisparpagliati sui tavoli e negli angoli.Aveva svuotato i portarivistestrabordanti da più di un decennio. Insole sette ore, aveva spazzato via dicolpo anni di penombra e tenebre con lasua lena e la sua presenza, e ancora lerimanevano tempo e voglia di sorridere.
«Mi piaceva di più com'era prima»dissi.
«Certo. A lei e ai centomila scarafaggiche aveva per inquilini e che hoscacciato con aria fresca e ammoniaca.»
«È questa la puzza che si sente?»
«La puzza è odore di pulito» protestòIsabella. «Potrebbe essere un pocograto.»
«Lo sono.»
«Non si nota. Domani salgo nello studioe...»
«Che non ti venga neanche in mente.»
Isabella si strinse nelle spalle, però ilsuo sguardo era determinato e seppi cheentro ventiquattr'ore lo studio della torreavrebbe sofferto una tra-sformazioneirreparabile.
«Comunque, stamattina ho trovato unabusta all'ingresso. Qualcuno deve averla
infilata sotto la porta stanotte.»
La guardai da sopra la tazza.
«Il portone di sotto è chiuso a chiave»dissi.
«Lo pensavo anch'io. A dire il vero mi èsembrato molto strano e, anche se c'erail suo nome...»
«L'hai aperta.»
«Temo di sì. L'ho fatto senza volere.»
«Isabella, aprire la corrispondenza deglialtri non è segno di buona educazione. Inqualche posto è perfino un reato punibilecon il carcere.»
«Lo dico sempre a mia madre, che miapre tutte le lettere. Ed è ancora inlibertà.»
«Dov'è la lettera?»
Isabella tirò fuori una busta dalla tascadel grembiule che aveva indossato e mela tese evitando il mio sguardo. I bordierano seghettati e la carta spessa eporosa, color avorio, con il sigillodell'angelo - rotto - sulla ceralaccarossa e il mio nome scritto coninchiostro cremisi e profumato. L'apriied estrassi un foglio piegato in due.
Stimato David,
spero che stia bene in salute e che abbia
incassato senza problemi la sommaconcordata. Le va di vederci stasera acasa mia per cominciare a discutere idettagli del nostro progetto? Verràservita una cena leggera verso le dieci.L'aspetto.
Il suo amico
Andreas Corelli
Ripiegai il foglio e lo rimisi nella busta.Isabella mi osservava intrigata.
«Buone notizie?»
«Nulla che ti riguardi.»
«Chi è il signor Corelli? Ha una bella
calligrafia, non come lei.»
La guardai con severità.
«Se diventerò la sua assistente, credoche dovrò sapere con chi ha rapporti. Seper caso devo mandarli a spasso, vogliodire.»
Sospirai.
«È un editore.»
«Dev'essere un buon editore, guardi checarta da lettera e che buste...
Che libro sta scrivendo per lui?»
«Niente che ti riguardi.»
«Come faccio ad assisterla se non midice a che cosa sta lavorando? No,meglio che non risponda. Sto zitta.»
Per dieci miracolosi secondi, Isabellarestò in silenzio.
«Com'è questo signor Corelli?»
La guardai freddamente.
«Particolare.»
«Dio li fa e... non dico nient'altro.»
Osservando quella ragazza dall'animonobile mi sentii, se possibile, ancora piùmeschino e capii che quanto primal'avessi allontanata da me, anche a
rischio di ferirla, meglio sarebbe statoper entrambi.
«Perché mi guarda così?»
«Stasera esco, Isabella.»
«Le preparo qualcosa per cena? Tornatardi?»
«Ceno fuori e non so quando torno, ma aqualunque ora sia, non voglio trovartiqui. Voglio che prendi le tue cose e te nevai. Dove, mi è indifferente. Qui non c'èposto per te. Capito?»
Il suo viso impallidì e gli occhi le siinumidirono. Si morse le labbra e misorrise con le guance solcate di lacrime.
«Sono di troppo. Capito.»
«E non pulire più.»
Mi alzai e la lasciai sola in salotto. Mirifugiai nello studio della torre.
Aprii le finestre. Il pianto di Isabellaarrivava fin dal piano di sotto.Contemplai la città stesa al sole dimezzogiorno e rivolsi lo sguardoall'altro e-stremo, dove credetti quasi divedere le tegole brillanti di Villa Heliuse di immaginare Cristina, la signoraVidal, in alto, alle finestre del torrione,che guardava verso La Ribera. Qualcosadi oscuro e di torbido mi ricoprì ilcuore. Dimenticai il pianto di Isabella edesiderai soltanto che arrivasse il
momento di incontrare Corelli perparlare del suo maledetto libro.
Rimasi nello studio della torre fino aquando il tramonto si sparse sulla cittàcome sangue nell'acqua. Faceva caldo,più che in tutta l'estate, e i tetti dellaRibera sembravano vibrare allo sguardocome miraggi di vapore.
Scesi e mi cambiai. La casa erasilenziosa, le persiane del salottosocchiuse e le vetrate imbevute di unchiarore ambrato che si diffondeva nelcorridoio centrale.
«Isabella?» chiamai.
Non ottenni risposta. Mi affacciai in
salotto e verificai che se n'era andata.Prima di farlo, però, si era messa ariordinare e a pulire la collezione delleopere complete di Ignatius B. Samsonche per anni avevano accumulatopolvere e oblio in una cristalliera cheadesso brillava. La ragazza avevalasciato uno dei volumi aperto su unleggio. Lessi un rigo a caso e mi sembròdi viaggiare in un tempo in cui tuttosembrava semplice quanto inevitabile.
"'La poesia si scrive con le lacrime, iromanzi con il sangue e la storia con lebolle di sapone' disse il cardinalementre bagnava di veleno la lama delcoltello alla luce del candelabro."
La studiata ingenuità di quelle frasi mistrappò un sorriso e mi restituì unsospetto che non mi aveva maiabbandonato: forse sarebbe stato meglioper tutti, soprattutto per me, se IgnatiusB. Samson non si fosse mai suicidato eDavid Martín non avesse preso il suoposto.
8
Si stava già facendo buio quando uscii.Il caldo e l'umidità avevano spinto moltiabitanti del quartiere a portarsi le sediein strada in cerca di una brezza che nonarrivava. Evitai gli improvvisaticapannelli davanti ai portoni e agliangoli e mi diressi verso la stazione
Francia, dove si potevano sempretrovare due o tre taxi in attesa. Salii sulprimo della fila. Ci vollero una ventinadi minuti per attraversare la città erisalire il pendio della collina su cui sitrovava il bosco spettrale dell'architettoGaudí. Le luci della casa di Corellierano visibili da lontano.
«Non sapevo che ci abitasse qualcuno»commentò l'autista.
Appena ebbi pagato la corsa, manciainclusa, non perse un secondo asquagliarsela in tutta fretta. Attesiqualche istante prima di bussare allaporta, assaporando lo strano silenzio cheregnava in quel luogo. Soltanto una
foglia si agitava nel bosco che ricoprivala collina alle mie spalle. Un cielodisseminato di stelle e pennellate di nubisi estendeva in ogni direzione. Potevosentire il suono del mio respiro, delfruscio dei miei vestiti mentrecamminavo, dei miei passi che siavvicinavano alla porta. Suonai ilcampanello e attesi.
La porta si aprì qualche momento dopo.Un uomo dallo sguardo e dalle spallestanchi annuì alla mia presenza e mi fececenno di entrare. L'abbi-gliamentosuggeriva che si trattava di una specie dimaggiordomo o di domestico. Nonemise alcun suono. Lo seguii attraversoil corridoio che ricordavo fiancheggiato
da ritratti, e mi cedette il passo nelgrande salone sul fondo, dal quale sipoteva contemplare tutta la città inlontananza. Con una lieve riverenza milasciò solo e si ritirò con la stessalentezza con cui mi avevaaccompagnato. Mi avvicinai aifinestroni e guardai attraverso le ten-dine, per ammazzare il tempo in attesa diCorelli. Erano trascorsi un paio diminuti quando notai che una figura miosservava da un angolo della sala. Eraseduto, completamente immobile, su unapoltrona, tra la penombra e la luce diuna lanterna che a stento rivelava legambe e le mani appoggiate ai braccioli.Lo riconobbi dal brillio degli occhi chenon sbattevano mai le palpebre e dal
riflesso della lanterna sulla spilla aforma di angelo che portava sempre sulrisvolto della giacca. Appena posai losguardo su di lui, si alzò e si avvicinò apassi rapidi, troppo rapidi, e con unsorriso da lupo che mi gelò il sangue.
«Buona sera, Martín.»
Annuii cercando di rispondere al suosorriso.
«L'ho spaventata di nuovo» disse. «Midispiace. Posso offrirle qualcosa dabere o passiamo senza preamboli allacena?»
«A dire il vero, non ho appetito.»
«È questo caldo, senza dubbio. Se le va,possiamo andare in giardino echiacchierare lì.»
Il silenzioso maggiordomo fece atto dipresenza e procedette ad aprire le porteche davano in giardino, dove un sentierodi candele sistemate su piat-tini da caffèconduceva a un tavolo di metallo biancocon due sedie messe una di fronteall'altra. La fiamma delle candelebruciava diritta, senza nessunaoscillazione. La luna diffondeva un tenuechiarore azzurrato. Presi posto e Corellifece lo stesso mentre il maggiordomo ciriempiva due bicchieri da un recipiente,immaginai pieno di vino o di qualcheliquore che non avevo intenzione di
assaggiare. Alla luce di quei tre quartidi luna, Corelli mi sembrò più giovane,con i tratti del volto più affilati. Miosservava con un'intensità prossima allavoracità.
«Qualcosa la preoccupa, Martín.»
«Immagino abbia sentito dell'incendio.»
«Una fine spiacevole e tuttaviapoeticamente giusta.»
«Le sembra giusto che due uominimuoiano in quel modo?»
«Un modo meno cruento le sembrerebbepiù accettabile? La giustizia è unartificio della prospettiva, non un valore
universale. Non fingerò unacosternazione che non provo, e credonemmeno lei, per quanto voglia mo-strarla. Ma se preferisce osserviamo unminuto di silenzio.»
«Non sarà necessario.»
«Certo che no. È necessario solo quandonon si ha niente di valido da dire. Ilsilenzio fa sembrare saggi perfino glistupidi, per un minuto. Qualcos'altro chela preoccupa, Martín?»
«La polizia sembra ritenere che io abbiaqualcosa a che fare con l'accaduto. Mihanno chiesto di lei.»
Corelli annuì con noncuranza.
«La polizia deve fare il suo lavoro e noiil nostro. Cosa ne dice se diamo peresaurito l'argomento?»
Annuii lentamente. Corelli sorrise.
«Poco fa, mentre l'aspettavo, mi sonoreso conto che noi due abbiamo insospeso una piccola conversazioneretorica. Prima ce ne sbarazziamo,prima arriveremo al dunque» disse. «Mipiacerebbe cominciare chiedendolecos'è per lei la fede.»
Esitai qualche istante.
«Non sono mai stato una personareligiosa. Più che credere o non credere,ho dei dubbi. Il dubbio è la mia fede.»
«Molto prudente e molto borghese. Mamettendo palloni in fallo laterale non sivince la partita. Per quale motivo,secondo lei, credenze di ogni tipocompaiono e scompaiono nel corsodella storia?»
«Non lo so. Credo per fattori sociali,economici o politici. Lei parla con unoche ha smesso di andare a scuola a diecianni. La storia non è il mio forte.»
«La storia è l'immondezzaio dellabiologia, Martín.»
«Il giorno in cui hanno spiegato questoargomento forse non ero a scuola.»
«Questa lezione non viene impartita
nelle aule, Martín. Ce la imparti-sconola ragione e l'osservazione della realtà.Ma nessuno vuole impararla, perciò èquella che dobbiamo analizzare meglioper svolgere bene il nostro lavoro. Ogniopportunità di fare un affare nascedall'incapacità degli altri di risolvere unproblema semplice e inevitabile.»
«Parliamo di religione o di economia?»
«Scelga lei la terminologia.»
«Se capisco bene, lei suggerisce che lafede, l'atto di credere in miti o ideologieo leggende sovrannaturali, è unaconseguenza della biologia.»
«Né più né meno.»
«Una visione piuttosto cinica per uneditore di testi religiosi» notai.
«Una visione professionale espassionata» specificò Corelli.«L'essere umano crede come respira,per sopravvivere.»
«Questa teoria è sua?»
«Non è una teoria, è una statistica.»
«Mi viene in mente che almeno tre quartidel mondo non sarebbero d'accordo conquest'affermazione» osservai.
«Naturalmente. Se fossero d'accordo,non sarebbero potenziali credenti.
Nessuno può venire davvero convinto diquello in cui non ha bisogno di credereper un imperativo biologico.»
«Allora secondo lei è nella nostra naturavivere nell'inganno?»
«Sopravvivere, è nella nostra natura. Lafede è una risposta istintiva ad aspettidell'esistenza che non possiamo spiegarein altro modo: il vuoto morale chepercepiamo nell'universo, la certezzadella morte, il mistero dell'origine dellecose o il senso della nostra vita, o la suaassenza. Sono aspetti elementari e distraordinaria semplicità, ma i nostristessi limiti ci impediscono dirispondere in modo univoco a queste
domande e per questo motivogeneriamo, come difesa, una rispostaemotiva. È pura e semplice biologia.»
«Secondo lei, allora, tutte le fedi e gliideali sarebbero solo una finzione.»
«Qualsiasi interpretazione oosservazione della realtà lo è. In questocaso, il problema sta nel fatto chel'uomo è un animale morale abbandonatoin un universo amorale e condannato aun'esistenza finita e senza altrosignificato che quello di perpetuare ilciclo naturale della specie. Èimpossibile sopravvivere in uno statoprolungato di realtà, almeno per unessere umano. Passiamo buona parte
della nostra vita a sognare, soprattuttoquando siamo svegli. Come le dicevo,semplice biologia.»
Sospirai.
«E dopo tutto questo, lei vuole che io miinventi una favola che faccia cadere inginocchio gli incauti e li convinca diaver visto la luce, dell'esi-
stenza di qualcosa in cui credere, per cuivivere e per cui morire e perfinoammazzare.»
«Esatto. Non le chiedo di inventare nullache non sia già stato inventato, in unaforma o in un'altra. Le chiedo soltanto diaiutarmi a dar da bere agli assetati.»
«Un proposito lodevole e pio» ironizzai.
«No, una semplice propostacommerciale. La natura è un grandelibero mercato. La legge della domandae dell'offerta è una questione molecola-re.»
«Forse dovrebbe cercarsi unintellettuale per questo lavoro. Aproposito di questioni molecolari emercantili, le assicuro che la maggiorparte di loro non ha mai visto centomilafranchi tutti insieme e scommetto chesaranno disposti a vendersi l'anima, o ainventarsela, per una parte di quellasomma.»
Lo scintillio metallico dei suoi occhi mi
fece sospettare che Corelli stava perdedicarmi un altro dei suoi acidisermoni tascabili. Visualizzai il saldodel mio conto al Banco HispanoAmericano e mi dissi che centomilafranchi valevano bene una messa o unacollezione di omelie.
«Un intellettuale di solito è uno che nonsi distingue esattamente per il suointelletto» sentenziò Corelli. «Siattribuisce da solo quella definizioneper compensare l'impotenza naturale cheintuisce nelle sue capacità. È la vecchiastoria del dimmi di cosa ti vanti e ti diròdi cosa sei privo. Pane quotidiano.L'incompetente si presenta sempre comeesperto, il crudele come misericordioso,
il peccatore come baciapile, l'usuraiocome benefattore, il meschino comepatriota, l'arrogante come umile, ilvolgare come elegante e lo stupido comeintellettuale. Di nuovo, tutta opera dellanatura, la quale, lungi dall'essere lasilfide cantata dai poeti, è una madrecrudele e vorace che ha bisogno dicibarsi delle creature che partorisce percontinuare a vivere.»
Corelli e la sua poetica della biologiaferoce iniziavano a darmi la nausea. Laveemenza e l'ira trattenute che stillavanole parole dell'editore mi mettevano adisagio e mi domandai se ci fossequalcosa nell'universo che non glisembrasse ripugnante e spregevole,
incluso me stesso.
«Lei dovrebbe tenere conferenze diorientamento nelle scuole e nelleparrocchie la Domenica delle Palme.Avrebbe un successo impressionante»suggerii.
Corelli rise con freddezza.
«Non cambi argomento. Quello che iocerco è l'opposto di un intellettua-
le, vale a dire qualcuno intelligente. El'ho trovato.»
«Mi lusinga.»
«Meglio ancora, la pago. E molto bene,
che è l'unica vera lusinga in questomondo mercenario. Non accetti maidecorazioni che non siano stampate suun assegno. Arrecano benefici solo a chile concede. E visto che la pago, speroche mi ascolti e segua le mie istruzioni.Mi creda se le dico che non ho alcuninteresse a farle perdere tempo. Finchélei è stipendiato, il suo tempo è anche ilmio.»
Il tono era amabile, ma lo scintillio deisuoi occhi era d'acciaio e non lasciavaspazio a equivoci.
«Non è necessario che me lo ricordiogni cinque minuti.»
«Perdoni la mia insistenza, amico mio.
Se le do il voltastomaco con tutti questisproloqui è per sbarazzarmene quantoprima. Quello che voglio da lei è laforma, non il contenuto. Il contenuto èsempre lo stesso ed è stato inventato daquando esiste l'essere umano. È incisonel suo cuore come un numero di serie.Quello che voglio da lei è che trovi unmodo intelligente e seduttivo dirispondere alle domande che tutti noi cirivolgiamo, e che lo faccia a partiredalla sua personale lettura dell'animoumano, mettendo in pratica la sua arte eil suo mestiere. Voglio che mi porti unanarrazione che risvegli l'anima.»
«Niente di meno...»
«E niente di più.»
«Lei parla di manipolare sentimenti edemozioni. Non sarebbe più facileconvincere la gente con un'esposizionerazionale, semplice e chiara?»
«No. È impossibile avviare un dialogorazionale con una persona su credenze econcetti che non ha acquisito mediante laragione. Fa lo stesso se parliamo di Dio,della razza o dell'orgoglio patriottico.Per questo mi serve qualcosa di piùpotente di una semplice esposizioneretorica. Mi serve la forza dell'arte, lamessa in scena. Le parole delle canzonisono ciò che crediamo di capire, ma arenderle credibili o no è la musica.»
Cercai di inghiottire tutto quelguazzabuglio senza strozzarmi.
«Tranquillo, per oggi niente piùdiscorsi» tagliò corto Corelli. «Veniamoalla parte pratica: lei e io ci vedremoapprossimativamente ogni quindicigiorni. Mi informerà sui suoi progressi emi mostrerà il lavoro fatto. Se hoosservazioni o cambiamenti dasuggerire, glielo farò presente. Il lavorodurerà dodici mesi, o la frazionenecessaria per completarlo. Al terminedi questo periodo lei mi consegnerà,senza eccezioni, tutto il testo e ladocumentazione prodotta, che spettanoall'unico proprietario e titolare dei dirit-
ti, cioè io. Il suo nome non figureràcome autore e lei si impegna a non ri-vendicarlo dopo la consegna e a nonparlare con nessuno del lavororealizzato, o dei termini di questoaccordo, né in privato né in pubblico. Incambio, otterrà un anticipo di centomilafranchi, che le è già stato versato, e allafine, e previa consegna del lavoro eapprovazione da parte mia, un bonusaddizionale di altri cinquantamilafranchi.»
Deglutii. Uno non è pienamentecosciente dell'avidità che si nascondenel suo cuore fino a quando non sente ildolce tintinnio dei soldi nelle tasche.
«Non vuole formalizzare un contrattoper iscritto?»
«Il nostro è un accordo sulla parolad'onore. La sua e la mia. Ed è già statosiglato. Un accordo sulla parola d'onorenon si può infrangere perché infrange chilo ha sottoscritto» disse Corelli con untono che mi fece pensare che sarebbestato preferibile firmare comunque unpezzo di carta, sia pure con il sangue.«Qualche dubbio?»
«Sì. Perché?»
«Non la capisco, Martín.»
«Perché vuole questo materiale, o comepreferisce chiamarlo? Cosa pensa di
farci?»
«Problemi di coscienza, Martín, arrivatia questo punto?»
«Forse lei mi prende per un individuosenza princìpi, ma se partecipo aqualcosa come ciò che mi proponevoglio sapere qual è l'obiettivo. Credodi averne diritto.»
Corelli sorrise e posò la sua mano sullamia. Provai un brivido al contatto dellapelle gelida e liscia come il marmo.
«Perché lei vuole vivere.»
«Questo suona vagamente minaccioso.»
«Un semplice e amichevole promemoriadi ciò che già sa. Lei mi aiuterà perchévuole vivere e perché non le importanoné il prezzo né le conse-guenze. Perchénon molto tempo fa sapeva di essere alleporte della morte e adesso ha un'eternitàdavanti a sé e l'opportunità di una vita.Mi aiuterà perché è umano. E perché,anche se non vuole ammetterlo, hafede.»
Scostai la mano fuori dalla sua portata el'osservai alzarsi dalla sedia e dirigersiverso il fondo del giardino.
«Non si preoccupi, Martín. Andrà tuttobene. Mi dia retta» disse Corelli in untono dolce e soporifero, quasi materno.
«Posso andare?»
«Certo. Non voglio trattenerla più delnecessario. Mi è piaciuta la nostraconversazione. Ora la lascerò ripensarea tutto quello di cui abbiamo discusso.Vedrà, passata l'indigestione, si renderàconto che le vere risposte verranno a lei.Non c'è nulla nel sentiero della vita chenon sappiamo già prima di imboccarlo.Non si impara nulla di importante nellavita, semplicemente si ricorda.»
Corelli fece un cenno al taciturnomaggiordomo che aspettava al limite delgiardino.
«Un'automobile la porterà a casa. Noi civediamo tra due settimane.»
«Qui?»
«Lo dirà Dio» mormorò leccandosi lelabbra come se avesse detto una battutadeliziosa.
Il maggiordomo si avvicinò e mi indicòdi seguirlo. Corelli annuì e si ri-sedette,lo sguardo di nuovo perso sulla città.
9
L'automobile, per chiamarla in qualchemodo, aspettava alla porta della villa.Non era un'auto qualunque, ma un pezzoda collezione. Mi fece pensare a unacarrozza incantata, a una cattedralesemovente con cromature e curve fatte discienza pura, e il tocco finale
dell'emblema di un angelo d'argento sulcofano a mo' di polena. In altre parole,una Rolls-Royce. Il maggiordomo miaprì la portiera e mi salutò con unariverenza. Entrai nell'abitacolo, chesembrava più una stanza d'albergo che lacabina di un veicolo a motore. L'auto simise in moto appena mi appoggiai alsedile e partì giù per la collina.
«Sa l'indirizzo?» domandai.
L'autista, una figura scura dall'altra partedel divisorio di vetro, fece un leggerocenno di assenso. AttraversammoBarcellona nel silenzio narcotico diquella carrozza di metallo che sembravasfiorare appena il suolo. Vidi sfilare
strade e palazzi dal finestrino come se sitrattasse di scogliere som-merse. Era giàpassata mezzanotte quando la Rolls-Royce nera svoltò in calle Comercio eimboccò il paseo del Born. Si fermòall'inizio di calle Flassaders, troppostretta per permetterne il passaggio.L'autista scese e mi aprì la portiera conun inchino. Scesi e lui la richiuse, poirisalì in macchina senza dire una parola.Lo vidi allontanarsi finché la sagomascura si dissolse in un velo di ombre. Michiesi cosa avevo fatto e, preferendonon trovare la risposta, mi incamminaiverso casa con la sensazione che ilmondo intero fosse una prigione senzapossibilità di fuga.
Entrato in casa, andai direttamente nellostudio. Aprii le finestre ai quattro venti elasciai che la brezza umida e infocatapenetrasse nella stanza.
Su alcuni tetti del quartiere si potevanoscorgere figure stese su materassi elenzuola che cercavano di sfuggire alcaldo asfissiante e di conciliare ilsonno. In lontananza, le tre grandiciminiere del Paralelo si innalzavanocome pire funebri, spargendo un mantodi cenere bianca che si stendeva sopraBarcellona come polvere di vetro. Piùvicino, la statua della Mercè chespiccava il volo dalla cupola dellachiesa mi ricordò l'angelo della Rolls-Royce e quello che Corelli sfoggiava
sempre sul risvolto. Sentivo che la città,dopo molti mesi di silenzio, tornava aparlarmi e a raccontarmi i suoi segreti.
Fu allora che la vidi, accoccolata sulloscalino di una porta di quel miserabile eangusto tunnel fra vecchi palazzichiamato calle Mosques. Isabella. Michiesi da quanto tempo fosse lì e midissi che non erano affari miei.
Stavo per chiudere la finestra e andarealla scrivania quando notai che non erasola. Dall'estremità del vicolo, un paiodi figure si avvicinavano lentamente alei, forse troppo. Sospirai, desiderandoche passassero oltre. Non lo fecero. Unasi appostò dall'altro lato, bloccando
l'uscita della strada.
L'altra si accovacciò davanti allaragazza, allungando il braccio verso dilei. Isabella si mosse. Qualche istantedopo le due figure si gettarono su di leie la sentii gridare.
Mi ci volle più o meno un minuto perarrivare fin lì. Quando lo feci, uno degliuomini teneva stretta Isabella per lebraccia e l'altro le aveva sollevato lagonna. Un'espressione di terroreattanagliava il viso della ragazza. Ilsecondo individuo, che si stava facendostrada fra le sue cosce tra le risate, lepuntava un coltello alla gola. Tre fili disangue gocciolavano dal taglio.
Mi guardai attorno. Un paio di casse dirottami e una pila di sampietrini emateriali da costruzione abbandonaticontro il muro. Afferrai quella che sirivelò una sbarra di metallo, solida epesante, di mezzo metro. Il primo adaccorgersi della mia presenza fu quellocon il coltello. Avanzai di un passo,brandendo la sbarra di metallo. Il suosguardo saltò dalla sbarra ai miei occhie vidi che gli moriva il sorriso sullelabbra. L'altro si girò e mi vide avanzareverso di lui con la sbarra sollevata.Bastò che gli facessi un cenno con latesta perché lasciasse Isabella e siaffrettasse a ripararsi dietro il suocompagno.
«Dài, andiamo» mormorò.
L'altro ignorò le sue parole. Miguardava fisso con il fuoco negli occhi eil coltello in mano.
«A te chi ti ha invitato, figlio diputtana?»
Senza staccare gli occhi dall'uomo conl'arma, presi Isabella per un braccio e lasollevai da terra. Cercai le chiavi intasca e gliele passai.
«Va' a casa» dissi. «Fa' come ti dico.»
Lei esitò un istante, ma poi sentii i suoipassi allontanarsi nel vicolo verso calleFlassaders. Il tipo con il coltello la vide
andare via e sorrise con rabbia.
«Ti faccio a fette, stronzo.»
Non dubitai della sua capacità e dellasua voglia di mettere in pratica laminaccia, ma qualcosa nel suo sguardomi faceva pensare che il mio av-versario non era del tutto imbecille: senon l'aveva ancora fatto, era perché sistava chiedendo quanto pesasse lasbarra di metallo che avevo in mano e,soprattutto, se avrei avuto la forza, ilcoraggio e il tempo di usarla perfracassargli il cranio prima che luipotesse affondare la lama del suocoltello.
«Provaci» lo sfidai.
Il tipo sostenne il mio sguardo perdiversi secondi e poi rise. Il ragazzo cheera con lui sospirò di sollievo. L'uomorichiuse la lama e sputò ai miei piedi. Sivoltò e si allontanò verso le ombre dacui era uscito, mentre il suo compagnogli trotterellava dietro come un canefedele.
Trovai Isabella accoccolata sulpianerottolo interno della casa dellatorre. Tremava e teneva le chiavi contutte e due le mani. Mi vide entrare e sialzò di scatto.
«Vuoi che chiami un medico?»
Scosse la testa.
«Sei sicura?»
«Non erano ancora riusciti a farminiente» mormorò, mordendosi lelacrime.
«Non mi è sembrato.»
«Non mi hanno fatto niente, d'accordo?»protestò.
«D'accordo» dissi.
Volevo sostenerla per un braccio mentresalivamo le scale, ma lei rifiutò ilcontatto.
Una volta in casa, l'accompagnai inbagno e accesi la luce.
«Hai un cambio di vestiti puliti dametterti?»
Isabella mi mostrò la borsa che portavacon sé e annuì.
«Su, lavati, mentre preparo qualcosa damangiare.»
«Come può avere fame adesso?»
«Be', ce l'ho.»
Isabella si morse il labbro inferiore.
«A dire il vero anch'io...»
«Discussione finita, allora» dissi.
Chiusi la porta del bagno e aspettai disentir scorrere l'acqua. Tornai in cucinae misi una pentola sul fuoco. Era rimastoun po' di riso, della pan-cetta e qualcheortaggio portato da Isabella la mattinaprima. Improvvisai qualcosa con quegliavanzi e aspettai quasi mezzora cheuscisse dal bagno, bevendomi quasimezza bottiglia di vino. La sentiipiangere di rabbia dall'altro lato delmuro. Quando comparve sulla portadella cucina aveva gli occhi arrossati esembrava più bambina che mai.
«Non so se ho ancora fame» mormorò.
«Siediti e mangia.»
Ci sedemmo alla piccola tavola al
centro della cucina. Isabella esaminòcon un certo sospetto il piatto di riso ebocconi vari che le avevo servito.
«Mangia» ordinai.
Prese una cucchiaiata esplorativa e se laportò alle labbra.
«È buono» disse.
Le versai mezzo bicchiere di vino eriempii il resto d'acqua.
«Mio padre non mi lascia bere vino.»
«Io non sono tuo padre.»
Cenammo in silenzio, scambiandoci
occhiate. Isabella svuotò il piatto emangiò il pezzo di pane che le avevotagliato. Sorrideva timidamente. Non sirendeva conto che lo spavento non le eraancora piombato addosso. Poil'accompagnai alla porta della sua stanzae accesi la luce.
«Cerca di riposare un po'» le dissi. «Sehai bisogno di qualcosa dai un colpo sulmuro. Sono nella stanza accanto.»
Isabella annuì.
«L'ho già sentita russare l'altra notte.»
«Io non russo.»
«Saranno state le tubature. O forse
qualche vicino che ha un orso.»
«Un'altra parola e te ne torni perstrada.»
Isabella sorrise e annuì.
«Grazie» bisbigliò. «Non chiuda deltutto la porta, per favore. La lascisocchiusa.»
«Buona notte» dissi spegnendo la luce elasciando Isabella nella penombra.
Più tardi, mentre mi spogliavo nella miastanza, notai che avevo un se-
gno scuro sulla guancia, come unalacrima nera. Mi avvicinai allo specchio
e lo strofinai con le dita. Era sanguesecco. Solo allora mi resi conto diessere esausto e di avere doloridappertutto.
10
La mattina dopo, prima che Isabella sisvegliasse, andai alla drogheria che lasua famiglia gestiva in calle Mirallers.Era da poco passata l'alba e la serrandadel negozio era mezza aperta. M'infilaidentro e trovai un paio di garzoni cheaccatastavano scatole di tè e altremercanzie sul bancone.
«È chiuso» disse uno di loro.
«Non sembra. Va' a chiamare il
proprietario.»
Mentre aspettavo, mi misi a esaminarel'emporio familiare dell'ingrata eredeIsabella, che nella sua infinita innocenzaaveva rinunciato al miele del commercioper abbassarsi alle miserie dellaletteratura. Il negozio era un piccolobazar di meraviglie provenienti da tuttigli angoli del mondo.
Marmellate, dolci e tè. Caffè, spezie econserve. Frutta e carni stagionate.
Cioccolata e insaccati affumicati. Unparadiso pantagruelico per tasche benfornite. Don Odón, padre della creaturae responsabile della ditta, si presentòdopo un po' con un camice blu, un paio
di baffi da maresciallo e un'espressionecosternata che lo situava inun'allarmante prossimità all'in-farto.Decisi di saltare le formalità.
«Mi dice sua figlia che lei ha un fucile adue canne con cui ha promesso diammazzarmi» dissi, aprendo le braccia acroce. «Eccomi qui.»
«E lei chi è, svergognato?»
«Sono lo svergognato che ha dovutoospitare una ragazza perché quelcalabrache di suo padre non è capace ditenerla in riga.»
La rabbia gli scivolò via dalla faccia eil negoziante mostrò un sorriso
angosciato e pusillanime.
«Signor Martín? Non l'avevoriconosciuta... Come sta la bambina?»
Sospirai.
«La bambina è sana e salva a casa mia,russando come un mastino, ma conl'onore e la virtù intatti.»
Il negoziante si fece il segno della crocedue volte di seguito, sollevato.
«Il Signore gliene renda merito.»
«E lei possa vedere quel momento, manel frattempo le chiedo di farmi il favoredi venirsela a riprendere entro oggi
oppure le spacco la faccia, fucile o no.»
«Fucile?» mormorò il negoziante,confuso.
Sua moglie, una donna minuta e dallosguardo nervoso, ci spiava da dietro unatenda che nascondeva il retrobottega.Qualcosa mi diceva che non cisarebbero state sparatorie. Don Odón,sbuffando, sembrò afflosciarsi su sestesso.
«Non desidero altro, signor Martín. Peròla bambina non vuole stare qua» spiegò,desolato.
Vedendo che il negoziante non era l'orcodipinto da Isabella, mi pentii del tono
delle mie parole.
«Non è stato lei a cacciarla di casa?»
Don Odón spalancò gli occhi comepiatti, afflitto. Sua moglie si fece avantie gli prese la mano.
«Abbiamo avuto una discussione. Sisono dette cose che non si sarebberodovute dire, da entrambe le parti. Ma ilfatto è che la bambina ha un carattereche tienila... Ha minacciato di andarsenedicendo che non l'avremmo rivista maipiù. Quella santa donna di sua madre perpoco non ci rimane per la tachicardia. Ioho alzato la voce e ho detto che l'avreimessa in convento.»
«Un argomento infallibile perconvincere una ragazza di sedici anni»notai.
«È la prima cosa che mi è venuta inmente...» spiegò il negoziante.
«Come avrei potuto metterla inconvento?»
«A quanto ho visto, solo con l'aiuto di unintero reggimento della Guardia Civil.»
«Non so cosa le abbia raccontato labambina, signor Martín, ma non lecreda. Non saremo persone raffinate, manon siamo neanche mostri. Io non so piùcome gestirla. Non sono il tipo d'uomocapace di togliersi la cinta e farla
ubbidire a cinghiate. E la mia signoraqui presente non alza la voce nemmenocon il gatto. Non so dove la bambinaabbia preso quel carattere.
Credo a furia di leggere tanto. E guardiche le suore ci avevano avvisato.
Lo diceva mio padre, che riposi in pace:il giorno in cui si permetterà alle donnedi imparare a leggere e scrivere, ilmondo sarà ingovernabile.»
«Gran pensatore, suo padre, ma questonon risolve né il suo problema né ilmio.»
«E cosa possiamo fare? Isabella nonvuole stare con noi, signor Martín.
Dice che siamo ottusi, che non lacapiamo, che vogliamo seppellirla inquesto negozio... Cos'altro potreidesiderare se non capirla? Lavoro quida quando avevo sette anni, dall'alba altramonto, e l'unica cosa che ho capito èche il mondo è un posto repellente esenza riguardi per una ragazzina con latesta fra le nuvole» spiegò il negoziante,appoggiandosi a un barile. «La miapaura è che, se la costringo a tornare, ciscappi davvero e finisca nelle mani diqualche. .. Non voglio nemmenopensarci.»
«È vero» aggiunse sua moglie, cheparlava con un pizzico di accentoitaliano. «Creda, la bambina ci ha
spezzato il cuore, però non è la primavolta che se ne va. È venuta uguale a miamadre, che aveva un caratterenapoletano...»
«Ah, la mamma1» ricordò don Odón,atterrito solo all'evocare la memoriadella suocera.
«Quando ha detto che veniva ad abitarea casa sua per qualche giorno mentrel'aiutava nel lavoro, ci siamotranquillizzati un po'» continuò la madredi Isabella «perché sappiamo che lei èuna brava persona e in fondo la bambinaè qui vicino, a due strade da qui.Sappiamo che lei saprà con-vincerla atornare.»
Mi chiesi cosa avesse raccontatoIsabella di me per convincerli che ilsottoscritto camminava sull'acqua.
«Proprio ieri notte, a un tiro di schioppoda qui, hanno riempito di botte un paiodi operai che tornavano a casa. Mi dicalei. Pare che li abbiano colpiti con unferro fino a ridurli come stracci. Diconoche non si sa se uno sopravviverà e chel'altro rimarrà sciancato per tutta lavita» disse la madre. «In che mondoviviamo?»
Don Odón mi guardò, costernato.
«Se vengo a prenderla, se ne andrà dinuovo. E stavolta non so se incontreràuno come lei. Sappiamo che non sta
bene che una ragazzina abiti nella casadi uno scapolo, ma almeno ci risulta chelei è onesto e saprà averne cura.»
Il negoziante sembrava sul punto discoppiare a piangere, Avrei preferitoche corresse a prendere il fucile. C'erasempre la possibilità che qualche cuginonapoletano si presentasse dalle nostreparti con uno schioppo in mano persalvaguardare l'onore della bambina.Porca miseria2 .
«Ho la sua parola che se ne prenderàcura finché recupera l'uso della ragionee torna a casa?»
Sbuffai.
«Ha la mia parola.»
Tornai a calle Flassaders carico dighiottonerie e leccornie che don Odón 1In italiano nel testo.
2 In italiano nel testo.
e sua moglie vollero affibbiarmi comeomaggio della casa. Ribadii che mi sareioccupato di Isabella per qualche giornofin quando non avesse messo giudizio ecapito che il suo posto era con la suafamiglia. I commercianti insistettero apagarmi per il suo mantenimento,proposta che rifiutai. Il mio piano erache nel giro di una settimana Isabellatornasse a dormire a casa sua, anche seper riuscirci avrei dovuto mantenere la
finzione che fosse la mia assistentedurante il giorno. Erano cadute torri benpiù alte.
Entrando in casa, la trovai seduta altavolo della cucina. Aveva lavato tutti ipiatti della sera prima, aveva fatto ilcaffè e si era vestita e pettinata comeuna santa uscita da un'immaginetta.Isabella, che non era stupida nemmenoun po', sapeva perfettamente da dovevenivo e si armò del suo sguardomigliore da cane abbandonato e misorrise, sottomessa. Lasciai le borse conla scorta di delizie di don Odónsull'acquaio e la guardai.
«Mio padre non le ha sparato?»
«Aveva finito le munizioni e ha decisodi lanciarmi tutti questi vasetti dimarmellata e questi pezzi di formaggiomanchego. »
Isabella strinse le labbra, facendo unafaccia di circostanza.
«Sicché il nome Isabella è per via dellanonna?»
«La mamma3» confermò. «Nel suoquartiere la chiamavano la Vesuvia.»
«Ci credo.»
«Dicono che assomiglio un poco a lei.Per l'ostinazione.»
Non c'era bisogno di un notaio perattestarlo, pensai.
«I tuoi genitori sono brave persone,Isabella. Non ti capiscono meno diquanto tu capisca loro.»
La ragazza non disse nulla. Mi versò unatazza di caffè e attese il verdet-to. Avevodue possibilità: cacciarla di casa e farmorire di crepacuore la coppia dinegozianti o fare di necessità virtù earmarmi di pazienza per due o tre giorni.Immaginai che quarantott'ore della miaincarnazione più cinica e sferzantesarebbero bastate a spezzare la ferreadeterminazione di una ragazzina e arispedirla in ginocchio alle gonne della
madre implorando perdono e alloggio apensione completa.
«Puoi restare qui per il momento...»
«Grazie!»
«Non correre. Puoi restare a condizioneche, uno, ogni giorno passi un momentoin negozio per salutare i tuoi genitori edire che stai bene, e, due, che miobbedisca e rispetti le regole di questacasa.»
Il discorsetto suonava patriarcale, maeccessivamente magnanimo. Man-
3 In italiano nel testo.
tenni l'espressione severa e decisi diforzare un po' i toni.
«E quali sono le regole di questa casa?»domandò Isabella.
«Fondamentalmente, quello che a me migira.»
«Mi sembra giusto.»
«Affare fatto, allora.»
Isabella aggirò la tavola e mi abbracciòcon gratitudine. Sentii il calore e leforme sode del suo corpo didiciassettenne contro il mio. La scostaicon delicatezza e la tenni a un metro didistanza.
«La prima regola è che questo non èPiccole donne e qui non ci abbrac-ciamo e non scoppiamo a piangereall'improvviso.»
«Come vuole lei.»
«Ecco il motto su cui costruiremo lanostra convivenza: come voglio io.»
Isabella rise e partì rapida verso ilcorridoio.
«Dove credi di andare?»
«A mettere in ordine il suo studio. Nonvorrà lasciarlo com'è, vero?»
11
Avevo bisogno di un posto dove pensaree sfuggire allo zelo domestico eall'ossessione per la pulizia della mianuova assistente, così andai allabiblioteca che occupava la navata adarcate gotiche dell'antico ospiziomedievale di calle del Carmen. Passai ilresto della giornata circondato davolumi che odoravano di sepolcropapale, leggendo di mitologia e storiadelle religioni finché gli occhi nonfurono sul punto di cadermi sulla tavolae di ruzzolare fuori dalla biblioteca.Dopo ore di letture senza tregua,calcolai di avere a stento raggranellatouna milionesima parte di quello chepotevo trovare sotto le arcate di quelsantuario di libri, per non parlare di
tutto quello che si era scrittosull'argomento. Decisi che sarei tornatoil giorno dopo, e quello dopo ancora, eche avrei dedicato almeno un'interasettimana ad alimentare la caldaia delmio pensiero con pagine e pagine su dèi,miracoli e profezie, santi e apparizioni,rivelazioni e misteri. Qualunque cosapur di non pensare a Cristina e donPedro e alla loro vita matrimoniale.
Visto che disponevo di un'assistentesollecita, le diedi istruzioni perché siprocurasse copie dei libri di catechismoe dei testi scolastici utilizzati in città perl'insegnamento della religione e me nestilasse poi un riassunto.
Isabella non discusse gli ordini, maaggrottò le sopracciglia quando liricevette.
«Voglio sapere per filo e per segnocome viene insegnato ai bambini tuttol'ambaradan, dall'arca di Noè almiracolo dei pani e dei pesci» spiegai.
«E a che scopo?»
«Perché sono fatto così e ho un ampioventaglio di curiosità.»
«Si sta documentando per una nuovaversione del Dolce cuore di Gesù fa'ch'io t'ami sempre più?»
«No. Ho in mente una versione
romanzata delle avventure di Catalina deErauso, la suora soldato. Tu limitati afare quello che ti dico e non discutere oti rispedisco al negozio dei tuoi avendere cotognate a tutto spiano.»
«Lei è un despota.»
«Sono contento che a poco a poco ciconosciamo.»
«Ha a che fare con il libro che devescrivere per quell'editore, Corelli?»
«Può darsi.»
«Mi sa che questo libro non hapossibilità commerciali.»
«E tu che ne sai?»
«Più di quanto lei creda. E non c'èbisogno che faccia così, perché cercosolo di aiutarla. O ha deciso di nonessere più uno scrittore professionista edi trasformarsi in un dilettante da caffè epasticcini?»
«Al momento sono occupato a fare labambinaia.»
«Io non tirerei in ballo chi fa dabambinaia a chi, perché l'avrei vintaprima di cominciare.»
«E di cosa vorrebbe discutere vostraeccellenza?»
«L'arte commerciale contrapposta allestupidaggini con tanto di morale.»
«Cara Isabella, mia piccola Vesuvia:nell'arte commerciale, e ogni arte degnadi questo nome prima o poi diventacommerciale, la stupidità sta quasisempre nello sguardo dell'osservatore.»
«Mi sta dando della stupida?»
«Ti sto richiamando all'ordine. Fa'quello che ti dico. E punto. Zitta.»
Indicai la porta e Isabella sbarrò gliocchi, mormorando qualche impro-perioche non riuscii a sentire mentre siallontanava lungo il corridoio.
Mentre Isabella batteva scuole e libreriealla ricerca di libri di testo e dicatechismo da riassumere, io mi recavoalla biblioteca del Carmen adapprofondire la mia educazioneteologica, impegno che intraprendevocon stravaganti dosi di caffè e distoicismo. I primi sette giorni di quellastrana creazione non partorirono altroche dubbi. Una delle poche certezzetrovate fu che la stragrande maggioranzadegli autori che si erano sentiti chiamatia scrivere di cose divine, umane e sacredovevano essere studiosi dotti e pii almassimo grado, ma come scrittori eranouna palla. Il sofferente lettore costretto ascivolare sulle loro pagine dovevamettercela tutta per non cadere in uno
stato di coma indotto dalla noia a ognipunto e a capo.
Dopo essere sopravvissuto a migliaia dipagine sull'argomento, cominciavo adavere l'impressione che le centinaia difedi religiose catalogate nel corso dellastoria della stampa risultasserostraordinariamente simili tra loro.Attribuii questa prima impressione allamia ignoranza o a una mancanza didocumentazione adeguata, ma nonriuscivo a scacciare l'idea di averpassato in rassegna decine di storiepoliziesche in cui l'assassino cambiava,ma la meccanica della trama eraessenzialmente sempre la stessa. Miti eleggende, sia sulle divinità sia sulla
formazione e la storia di popoli e razze,cominciarono a sembrarmi immagini dirompicapo poco differenziati e costruitisempre con le stesse tessere, anche se inun ordine diverso.
Dopo due giorni ero già diventato amicodi Eulalia, la bibliotecaria, che miselezionava testi e tomi nell'oceano dicarta di cui era responsabile e che ditanto in tanto veniva a trovarmi al miotavolo d'angolo per chiedermi se avessibisogno di qualcos'altro. Doveva averela mia età e l'intelli-genza le sprizzavadagli occhi, di solito sotto forma difrecciate acuminate e vagamentevelenose.
«Sta leggendo un bel po' su santi eaffini... Ha deciso di farsi chierichettoadesso, alle soglie della maturità?»
«È solo per documentazione.»
«Ah, dicono tutti così.»
Le battute e l'ingegno della bibliotecariaoffrivano un balsamo impagabile persopravvivere a quei testi pesanti comemacigni e per proseguire nel miopellegrinaggio documentativo. QuandoEulalia aveva un po' di tempo liberoveniva al mio tavolo e mi aiutava amettere ordine in quel guazzabuglio.Erano pagine in cui abbondavanoracconti di padri e figli, madri pure esante, tradimenti e conversioni, profezie
e profeti martiri, inviati del cielo o delparadiso, neonati venuti al mondo persalvare l'universo, entità malefichedall'aspetto raccapricciante e dallamorfologia solitamente ani-malesca,esseri eterei e dai tratti razzialiaccettabili che erano agenti del bene ederoi sottoposti a tremende prove daldestino. Si percepiva sempre l'ideadell'esistenza terrena come una specie distazione di passaggio, che invitava alladocilità e all'accettazione del destino edelle norme della tribù, perché laricompensa si trovava sempre in unaldilà che prometteva paradi-
si ricolmi di tutto ciò di cui si era privinella vita mondana.
A mezzogiorno del giovedì, in una dellesue pause, Eulalia mi si avvicinò e michiese se, a parte leggere messali, ditanto in tanto mangiavo. La invitai apranzo a Casa Leopoldo, che aveva dapoco aperto lì vicino. Mentredegustavamo uno squisito stufato di codadi toro, mi raccontò che faceva quelmestiere da due anni e che da altri duestava lavorando a un romanzo che non leriusciva e che aveva come scenarioprincipale la biblioteca del Carmen, eper tema una serie di misteriosi delittiperpetrati al suo interno.
«Mi piacerebbe scrivere qualcosa disimile a quei romanzi di qualche anno fadi Ignatius B. Samson» disse. «Le dice
qualcosa?»
«Vagamente» risposi.
Eulalia non riusciva a elaborare la tramadel suo romanzo e io le suggerii di dareal tutto un tono leggermente sinistro e diincentrare la vicenda su un libro segretoposseduto da uno spirito tormentato, consottotrame di apparente contenutosovrannaturale.
«È quello che farebbe Ignatius B. al suoposto» azzardai.
«E cosa ci fa lei con tutte quelle letturesu angeli e demoni? Non mi dica che èun ex seminarista pentito.»
«Sto cercando di appurare cos'hanno incomune le origini di religioni e mitidiversi» spiegai.
«E cos'ha imparato finora?»
«Quasi niente. Non la voglio annoiarecon il miserere.»
«Non mi annoia. Racconti.»
Mi strinsi nelle spalle.
«Be', quello che finora ho trovato piùinteressante è che la maggioranza diqueste credenze nasce da un fatto o da unpersonaggio probabilmente storico, mapresto si evolve in movimenti socialimodellati dalle circostanze politiche,
economiche e sociali del gruppo che leaccetta. È ancora sveglia?»
Eulalia annuì.
«Buona parte della mitologia che sisviluppa attorno a ciascuna di questedottrine, dalle liturgie alle norme e aitabù, proviene dalla burocrazia che sigenera via via che evolvono, e non dalpresunto evento soprannaturale da cuihanno avuto origine. La maggioranzaparte da aneddoti semplici e sicu-ri, unmisto di senso comune e di folclore, etutta la carica bellicosa che sviluppaderiva dall'interpretazione posteriore diquei princìpi, quando non tendono asnaturarsi per opera dei loro
amministratori. L'aspetto ammini-
strativo e gerarchico sembra la chiavedella loro evoluzione. All'inizio laverità viene rivelata a tutti gli uomini,ma rapidamente compaiono indivi-duiche si attribuiscono la potestà e ildovere di interpretare, amministrare e,nel caso, alterare quella verità in nomedel bene comune. A questo scopofondano un'istituzione potente epotenzialmente repressiva. Questo feno-meno, tipico di tutti i gruppi di animalisociali, come ci insegna la biologia, nontarda a trasformare la dottrina in unelemento di controllo e di battagliapolitica. Prima o poi, la parola si fasangue, e la carne sanguina.»
Mi sembrò di cominciare a parlare comeCorelli e sospirai. Eulalia sorridevadebolmente e mi osservava con qualcheriserva.
«È questo che cerca? Sangue?»
«Come si dice? Per imparare bisognasputare sangue, non al contrario.»
«Io non ne sarei tanto sicura.»
«Intuisco che lei ha frequentato unascuola di suore.»
«Le dame nere. Otto anni.»
«È vero quello che si dice, che sonoproprio le alunne delle scuole di suore a
covare i desideri più oscuri einconfessabili?»
«Scommetto che le piacerebbescoprirlo.»
«Punti tutte le fiches sul sì.»
«Cos'altro ha imparato nel suo corsoaccelerato di teologia per mentifervide?»
«Poco altro. Le mie prime conclusionimi hanno lasciato un retrogusto dibanalità e incongruenza. Tutto questo misembrava già più o meno evidente senzabisogno di divorare enciclopedie etrattati sul sesso degli angeli, forseperché non sono in grado di superare i
miei pregiudizi o perché non c'è nienteda capire e il nocciolo della questionesta semplicemente nel credere o no,senza soffermarsi sul perché. Come lepare la mia retorica?
Continua a impressionarla?»
«Mi fa venire la pelle d'oca. Peccatonon averla conosciuta quando ero unastudentessa dagli oscuri desideri.»
«Lei è crudele, Eulalia.»
La bibliotecaria rise di gusto e miguardò a lungo negli occhi.
«Mi dica, Ignatius B., chi le ha spezzatoil cuore con tanta rabbia?»
«Vedo che lei sa leggere anche altro,oltre ai libri.»
Rimanemmo seduti ancora alcuni minuti,osservando l'andirivieni dei camerierinella sala di Casa Leopoldo.
«Sa qual è il bello dei cuori infranti?»domandò la bibliotecaria.
Scossi la testa.
«Che possono rompersi davverosoltanto una volta. Il resto sono graffi.»
«Lo metta nel suo libro.»
Indicai il suo anello di fidanzamento.
«Non so chi sia quel citrullo, ma speroche sappia di essere l'uomo piùfortunato del mondo.»
Eulalia sorrise con una certa tristezza eannuì. Tornammo in biblioteca e ognunoriprese il proprio posto, lei alla suascrivania e io al mio angolo.
Mi accomiatai da lei il giorno dopo,quando decisi che non potevo né volevoleggere nemmeno un altro rigo surivelazioni e verità eterne. Sulla stradadella biblioteca le comprai una rosabianca da un fioraio delle Ramblas egliela lasciai sulla scrivania. La trovaiin uno dei corridoi che sistemava libri.
«Già mi abbandona, così presto?» disse
quando mi vide. «Chi mi farà icomplimenti adesso?»
«Chi non glieli farà?»
Mi accompagnò all'uscita e mi strinse lamano in cima alla scalinata che portavaal cortile del vecchio ospedale.M'incamminai giù per le scale. A metàstrada mi fermai e mi voltai. Era ancoralì, a osservarmi.
«Buona fortuna, Ignatius B. Spero chetrovi quello che cerca.»
12
Mentre cenavo con Isabella alla tavoladel salotto, notai che la mia nuova
assistente mi guardava di sottecchi.
«Non le piace la minestra? Non l'hatoccata...» azzardò la ragazza.
Guardai il piatto intatto che avevolasciato raffreddare. Presi unacucchiaiata e feci finta di provare losquisito manicaretto.
«Buonissima» concessi.
«E non ha detto nemmeno una parola daquando è tornato dalla biblioteca»aggiunse Isabella.
«Qualche altro reclamo?»
Isabella sviò lo sguardo, infastidita.
Mangiai la minestra fredda senzaappetito, un pretesto per non dover fareconversazione.
«Perché è così triste? È per quelladonna?»
Lasciai il cucchiaio nel piatto.
Non risposi e continuai a rimestare nellaminestra con il cucchiaio. Isabella nonmi toglieva gli occhi di dosso.
«Si chiama Cristina» dissi. «E non sonotriste. Sono contento per lei per-
ché ha sposato il mio migliore amico esarà molto felice.»
«E io sono la regina di Saba.»
«Tu sei solo una ficcanaso.»
«Mi piace di più così, quando è dicattivo umore e dice la verità.»
«Allora vediamo se ti piace questo:smamma nella tua stanza e lasciami inpace una buona volta.»
Cercò di sorridere, ma quando allungaila mano verso di lei gli occhi le si eranoriempiti di lacrime. Prese il mio piatto eil suo e fuggì in cucina.
Sentii i piatti cadere nell'acquaio e,qualche secondo dopo, la porta della suastanza chiudersi di botto. Sospirai e
assaporai il bicchiere di vino rimasto,un vinello squisito che veniva dalnegozio dei genitori di Isabella. Dopo unpo' mi avvicinai alla porta della suastanza e bussai leggermente con lenocche. Non rispose, ma potevo sentirlasinghiozzare. Cercai di aprire, ma laragazza aveva chiuso dall'interno.
Salii nello studio, che dopo il passaggiodi Isabella odorava di fiori freschi esembrava la cabina di una nave dacrociera di lusso. Isabella aveva messoin ordine i libri, spolverato e lasciatotutto brillante e irriconoscibile.
La vecchia Underwood sembrava unascultura e le lettere della tastiera si
leggevano di nuovo senza difficoltà. Unapila di fogli accuratamente ordinatigiaceva sulla scrivania con i riassunti divari testi scolastici di religione ecatechesi insieme alla corrispondenzadel giorno. In un piattino da caffèc'erano un paio di sigari chesprigionavano un profumo moltogradevole. Macanudos, una delle deliziecubane che un contatto nella Manifattu-ra Tabacchi passava sottobanco al padredi Isabella. Ne presi uno e l'accesi.Aveva un sapore intenso che lasciavaintuire nel suo respiro tiepido tutti gliaromi e i veleni che un uomo potevadesiderare per morire in pace. Misedetti alla scrivania ed esaminai lelettere della giornata. Le ignorai tutte
meno una, di carta pergamena ocraornata da quella calligrafia che avreiriconosciuto dovunque. La missiva delmio nuovo editore e mecenate, AndreasCorelli, mi dava appuntamento ladomenica a metà pomeriggio in cimaalla torre della nuova funivia cheattraversava il porto di Barcellona.
La torre di San Sebastián si innalzava acento metri d'altezza in un ammasso dicavi e acciaio che provocava levertigini al solo vederlo. La linea dellafunivia era stata inaugurata quello stessoanno per l'Esposizione Universale cheaveva messo tutto a soqquadro ecostellato Barcellona di portenti. Lafunivia attraversava la darsena del porto
da quella prima torre a un pilastrocentrale che ricordava la torre Eiffel eserviva da fulcro e dal quale partivanole cabine sospese nel vuoto nellaseconda parte del tragitto fino alMontjuïc, dove si trovava il cuoredell'Esposizione. Il prodigio dellatecnica prometteva panorami della cittàfino a quel momento consentiti solo adirigibili, uccelli di una certa grandezzae chicchi di grandine. Per come lavedevo io, gli uomini e i gabbiani nonerano stati concepiti per condividere lostesso spazio aereo, e appena entrainell'ascensore che saliva in cima allatorre sentii lo stomaco restringersi fino adiventare una biglia.
L'ascesa mi sembrò infinita, e losferragliare di quella capsula di latta unautentico esercizio di nausea.
Trovai Corelli intento a guardare da unodei finestroni affacciati sulla darsena delporto e sulla città intera, gli occhiperduti negli acquerelli di vele e alberiche scivolavano sull'acqua. Indossavaun completo di seta bianca egiocherellava con una zolletta dizucchero che teneva fra le dita e cheinghiottì con voracità da lupo.Tossicchiai e il mio principale si girò,sorridendo compiaciuto.
«Un panorama meraviglioso, non lepare?» domandò Corelli.
Annuii, bianco come un foglio.
«Le fa impressione l'altezza?»
«Sono un animale di superficie» risposi,tenendomi a una distanza prudenzialedalla finestra.
«Mi sono permesso di comprare bigliettidi andata e ritorno» m'informò.
«Troppo gentile.»
Lo seguii fino alla passerella d'accessoalle cabine che partivano dalla torre erimanevano sospese nel vuoto a quasi uncentinaio di metri d'altezza per un tempoche mi sembrava infinito.
«Come ha trascorso la settimana,Martín?»
«Leggendo.»
Mi guardò brevemente.
«Dalla sua espressione annoiatasospetto che non si trattava di AlexandreDumas.»
«Piuttosto di una collezione di forforosiaccademici con la loro prosa dicemento.»
«Ah, intellettuali. E lei voleva che neassumessi uno. Perché mai, se si ha cosìpoco da dire, lo si dice nella manierapiù pomposa e pedante possibile?»
chiese Corelli. «Sarà per ingannare glialtri o se stessi?»
«Forse tutte e due le cose.»
Il principale mi consegnò i biglietti e mifece cenno di passare per primo. Lidiedi al controllore che teneva aperta laporta della cabina. Entrai senza alcunentusiasmo. Decisi di stare al centro, ilpiù lontano possibile dai vetri. Corellisorrideva come un bambino euforico.
«Forse parte del suo problema è che haletto i commentatori e non i commentati.Un errore abituale, ma fatale, quando sivuole imparare qualcosa di utile»osservò Corelli.
Le porte della cabina si chiusero e unbrusco scossone ci mandò in orbi-ta. Miaggrappai a una sbarra di metallo erespirai a fondo.
«Intuisco che gli studiosi e i teorici nonsono santi di cui lei è devoto»
dissi.
«Non sono devoto di nessun santo,amico mio, e men che meno di quelli chesi canonizzano da soli o tra di loro. Lateoria è la pratica degli impo-tenti. Lesuggerisco di lasciare da parte glienciclopedisti e i loro articoli e diandare direttamente alle fonti. Mi dica,ha letto la Bibbia?»
Esitai un istante. La cabina si affacciònel vuoto. Guardai a terra.
«Frammenti qui e là, suppongo»mormorai.
«Suppone. Come quasi tutti. Graveerrore. Tutti dovrebbero leggere laBibbia. E rileggerla. Credenti e noncredenti, fa lo stesso. Io la rileggoalmeno una volta all'anno. È il mio libropreferito.»
«E lei è un credente o uno scettico?»chiesi.
«Sono un professionista. E anche lei.Quello che crediamo o no è irrilevanteper portare a termine il nostro lavoro.
Credere o non credere è un atto dapusillanimi. Si sa o non si sa, punto.»
«Allora confesso che non so nulla.»
«Continui su questa strada e incontrerà ipassi del grande filosofo. E
lungo la strada legga la Bibbia dall'aalla zeta. È una delle più grandi storiemai raccontate. Non commetta l'errore diconfondere la parola di Dio conl'industria del messale che di quellavive.»
Più tempo passavo in compagniadell'editore, meno ero convinto dicapirlo.
«Credo di essermi perso. Stiamoparlando di leggende e favole e leiadesso mi dice di pensare alla Bibbiacome alla parola letterale di Dio?»
Un'ombra d'impazienza e irritazione gliannebbiò lo sguardo.
«Parlo in senso figurato. Dio non è unciarlatano. La parola è moneta umana.»
A quel punto mi sorrise come si sorridea un bambino che non è in grado dicapire le cose più elementari, per nondargli uno schiaffo. Osservandolo, miresi conto che era impossibile saperequando l'editore parlasse sul serio oscherzasse. Impossibile comeindovinare lo scopo di quella
stravagante impresa per la quale mistava pagando uno stipendio da monarcareggente.
In più, la cabina si agitava al ventocome una mela su un albero sferzato daun uragano. Non avevo mai pensato tantoa Isaac Newton in tutta la mia vita.
«Lei è un fifone, Martín. Questomarchingegno è completamente sicuro.»
«Ci crederò quando tocchiamo terra.»
Ci stavamo avvicinando al puntomediano del tragitto, la torre di SanJaime, che si innalzava tra i moli vicinial grande palazzo delle Dogane.
«Le dispiace se scendiamo qui?»domandai.
Corelli fece spallucce e annuìcontrovoglia. Non respirai con calma finquando non fui sull'ascensore della torree lo sentii toccare terra. Uscendo suimoli trovammo una panchina cheguardava le acque del porto e ilMontjuic e ci sedemmo a osservare lafunivia sopra di noi; io con sollievo,Corelli con rimpianto.
«Mi parli delle sue prime impressioni.Di quello che le hanno suggerito questigiorni di studio e di lettura intensiva.»
Riassunsi quello che credevo di avereimparato, o disimparato, in quei giorni.
L'editore ascoltava attento, annuendo egesticolando con le mani.
Alla fine del mio rapporto tecnico sumiti e credenze dell'essere umano,Corelli si pronunciò positivamente.
«Credo che lei abbia fatto un eccellentelavoro di sintesi. Non ha trovato ilproverbiale ago nel pagliaio, ma hacapito che l'unica cosa davverointeressante del mucchio di paglia è undannato spillo e tutto il resto è cibo pergli asini. A proposito di asini, mi dica,le interessano le favole?»
«Da bambino, per un paio di mesi,volevo essere Esopo.»
«Tutti lasciamo grandi speranze lungo ilcammino.»
«Cosa voleva essere da bambino, signorCorelli?»
«Dio.»
Il suo sorriso da sciacallo cancellò ilmio di colpo.
«Martín, le favole sono probabilmenteuno dei meccanismi letterari piùinteressanti che siano stati inventati. Sache cosa ci insegnano?»
«Lezioni morali?»
«No. Ci insegnano che gli esseri umani
imparano e assorbono idee e concettiattraverso narrazioni, storie, nonattraverso lezioni magistrali o discorsiteorici. La stessa cosa ci insegnaqualunque grande testo religioso.
Si tratta sempre di racconti conpersonaggi che devono affrontare la vitae superare ostacoli, figure che siimbarcano in un viaggio diarricchimento spirituale attraversoperipezie e rivelazioni. Tutti i libri sacrisono, prima di tutto, grandi storie le cuitrame affrontano gli aspetti fondamentalidella natura umana e li collocano in undeterminato contesto morale e in unacornice di dogmi sovrannaturali. Hopreferito che trascorresse una settimana
infelice a leggere tesi, discorsi, opinionie commenti perché si rendesse conto dasolo che da quelli non c'è niente daimparare. Di fatto sono solo esercizi dibuona o cattiva volontà, normalmentefalliti, per cercare di imparare a lorovolta. Sono finite le conversazioni excathedra. A partire da oggi voglio cheinizi a leggere i racconti dei fratelliGrimm, le tragedie di Eschilo, ilRamayana o le leggende celtiche. Leistesso. Voglio che analiz-zi comefunzionano quei testi, che ne distillil'essenza e i motivi per cui provocanouna reazione emotiva. Voglio che imparila grammatica, non la morale dellafavola. E voglio che fra due o tresettimane mi porti qualcosa di suo,
l'inizio di una storia. Voglio che mifaccia credere.»
«Pensavo che eravamo professionisti enon potevamo commettere il peccato dicredere in qualcosa.»
Corelli sorrise, mostrando i denti.
«Si può convertire solo un peccatore,mai un santo.»
13
I giorni passavano fra letture e intoppi.Abituato da anni a vivere da solo e aquello stato di metodica e sottovalutataanarchia tipico del maschio scapolo, lacostante presenza di una donna in casa,
per quanto fosse un'a-dolescente discolae dal carattere lunatico, cominciava aminare le mie abi-tudini in modo sottilema sistematico. Io credevo nel disordinecategoriz-zato; Isabella no. Io credevoche gli oggetti trovano il proprio postonel caos di una casa; Isabella no. Iocredevo nella solitudine e nel silenzio;Isabella no. Nel giro di un paio di giorniscoprii che non ero in grado di trovarealcunché nella mia stessa casa. Secercavo un tagliacarte o un bicchiere oun paio di scarpe, dovevo domandare aIsabella dove la provvidenza le avevaispirato di nasconderli.
«Non nascondo niente. Metto le cose alloro posto, che è diverso.»
Non passava giorno in cui non provassil'impulso di strangolarla una mezzadozzina di volte. Quando mi rifugiavonello studio in cerca di pace e ditranquillità per pensare, Isabellacompariva dopo pochi minuti con unatazza di tè o dei pasticcini, sorridente.Cominciava ad aggirarsi per lo studio, siaffacciava alla finestra, iniziava amettere in ordine il ripiano dellascrivania e poi mi chiedeva cosa cifacessi lassù, così silenzioso e pieno dimistero. Scoprii che le ragazze didiciassette anni possiedono una talecapacità verbale che il loro cervello lespinge a esercitarla ogni venti secondi.
Il terzo giorno decisi che bisognava
trovarle un fidanzato, possibilmentesordo.
«Isabella, come è possibile che unaragazza carina come te non abbiapretendenti?»
«Chi ha detto che non ce li ho?»
«Non c'è nessun ragazzo che ti piace?»
«I ragazzi della mia età sono noiosi. Nonhanno niente da dire e la metà sembranoscemi con la nocca.»
Stavo per dirle che con l'età nonmiglioravano, ma non volli rovinarle lafesta.
«Allora di che età ti piacciono?»
«Anziani. Come lei.»
«Ti sembro anziano?»
«Be', non è più un pivellino.»
Preferii credere che mi stesse prendendoin giro piuttosto che incassare quelcolpo basso alla mia vanità. Decisi dicavarmela con qualche goccia disarcasmo.
«La buona notizia è che alle ragazzinepiacciono gli uomini anziani, e la cattivache agli uomini anziani, e specialmente aquelli decrepiti e bavosi, piacciono leragazzine.»
«Lo so. Non creda che mi succhi ancorail dito.»
Isabella mi osservò, macchinandoqualcosa, e sorrise con malizia. Eccoci,pensai.
«E anche a lei piacciono le ragazzine?»
Avevo la risposta sulle labbra prima chemi facesse la domanda. Adottai un tonodidattico ed equanime, da cattedratico digeografia.
«Mi piacevano quando avevo la tua età.Generalmente mi piacciono le ragazzedella mia.»
«Alla sua età non sono più ragazze, sono
signorine o, se proprio ci tiene,signore.»
«Fine del dibattito. Non hai niente dafare di sotto?»
«No.»
«Allora mettiti a scrivere. Non ti tengoqui per lavare i piatti e nascondermi lecose. Ti tengo perché mi hai detto chevolevi imparare a scrivere e io sonol'unico idiota che conosci in grado diaiutarti a farlo.»
«Non c'è bisogno che si arrabbi. È chemi manca l'ispirazione.»
«L'ispirazione viene quando si mettono i
gomiti sul tavolo, il culo sulla sedia e sicomincia a sudare. Scegli un tema,un'idea e spremiti le meningi fin quandoti fanno male. Questa si chiamaispirazione.»
«Il tema ce l'ho già.»
«Alleluia.»
«Scriverò su di lei.»
Un lungo silenzio di sguardi scambiati,di avversari che si fissano al di sopradella scacchiera.
«Perché?»
«Mi sembra interessante. E strano.»
«E anziano.»
«E suscettibile. Quasi come un ragazzodella mia età.»
Mio malgrado, stavo cominciando adabituarmi alla compagnia di Isabella,alle sue frecciate e alla luce che avevaportato in quella casa. Se le cosefossero andate avanti così, le miepeggiori paure si sarebbero concre-tizzate e avremmo finito per diventareamici.
«E lei ce l'ha già un tema con tutti queilibracci che sta consultando?»
Decisi che meno avessi raccontato aIsabella del mio incarico, meglio
sarebbe stato.
«Sono ancora nella fase delladocumentazione.»
«Documentazione? E come funziona?»
«Fondamentalmente, si leggono migliaiadi pagine per imparare il necessario earrivare all'essenziale di un tema, allasua verità emotiva, e poi si disimparatutto per iniziare da zero.»
Isabella sospirò.
«Cos'è la verità emotiva?»
«È la sincerità all'interno dellafinzione.»
«Allora bisogna essere onesti e bravepersone per scrivere narrativa?»
«No. Bisogna avere mestiere. La veritàemotiva non è una qualità morale, è unatecnica.»
«Parla come uno scienziato» protestòIsabella.
«La letteratura, almeno quella buona, èuna scienza con sangue artistico.
Come l'architettura o la musica.»
«Io pensavo che fosse qualcosa chesgorgava dall'artista, così,all'improvviso.»
«A sgorgare così all'improvviso sonosolo i peli e le verruche.»
Isabella considerò quelle rivelazionicon scarso entusiasmo.
«Tutto questo lo dice per scoraggiarmi efarmi tornare a casa.»
«Non avrò questa fortuna.»
«Lei è il peggior maestro del mondo.»
«Il maestro lo fa l'alunno, non ilcontrario.»
«Non si può discutere con lei perché satutti i trucchi della retorica. Non ègiusto.»
«Niente è giusto. Al massimo si puòsperare che sia logico. La giustizia è unamalattia rara in un mondo per il restosano come un pesce.»
«Amen. È questo che succedediventando grandi? Si smette di crederenelle cose, come lei?»
«No. Via via che s'invecchia, la maggiorparte della gente continua a credere asciocchezze, generalmente sempre piùgrandi. Io vado controcor-rente perchémi piace girarmi i pollici.»
«Non ci giuri. Io quando sarò anzianacontinuerò a credere nelle cose»
minacciò Isabella.
«Buona fortuna.»
«E inoltre credo in lei.»
Non distolse lo sguardo quando la fissai.
«Perché non mi conosci.»
«Questo lo crede lei. Non è cosìmisterioso come pensa.»
«Non pretendo di essere misterioso.»
«Era un sostituto amabile di antipatico.Anch'io conosco qualche truccoretorico.»
«Questa non è retorica. È ironia. Sonocose diverse.»
«Deve sempre averla vinta nellediscussioni?»
«Quando mi rendono le cose così facili,sì.»
«E quell'uomo, il suo principale...»
«Corelli?»
«Corelli. Le rende le cose facili?»
«No. Corelli conosce molti più trucchiretorici di me.»
«Mi sembrava. Si fida di lui?»
«Perché me lo chiedi?»
«Non so. Si fida?»
«Perché non dovrei fidarmi?»
Isabella si strinse nelle spalle.
«Cos'è concretamente che le hacommissionato? Non me lo vuole dire?»
«Te l'ho già detto. Vuole che scriva unlibro per la sua casa editrice.»
«Un romanzo?»
«Non esattamente. Piuttosto una favola.Una leggenda.»
«Un libro per bambini?»
«Qualcosa del genere.»
«E lei lo farà?»
«Paga molto bene.»
Isabella aggrottò le sopracciglia.
«Per questo scrive? Perché la paganobene?»
«A volte.»
«E stavolta?»
«Stavolta scriverò questo libro perchédevo farlo.»
«È in debito con lui?»
«Si potrebbe dire così, suppongo.»
Isabella soppesò la questione. Misembrò che stesse per dire qualcosa, maci pensò su e si morse le labbra. Invecemi rivolse un sorriso innocente e uno deisuoi sguardi angelicali con cui eracapace di cambiare argomento in unbattito di ciglia.
«Anche a me piacerebbe essere pagataper scrivere» disse.
«A chiunque scrive piacerebbe, maquesto non significa che ci riuscirà.»
«E come ci si riesce?»
«Si comincia scendendo in salotto,
prendendo un foglio...»
«Mettendo i gomiti sul tavolo espremendosi le meningi fin quando fannomale. Già.»
Mi guardò negli occhi, esitante. Era giàuna settimana e mezza che la tenevo incasa e non avevo fatto cenno dirimandarla dai suoi. Immaginai che sichiedesse quando l'avrei fatto o perchénon l'avessi ancora fatto.
Anch'io me lo chiedevo e non trovavo larisposta.
«Mi piace essere la sua assistente, anchese lei è com'è» disse alla fine.
La ragazza mi guardava come se la suavita dipendesse da una parola gentile.Non resistetti alla tentazione. Le buoneparole sono gesti di bontà vani che nonesigono alcun sacrificio e sono piùgraditi di quelli pratici.
«Anche a me piace che tu sia la miaassistente, Isabella, anche se sono comesono. E mi piacerà di più quando non cisarà più bisogno che tu sia la miaassistente e non avrai più niente daimparare da me.»
«Crede che ho qualche possibilità?»
«Non ho alcun dubbio. Tra dieci anni tusarai la maestra e io l'apprendista»dissi, ripetendo quelle parole che ancora
mi sapevano di tradimento.
«Bugiardo» disse baciandomidolcemente sulla guancia per poi, subitodopo, uscire di corsa giù per le scale.
14
Nel pomeriggio lasciai Isabella allascrivania che avevamo sistemato per leiin salotto, davanti ai fogli bianchi, e mirecai alla libreria di don GustavoBarceló in calle Ferran con l'intenzionedi procurarmi una buona e leggibileedizione della Bibbia. L'intero set divecchi e nuovi testamenti di cuidisponevo a casa era stampato incaratteri microscopici su carta velinase-mitrasparente, e la loro lettura, più
che al fervore e all'ispirazione divini,induceva all'emicrania. Barceló, che tramolte altre cose era un pertinacecollezionista di libri sacri e testiapocrifi cristiani, aveva un séparé nelretro della libreria con un formidabileassortimento di Vangeli, memorie disanti e beati e ogni tipo di testi religiosi.
Quando mi vide entrare in libreria, unodei dipendenti corse ad avvisare ilproprietario nell'ufficio del retrobottega.Barceló emerse dal suo studio, euforico.
«Che bel vedere. Sempere me l'avevadetto che lei era rinato, ma così è daantologia. Al suo fianco, RodolfoValentino sembra appena arrivato dalla
campagna. Dove si era ficcato,mascalzone?»
«Qui e là» dissi.
«Dappertutto meno che al pranzo dinozze di Vidal. Ci è mancato, amicomio.»
«Mi permetta di dubitarne.»
Il libraio annuì, facendo intendere cheveniva incontro al mio desiderio di nonapprofondire l'argomento.
«Gradisce una tazza di tè?»
«Anche due. E una Bibbia. Se possibile,maneggevole.»
«Non sarà un problema» disse il libraio.«Dalmau!»
Un commesso accorse sollecitoall'appello.
«Dalmau, all'amico Martín serveun'edizione della Bibbia di carattere nondecorativo, ma leggibile. Pensavo aTorre Amat, 1825. Cosa gliene pare?»
Una delle particolarità della libreria diBarceló era che vi si parlava di libricome di vini sopraffini, catalogandobouquet, aroma, corposità e anno divendemmia.
«Scelta eccellente, signor Barceló,sebbene io propenderei per la versione
attualizzata e riveduta.»
«1860?»
«1893.»
«Naturalmente. Aggiudicata. La incartiall'amico Martín e la segni in conto allacasa.»
«Assolutamente no» obiettai.
«Il giorno che mi farò pagare per laParola di Dio da un miscredente comelei, sarà il giorno in cui una saettadistruttrice mi fulminerà, e a ragione.»
Dalmau partì spedito alla ricerca dellamia Bibbia e io seguii Barceló nel suo
ufficio, dove il libraio servì due tazze ditè e mi offrì un sigaro dall'u-midificatore. Lo accettai e lo accesi allafiamma di una candela che mi tendevaBarceló.
«Macanudo?»
«Vedo che si sta raffinando il palato. Unuomo deve avere qualche vizio, sepossibile di classe, altrimenti quandoarriva alla vecchiaia non ha nulla da cuiredimersi. In effetti, le farò compagnia,che diamine.»
Una nube di eccellente fumo di sigarocubano ci ricoprì come l'alta marea.
«Sono stato qualche mese fa a Parigi e
ho avuto l'opportunità di fare indaginisul tema di cui ha parlato all'amicoSempere tempo addietro» spiegòBarceló.
«Éditions de la Lumière.»
«Esatto. Mi sarebbe piaciuto scoprirequalcosa di più, ma purtroppo daquando la casa editrice ha chiuso nonsembra che qualcuno abbia acquisito ilcatalogo, ed è stato difficile tirare fuorigrandi cose.»
«Dice che ha chiuso? Quando?»
«Millenovecentoquattordici, se lamemoria non mi tradisce.»
«Dev'esserci un errore.»
«No, se parliamo delle Éditions de laLumière, in boulevard St.-
Germain.»
«Proprio quelle.»
«Guardi, in realtà mi sono annotato tuttoper non dimenticarmi quando cisaremmo visti.»
Barceló cercò nel cassetto dellascrivania e tirò fuori un piccoloquaderno di appunti.
«Ecco qua: "Éditions de la Lumière,casa editrice di testi religiosi con uffici
a Roma, Parigi, Londra e Berlino.Fondatore e direttore, Andreas Corelli.Anno di apertura della prima sede aParigi, 1881".»
«Impossibile» mormorai
Barceló si strinse nelle spalle.
«Be', posso essermi sbagliato, però...»
«Ha avuto modo di visitare gli uffici?»
«In realtà ci ho provato, perché il mioalbergo era di fronte al Pantheon,proprio lì vicino, e l'ex sede della casaeditrice era sul lato sud del boulevard,fra rue St.-Jacques e boulevard St.-Michel.»
«E allora?»
«Il palazzo era vuoto e sbarrato, esembrava ci fosse stato un incendio oqualcosa di simile. L'unica cosa intattaera il battente della porta, un pezzodavvero pregevole a forma di angelo. Inbronzo, direi. Me lo sarei portato via senon fosse stato che un gendarme miguardava di sottecchi e non ho avuto ilcoraggio di provocare un incidentediplomatico, non fosse mai che laFrancia decidesse di invaderci dinuovo.»
«Visto il panorama, forse ci facevano unfavore.»
«Ora che me lo dice... Ma tornando al
punto, quando ho visto in quale stato eraridotto il palazzo sono andato adomandare al caffè di fianco e mi hannodetto che era così da più di vent'anni.»
«È riuscito a sapere qualcosadell'editore?»
«Corelli? A quanto ho capito, la casaeditrice ha chiuso quando lui ha decisodi ritirarsi, anche se non doveva averenemmeno cinquant'anni.
Credo si sia trasferito in una villa nelsud della Francia, nel Luberon, e che siamorto poco tempo dopo. Morso diserpente, si è detto. Una vipera. Si ritiriin Provenza, se vuole fare la stessafine.»
«È sicuro che sia morto?»
«Père Coligny, un ex concorrente, mi hafatto vedere il suo necrologio, checustodiva incorniciato come se fosse untrofeo. Ha detto che lo guardava ognigiorno per ricordarsi che quel maledettobastardo era morto e sepolto. Le sueparole esatte, anche se in francesesuonavano molto più belle e musicali.»
«Coligny le ha detto se Corelli avevaqualche figlio?»
«Ho avuto l'impressione che Corelli nonfosse il suo argomento preferito e,appena ha potuto, Coligny ha glissato.C'era stato uno scandalo, pare, quandoCorelli gli aveva rubato uno dei suoi
autori, un certo Lambert.»
«Cos'era successo?»
«La cosa più divertente dell'affare è cheColigny non era mai nemmeno riuscito avedere Corelli. Tutti i loro contatti siriducevano alla corrispondenzacommerciale. Il nocciolo dellaquestione, direi, era che, a quanto pare,monsieur Lambert aveva firmato uncontratto per scrivere un libro per leÉditions de la Lumière di nascosto daColigny, per il quale lavorava inesclusiva. Lambert era un oppiomaneterminale e aveva abbastanza debiti dalastricare rue Rivoli da un capo all'altro.Coligny sospettava che Corelli gli
avesse offerto una somma astronomica eil poveretto, che stava morendo, avevaaccettato perché voleva sistemare ifigli.»
«Che tipo di libro?»
«Qualcosa di contenuto religioso.Coligny mi ha citato il titolo, un lati-norum alla moda che adesso non miviene in mente. Come sa, tutti i messalihanno un certo stile. Pax Gloria Mundio qualcosa del genere.»
«E cosa ne è stato del libro e diLambert?»
«Qui la questione si complica. A quantopare, il povero Lambert, in un accesso
di follia, voleva bruciare il manoscrittoed è rimasto tra le fiamme con tutta lacasa editrice. Molti hanno pensato chel'oppio avesse finito per friggergli ilcervello, ma Coligny sospettava chefosse stato Corelli a spin-gerlo alsuicidio.»
«Perché l'avrebbe fatto?»
«Chissà! Forse non volevacorrispondergli la somma promessa.Forse sono fantasie di Coligny, che iodefinirei un appassionato di Beaujolaistutti e dodici i mesi dell'anno. Senzaspingersi oltre, mi ha detto che Corelliaveva cercato di ucciderlo per liberareLambert dal contratto e che l'aveva
lasciato in pace solo quando lui avevadeciso di rescinderlo e di lasciarelibero lo scrittore.»
«Non ha detto che non l'aveva maivisto?»
«A maggior ragione. Io credo cheColigny delirasse. Quando sono andato atrovarlo a casa sua, ho visto piùcrocifissi, madonne e immagini di santiche in un negozio di presepi. Ho avutol'impressione che non avesse tutte lerotelle al loro posto. Nel salutarmi, miha detto di stare lontano da Corelli.»
«Ma non aveva detto che era morto?»
« Ecco qua4 . »
Rimasi in silenzio. Barceló mi guardava,intrigato.
«Ho l'impressione che i risultati dellemie ricerche non le abbiano provocatograndi sorprese.»
Abbozzai un sorriso noncurante,togliendo importanza alla questione.
«Al contrario. La ringrazio per averdedicato del tempo alle indagini.»
«Di nulla. Per me è un piacere andare ingiro per Parigi a spettegolare, lei miconosce.»
4 In italiano nel testo.
Barceló strappò dal quadernetto lapagina con i dati che aveva annotato eme la diede.
«Per quello che può servirle. Qui c'ètutto quello che ho potuto verificare.»
Mi alzai e gli strinsi la mano. Miaccompagnò all'uscita, dove Dalmau miaveva preparato il pacchetto.
«Se vuole qualche immaginetta delBambin Gesù che apre e chiude gliocchi a seconda da dove si guarda,abbiamo anche quelle. E un'altra con laVergine circondata da agnellini che,facendola girare, si trasformano incherubini paffuti. Un prodigio dellatecnologia stereoscopica.»
«Per il momento mi basta la parolarivelata.»
«Così sia.»
Ero grato agli sforzi del libraio perdarmi coraggio, ma via via che miallontanavo cominciò a invadermi unafredda inquietudine ed ebbil'impressione che le strade e il miodestino fossero lastricati sulle sabbiemobili.
15
Sulla strada di casa mi fermai davantialle vetrine di una cartoleria in calleArgenteria. Su un tessuto drappeggiatospiccava un astuccio che conteneva dei
pennini con un'impugnatura di avorio intono con un calamaio bianco su cuierano incise quelle che parevano muse ofate. L'insieme aveva un'aria un po'melodrammatica e sembrava rubatodalla scrivania di qualche romanziererusso, di quelli che si dissanguano conmigliaia di pagine. Isabella aveva unacalligrafia danzante che le invidiavo,limpida e pura come la sua coscienza, emi parve che quel set di pennini portasseil suo nome. Entrai e chiesi al commessodi mostrarmelo. I pennini erano placcatiin oro e lo scherzetto costava unapiccola fortuna, ma decisi che nonsarebbe stato eccessivo contraccambiarecon un gesto gentile la cortesia e lapazienza che la mia giovane assistente
mi dedicava. Chiesi di in-cartarlo concarta porpora brillante e con un fioccodella grandezza di una carrozza.
Arrivato a casa mi preparai a gustare lasoddisfazione egoistica di pre-sentarsicon un regalo in mano. Stavo perchiamare Isabella come se fosse unamascotte fedele senza altro da fare senon attendere con devozione il ritornodel padrone, ma quello che vidi aprendola porta mi lasciò a bocca aperta. Ilcorridoio era buio come un tunnel. Laporta della stanza in fondo era aperta eproiettava sul pavimento una striscia diluce giallastra e palpi-
tante.
«Isabella?» chiamai, la bocca secca.
«Sono qui.»
La voce proveniva dall'interno dellastanza. Lasciai il pacchetto sul tavolinodell'ingresso e avanzai. Mi fermai sullasoglia e guardai dentro. Isabella eraseduta a terra. Aveva messo una candelain un lungo bicchiere e si dedicavaansiosamente alla sua secondavocazione dopo la letteratura: mettereordine nelle case altrui.
«Come sei entrata?»
Mi guardò sorridente e si strinse nellespalle.
«Ero in salotto e ho sentito un rumore.Ho pensato che fosse lei di ritorno equando sono uscita in corridoio ho vistola porta della stanza aperta.
Mi sembrava che avesse detto che lateneva chiusa.»
«Esci. Non mi piace che entri in questastanza. È molto umida.»
«Bella sciocchezza. Con tutto il lavoroche c'è da fare qui. Su, guardi.
Guardi cosa ho trovato.»
Esitai.
«Entri, forza.»
Entrai nella stanza e mi accovacciaiaccanto a lei. Isabella aveva separa-togli oggetti e le casse per tipo: libri,giocattoli, fotografie, vestiti, scarpe,occhiali. Guardai tutti quegli oggetti conapprensione. Isabella sembravaincantata, come se avesse scoperto leminiere del re Salomone.
«È tutta roba sua?»
Scossi la testa.
«È del vecchio proprietario.»
«Lo conosceva?»
«No. Era tutto qui da anni quando hotraslocato.»
Isabella aveva fra le mani un pacchettodi lettere e me lo mostrò come se sitrattasse di una prova istruttoria.
«Credo di aver scoperto come sìchiamava.»
«Non mi dire.»
Isabella sorrise, chiaramente rapitadalle sue ambizioni da detective.
«Marlasca» sentenziò. «Si chiamavaDiego Marlasca. Non le sembracurioso?»
«Cosa?»
«Che le iniziali siano le stesse delle sue:
D.M.»
«È una semplice coincidenza. Decine dimigliaia di persone in questa città hannole stesse iniziali.»
Isabella mi strizzò l'occhio. Si divertivacome non mai.
«Guardi cosa ho trovato.»
Aveva recuperato una scatola di lattapiena di vecchie foto. Erano immaginid'altri tempi, cartoline dell'anticaBarcellona, dei palazzi abbattuti nelParque de la Ciudadela perl'Esposizione Universale del 1888, digrandi casermoni distrutti e vialidisseminati di persone vestite alla
maniera ce-rimoniosa dell'epoca, dicarri e memorie che avevano il coloredella mia infanzia. Volti e sguardiperduti mi contemplavano da trent'annidi distanza. In parecchie di quellefotografie mi sembrò di riconoscere ilviso di un'attrice popolare nei miei annidi gioventù e caduta nell'oblio da moltotempo. Isabella mi osservava,silenziosa.
«La riconosce?» domandò.
«Mi sembra che si chiamasse IreneSabino, credo. Era un'attrice di una certafama nei teatri del Paralelo. Tanto tempofa. Prima che tu nascessi.»
«Allora guardi questa.»
Isabella mi tese una fotografia in cuiIrene Sabino appariva appoggiata a unafinestra che non ci misi molto aidentificare come quella del mio studioin cima alla torre.
«Interessante, vero?» chiese Isabella.«Crede che vivesse qui?»
Mi strinsi nelle spalle.
«Forse era l'amante di quel DiegoMarlasca...»
«In ogni caso, non credo che siano affarinostri.»
«Com'è sciocco, a volte.»
Isabella rimise le foto nella scatola. Nelfarlo, gliene scivolò una dalle mani. Ecadde ai miei piedi. La raccolsi e laesaminai. Irene Sabino, con unosfolgorante vestito nero, posava assiemea un gruppo di persone vestite da festa inquello che mi parve di riconoscere comeil grande salone del Circulo Ecuestre.Era soltanto l'immagine di una festa chenon avrebbe richiamato la miaattenzione se non fosse stato perché, insecondo piano, quasi sfocato, sidistingueva un signore dai capellibianchi in cima alla scalinata: AndreasCorelli.
«È impallidito» disse Isabella.
Mi prese la foto dalle mani e la esaminòsenza dire nulla. Mi alzai e le feci segnodi uscire dalla stanza.
«Non voglio che entri mai più qui» dissisenza forze.
«Perché?»
Aspettai che uscisse e chiusi la porta.Isabella mi guardava come se non fossidel tutto in me.
«Domani avvisi le sorelle della carità edici di passare a ritirare questa roba. Siportino via tutto, e quello che nonvogliono lo buttino via.»
«Ma...»
«Non discutere.»
Non volevo affrontare il suo sguardo emi diressi verso le scale che salivanoallo studio. Isabella mi fissava dalcorridoio.
«Chi è quell'uomo, signor Martín?»
«Nessuno» mormorai. «Nessuno.»
16
Salii nello studio. Era notte alta, senzaluna né stelle in cielo. Spalancai lefinestre e mi affacciai a guardare la cittàimmersa nell'ombra. C'era appena unsoffio di brezza e il sudore mordeva lapelle. Mi sedetti sul davanzale e accesi
il secondo dei sigari che Isabella miaveva lasciato sulla scrivania giorniprima, in attesa di un alito di ventofresco o di un'idea un po'
più presentabile di quella collezione diluoghi comuni con cui portare acompimento l'incarico del mioprincipale. Sentii allora il rumore delleimposte della camera da letto di Isabellache si aprivano al piano di sotto. Unrettangolo di luce si allargò sul cortile evidi il suo profilo stagliarsi all'interno.Isabella si avvicinò alla finestra e scrutònell'ombra senza avvertire la miapresenza. La guardai spogliarsilentamente. La vidi andare allo specchiodell'armadio ed esaminare il suo corpo,
accarezzarsi il ventre con i polpastrellie percorrere i tagli che si era procuratanella parte interna delle cosce e dellebraccia. Si contemplò a lungo, senzaaltro indumento se non uno sguardosconfitto, e poi spense la luce.
Tornai alla scrivania e mi sedetti davantialla pila di appunti e note che avevoraccolto per il libro del mio principale.Riesaminai quegli abbozzi di storiezeppe di rivelazioni mistiche e di profetiche sopravvivevano a prove tremende eritornavano con la verità rivelata, dineonati messianici abbandonati sullaporta di famiglie umili e pure di cuoreperseguitati da imperi laici e malefici,di paradisi promessi in altre dimensioni
a quanti accettas-sero sportivamente ilproprio destino e le regole del gioco, edi divinità o-ziose e antropomorfe, senzanulla di meglio da fare che mantenereuna sorveglianza telepatica sullacoscienza di milioni di fragili primatiche avevano imparato a pensare giustoin tempo per scoprirsi abbandonati allapropria sorte in un angolo remotodell'universo, e la cui vanità, odisperazione, li portava a credere aocchi chiusi che cielo e inferno nonfacessero altro che pensare ai lorovolgari e meschini peccatucci.
Mi domandai se non fosse proprioquello ciò che il mio principale avevavisto in me, una mente mercenaria e
priva di scrupoli per elaborare unracconto narcotizzante capace dimandare a letto i bambini o diconvincere un povero diavolo senzasperanze ad assassinare il suo vicino incambio della gratitudine eterna didivinità che condividevano l'etica deipistoleri. Giorni prima era arrivataun'altra di quelle missive con cui ilprincipale mi dava appuntamento perdiscutere sui progressi del mio lavoro.Stanco dei miei stessi scrupoli, mi dissiche mancavano solo ventiquattr'oreall'appuntamento e che, alla velocità concui procedevo, mi sarei presentato amani vuote e con la testa piena di dubbie sospetti. Non avendo alternative, feciquello che avevo fatto per tanti anni in
situazioni simili. Misi un foglio nellaUnderwood e, con le mani sulla tastieracome un pianista in attesa dell'attacco,cominciai a spremermi le meningi, pervedere cosa ne sarebbe uscito.
17
«Interessante» disse il principalequando finì la decima e ultima pagina.
«Strano, ma interessante.»
Eravamo seduti su una panchina nelletenebre dorate del pergolato del Parquede la Ciudadela. Una volta di fogliefiltrava la luce fino a ridurla a polvered'oro, e un orto botanico scolpiva ichiaroscuri di quella strana penombra
luminosa che ci circondava. Accesi unasigaretta e guardai il fumo salire dallemie dita in volute azzurrate.
«Detto da lei, strano è un aggettivoinquietante» osservai.
«Mi riferivo a strano in opposizione aordinario» precisò Corelli.
«Ma?»
«Non ci sono ma, amico mio. Credo chelei abbia imboccato una stradainteressante e con molte possibilità.»
Per un romanziere, quando gli diconoche qualcuna delle sue pagine èinteressante e ha delle possibilità è
segno che le cose non vanno bene.Corelli sembrò leggere la miainquietudine.
«Lei ha girato intorno alla questione.Invece di risalire ai riferimenti mi-tologici, ha iniziato dalle fonti piùprosaiche. Posso chiederle dove hapreso l'idea di un messia guerrieroinvece che pacifico?»
«Lei ha citato la biologia.»
«Tutto ciò che abbiamo bisogno disapere è scritto nel grande libro dellanatura. Basta avere coraggio e luciditàdi mente e di spirito per leggerlo»
convenne Corelli.
«Uno dei libri che ho consultatospiegava che nell'essere umano ilmaschio raggiunge il punto critico difertilità a diciassette anni. La donna loraggiunge dopo, e lo mantiene, e inqualche modo agisce da selettore egiudice dei geni che accetta diriprodurre e di quelli che rifiuta. Ilmaschio, invece, semplicementepropone e si consuma molto più in fretta.L'età in cui raggiunge la massimapotenza riproduttiva è quella in cui ilsuo spirito combattivo è al suo puntocritico. Un ragazzo è il soldato perfetto.Possie-de un grande potenziale diaggressività e una scarsa o nullacapacità critica per analizzarlo edecidere come incanalarlo. Nel corso
della storia, numerose società hannotrovato il modo di impiegare questocapitale di aggressività e hannotrasformato in soldati gli adolescenti,carne da cannone con cui sottomettere ivicini o difendersi dai loro attacchi.Qualcosa mi diceva che il nostroprotagonista era un inviato dei cieli, manella prima parte della sua giovinezza sisollevava in armi e liberava la verità acolpi di spada.»
«Ha deciso di mescolare la storia con labiologia, Martín?»
«Dalle sue parole mi era sembrato dicapire che erano una cosa sola.»
Corelli sorrise. Non so se ne fosse
consapevole, ma quando lo facevasembrava un lupo affamato. Deglutii eignorai quell'espressione che facevavenire la pelle d'oca.
«Ci ho pensato e mi sono reso conto chela maggior parte delle grandi religioniha tratto origine, o ha raggiunto ilproprio punto critico di espan-sione einfluenza, nei momenti storici in cui lesocietà che le adottavano avevano unabase demografica più giovane eimpoverita. Società nelle quali ilsettanta per cento della popolazioneaveva meno di diciotto anni, e la metàerano maschi adolescenti con le veneardenti di aggressività e im-pulsi fertili,terreno propizio all'accettazione e al
rigoglio della fede.»
«È una semplificazione, ma capiscodove vuole andare a parare, Martín.»
«Lo so. Ma tenendo conto di questelinee generali mi sono chiesto perchénon andare dritto al nocciolo dellaquestione ed elaborare una mitologiaintorno a questo messia guerriero, disangue e rabbia, che salva il suo popolo,i suoi geni, le sue donne e i suoi anziani,garanti del dogma politi-co e razziale,dai nemici, vale a dire da tutti coloroche non accettano o non si sottomettonoalla sua dottrina.»
«E gli adulti?»
«All'adulto arriveremo facendo appelloalla sua frustrazione. A mano a mano chela vita avanza e che bisogna rinunciarealle illusioni, ai sogni e ai desideri dellagioventù, aumenta la sensazione diessere vittima del mondo e degli altri.Troviamo sempre qualche colpevoledella nostra sventura o del nostrofallimento, qualcuno che vogliamoescludere. Abbracciare una dottrina cherenda positivo questo rancore e questovittimismo è consolante e dà forza.L'adulto si sente così parte del gruppo esublima i propri desideri e i proprianeliti perduti attraverso la comunità.»
«Forse» concesse Corelli. «E tuttaquell'iconografia della morte e di
bandiere e scudi? Non le sembracontroproducente?»
«No. Mi sembra essenziale. L'abito fa ilmonaco, ma soprattutto il fedele.»
«E cosa mi dice delle donne, dell'altrametà? Mi dispiace, ma faccio fatica aimmaginare che una parte sostanzialedelle donne di una società creda abandierine e scudi. La psicologia delboy scout è una cosa da maschiet-ti.»
«Ogni religione organizzata, con scarseeccezioni, ha come pilastrofondamentale il soggiogamento, larepressione e l'annullamento della donnanel gruppo. La donna deve accettare ilruolo di presenza eterea, passiva e
materna, mai quello di autorità o diindipendenza, oppure ne paga le con-seguenze. Può avere un posto d'onore trai simboli, ma non nella gerarchia.
La religione e la guerra sono affarimaschili. E, comunque, la donna finiscea volte per diventare complice edesecutrice del suo stessosoggiogamento.»
«E i vecchi?»
«La vecchiaia è la vaselina dellacredulità. Quando la morte bussa allaporta, lo scetticismo salta dalla finestra.Una bella crisi cardiovascolare e sicrede pure a Cappuccetto Rosso.»
Corelli rise.
«Attento, Martín, mi sembra che stiadiventando più cinico di me.»
Lo guardai come se fossi un alunnodocile e ansioso di ottenere l'appro-vazione di un maestro difficile edesigente. Corelli mi batté la mano sulginocchio, annuendo compiaciuto.
«Mi piace. Mi piace il profumo di tuttoquesto. Voglio che ci ragioni su e gli diauna forma. Le concederò più tempo. Ciincontreremo fra due o tre settimane.L'avviserò con qualche giorno dianticipo.»
«Deve lasciare la città?»
«Questioni della casa editrice mireclamano e temo di avere davantiqualche giorno di viaggio. Ma partocontento. Ha fatto un buon lavoro.
Sapevo di aver trovato il mio candidatoideale.»
Il principale si alzò e mi tese la mano.Mi asciugai sui pantaloni il sudore chemi inzuppava il palmo e gliela strinsi.
«Ci mancherà» improvvisai.
«Non esageri, Martín, stava andandobenissimo.»
Lo vidi andar via nelle tenebre delpergolato, mentre l'eco dei suoi passi
svaniva nell'ombra. Rimasi lì ancora unbel po', chiedendomi se il principaleavesse abboccato all'amo e si fossebevuto il mucchio di menzogne che gliavevo appena rifilato. Ero sicuro diavergli raccontato esattamente quelloche voleva sentirsi dire. Speravo checosì fosse e che quella sfilza dispropositi lo avesse soddisfatto per ilmomento e convinto che il sottoscritto,l'infelice romanziere fallito, si eraconvertito al movimento. Pensai chequalunque cosa potesse farmiguadagnare un po' di tempo per capiredove mi fossi infilato valeva il tentativo.Quando mi alzai e lasciai il pergolato,mi tremavano ancora le mani.
18
Anni di esperienza nella scrittura ditrame poliziesche forniscono una seriedi princìpi di base da cui iniziareun'indagine. Uno di questi è che quasitutti gli intrecci abbastanza solidi,inclusi quelli passionali, nascono emuoiono in mezzo all'odore dei soldi edelle proprietà immobiliari. Uscendodal pergolato mi diressi all'ufficio delRegistro in calle del Consejo de Cientoe chiesi di consultare i volumi in cui sifaceva riferimento all'acqui-sto, allavendita e alla proprietà della mia casa. Itomi dell'ufficio del Registro contengonoquasi altrettante informazioni sulla realtàdella vita quanto le opere complete dei
più prestigiosi filosofi, o forse di più.
Iniziai a consultare la sezione checonteneva la pratica di affitto a mionome dell'immobile ubicato al numero30 di calle Flassaders. Lì trovai leindicazioni necessarie per passare alsetaccio la storia dell'edificio primadell'acquisizione della proprietà daparte del Banco Hispano Colonial nel1911 nel quadro di un procedimento disequestro nei confronti della famigliaMarlasca, che a quanto pareva avevaereditato l'immobile alla morte delproprietario. Lì si menzionava unavvocato chiamato S. Valera, che avevaagito come rappresentante della famiglianel corso della causa. Un nuovo salto
nel passato mi permise di scoprire leinformazioni sull'acquisto della villa daparte di don Diego Marlasca Pongiluppinel 1902 da un certo Bernabé Massot yCaballé. Annotai su un foglio a partetutti i dati, dal no-
me dell'avvocato ai partecipanti alletransazioni e alle rispettive date. Unodegli impiegati avvisò a voce alta chemancavano quindici minuti alla chiusurae mi preparai ad andarmene, ma primami affrettai a consultare lo stato dellaproprietà della residenza di AndreasCorelli vicino al Park Güell. Trascorsi iquindici minuti, e senza avere avutosuccesso nelle mie ricerche, sollevai gliocchi dal volume del registro per
incontrare lo sguardo cinereo delsegretario. Era un tipo smunto, lucido dibrillantina dai capelli ai baffi e stillavaquell'inerzia polemica tipica di chi fadel proprio lavoro una tribuna da cuiostacolare la vita degli altri.
«Mi scusi. Non riesco a trovare unaproprietà» dissi.
«Sarà perché non esiste o perché non sacercare. Per oggi abbiamo chiuso.»
Risposi a quello sfoggio di amabilità edefficienza con il mio migliore sorriso.
«Forse con l'aiuto di un esperto come leiriesco a trovarla» suggerii.
Mi rivolse uno sguardo schifato e mistrappò il volume dalle mani.
«Torni domani.»
La mia sosta successiva fu alcerimonioso palazzo dell'ordine degliavvocati in calle Mallorca, a pochetraverse da lì. Salii le scale sorvegliateda lampadari di cristallo e da quella chemi parve una scultura della giustizia conbusto e atteggiamento da diva delParatelo. Un ometto dall'aspetto da topomi ricevette in segreteria con un sorrisoaffabile e mi chiese in che cosa potevaaiutarmi.
«Cerco un avvocato.»
«È capitato nel posto giusto. Qui nonsappiamo più come toglierceli di dosso.Ce ne sono ogni giorno di più. Siriproducono come conigli.»
«È il mondo moderno. Quello che cercosi chiama, o si chiamava, Valera, S.Valera.»
L'ometto si smarrì in un labirinto dischedari, mormorando sottovoce.
Aspettai appoggiato al banco, lasciandoscorrere lo sguardo su quell'arre-damento impregnato del pesocontundente della legge. Cinque minutidopo, l'ometto tornò con una cartellina.
«Mi risultano dieci Valera. Due con la
esse. Sebastián e Soponcio.»
«Soponcio?»
«Lei è molto giovane, ma anni fa era unnome quotato e idoneo all'eser-ciziodella professione legale. Poi è arrivatoil charleston e ha rovinato tutto.»
«È vivo don Soponcio?»
«Secondo l'archivio e la cessazione deipagamenti della quota dell'ordine,Soponcio Valera y Menacho fu ricevutonella gloria di nostro Signore nell'anno1919. Memento mori. Sebastián è ilfiglio.»
«In esercizio?»
«Costante e pieno. Intuisco che lei vorràl'indirizzo.»
«Se non è troppo disturbo.»
L'ometto me l'annotò su un foglietto e melo diede.
«Diagonal 422. È a un tiro di schioppoda qui, anche se sono già le due e aquest'ora gli avvocati di grido portano apranzo ricche eredi vedove o fabbricantidi tessuti e di esplosivi. Io aspetterei lequattro.»
Misi l'indirizzo nella tasca della giacca.
«Farò così. Moltissime grazie per il suoaiuto.»
«Siamo qui per questo. Che Diol'accompagni.»
Mi restavano un paio d'ore da perdereprima di fare visita all'avvocato Valera,così presi un tram fino a via Layetana escesi all'altezza di calle Condal. Lalibreria di Sempere e Figli era a unpasso da lì e sapevo per esperienza cheil vecchio libraio, contravvenendo allaprassi immutabile del commercio locale,non chiudeva a mezzogiorno. Lo trovai,come sempre, al bancone, a sistemarelibri e a servire un nutrito gruppo diclienti che passeggiavano fra i tavoli egli scaffali alla caccia di qualche tesoro.Sorrise vedendomi e si avvicinò persalutarmi. Era più magro e pallido
dell'ultima volta che ci eravamo visti.Dovette leggere la preoccupazione nelmio sguardo perché si strinse nellespalle e fece un gesto come per togliereimportanza alla questione.
«Chi tanto e chi niente. Lei è diventatoun figurino e io un rottame, ha visto?»disse.
«Sta bene?»
«Io, come una rosa. È la maledettaangina. Nulla di serio. Cosa la porta daqueste parti, Martín, amico mio?»
«Pensavo di invitarla a pranzo.»
«La ringrazio, ma non posso lasciare il
timone. Mio figlio se n'è andato a Sarriàa valutare una collezione e gli affari nonvanno tanto bene da chiudere quando cisono clienti per la strada.»
«Non mi dica che avete problemi disoldi.»
«Questa è una libreria, Martín, non unostudio di notaio. Qui la scrittura dàappena il necessario, e a volte nemmenoquello.»
«Se ha bisogno di aiuto...»
Sempere mi fermò alzando la mano.
«Se vuole aiutarmi, compri qualchelibro.»
«Lei sa che il debito che ho nei suoiconfronti non si paga con il denaro.»
«Ragione di più perché non le passineanche per la testa. Non si preoccupiper noi, Martín, da qui non cicacceranno se non in una cassa di pino.
Ma se vuole può dividere con me unsucculento pranzo a base di pane conl'uvetta e formaggio fresco di Burgos.Con questo e un Montecristo si puòsopravvivere cent'anni.»
19
Sempere quasi non toccò cibo.Sorrideva stancamente e fingevainteresse per i miei commenti, ma si
vedeva che a tratti gli costava faticarespirare.
«Mi racconti, Martín, a cosa stalavorando?»
«Difficile da spiegare. Un libro sucommissione.»
«Romanzo?»
«Non esattamente. Non saprei benecome definirlo.»
«L'importante è che stia lavorando. L'hosempre detto che l'ozio ram-mollisce lospirito. Bisogna tenere il cervellooccupato. E se non si ha cervello,almeno le mani.»
«Però a volte si lavora più del dovuto,signor Sempere. Non dovrebbeprendersi un po' di respiro? Da quantianni è qui in prima linea senza fermarsimai?»
Sempere si guardò attorno.
«Questo posto è la mia vita, Martín.Dove potrei andare? Su una panchinadel parco al sole a dar da mangiare aipiccioni e a lamentarmi dei reu-matismi? Morirei in dieci minuti. Il mioposto è qui. E mio figlio non è ancorapronto per prendere le redini, anche selo pensa.»
«Ma è un buon lavoratore. E una bravapersona.»
«Troppo una brava persona, detto tranoi. A volte lo guardo e mi domandocosa ne sarà di lui il giorno in cui verròa mancare. Come se la caverà...»
«Tutti i padri fanno così, signorSempere.»
«Anche il suo? Mi scusi, non volevo...»
«Non si preoccupi. Mio padre aveva giàabbastanza grattacapi per conto suo percaricarsi addosso anche quelli che glidavo io. Suo figlio sa cavar-
sela meglio di quanto lei creda.»
Sempere mi guardava, esitante.
«Sa cosa credo gli manchi?»
«Malizia?»
«Una donna.»
«Non gli mancheranno le fidanzate, contutte le tortorelle che si affolla-nodavanti alle vetrine per ammirarlo.»
«Io parlo di una donna vera, di quelleche ti fanno essere quello che deviessere.»
«È ancora giovane. Lasci che si divertaqualche anno.»
«Questa è buona. Se almeno sidivertisse. Io alla sua età, se avessi
avuto quel coro di ragazze, avreipeccato come un cardinale.»
«Dio dà il pane a chi non ha i denti.»
«Ecco cosa gli manca: denti. E voglia dimordere.»
Mi sembrò che qualcosa ronzasse intesta al libraio. Mi guardava esorrideva.
«Forse lei può aiutarlo...»
«Io?»
«Lei è un uomo di mondo, Martín. E nonmi guardi così. Sicuro che, se si applica,gli trova una brava ragazza, a mio figlio.
Il viso carino già ce l'ha. Il resto glieloinsegna lei.»
Rimasi senza parole.
«Non voleva aiutarmi?» chiese illibraio. «Ecco qua.»
«Io parlavo di soldi.»
«E io parlo di mio figlio, del futuro diquesta casa. Di tutta la mia vita.»
Sospirai. Sempere mi prese la mano estrinse con la poca forza che glirimaneva.
«Mi prometta che non mi lascerà andarvia da questo mondo senza vedere mio
figlio sistemato con una donna di quelleper cui vale la pena morire.
E che mi dia un nipote.»
«Se lo sapevo, mi fermavo a pranzare alcaffè Novedades.»
Sempere sorrise.
«A volte penso che sarebbe dovutoessere lei mio figlio, Martín.»
Guardai il libraio, più fragile e vecchioche mai, appena un'ombra dell'uomoforte e imponente dei miei ricordid'infanzia tra quei muri, e sentii ilmondo crollare ai miei piedi. Miavvicinai a lui e, prima di rendermene
conto, feci quello che non avevo maifatto da quando lo conoscevo. Gli diediun bacio su quella fronte punteggiata dimacchie e coronata da quat-
tro capelli grigi.
«Me lo promette?»
«Glielo prometto» gli dissi, avviandomiverso l'uscita.
20
Lo studio dell'avvocato Valera occupavail piano alto di uno stravagante edificiomodernista incassato al numero 442dell'avenida Diagonal, a un passodall'angolo con Paseo de Gracia. La
proprietà, in mancanza di miglioridefinizioni, sembrava un incrocio fra ungigantesco orologio a caril-lon e unvascello pirata, dotato di grandiosifinestroni e con un tetto a man-sardaverde. In qualunque altro luogo dellaTerra, quella struttura barocca ebizantina sarebbe stata proclamata unadelle sette meraviglie del mondo o unaborto diabolico, opera di qualcheartista pazzo posseduto da spiritidell'aldilà. Nell'Ensanche di Barcellona,dove esemplari simili spuntavanodappertutto come trifogli dopo lapioggia, a stento riusciva a far sollevareun sopracciglio.
Avanzai nell'atrio e scoprii un ascensore
che mi fece pensare a quello cheavrebbe lasciato al suo passaggio ungrande ragno tessitore di cattedraliinvece che di tele. Il portiere mi aprì lacabina e m'imprigionò in quella stranacapsula che iniziò a salire lungo la partecentrale della scalinata.
Una segretaria dall'aria severa mi aprìla porta di rovere intagliata e mi fececenno di entrare. Le dissi il mio nome espiegai che non avevo presoappuntamento, ma che ero lì per unaquestione legata alla compravendita diun immobile del quartiere della Ribera.Qualcosa cambiò nel suo sguardoimperturbabile.
«La casa della torre?» chiese.
Annuii. La segretaria mi guidò verso unufficio deserto e mi invitò a entrare.Intuii che non era la sala d'attesaufficiale.
«Aspetti un momento, per favore, signorMartín. Avverto l'avvocato.»
Passai i successivi quarantacinqueminuti in quell'ufficio, circondato dascaffali stipati di volumi grandi comelapidi funerarie, con iscrizioni sui dorsidel tipo "1888-1889, B.C.A. Sezioneprima. Titolo secondo" che in-vitavanoalla lettura compulsiva. L'ufficio avevaun ampio finestrone sulla Diagonal dalquale si poteva contemplare tutta la
città. I mobili odoravano di legnopregiato stagionato e macerato neldenaro. Tappeti e poltrone di pellesuggerivano un'atmosfera da clubbritannico. Cercai di sollevare una dellelampade che dominavano la scrivania ecalcolai che doveva pesare non meno ditrenta chili. Un grande dipinto a olioappeso sopra un camino mai accesomostrava la tronfia ed espansivapresenza di qualcuno che non potevaessere altri che l'ineffabile donSoponcio Valera y Menacho. Il tita-nicoleguleio sfoggiava favoriti e baffi cheassomigliavano alla criniera di unvecchio leone, e gli occhi, di fuoco eacciaio, dominavano dall'aldilà ogniangolo della stanza con la gravità di una
sentenza di morte.
«Non parla, ma se ci si ferma a guardareil quadro per un po' sembra sul punto difarlo da un momento all'altro» disse lavoce alle mie spalle.
Non l'avevo sentito entrare. SebastiánValera era un uomo dal passo discretoche sembrava aver trascorso gran partedella vita cercando di trasci-narsi fuoridall'ombra di suo padre e che adesso, acinquant'anni e rotti, si era stancato diprovarci. Il suo sguardo intelligente epenetrante proteggevaquell'atteggiamento raffinato chepossiedono solo le principesse reali egli avvocati davvero cari. Mi tese la
mano e gliela strinsi.
«Mi dispiace averla fatta attendere, manon aspettavo la sua visita» disse,invitandomi a sedere.
«Al contrario. La ringrazio per lacortesia di ricevermi.»
Valera sorrideva come può farlo soltantochi conosce e fissa il prezzo di ogniminuto.
«La segretaria mi dice che il suo nome èDavid Martín. David Martín, loscrittore?»
La mia faccia sorpresa dovettesmascherarmi.
«Vengo da una famiglia di grandi lettori»spiegò. «In cosa posso esserle utile?»
«Vorrei informazioni sullacompravendita di una proprietà ubicatain...»
«La casa della torre?» interruppel'avvocato, cortese.
«Sì.»
«La conosce?»
«Ci abito.»
Valera mi guardò a lungo senzaabbandonare il sorriso. Si raddrizzòsulla sedia e adottò un atteggiamento
chiuso e teso.
«Lei è l'attuale proprietario?»
«In realtà, vi risiedo come affittuario.»
«E cosa vorrebbe sapere, signorMartín?»
«Vorrei conoscere, se possibile, idettagli dell'acquisizione dell'immobileda parte del Banco Hispano Colonial eprocurarmi qualche informazione sulvecchio proprietario.»
«Don Diego Marlasca» mormoròl'avvocato. «Posso chiederle la naturadel suo interesse?»
«Scrupolosità. Recentemente, nel corsodi una ristrutturazione della villa, hotrovato una serie di oggetti che credo gliappartengano.»
L'avvocato aggrottò le sopracciglia.
«Oggetti?»
«Un libro. O, più propriamente, unmanoscritto.»
«Il signor Marlasca era un grandeappassionato di letteratura. In realtà, eraautore di numerosi libri di diritto eanche di storia e di altri argomenti.
Un grande erudito. E un grand'uomo,anche se alla fine della sua vita ci fu chi
cercò di infangarne la reputazione.»
L'avvocato notò la meraviglia sulla miafaccia.
«Presumo che non sia al corrente dellecircostanze della morte del signorMarlasca.»
«Temo di no.»
Valera sospirò come se fosse incerto secontinuare a parlare.
«Non ne scriverà, vero? E non scriverànemmeno di Irene Sabino?»
«No.»
«Ho la sua parola?»
Annuii.
Valera si strinse nelle spalle.
«Del resto, non potrei nemmeno dirlecose che non siano già state detteall'epoca» mormorò, più rivolto a sestesso che a me.
L'avvocato guardò brevemente il ritrattodel padre e poi posò gli occhi su di me.
«Diego Marlasca era il socio e ilmiglior amico di mio padre. Insiemefondarono questo studio. Il signorMarlasca era molto brillante. Purtroppo,era anche un uomo complesso, che
soffriva di lunghi periodi di malinconia.Arrivò un momento in cui lui e miopadre decisero di sciogliere i lorovincoli. Il signor Marlasca lasciò laprofessione per consacrarsi alla suaprima vocazione: la scrittura. Diconoche quasi tutti gli avvocati desiderino insegreto lasciare l'avvocatura e diventarescrittori...»
«Fin quando mettono a confronto iguadagni.»
«Il fatto è che don Diego aveva avviatoun rapporto di amicizia con un'attriceche godeva all'epoca di una certapopolarità, Irene Sabino, per la qualevoleva scrivere un dramma. Non c'era
altro. Il signor Marlasca era ungentiluomo e non fu mai infedele allamoglie, ma lei sa com'è la gente...
Pettegolezzi. Chiacchiere e gelosie.Fatto sta che si sparse la voce che donDiego intrattenesse una relazione illecitacon Irene Sabino. Sua moglie non glieloperdonò e la coppia si separò. Il signorMarlasca, distrutto, acquistò la casadella torre e vi si trasferì. Per disgrazia,ci viveva da nemmeno un anno quandomorì in uno sfortunato incidente.»
«Che tipo di incidente?»
«Morì annegato. Una tragedia.»
Valera aveva abbassato gli occhi e
parlava in un sospiro.
«E lo scandalo?»
«Diciamo che certe lingue viperinevollero far credere che il signorMarlasca si fosse suicidato dopo aversofferto una delusione amorosa conIrene Sabino.»
«E andò così?»
Valera si tolse gli occhiali e si sfregò gliocchi.
«Se vuole che le dica la verità, non loso. Non lo so e non m'importa. Il passatoè passato.»
«E che ne è stato di Irene Sabino?»
Valera si rimise gli occhiali.
«Credevo che il suo interesse silimitasse al signor Marlasca e ai dettaglidella compravendita.»
«Pura curiosità. Tra i suoi effettipersonali ho trovato numerose fotografiedi Irene Sabino, e lettere dell'attrice alsignor Marlasca...»
«Dove vuole arrivare con tutto questo?»sbottò Valera. «Vuole soldi?»
«No.»
«Ne sono contento, perché nessuno
gliene darà. La questione non interessapiù. Ha capito?»
«Perfettamente, signor Valera. Nonintendevo importunarla né fare insi-nuazioni fuori luogo. Mi dispiace diaverla offesa con le mie domande.»
L'avvocato sorrise e si lasciò sfuggireun sospiro gentile, come se laconversazione fosse ormai finita.
«Non ha importanza. Mi scusi lei.»
Approfittando della sua venaconciliatrice, adottai la mia espressionepiù dolce.
«Forse donna Alicia Marlasca, la
vedova...»
Valera si rannicchiò nella poltrona,visibilmente a disagio.
«Signor Martín, non vorrei esserefrainteso, ma rientra nei miei doveri diavvocato della famiglia proteggernel'intimità. Per ovvi motivi. È passatomolto tempo, ma non vorrei che ora siriaprissero vecchie ferite che nonportano da nessuna parte.»
«Mi rendo conto.»
L'avvocato mi osservava, teso.
«E ha detto di aver trovato un libro?»domandò.
«Sì... Un manoscritto. Probabilmentenon ha importanza.»
«Probabilmente no. Di cosa tratta?»
«Teologia, direi.»
Valera annuì.
«La sorprende?» chiesi.
«No. Al contrario. Don Diego eraun'autorità in storia delle religioni. Unsaggio. Qui lo ricordiamo ancora congrande affetto. Mi dica, quali aspetticoncreti della compravendita volevaapprofondire?»
«Credo che mi abbia già aiutato molto,
signor Valera. Non vorrei rubarle altrotempo.»
L'avvocato annuì, sollevato.
«È la casa, vero?»
«È un posto strano, sì» convenni.
«Ricordo di esserci stato una volta dagiovane, poco dopo che l'avevacomprata don Diego.»
«Sa perché la comprò?»
«Disse che ne era affascinato fin daragazzo e di avere sempre pensato chegli sarebbe piaciuto viverci. Don Diegoera fatto così. A volte sembrava un
ragazzino capace di dare tutto in cambiodi una semplice illusione.»
Non dissi nulla.
«Si sente bene?»
«Perfettamente. Sa qualcosa delproprietario da cui la comprò il signorMarlasca? Un certo Bernabé Massot?»
«Un americano. Non ci ha passatonemmeno un'ora. La comprò quandotornò da Cuba e la tenne vuota perdiversi anni. Non disse mai perché.
Abitava in una villa che si era fattocostruire ad Arenys de Mar. La vendet-te per quattro soldi. Non voleva saperne
più nulla.»
«E prima di lui?»
«Credo che ci vivesse un sacerdote. Ungesuita. Non ne sono sicuro. Era miopadre a gestire gli affari di don Diego e,alla sua morte, distrusse tutti gliarchivi.»
«Perché fece una cosa del genere?»
«Per tutto quello che le ho raccontato.Per evitare pettegolezzi e preser-vare lamemoria del suo amico, suppongo. Inrealtà non me l'ha mai detto.
Mio padre non era abituato a fornirespiegazioni dei suoi atti. Avrà avuto i
suoi motivi. Motivi validi, senza alcundubbio. Don Diego era stato un buonamico, oltre che socio, e quella vicendafu molto dolorosa per mio padre.»
«Cosa ne è stato del gesuita?»
«Credo avesse problemi disciplinaricon l'ordine. Era amico di monsi-gnorCinto Verdaguer e mi pare che fuimplicato in qualcuno dei suoi guai,sa...»
«Esorcismi?»
«Pettegolezzi.»
«Come può un gesuita espulsodall'ordine permettersi una casa del
genere?»
Valera si strinse di nuovo nelle spalle ededussi di essere arrivato al fondo delbarile.
«Mi piacerebbe poterla aiutare di più,signor Martín, ma non so come.
Mi creda.»
«Grazie per il suo tempo, signorValera.»
Annuì e premette un campanello sullascrivania. La segretaria che mi avevaricevuto comparve sulla porta. Valera mioffrì la mano e gliela strinsi.
«Il signor Martín va via. Accompagnalo,Margarita.»
La segretaria mi fece strada. Prima diuscire mi girai per guardare l'avvocato,accasciato sotto il ritratto del padre.Seguii Margarita fino alla porta eproprio quando stava per chiuderla lerivolsi il più innocente dei miei sorrisi.
«Mi scusi. L'avvocato Valera mi ha datoprima l'indirizzo della signora Marlasca,ma adesso che ci penso non sono sicurodi ricordare il numero civico...»
Margarita sospirò, ansiosa di liberarsidi me.
«È il tredici. Carretera de Vallvidrera,
numero tredici.»
«Certo.»
«Arrivederci» disse Margarita.
Prima che potessi rispondere al suosaluto, la porta mi si chiuse in faccia conla solennità e la gravità di un santosepolcro.
21
Tornando alla casa della torre, imparai avedere con altri occhi quello che erastato il mio focolare e il mio carcere pertroppi anni. Entrai dal portone con lasensazione di attraversare le fauci di unessere di pietra e om-
bra. Salii le scale come se miaddentrassi nelle sue viscere e aprii laporta di casa per ritrovarmi in quellungo corridoio buio che si perdevanella penombra e che, per la primavolta, mi parve l'anticamera di unamente sospettosa e avvelenata. In fondo,nel fulgore scarlatto del crepuscolo chetrapelava dal salotto, si stagliava lafigura di Isabella che avanzava verso dime. Chiusi la porta e accesi la lucedell'ingresso.
Isabella si era vestita come unasignorina raffinata, i capelli raccolti e untrucco che la facevano sembrare unadonna con dieci anni in più.
«Sei molto bella ed elegante» dissifreddamente.
«Quasi come una ragazza della sua età,vero? Le piace il vestito?»
«Dove l'hai preso?»
«Era in un baule nella stanza in fondo.Credo che fosse di Irene Sabino.
Come le sembra? Non mi sta d'incanto?»
«Ti avevo detto di avvisare perchévenissero a prendere tutto.»
«E l'ho fatto. Stamattina sono andata inparrocchia a chiedere e mi hanno dettoche loro non possono venire a ritirare
niente, ma che possiamo por-tarlo noi.»
La guardai senza dire nulla.
«È la verità» disse lei.
«Toglitelo e rimettilo dove l'hai trovato.E lavati la faccia. Sembri...»
«Una qualunque?» terminò la fraseIsabella.
Scossi la testa, sospirando.
«No. Tu non potresti mai sembrare unaqualunque, Isabella.»
«Certo. Per questo le piaccio così poco»mormorò voltandosi e dirigen-dosi
verso la sua camera.
«Isabella» chiamai.
Mi ignorò ed entrò nella stanza.
«Isabella» ripetei, alzando la voce.
Mi indirizzò uno sguardo ostile e sbattéla porta. Sentii che iniziava a spostarecose in camera da letto e mi avvicinai.Bussai. Nessuna risposta.
Bussai di nuovo. Aprii e la trovai chepiegava le quattro cose che avevaportato con sé e le metteva nella suaborsa.
«Cosa stai facendo?» chiesi.
«Me ne vado, ecco quello che faccio.Me ne vado e la lascio in pace. O
in guerra, perché con lei non si sa mai.»
«Posso sapere dove vai?»
«E cosa gliene importa? È una domandaretorica o ironica? Per lei, chiaramente,fa lo stesso, ma siccome io sonoun'imbecille, non so distingue-
re.»
«Isabella, aspetta un momento e...»
«Non si preoccupi per il vestito, adessome lo tolgo. E i pennini può ri-portarliindietro, tanto non li ho usati e nemmenomi piacciono. Sono una pacchianata dabambina dell'asilo.»
Mi avvicinai e le misi una mano sullaspalla. Si scostò d'un balzo, come sel'avesse sfiorata un serpente.
«Non mi tocchi.»
«Isabella, scusami. Per favore. Nonvolevo offenderti.»
Mi guardò con le lacrime agli occhi e unsorriso amaro.
«Ma se non ha fatto altro. Da quandosono qui. Non ha fatto altro che in-sultarmi e trattarmi come se fossi unapovera idiota che non capisce niente.»
«Scusa» ripetei. «Lascia stare quellecose. Non te ne andare.»
«Perché no?»
«Perché te lo chiedo per favore.»
«Se voglio compassione e carità, possotrovarle da qualche altra parte.»
«Non è compassione, né carità, a meno
che non le provi tu per me. Ti chiedo direstare perché l'idiota sono io, e nonvoglio stare solo. Non posso staresolo.»
«Che gentile. Sempre a pensare aglialtri. Si compri un cane.»
Lasciò cadere la borsa sul letto e miaffrontò, asciugandosi le lacrime etirando fuori la rabbia che avevaaccumulato. Deglutii.
«Allora, visto che stiamo giocando adire la verità, lasci che le dica che saràsempre solo. Sarà solo perché non saamare né condividere. Lei è come questacasa, che mi fa drizzare i capelli in testa.Non mi meraviglia che la sua signorina
in bianco l'abbia piantato né che lofacciano tutti. Lei non ama e non silascia amare.»
La guardai avvilito, come se me leavessero appena date e non sapessi dadove erano venuti i colpi. Cercai leparole e trovai soltanto dei balbettii.
«Davvero non ti piace il set di pennini?»riuscii ad articolare alla fine.
Isabella alzò gli occhi al cielo, esausta.
«Non faccia quell'espressione da canebastonato, perché sarò pure idiota, manon fino a questo punto.»
Restai in silenzio, appoggiato alla
cornice della porta. Isabella miosservava con un'aria tra sospettosa ecompassionevole.
«Non volevo dire certe cose della suaamica, quella delle foto. Scusi»
mormorò.
«Non scusarti. È la verità.»
Abbassai gli occhi e uscii dalla stanza.Mi rifugiai nello studio a contemplare lacittà scura e sepolta dalla nebbiolina.Dopo un po' sentii i suoi passi sullescale, esitanti.
«È lì su?» chiamò.
«Sì.»
Isabella entrò nella stanza. Si eracambiata il vestito e si era lavata via lelacrime dalla faccia. Mi sorrise e io fecilo stesso.
«Perché è così, lei?» domandò.
Mi strinsi nelle spalle. Isabella siavvicinò e si sedette sul davanzale,accanto a me. Ci godemmo lo spettacolodi silenzi e ombre sui tetti della cittàvecchia senza bisogno di dire nulla.Dopo un po', mi sorrise e mi guardò.
«E se accendiamo uno di quei sigari chele regala mio padre e ce lo fu-miamoinsieme?»
«Neanche a parlarne.»
Isabella sprofondò in uno dei suoi lunghisilenzi. Ogni tanto mi guardavabrevemente e sorrideva. Io la osservavodi sottecchi e mi accorgevo che bastavaguardarla e diventava meno difficilecredere che forse restava qualcosa dibuono e decente in questo schifo dimondo e, con un po' di fortuna, anche inme.
«Rimani?» domandai.
«Mi dia un buon motivo. Un motivosincero, cioè, nel suo caso, egoisti-co. Emeglio per lei che non sia una bugia,altrimenti me ne vado su due piedi.»
Si riparò dietro uno sguardo difensivo,in attesa di qualche mia lusinga, e per unistante mi sembrò l'unica persona almondo a cui non volevo né potevomentire. Abbassai gli occhi e per unavolta dissi la verità, fosse anche soloper sentirla io stesso a voce alta.
«Perché sei l'unica amica che mi resta.»
La durezza della sua espressione svanìe, prima di riconoscere la compassionenei suoi occhi, distolsi lo sguardo.
«E il signor Sempere e quell'altro tantopedante, Barceló?»
«Sei l'unica che mi resti che si azzardi adirmi la verità.»
«E il suo amico, il suo principale, nongliela dice?»
«Non mischiare la lana con la seta. Luinon è mio amico. E non credo abbia maidetto la verità in tutta la vita.»
Isabella mi guardò attentamente.
«Lo vede? Sapevo che non si fidava dilui. Gliel'ho letto in faccia fin dal primogiorno.»
Cercai di recuperare un po' di dignità,ma trovai solo sarcasmo.
«Hai aggiunto la lettura delle facce altuo elenco di talenti?»
«Per leggere la sua non c'è bisogno dinessun talento» ribatté Isabella.
«È come una favola di Pollicino.»
«E cos'altro leggi sul mio volto, egregiasibilla?»
«Paura.»
Cercai di ridere senza averne voglia.
«Non deve vergognarsi di avere paura.È segno di buon senso. Gli unici che nonhanno paura di nulla sono i matti dalegare. L'ho letto in un libro.»
«Il manuale del fifone?»
«Non c'è bisogno che lo ammetta, sequesto mette in pericolo il suo senso dimascolinità. So che voi uomini credeteche le dimensioni della vostratestardaggine corrispondano a quelledelle vostre vergogne.»
«Anche questo l'hai letto in quel libro?»
«No, è farina del mio sacco.»
Lasciai cadere le braccia, arrendendomiall'evidenza.
«D'accordo. Sì, ammetto di sentire unavaga inquietudine.»
«Lei sì, che è vago. Muore dalla paura.Confessi.»
«Non esageriamo. Diciamo che hoqualche dubbio sul rapporto con il mioeditore, il che, data la mia esperienza, ècomprensibile. A quanto ne so, Corelli èun perfetto gentiluomo e il nostrorapporto professionale sarà fruttifero epositivo per entrambe le parti.»
«Per questo le borbotta la pancia ognivolta che salta fuori il suo nome.»
Sospirai, senza più fiato per discutere.
«Cosa vuoi che ti dica, Isabella?»
«Che non lavorerà più per lui.»
«Questo non posso farlo.»
«E perché no? Non può restituirgli isoldi e mandarlo a spasso?»
«Non è così semplice.»
«Perché no? Si è ficcato in qualcheguaio?»
«Credo di sì.»
«Di che tipo?»
«È quello che sto tentando di appurare.In ogni caso, sono l'unico responsabile edevo risolverlo io. Niente di cui tudebba preoccuparti.»
Isabella mi guardò, rassegnata per ilmomento, ma non convinta.
«Come persona lei è un disastrocompleto, lo sa?»
«Sto abituandomi all'idea.»
«Se vuole che resti, le regole, qui,devono cambiare.»
«Sono tutt'orecchi.»
«È finito il dispotismo illuminato. Apartire da oggi, in questa casa vige lademocrazia.»
«Libertà, uguaglianza e fraternità.»
«Stia attento alla fraternità. Ma basta"comando io e ordino io", e niente piùsceneggiate alla mister Rochester.»
«Come vuole, miss Eyre.»
«E non si faccia illusioni, non la sposonemmeno se rimane cieco.»
Le tesi la mano per siglare il nostropatto. La strinse, esitando, e poi miabbracciò. Mi lasciai avvolgere dallesue braccia e le appoggiai il viso suicapelli. Il contatto con lei era pace eaccoglienza, la luce vitale di una ragazzadi diciassette anni che volli crederesimile all'abbraccio che mia madre nonebbe mai il tempo di darmi.
«Amici?» mormorai.
«Finché morte non ci separi.»
22
Le nuove regole del regno di Isabella Ientrarono in vigore alle ore nove delgiorno dopo, quando la mia assistentefece la sua comparsa in cucina e, senzatanti giri di parole, mi informò su comesarebbero andate le cose a partire daquel momento.
«Ho pensato che lei ha bisogno di unaroutine nella sua vita. Sennò sidisorienta e agisce in manieradissoluta.»
«Dove l'hai presa questa espressione?»
«Da uno dei suoi libri. D-i-s-s-o-l-u-t-a.Suona bene.»
«E fa rima con prosti...»
«Non cambi argomento.»
Durante la giornata, avremmo lavoratoentrambi ai rispettivi manoscritti.
Dopo aver cenato insieme, lei miavrebbe mostrato le pagine scritte e leavremmo discusse. Io giuravo di esseresincero e di darle le indicazioniopportune, niente zuccherini per farlacontenta. Le domeniche sarebbero statedi vacanza e io l'avrei portata alcinematografo, a teatro o a passeggio.Lei mi avrebbe aiutato a cercaredocumentazione nelle biblioteche e negliarchivi e avrebbe fatto in modo che ladispensa fosse piena grazie alla
connessione con l'emporio di famiglia.Io avrei preparato la colazione e lei lacena. Il pranzo l'avrebbe preparato chifosse stato libero in quel momento. Cisaremmo divisi i lavori e io miimpegnavo ad accettare il fattoincontestabile che la casa doveva esserepulita con regolarità. Io non avreiassolutamente cercato di trovarle unfidanzato e lei si sarebbe astenuta daldiscutere le mie ragioni per lavorare perCorelli o dal manifestare le sue opinionial riguardo, a meno che non fossi io achiedergliele. Per il resto, avremmoimprovvisato in corso d'opera.
Sollevai la mia tazza di caffè ebrindammo alla mia sconfitta e alla mia
resa incondizionata.
In appena un paio di giorni mi consegnaialla pace e alla serenità del vassallo.Isabella aveva un risveglio lento evischioso, e quando emergeva dalla suastanza con gli occhi semichiusi,strascicando un paio delle mie pantofoleche le stavano grandi di mezzo piede, ioavevo già preparato la colazione, ilcaffè e un quotidiano del mattino, unodiverso ogni giorno.
La routine è la governantedell'ispirazione. Non erano trascorsenemmeno quarantott'oredall'instaurazione del nuovo regimequando scoprii che cominciavo a
recuperare la disciplina dei miei annipiù produttivi. Le ore di reclusione nellostudio si cristallizzarono rapidamente inpagine e pagine nelle quali, non senzauna certa inquietudine, iniziai ariconoscere che il lavoro avevaraggiunto quel punto di consistenza incui smette di essere un'idea e diventauna realtà.
Il testo scorreva, brillante ed elettrico.Si lasciava leggere come se si trattassedi una leggenda, una saga mitologica diprodigi e penurie popolata di personaggie scenari intrecciati attorno a unaprofezia di speranza per la stirpe. Lanarrazione spianava la strada all'avventodi un salvatore guerriero che avrebbe
liberato la nazione da ogni male e offesaper restituirle la gloria e l'orgoglio,usurpati da scaltri nemici che avevanocospirato da sempre e per sempre controil popolo, quale che fosse. Ilmeccanismo era impeccabile efunzionava ugualmente se applicato aqualunque credo, stirpe o tribù.Bandiere, dèi e proclami erano comejolly di un mazzo che distribuiva semprele stesse carte. Vista la natura dellavoro, avevo optato per utilizzare unodegli artifici più complessi e difficili darealizzare in qualsiasi testo letterario:l'apparente assenza di artifici. Illinguaggio risuo-nava chiaro e semplice,la voce onesta e limpida di unacoscienza che non narra, ma
semplicemente rivela. A volte misoffermavo a rileggere quanto avevoscritto fino a quel momento ed eroinvaso dalla vanità cieca di senti-
re che il macchinario che stavomontando funzionava con una precisioneassoluta. Mi resi conto che, per la primavolta da molto tempo, passavo ore interesenza pensare a Cristina o a PedroVidal. Le cose, dissi fra me, andavanoper il meglio. Forse per questo, perchémi sembrava finalmente di uscire daltunnel, feci quello che ho sempre fattoogni volta che la mia vita si èincamminata su una buona strada:rovinare tutto.
Una mattina, dopo colazione, indossaiuno dei miei vestiti da cittadinorispettabile. Passai dal salotto persalutare Isabella e la vidi china sullascrivania a rileggere pagine del giornoprima.
«Oggi non scrive?» chiese senza alzaregli occhi.
«Giornata di riflessione.»
Notai che aveva sistemato il set dipennini e il calamaio delle muse accantoal suo quaderno.
«Credevo che per te fosse unapacchianata» dissi.
«Infatti, ma sono una ragazza didiciassette anni e ho tutti i diritti difarmi piacere le pacchianate. Come leicon i sigari.»
Il profumo di colonia la raggiunse e milanciò un'occhiata intrigata. Vedendo chemi ero vestito per uscire, aggrottò lesopracciglia.
«Va a fare di nuovo il detective?»domandò.
«Un poco.»
«Non ha bisogno di un guardaspalle?Una dottoressa Watson? Qualcuno conun po' di buonsenso?»
«Non imparare a cercare pretesti pernon scrivere prima di imparare ascrivere. È un privilegio deiprofessionisti e bisogna guadagnarselo.»
«Io credo che, se sono la sua assistente,devo esserlo in tutto.»
Sorrisi mansueto.
«Ora che me lo dici, c'è qualcosa chevolevo chiederti. No, non spaven-tarti.Ha a che fare con Sempere. Ho saputoche ha problemi di soldi e che lalibreria traballa.»
«Non può essere.»
«Purtroppo è così, ma non succederà
nulla perché noi non permetteremo chele cose peggiorino.»
«Guardi che il signor Sempere è moltoorgoglioso e non la lascerà... Ci ha giàprovato, vero?»
Annuii.
«Perciò ho pensato che dobbiamo esserepiù astuti e fare ricorso all'ete-rodossiae alle male arti.»
«La sua specialità.»
Ignorai il tono di riprovazione eproseguii il discorso.
«Ecco cosa ho pensato: come per caso,
càpiti in libreria e dici a Sempere chesono un orco, che non ne puoi più dime...»
«Fin qui, verosimile al cento per cento.»
«Non interrompere. Poi gli dici ancheche quello che ti pago per farmi daassistente è una miseria.»
«Ma se non mi dà neanche uncentesimo...»
Sospirai, armandomi di pazienza.
«Quando ti dirà che gli dispiace, perchélo dirà, fai la faccia da damigel-la inpericolo e gli confessi, magari conqualche lacrimuccia, che tuo padre ti ha
diseredato e ti vuole fare monaca e perquesto hai pensato che forse potevilavorare lì qualche ora, in prova, incambio del tre per cento di commissionesu quello che vendi, per costruirti unfuturo lontano dal convento come donnalibertaria e consacrata alla diffusionedelle belle lettere.»
Isabella strabuzzò gli occhi.
«Tre per cento? Vuole aiutare Sempere ovuole forse spennarlo?»
«Voglio che indossi un vestito comequello dell'altra sera, ti agghindi comesai e vai a trovarlo quando suo figlio èin libreria, di solito nel pomeriggio.»
«Stiamo parlando di quello bello?»
«Quanti figli ha il signor Sempere?»
Isabella tirò le somme e quandocominciò a capire dove andavo a pararemi lanciò un'occhiata sulfurea.
«Se mio padre sapesse che specie dimente perversa ha lei, si compre-rebbeil fucile.»
«Voglio solo che il figlio ti veda. E cheil padre veda come il figlio ti guarda.»
«Lei è ancora peggio di quanto pensavo.Ora si dedica alla tratta delle bianche.»
«È semplice carità cristiana. Inoltre, sei
stata tu la prima ad ammettere che ilfiglio di Sempere è di bell'aspetto.»
«Di bell'aspetto e un po' stupido.»
«Non esageriamo. Sempere junior èsemplicemente un po' timido in presenzadel genere femminile, il che gli fa onore.È un cittadino modello che, nonostantesia cosciente dell'effetto persuasivodella sua grazia e della sua prestanza,esercita autocontrollo e ascetismo perrispetto e devozione alla purezza senzamacchia della donna barcellonese. Nonmi dirai che questo non gli conferisceun'aura di nobiltà e fascino che faappello ai tuoi istinti, quello materno equelli periferici!»
«A volte credo di odiarla, signorMartín.»
«Aggrappati a questo sentimento, ma nonincolpare il povero figliolo di Semperedelle mie carenze come essere umanoperché lui è, confidenzial-mente, unsant'uomo.»
«Eravamo d'accordo che non mi avrebbecercato un fidanzato.»
«Nessuno ha parlato di fidanzamento. Semi lasci finire, ti racconto il resto.»
«Prosegua, Rasputin.»
«Quando Sempere padre dirà di sì,perché lo dirà, voglio che ogni giorno tu
stia due o tre ore al banco dellalibreria.»
«Vestita come? Da Mata Hari?»
«Con il decoro e il buon gusto che ticaratterizzano. Carina, invitante, masenza esagerare. Se occorre, prendi unodei vestiti di Irene Sabino, peròdecente.»
«Ce ne sono due o tre che mi stanno daschianto» osservò Isabella, sdi-linquendosi in anticipo.
«Be', indossa quello che ti copre dipiù.»
«Lei è un reazionario. E la mia
formazione letteraria?»
«Quale migliore aula di Sempere e Figliper ampliarla? Lì sarai circondata dacapolavori da cui imparare un sacco.»
«E cosa faccio? Respiro a fondo pervedere se mi resta appiccicatoqualcosa?»
«È solo per qualche ora al giorno. Poipuoi continuare con il tuo lavoro qui,come finora, e ricevere i miei consigli,che non hanno prezzo e faran-no di teuna nuova Jane Austen.»
«E dov'è il trucco?»
«Il trucco è che ogni giorno io ti darò
qualche peseta e ogni volta che i clientiti pagano e apri la cassa ce la mettidentro con discrezione.»
«Così, questo è il piano...»
«Come puoi vedere, non ha niente diperverso.»
Isabella aggrottò le sopracciglia.
«Non funzionerà. Si accorgerà che c'èqualcosa di strano. Il signor Sempere èpiù sveglio della fame.»
«Funzionerà. E se Sempere si stupisce,gli dici che i clienti, quando vedono unaragazza bella e simpatica dietro ilbancone, aprono il portafoglio e si
mostrano più generosi.»
«Questo succederà nei tuguri di bassalega che frequenta lei, non in unalibreria.»
«Non sono d'accordo. Se entro in unalibreria e trovo una commessaaffascinante come te sono capace dicomprare perfino l'ultimo premionazionale di letteratura.»
«Perché la sua mente è più sporca di unagruccia da pollaio.»
«Ho anche, o dovrei dire abbiamo, undebito di gratitudine con Sempere.»
«Questo è un colpo basso.»
«Allora non costringermi a mirareancora più in basso.»
Ogni manovra di persuasione che sirispetti fa appello prima alla curiosità,poi alla vanità e, per ultimo, alla bontà oal rimorso. Isabella abbassò lo sguardoe annuì lentamente.
«E quando vorrebbe mettere in pratica ilsuo piano della ninfa con il panesottobraccio?»
«Non lasciamo per domani quello chepossiamo fare oggi.»
«Oggi?»
«Questo pomeriggio.»
«Mi dica la verità. È uno stratagemmaper lavare il denaro che le paga il suoprincipale e purgare la sua coscienza oqualunque cosa abbia al suo posto?»
«Sai che i miei moventi sono sempreegoistici.»
«E cosa succede se il signor Semperedice di no?»
«Tu assicurati che il figlio sia lì e vaccicon il vestito della domenica, ma nonquello della messa.»
«È un piano degradante e offensivo.»
«E ti piace da matti.»
Isabella alla fine sorrise, felina.
«E se il figlio ha un attacco di coraggioe decide di osare più del dovuto?»
«Ti garantisco che l'erede non siazzarderà a metterti un dito addosso senon in presenza di un prete e con uncertificato della diocesi in mano.»
«Chi troppo e chi niente.»
«Lo farai?»
«Per lei?»
«Per la letteratura.»
23
Uscendo in strada mi sorprese un ventofreddo e tagliente che spazzava le stradecon impazienza e capii che l'autunnostava entrando in punta di piedi aBarcellona. In plaza Palacio salii su untram che aspettava vuoto come unagrande trappola per topi di ferro battuto.Occupai un posto vicino al finestrino epagai il biglietto al controllore.
«Va a Sarrià?» domandai.
«Fino alla piazza.»
Appoggiai la testa contro il finestrino edopo un po' il tram partì con unoscossone. Chiusi gli occhi e miabbandonai a uno di quei pisolini che cisi può godere solo a bordo di qualche
mostro meccanico, l'aspirazionedell'uomo moderno. Sognai di viaggiarein un treno fatto di ossa nere e di vagonia forma di bara che attraversava unaBarcellona deserta e disseminata diindumenti abbandonati, come se i corpiche li avevano occupati fosseroevaporati. Una tundra di cappelli evestiti, completi e scarpe ricopriva lestrade stregate dal silenzio. Lalocomotiva sprigionava una scia di fumoscarlatto che si spargeva in cielo comepittura versata. Il principale, sorridente,viaggiava accanto a me. Era vestito dibianco e portava i guanti.
Qualcosa di scuro e gelatinoso gligocciolava dalla punta delle dita.
« Cos'è successo alla gente? »
« Abbia fede, Martín. Abbia fede. »
Quando mi svegliai, il tram scivolavalentamente all'ingresso della piazza diSarrià. Scesi prima che si fosse fermatodel tutto e imboccai la salita di calleMayor de Sarrià. Quindici minuti piùtardi arrivavo a destinazione.
La carretera de Vallvidrera partiva da unbosco scuro alle spalle del castello dimattoni rossi del Colegio San Ignacio.La strada saliva verso la montagna,fiancheggiata da ville solitarie ericoperta da un manto di foglie secche.Nubi basse scivolavano lungo il fiancodella collina e si disfacevano in aliti di
nebbia. Presi il marciapiede dei numeridispari e perlustrai con lo sguardo murie cancelli cercando di leggere lanumerazione. Al di là si intravedevanofacciate di pietra annerita e fontaneasciutte arenate tra sentieri invasi dalleerbacce. Percorsi un tratto dimarciapiede all'ombra di una lunga filadi cipressi e scoprii che la numerazionesaltava dall'11 al 15.
Confuso, ritornai sui miei passicercando il numero 13. Cominciavo asospettare che la segretariadell'avvocato Valera fosse più astuta diquanto sembrava e che mi avesse datoun indirizzo falso, quando notail'ingresso di un vialetto che partiva dal
marciapiede e si prolungava per un altrocentinaio di metri fino a un cancelloscuro che formava una cresta di lance.
Imboccai lo stretto vicolo lastricato e miavvicinai all'inferriata. Un giardino foltoe non curato era strisciato versol'esterno, e i rami di un eucalip-toattraversavano le lance del cancellocome braccia supplicanti tra le sbarre diuna cella. Scostai le foglie chericoprivano parte del muro e scoprii lelettere e le cifre incise sulla pietra.
Casa Marlasca
13
Seguii la cancellata che fiancheggiava il
giardino, cercando di scrutareall'interno. A una ventina di metri trovaiuna porta metallica incassata nel muro dipietra. C'era un battente sulla lastra diferro, saldato con lacrime di ruggine. Laporta era socchiusa. Spinsi con la spallae riuscii a farla cedere abbastanza perpassare senza che gli spigoli di pietrache sporgevano dal muro mistrappassero i vestiti. Un intenso odoredi terra bagnata impregnava l'aria.
Un sentiero di piastrelle di marmo siapriva tra gli alberi e conduceva a unaradura ricoperta di pietre bianche. Su unlato si potevano vedere dei garage con ilportone aperto e i resti di quella che untempo era stata una Mercedes-Benz e
adesso sembrava un carro funebreabbandonato alla sua sorte. La casa erauna struttura in stile modernista innalzatasu tre piani dalle linee curve, sormontatada una cresta di abbaini che siaccalcavano sopra torrioni e archi.Finestroni stretti e acuminati comepugnali si aprivano nella facciatapunteggiata di incisioni e gargolle. Ivetri riflettevano il passaggio silenziosodelle nuvole. Mi sembrò di scorgere unviso stagliarsi dietro uno dei finestronidel primo piano.
Senza pensarci troppo, alzai la mano eabbozzai un saluto. Non volevo che miscambiassero per un ladro. La sagomarestò lì a osservarmi, immobile come un
ragno. Abbassai gli occhi un istante e,quando tornai a guardarla, era sparita.
«Buon giorno!» chiamai.
Attesi qualche secondo e non ottenendorisposta mi avvicinai lentamente allacasa. Una piscina ovale fiancheggiava lafacciata est. Sull'altro lato si innalzavauna veranda a vetrate. Sedie di telasfilacciata circondavano la piscina. Untrampolino aggredito dall'edera siprotendeva sulla lastra di acqua scura.Mi avvicinai al bordo e vidi che lavasca era disseminata di foglie morte ealghe che ondeggiavano sulla superficie.Stavo contemplando il mio riflessonell'acqua della piscina quando sentii
che una sagoma scura incombeva allemie spalle.
Mi voltai bruscamente e mi imbattei inun volto affilato e cupo che mi scrutavacon inquietudine e sospetto.
«Chi è lei e cosa ci fa qui?»
«Mi chiamo David Martín e mi mandal'avvocato Valera» improvvisai.
Alicia Marlasca strinse le labbra.
«Lei è la signora Marlasca? DonnaAlicia?»
«Cos'è successo a quello che viene disolito?» chiese.
Capii che mi aveva scambiato per unpraticante dello studio di Valera eriteneva che portassi qualche documentoda firmare o un messaggio da parte degliavvocati. Per un istante valutai lapossibilità di adottare quell'i-dentità, maqualcosa nell'aspetto della donna midisse che nella sua vita aveva già sentitoabbastanza bugie per sopportarne altre.
«Non lavoro per lo studio, signoraMarlasca. Il motivo della mia visita è diindole privata. Mi chiedevo se leiavesse qualche minuto per parlare di unadelle vecchie proprietà del suo defuntomarito, don Diego.»
La vedova impallidì e distolse lo
sguardo. Si appoggiava a un bastone evidi che sulla porta della veranda c'erauna sedia a rotelle sulla quale immaginaitrascorresse più tempo di quanto lepiacesse ammettere.
«Ormai non resta più nessuna proprietàdi mio marito, signor...»
«Martín.»
«Hanno preso tutto le banche, signorMartín. Tutto meno questa casa, chegrazie ai consigli del signor Valera, ilpadre, fu intestata a mio nome. Il restose lo sono portato via le iene...»
«Mi riferivo alla casa della torre, incalle Flassaders.»
La vedova sospirò. Calcolai che dovevaavere sessanta o sessantacinque anni.L'eco di quella che doveva essere statauna bellezza sfolgorante quasi non si eraspento.
«Si scordi di quella casa. È un postomaledetto.»
«Purtroppo non posso farlo. Ci abito.»
La signora Marlasca aggrottò lesopracciglia.
«Credevo che nessuno ci potesse vivere.È rimasta vuota molti anni.»
«L'ho affittata già da parecchio tempo. Ilmotivo della mia visita è che, nel corso
di qualche lavoro di ristrutturazione, hotrovato una serie di effetti personali checredo appartenessero al suo defuntomarito e, immagino, a lei.»
«Non c'è niente di mio in quella casa.Quello che ha trovato sarà di quelladonna...»
«Irene Sabino?»
Alicia Marlasca sorrise con amarezza.
«Cos'è che davvero vuole sapere, signorMartín? Mi dica la verità. Lei non èvenuto fin qui per restituirmi le vecchiecose di mio marito.»
Ci guardammo in silenzio e seppi che
non potevo né volevo mentire a quelladonna, a nessun costo.
«Sto cercando di capire cosa accadde asuo marito, signora Marlasca.»
«Perché?»
«Perché credo che a me stia succedendola stessa cosa.»
Casa Marlasca aveva quell'atmosfera damausoleo abbandonato delle grandidimore che vivono dell'assenza e dellamancanza. Lontana dai giorni di fortunae di gloria, dai tempi in cui un esercitodi domestici la manteneva intatta e pienadi splendore, la casa ora andava inrovina. La pittura delle pareti, scrostata;
le piastrelle del pavimento, dissestate; imobili, rosi dall'umidità e dal freddo; isoffitti, caduti; e i grandi tappeti,spelacchiati e scoloriti. Aiutai la vedovaa sistemarsi sulla sedia a rotelle eseguendo le sue indicazioni la condussiin una sala di lettura in cui quasi nonrestavano più né libri né quadri.
«Ho dovuto vendere gran parte dellecose per sopravvivere» spiegò.
«Non fosse stato per l'avvocato Valera,che continua a mandarmi ogni mese unapiccola pensione dello studio, non avreisaputo dove andare.»
«Vive sola qui?»
La vedova annuì.
«Questa è la mia casa. L'unico postodove sono stata felice, anche se sonopassati tanti anni. Ho vissuto sempre quie morirò qui. Scusi se non le ho offertonulla. Non ricevo visite da tanto e nonso più come trattare gli ospiti.Preferisce tè o caffè?»
«Sto bene così, grazie.»
La signora Marlasca sorrise e indicò lapoltrona su cui ero seduto.
«Quella era la preferita di mio marito.Si sedeva lì a leggere fino a molto tardi,davanti al fuoco. Io a volte mi mettevoqui, accanto a lui, e lo ascol-tavo. A lui
piaceva raccontarmi cose, almenoallora. Siamo stati molto felici in questacasa...»
«Cosa accadde?»
La vedova si strinse nelle spalle, losguardo perso nelle ceneri del cami-
no.
«È sicuro di voler sentire questastoria?»
«La prego.»
24
«A dire la verità, non so bene quando fu
che mio marito Diego la conobbe.Ricordo solo che una volta cominciò aparlarne, di sfuggita, e che ben prestonon ci fu giorno in cui non lo sentissipronunciare il suo nome: Irene Sabino.Mi disse che gliel'aveva presentata uncerto Damián Roures, che organizzavasedute spiritiche in un appartamento dicalle Elisabets.
Diego era uno studioso di religioni emitologie, e aveva assistito a diversesedute come osservatore. A quell'epoca,Irene Sabino era una delle attrici piùpopolari del Paratelo. Era una bellezza,non lo nego. A parte ciò, non credosapesse contare più in là di dieci. Sidiceva che era nata tra le baracche della
spiaggia del Bogatell, che la madrel'aveva abbandonata nella bi-donvilledel Somorrostro e che era cresciuta inmezzo a mendicanti e gente che andavalì a nascondersi. Iniziò a ballare neicabaret e nei locali del Paratelo e delRaval a quattordici anni. Ballare, si faper dire. Immagino che abbia cominciatoa prostituirsi prima di imparare aleggere, se pure imparò... Per un periodofu la stella della sala La Criolla, o cosìdicevano. Poi passò ad altri locali dimaggior classe. Credo che fu all'Apolodove conobbe un certo Juan Corbera,che tutti chiamavano Jaco. Jaco era ilsuo agente e probabilmente il suoamante. Fu lui a inventare il nome diIrene Sabino e la leggenda che fosse la
figlia segreta di una grande vedette diParigi e di un principe della nobiltàeuropea. Non so qual era il suo veronome. Non so se riuscì mai ad averneuno. Jaco la introdusse alle sedutespiritiche, credo dietro suggerimento diRoures, e i due si spartivano i proventidella vendita della sua presuntaverginità a uomini ricchi e annoiati cheparteci-pavano a quelle farse pervincere la monotonia. Dicevano che lasua specialità erano le coppie.
«Quello che Jaco e il suo socio Rouresnon sospettavano è che Irene eraossessionata da quelle sedute e credevadavvero che durante quelle panto-mimesi potesse entrare in contatto con il
mondo degli spiriti. Era convinta chesua madre le mandasse messaggidall'altro mondo e perfino quandoraggiunse la fama continuava ad andarciper entrare in contatto con lei. Lìconobbe mio marito Diego. Credo cheattraversassimo un brutto periodo, cometutte le coppie. Da tempo Diego volevaabbandonare la professione e dedicarsiesclusivamente alla scrittura. Riconoscoche non trovò in me l'appoggio di cuiaveva bisogno. Io credevo che sel'avesse fatto avrebbe gettato la vita alleortiche, ma forse temevo solo di perderetutto questo, la casa, i domestici... Persitutto lo stesso, e anche lui. A separarcidefinitivamente fu la perdita di Ismael.Ismael era nostro figlio. Diego era pazzo
di lui. Non ho mai visto un padre tantoattaccato al figlio. Ismael, non io, era lasua vita. Stavamo discutendo nellacamera da letto al primo piano.
Avevo iniziato a recriminare sul tempoche passava a scrivere, sul fatto che ilsuo socio Valera, stanco di addossarsi illavoro di tutti e due, gli aveva dato unultimatum e meditava di sciogliere lasocietà e mettersi per conto suo. Diegodisse che non gli importava, che eradisposto a vendere la sua quota dellostudio per dedicarsi alla sua vocazione.Quel pomeriggio ci ac-corgemmodell'assenza di Ismael. Non era incamera sua, né in giardino.
Credetti che, sentendoci litigare, si fossespaventato e fosse uscito. Non era laprima volta che lo faceva. Mesi primal'avevano trovato in lacrime su unapanchina di plaza Sarrià. Uscimmo acercarlo al tramonto. Non c'era tracciadi lui da nessuna parte. Andammo a casadei vicini, negli ospedali...
Tornando, all'alba, dopo aver passato lanotte a cercarlo, trovammo il suo corpoin fondo alla piscina. Era annegato lasera prima e non avevamo sentito le suegrida di aiuto perché stavamo litigando avoce alta. Aveva sette anni. Diego nonmi perdonò mai, e non perdonònemmeno se stesso. Ben presto fummoincapaci di sopportare la presenza l'uno
dell'altra. Ogni volta che ci guardavamoo ci toccavamo vedevamo il cadavere dinostro figlio in fondo a quella maledettapiscina. Un giorno mi svegliai e seppiche Diego mi aveva abbandonato.Lasciò lo studio e andò ad abitare in unagrande casa del quartiere della Riberache da anni lo ossessionava. Diceva chestava scrivendo, che aveva ricevuto unincarico molto importante da un editoredi Parigi, che non dovevo preoccuparmiper i soldi. Io sapevo che stava conIrene, anche se lui non lo ammetteva.Era un uomo distrutto. Era convinto chegli restasse poco tempo da vivere.Credeva di aver preso una malattia, unaspecie di parassita, che lo stavadivorando dal di dentro. Parlava solo
della morte. Non ascoltava nessuno. Néme né Valera... Solo Irene e Roures, chegli avvelenavano il cervello con storiedi spiriti e gli e-storcevano denaro conla promessa di metterlo in contatto conIsmael. Una volta andai alla casa dellatorre e lo supplicai di aprirmi. Non mifece entrare. Mi disse che era occupato,che stava lavorando a qualcosa che gliavrebbe permesso di salvare Ismael. Aquel punto mi resi conto che cominciavaa perdere la ragione. Era convinto chese avesse scritto quel maledet-
to libro per l'editore di Parigi nostrofiglio sarebbe tornato indietro dallamorte. Credo che Irene, Roures e Jacosiano riusciti a spillargli i soldi che gli
restavano, che ci restavano... Mesidopo, quando ormai non vedeva piùnessuno e passava tutto il tempo chiusoin quel posto orribile, lo trovaronomorto. La polizia disse che era stato unincidente, ma io non ci ho mai creduto.Jaco era scomparso e non c'era tracciadei soldi, mentre Roures diceva di nonsapere nulla. Dichiarò che da mesi nonaveva contatti con Diego perché eraimpazzito e gli faceva paura. Disse chele ultime volte che si era presentato allesue sedute spiritiche Diego terrorizzavai clienti con le sue storie di animemaledette e che lui gli aveva proibito ditornare. Diceva che c'era un grande lagodi sangue sotto la città. Diceva che suofiglio gli parlava in sogno, che Ismael
era prigioniero di un'ombra con la pelledi serpente che si faceva passare per unbambino e giocava con lui... Nessuno sisorprese quando lo trovarono morto.Secondo Irene, Diego si era tolto la vitaper colpa mia: quella moglie fredda ecalcolatrice che aveva lasciato moriresuo figlio perché non voleva rinunciarea una vita nel lusso lo aveva spintoverso la morte. Disse che lei era l'unicaad averlo amato davvero e che nonaveva mai accettato neppure uncentesimo. E credo che, almeno suquesto, dicesse la verità. Credo che Jacol'abbia usata per sedurre Diego erubargli tutto. Poi, al momento dellaverità, la mollò e fuggì senza dividere unsoldo con lei. Così disse la polizia, o
almeno alcuni poliziotti. Mi è sempresembrato che non volessero rimestare inquell'affare e che la versione delsuicidio fosse la più conveniente perloro. Ma io non credo che Diego si siatolto la vita. Non l'ho creduto allora enon lo credo adesso.
Credo che l'abbiano ucciso Irene e Jaco.E non solo per denaro. C'era altro.
Mi ricordo che la pensava così ancheuno dei poliziotti assegnati al caso, unuomo molto giovane, Ricardo Salvador.Disse che qualcosa non quadrava nellaversione ufficiale dei fatti e chequalcuno stava coprendo la vera causadella morte di Diego. Salvador lottò per
chiarire le cose finché lo sollevaronodal caso e, col tempo, lo espulsero dalcorpo. Perfino allora continuò aindagare per conto suo. A volte veniva atrovarmi. Diventammo buoni amici...Ero una donna sola, in rovina edisperata. Valera mi suggeriva dirisposarmi. Anche lui mi incolpava perquello che era successo a mio marito earrivò a insinuare che c'erano molticommercianti scapoli ai quali unavedova di bella presenza e dall'ariaaristocratica poteva scaldare il lettonegli anni d'oro. Col tempo, ancheSalvador smise di venirmi a trovare.Non gliene faccio una colpa. Nel suotentativo di aiutarmi, si era rovinato lavita. A volte mi sembra che sia l'unica
cosa che sono riuscita a fa-
re per gli altri in questo mondo,rovinargli la vita... Fino a oggi nonavevo raccontato a nessuno questastoria, signor Martín. Se vuole unconsiglio, si scordi di quella casa, dime, di mio marito e di questa storia. Sene vada lontano. Questa città èmaledetta. Maledetta.»
25
Lasciai Casa Marlasca con il cuorenelle calze e vagai senza meta per illabirinto di strade solitarie cheportavano verso Pedralbes. Il cielo eracoperto da una ragnatela di nuvole grigieche a stento permettevano al sole di
filtrare. Aghi di luce perforavano quelsudario e spazzavano il fianco dellacollina. Seguii con lo sguardo quellelinee luminose e vidi come, inlontananza, accarezzavano il tettosmaltato di Villa Helius. Le finestrebrillavano lontane. Trascurando il buonsenso, mi incamminai in quelladirezione.
Via via che mi avvicinavo, il cielo sioscurava e un vento tagliente sollevavaspirali di foglie morte al mio passaggio.Mi fermai all'inizio di calle Panama.Villa Helius si ergeva davanti a me. Nonosai attraversare la strada e avvicinarmial muro che circondava il giardino.Rimasi lì sa Dio quanto tempo, incapace
di fuggire o di andare alla porta ebussare. Fu allora che la vidi passaredavanti a uno dei finestroni del secondopiano. Sentii un freddo intenso nelleviscere. Stavo per andarmene quando sivoltò e si fermò. Si avvicinò al vetro esentii i suoi occhi nei miei. Alzò lamano, come se volesse salutare, ma nonarrivò a distendere le dita. Non ebbi ilcoraggio di sostenere il suo sguardo emi voltai, allontanandomi giù per lastrada. Mi tremavano le mani e me lemisi in tasca perché non si notasse.
Prima di girare l'angolo, mi voltai dinuovo e vidi che era ancora lì aguardarmi. Volevo odiarla, ma mimancarono le forze.
Arrivai a casa con il freddo, o cosìvolevo pensare, nelle ossa. Varcando ilportone, vidi una busta che spuntavadalla cassetta postale dell'androne.
Pergamena e ceralacca. Notizie delprincipale. L'aprii mentre mi trascinavosu per le scale. La sua calligrafiaelegante mi dava appuntamento per ilgiorno dopo. Arrivando sul pianerottolo,vidi che la porta era socchiusa e cheIsabella mi aspettava sorridente.
«Ero nello studio e l'ho vista arrivare»disse.
Cercai di sorriderle, ma non dovettiessere molto convincente perché appenaIsabella mi guardò negli occhi assunse
un'aria preoccupata.
«Si sente bene?»
«Non è niente. Credo di avere preso unpo' di freddo.»
«Ho un brodino sul fuoco che sarà comeuna mano santa. Entri.»
Mi prese per il braccio e mi condusse insalotto.
«Isabella, non sono un invalido.»
Mi lasciò e abbassò gli occhi.
«Scusi.»
Non avevo forze per litigare connessuno, e men che meno con la miaostinata assistente, perciò mi lasciaiguidare verso una delle poltrone delsalotto e vi sprofondai come un saccod'ossa. Isabella si sedette di fronte a mee mi guardò, allarmata.
«Cos'è successo?»
Le sorrisi tranquillizzante.
«Niente. Non è successo niente. Nondovevi portarmi una tazza di brodo?»
«Subito.»
Si precipitò in cucina e la sentiisfaccendare. Respirai a fondo e chiusi
gli occhi finché sentii i passi di Isabellache si avvicinavano.
Mi tese un tazzone fumante didimensioni esagerate.
«Sembra un orinale» dissi.
«Beva e non dica bestialità.»
Annusai il brodo. Aveva un buon odore,ma non volevo fornire prove dieccessiva docilità.
«Ha uno strano odore. Cosa c'è dentro?»
«Odora di pollo perché c'è pollo, sale eun goccino di Jerez. Se lo beva.»
Ne bevvi un sorso e le restituii iltazzone. Isabella scosse la testa.
«Tutto.»
Sospirai e bevvi un altro sorso. Erabuono, mio malgrado.
«Com'è andata la giornata, allora?»chiese Isabella.
«Ha avuto i suoi momenti. E a te?»
«Lei ha di fronte la nuova star deidipendenti di Sempere e Figli.»
«Eccellente.»
«Prima delle cinque avevo già venduto
due copie del Ritratto di Dorian Gray ele opere complete di Thomas Hardy a unsignore molto distinto di Madrid che miha dato anche la mancia. Non facciaquella faccia, perché ho messo nellacassa anche quella.»
«E Sempere figlio, cos'ha detto?»
«Dire, non ha detto un granché. È statotutto il tempo come un allocco a far fintadi non guardarmi, ma senza togliermi gliocchi di dosso. Non posso nemmenoavvicinarmi a una sedia, tanto mi haguardato il sedere ogni volta che salivosulla scala per prendere un libro.»
Sorrisi e annuii.
«Grazie, Isabella.»
Mi guardò fisso negli occhi.
«Lo dica di nuovo.»
«Grazie, Isabella. Di tutto cuore.»
Arrossì e distolse lo sguardo. Restammoper un po' in un placido silenzio,godendoci quell'affiatamento che a voltenon aveva bisogno nemmeno di parole.Finii il brodo, anche se non mi entravapiù nemmeno una goccia, e le mostrai iltazzone vuoto. Annuì.
«È andato a trovarla, vero? Quelladonna. Cristina» disse Isabella,sfuggendo il mio sguardo.
«Isabella, la lettrice di facce...»
«Mi dica la verità.»
«L'ho vista solo da lontano.»
Isabella mi osservò con cautela, come seesitasse tra dirmi o non dirmi qualcosache le si era incagliato nella coscienza.
«L'ama?» domandò alla fine.
Ci guardammo in silenzio.
«Io non so amare nessuno. Lo sai. Sonoun egoista e tutto il resto. Parliamod'altro.»
Isabella annuì, lo sguardo catturato dalla
busta che mi spuntava dalla tasca.
«Notizie del principale?»
«La convocazione mensile.L'eccellentissimo signor AndreasCorelli si pregia di darmi appuntamentodomani alle sette del mattino alle portedel cimitero del Pueblo Nuevo. Nonpoteva scegliere un posto diverso.»
«E pensa di andarci?»
«Cos'altro posso fare?»
«Può prendere un treno stasera stessa escomparire per sempre.»
«Sei la seconda persona a propormelo
oggi. Scomparire da qui.»
«Ci sarà un motivo.»
«E chi sarà la tua guida e il tuo mentorenei disastri della letteratura?»
«Io vengo con lei.»
Sorrisi e le presi la mano.
«Con te in capo al mondo, Isabella.»
Ritirò la mano di scatto e mi guardò,offesa.
«Lei si prende gioco di me.»
«Isabella, se un giorno mi venisse in
mente di prendermi gioco di te, misparerei un colpo.»
«Non dica queste cose. Non mi piacequando parla così.»
«Scusa.»
La mia assistente tornò alla scrivania es'immerse in uno dei suoi lunghi silenzi.La osservai sfogliare le pagine scrittenella giornata, fare correzioni ecancellare paragrafi interi con il set dipennini che le avevo regalato.
«Se mi guarda, non riesco aconcentrarmi.»
Mi alzai e aggirai la scrivania.
«Allora ti lascio lavorare e dopo cenami fai vedere quello che hai scritto.»
«Non è pronto. Devo correggerlo tutto eriscriverlo e...»
«Non è mai pronto, Isabella. Abituati.Lo leggeremo insieme dopo cena.»
«Domani.»
Mi arresi.
«Domani.»
Annuì e mi accinsi a lasciarla sola conle sue parole. Stavo chiudendo la portadel salotto quando sentii la sua voce chemi chiamava.
«David?»
Mi fermai in silenzio dall'altro lato dellaporta.
«Non è vero. Non è vero che lei non saamare nessuno.»
Mi rifugiai nella mia stanza e chiusi laporta. Mi stesi di fianco sul letto,raccolto su me stesso, e chiusi gli occhi.
26
Uscii di casa dopo l'alba. Nubi scure sitrascinavano sopra i tetti e ruba-vano ilcolore alle strade. Mentre attraversavoil Parque de la Ciudadela vidi le primegocce colpire le foglie degli alberi e
schioccare sul vialetto, sollevandovolute di polvere come se fosseropallottole. Dall'altro lato del parco, unaforesta di fabbriche e gasometri simoltiplicava verso l'orizzonte, ilpulviscolo delle ciminiere diluito inquella pioggia nera che precipitava dalcielo in lacrime di catrame. Percorsil'inospitale viale di cipressi checonduceva alle porte del cimiterodell'Est, lo stesso tragitto che tante volteavevo fatto con mio padre. Il principaleera già lì. Lo vidi da lontano, cheaspettava imperturbabile sotto lapioggia, ai piedi di uno dei grandi angeliche sorvegliavano l'entrata principaledel camposanto. Vestiva di nero e aimpedire che si confondesse con una
delle centinaia di statue oltre le can-cellate erano soltanto i suoi occhi. Nonmosse una palpebra finché non fui apochi metri e, non sapendo cosa fare, losalutai con la mano. Faceva freddo e ilvento odorava di calce e di zolfo.
«I visitatori occasionali credonoingenuamente che ci siano sempre caldoe sole in questa città» disse ilprincipale. «Ma, come amo dire, primao poi l'anima antica, torbida e oscura diBarcellona si riflette in cielo.»
«Dovrebbe pubblicare guide turisticheinvece di testi religiosi» suggerii.
«Praticamente sono la stessa cosa. Comeha passato questi giorni di pace e
tranquillità? Il lavoro è andato avanti?Ha buone notizie per me?»
Aprii la giacca e gli diedi un plico difogli. Ci addentrammo nel cimitero incerca di un posto al riparo dalla pioggia.Il principale scelse un vecchio mausoleoche ci offriva una cupola sostenuta dacolonne di marmo e circondata da angelidal volto affilato e dalle dita troppolunghe. Ci sedemmo su una panchina dipietra fredda. Lui mi rivolse uno deisuoi sorrisi canini e mi fecel'occhiolino, mentre le sue pupille giallee brillanti si chiudevano in un punto neroin cui potevo vedere riflesso il miovolto pallido e visibilmente inquieto.
«Si rilassi, Martín. Lei dà troppaimportanza al macchinario di scena.»
Iniziò a leggere con calma i fogli che gliavevo portato.
«Credo che mi farò un giro mentre leilegge» dissi.
Corelli annuì senza alzare gli occhidalle pagine.
«Non scappi» mormorò.
Mi allontanai il più in fretta possibilesenza che sembrasse evidente che lofacevo e mi persi tra le strade e glianfratti della necropoli. Aggirai obe-lischi e sepolcri, addentrandomi nel
cuore del cimitero. La lapide era ancoralì, segnalata da un vaso vuoto in cuirimaneva lo scheletro di fioripietrificati. Vidal aveva pagato leesequie e aveva perfino commissionatoa uno scultore di una certa reputazionenell'ambiente delle pompe funebri unaPietà che custodiva la tomba alzando gliocchi al cielo, le mani sul petto inatteggiamento di supplica. Miinginocchiai davanti alla lapide e laripulii dal muschio che aveva ricopertole lettere incise a scalpello.
JOSÉ ANTONIO MARTÍN CLARÉS
1875-1908
Eroe della guerra delle Filippine.
Il suo paese e i suoi amici
non lo dimenticheranno mai
«Buon giorno, papà» dissi.
Contemplai la pioggia nera chescivolava sul viso della Pietà, la pioggiache batteva sulle lapidi, e sorrisi allasalute di quegli amici che non ebbe maie del paese che lo mandò a morire davivo per arricchire quattro ca-poccioniche non seppero mai nemmeno cheesisteva. Mi sedetti sulla lapide epoggiai la mano sul marmo.
«Chi gliel'avrebbe detto, vero?»
Mio padre, che aveva vissuto la sua
esistenza sull'orlo della miseria, ri-posava per l'eternità in una tomba daborghese. Da bambino non avevo maicapito perché il giornale avesse decisodi pagargli un funerale con un preteelegante e le prefiche, i fiori e unsepolcro da importatore di zucchero.
Nessuno mi disse che era stato Vidal apagare i fasti dell'uomo morto al suoposto, anche se io l'avevo sempresospettato, attribuendo quel gesto allabontà e generosità infinite con cui ilcielo aveva benedetto il mio mentore eidolo, il grande don Pedro Vidal.
«Devo chiederle perdono, papà. Peranni l'ho odiata per avermi lasciato qui,
da solo. Mi dicevo che aveva avuto lamorte che si era cercato. Per questo nonero mai venuto a trovarla. Mi perdoni.»
A mio padre non erano mai piaciute lelacrime. Credeva che un uomo nonpiangesse mai per gli altri, ma solo perse stesso. E se lo faceva era unvigliacco e non meritava nessuna pietà.Non volli piangere per lui e tradir-loancora una volta.
«Mi sarebbe piaciuto che lei vedesse ilmio nome su un libro, anche se nonavrebbe potuto leggerlo. Mi sarebbepiaciuto averla qui, con me, per vederecome suo figlio riusciva ad aprirsi unastrada e a fare alcune delle cose che a
lei vennero sempre vietate. Mi sarebbepiaciuto conoscerla, papà, e che leiconoscesse me. L'ho trasformata in unestraneo per dimenti-carla e adessol'estraneo sono io.»
Non lo sentii avvicinarsi, ma sollevandola testa vidi il principale che miosservava in silenzio ad appena pochimetri. Mi alzai e mi avvicinai a lui comeun cane ben ammaestrato. Mi chiesi sesapesse che lì era sepolto mio padre ese mi avesse dato appuntamento in quelposto proprio per quel motivo. La miafaccia doveva essere un libro aperto,perché lui scosse la testa e mi posò unamano sulla spalla.
«Non lo sapevo, Martín. Mi dispiace.»
Non ero disposto ad aprirgli la porta delcameratismo. Mi girai per libe-rarmi dalsuo gesto di affetto e commiserazione estrinsi gli occhi per trat-
tenere lacrime di rabbia. Mi avviaiverso l'uscita, senza aspettarlo. Luiattese qualche secondo e poi decise diseguirmi. Camminò al mio fianco insilenzio fin quando arrivammo alla portaprincipale. Lì mi fermai e lo guardai conimpazienza.
«E allora? Ha qualche commento?»
Il principale ignorò il mio tonovagamente ostile e sorrise paziente.
«Il lavoro è eccellente.»
«Ma...»
«Se dovessi fare un'osservazione seria,credo che lei abbia colto nel segnocostruendo tutta la storia dal punto divista di un testimone dei fatti che sisente vittima e parla in nome del popoloche attende questo salvatore guerriero.Voglio che continui su questa strada.»
«Non le sembra forzato, artificioso...?»
«Al contrario. Niente ci fa credere piùdella paura, della certezza di essereminacciati. Quando ci sentiamo vittime,tutte le nostre azioni e le nostre credenzevengono legittimate, per quanto
discutibili siano. I nostri opposi-tori, osemplicemente i nostri vicini, smettonodi essere al nostro livello e diventanonemici. Smettiamo di essere aggressoriper diventare difensori.
L'invidia, l'avidità o il risentimento checi muovono vengono santificati, perchédiciamo a noi stessi di agire in nostradifesa. Il male, la minaccia, è semprenell'altro. Il primo passo per crederecon passione è la paura. La paura diperdere la nostra identità, la nostra vita,la nostra condizione o le nostre fedi. Lapaura è la polvere da sparo e l'odio è lamiccia. Il dogma, in ultima istanza, èsolo un fiammifero acceso. È qui che lasua trama ha qualche lacuna, credo.»
«Mi chiarisca una cosa. Lei cerca fede odogma?»
«Ci può bastare che le persone credano.Devono credere a quello che vogliamoche credano. E non devono metterlo indiscussione né ascoltare la voce di chilo fa. Il dogma deve far partedell'identità stessa. Chiunque lo metta indiscussione è nostro nemico. È il male.Ed è nostro diritto, e dovere, affrontarloe distruggerlo. È l'unico cammino disalvezza. Credere per sopravvivere.»
Sospirai e distolsi lo sguardo, annuendodi malavoglia.
«Non la vedo convinto, Martín. Mi dicaquello che pensa. Crede che mi sbagli?»
«Non lo so. Credo che semplifichi lecose in modo pericoloso. Tutto il suodiscorso sembra un semplicemeccanismo per generare e incanalareodio.»
«L'aggettivo che stava per usare non erapericoloso, bensì ripugnante,
ma non ne terrò conto.»
«Perché dobbiamo ridurre la fede a unatto di rifiuto e di obbedienza cieca?Non è possibile credere in valori diaccettazione, di concordia?»
Il principale sorrise, divertito.
«È possibile credere in qualunque cosa,
Martín, nel libero mercato o inTopolino. Perfino nel fatto che noncrediamo in nulla, come fa lei, che è lacredulità più grande. Ho ragione?»
«Il cliente ha sempre ragione. Qual è lalacuna che vede nella storia?»
«Manca il cattivo. La maggior parte dinoi, ce ne rendiamo conto o no, cidefiniamo in opposizione a qualcosa o aqualcuno, più che a favore di qualcosa oqualcuno. È più facile reagire che agire,per così dire. Niente ravviva la fede e lozelo del dogma quanto un buonantagonista. Quanto più inverosimile,tanto meglio.»
«Avevo pensato che quel ruolo potesse
funzionare meglio in astratto.
L'antagonista sarebbe il non credente, lostraniero, colui che è fuori dal gruppo.»
«Sì, però mi piacerebbe che fosse piùconcreto. È difficile odiare un'idea.Richiede una certa disciplinaintellettuale e uno spirito ossessivo emal-sano, che non abbondano. È moltopiù facile odiare qualcuno con un voltoriconoscibile a cui dare la colpa di tuttociò che ci disturba. Non deve essere perforza un personaggio individuale. Puòessere una nazione, una razza, ungruppo... quello che sia.»
Il cinismo nitido e sereno del principaleriusciva ad averla vinta anche con me.
Sospirai, abbattuto.
«Adesso non mi faccia il cittadinomodello, Martín. Per lei fa lo stesso, eabbiamo bisogno di un cattivo in questovaudeville. Dovrebbe saperlo meglio dichiunque altro. Non c'è dramma senzaconflitto.»
«Che tipo di cattivo le piacerebbe? Untiranno invasore? Un falso profe-ta?L'uomo nero?»
«Lascio a lei la scelta dei costumi discena. Uno qualunque degli abitualisospetti mi sta bene. Una delle funzionidel nostro cattivo dev'essere quella diconsentirci di adottare il ruolo di vittimae reclamare la nostra superiori-tà
morale. Proietteremo su di lui tuttoquello che siamo incapaci diriconoscere in noi stessi e chedemonizziamo in accordo con i nostriinteressi personali. È l'aritmetica dibase del fariseismo. Le ho già detto dileggere la Bibbia. Tutte le risposte checerca sono lì.»
«Lo sto facendo.»
«Basta convincere il sant'uomo che èlibero da ogni peccato perché inizi atirare pietre, o bombe, con entusiasmo.E in realtà non c'è bisogno di un grandesforzo, perché si convince con unminimo di coraggio e di alibi.
Non so se mi spiego.»
«Alla perfezione. I suoi argomenti hannola sottigliezza di un crogiolosiderurgico.»
«Non credo che mi piaccia tanto questotono condiscendente, Martín. Le pareforse che tutto ciò non sia all'altezzadella sua purezza morale ointellettuale?»
«Assolutamente» mormorai,pusillanime.
«Cos'è allora che le solletica lacoscienza, amico mio?»
«Il solito. Non sono sicuro di essere ilnichilista che le serve.»
«Nessuno lo è. Il nichilismo è una posa,non una dottrina. Metta la fiamma di unacandela sotto i testicoli di un nichilista econstaterà come vede in fretta la lucedell'esistenza. A darle fastidio è un'altracosa.»
Alzai lo sguardo e ripescai il tono più disfida che ero capace di usare fissando ilprincipale negli occhi.
«Forse a darmi fastidio è che possocapire tutto quello che dice, ma non losento.»
«La pago per sentire?»
«A volte pensare e sentire sono la stessacosa. L'idea è sua, non mia.»
Il principale sorrise con una delle suepause drammatiche, come un maestro discuola che prepara la stoccata letale concui zittire un alunno discolo e svogliato.
«E lei cosa sente, Martín?»
L'ironia e il disprezzo nella sua voce midiedero coraggio e aprii il rubinettodell'umiliazione che avevo accumulatoper mesi alla sua ombra.
Rabbia e vergogna di sentirmi intimoritodalla sua presenza e di permettere i suoidiscorsi avvelenati. Rabbia e vergognaperché mi aveva dimostrato che,sebbene io preferissi credere che in mec'era disperazione, la mia anima erameschina e miserabile quanto il suo
umanesimo da fogna. Rabbia e vergognadi sentire, di sapere, che aveva sempreragione, soprattutto quando faceva piùmale accettarlo.
«Le ho fatto una domanda, Martín. Cosasente lei?»
«Sento che la cosa migliore sarebbelasciare le cose come stanno e restituirlei suoi soldi. Sento che, qualunque cosasi proponga con questa assur-daimpresa, preferisco non parteciparvi. Esoprattutto sento che mi dispiace averlaconosciuta.»
Il mio principale lasciò cadere lepalpebre e s'immerse in un lungosilenzio. Si voltò e si allontanò di
qualche passo in direzione delle portedella necropoli. Osservai il suo profiloscuro ritagliato sullo sfondo del giardinodi marmo, e la sua ombra immobile sottola pioggia. Provai paura, un timoretorbido che mi nasceva dalle viscere emi ispirava un desiderio infan-tile dichiedere scusa e di accettare qualunquepunizione mi venisse imposta pur di nondover sopportare quel silenzio. E provaischifo. Della sua presenza e,specialmente, di me stesso.
Il principale si girò e si avvicinò dinuovo. Si fermò ad appena pochicentimetri e chinò il suo volto sul mio.Sentii il suo alito freddo e mi persi neisuoi occhi neri, senza fondo. Stavolta la
voce e il tono erano di ghiaccio, privi diquella umanità pratica e studiata chesprizzavano la sua conversazione e isuoi gesti.
«Glielo dirò per l'ultima volta. Lei faràla sua parte e io la mia. Questa è l'unicacosa che può e deve sentire.»
Non mi resi conto che stavo annuendoripetutamente finché il principale nontirò fuori il plico di pagine dalla tasca eme le tese. Le lasciò cadere prima chepotessi prenderle. Il vento le trascinò inun mulinello e le vidi spargersi versol'entrata del camposanto. Mi affrettai acercare di salvarle dalla pioggia, maalcune erano cadute nelle pozzanghere e
si dissanguava-no nell'acqua, mentre leparole si staccavano a filamenti. Leriunii tutte in un mazzo di carta bagnata.Quando alzai gli occhi e mi guardaiintorno, il principale se n'era andato.
27
Se c'era un momento in cui avevo avutobisogno di un volto amico nel qualerifugiarmi, era quello. Il vecchioedificio della "Voz de la Industria"
spuntava dietro i muri del cimitero. Midiressi lì con la speranza di trovare ilmio maestro don Basilio, una di quellerare anime immuni dalla stupidità delmondo che danno sempre buoni consigli.Entrando nella sede del giornale, scoprii
che ancora riconoscevo la maggior partedel personale. Sembrava che non fossepassato neppure un minuto da quando men'ero andato sei anni prima. Quelli chemi riconobbero, a loro volta, miguardavano con sospetto e distoglievanolo sguardo per evitare di dovermisalutare. Mi infilai nella sala dellaredazione e andai dritto nello studio didon Basilio, in fondo. La sala era vuota.
«Chi cerca?»
Mi girai e mi imbattei in Roseli, uno deiredattori che già mi sembravano vecchiquando lavoravo lì da ragazzino e cheaveva firmato la recensione velenosadei Passi del cielo in cui venivo definito
"redattore di annunci a pagamento".
«Signor Roseli, sono Martín. DavidMartín. Non si ricorda di me?»
Roseli dedicò vari secondi aispezionarmi, fingendo di avere grandedifficoltà a riconoscermi, e alla fineannuì.
«E don Basilio?»
«Se n'è andato due mesi fa. Lo troveràalla redazione della "Vanguardia". Se lovede, me lo saluti.»
«Certamente.»
«Mi dispiace per la faccenda del suo
libro» disse Roseli con un sorrisocompiacente.
Attraversai la redazione navigando trasguardi schivi, sorrisi sghembi emormorii gelidi. Il tempo cura tutto,pensai, meno la verità.
Mezz'ora più tardi, un taxi mi lasciavaalle porte della sede della "Vanguardia"in calle Pelayo. A differenza dellasinistra decrepitezza del mio vecchiogiornale, lì tutto promanava un'aria disignorilità e di opulenza. Mi identificaial banco della portineria e un ragazzocon l'aspetto da apprendista, che miricordò me stesso nei miei anni daGrillo Parlante, fu mandato ad avvisare
don Basilio che aveva visite. L'aspettoleonino del mio vecchio maestro non eravenuto meno con il passare degli anni.Se possibile, e con il tocco del nuovoabbigliamento in tono con l'esclusivascenografia, don Basilio aveva unpersonale formidabile come ai tempidella "Voz de la Industria". Quando mivide, gli s'illuminarono gli occhi diallegria e, infran-gendo il suo ferreoprotocollo, mi accolse con un abbraccionel quale avrei facilmente potutorompermi due o tre costole se non cifosse stato del pubblico presente, per ilquale, contento o no, don Basilio dovevasalvare le apparenze e la reputazione.
«Ci stiamo imborghesendo, don
Basilio?»
Il mio vecchio capo si strinse nellespalle, facendo un gesto per togliereimportanza al nuovo arredamento che locircondava.
«Non si lasci impressionare.»
«Non sia modesto, don Basilio, qui è neltesoro della corona. Li sta già mettendoin riga?»
Don Basilio tirò fuori la sua perennematita rossa e me la mostrò, facendomil'occhiolino.
«Ne consumo quattro a settimana.»
«Due in meno che alla "Voz".»
«Mi dia tempo, qui c'è qualche genioche mette la punteggiatura a fucila-te ecrede che il sommario sia una specie dilibro delle addizioni.»
Malgrado le sue parole, era evidente chedon Basilio si trovava a proprio agionella nuova casa e aveva perfino unaspetto più florido.
«Non mi dica che è venuto a chiedermilavoro perché sono capace di darglielo»minacciò.
«La ringrazio, don Basilio, ma lei sa cheho smesso la tonaca e che il giornalismonon è cosa per me.»
«Allora mi dica in cosa può esserle utilequesto vecchio brontolone.»
«Ho bisogno di informazioni su unvecchio caso per una storia a cui stolavorando, la morte di un avvocato digrido di nome Marlasca, DiegoMarlasca.»
«Di quando stiamo parlando?»
«1904.»
Don Basilio sospirò.
«Credito a lungo termine. Ne è passatadi acqua sotto i ponti.»
«Non abbastanza da ripulire la
faccenda.»
Don Basilio mi posò la mano sullaspalla e mi fece cenno di seguirloall'interno della redazione.
«Non si preoccupi, è venuto nel postogiusto. Questa brava gente ha unarchivio da fare invidia al Vaticano. Seè uscito qualcosa sulla stampa, qui lotroviamo. E poi il capo dell'archivio èun buon amico. L'avverto che io,paragonato a luì, sono Biancaneve. Nonfaccia caso ai suoi modi bruschi.
In fondo, ma proprio in fondo in fondo, èun pezzo di pane.»
Seguii don Basilio attraverso un ampio
atrio di legni pregiati. Su un lato siapriva una sala circolare con una grandetavola rotonda e una serie di ritratti daiquali ci osservava una pleiade diaristocratici dall'aspetto severo.
«La stanza del sabba» spiegò donBasilio. «Qui si riuniscono i capiredat-tori con il condirettore, che è ilsottoscritto, e il direttore e, come i bravicavalieri della Tavola rotonda, troviamoil santo Graal tutti i giorni alle sette disera.»
«Impressionante.»
«Non ha ancora visto nulla» disse donBasilio, strizzandomi l'occhio.
«Guardi.»
Si mise sotto uno degli augusti ritratti espinse il pannello di legno che ricoprivala parete. Il pannello cedette con unoscricchiolio, rivelando un corridoionascosto.
«Eh? Cosa mi dice, Martín? E questo èsolo uno dei tanti passaggi segreti dellacasa. Nemmeno i Borgia avevano unlabirinto simile.»
Lo seguii lungo il corridoio e arrivammoin una grande sala di lettura circondatada teche di vetro, sepolcro dellabiblioteca segreta della "Vanguardia". Infondo alla sala, sotto il fascio di luce diuna lampada di cristallo verdino, si
distingueva la sagoma di un uomo dimezza età seduto a un tavolo a esaminareun documento con una lente. Vedendocientrare, alzò gli occhi e ci rivolse unosguardo che avrebbe pietrificatochiunque fosse minorenne o facilmenteimpressionabile.
«Le presento don José Maria Brotons,signore dell'inframondo e capo dellecatacombe di questa santa casa»annunciò don Basilio.
Brotons, senza mollare la lente, si limitòa osservarmi con quegli occhi cheossidavano al contatto. Mi avvicinai egli tesi la mano.
«Questo è il mio vecchio allievo, David
Martín.»
Brotons mi strinse la mano dimalavoglia e guardò don Basilio.
«Lo scrittore?»
«In persona.»
Brotons annuì.
«Ne ha di coraggio, a uscire per stradadopo le mazzate che le hanno dato. Cosaci fa qui?»
«È venuto a supplicare il suo aiuto,benedizione e consiglio su un argomentodi alta investigazione e archeologia deldocumento» spiegò don Basilio.
«E dov'è il sacrificio di sangue?» sbottòBrotons.
Deglutii.
«Sacrificio?» chiesi.
Brotons mi guardò come se fossi idiota.
«Una capra, un agnellino, almeno uncappone...»
Rimasi di stucco. Brotons sostenne ilmio sguardo senza battere ciglio per unistante infinito. Poi, quando cominciavoa sentire il prurito del sudore sullaschiena, il capo dell'archivio e donBasilio scoppiarono a ridere. Li lasciaisghignazzare di gusto a mie spese finché
restarono senza fiato e do-vetteroasciugarsi le lacrime. Chiaramente, donBasilio aveva trovato un'anima gemellanel nuovo collega.
«Venga da questa parte, giovanotto»disse Brotons, la facciata feroce inritirata. «Vediamo cosa le troviamo.»
28
Gli archivi del giornale si trovavano inuno degli scantinati del palazzo, sotto ilpiano che ospitava il grandemacchinario della rotativa, un mostro ditecnologia postvittoriana che sembravaun incrocio tra una spaventosalocomotiva a vapore e una macchina perfabbricare fulmini.
«Le presento la rotativa, più nota comeLeviatano. Faccia attenzione, dicono chesi è già divorata più di un incauto»avvertì don Basilio. «È come Giona e labalena, ma con effetto trinciato.»
«A qualcosa servirà.»
«Uno di questi giorni potremmo buttarcidentro il borsista, quello nuovo, chedice di essere nipote di Macià e fa tantoil furbetto» propose Brotons.
«Decida giorno e ora e festeggiamo conun piatto di cap-i-pota» convenne donBasilio.
Scoppiarono a ridere come dueragazzini. Dio li fa e poi li accoppia,
pensai.
La sala dell'archivio era un labirinto dicorridoi formati da scaffalature alte tremetri. Un paio di creature pallide, cheavevano l'aria di chi non usciva daquello scantinato da quindici anni,svolgevano le funzioni di assistenti diBrotons. Vedendolo, accorsero comecuccioli fedeli in attesa dei suoi ordini.Brotons mi rivolse uno sguardoinquisitorio.
«Cosa cerchiamo?»
«1904. Morte di un avvocato di nomeDiego Marlasca. Membro eminen-tedella buona società barcellonese, sociofondatore dello studio Valera, Marlasca
e Sentís.»
«Mese?»
«Novembre.»
A un cenno di Brotons, i due assistentipartirono alla ricerca delle copie delmese di novembre del 1904. Aquell'epoca, la morte era tanto presentenel colore dei giorni che la maggioranzadei giornali aprivano ancora la primapagina con grandi necrologi. C'era dasupporre che un personaggio dellastatura di Marlasca avesse dato originea più di un articolo sulla stampacittadina e che il suo necrologio fossestato materia da prima pagina. Gliassistenti tornarono con parecchi volumi
e li depositarono su una grandescrivania. Ci dividemmo i compiti einsieme trovammo il necrologio di donDiego Marlasca in prima pagina, comeavevo immaginato. L'edizione era del 23novembre 1904.
« Habemus cadavere» annunciòBrotons, lo scopritore.
C'erano quattro necrologi dedicati aMarlasca. Uno della sua famiglia, unodello studio, uno dell'ordine degliavvocati di Barcellona e l'ultimodell'associazione culturale dell'AteneoBarcelonés.
«È il bello dell'essere ricchi. Si muorecinque o sei volte» osservò don Basilio.
I necrologi in sé non erano granchéinteressanti. Suppliche per l'animaimmortale del defunto, indicazioni sulfatto che il funerale sarebbe statoriservato agli intimi, grandiosi soffietti aun grande cittadino, erudito e membroinsostituibile della società barcelloneseeccetera eccetera.
«Quello che interessa a lei deve esserenelle edizioni di uno o due giorni primao dopo» suggerì Brotons.
Sfogliammo i quotidiani della settimanadella morte dell'avvocato e trovammouna serie di notizie riguardantiMarlasca. La prima annunciava che ilfamoso erudito era deceduto in un
incidente. Don Basilio la lesse a vocealta.
«Questa l'ha scritta un orango»sentenziò. «Tre paragrafi ridondanti chenon dicono niente e solo alla fine sispiega che la morte è stata accidentale,ma senza dire di che tipo di incidente siè trattato.»
«Qui c'è qualcosa di interessante» disseBrotons.
Un articolo del giorno successivospiegava che la polizia stava indagandosulle circostanze dell'incidente perstabilire con precisione l'accaduto.
La cosa più interessante era
l'affermazione che nel rapporto delmedico legale sulla causa del decesso sidiceva che Marlasca era mortoannegato.
«Annegato?» interruppe don Basilio.«Come? Dove?»
«Non lo chiarisce. Probabilmente hannodovuto tagliare il pezzo per in-serirequesta urgente ed estesa apologia dellasardana che apre a tre colonne con iltitolo "Al suono della tenora: vigore earmonia"» suggerì Brotons.
«Dice chi era il responsabile delleindagini?» domandai.
«Un certo Salvador. Ricardo Salvador»
disse Brotons.
Esaminammo il resto delle notizierelative alla morte di Marlasca, ma nonc'era nulla di interessante. I testi siriversavano gli uni negli altri, ripetendouna cantilena che suonava troppo similealla linea ufficiale fornita dallo studio diValera e compagni.
«Puzza di insabbiamento» suggerìBrotons.
Sospirai, scoraggiato. Avevo sperato ditrovare qualcosa di più che sempliciricordi mielosi e notizie vuote che nonchiarivano nulla degli eventi.
«Lei non aveva un buon contatto alla
polizia?» chiese don Basilio.
«Come si chiamava?»
«Víctor Grandes» disse Brotons.
«Magari potrebbe metterla in contattocon quel Salvador.»
Tossicchiai e i due omoni mi guardaronocon le ciglia aggrottate.
«Per ragioni che non c'entrano conquesta faccenda, o che forse c'entranotroppo, preferirei non coinvolgerel'ispettore Grandes» spiegai.
Brotons e don Basilio si scambiaronoun'occhiata.
«D'accordo. Qualche altro nome dacancellare dalla lista?»
«Marcos e Castelo.»
«Vedo che non ha perso il talento difarsi amici dovunque vada» osservò donBasilio.
Brotons si sfregò il mento.
«Non ci agitiamo. Credo di potertrovare qualche altra via di accesso chenon induca sospetti.»
«Se mi trova Salvador, le sacrificoquello che vuole, anche un maiale.»
«Con questo fatto della gotta, mi hanno
tolto gli insaccati, ma non direi di no aun buon sigaro» disse Brotons.
«Due» aggiunse don Basilio.
Mentre correvo da un tabaccaio di calleTallers in cerca dei due esemplari diCohiba più prelibati e cari del negozio,Brotons fece un paio di discretetelefonate alla polizia e confermò cheSalvador aveva lasciato il corpo, perchécostretto, e aveva iniziato a lavorarecome guardaspalle per gli industriali ocome detective per diversi studi legalidella città. Quando tornai in redazioneper consegnare i sigari ai mieibenefattori, il capo dell'archivio miallungò un appunto con un indirizzo.
Ricardo Salvador
Calle de la Lleona, 21. Ultimo piano.
«Che il Signore vi ripaghi» dissi.
«E che lei possa vedere quel momento.»
29
La calle de la Lleona, più conosciuta dailocali come calle dels Tres Llits, dei TreLetti, in onore del celebre postriboloche ospitava, era un vicolo tenebrosoquasi quanto la sua reputazione. Partivadai portici all'ombra di plaza Real e sisnodava lungo una fenditura umida edestranea alla luce del sole tra vecchipalazzi ammucchiati gli uni sugli altri e
cuciti insieme da una perpetua ragnateladi corde di panni stesi. Dalle suefacciate decrepite si staccavano pezzi diintonaco ocra, e le lastre di pietra chericoprivano il suolo erano stateinzuppate di sangue durante gli anni delpisto-lerismo. Più di una volta l'avevoutilizzata come scenario delle mie storiedella Città dei maledetti e perfinoadesso, deserta e dimenticata, per mecontinuava ad avere l'odore degliintrighi e della polvere da sparo. Allavista di quel cupo scenario, tuttolasciava credere che il pensionamentoforzato del commissario Salvador dalcorpo di polizia non fosse statogeneroso.
Il numero 21 era un modesto immobileincassato fra due palazzi che lostringevano come una tenaglia. Ilportone, aperto, non era che un pozzod'ombra da cui partiva una scala stretta eripida che saliva a spirale. Il pavimentoera pieno di pozzanghere, e un liquidoscuro e viscoso sgocciava dagliinterstizi fra le mattonelle. Salii le scalealla meglio, senza mollare la ringhierama senza fidarmene. C'era solo unaporta a ogni pianerottolo e, a giudicaredall'aspetto della proprietà, immaginaiche nessuno di quegli ap-partamentisuperasse i quaranta metri quadri. Unpiccolo lucernario coro-nava la trombadelle scale e bagnava di un tenuechiarore i piani superiori.
La porta dell'ultimo piano era in fondo aun piccolo corridoio. Mi sorpresetrovarla aperta. Bussai con le nocche,ma non ebbi risposta. La porta dava suuna stanzetta in cui si vedevano unapoltrona, un tavolo e una scaffala-turacon libri e scatole di latta. Una specie dicucina e di lavanderia occupavano lacamera attigua. L'unica benedizione diquella cella era un terrazzo sul lastrico.Anche la porta del terrazzo era aperta eda lì si insinuava una brezza fresca cheportava con sé l'odore di cibo e dibucato dei tetti della città vecchia.
«Qualcuno in casa?» chiamai.
Non avendo risposta, raggiunsi la porta
del terrazzo e mi affacciai fuori.
La giungla di tetti, torrette, serbatoid'acqua, parafulmini e comignoli siestendeva in ogni direzione. Non avevofatto nemmeno un passo quando sentii ilferro freddo sulla nuca e lo schioccometallico di un revolver a cui venivaarmato il percussore. Non mi venne inmente altro che alzare le mani e cercaredi non muovere nemmeno unsopracciglio.
«Mi chiamo David Martín. Alla poliziami hanno dato il suo indirizzo.
Vorrei parlare con lei di un caso di cuisi è occupato quando era in servizio.»
«Lei entra sempre nelle case della gentesenza bussare, signor David Martín?»
«La porta era aperta. Ho chiamato, maforse non mi ha sentito. Posso abbassarele mani?»
«Non le ho detto di alzarle. Qualecaso?»
«La morte di Diego Marlasca. Sonol'inquilino di quella che è stata la suaultima residenza. La casa della torre incalle Flassaders.»
La voce tacque. La pressione delrevolver era sempre lì, costante.
«Signor Salvador?» domandai.
«Sto pensando se non sarebbe megliofarle saltare subito le cervella.»
«Non vuole prima sentire la miastoria?»
L'uomo allentò la pressione delrevolver. Sentii che il percussore venivarilasciato e mi girai lentamente. RicardoSalvador aveva un aspetto imponente ecupo, i capelli grigi e gli occhi azzurrochiaro penetranti come aghi. Calcolaiche doveva essere sulla cinquantina, masarebbe stata dura trovare uomini con lametà dei suoi anni che si azzardassero asbarrargli la strada. Deglutii. Salvadorabbassò il revolver e mi diede le spalle,tornando all'interno dell'appartamento.
«Mi scusi per l'accoglienza» mormorò.
Lo seguii fino alla piccola cucina e mifermai sulla soglia. Salvador lasciò lapistola sull'acquaio e accese uno deifornelli con carta e cartone. Tirò fuori unbarattolo di caffè e mi guardòinquisitorio.
«No, grazie.»
«È l'unica cosa buona che ho, l'avverto»disse.
«Allora le faccio compagnia.»
Salvador introdusse un paio di generosecucchiaiate di caffè macinato nellacaffettiera, la riempì con l'acqua di una
brocca e la mise sul fuoco.
«Chi le ha parlato di me?»
«Qualche giorno fa sono andato atrovare la signora Marlasca, la vedova.
È stata lei a parlarmene. Mi ha detto chelei era l'unico ad aver cercato discoprire la verità, e che questo fatto leera costato il posto.»
«È una maniera di descrivere le cose,immagino.»
Notai che la menzione della vedova gliaveva intorbidito lo sguardo e mi chiesicosa fosse accaduto fra loro in queigiorni di sventura.
«Come sta?» domandò. «La signoraMarlasca.»
«Credo che lei le manchi» azzardai.
Salvador annuì. La sua ferocia eracompletamente venuta meno.
«È da molto che non vado a trovarla.»
«La signora crede che lei la incolpi diquello che le è successo. Penso che lefarebbe piacere rivederla, anche se èpassato tanto tempo.»
«Forse ha ragione. Forse dovrei andarea trovarla...»
«Può parlarmi di quello che accadde?»
Salvador recuperò l'aspetto severo eannuì.
«Cosa vuole sapere?»
«La vedova Marlasca mi ha spiegato chelei non accettò mai la versione secondocui suo marito si sarebbe tolto la vita eche aveva dei sospetti.»
«Più che sospetti. Qualcuno le haraccontato come morì Marlasca?»
«So solo che parlarono di un incidente.»
«Morì annegato. O almeno, così dicevail rapporto finale della polizia.»
«Come annegò?»
«C'è solo un modo di annegare, ma citornerò dopo. La cosa curiosa è dove.»
«In mare?»
Salvador sorrise. Era un sorriso nero eamaro come il caffè che iniziava asalire. Salvador lo annusò.
«È sicuro di voler sentire questastoria?»
«Non sono mai stato più sicuro diqualcosa in vita mia.»
Mi tese una tazza e mi guardò dall'alto inbasso, analizzandomi.
«Presumo che lei sia già stato a trovare
quel figlio di puttana di Valera.»
«Se si riferisce al socio di Marlasca, èmorto. Ho parlato con il figlio.»
«Figlio di puttana pure lui, solo conmeno fegato. Non so cosa le abbiaraccontato, ma di sicuro non le ha dettoche fra tutti e due riuscirono a farmiespellere dal corpo e a trasformarmi inun paria a cui nessuno faceva nemmenol'elemosina.»
«Temo che si sia dimenticato diincluderlo nella sua versione dei fatti»
ammisi.
«Non mi sorprende.»
«Mi stava raccontando come annegòMarlasca.»
«È lì che le cose si fanno interessanti»disse Salvador. «Sapeva che il signorMarlasca, oltre che avvocato, erudito escrittore, in gioventù era stato due voltecampione della traversata del porto anuoto organizzata durante le festenatalizie dal Club Natación Barcelona?»
«Come può annegare un campione dinuoto?»
«Il problema è dove. Il cadavere delsignor Marlasca fu trovato nella cisternasul tetto del Depósito de las Aguas delParque de la Ciudadela. Conosce ilposto?»
Deglutii e annuii. Era lì che avevoincontrato Corelli la prima volta.
«Se lo conosce saprà che, quando lacisterna è piena, ha solo un metro diprofondità ed è, essenzialmente, unatavola. Il giorno in cui l'avvocato futrovato morto, era mezza vuota e illivello dell'acqua non arrivava asessanta centimetri.»
«Un campione di nuoto non annega insessanta centimetri» osservai.
«Quello che ho detto anch'io.»
«C'erano altre opinioni?»
Salvador sorrise amaro.
«Per cominciare, è discutibile che siaannegato. Il medico legale che praticòl'autopsia al cadavere trovò un po'd'acqua nei polmoni, ma secondo il suoreferto la morte era dovuta a un arrestocardiaco.»
«Non capisco.»
«Quando Marlasca cadde nella cisterna,o quando qualcuno ce lo spinse, era infiamme. Il cadavere presentava ustionidi terzo grado sul torso, sulle braccia esul volto. Secondo il medico legale, ilcorpo poteva aver bruciato per quasi unminuto prima di entrare in contatto conl'acqua. Resti trovati sui vestitidell'avvocato rivelavano la presenza di
qualche tipo di solvente nei tessuti.Marlasca fu bruciato vivo.»
Ci misi qualche secondo a digerire tutto.
«Perché qualcuno avrebbe fatto una cosadel genere?»
«Regolamento di conti? Semplicecrudeltà? Scelga lei. La mia opinione èche qualcuno voleva ritardarel'identificazione del corpo di Marlascaper guadagnare tempo e confondere lapolizia.»
«Chi?»
«Jaco Corbera.»
«L'agente di Irene Sabino.»
«Che sparì lo stesso giorno della mortedi Marlasca con l'importo di un contocorrente personale che l'avvocato avevapresso il Banco Hispano Colonial e dicui sua moglie non sapeva nulla.»
«Centomila franchi francesi» dissi.
Salvador mi guardò, intrigato.
«E lei come fa a saperlo?»
«Non ha importanza. Cosa ci facevaMarlasca sul tetto del Depósito de lasAguas? Non è esattamente un luogo dipassaggio.»
«Questo è un altro punto confuso.Trovammo un'agenda nel suo studio conl'annotazione che aveva lì unappuntamento alle cinque. O cosìpareva.
Sull'agenda figuravano solo un'ora, unluogo e un'iniziale. Una "C".Probabilmente, Corbera.»
«Cosa crede che sia accaduto, allora?»domandai.
«Quello che credo, e che l'evidenzasuggerisce, è che Jaco ingannò IreneSabino perché manipolasse Marlasca.Saprà già che l'avvocato era osses-sionato da quelle fregature delle sedutespiritiche, specialmente dopo la morte
del figlio. Jaco aveva un socio, DamiánRoures, introdotto in questi ambienti. Uncommediante fatto e finito. Insieme, econ l'aiuto di Irene Sabino,infinocchiarono Marlasca,promettendogli un contatto con ilbambino nel mondo degli spiriti.Marlasca era un uomo disperato edisposto a credere a qualsiasi cosa.Quel trio di vermi aveva organizzatol'affare perfetto finché Jaco non diventòpiù avido del dovuto. C'è chi pensa chela Sabino non agisse in malafede, chefosse davvero innamorata di Marlasca ecredesse a tutto proprio come lui. Io nonne sono convinto, ma agli effetti diquanto accadde è irrilevante. Jaco vennea sapere che Marlasca aveva quei fondi
in banca e decise di toglierlo di mezzo esparire con il denaro, lasciando una sciadi confusione. L'appuntamentosull'agenda poteva essere una pista falsalasciata dalla Sabino o da Jaco. Nonc'era nessuna prova che l'avesseannotato Marlasca.»
«E da dove provenivano i centomilafranchi che l'avvocato aveva al BancoHispano Colonial?»
«Lo stesso Marlasca li aveva depositatiin contanti un anno prima. Non ho laminima idea di dove avesse preso unacifra del genere. Quello che so è chequanto ne restava fu prelevato, incontanti, la mattina del giorno in cui
morì. Gli avvocati dissero poi che ildenaro era stato trasferito a una speciedi fondo tutelato e che non erascomparso: Marlasca avevasemplicemente deciso di riorganizzarele sue finanze. Ma a me risulta difficilecredere che uno riorganizzi le suefinanze e sposti quasi centomila franchial mattino per poi essere bruciato vivoal pomeriggio. Non credo che queldenaro sia finito in qualche fondomisterioso. Oggi come oggi nulla miconvince che non sia finito nelle mani diJaco Corbera e Irene Sabino. Almenoall'inizio, perché dubito che lei poiabbia mai visto un centesimo. Jaco sparìcon i soldi. Per sempre.»
«Cosa ne è stato di lei, allora?»
«Questo è un altro degli aspetti che mifanno pensare che Jaco abbia in-gannatoRoures e Irene Sabino. Poco dopo lamorte di Marlasca, Roures lasciò gliaffari d'oltretomba e aprì un negozio diarticoli di magia in calle Princesa. Cheio sappia, è ancora lì. Irene Sabinolavorò ancora per un paio di anni incabaret e locali con ingaggi sempre piùbassi. L'ultima cosa che seppi di lei fuche si prostituiva nel Raval e che vivevain miseria. Ovvia-
mente non ebbe nemmeno uno di queifranchi. E neppure Roures.»
«E Jaco?»
«La cosa più probabile è che abbialasciato il paese sotto falso nome e chesi trovi da qualche parte vivendocomodamente di rendita.»
In realtà, tutta quella storia, invece dichiarirmi qualcosa, mi spalancava altriinterrogativi. Salvador dovetteinterpretare il mio sguardo sconfortato emi rivolse un sorriso dicommiserazione.
«Valera e i suoi amici in Comuneriuscirono a fare in modo che la stampapubblicasse la versione dell'incidente.Risolse la questione con un funerale dilusso per non intorbidare le acque degliaffari dello studio, che in buona parte
erano gli affari del Comune e dellaProvincia, e sorvolando sullo stranocomportamento del signor Marlascanegli ultimi dodici mesi di vita, daquando aveva abbandonato la famiglia ei soci decidendo di acquistare una casain rovina in una zona della città in cuinon aveva messo il suo piede bencalzato in tutta la vita per dedicarsi,secondo il suo ex socio, a scrivere.»
«Valera disse cosa voleva scrivereMarlasca?»
«Un libro di poesia o qualcosa delgenere.»
«E lei gli credette?»
«Ho visto cose ben strane nel miolavoro, amico mio, ma avvocati pieni disoldi che mollano tutto per ritirarsi ascrivere sonetti non fanno parte delrepertorio.»
«E allora?»
«Allora sarebbe stato più ragionevoledimenticarmi della questione e farequello che mi veniva detto.»
«Ma non fu così.»
«No. E non perché sia un eroe o unimbecille. Lo feci perché ogni volta chevedevo quella povera donna, la vedovaMarlasca, mi si rivoltava lo stomaco enon riuscivo più a guardarmi nello
specchio senza fare quello che sisuppone fossi pagato per fare.»
Indicò l'ambiente misero e freddo chegli faceva da casa e rise.
«Mi creda, se l'avessi saputo avreipreferito essere un vigliacco e nonmettermi in luce. Non posso dire chealla polizia non mi avessero avvertito.Morto e sepolto l'avvocato, bisognavavoltare pagina e dedicare i nostri sforzialle indagini su anarchici morti di famee maestri di scuola dalle idee sospette.»
«Lei dice sepolto... Dov'è la tomba diDiego Marlasca?»
«Credo nella cappella di famiglia del
cimitero di Sant Gervasi, non mol-
to lontano dalla casa in cui vive lavedova. Posso chiederle il motivo delsuo interesse in questa vicenda? E nonmi dica che le si è risvegliata lacuriosità solo perché abita nella casadella torre.»
«È difficile da spiegare.»
«Se vuole un consiglio da amico, guardime e si curi. Lasci perdere.»
«Mi piacerebbe. Il problema è che noncredo che questa storia lascerà perdereme.»
Salvador mi guardò a lungo e annuì.
Prese un foglio e annotò un numero.
«Questo è il telefono dei vicini di sotto.Sono brave persone e gli unici ad averloin tutta la scala. Può trovarmi lì olasciare un messaggio. Chieda diEmilio. Se ha bisogno di aiuto, non esitia chiamarmi. E stia attento. Jaco èsparito di scena da molti anni, ma c'èancora gente a cui non interessasmuovere le acque. Centomila franchisono una bella cifra.»
Accettai il numero e lo misi via.
«La ringrazio.»
«Di nulla. In fin dei conti, ormai cosapossono farmi?»
«Non avrebbe una foto di DiegoMarlasca? Non ne ho trovata nemmenouna in tutta la casa.»
«Non so... Credo che qualcuna dovreiaverla. Mi faccia guardare.»
Salvador si diresse verso una scrivanianell'angolo della stanza e tirò fuori unascatola di latta piena di carte.
«Conservo ancora documenti del caso...Come vede, non imparo nemmeno congli anni... Ecco, guardi. Questa foto mela diede la vedova.»
Mi tese un vecchio ritratto da studio incui compariva un uomo alto e dibell'aspetto di quaranta e passa anni che
sorrideva alla macchina su uno sfondodi velluto. Mi persi in quello sguardolimpido, chiedendomi come fossepossibile che dietro vi si nascondesse ilmondo tenebroso che avevo incontratonelle pagine di Lux Aeterna.
«Posso tenerla?»
Salvador esitò.
«Credo di sì. Ma non la perda.»
«Le prometto che gliela restituirò.»
«Mi prometta di stare attento e sarò piùtranquillo. E che se non lo farà e simetterà nei guai mi chiamerà.»
Gli diedi la mano e me la strinse.
«Promesso.»
30
Cominciava a tramontare il sole quandolasciai Ricardo Salvador nella suafredda soffitta e tornai nella plaza Realinondata da una luce polverosa chedipingeva di rosso le sagome deipassanti. Mi misi a camminare e finiiper rifugiarmi nell'unico posto di tutta lacittà in cui mi ero sempre sentitoprotetto e ben accolto. Quando arrivai incalle Santa Ana, la libreria Sempere eFigli stava per chiudere. Il crepuscolostrisciava sulla città e una breccia blu eporpora si era aperta in cielo. Mi fermai
davanti alla vetrina e vidi che Semperefiglio aveva appena finito di servire uncliente che stava per andarsene. Quandomi vide, sorrise e mi salutò con quellatimidezza che sembrava più che altropudore.
«Proprio a lei stavo pensando, Martín.Tutto bene?»
«Meglio non si potrebbe.»
«Glielo si legge in faccia. Su, entri,facciamo un po' di caffè.»
Mi si fece incontro e mi cedette il passo.Entrai nella libreria e aspirai quelprofumo di carta e magia cheinspiegabilmente a nessuno era ancora
venuto in mente di imbottigliare.Sempere figlio mi fece cenno di seguirlonel retrobottega, dove si mise apreparare una caffettiera.
«E suo padre? Come sta? L'ho visto unpo' moscio l'altro giorno.»
Sempere figlio annuì, come se fossegrato per la domanda. Mi resi conto cheprobabilmente non aveva nessuno concui parlarne.
«Ha visto tempi migliori, è vero. Ilmedico dice che deve stare attentoall'angina, ma lui insiste a lavorare piùdi prima. A volte devo arrabbiarmi conlui, ma sembra convinto che se lascia lalibreria nelle mie mani andrà tutto a
catafascio. Stamattina, quando mi sonoalzato, gli ho detto di farmi il favore direstare a letto e di non scendere alavorare per tutto il giorno.
Ci crede? Tre minuti dopo me lo trovoin sala da pranzo che si mette lescarpe.»
«È un uomo dalle idee salde» convenni.
«È testardo come un mulo» replicò.«Meno male che adesso abbiamo un po'di aiuto, se no...»
Sfoderai la mia espressione di sorpresae innocenza, così sollecita e spontanea.
«La ragazza» chiarì Sempere figlio.
«Isabella, la sua assistente. Per questostavo pensando a lei. Spero che non ledispiaccia se passa qualche ora qui. Adire il vero, così come stanno le cose, ilsuo aiuto è prezioso, ma se lei ècontrario...»
Repressi un sorriso per il modo in cui siera sdilinquito con le due elle diIsabella.
«Be', se è una cosa temporanea...Isabella è davvero una brava ragazza.
Intelligente e lavoratrice» dissi.«Assolutamente di fiducia. Andiamomolto d'accordo.»
«Be', lei l'accusa di essere un despota.»
«Questo dice?»
«In realtà, ha un soprannome per lei:mister Hyde.»
«Che angelo. Non ci faccia caso. Sacome sono le donne.»
«Sì, lo so» replicò Sempere figlio, in untono che faceva capire che sapeva moltecose, ma di quella non aveva la minimaidea.
«Isabella le dice questo di me, ma noncreda che a me non dica nulla di lei»azzardai.
Vidi che qualcosa gli si agitava in volto.Lasciai che le mie parole corro-dessero
lentamente gli strati della sua armatura.Mi tese una tazza di caffè con un sorrisopremuroso e riprese l'argomento con unascusa che non avrebbe superato il filtrodi un'operetta da quattro soldi.
«Chissà cosa dirà di me» lasciò cadere.
Lo tenni a macerare nell'incertezzaqualche istante.
«Le piacerebbe saperlo?» chiesicasualmente, nascondendo il sorrisodietro la tazza.
Sempere figlio si strinse nelle spalle.
«Dice che lei è un uomo buono egeneroso, che la gente non la capisce
perché è un po' timido e non vede quelloche c'è dietro, cito testualmente, unaspetto da attore cinematografico e unapersonalità affascinante.»
Sempere figlio deglutì e mi guardò,attonito.
«Non le dirò bugie, Sempere, amicomio. Guardi, in realtà sono contento cheabbia tirato fuori l'argomento perché adire il vero sono giorni che volevoparlarne con lei e non sapevo comefare.»
«Parlare di cosa?»
Abbassai la voce e lo fissai negli occhi.
«A quattr'occhi, le dirò che Isabellavuole lavorare qui perché l'ammira etemo sia segretamente innamorata dilei.»
Sempere mi guardava al limite dellosconcerto.
«Ma un amore puro, eh! Attenzione.Spirituale. Come un'eroina di Dickens,per capirci. Niente frivolezze nébambinate. Isabella, anche se è giovane,è una donna. Lo avrà sicuramentenotato...»
«Ora che me lo dice...»
«E non parlo solo della sua, se mipermette la licenza, squisitamente
soffice cornice, bensì del quadro dibontà e bellezza interiore che portadentro di sé, in attesa del momentoopportuno per emergere e fare di unfortunato l'uomo più felice del mondo.»
Sempere non sapeva dove nascondersi.
«E inoltre ha dei talenti nascosti. Parlavarie lingue. Suona il piano come gliangeli. Ha una testa per i numeri chenemmeno Isaac Newton. E oltre-tuttocucina da schianto. Mi guardi. Sonoingrassato diversi chili da quandolavora per me. Delizie che neanche laTour d'Argent... Non mi dica che non sen'era accorto?»
«Be', non ha detto di saper cucinare...»
«Parlo del colpo di fulmine.»
«A dire il vero...»
«Sa cos'è? La ragazza, in fondo, anchese si dà quelle arie da belvetta dadomare, è mansueta e timida fino aestremi patologici. Colpa dellemonache, che le rimbambiscono contutte quelle storie sull'inferno e quellelezioni di taglio e cucito. Viva la scuolalaica.»
«Be', io avrei giurato che mi ritenessepoco meno che stupido» assicuròSempere.
«Eccola. La prova inconfutabile.Sempere, amico mio, quando una donna
tratta qualcuno da stupido significa chele si stanno aguzzando le gona-di.»
«Ne è sicuro?»
«Più che dell'affidabilità del Banco diSpagna. Mi dia retta, di queste cose unpo' ne capisco.»
«Così dice mio padre. E cosa devofare?»
«Be', dipende. A lei piace la ragazza?»
«Se mi piace? Non so. Come si fa asapere se...?»
«È semplicissimo. Quando la guarda dinascosto le viene voglia come di
morderla?»
«Morderla?»
«Sul sedere, per esempio.»
«Signor Martín...»
«Non mi faccia il pudico, siamo tragentiluomini e si sa che noi maschisiamo l'anello perduto tra il pirata e ilmaiale. Le piace o no?»
«Be', Isabella è una ragazza aggraziata.»
«Che altro?»
«Intelligente. Simpatica. Lavoratrice.»
«Vada avanti.»
«E una buona cristiana, credo. Non cheio sia molto praticante, però...»
«Non me ne parli. Isabella va più amessa di quanto si lavi i denti. Lemonache, gliel'ho detto.»
«Però di morderla, la verità, non mi eravenuto in mente.»
«Finché non gliel'ho suggerito io.»
«Devo dirle che mi sembra unamancanza di rispetto parlare così di lei,o di chiunque, e che dovrebbevergognarsi...» protestò Sempere figlio.
« Mea culpa» intonai alzando le mani insegno di resa. «Ma non importa, perchéognuno manifesta la propria devozione asuo modo. Io sono una creatura frivola esuperficiale, e di lì il mio punto di vistalupesco, ma lei, con quella aureagravitas, è un uomo dai sentimentimistici e profondi.
Quel che conta è che la ragazza l'adora eche il sentimento è reciproco.»
«Be'...»
«Niente be' né ma. Le cose come stanno,Sempere. Lei è un uomo rispettabile eresponsabile. Se fossi io... cosa glielodico a fare? Ma lei non è uomo chegiochi con i sentimenti nobili e puri di
una donna in fiore. Mi sbaglio?»
«Credo di no.»
«Allora è fatta.»
«Cosa?»
«Non è chiaro?»
«No.»
«È ora di farle la corte.»
«Prego?»
«Corteggiare o, in linguaggio scientifico,fare il filo. Vede, Sempere, per qualchestrano motivo, secoli di presunta civiltà
ci hanno condotto in una situazione incui non ci si può buttare addosso alledonne agli angoli di strada, o proporreloro il matrimonio, così di colpo. Primabisogna fare loro la corte.»
«Matrimonio? È impazzito?»
«Quello che voglio dirle è che magari, equesta è una sua idea anche se non se n'èancora reso conto, oggi, domani odopodomani, quando le sarà passata lafifa e non sembrerà che sbavi, alla finedell'orario di Isabella in libreria, lei lainvita a prendere qualcosa in un postomagico e così vi rendete conto unabuona volta di essere fatti l'uno perl'altra. Facciamo a Els Quatre Gats,
dove sono un po' spilorci e tengono laluce fioca per rispar-miare corrente, equesto aiuta sempre in casi simili. Per laragazza ordina un dolce di ricotta conuna bella cucchiaiata di miele, chestimola gli appe-titi, e poi, come senzavolere, le rifila un paio di bicchieri diquel moscatel-lo che dà alla testa perforza e, mentre le mette la mano sulginocchio, me la rimbambisce conquello scilinguagnolo che tiene tanto bennascosto, mascalzone.»
«Ma se non so niente di lei, né di quelloche le interessa né...»
«Le interessano le stesse cose che a lei.I libri, la letteratura, l'odore di questi
tesori che ha qui e la promessa dipassione e avventura dei romanzipopolari. Le interessa sconfiggere lasolitudine e non perdere tempo a capireche in questo schifo di mondo nientevale un centesimo se non abbiamoqualcuno con cui condividerlo. Già sal'essenziale. Il resto lo impara e se logode strada facendo.»
Sempere restò pensieroso, alternandosguardi alla sua tazza di caffè, intatta, eal sottoscritto, che manteneva di riffa odi raffa il suo sorriso da venditore dititoli di borsa.
«Non so se ringraziarla o denunciarlaalla polizia» disse alla fine.
In quel momento si sentirono i passipesanti di Sempere padre in libreria.Pochi secondi dopo si affacciava nelretrobottega e ci guardava aggrottando leciglia.
«E allora? Nessuno che bada al negozioe qui in due a fare chiacchiere come sefosse la festa del patrono? E se entraqualche cliente? O uno svergognato chesi porta via tutto?»
Sempere figlio sospirò, alzando gliocchi al cielo.
«Non abbia paura, signor Sempere, ilibri sono l'unica cosa al mondo che nonsi ruba» dissi facendogli l'occhiolino.
Un sorriso complice gli illuminò ilvolto. Sempere figlio ne approfittò persfuggire alle mie grinfie e svignarsela inlibreria. Suo padre si sedette accanto ame e annusò la tazza di caffè lasciataintatta dal figlio.
«Cosa dice il medico della caffeina peril cuore?» chiesi.
«Quello non si trova le chiappenemmeno con un manuale di anatomia.
Cosa vuole che ne sappia del cuore?»
«Più di lei, sicuro» replicai,togliendogli la tazza dalle mani.
«Ma se sono un toro, Martín.»
«Un mulo, ecco cos'è. Mi faccia ilfavore di rientrare in casa e di mettersi aletto.»
«A letto vale la pena di stare soltantoquando si è giovani e in compagnia.»
«Se vuole compagnia, gliela cerco, perònon credo che ci troviamo nellacongiuntura cardiaca adeguata.»
«Martín, alla mia età l'erotismo si riducead assaporare un crème caramel e aguardare il collo alle vedove. Apreoccuparmi è l'erede. Qualche pro-gresso su questo terreno?»
«Siamo in fase di concimazione esemina. Bisogna vedere se il clima ci
aiuta e avremo qualcosa da raccogliere.In due o tre giorni posso farle unaprevisione al rialzo con il sessanta osettanta per cento di affidabilità.»
Sempere sorrise, compiaciuto.
«Colpo da maestro, quello di mandarmiIsabella come commessa» disse.
«Ma non la vede un po' troppo giovaneper mio figlio?»
«Quello che vedo un po' immaturo è lui,se devo essere sincero. O si sveglia oIsabella se lo mangia crudo in cinqueminuti. Meno male che è di buoncarattere, se no...»
«Come posso ringraziarla?»
«Rientrando in casa e mettendosi a letto.Se ha bisogno di compagnia piccante, siporti Fortunata e Jacinta. »
«Ha ragione. Don Benito Pérez-Galdósnon tradisce mai.»
«Neanche volendo. Su, in branda.»
Sempere si alzò. Gli costava muoversi erespirava a fatica, con un soffio raucoche faceva drizzare i capelli in testa. Lopresi per il braccio per aiutarlo e miaccorsi che la sua pelle era fredda.
«Non si spaventi, Martín. È il miometabolismo, un po' lento.»
«Oggi mi sembra come quello di Guerrae pace. »
«Un pisolino e ritorno come nuovo.»
Decisi di accompagnarlo finoall'appartamento in cui abitavano padree figlio, proprio sopra la libreria, e diassicurarmi che si infilasse sotto lecoperte. Ci mettemmo un quarto d'ora afare le scale. Lungo il cammino in-contrammo uno dei vicini, don Anacleto,un affabile professore che dava lezionidi lingua e letteratura dai gesuiti di Caspe stava ritornando a casa.
«Come va la vita oggi, Sempere, amicomio?»
«In salita, don Anacleto.»
Con l'aiuto del professore riuscii adarrivare al primo piano con Semperepraticamente appeso al collo.
«Con il vostro permesso, vado ariposarmi dopo una lunga giornata dibattaglia con quel branco di primati cheho come alunni» annunciò il professore.«Ve lo dico io, questo paese sidisintegrerà nello spazio di unagenerazione. Si scanneranno gli uni congli altri come topi.»
Sempere fece un'espressione come adirmi di non fare troppo caso a donAnacleto.
«Brav'uomo» mormorò «ma affoga in unbicchier d'acqua.»
Entrando in casa, mi assalì il ricordo diquella lontana mattina in cui ero arrivatolì insanguinato, con una copia di Grandisperanze tra le mani, e Sempere miaveva portato in braccio fino in casa emi aveva offerto una tazza di cioccolatacalda, che avevo bevuto mentreaspettavamo il dottore e lui misussurrava parole tranquillizzanti e mipuliva il sangue con un asciugamanotiepido e una delicatezza che nessuno miaveva mai dimostrato prima. A queitempi, Sempere era un uomo forte che mipareva un gigante in tutti i sensi e senzail quale non credo sarei sopravvissuto a
quegli anni di scarsa fortuna. Poco onulla restava di quella forza mentre lososte-nevo tra le braccia per aiutarlo ainfilarsi a letto e gli mettevo addosso unpaio di coperte. Mi sedetti accanto a luie gli presi la mano senza sapere cosadire.
«Senta, se cominciamo tutti e due apiangere come Maddalene, meglio chese ne vada» disse lui.
«Si riguardi, ha capito?»
«Fra la bambagia, non abbia paura.»
Annuii e mi diressi all'uscita.
«Martín?»
Mi voltai sulla soglia. Sempere mifissava con la stessa preoccupazione concui mi aveva guardato quella mattina incui avevo perso qualche dente e buonaparte dell'innocenza. Me ne andai primache mi domandasse cosa mi stavasuccedendo.
31
Una delle prime risorse dello scrittoreprofessionista che Isabella avevaimparato da me era l'arte e la pratica diprocrastinare. Ogni veterano delmestiere sa che qualunque occupazione,dal temperare la matita al catalo-gare leragnatele, ha la priorità al momento disedersi alla scrivania per spremersi le
meningi. Isabella aveva assorbito perosmosi questa lezione fondamentale equando arrivai a casa, invece di trovarlaallo scrittoio, la sorpresi in cucina adare gli ultimi ritocchi a una cena cheaveva un profumo e un aspetto come sela sua elaborazione avesse richiestomolte ore.
«Festeggiamo qualcosa?» chiesi.
«Con la faccia che ha, non credoproprio.»
«Cosa c'è di buono?»
«Anatra caramellata con pere al forno esalsa al cioccolato. Ho trovato la ricettain uno dei suoi libri di cucina.»
«Io non ho libri di cucina.»
Isabella si alzò e prese un volumerilegato in pelle che depositò sul tavolo.Titolo: Le 101 migliori ricette dellacucina francese, di Michel Aragon.
«Questo lo crede lei. In seconda fila,sugli scaffali della biblioteca, ho trovatodi tutto, perfino un manuale di igienematrimoniale del dottor Pérez-Aguadocon illustrazioni molto esplicite e frasidel tipo "la femmina, per disegnodivino, non conosce desiderio carnale ela sua realizzazione spirituale esentimentale si sublima nell'esercizionaturale della maternità e dei lavoridomestici". Lì ci sono le miniere del re
Salomone.»
«E si può sapere cosa cercavi nellaseconda fila degli scaffali?»
«Ispirazione. E l'ho trovata.»
«Però di tipo culinario. Eravamo rimastiche avresti scritto tutti i giorni, con osenza ispirazione.»
«Mi sono arenata. E la colpa è sua,perché mi fa fare più lavori e micoinvolge nei suoi intrighi con quelsantarellino di Sempere figlio.»
«Ti sembra bello prenderti giocodell'uomo che è perdutamenteinnamorato di te?»
«Cosa?»
«Mi hai sentito. Sempere figlio mi haconfessato che gli hai rubato il sonno.Letteralmente. Non dorme, non mangia,non beve, non può nemmeno orinare, ilpoveretto, a furia di pensare a te tutto ilgiorno.»
«Lei delira.»
«A delirare è il povero Sempere.Avresti dovuto vederlo. Sono stato lì lìper sparargli un colpo e liberarlo daldolore e dalla miseria che lo ango-sciano.»
«Ma se non mi dà nemmeno retta»protestò Isabella.
«Perché non sa come aprire il suo cuoree trovare le parole per esprimere i suoisentimenti. Noi uomini siamo così.Brutali e primitivi.»
«Comunque ha saputo trovarle le paroleper sgridarmi, quando ho sbagliato asistemare la collana degli Episodinazionali. Bello scilinguagnolo.»
«Non è la stessa cosa. Un conto sono irapporti amministrativi e un altro illinguaggio della passione.»
«Stupidaggini.»
«Non c'è niente di stupido nell'amore,esimia assistente. Ma, cambiandoargomento, ceniamo o no?»
Isabella aveva imbandito una tavolaintonata con il banchetto che avevacucinato, mettendo in campo un arsenaledi piatti, posate e bicchieri che nonavevo mai visto.
«Non so come mai, avendo queste cosebellissime, non le usa. Teneva tutto inqualche cassa nella stanza accanto allalavanderia» disse Isabella.
«È proprio un uomo...»
Sollevai uno dei coltelli e lo osservaialla luce delle candele disposte daIsabella. Capii che si trattava delleposate personali di Diego Marlasca esentii che perdevo completamentel'appetito.
«Cosa c'è?» domandò Isabella.
Scossi la testa. La mia assistente miservì due piatti e rimase a guardarmi, inattesa. Provai il primo boccone esorrisi, annuendo.
«Buonissima» dissi.
«Un po' gommosa, credo. La ricettadiceva che bisognava arrostirla a fuocolento per non so quanto tempo, ma con lasua cucina il fuoco o è inesistente obrucia tutto, non c'è via di mezzo.»
«È buona» ripetei, mangiando senzaavere fame.
Isabella mi guardava di sottecchi.
Continuammo a cenare in silenzio, con iltintinnio di piatti e posate per unicacompagnia.
«Diceva sul serio a proposito diSempere figlio?»
Annuii senza alzare gli occhi dal piatto.
«E cos'altro le ha detto di me?»
«Che hai una bellezza classica, che seiintelligente, intensamente femminile,perché lui è così, un po' vezzoso, e chesente un legame spirituale tra di voi.»
Isabella mi infilzò con uno sguardoassassino.
«Giuri che non se lo sta inventando»disse.
Misi la mano destra sul libro di ricette esollevai la sinistra.
«Lo giuro sulle 101 migliori ricettedella cucina francese» dichiarai.
«Si giura con l'altra mano.»
Cambiai mano e ripetei l'operazione conespressione solenne. Isabella sospirò.
«E cosa devo fare?»
«Non lo so. Cosa fanno gli innamorati?Vanno a passeggio, a ballare...»
«Ma io non sono innamorata di quelsignore.»
Continuai a degustare l'anatracaramellata, incurante delle sue occhiateinsistenti. Dopo un po', Isabella diedeuna manata sul tavolo.
«Mi faccia il piacere di guardarmi. Lacolpa è tutta sua.»
Lasciai le posate con calma, mi puliicon il tovagliolo e la guardai.
«Cosa devo fare?» chiese di nuovo.
«Dipende. Ti piace Sempere o no?»
Una nube di dubbi le attraversò il viso.
«Non lo so. Per cominciare, è un po'vecchio per me.»
«Ha praticamente la mia età» osservai.«Al massimo, uno o due anni in più.Forse tre.»
«O quattro o cinque.»
Sospirai.
«È nel fiore della vita. Eravamo rimastiche ti piacevano un po' maturi.»
«Non si prenda gioco di me.»
«Isabella, non sono io che posso dirticosa devi fare...»
«Questa sì che è buona.»
«Lasciami finire. Voglio dire che questaè una cosa fra Sempere e te. Se michiedi un consiglio, ti direi di dargli unapossibilità. Niente di più. Se uno diquesti giorni decide di fare il primopasso e ti invita, diciamo, a prenderequalcosa, accetta. Magari cominciate aparlare e vi conoscete e finite perdiventare grandi amici, o magari no.Però credo che Sempere sia unbrav'uomo, il suo interesse per te ègenuino e oserei dire che, se ci pensi, infondo anche tu provi qualcosa per lui.»
«Lei è pieno di fissazioni.»
«Ma Sempere no. E credo che non
rispettare l'affetto e l'ammirazione cheprova per te sarebbe meschino. E tu nonlo sei.»
«Questo è un ricatto sentimentale.»
«No, è la vita.»
Isabella mi fulminò con lo sguardo. Lesorrisi.
«Almeno, mi faccia il piacere di finirela cena» ordinò.
Svuotai il piatto, lo ripulii con il pane emi lasciai sfuggire un sospiro disoddisfazione.
«Cosa c'è per dessert?»
Dopo cena, lasciai un'Isabellameditabonda nella sala di lettura amacerare i suoi dubbi e le sueinquietudini e salii allo studio dellatorre. Tirai fuori la foto di DiegoMarlasca che mi aveva prestatoSalvador e la misi ai piedi dellalampada. Subito dopo diedi uno sguardoalla piccola cittadella di bloc notes,appunti e fogli che avevo via viaaccumulato per il principale. Con il gelodelle posate di Diego Marlasca ancorasulle dita, non feci fatica a immaginarloseduto lì, a contemplare lo stessopanorama sui tetti della Ribera. Presi acaso una delle mie cartelle e iniziai aleggere. Riconoscevo le parole e le frasiperché le avevo scritte io, ma lo spirito
torbido che le nutriva mi era più lontanoche mai. Lasciai cadere il foglio a terrae alzai lo sguardo per trovare il mioriflesso sul vetro della finestra, unosconosciuto sulle tenebre azzurrate cheseppellivano la città. Capii che quellanotte non avrei potuto lavorare, che nonsarei stato in grado di imbastire un soloparagrafo per il principale. Spensi laluce della scrivania e rimasi sedutonella penombra, ascoltando il vento chegraffiava le finestre e immaginandoDiego Marlasca che precipitava infiamme nelle acque della cisterna,mentre le ultime bolle d'aria gliuscivano dalle labbra e il liquido gelidogli inondava i polmoni.
Mi svegliai all'alba dolorante eincastrato nella poltrona dello studio.Mi alzai e sentii scrocchiare due o treingranaggi della mia anatomia. Mitrascinai alla finestra e la spalancai. Itetti della città vecchia brillavano dibrina e un cielo porpora si stendevasopra Barcellona. Al suono dellecampane di Santa Maria del Mar, unanuvola di ali nere si alzò in volo da unapiccionaia. Un vento freddo e taglientemi portò l'odore dei moli e delle ceneridi carbone che uscivano dalle ciminieredel quartiere.
Scesi nell'appartamento e andai incucina a preparare il caffè. Diediun'occhiata alla credenza e restai
attonito. Da quando avevo in casaIsabella, la mia dispensa somigliava alnegozio di alimentari Quilmes sullaRambla de Catalunya. In mezzo allasfilata di manicaretti esotici importatidal negozio del padre di Isabella, trovaiuna scatola di latta di biscotti in-glesiricoperti di cioccolato e decisi diprovarli. Mezz'ora dopo, quando le veneiniziarono a pompare zucchero ecaffeina, il cervello si mise in moto edebbi la geniale idea di iniziare lagiornata complicandomi, se possibile,un po' di più la vita. Appena scoccatol'orario di apertura, avrei fatto una visitaal negozio di articoli di magia eprestidigitazione di calle Princesa.
«Cosa fa sveglio a quest'ora?»
La voce della mia coscienza, Isabella,mi osservava dalla soglia.
«Mangio biscotti.»
Isabella si sedette a tavola e si versòuna tazza di caffè. Aveva l'aria di chinon ha chiuso occhio.
«Mio padre dice che è la marcapreferita della regina madre.»
«Perciò è così bella.»
Prese un biscotto e lo mordicchiò conaria assente.
«Hai pensato a cosa fare? Con Sempere,intendo dire...»
Isabella mi lanciò un'occhiata velenosa.
«E lei cosa farà oggi? Niente di buono,sicuramente.»
«Un paio di commissioni.»
«Già.»
«Già, già? O già, avverbio di tempo?»
Isabella posò la tazza sul tavolo e miaffrontò con la sua espressione dainterrogatorio sommario.
«Perché non parla mai di quello che sta
combinando con quel tipo, il suoprincipale?»
«Fra le altre cose, per il tuo bene.»
«Per il mio bene. Certo. Che stupida. Aproposito, mi sono dimenticata di dirleche ieri è passato il suo amico,l'ispettore.»
«Grandes? Era solo?»
«No. Con un paio di sgherri grandi comearmadi e con la faccia da cani paciosi.»
L'idea di Marcos e Castelo alla miaporta mi fece venire un nodo allostomaco.
«E cosa voleva Grandes?»
«Non l'ha detto.»
«E allora cos'ha detto?»
«Mi ha chiesto chi ero.»
«E tu cos'hai risposto?»
«Che ero la sua amante.»
«Davvero spiritosa.»
«Be', uno dei ragazzoni si è divertitomolto.»
Isabella prese un altro biscotto e lodivorò in due morsi. Si accorse che la
stavo guardando di sottecchi e smisesubito di masticare.
«Cosa ho detto?» chiese, spruzzando unanuvola di briciole di biscotto.
32
Un dito di luce vaporosa scendeva dalmanto di nuvole e accendeva la pitturarossa della facciata del negozio diarticoli di magia di calle Princesa. Labottega si trovava dietro un paravento dilegno scolpito. Le vetrate della portalasciavano intravedere a stento icontorni di un interno cupo e rivestito datendaggi di velluto nero cheavvolgevano vetrine con maschere eaggeggi di gusto vittoriano, mazzi di
carte truccati e daghe con i contrap-pesi,libri di magia e boccette di vetro molatoche contenevano un arcoba-leno diliquidi con le etichette in latino eprobabilmente imbottigliati ad Albacete.Il campanello dell'entrata annunciò lamia presenza. In fondo c'era un banconedeserto. Attesi qualche secondo,esaminando la raccolta di curiosità delbazar. Stavo cercando il mio volto inuno specchio nel quale si rifletteva tuttoil negozio tranne me, quando scorsi conla coda dell'occhio una figura minuta chesi affacciava da dietro la tenda delretrobottega.
«Un trucco interessante, vero?» dissel'ometto dai capelli bianchi e dallo
sguardo penetrante.
Annuii.
«Come funziona?»
«Non lo so ancora. Mi è arrivato un paiodi giorni fa da un fabbricante di specchitruccati di Istanbul. L'autore la chiamainversione refrattaria.»
«Ci ricorda che niente è quello chesembra» notai.
«Eccetto la magia. In cosa posso esserleutile?»
«Parlo con il signor Damián Roures?»
L'ometto annuì lentamente, senza battereciglio. Notai che aveva le labbraatteggiate in una smorfia sorridente che,come il suo specchio, non era quello chesembrava. Lo sguardo era freddo eguardingo.
«Mi hanno raccomandato il suonegozio.»
«Posso chiedere chi è stato cosìgentile?»
«Ricardo Salvador.»
Il tentativo di sorriso affabile gli sicancellò dalla faccia.
«Non sapevo che fosse ancora vivo.
Non lo vedo da venticinque anni.»
«E Irene Sabino?»
Roures sospirò, scuotendo la testa.Aggirò il bancone e si avvicinò allaporta. Appese il cartello con la scritta"Chiuso" e diede due giri di chiave.
«Chi è lei?»
«Mi chiamo Martín. Sto cercando dichiarire le circostanze della morte delsignor Diego Marlasca, e so che lei loconosceva.»
«Che io sappia, sono state chiarite moltianni fa. Il signor Marlasca si suicidò.»
«Io avevo capito un'altra cosa.»
«Non so cosa le abbia raccontato quelpoliziotto. Il risentimento danneggia lamemoria, signor... Martín. Salvador hagià provato a suo tempo a vendere lastoria di un complotto di cui non avevanessuna prova. Tutti sapevano che stavascaldando il letto alla vedova Marlascae che voleva fare l'eroe della situazione.Come c'era da attendersi, i suoisuperiori lo misero in riga e loespulsero dal corpo.»
«Lui crede che ci fu un tentativo dinascondere la verità.»
Roures rise.
«La verità... Non mi faccia ridere.Quello che si cercò di coprire fu loscandalo. Lo studio di Valera eMarlasca aveva le mani in pasta in quasitutti gli affari di questa città. A nessunointeressava che venisse fuori una storiacome quella. Marlasca avevaabbandonato la sua posizione sociale, illavoro e la moglie per chiudersi inquella casa a fare Dio sa cosa. Chiunquecon un po' di sale in zucca potevaimmaginare che non sarebbe andata afinire bene.»
«Questo non impedì a lei e al suo socioJaco di mettere a frutto la pazzia diMarlasca promettendogli la possibilitàdi entrare in contatto con l'aldilà nelle
vostre sedute spiritiche...»
«Non gli ho mai promesso niente. Quellesedute erano un semplice divertimento.Lo sapevano tutti. Non cerchi discaricarmi addosso il morto, io nonfacevo altro che guadagnarmi la vitaonestamente.»
«E il suo socio Jaco?»
«Io rispondo di me. Quello che facevaJaco non era responsabilità mia.»
«Dunque qualcosa fece.»
«Cosa vuole che le dica? Che si portòvia i soldi che Salvador insisteva a direche erano su un conto segreto? Che
ammazzò Marlasca e ci ingannò tutti?»
«E non andò così?»
Roures mi guardò a lungo.
«Non lo so. Non l'ho più visto dalgiorno che morì Marlasca. Ho già dettoa Salvador e agli altri poliziotti quelloche sapevo. Non ho mai mentito.
Mai. Se Jaco ha fatto qualcosa, non l'homai saputo e non ne ho ricavato nulla.»
«Cosa mi dice di Irene Sabino?»
«Irene amava Marlasca. Non avrebbemai fatto niente per danneggiarlo.»
«Sa cosa ne è stato di lei? È ancoraviva?»
«Credo di sì. Mi hanno detto chelavorava in una lavanderia del Raval.
Irene era una brava donna. Troppobuona. È finita così. Lei credeva aquelle cose. Ci credeva col cuore.»
«E Marlasca? Cosa cercava in quelmondo?»
«Marlasca era impelagato in qualcosa,non mi chieda cosa. Qualcosa che né ioné Jaco gli avevamo venduto népotevamo vendergli. So quello che sentiidire una volta da Irene. A quanto pareva,Marlasca aveva incontrato qualcuno,
qualcuno che io non conoscevo, e micreda che conoscevo e conosco tuttinell'ambiente, che gli aveva promessoche se faceva qualcosa, non so cosa,avrebbe riscattato il figlio Ismael dalregno dei morti.»
«Irene disse chi era questo qualcuno?»
«Lei non l'aveva mai visto. Marlascanon glielo permetteva. Ma lei sapevache lui aveva paura.»
«Paura di cosa?»
Roures fece schioccare la lingua.
«Credeva che fosse maledetto.»
«Si spieghi.»
«Gliel'ho già detto. Era malato. Eraconvinto che qualcosa gli si fosseinsinuato dentro.»
«Qualcosa?»
«Uno spirito. Un parassita. Non lo so.Vede, in questo ambiente si conoscemolta gente che non ha esattamente latesta a posto. Gli capita una tragediapersonale, perdono un amante o unafortuna e precipitano in un buco nero. Ilcervello è l'organo più fragile del corpo.Il signor Marlasca era fuori di testa, echiunque ci parlasse per cinque minutipoteva rendersene conto. Perciò venneda me.»
«E lei gli disse quello che volevasentire.»
«No. Gli dissi la verità.»
«La sua verità?»
«L'unica che conosco. Mi sembrò chequell'uomo fosse seriamente squi-libratoe non volli approfittarmi di lui. Questecose non finiscono mai bene. In questaattività c'è un limite che uno nonattraversa se sa cosa gli conviene. Chiarriva in cerca di divertimento o di unpo' di emozioni e di consolazionedall'aldilà, viene servito e ci si fapagare per il lavoro prestato. Ma chiarriva già sul punto di perdere laragione viene rimandato a casa. Si tratta
di uno spettacolo come qualunque altro.Si ha bisogno di spet-tatori, non diilluminati.»
«Un'etica esemplare. Cosa disse, allora,a Marlasca?»
«Che erano tutte superstizioni, favole.Gli dissi che ero un commediante che siguadagnava da vivere organizzandosedute spiritiche per poveri disgraziatiche avevano perduto i loro cari eavevano bisogno di credere che amanti,padri e amici li aspettassero nell'altromondo. Gli dissi che non c'era nientedall'altra parte, solo un grande vuoto,che questo mondo era tutto quantoavevamo. Gli dissi di scordarsi degli
spiriti e di tornare dalla sua famiglia.»
«E lui le credette?»
«Evidentemente no. Smise di venire allesedute e cercò aiuto altrove.»
«Dove?»
«Irene era cresciuta nelle baracche dellaspiaggia del Bogatell e, anche se eradiventata famosa ballando e recitandonel Paralelo, apparteneva ancora a quelquartiere. Mi raccontò di aver portatoMarlasca da una donna che chiamavanola Strega del Somorrostro per chiedergliprotezione dalla persona con cui lui erain debito.»
«Irene disse il nome di questa persona?»
«Se lo fece, non lo ricordo. Le ho giàdetto che smisero di venire alle sedute.»
«Andreas Corelli?»
«Non l'ho mai sentito nominare.»
«Dove posso trovare Irene Sabino?»
«Le ho già detto tutto quello che so»replicò Roures, esasperato.
«Un'ultima domanda e me ne vado.»
«Vediamo se è vero.»
«Ricorda se ha mai sentito Marlasca
parlare di qualcosa chiamato LuxAeterna?»
Roures aggrottò le sopracciglia, negandocon la testa.
«Grazie per il suo aiuto.»
«Di nulla. E, se possibile, non si facciapiù vedere.»
Annuii e mi diressi all'uscita. Roures miseguiva con gli occhi, sospetto-so.
«Aspetti» disse prima che attraversassila soglia del retrobottega.
Mi girai. L'ometto mi osservava,esitante.
«Credo di ricordare che Lux Aeternaera il titolo di una specie di pamphletreligioso che usavamo qualche voltanelle sedute dell'appartamento di calleElisabets. Faceva parte di una collana dilibretti simili, probabilmente preso inprestito dalla biblioteca di superstizionidella società El Porvenir. Non so se èquello a cui lei si riferisce.»
«Ricorda di cosa trattava?»
«Chi lo conosceva meglio era il miosocio, Jaco, che conduceva le sedute.Però, a quanto ricordo, Lux Aeterna eraun poema sulla morte e i sette nomi delFiglio del Mattino, il Portatore dellaLuce.»
«Il Portatore della Luce?»
Roures sorrise.
«Lucifero.»
33
Una volta in strada, mi incamminaiverso casa chiedendomi cosa avrei fattoa quel punto. Ero quasi all'imbocco dicalle Moncada quando lo vidi.
L'ispettore Víctor Grandes, appoggiatoal muro, assaporava una sigaretta e misorrideva. Mi salutò con la mano eattraversai la strada per andargliincontro.
«Non sapevo che fosse interessato allamagia, Martín.»
«E io non sapevo che lei mi seguisse,ispettore.»
«Non la seguo. Ma lei è un uomodifficile da trovare, così ho deciso chese la montagna non veniva da me, sareiandato io alla montagna. Ha cinqueminuti per bere qualcosa? Offre ilComando di polizia.»
«In questo caso... Non si è portato glichaperon oggi?»
«Marcos e Castelo sono rimasti alComando a sbrigare pratiche, però seavessi detto che venivo da lei si
sarebbero precipitati.»
Scendemmo lungo il canyon di vecchipalazzi medievali fino a El Xam-panyete trovammo un tavolo in fondo al locale.Un cameriere armato di uno straccio chepuzzava di varechina ci guardò eGrandes ordinò un paio di birre e unpiattino di formaggio. Quandoarrivarono le birre e lo stuzzi-chinol'ispettore mi offrì il piatto, ma declinail'invito.
«Le dispiace? A quest'ora ho una fameche non mi reggo in piedi.»
« Bon appétit. »
Grandes inghiottì un pezzo di formaggio
e se lo gustò a occhi chiusi.
«Non le hanno detto che ieri sonopassato da casa sua?»
«Mi hanno avvisato tardi.»
«Comprensibile. Senta, che gioiellino,la bambina. Come si chiama?»
«Isabella.»
«Canaglia, che bella vita fa qualcuno. Lainvidio. Quanti anni ha il bocconcino?»
Gli lanciai un'occhiata velenosa.L'ispettore sorrise compiaciuto.
«Mi ha detto un uccellino che lei
ultimamente si è messo a fare ildetective. Non lascia niente a noiprofessionisti?»
«Come si chiama il suo uccellino?»
«È piuttosto un uccellaccio. Uno deimiei superiori è intimo dell'avvocatoValera.»
«Anche lei nell'organicodell'avvocato?»
«Ancora no, amico mio. Mi conosce,ormai. Vecchia scuola. L'onore e tuttequelle stronzate.»
«Peccato.»
«E mi dica, come sta il povero RicardoSalvador? Sa che da una ventina d'anninon sentivo quel nome? Lo davano tuttiper morto.»
«Una diagnosi precipitosa.»
«E come sta?»
«Solo, tradito e dimenticato.»
L'ispettore annuì lentamente.
«Fa pensare al futuro che riserva questomestiere, vero?»
«Scommetto che nel suo caso le coseandranno diversamente e che l'a-scesa aivertici del corpo è questione di un paio
d'anni. La vedo direttore generale primadei quarantacinque, a baciare mani avescovi e generali dell'esercito allasfilata del Corpus Domini.»
Grandes annuì freddamente, ignorando iltono sarcastico.
«A proposito di baciamano, ha saputodel suo amico Vidal?»
Grandes non iniziava mai unaconversazione senza un asso nascostonella manica. Mi osservò sorridendo,assaporando la mia inquietudine.
«Cosa?» mormorai.
«Dicono che l'altra notte la moglie ha
cercato di suicidarsi.»
«Cristina?»
«È vero, lei la conosce...»
Non mi resi conto che mi ero alzato eche mi tremavano le mani.
«Calma. La signora Vidal sta bene. Solouno spavento. A quanto pare, le èscappata la mano con il laudano.. Mifaccia il piacere di sedersi, Martín.
Per favore.»
Mi sedetti. Lo stomaco mi si eraaggrovigliato in un nodo di chiodi.
«Quando è successo?»
«Due o tre giorni fa.»
Mi venne alla memoria l'immagine diCristina alla finestra di Villa Heliusgiorni prima, quando mi salutava con lamano mentre io sfuggivo il suo sguardo ele davo le spalle.
«Martín?» chiese l'ispettore,passandomi la mano davanti agli occhicome se temesse che fossicompletamente partito.
«Sì?»
L'ispettore mi osservò con quella chesembrava genuina preoccupazione.
«Ha qualcosa da raccontarmi? So chenon mi crederà, ma mi piacerebbeaiutarla.»
«Crede ancora che sia stato io auccidere Barrido e il socio?»
Grandes negò.
«Non l'ho mai creduto, ma ad altripiacerebbe farlo.»
«Allora perché indaga su di me?»
«Si tranquillizzi. Non sto indagando sudi lei, Martín. Non l'ho mai fatto.
Il giorno che lo farò se ne accorgerà. Peril momento la osservo. Mi è simpatico e
mi preoccupo che finisca in qualcheguaio. Perché non si fida di me e non midice cosa sta succedendo?»
I nostri sguardi si incontrarono e per unistante fui tentato di raccontargli tutto.L'avrei fatto, se avessi saputo da dovecominciare.
«Non succede niente, ispettore.»
Grandes annuì e mi guardò concompassione, o forse solo condelusione.
Finì la sua birra e lasciò qualche monetasul tavolo. Mi diede una pacca sullaspalla e si alzò.
«Si riguardi, Martín. E stia attento adove mette i piedi. Non tutti l'ap-prezzano come me.»
«Me ne ricorderò.»
Era quasi mezzogiorno quando tornai acasa senza riuscire a non pensare aquello che mi aveva raccontatol'ispettore. Salii i gradini della scalinatalentamente, come se mi pesasse financhel'anima. Aprii la porta temendo ditrovare un'Isabella in vena diconversazione. La casa era silenziosa.Percorsi il corridoio fino al salotto infondo e la trovai lì, addormentata suldivano con un libro aperto sul petto, unodei miei vecchi romanzi. Non potei
evitare di sorridere. In quei giornid'autunno, la temperatura in casa erascesa sensibilmente e temetti chepotesse prendere freddo. A volte lavedevo girare per casa con una mantelladi lana sulle spalle. Andai un istantenella sua stanza per cercarla emettergliela addosso con circospezione.La porta era socchiusa e, sebbene fossiin casa mia, sta di fatto che non entravoin quella stanza da quando Isabella vi siera sistemata ed ebbi qualche remora afarlo. Scorsi la mantella piegata su unasedia ed entrai a prenderla. La stanzaprofumava dell'aroma dolce e limonosodi Isabella. Il letto era ancora disfatto emi chinai per aggiustare le lenzuola e lecoperte, sapendo che quando mi
dedicavo a qualche lavoro domestico lamia categoria morale guadagnava puntiagli occhi della mia assistente.
Fu allora che notai qualcosa tra ilmaterasso e la rete. L'angolo di un fogliospuntava dalla rimboccatura dellenzuolo. Quando lo tirai, vidi che sitrattava di un plico. Lo estrassicompletamente e mi ritrovai fra le maniquelle che sembravano una ventina dibuste di carta azzurra legate da unnastro. Mi sentii invadere da unasensazione di gelo, ma negai dentro dime. Sciolsi il nodo del nastro e presiuna delle buste. C'erano il mio nome e ilmio indirizzo. Il mittente dicevasemplicemente Cristina.
Mi sedetti sul letto di spalle alla portaed esaminai i timbri postali, uno dopol'altro. Il primo era vecchio di diversesettimane, l'ultimo di tre giorni prima.Tutte le buste erano aperte. Chiusi gliocchi e sentii che le lettere mi cadevanodi mano. La sentii respirare alle miespalle, immobile sulla soglia.
«Mi perdoni» mormorò Isabella.
Si avvicinò lentamente e si inginocchiòper raccogliere le lettere, a una a una.Quando le ebbe riunite tutte, me le tesecon uno sguardo ferito.
«L'ho fatto per proteggerla» disse.
Le si riempirono gli occhi di lacrime e
mi posò la mano sulla spalla.
«Vattene» dissi.
La scostai da me e mi alzai. Isabella silasciò cadere a terra, gemendo come sequalcosa le bruciasse dentro.
«Vattene da questa casa.»
Uscii senza prendermi la briga dichiudermi la porta alle spalle. Arrivai instrada e mi trovai di fronte un mondo difacciate e volti estranei e lontani. Mimisi a camminare senza meta,indifferente al freddo e a quel ventoimpregnato di pioggia che cominciava asferzare la città con il respiro di unamaledizione.
34
Il tram si fermò alle porte della torre diBellesguard, dove la città moriva aipiedi della collina. Mi incamminaiverso l'ingresso del cimitero di SantGervasi seguendo il sentiero di lucegiallastra che i fari del tram trapana-vano nella pioggia. I muri delcamposanto si innalzavano a unacinquantina di metri come una fortezzadi marmo dalla quale emergeva unguazzabuglio di statue del colore deltemporale. All'entrata trovai unaguardiola dove un custode avvolto in uncappotto si riscaldava le mani al fuocodi un braciere. Vedendomi comparire trala pioggia si alzò allarmato. Mi esaminò
per qualche secondo prima di aprire laporticina. «Cerco la cappella dellafamiglia Marlasca.» «Farà scuro inmeno di mezz'ora. Meglio che torniun'altra volta.»
«Prima mi dice dov'è, prima me nevado.» Il custode consultò un elenco emi mostrò l'ubicazione puntando il ditosu una mappa appesa al muro. Miallontanai senza ringraziarlo.
Non fu difficile trovare la cappella inmezzo alla cittadella di tombe emausolei che si assiepavano dentro lemura del camposanto. La struttura sitrovava su un basamento di marmo. Instile modernista, la cappella descriveva
una specie di arco formato da due grandiscalinate disposte a mo' di anfiteatro cheascendevano a un loggione sostenuto dacolonne, al cui interno si apriva un atriofiancheggiato da lapidi. Il loggione eracoronato da una cupola sulla cui cima siinnalzava una statua di marmo brunito. Ilviso era nascosto da un velo, maavvicinandosi alla cappella si aveval'impressione che quella sentinellad'oltretomba girasse la testa per seguirlocon gli occhi. Salii per una dellescalinate e, arrivato all'entrata delloggione, mi fermai a guardare indietro.Le luci della città s'intravedevano nellapioggia, lontane.
Mi addentrai nel loggione. Al centro si
ergeva la statua di una figura femminileabbracciata a un crocifisso inatteggiamento supplice. Il volto era statosfigurato con dei colpi, e qualcunoaveva dipinto di nero gli occhi e lelabbra, conferendole un aspetto da lupa.Non era l'unico segno di pro-fanazionedella cappella. Le lapidi mostravanoquelli che sembravano marchi o graffirealizzati con qualche oggetto appuntito,e alcune erano state incise con disegniosceni e parole che nella penombra astento si riuscivano a leggere. La tombadi Diego Marlasca era in fondo. Mi ciavvicinai e misi la mano sulla lapide.Tirai fuori il ritratto di Marlasca che miaveva dato Salvador e lo esaminai.
Fu allora che sentii i passi sulle scaleche conducevano alla cappella.
Misi la foto nel cappotto e mi giraiverso l'ingresso del loggione. I passi sierano fermati e si udiva soltanto lapioggia che batteva sul marmo. Miavvicinai lentamente all'ingresso e miaffacciai. La sagoma era di spalle, in-tenta a guardare la città in lontananza.Era una donna vestita di bianco con latesta coperta da uno scialle. Si giròpiano e mi guardò. Sorrideva.Nonostante gli anni, la riconobbiall'istante. Irene Sabino. Feci un passoverso di lei e solo allora capii che c'eraqualcuno alle mie spalle. Il colpo allanuca fece esplodere uno spasmo di luce
bianca. Sentii che cadevo in ginocchio.
Un secondo dopo mi afflosciai sulmarmo inzaccherato. Una sagoma scurasi stagliava nella pioggia. Irene siinginocchiò accanto a me. Sentii la suamano tastarmi la testa e palpare il puntoin cui avevo ricevuto il colpo. Vidi lesue dita ritrarsi bagnate di sangue. Conquelle mi accarezzò il viso.
L'ultima cosa che scorsi prima diperdere i sensi fu Irene Sabino cheestra-eva un rasoio e l'aprivalentamente, e le gocce argentee dipioggia che scivolavano sulla lamamentre l'avvicinava a me.
Aprii gli occhi al fulgore accecante
della lampada a olio. Il volto delcustode mi osservava senza alcunaespressione. Cercai di sbattere lepalpebre mentre una vampata di doloremi attraversava il cranio partendo dallanuca.
«È vivo?» chiese il custode, senzaspecificare se la domanda fosse rivoltaa me o puramente retorica.
«Sì» gemetti. «Non le venga in mente dimettermi in una fossa.»
Il custode mi aiutò a raddrizzarmi. Ognicentimetro mi costava una fitta alla testa.
«Cos'è successo?»
«Se non lo sa lei... Avrei dovutochiudere già da un'ora, ma nonvedendola sono venuto fin qui per capirecosa succedeva e l'ho trovata a smaltirela sbornia.»
«E la donna?»
«Quale donna?»
«Erano in due.»
«Due donne?»
Sospirai, scuotendo la testa.
«Può aiutarmi ad alzarmi?»
Con l'aiuto del custode, riuscii a
rimettermi in piedi. Fu allora che sentiiil bruciore e mi accorsi di avere lacamicia aperta. Diversi tagli superficialimi attraversavano il petto.
«Senta, non è un bello spettacolo...»
Mi chiusi il cappotto e, nel farlo, tastainella tasca interna. La foto di Marlascaera scomparsa.
«Ha il telefono nella guardiola?»
«Sì, nella sala dei bagni turchi.»
«Può almeno aiutarmi a raggiungere latorre di Bellesguard così da lì possochiamare un taxi?»
Il custode imprecò e mi afferrò sotto leascelle.
«Gliel'avevo detto di tornare un'altravolta» disse rassegnato.
35
Mancavano solo pochi minuti amezzanotte quando arrivai finalmentealla casa della torre. Appena aprii laporta, seppi che Isabella se n'era andata.Il suono dei miei passi nel corridoioaveva un'altra eco. Non accesi nemmenola luce. Mi addentrai nella casa inpenombra e mi affacciai in quella cheera stata la sua stanza. Isabella l'avevapulita e messa in ordine.
Le lenzuola e le coperte eranoaccuratamente piegate su una sedia, ilmaterasso scoperto. Il suo odore ancorafluttuava nell'aria. Andai in salotto e misedetti alla scrivania utilizzata dalla miaassistente. Isabella aveva tempera-to lematite e le aveva sistemate in modoimpeccabile in un bicchiere. La pila difogli bianchi era in bell'ordine sopra unvassoio. Il set di pennini che le avevoregalato giaceva a un'estremità deltavolo. La casa non mi era mai sembratacosì vuota.
In bagno mi liberai dei vestiti zuppi e mimisi una garza con dell'alcol sulla nuca.Il dolore era diminuito fino a ridursi aun battito sordo e a una sensazione
generale non molto diversa dai postumidi una monumentale sbronza. Allospecchio i tagli sul petto sembravanolinee tracciate con una penna. Eranonetti e superficiali, ma bruciavanoparecchio. Li pulii con l'alcol e speraiche non si infettassero.
Mi misi a letto e mi rimboccai fino alcollo due o tre coperte. Le uniche partidel corpo che non mi facevano maleerano quelle che il freddo e la pioggiaavevano intirizzito fino a privarle disensibilità. Aspettai di scal-darmi,ascoltando quel silenzio freddo, unsilenzio d'assenza e di vuoto chesoffocava la casa. Prima di andarsene,Isabella aveva lasciato le buste con le
lettere di Cristina sul comodino.Allungai la mano e ne tirai fuori una acaso, datata due settimane prima.
Caro David,
i giorni passano e io continuo a scrivertilettere a cui immagino tu preferisca nonrispondere, se pure le apri. Ho iniziato apensare che le scrivo solo per me, persconfiggere la solitudine e credere perun istante di averti vicino. Ogni giornomi domando cosa ne sarà di te e cosastarai facendo.
A volte penso che hai lasciatoBarcellona per non tornare mai più e tiimmagino da qualche parte circondatoda estranei, a cominciare una nuova vita
che non conoscerò mai. Altre voltepenso che mi odii ancora, che distruggiqueste lettere e che vorresti non avermimai conosciuto. Non te ne faccio unacolpa. È curioso quanto sia facileraccontare da soli a un pezzo di cartaquello che non si osa dire in faccia.
Le cose per me non sono facili. Pedronon potrebbe essere più buono ecomprensivo con me, tanto che a voltemi irritano la sua pazienza e la suavoglia di farmi felice, che mi fannosentire sol-
tanto miserabile. Pedro mi ha mostratoche ho il cuore arido e non merito chequalcuno mi ami. Passa quasi tutta la
giornata con me.
Non vuole lasciarmi sola.
Sorrido sempre e condivido il suo letto.Quando mi chiede se lo amo, gli dico disì, e quando vedo la verità riflessa neisuoi occhi vorrei morire. Non me lorimprovera mai. Parla molto di te. Glimanchi. Tanto che a volte penso che lapersona che più ama al mondo sei tu. Lovedo invecchiare, da solo, con lapeggiore delle compagnie, la mia. Nonpretendo che tu mi perdoni, ma sequalcosa desidero a questo mondo è cheperdoni lui. Non vale la pena negargli latua amicizia e la tua compagnia per me.
Ieri ho finito di leggere uno dei tuoi
libri. Pedro li ha tutti e li ho letti perchéè l'unico modo in cui ho l'impressione distare con te.
Era una storia triste e strana, di duepupazzi rotti e abbandonati in un circoambulante che, per lo spazio di unanotte, acquistavano vita sapendo chesarebbero morti all'alba. Leggendola, miè sembrato che scrivessi di noi.
Qualche settimana fa ho sognato dirivederti, ci incontravamo per strada enon ti ricordavi di me. Sorridevi e michiedevi come mi chiamavo. Non sapevinulla di me. Non mi odiavi. Tutte lenotti, quando Pedro si addormentaaccanto a me, chiudo gli occhi e prego il
cielo o l'inferno di permettermi di rifarequel sogno.
Domani, o forse dopodomani, ti scriveròdi nuovo per dirti che ti amo, anche sequesto non significa nulla per te.
Cristina
Lasciai cadere a terra la lettera,incapace di continuare a leggere.Domani è un altro giorno, dissi fra me.Difficilmente peggiore di oggi. Non im-maginavo che le delizie di quellagiornata erano solo iniziate. Dovevoessere riuscito a dormire un paio d'oreal massimo quando mi svegliaiall'improvviso nel cuore della notte.Qualcuno bussava con forza alla porta.
Rimasi qualche secondo storditonell'oscurità, cercando il filodell'interrutto-re della luce. Di nuovo icolpi alla porta. Accesi la luce, scesidal letto e andai all'ingresso. Aprii lospioncino. Tre volti nella penombra delpianerottolo. L'ispettore Grandes e,dietro di lui, Marcos e Castelo. Tutti etre a fissare lo spioncino. Respirai afondo un paio di volte prima di aprire.
«Salve, Martín. Scusi l'ora.»
«E che ora sarebbe?»
«Ora di muovere il culo, figlio diputtana» grugnì Marcos, strappando aCastelo un sorriso con cui avrei potutoradermi la barba.
Grandes lanciò a entrambi uno sguardodi riprovazione e sospirò.
«Le tre di notte passate» disse. «Possoentrare?»
Sospirai infastidito, ma annuii,cedendogli il passo. L'ispettore fececenno ai suoi uomini di aspettarlo sulpianerottolo. Marcos e Casteloannuirono a denti stretti e mi rivolserouno sguardo subdolo. Gli chiusi la portain faccia.
«Dovrebbe essere più cauto con queidue» disse Grandes mentre s'inol-trava asuo agio lungo il corridoio.
«Prego, faccia come se fosse a casa
sua...» dissi.
Tornai nella mia stanza e indossai acasaccio le prime cose che trovai,vestiti sporchi ammucchiati su una sedia.Quando uscii, non c'era traccia diGrandes.
Percorsi il corridoio fino in salotto e lotrovai lì, a contemplare dalla finestra lenubi basse che strisciavano sui tetti.
«E il bocconcino?» chiese.
«A casa sua.»
Grandes si girò sorridendo.
«Uomo saggio, non le tiene a pensione
completa» disse indicando una poltrona.«Si sieda.»
Mi ci lasciai cadere. Grandes rimase inpiedi fissandomi.
«Allora?» chiesi alla fine.
«Ha una brutta faccia, Martín. S'èficcato in qualche rissa?»
«Sono caduto.»
«Già. So che oggi è stato al negozio diarticoli di magia di proprietà del signorDamián Roures in calle Princesa.»
«Ma se mi ha visto uscire di lì amezzogiorno... Cosa significa tutto
questo?»
Grandes mi osservava freddamente.
«Prenda un cappotto e una sciarpa oquel che sia. Fa freddo. Andiamo alcommissariato.»
«A fare che?»
«Faccia come le dico.»
Un'auto del Comando ci aspettava sulpaseo del Born. Marcos e Castelo mificcarono nell'abitacolo senza troppiriguardi e si appostarono di fianco a me,stringendomi in mezzo.
«Sta comodo il signorino?» chiese
Castelo affondandomi il gomito nellecostole.
L'ispettore si sedette davanti, accantoall'autista. Nessuno di loro aprì boccanei cinque minuti che impiegammo apercorrere una via Layetana deserta esepolta in una nebbia ocra. Arrivati alcommissariato, Grandes scese dall'autoed entrò senza aspettare. Marcos eCastelo mi presero ciascuno per unbraccio come se volessero stritolarmi leossa e mi trascinaro-no per un labirintodi scale, corridoi e celle fino a unastanza senza finestre che puzzava disudore e orina. Al centro c'erano untavolo di legno tarlato e due sediesgangherate. Una lampadina spoglia
pendeva dal soffitto e c'era una grata discolo in mezzo alla stanza, nel punto incui convergevano le due leggerependenze che formavano il pavimento.Faceva un freddo atroce. Prima che mene rendessi conto, la porta si chiuse conforza alle mie spalle. Sentii dei passiche si allontanavano. Feci dodici giriattorno a quella cella prima diabbandonarmi su una sedia traballante.Nell'ora successiva, a parte il miorespiro, lo scricchiolio della sedia el'eco di un gocciolio che non riuscii alocalizzare, non sentii nessun altrorumore.
Un'eternità dopo percepii l'eco di passiche si avvicinavano e dopo un po' la
porta si aprì. Marcos si affacciòall'interno della cella, sorridente.
Tenne aperta la porta e cedette il passo aGrandes, che entrò senza posare gliocchi su di me e si accomodò sulla sediadall'altra parte del tavolo. Annuì aMarcos e lui chiuse la porta, non senzaavermi prima lanciato un baciosilenzioso in aria e avermi fattol'occhiolino. L'ispettore ci mise trentasecondi buoni prima di degnarsi diguardarmi in faccia.
«Se voleva impressionarmi, ci èriuscito, ispettore.»
Grandes non fece caso alla mia ironia emi fissò come se non mi avesse mai
visto.
«Cosa sa lei di Damián Roures?»domandò.
Mi strinsi nelle spalle.
«Non molto. Che ha un negozio diarticoli di magia. In realtà non ne sapevoniente fino a qualche giorno fa, quandoRicardo Salvador mi ha parlato di lui.Oggi, o ieri, non so nemmeno più cheora sia, sono andato a trovarlo per avereinformazioni sull'uomo che abitavaprima nella casa in cui vivo. Salvadormi aveva detto che Roures e il vecchioproprietario...»
«Marlasca.»
«Sì, Diego Marlasca. Come dicevo,Salvador mi ha raccontato che lui eRoures avevano avuto rapporti anni fa.Gli ho fatto qualche domanda e harisposto come ha potuto o saputo. Epoco altro.»
Grandes annuì ripetutamente.
«Questa è la sua versione?»
«Non so. Qual è la sua? Confrontiamolee forse riesco a capire che cazzo cifaccio nel cuore della notte a congelarmiin una cantina che puzza di merda.»
«Non alzi la voce, Martín.»
«Scusi, ispettore, ma credo che potrebbe
almeno degnarsi di dirmi cosa ci faccioqui.»
«Glielo dirò. Circa tre ore fa, unabitante del palazzo accanto al negoziodel signor Roures tornava a casa tardiquando ha visto la porta aperta e le luciaccese. Sorpreso, è entrato e, nonvedendo il proprietario e non sen-tendolo rispondere alle sue chiamate, siè diretto nel retrobottega dove lo hatrovato legato mani e piedi con il fil diferro, su una sedia, in una pozza disangue.»
Grandes fece una lunga pausa cheimpiegò a trapanarmi con gli occhi.
Immaginai che ci fosse qualcos'altro.
L'ispettore riservava sempre un colpo aeffetto per il finale.
«Morto?» domandai.
Grandes annuì.
«Abbastanza. Qualcuno si è divertito astrappargli gli occhi e a mozzar-gli lalingua con delle forbici. Il medico legalepensa che sia morto affoga-to dal suostesso sangue mezz'ora dopo.»
Mi mancava l'aria. Grandes micamminava intorno. Si fermò alle miespalle e lo sentii accendersi unasigaretta.
«Come ha preso questo colpo? Sembra
recente.»
«Sono scivolato nella pioggia e hobattuto la nuca.»
«Non mi tratti da imbecille, Martín. Nonle conviene. Preferisce che la lasci unpo' con Marcos e Castelo e vediamo sele insegnano le buone maniere?»
«E va bene. Mi hanno colpito.»
«Chi?»
«Non lo so.»
«Questa conversazione comincia adannoiarmi, Martín.»
«S'immagini a me.»
Grandes si sedette di nuovo di fronte ame e mi rivolse un sorriso conciliante.
«Non crederà che abbia qualcosa a chefare con la morte di quell'uomo?»
«No, Martín. Non lo credo. Però credoche lei non mi stia raccontando la veritàe che in qualche modo la morte di quelpovero disgraziato sia in rapporto con lasua visita. Come quella di Barrido edEscobillas.»
«Cosa glielo fa pensare?»
«Lo chiami un presentimento.»
«Le ho già detto quello che so.»
«L'ho già avvertita di non prendermi perimbecille, Martín. Marcos e Castelosono lì fuori in attesa di un'opportunitàper fare quattro chiacchiere da soli conlei. È questo che vuole?»
«No.»
«Allora mi aiuti a tirarla fuori da questasituazione e a rispedirla a casa primache le si raffreddino le lenzuola.»
«Cosa vuole sapere?»
«La verità, per esempio.»
Spinsi indietro la sedia e mi alzai,
esasperato. Il freddo mi era penetrato finnelle ossa e avevo la sensazione che latesta mi scoppiasse. Cominciai acamminare in circolo attorno al tavolo,sputando fuori le parole come se fosseropietre.
«La verità? Le dirò la verità. La verità èche non so quale sia la verità.
Non so cosa raccontarle. Non so perchésono andato da Roures e da Salvador.Non so cosa sto cercando né cosa mi stasuccedendo. Ecco la verità.»
Grandes mi osservava stoicamente.
«Smetta di girare e si sieda. Mi stafacendo venire il mal di mare.»
«Non ne ho voglia.»
«Martín, tra quello che mi dice e il nullanon c'è nessuna differenza. Le chiedosoltanto di aiutarmi in modo che iopossa aiutarla.»
«Lei non potrebbe aiutarmi neanchevolendo.»
«E chi può farlo allora?»
Mi abbandonai di nuovo sulla sedia.
«Non lo so...» mormorai.
Mi sembrò di vedere un accenno dicompassione, o forse era solostanchezza, negli occhi dell'ispettore.
«Guardi, Martín. Iniziamo da capo.Facciamolo alla sua maniera. Miracconti una storia. Cominci dalprincipio.»
Lo guardai in silenzio.
«Martín, non creda che, siccome mi èsimpatico, io non farò il mio lavoro.»
«Faccia quello che deve fare. Chiamipure Hansel e Gretel, se vuole.»
In quell'istante notai una punta diinquietudine sul suo viso. Siavvicinavano dei passi nel corridoio equalcosa mi disse che l'ispettore non liaspettava. Si sentì qualche parola eGrandes, nervoso, si avvicinò alla porta.
Bussò tre volte con le nocche e Marcos,che la sorvegliava, aprì. Un uomo con uncappotto di cammello e un vestitoelegante entrò nella stanza, si guardòattorno con aria disgustata e poi mirivolse un sorriso di infinita dolcezzamentre si toglieva i guanti con grandeflemma. L'osservai, attonito,riconoscendo l'avvocato Valera.
«Sta bene, signor Martín?» domandò.
Annuii. L'avvocato condusse l'ispettorein un angolo. Li sentii mormorare.Grandes gesticolava con furia trattenuta.Valera lo osservava freddamente escuoteva la testa. La conversazione duròquasi un minuto. Alla fine Grandes
sospirò e lasciò cadere le braccia.
«Prenda la sciarpa, signor Martín, ce neandiamo» disse Valera. «L'i-spettore hafinito con le domande.»
Alle sue spalle, Grandes si morse lelabbra, fulminando con un'occhiataMarcos, che si strinse nelle spalle.Valera, senza abbandonare il sorrisoamabile ed esperto, mi prese per ilbraccio e mi tirò fuori da quella cella.
«Spero che il trattamento ricevuto daparte di questi agenti sia stato cor-retto,signor Martín.»
«Sì» riuscii a balbettare.
«Un momento» disse Grandes alle nostrespalle.
Valera si fermò e, facendomi cenno ditacere, si voltò.
«Per qualsiasi problema con il signorMartín può rivolgersi al nostro studio,che se ne occuperà con molto piacere.Nel frattempo, a meno che lei non abbiaqualche motivo grave per trattenere ilsignor Martín in questi uffici, per oggice ne andiamo augurandole buona notte eringraziandola per la sua cortesia, di cuivolentieri riferirò ai suoi superiori, inparticolare all'ispettore capo Salgado,che come lei sa è un mio grande amico.»
Il sergente Marcos accennò ad
avvicinarsi a noi, ma l'ispettore lotrattenne. Scambiai con lui un ultimosguardo prima che Valera mi prendessedi nuovo per il braccio e mi tirasse via.
«Non si fermi» mormorò.
Percorremmo il lungo corridoiopunteggiato di luci smorte fino a unascala che ci condusse in un altro lungocorridoio, per arrivare poi a unaporticina che dava sull'atrio del pianoterra e all'uscita, dove ci attendeva unaMercedes-Benz con il motore acceso eun autista che appena vide Valera ci aprìla portiera. Entrai e mi sistemainell'abitacolo. L'automobile era dotatadi riscaldamento e i sedili di pelle erano
tiepidi. Valera si sedette al mio fianco e,con un colpetto sul vetro che separaval'abitacolo dall'autista, gli ordinò dipartire. Quando l'automobile fu in motoe imboccò la corsia centrale di viaLayetana, mi sorrise come se nientefosse e indicò la nebbia che si apriva alnostro passaggio come una boscaglia.
«Una brutta nottata, vero?» chiese comeper caso.
«Dove andiamo?»
«A casa sua, naturalmente. A meno chelei preferisca andare in albergo o...»
«No. Va bene.»
L'automobile scendeva lentamente per lavia Layetana. Valera osservava conindifferenza le strade deserte.
«Cosa ci fa lei qui?» domandai alla fine.
«Cosa le sembra che stia facendo? Larappresento e tutelo i suoi interessi.»
«Dica all'autista di fermarsi.»
L'autista cercò lo sguardo di Valeranello specchietto retrovisore.L'avvocato scosse la testa e gli fececenno di proseguire.
«Non dica sciocchezze, signor Martín. Ètardi, fa freddo e l'accompagno a casa.»
«Preferisco andare a piedi.»
«Sia ragionevole.»
«Chi l'ha mandata?»
Valera sospirò e si sfregò gli occhi.
«Lei ha buoni amici, Martín. Nella vita èimportante avere buoni amici esoprattutto saperseli conservare» disse.«Importante come sapere quando ci siostina a proseguire su una stradasbagliata.»
«Non sarà quella che passa da casaMarlasca, al numero 13 della carreterade Vallvidrera?»
L'avvocato sorrise paziente, come sestesse rimproverando con affetto unbambino discolo.
«Signor Martín, mi creda quando le dicoche più lontano si tiene da quella casa eda quella faccenda, meglio sarà per lei.Mi dia retta, anche se soltanto su questoconsiglio.»
L'autista svoltò per il paseo de Colón eimboccò il paseo del Born da calleComercio. I carretti di pesce e di carne,di ghiaccio e di spezie cominciavano adaccalcarsi davanti alla grande area delmercato. Mentre passa-vamo, quattrogarzoni scaricavano la carcassasquartata di un vitello la-
sciando una scia di sangue e vapore cheimpregnava l'aria.
«Un quartiere pieno di fascino e discorci pittoreschi, il suo, signorMartín.»
L'autista si fermò all'imbocco di calleFlassaders e scese dall'auto per a-prircila portiera. L'avvocato scese insieme ame.
«L'accompagno fino al portone» disse.
«Penseranno che siamo fidanzati.»
Ci addentrammo nel canyon di ombredel vicolo in direzione di casa mia.Arrivati al portone, l'avvocato mi diede
la mano con cortesia professionale.
«Grazie per avermi tirato fuori da quelpostaccio.»
«Non ringrazi me» rispose Valera,estraendo una busta dalla tasca internadel cappotto.
Riconobbi il sigillo dell'angelo sullaceralacca perfino nella penombra chesgocciolava dal lampione appeso almuro sulle nostre teste. Valera mi tese labusta e, con un ultimo cenno di assenso,si allontanò per tornare all'automobileche lo stava aspettando. Aprii il portonee salii le scale fino al pianerottolo dicasa. Entrando, andai direttamente nellostudio e posai la busta sulla scrivania.
L'aprii e tirai fuori il foglio ripiegatosulla calligrafia del mio principale.
Amico Martín,
spero e mi auguro che questo biglietto latrovi di buonumore e in salute. Si dà ilcaso che sia di passaggio in città e mipiacerebbe molto poter approfittaredella sua compagnia questo venerdì allediciannove nella sala biliardi delCirculo Ecuestre per discutere deiprogressi del nostro progetto.
Fino ad allora, la saluta con affetto ilsuo amico Andreas Corelli
Ripiegai il foglio e lo rimisi con curanella busta. Accesi un fiammifero e,
tenendola per un angolo, l'avvicinai allafiamma. La guardai bruciare finché laceralacca prese fuoco in lacrimescarlatte che si sparsero sulla scrivaniae le mie dita si ricoprirono di cenere.
«Vada all'inferno» mormorai, mentre lanotte, più scura che mai, sprofondavadietro i vetri.
36
Aspettai un'alba che non arrivava sedutosulla poltrona dello studio finché mivinse la rabbia e uscii in strada dispostoa sfidare l'avvertimento dell'avvocatoValera. C'era quel freddo tagliente cheprecede l'alba in inverno. Attraversandoil paseo del Born, mi parve di sentire
dei passi alle mie spalle. Mi voltai unistante, ma non riuscii a vedere nessuno,tranne i garzoni del mercato chescaricavano i carretti, e proseguii per lamia strada. Arrivando in plaza Palacio,avvistai le luci del primo tram in attesatra la nebbiolina che saliva dalle acquedel porto. Serpentine di luce azzurratascintillavano sui fili. Salii sul tram e misedetti davanti. Mi fece il biglietto lostesso controllore della voltaprecedente. Una decina di passeggeriarrivarono a poco a poco, tutti soli.Dopo pochi minuti il tram partì einiziammo il tragitto mentre nel cielo siestendeva una rete di capillari rossastritra le nuvole nere. Non c'era bisogno diessere un poeta o un saggio per sapere
che sarebbe stata una brutta giornata.
Quando arrivammo a Sarrià, si era fattogiorno con una luce grigia e smorta cheimpediva di distinguere i colori. Saliiper le viuzze solitarie del quartiereverso le falde della collina. A tratti mipareva di sentire dei passi dietro di me,ma ogni volta che mi fermavo perguardarmi alle spalle non c'era nessuno.Alla fine arrivai all'ingresso del vialettoche portava a Casa Marlasca e mi fecistrada attraverso il manto di foglie morteche crepitava ai miei piedi. Attraversailentamente il cortile e salii gli scalinifino alla porta principale, scrutando ifinestroni della facciata. Picchiai trevolte il battente e arretrai di qualche
passo. Aspettai un minuto senza ottenererisposta e bussai di nuovo. Sentii l'ecodei colpi perdersi all'interno della casa.
«Buongiorno!» chiamai.
Il bosco che circondava la villa sembròassorbire l'eco della mia voce.
Aggirai la casa fino al padiglione cheospitava la piscina e mi avvicinai allaveranda a vetrate. Le finestre eranooscurate da imposte di legno socchiuseche impedivano di vedere all'interno.Quella accanto alla porta a vetri chedava sulla veranda era mezza aperta.Attraverso il vetro si vedeva ilsaliscendi che la chiudeva. Introdussi ilbraccio dalla finestra socchiusa e liberai
il saliscendi. La porta cedette con unsuono metallico. Mi guardai ancora unavolta alle spalle, assicurandomi che nonci fosse nessuno, ed entrai.
Via via che i miei occhi si abituavanoalla penombra, cominciai a indovinare icontorni della sala. Andai ai finestroni esocchiusi le imposte per avere un po' dichiarore. Una sventagliata di lame diluce attraversò le tenebre e disegnò ilprofilo della stanza.
«C'è qualcuno?» chiesi.
Sentii il suono della mia voce affondarenelle viscere della casa come unamoneta che cade in un pozzo senzafondo. Andai all'estremità della stanza
dove un arco di legno intagliato dava suun corridoio buio, fiancheggiato daquadri che a stento si vedevano sui muridi velluto. All'altro capo si apriva ungrande salone circolare con pavimenti amosaico e una vetrata smaltata in cui sidistingueva la figura di un angelo biancocon un braccio teso e dita di fuoco. Unagrande scalinata di pietra saliva in unaspirale che circondava la sala. Mifermai ai piedi dei gradini e chiamai dinuovo.
«Buongiorno! Signora Marlasca?»
La casa era immersa in un silenzioassoluto e l'eco smorta si portava via lemie parole. Salii per le scale fino al
primo piano e mi fermai sul pianerottoloda cui si potevano contemplare il salonee la vetrata. Da lì potei vedere le traccelasciate dai miei passi sulla pellicola dipolvere che ricopriva il pavimento. Aparte le mie orme, l'unico segno dipassaggio che riuscii a notare era unaspecie di corridoio tracciato sullapolvere da due linee continue separateda una distanza di due o tre palmi, conall'interno orme di scarpe. Orme grandi.Osservai quelle tracce, disorientato,finché capii cosa stavo vedendo. I segnidi una sedia a rotelle e le orme di chi laspingeva.
Mi sembrò di sentire un rumore alle miespalle e mi voltai. Una porta socchiusa
all'estremità di un corridoio oscillavaleggermente. Da lì proveniva unacorrente di aria fredda. Mi avvicinaipiano. Mentre lo facevo, diediun'occhiata alle stanze che si trovavanosu entrambi i lati. Si trattava di camereda letto con i mobili ricoperti da teli elenzuola. Le finestre chiuse e unapenombra fitta suggerivano che nonfossero state utilizzate da molto tempo,tranne una più ampia delle altre, unacamera da letto matrimoniale.
Ci entrai e mi accorsi che odorava diquella strana miscela di profumo emalattia che accompagna le personeanziane. Immaginai che fosse la stanzadella vedova Marlasca, ma non c'era
traccia della sua presenza.
Il letto era rifatto con cura. Di frontec'era un comò con una serie di ritrattiincorniciati. In tutti, senza eccezione,appariva un bambino dai capelli chiari edall'aria allegra. Ismael Marlasca. Inalcune immagini era in posa con lamadre o con altri bambini. Non c'eratraccia di Diego Marlasca in nessuna diquelle fotografie.
Il rumore di una porta nel corridoio mispaventò di nuovo e uscii dalla stanzalasciando le foto così come le avevotrovate. La porta all'estremità delcorridoio continuava a oscillare. Midiressi lì e mi fermai un istante prima di
entrare. Respirai a fondo e aprii.
Era tutto bianco. I muri e il soffitto eranodipinti di un bianco immacolato. Tendedi seta bianca. Un lettino coperto da telibianchi. Un tappeto bianco. Scaffali earmadi bianchi. Dopo la penombra cheregnava in tutta la casa, quel barbagliomi offuscò la vista per qualche secondo.La stanza pareva ricalcare una visioneonirica, una fantasia fiabesca. Sugliscaffali c'erano giocattoli e libri difavole. Un arlecchino di porcellana agrandezza naturale era seduto davanti auna toilette, guardandosi allo specchio.Dal soffitto pendeva un giocattolo contante cordicelle a cui erano appesi degliuccelli bianchi. A prima vista sembrava
la stanza di un bambino viziato, IsmaelMarlasca, ma l'atmosfera opprimente eraquella di una camera mortuaria.
Mi sedetti sul letto e sospirai. Soloallora notai che c'era qualcosa chesembrava fuori luogo. A cominciaredall'odore. Una puzza dolciastraaleggiava nell'aria. Mi alzai e miguardai attorno. Su una cassettiera c'eraun piatto di porcellana con una candelanera, la cera sciolta in un grappolo dilacrime scure. Mi girai. L'odoresembrava provenire dalla testiera delletto.
Aprii il cassetto del comodino e trovaiun crocifisso spezzato in tre parti.
Sentivo la puzza più vicina. Feci un paiodi giri per la stanza, ma senza trovare lafonte di quell'odore. Fu allora che lavidi. C'era qualcosa sotto il letto. Miinginocchiai e guardai sotto la rete. Unascatola di latta, come quelle che usano ibambini per conservare i loro tesorid'infanzia. La tirai fuori e la misi sulletto. La puzza era adesso molto piùnetta e penetrante.
Ignorai la nausea e aprii la scatola.All'interno c'era una colomba bianca conil cuore attraversato da un ago. Feci unpasso indietro, tappandomi la bocca e ilnaso, e poi arretrai fino in corridoio. Gliocchi dell'arlecchino, con il loro sorrisoda sciacallo, mi osservavano dallo
specchio. Tornai di corsa verso le scalee le feci a precipizio, cercando ilcorridoio che portava alla sala di letturae la porta che ero riuscito ad aprire ingiardino. A un certo punto credetti diessermi perso e che la casa, come unacreatura capace di spostare a suopiacimento saloni e corridoi, nonvolesse lasciarmi fuggire. Alla fineavvistai la veranda a vetrate e corsiverso la porta. Solo allora, mentrearmeggiavo con la serratura, sentiiquella risata maligna alle mie spalle eseppi di non essere solo nella casa. Mivoltai un istante e riuscii a scorgere unasagoma scura che mi osservava dalfondo del corridoio impugnando unoggetto rilucente. Un coltello.
La serratura cedette sotto le mie mani eaprii la porta con uno spintone.
L'impeto mi fece cadere bocconi sullepiastrelle di marmo che circondavano lapiscina. La faccia si fermò ad appena unpalmo dalla superficie e sentii il fetoredell'acqua stagnante. Per un istantescrutai nelle tenebre che s'intravedevanosul fondo della piscina. Un varco si aprìfra le nubi e la luce del sole scivolòattraverso l'acqua, spazzando il fondo dimosaico dis-selciato. La visione duròappena un istante. La sedia a rotelle eracaduta in avanti, arenata sul fondo. Laluce proseguì nel suo percorso verso laparte più profonda della piscina e fu lìche la trovai. Appoggiato alla parete
giaceva quello che mi parve un corpoavvolto in un vestito bianco sfilacciato.
Pensai che si trattasse di un manichino,con quelle labbra scarlatte corrosedall'acqua e quegli occhi brillanti comezaffiri. I suoi capelli rossi dondo-lavanolentamente nell'acqua putrida e la pelleera blu. Era la vedova Marlasca. Unsecondo dopo, il varco in cielo sirichiuse e le acque ridiventaro-no unospecchio scuro in cui riuscii solo avedere il mio volto e una sagoma che simaterializzava alle mie spalle, sullasoglia della veranda, con il coltello inmano. Mi alzai rapidamente e mi misi acorrere verso il giardino, attraversandoil bosco, graffiandomi la faccia e le
mani con gli arbusti, finché raggiunsi ilportone metallico e uscii nel vialetto.Continuai a correre e non mi fermai finoa quando arrivai alla carretera deVallvidrera. Una volta lì, senza fiato, mivoltai e vidi che Casa Marlasca era dinuovo nascosta oltre il vialetto,invisibile al mondo.
37
Tornai a casa con lo stesso tram,percorrendo la città che si faceva ogniminuto più buia sotto un vento gelidoche sollevava le foglie morte per lestrade. Scendendo in plaza Palacio,sentii due marinai provenienti dallebanchine parlare di una burrasca che si
avvicinava dal mare e che avrebbecolpito la città prima di sera. Alzai losguardo e vidi che il cielo cominciava aricoprirsi di un manto di nubi rosse chesi spandevano sul mare come sangueversato. Nelle strade attorno al Born lagente si affannava ad assi-curare porte efinestre, i commercianti chiudevano inegozi prima del solito e i bambiniuscivano in strada a sfidare il vento,spalancando le braccia a croce eridendo del rimbombo dei tuoni lontani.I lampioni sfarfallavano e i balenii deilampi velavano di luce bianca lefacciate. Mi affrettai verso il portonedella casa della torre e salii le scale infretta e furia. Si sentiva il frastuonodella burrasca avvicinarsi al di là dei
muri.
In casa faceva tanto freddo che, entrandoin corridoio, potevo vedere il contornodel mio fiato. Andai direttamente nellastanza dove c'era una vecchia stufa acarbone che avevo usato solo quattro ocinque volte da quando abitavo lì el'accesi con un fascio di giornali vecchie asciutti. Accesi anche il camino delsalotto e mi sedetti a terra davanti allefiamme. Mi tremavano le mani e nonsapevo se era per il freddo o per lapaura. Aspettai di recuperare un po' dicalore contemplando il reticolo di lucebianca lasciato dai fulmini in cielo.
La pioggia non arrivò fino a sera e
quando iniziò a cadere precipitò incortine di gocce furiose che in pochiminuti accecarono la notte e annega-ronotetti e vicoli sotto un manto nero checolpiva con forza i vetri e i muri. Apoco a poco, tra la stufa a carbone e ilcamino, la casa si riscaldò, ma iocontinuavo ad avere freddo. Mi alzai eandai nella camera da letto in cerca dicoperte per avvolgermi. Aprii l'armadioe cominciai a frugare nei due grandicassetti della parte inferiore. L'astuccioera ancora lì, nascosto sul fondo. Lopresi e lo misi sul letto.
L'aprii e contemplai il vecchio revolverdi mio padre, tutto ciò che mi restava dilui. Lo presi in mano, accarezzando il
grilletto con l'indice. Aprii il tamburo evi introdussi sei pallottole della scatoladi munizioni che si trovava nel doppiofondo dell'astuccio. Lasciai la scatolasul comodino e mi portai il revolver euna coperta in salotto. Una volta lì, mistesi sul sofà avvolto nella coperta conil revolver sul petto e lasciai vagare losguardo sul temporale dietro i finestroni.Potevo sentire il rumore dell'orologioche stava sulla mensola del camino. Nonavevo bisogno di guardarlo per sapereche mancava appena mezz'oraall'incontro con il principale nella salabiliardi del Circulo Ecuestre.
Chiusi gli occhi e lo immaginai mentrepercorreva le strade della città, deserte
e inondate d'acqua. Lo immaginai sulsedile posteriore della sua automobile,con gli occhi dorati che brillavanonell'oscurità e l'angelo d'argento sulcofano della Rolls-Royce che si facevastrada in mezzo al temporale. Loimmaginai immobile come una statua,senza respiro né sorriso, senza nessunaespressione. Dopo un po', ascoltando ilrumore della legna che bruciava e dellapioggia sui vetri, mi addormentai conl'arma tra le mani e la certezza che nonsarei andato all'appuntamento.
Poco dopo mezzanotte aprii gli occhi. Ilfuoco nel camino era quasi spento e ilsalotto era immerso nella penombraondeggiante proiettata dalle fiamme
azzurrine che consumavano le ultimebraci. Continuava a piovere forte. Ilrevolver era sempre tra le mie mani,tiepido. Rimasi lì, disteso, ancoraqualche secondo, senza quasi battereciglio. Seppi che c'era qualcuno allaporta ancora prima di sentire bussare.
Scostai la coperta e mi alzai. Sentii dinuovo i colpi. Nocche sulla porta dicasa. Mi alzai con l'arma in pugno eandai in corridoio. Altri colpi. Feciqualche passo verso la porta e mifermai. Lo immaginai sorridente sulpianerottolo, con l'angelo sul risvoltodella giacca che brillava nell'oscurità.
Armai il percussore. Di nuovo il rumore
di una mano che bussava alla porta.Cercai di accendere la luce, ma nonc'era elettricità. Continuai ad avanzarefino alla porta. Stavo per aprire lospioncino, ma non osai. Rimasi lìimmobile, quasi senza respirare, tenendol'arma puntata verso la porta.
«Se ne vada» urlai, senza forza nellavoce.
Sentii allora quel pianto dall'altra partee abbassai il revolver. Aprii la porta nelbuio e la trovai lì. Aveva i vestitibagnati e tremava. La sua pelle eragelida. Quando mi vide, fu sul punto dicadere tra le mie braccia. La sostenni e,senza trovare le parole da dire,
l'abbracciai forte. Mi sorrisedebolmente e quando le misi la manosulla guancia la baciò chiudendo gliocchi.
«Perdonami» mormorò Cristina.
Aprì gli occhi e mi rivolse quellosguardo ferito e spezzato che mi avrebbeperseguitato fino all'inferno. Le sorrisi.
«Benvenuta a casa.»
38
La spogliai alla luce di una candela. Letolsi le scarpe zuppe d'acqua, il vestitobagnato e le calze sfilacciate. Leasciugai il corpo e i capelli con un
asciugamano pulito. Tremava ancora difreddo quando la feci sdraiare sul letto emi stesi accanto a lei, abbracciandolaper scaldarla. Restammo così a lungo, insilenzio, ad ascoltare la pioggia.Lentamente sentii che il suo corpos'intiepidiva sotto le mie mani ecominciava a respirare profondamente.Credevo si fosse addormentata, quandola sentii parlare nella penombra.
«La tua amica è venuta a trovarmi.»
«Isabella.»
«Mi ha raccontato che ti aveva nascostole mie lettere. Che non l'aveva fatto inmalafede. Credeva di farlo per il tuobene e forse aveva ragione.»
Mi chinai su di lei e cercai i suoi occhi.Le accarezzai le labbra e sorrisedebolmente.
«Pensavo che ti fossi dimenticato di me»disse.
«Ci ho provato.»
Il suo viso era segnato dalla stanchezza.I mesi di assenza le avevano disegnatodelle linee sulla pelle e il suo sguardoaveva un'aria di sconfitta e di vuoto.
«Non siamo più giovani» disse,leggendo nei miei pensieri.
«Quando siamo stati giovani, tu e io?»
Scostai la coperta e contemplai il suocorpo nudo steso sul lenzuolo bianco. Leaccarezzai il collo e il seno, sfiorandoleappena la pelle con la punta delle dita.Le disegnai cerchi sul ventre e tracciai ilcontorno delle ossa che si insinuavanosotto i fianchi. Lasciai che le mie ditagiochic-chiassero sul vello quasitrasparente tra le sue cosce.
Cristina mi osservava in silenzio, con ilsorriso spezzato e gli occhi socchiusi.
«Cosa facciamo?» chiese.
Mi chinai su di lei e la baciai sullelabbra. Mi abbracciò e rimanemmo lìdistesi mentre la luce della candela siesauriva lentamente.
«Qualcosa ci verrà in mente» mormorò.
Poco dopo l'alba mi svegliai e scoprii diessere solo nel letto. Mi alzai di scatto,temendo che Cristina se ne fosse andatadi nuovo nel cuore della notte. Alloravidi che i suoi vestiti e le sue scarpeerano ancora sulla sedia e respirai afondo. La trovai in salotto, avvolta inuna coperta e seduta a terra davanti alcamino, dove un ciocco ridotto ormai abrace sprigionava una fiamma azzurra.Mi sedetti accanto a lei e la baciai sulcollo.
«Non riuscivo a dormire» disse, con losguardo fisso sul fuoco.
«Potevi svegliarmi.»
«Non me la sono sentita. Avevi l'aria diesserti addormentato per la prima voltada mesi. Ho preferito esplorare la tuacasa.»
«E allora?»
«Questa casa è stregata di tristezza»disse. «Perché non le dai fuoco?»
«E dove andremmo a vivere?»
«Al plurale?»
«Perché no?»
«Credevo che non scrivessi più raccontifantastici.»
«È come andare in bicicletta. Una voltache hai imparato...»
Cristina mi guardò a lungo.
«Cosa c'è nella stanza in fondo alcorridoio?»
«Niente. Vecchie cianfrusaglie.»
«È chiusa a chiave.»
«Vuoi vederla?»
Scosse la testa.
«È solo una casa, Cristina. Un mucchiodi pietre e ricordi. Niente di più.»
Cristina annuì con scarsa convinzione.
«Perché non ce ne andiamo?» domandò.
«Dove?»
«Lontano.»
Non riuscii a evitare di sorridere, ma leinon fece altrettanto.
«Dove?» chiesi di nuovo.
«Dove nessuno sappia chi siamo e anessuno importi saperlo.»
«È questo che vuoi?»
«E tu no?»
Esitai un istante.
«E Pedro?» domandai, quasistrozzandomi con le parole.
Lasciò cadere la coperta che aveva sullespalle e mi fissò con aria di sfida.
«Hai bisogno del suo permesso pervenire a letto con me?»
Mi morsi la lingua. Cristina mi guardavacon le lacrime agli occhi.
«Scusa» mormorò. «Non avevo il dirittodi dirlo.»
Raccolsi la coperta da terra e cercai dimettergliela addosso, ma lei si scostò e
respinse il mio gesto.
«Pedro mi ha lasciato» disse con lavoce rotta. «Si è trasferito ieri al Ritz adaspettare che me ne andassi. Mi ha dettoche sapeva che non lo amo, che l'hosposato per gratitudine o per pietà. Miha detto che non vuole la miacompassione, che ogni giorno chetrascorro accanto a lui fingendo diamarlo gli faccio del male. Mi ha dettoche, qualunque cosa avrei fatto, miavrebbe sempre amato e che per questonon voleva più rivedermi.»
Le tremavano le mani.
«Mi ha amato con tutto il cuore e io hosaputo solo renderlo infelice»
mormorò.
Chiuse gli occhi e il suo volto sicontrasse in una smorfia di dolore. Unattimo dopo le sfuggì un gemitoprofondo e iniziò a prendersi a pugni lafaccia e il corpo. Mi gettai su di lei e lastrinsi tra le braccia, immobiliz-zandola.Cristina si divincolava e urlava. Lapremetti contro il pavimento, tenendolaper le mani. Si arrese lentamente,esausta, il volto coperto di lacrime esaliva, gli occhi arrossati. Restammocosì quasi mezz'ora, fin quando sentii ilsuo corpo rilassarsi e sprofondare in unlungo silenzio. Le misi addosso lacoperta e l'abbracciai da dietro,nascondendole le mie lacrime.
«Ce ne andremo lontano» le mormoraiall'orecchio senza sapere se potevasentirmi o capirmi. «Ce ne andremolontano dove nessuno sappia chi siamo ea nessuno importi saperlo. Te loprometto.»
Cristina girò la testa e mi guardò. Aveval'aria assente, come se le avesserospezzato l'anima a martellate.L'abbracciai forte e la baciai in fronte.
La pioggia continuava a battere sui vetri.Intrappolati nella luce grigia e pallidadell'alba smorta, pensai per la primavolta che stavamo affondando.
39
Abbandonai il lavoro per il principalequel mattino stesso. Mentre Cristinadormiva, salii nello studio e misi lacartellina che conteneva pagine, note eappunti in un vecchio baule addossato aun muro. Il primo impulso era stato didarle fuoco, ma non ne ebbi il coraggio.Per tutta la vita avevo sentito che lepagine che lasciavo al mio passaggioerano parte di me. La gente normalemette al mondo dei figli; noi romanzieridei libri. Siamo condannati a metterci lavita, anche se quasi mai ce ne sono grati.Siamo condannati a morire nelle loropagine e a volte perfino a lasciare chesiano loro a toglierci la vita.
Fra tutte le strane creature di carta e
inchiostro che avevo portato in questomiserabile mondo, quella, la mia offertamercenaria alle promesse delprincipale, era senza dubbio la piùgrottesca. Non c'era nulla in quellepagine che meritasse qualcosa didiverso dal fuoco, ma era pur sempresangue del mio sangue e non avevo ilcoraggio di distruggerla. L'abbandonaiin fondo a quel baule e uscii dallo studioafflitto, quasi vergognandomi della miavigliaccheria e della torbida sensazionedi paternità che m'ispira-va quelmanoscritto tenebroso. Probabilmente ilprincipale avrebbe saputo apprezzarel'ironia della situazione. A me,semplicemente, dava la nausea.
Cristina dormì fino al pomeriggioinoltrato. Ne approfittai per andare acomprare un po' di latte, pane eformaggio in una bottega accanto almercato. La pioggia era finalmentecessata, ma le strade erano piene dipozzanghere e l'umidità si palpavanell'aria come se fosse una polverefredda che penetrava nei vestiti e nelleossa. Mentre aspettavo il mio turno nellalatteria, ebbi l'impressione che qualcunomi stesse osservando. Uscendo di nuovoin strada e attraversando il paseo delBorn, mi guardai alle spalle e vidi cheun bambino di non più di cinque anni miseguiva. Mi fermai e lo guardai. Anchelui si fermò e sostenne il mio sguardo.
«Non avere paura» gli dissi. «Vieni.»
Il bambino si avvicinò di qualche passoe si fermò a un paio di metri da me.Aveva la pelle pallida, quasi azzurrata,come se non avesse mai visto la luce delsole. Vestiva di nero e portava scarpe divernice nuove e lucide.
Aveva gli occhi scuri e le pupille cosìgrandi che a stento gli si vedeva ilbianco delle cornee.
«Come ti chiami?» domandai.
Il bambino sorrise e mi indicò con ildito. Cercai di fare un passo verso dilui, ma si mise a correre e lo vidiperdersi per il paseo del Born. Quando
tornai a casa, trovai una busta infilatanella porta. Il sigillo di ceralacca rossacon l'angelo era ancora tiepido. Guardaida una parte e dall'altra della strada, manon vidi nessuno. Entrai e mi chiusi ilportone alle spalle a doppia mandata.Mi fermai ai piedi delle scale e aprii labusta.
Caro amico,
mi rincresce profondamente che non siapotuto venire al nostro appuntamentoieri notte. Spero che stia bene e che nonsi siano verificate emergenze ocontrattempi. Mi spiace non aver potutogodere del piacere della sua compagniain questa occasione, ma spero e mi
auguro che, qualunque cosa le abbiaimpedito di vedermi, la questione abbiauna pronta e favorevole soluzione e chela prossima volta sia più propizia afacilitare il nostro incontro.
Devo assentarmi dalla città per qualchegiorno, ma appena tornato le farò averemie notizie. Nell'attesa di sapere di lei edei suoi progressi nel nostro comuneprogetto, la saluta come sempre conaffetto il suo amico
Andreas Corelli
Strinsi la lettera nel pugno e me l'infilaiin tasca. Entrai in casa con cautela eaccompagnai la porta con dolcezza. Miaffacciai nella camera da letto e vidi che
Cristina dormiva ancora. Andai incucina e cominciai a preparare il caffè euna piccola colazione. Dopo pochiminuti sentii i passi di Cristina alle miespalle. Mi osservava dalla soglia conaddosso un mio vecchio pullover che learrivava a metà coscia. Aveva i capelliin disordine e gli occhi gonfi. Sullelabbra e le guance aveva i segni scuridei colpi, come se l'avessi presa aschiaffi con forza. Sfuggiva il miosguardo.
«Scusa» mormorò.
«Hai fame?» chiesi.
Scosse la testa, ma io ignorai il suogesto e le feci cenno di sedersi a tavola.
Le servii una tazza di caffellattezuccherato e una fetta di pane appenasfornato con formaggio e un po' diprosciutto. Non fece nemmeno la mossadi toccare il piatto.
«Solo un boccone» suggerii.
Civettò di malavoglia con il formaggio emi sorrise debolmente.
«È buono» disse.
«Quando lo proverai, ti sembreràmigliore.»
Mangiammo in silenzio. Cristina, conmia sorpresa, mangiò metà del suopiatto. Poi si nascose dietro la tazza di
caffè e mi guardò di sottecchi.
«Se vuoi, me ne vado oggi stesso» dissealla fine. «Non preoccuparti.
Pedro mi ha dato dei soldi e...»
«Non voglio che te ne vada da nessunaparte. Non voglio che te ne vada maipiù. Mi hai sentito?»
«Non sono una buona compagnia,David.»
«Siamo in due.»
«Dicevi davvero? Di andarcenelontano?»
Annuii.
«Mio padre diceva che la vita non dàseconde opportunità.»
«Le dà solo a quelli a cui non ha maidato nemmeno la prima. In realtà, sonoopportunità di seconda mano chequalcuno non ha saputo utilizzare, masono sempre meglio di niente.»
Sorrise a stento.
«Portami a fare una passeggiata» disseall'improvviso.
«Dove vuoi andare?»
«Voglio dire addio a Barcellona.»
40
A metà pomeriggio il sole spuntò dasotto il manto di nuvole lasciato daltemporale. Le strade lucide di pioggia sitrasformarono in specchi su cuicamminavano i passanti e si rifletteva ilcolore ambrato del cielo. Ricordo cheandammo fino all'inizio delle Ramblas,dove la statua di Colombo spuntavadalla bruma. Camminavamo in silenzio,osservando le facciate e la folla come sefossero un miraggio, come se la cittàfosse ormai deserta e dimenticata.Barcellona non mi sembrò mai tantobella e tanto triste quanto quelpomeriggio. Quando iniziò a far scuro,ci dirigemmo verso la libreria di
Sempere e Figli. Ci appostammo in unportone dall'altra parte della strada,dove nessuno poteva vederci. La vetrinadella libreria proiettava una bolla diluce sui sampietrini umidi e brillanti.All'interno si riusciva a scorgereIsabella in cima a una scala che mettevain ordine i libri dell'ultimo scaffale,mentre il figlio di Sempere faceva fintadi rivedere il registro della contabilitàdietro il bancone e le guardava le gambedi nascosto. Seduto in un angolo,vecchio e stanco, il signor Sempere liosservava entrambi con un sorriso triste.
«Questo è il posto in cui ho trovatoquasi tutte le cose buone della mia vita»dissi senza pensare. «Non voglio dirgli
addio.»
Quando tornammo alla casa della torreera già buio. Entrando, ci accolse ilcalore del fuoco che avevo lasciatoacceso prima di uscire. Cristina miprecedette lungo il corridoio e, senzadire una parola, si spogliò lasciando unascia di vestiti sul pavimento. La trovaistesa sul letto, in attesa. Mi sdraiaiaccanto a lei e lasciai che mi guidasse lemani. Mentre l'accarezza-vo vidi imuscoli tendersi sotto la sua pelle. Neisuoi occhi non c'era tenerezza, ma undesiderio di calore e di urgenza. Miabbandonai nel suo corpo, penetrandolacon rabbia mentre sentivo le sue unghiesulla pelle. La sentii gemere di dolore e
di vita, come se le mancasse l'aria. Allafine ci abbandonammo esausti ericoperti di sudore l'uno accantoall'altra. Cristina mi appoggiò la testasulla spalla e cercò il mio sguardo.
«La tua amica mi ha detto che ti seicacciato in un guaio.»
«Isabella?»
«È molto preoccupata per te.»
«Isabella ha la tendenza a credere diessere mia madre.»
«Non penso che miri a quello.»
Evitai i suoi occhi.
«Mi ha raccontato che stai lavorando aun libro nuovo, su incarico di un editorestraniero. Lei lo chiama il tuoprincipale. Dice che ti paga una fortuna,ma che tu ti senti in colpa per averaccettato i soldi. Dice che hai paura diquell'uomo e che c'è qualcosa di torbidoin questo affare.»
Sospirai irritato.
«C'è qualcosa che Isabella non ti abbiaraccontato?»
«Il resto sono cose tra di noi» replicòfacendomi l'occhiolino. «Ha forsementito?»
«Non mentiva, faceva congetture.»
«E di cosa tratta il libro?»
«È un racconto per bambini.»
«Isabella mi ha avvertito che avrestirisposto così.»
«Se Isabella ti ha già dato tutte lerisposte, perché mi fai questedomande?»
Cristina mi guardò con severità.
«Per la tua tranquillità, e per quella diIsabella, ho abbandonato il libro.
C'est fini» assicurai.
«Quando?»
«Stamattina, mentre dormivi.»
Cristina aggrottò le sopracciglia,scettica.
«E quell'uomo, il tuo principale, lo sa?»
«Non gli ho parlato. Ma suppongo loimmagini. E se non lo immagina, lo faràmolto presto.»
«Dovrai restituirgli i soldi, allora?»
«Non credo che i soldi gli importinominimamente.»
Cristina sprofondò in un lungo silenzio.
«Posso leggerlo?» chiese alla fine.
«No.»
«Perché no?»
«È una bozza senza capo né coda. È soloun mucchio di idee e di appunti, diframmenti sparsi. Niente di leggibile. Tiannoierebbe.»
«Mi piacerebbe leggerlo lo stesso.»
«Perché?»
«Perché l'hai scritto tu. Pedro dicesempre che l'unico modo di conosceredavvero uno scrittore è attraverso lascia di inchiostro che lascia, dice che lapersona che uno crede di vedere è soloun personaggio vuoto e che la verità si
nasconde sempre nella finzione.»
«Deve averlo letto su qualchecartolina.»
«In realtà l'ha preso da uno dei tuoilibri. Lo so perché l'ho letto anch'i-
o.»
«Il plagio non lo innalza dal rango distupidaggine.»
«Io credo che abbia un senso.»
«Allora sarà vero.»
«Quindi posso leggerlo?»
«No.»
Cenammo con quanto restava del pane edel formaggio della mattina, seduti l'unodi fronte all'altra al tavolo di cucina,guardandoci di tanto in tanto. Cristinamasticava senza appetito, esaminandoogni boccone di pane alla luce dellalampada prima di portarselo alla bocca.
«C'è un treno che parte dalla stazioneFrancia per Parigi domani amezzogiorno» disse. «È troppo presto?»
Non riuscivo a togliermi dalla testal'immagine di Andreas Corelli che da unmomento all'altro saliva le scale ebussava alla mia porta.
«Immagino di no» convenni.
«Conosco un alberghetto di fronte aiJardins du Luxembourg che affitta stanzea mese. È un po' caro, però...» aggiunse.
Preferii non chiederle come maiconosceva quell'albergo.
«Il prezzo non importa, però non parlofrancese» sottolineai.
«Io sì.»
Abbassai lo sguardo.
«Guardami negli occhi, David.»
Alzai la testa controvoglia.
«Se preferisci che me ne vada...»
Negai ripetutamente. Mi afferrò la manoe se la portò alle labbra.
«Andrà bene, vedrai» disse. «Lo sento.Sarà la prima cosa che mi andrà benenella vita.»
La guardai, una donna spezzata nellapenombra con le lacrime agli occhi, enon desiderai altro al mondo che poterlerestituire ciò che non aveva mai avuto.
Ci sdraiammo sul divano del salotto alriparo di un paio di coperte, osservandole braci nel camino. Mi addormentaiaccarezzando i capelli di Cristina epensando che quella sarebbe stata
l'ultima notte che avrei trascorso inquella casa, la prigione in cui avevoseppellito la mia gioventù.
Sognai di correre per le strade di unaBarcellona infestata di orologi le cuilancette giravano in senso inverso.Vicoli e viali si curvavano al miopassaggio come tunnel con volontàpropria, formando un labirinto viventeche si prendeva gioco di tutti i mieitentativi di avanzare. Alla fine, sotto unsole di mezzogiorno che ardeva nelcielo come una sfera di metalloincandescente, riuscivo a raggiungere lastazione Francia e mi dirigevo in tuttafretta verso il binario dove il trenocominciava a muoversi. Gli correvo
dietro, ma il treno prendeva velocità enonostante i miei sforzi non riuscivo afar altro che sfiorarlo con la punta delledita. Continuavo a correre fino a perdereil fiato e quando arrivavo alla fine dellabanchina cadevo nel vuoto. Quandoalzavo gli occhi, era troppo tardi. Iltreno, ormai distante, si allontanava,mentre il volto di Cristina mi guardavadall'ultimo finestrino.
Aprii gli occhi e seppi che Cristina nonc'era. Il fuoco si era ridotto a un pugnodi cenere che a stento scintillava. Mialzai e guardai dal finestrone.
Accostai la faccia al vetro e notai unchiarore tremulo alle finestre dello
studio. Mi diressi verso la scala achiocciola che saliva alla torre. Unbagliore ramato si spargeva sui gradini.Salii lentamente. Arrivato in cima, mifermai sulla soglia dello studio. Cristinaera di spalle, seduta per terra.
Il baule accanto al muro era aperto.Cristina aveva tra le mani la cartellinache conteneva il manoscritto per ilprincipale e stava sciogliendo il nodoche la chiudeva.
Sentendo i miei passi, si fermò.
«Cosa ci fai qui?» domandai cercandodi nascondere l'allarme nella voce.
Lei si voltò e sorrise.
«Curiosavo.»
Seguì la linea del mio sguardo fino allacartellina che aveva fra le mani e adottòuna smorfia maliziosa.
«Cosa c'è qui dentro?»
«Niente. Note. Appunti. Niente diinteressante...»
«Bugiardo. Scommetto che è il libro acui stavi lavorando» disse iniziando asciogliere il nodo. «Muoio dalla vogliadi leggerlo...»
«Preferirei che non lo facessi» dissi neltono più rilassato di cui fui capace.
Cristina aggrottò le sopracciglia. Neapprofittai per accovacciarmi davanti alei e toglierle delicatamente la cartellinadalle mani.
«Cosa succede, David?»
«Niente, non succede niente» assicuraicon un sorriso stupido stampato sullelabbra.
Riannodai di nuovo lo spago dellacartellina e la rimisi nel baule.
«Non lo chiudi a chiave?» chieseCristina.
Mi voltai, pronto a offrirle delle scuse,ma era sparita giù per le scale.
Sospirai e chiusi il baule.
La trovai giù nella camera da letto. Perun istante mi guardò come se fossi unestraneo. Rimasi sulla porta.
«Scusa» iniziai.
«Non c'è motivo di farlo» replicò. «Nonavrei dovuto ficcare il naso dovenessuno mi aveva chiamato.»
«Non è questo.»
Mi rivolse un sorriso sotto zero e ungesto di noncuranza che tagliavano l'ariaa fette.
«Non ha importanza» disse.
Annuii, rimandando il secondo assalto aun altro momento.
«La biglietteria della stazione aprepresto» dissi. «Ho pensato di avviar-miin modo da essere lì appena apre ecomprare i biglietti per oggi amezzogiorno. Poi vado in banca aritirare i soldi.»
Cristina si limitò ad annuire.
«Molto bene.»
«Perché nel frattempo non prepari unaborsa con qualche vestito? Io torno almassimo tra un paio d'ore.»
Cristina sorrise debolmente.
«Ti aspetto qui.»
Mi avvicinai e le presi il viso tra lemani.
«Domani sera saremo a Parigi» le dissi.
La baciai sulla fronte e me ne andai.
41
L'atrio della stazione Francia stendevaai miei piedi uno specchio in cui sirifletteva il grande orologio sospeso alsoffitto. Le lancette segnavano le sette etrentacinque del mattino, ma gli sportellidella biglietteria erano ancora chiusi. Uncommesso armato di spazzolone e invena di preziosismi lustrava il
pavimento fischiettando una canzone e,per quanto lo permettes-se la sua zoppia,dimenando i fianchi con un certo garbo.In mancanza di altro da fare, mi misi aosservarlo. Era un ometto minuto che ilmondo aveva fatto raggrinzire su sestesso fino a togliergli tutto tranne ilsorriso e il piacere di pulire quelpavimento come se si trattasse dellaCappella Sistina.
Non c'era nessun altro, e alla fine siaccorse di essere osservato. Quando ilsuo quinto passaggio trasversale loportò davanti al mio posto diosservazione su una delle panchine dilegno disposte ai lati dell'atrio, ilcommesso si fermò e, appoggiandosi
con tutte e due le mani sullo spazzolone,trovò il coraggio per guardarmiapertamente.
«Non aprono mai all'ora che dicono»spiegò indicando gli sportelli.
«E allora perché mettono un cartello chedice che aprono alle sette?»
L'ometto si strinse nelle spalle e sospiròcon aria filosofica.
«Be', mettono anche gli orari ai treni e inquindici anni che sono qui non ne hovisto nemmeno uno che arrivasse opartisse all'ora prevista.»
Il commesso proseguì nella sua pulizia
in profondità e quindici minuti più tardisentii che si apriva il finestrino dellosportello. Mi avvicinai e sorrisi albigliettaio.
«Credevo che apriste alle sette» dissi.
«Così dice il cartello. Cosa desidera?»
«Due biglietti di prima classe per Parigisul treno di mezzogiorno.»
«Per oggi?»
«Se non è troppo disturbo.»
Il rilascio dei biglietti gli portò viaquasi quindici minuti. Una voltaterminato il suo capolavoro, li lasciò
cadere di malavoglia sul bancone.
«All'una. Binario quattro. Non facciatardi.»
Pagai e, siccome non me ne andavo, fuiossequiato da uno sguardo ostile einquisitorio.
«Qualcos'altro?»
Gli sorrisi e scossi la testa, opportunitàdi cui approfittò per chiudermi ilfinestrino in faccia. Mi girai eattraversai l'atrio immacolato e brillanteper merito del commesso, che mi salutòda lontano e mi augurò bon voyage.
La sede centrale del Banco Hispano
Colonial in calle Fontanella facevapensare a un tempio. Un grande porticodava accesso a una navata fiancheggiatada statue che si estendeva fino a una filadi sportelli disposti come un altare. Suentrambi i lati, a mo' di cappelle econfessionali, poltrone presidenziali etavoli di quercia presidiati da unesercito di funzionari e impiegatiimpeccabilmente vestiti e armati disorrisi cordiali. Prelevai quattromilafranchi in contanti e ricevetti leistruzioni su come ritirare fondi negliuffici della banca all'incrocio fra rue deRennes e boulevard Ra-spail a Parigi,vicino all'albergo di cui aveva parlatoCristina. Con quella piccola fortuna intasca mi accomiatai, senza dar retta ai
consigli del funzionario su quanto fosseimprudente andarsene in giro con unasomma si-
mile in contanti.
Il sole si stagliava sopra un cieloazzurro con il colore della buona sorte,e una brezza tersa portava il profumo delmare. Camminavo a passo leggero, comese mi fossi liberato da un tremendopeso, e iniziai a pensare che la cittàaveva deciso di lasciarmi andar viasenza rancore. Sul paseo del Born mifermai a comprare dei fiori per Cristina,rose bianche annodate da un nastrorosso. Salii le scale della casa dellatorre a due a due, con un sorriso
stampato sulle labbra e la certezza chequello sarebbe stato il primo giorno diuna vita che avevo creduto ormai persaper sempre. Stavo per aprire quando,introducendo la chiave nella serratura,la porta cedette. Era aperta.
La spinsi e avanzai nell'ingresso. Lacasa era silenziosa.
«Cristina?»
Lasciai i fiori sulla mensoladell'anticamera e mi affacciai nellacamera da letto. Cristina non c'era.Percorsi il corridoio fino al salotto infondo.
Nessuna traccia della sua presenza. Mi
avvicinai alla scala dello studio echiamai a voce alta.
«Cristina?»
L'eco mi restituì la mia voce. Mi strinsinelle spalle e consultai l'orologio chestava in una delle cristalliere del salotto.Erano quasi le nove. Immaginai cheCristina fosse uscita in cerca diqualcosa e che, male abituata dalla suavita a Pedralbes, dove avere a che farecon porte e serrature era una questioneriservata ai domestici, avesse lasciato laporta aperta. Mentre aspettavo, decisi distendermi sul sofà del salotto. Il soleentrava dalla vetrata, un sole invernalelimpido e brillante, e invitava a lasciarsi
accarezzare.
Chiusi gli occhi e cercai di pensare acosa avrei portato con me. Avevovissuto mezza vita circondato da tuttiquegli oggetti e adesso, al momento didire loro addio, ero incapace dicompilare una breve lista di quelli cheritenevo imprescindibili. A poco a poco,senza accorgermene, steso alla caldaluce del sole e di quelle tiepidesperanze, mi addormentai placidamente.
Quando mi svegliai e guardai l'orologiodella biblioteca era mezzogiorno emezzo. Mancava appena mezz'ora allapartenza del treno. Mi alzai di scatto ecorsi verso la camera da letto.
«Cristina?»
Stavolta girai tutta la casa, stanza perstanza, finché arrivai nello studio.
Non c'era nessuno, però mi parve dipercepire uno strano odore nell'aria.
Fosforo. La luce che penetrava daifinestroni catturava una tenue rete difilamenti di fumo azzurrato sospesinell'aria. Entrai nello studio e trovai unpaio di cerini bruciati sul pavimento.Sentii una fitta di inquietudine e miinginocchiai davanti al baule. L'aprii esospirai, sollevato. La cartellina con ilmanoscritto era ancora lì. Stavo perchiudere il baule quando me ne accorsi.Il nodo dello spago rosso che chiudeva
la cartellina era disfatto. La presi el'aprii. Scorsi le pagine, ma mi parveche non mancasse nulla. Richiusi lacartellina, stavolta con un doppio nodo,e la rimisi a posto. Chiusi il baule escesi di nuovo nell'appartamento. Misedetti ad aspettare su una sedia insalotto, guardando il lungo corridoio checonduceva alla porta d'ingresso. I minutipassarono con infinita crudeltà.
Lentamente la coscienza di quanto eraaccaduto mi crollò addosso e queldesiderio di credere e sperare sitrasformò pian piano in fiele e amarezza.
Ben presto sentii le campane di SantaMaría suonare le due. Il treno per Parigi
aveva già lasciato la stazione e Cristinanon era tornata. Capii allora che se n'eraandata, che quelle brevi ore cheavevamo condiviso erano state unmiraggio. Guardai dietro i vetri quellagiornata abbagliante che non aveva piùil colore della buona sorte e laimmaginai di ritorno a Villa Helius, acercare protezione tra le braccia diPedro Vidal. Sentii che il rancore mistava avvelenando il sangue a poco apoco e risi di me stesso e delle mieassurde speranze. Incapace di fare unsolo passo, rimasi a contemplare la cittàche si faceva scura con il tramonto e leombre che si allungavano sul pavimentodello studio. Mi alzai e mi avvicinai allafinestra. La spalancai e mi affacciai.
Davanti a me si apriva un vuotoverticale di parecchi metri, sufficienti afracassarmi le ossa, a trasformarle inpugnali che mi avrebbero attraversato ilcorpo lasciando che si spegnesse in unapozza di sangue in cortile. Mi chiesi seil dolore sarebbe stato atroce quantoimma-ginavo, o se la forza dell'impattosarebbe bastata ad addormentare i sensie a darmi una morte rapida ed efficace.
In quel momento sentii i colpi alla porta.Uno, due, tre. Bussavano con insistenza.Mi voltai, ancora stordito da queipensieri. Di nuovo i colpi.
C'era qualcuno da basso, alla mia porta.Ebbi un tuffo al cuore e mi preci-pitai
giù per le scale, convinto che Cristinafosse tornata, che lungo la strada fossesuccesso qualcosa che l'aveva trattenuta,che i miei miserabili e spregevolisentimenti di sfiducia erano statiingiustificati: quello era, dopo tutto, ilprimo giorno della nuova vita. Corsialla porta e l'aprii. Era lì, nellapenombra, vestita di bianco. Volevoabbracciarla, ma a quel punto vidi il suovolto inondato di lacrime e capii chequella donna non era Cristina.
«David» mormorò Isabella con la vocespezzata. «Il signor Sempere è morto.»
ATTO TERZO
Il gioco dell'angelo
1
Quando arrivammo alla libreria era giàscuro. Un bagliore dorato incri-nava ilnero della notte davanti alle porte diSempere e Figli, dove un centinaio dipersone si erano riunite con dellecandele in mano. Alcuni piangevano insilenzio, altri si scambiavano sguardisenza sapere cosa dire. Riconobbiqualche volto, amici e clienti diSempere, persone a cui il vecchio avevaregalato libri e che aveva iniziato allalettura. Via via che la notizia si spargevaper il quartiere, arrivavano altri clienti eamici che non riuscivano a credere cheil signor Sempere fosse morto.
Le luci della libreria erano accese eall'interno si poteva vedere don GustavoBarceló abbracciare con forza un uomogiovane che a stento si reggeva in piedi.Non mi resi conto che era il figlio diSempere finché Isabella non mi preseper mano e mi condusse dentro lalibreria. Vedendomi entrare, Barcelóalzò gli occhi e mi rivolse un sorrisosconfitto. Il figlio del libraio piangevatra le sue braccia e non ebbi il coraggiodi salutarlo. Fu Isabella ad avvicinarsi alui e a posargli la mano sulla spalla.Sempere figlio si girò e vidi il suo voltoabbattuto. Isabella lo guidò verso unasedia e lo aiutò a sedersi. Il figlio dellibraio vi crollò sopra come un pupazzorotto.
Isabella si chinò accanto a lui e loabbracciò. Non mi ero mai sentito tantoorgoglioso di qualcuno quanto lo fui inquel momento di Isabella, che non misembrava più una ragazza ma una donna,più forte e saggia di tutti noi cheeravamo lì.
Barceló si avvicinò e mi tese la manotremante. Gliela strinsi.
«È successo un paio d'ore fa» spiegòcon voce rauca. «Era rimasto solo perun momento in libreria e quando suofiglio è tornato... Dicono che stavalitigando con qualcuno... Non so.Secondo il dottore è stato il cuore.»
Deglutii.
«Dov'è?»
Barceló indicò con la testa la porta delretrobottega. Annuii e mi diressi lì.Prima di entrare, respirai a fondo estrinsi i pugni. Oltrepassai la soglia e lovidi. Era steso su un tavolo, con le maniincrociate sul ventre. Aveva la pellebianca come la carta e i tratti del visosembravano essersi infossati, come sefossero stati di cartone. Aveva ancoragli occhi aperti. Mi accorsi che mimancava l'aria e sentii come se qualcosami colpisse con enorme violenza allostomaco. Mi appoggiai al tavolo erespirai a fondo. Mi chinai su di lui e glichiusi le palpebre. Gli accarezzai laguancia, che era gelida, e guardai
attorno a me quel mondo di pagine e disogni che lui aveva creato.
Volli credere che Sempere fosse ancoralì, fra i suoi libri e i suoi amici.
Sentii dei passi alle mie spalle e mivoltai. Barceló scortava un paio diuomini vestiti di nero dall'aspetto cupo,la cui professione non lasciava adito adubbi.
«Questi signori sono delle pompefunebri» disse Barceló.
I due salutarono annuendo con gravitàprofessionale e si avvicinarono aesaminare il corpo. Uno di loro, alto emagro, fece un esame molto sommario e
segnalò qualcosa al collega, che annuì eannotò le indicazioni su un bloc notes.
«In linea di principio il funerale saràdomani pomeriggio, al cimitero delEste» disse Barceló. «Ho preferito farmicarico io della questione perché il figlioè distrutto, l'ha visto. E in queste cose,quanto prima...»
«Grazie, don Gustavo.»
Il libraio lanciò un'occhiata al suovecchio amico e sorrise fra le lacrime.
«E cosa faremo adesso che il vecchio ciha lasciati soli?» disse.
«Non lo so...»
Uno degli addetti delle pompe funebritossicchiò discretamente, facendointendere che aveva qualcosa dacomunicare.
«Se siete d'accordo, il mio collega e ioandremmo adesso a prendere la cassae...»
«Faccia quello che deve fare» lointerruppi.
«Qualche preferenza riguardo al ritofunebre?»
Lo guardai senza capire.
«Il defunto era credente?»
«Il signor Sempere credeva nei libri»dissi.
«Capisco» disse mentre si ritirava.
Guardai Barceló, che si strinse nellespalle.
«Mi faccia domandare al figlio»aggiunsi.
Ritornai in libreria. Isabella mi lanciòun'occhiata inquisitoria e si alzò,lasciandomi il posto accanto a Semperefiglio. Mi si avvicinò e le sussurrai imiei dubbi.
«Il signor Sempere era un buon amicodel parroco della chiesa di Santa Ana,
qui vicino. Corre voce che quelli delvescovado vogliono cacciarlo da anniperché è ribelle e indisciplinato, ma ètanto vecchio che hanno preferitoaspettare che muoia per i fatti suoiperché con lui non riescono ad averlavinta.»
«È l'uomo di cui abbiamo bisogno»dissi.
«Ci parlo io» disse Isabella.
Indicai Sempere figlio.
«Come sta?»
Isabella mi guardò negli occhi.
«E lei?»
«Bene» mentii. «Chi rimane con luistanotte?»
«Io» disse senza esitare un istante.
Annuii e la baciai sulla guancia prima ditornare nel retrobottega. Barceló si eraseduto di fronte al suo vecchio amico.
Mentre i due addetti delle pompe funebriprendevano misure e chiedevano discarpe e vestiti, versò due bicchieri dibrandy e me ne diede uno. Mi sedettiaccanto a lui.
«Alla salute dell'amico Sempere, cheinsegnò a tutti noi a leggere, quando nona vivere» disse.
Brindammo e bevemmo in silenzio.Restammo lì finché gli addettidell'agenzia funeraria rientrarono con labara e i vestiti con cui Sempere sarebbestato seppellito.
«Se siete d'accordo, ce ne occupiamonoi» suggerì quello che pareva piùsveglio. Annuii. Prima di tornare in
libreria raccolsi la vecchia copia diGrandi speranze che non mi ero mairipreso e la misi tra le mani del signorSempere.
«Per il viaggio» dissi.
Dopo un quarto d'ora gli addettidell'agenzia sollevarono il feretro e lodepositarono su un grande tavolodisposto al centro della libreria. Unafolla di persone si era riunita in strada eattendeva in un profondo silenzio.
Andai verso le porte della libreria e leaprii. A uno a uno, gli amici di Semperee Figli sfilarono all'interno del negozioper vedere il libraio. Più d'uno nonriusciva a trattenere le lacrime. Di fronte
a quello spettacolo, Isabella prese permano il figlio e se lo portò nella casa,proprio sopra la libreria, dove avevavissuto con il padre per tutta la vita.Barceló e io restammo lì, a farcompagnia al vecchio Sempere mentrela gente veniva a salutarlo per l'ultimavolta. Alcuni, i più intimi, sitrattenevano. La veglia durò tutta lanotte. Barceló rimase fino alle cinquedel mattino e io fino a quando Isabellascese, poco dopo l'alba, e mi ordinò diandarmene a casa, almeno per lavarmi ecambiarmi.
Guardai il povero Sempere e le sorrisi.Non potevo credere che oltrepas-sandoquella porta non lo avrei più trovato
dietro il bancone. Ricordai la primavolta che ero stato nella libreria, quandoero solo un ragazzino, e il libraio mi erasembrato alto e forte. Indistruttibile.L'uomo più saggio del mondo.
«Se ne vada a casa, per favore» sussurròIsabella.
«A far che?»
«Per favore...»
Mi accompagnò in strada e miabbracciò.
«So quanto lo stimava e quello chesignificava per lei» mi disse.
Nessuno lo sapeva, pensai. Nessuno.Però annuii, e dopo averla baciata sullaguancia cominciai a camminare senzameta, percorrendo strade che misembravano più vuote che mai, convintoche se non mi fossi fermato, se avessicontinuato a camminare, non mi sareireso conto che il mondo che credevo diconoscere non c'era più.
2
La folla si era riunita all'ingresso delcimitero ad aspettare l'arrivo del carrofunebre. Nessuno osava parlare. Sisentiva il rumore del mare in lontananzae l'eco di un treno merci che scivolavaverso la città di fabbriche che si
estendeva alle spalle del camposanto.Faceva freddo e granelli di nevefluttuavano nel vento. Poco dopo le tredel pomeriggio il carro funebre, tiratoda cavalli neri, imboccò un'avenida deIcària fiancheggiata da cipressi e vecchimagazzini. Il figlio di Sempere eIsabella viaggiavano con lui. Seicolleghi della associazione dei librai diBarcellona, tra i quali don Gustavo,sollevarono il feretro sulle spalle e lotrasportarono all'interno del cimitero. Lagente li seguì, formando una comitivasilenziosa che percorse le strade e ipadiglioni sotto un manto di nuvolebasse che ondeggiavano come unalamina di mercurio. Sentii qualcuno direche il figlio del libraio sembrava
invecchiato di quindici anni in una solanotte. Lo chiamavano il signor Sempere,perché adesso era lui il responsabiledella libreria, e per quattro generazioniquel bazar incantato di calle Santa Ananon aveva mai cambiato nome ed erasempre stato diretto da un signorSempere. Isabella lo teneva per ilbraccio e mi parve che, se non ci fossestata lei, sarebbe crollato come unburattino privo di fili.
Il parroco della chiesa di Santa Ana, unveterano dell'età del defunto, aspettavadavanti al sepolcro, una lastra di marmosobria e senza orpelli che passava quasiinavvertita. I sei librai che avevanoportato il feretro lo depositarono davanti
alla tomba. Barceló, che mi aveva visto,mi salutò con un cenno del capo. Preferiirimanere indietro, non so se pervigliaccheria o per rispetto. Da lìpotevo vedere la tomba di mio padre, auna trentina di metri. Una volta che lafolla si fu schierata attorno al feretro, ilparroco alzò gli occhi e sorrise.
«Il signor Sempere e io siamo statiamici per quasi quarant'anni, e in tuttoquesto tempo abbiamo parlato di Dio edei misteri della vita una sola volta.Quasi nessuno lo sa, però il signorSempere non era più stato in chiesa dalfunerale di sua moglie Diana, al cuifianco lo accompagniamo oggi affinchériposino uno accanto all'altra per
sempre. Forse per questo tutti loprendevano per un ateo, ma lui era unuomo di fede. Credeva nei suoi amici,nella verità delle cose e in qualcosa acui non osava dare un nome e un voltoperché diceva che per far questoc'eravamo noi preti. Il signor Semperecredeva che tutti facciamo parte diqualcosa, e che, lasciando questomondo, i nostri ricordi e i nostridesideri non vanno perduti, madiventano i ricordi e i desideri di chiprende il nostro posto. Non sapeva seavevamo creato Dio a nostra immagine esomiglianza, o se lui aveva creato noisenza sapere bene quello che faceva.Credeva che Dio, o chiunque ci abbiamesso qui, vive in ciascuna delle nostre
azioni, in ciascuna delle nostre parole, esi manifesta in tutto ciò che ci fa esserequalcosa di più che semplici statue difango. Il signor Sempere credeva cheDio vivesse un po', o molto, nei libri eper questo dedicò la propria vita acondividerli, a proteggerli e adassicurarsi che le loro pagine, come inostri ricordi e i nostri desideri, nonandassero mai perdute, perché credeva,e fece credere anche a me, che finchéfosse rimasta una sola persona al mondocapace di leggerli e di viverli, sarebberestato un frammento di Dio o di vita. Soche al mio amico non sarebbe piaciutoche ci accomiatassimo da lui conorazioni e canti. So che gli sarebbebastato sapere che i suoi amici, tanti
quanti sono venuti qui oggi a salutarlo,non l'avrebbero mai dimenticato. Non hodubbi che il Signore, sebbene il vecchioSempere non se l'aspettasse, accoglieràaccanto a sé il nostro caro amico, e soche vivrà per sempre nei cuori di tutti ipresenti, di tutti coloro che un giornoscoprirono la magia dei libri grazie alui, e di tutti coloro che, anche senzaconoscerlo, un giorno oltre-passerannole porte della sua piccola libreria, dove,come a lui piaceva dire, la storia èappena cominciata. Riposi in pace,Sempere, amico mio, e che Dio concedaa tutti noi l'opportunità di onorare la suamemoria e il privilegio di averlaconosciuta.»
Un infinito silenzio pervase il cimiteroquando il parroco finì di parlare earretrò di qualche passo, benedicendo labara e abbassando lo sguardo. A unsegnale del capo degli addetti dellepompe funebri, i becchini si feceroavanti e calarono il feretro lentamentecon delle corde. Ricordo il rumore dellabara che toccava il fondo e i singhiozzisoffocati della gente. Ricordo che rimasilì, incapace di fare un passo, osservandoi becchini che ricoprivano la tomba conla grande lastra di marmo su cui sileggeva solo la parola Sempere e nellaquale sua moglie Diana giaceva daventisei anni.
Lentamente, la folla si ritirò verso le
porte del cimitero, dove si divise ingruppi che non sapevano dove andare,perché nessuno voleva muoversi da lì elasciare il povero signor Sempere.Barceló e Isabella, uno per lato, siportarono via il figlio del libraio.Rimasi lì fin quando tutti si furono allon-tanati e solo allora osai avvicinarmi allatomba di Sempere. Mi inginocchiai epoggiai la mano sul marmo.
«A presto» mormorai.
Lo sentii avvicinarsi e seppi che era luiprima di vederlo. Mi alzai e mi voltai.Pedro Vidal mi offrì la mano e il sorrisopiù triste che avessi mai visto.
«Non mi stringi la mano?» domandò.
Non lo feci, e qualche secondo dopoVidal annuì tra sé e ritirò la sua.
«Cosa ci fa lei qui?» sbottai.
«Sempere era anche mio amico»replicò.
«Già. Ed è solo?»
Vidal mi guardò senza capire.
«Dov'è?» chiesi.
«Chi?»
Mi lasciai sfuggire una risata amara.Barceló, che ci aveva visto, si stavaavvicinando con aria costernata.
«Cosa le ha promesso adesso percomprarla?»
Lo sguardo di Vidal s'indurì.
«Non sai quello che dici, David.»
Avanzai fino a sentire il suo fiato sullafaccia.
«Dov'è?» insistetti.
«Non lo so» rispose.
«Certo» dissi distogliendo lo sguardo.
Mi girai, pronto a incamminarmi versol'uscita, ma Vidal mi afferrò per ilbraccio e mi fermò.
«David, aspetta...»
Prima che mi rendessi conto di quelloche stavo facendo, mi girai e lo colpiicon tutte le mie forze. Il mio pugno sischiantò sul suo volto e lo vidi cadereall'indietro. Mi accorsi del sangue sullamano e sentii dei passi che siavvicinavano in tutta fretta. Un paio dibraccia mi afferrarono e mi sepa-raronoda Vidal.
«Per l'amor di Dio, Martín...» disseBarceló.
Il libraio si accovacciò accanto a Vidal,che aveva la bocca piena di sangue eansimava. Gli sostenne la testa e milanciò un'occhiata furiosa. Me ne andai
in tutta fretta, incrociando lungo lastrada alcuni partecipanti alla cerimoniache si erano fermati a osservare illitigio. Non ebbi il coraggio di guardarliin faccia.
3
Passai diversi giorni senza uscire dicasa, dormendo fuori orario, senza quasitoccare cibo. Di notte mi sedevo insalotto davanti al fuoco e ascol-tavo ilsilenzio, sperando di sentire dei passialla porta, convinto che sarebbe arrivataCristina, che appena avesse saputo dellamorte del signor Sempere sarebbetornata al mio fianco, anche se solo percompassione, che a quel punto già mi
sarebbe bastata. Quando era trascorsaquasi una settimana dalla morte dellibraio e sapevo ormai che Cristina nonsarebbe venuta, cominciai a salire dinuovo nello studio. Recuperai dal bauleil manoscritto per il principale e iniziaia rileggerlo, assaporando ogni frase eogni paragrafo. La lettura mi ispirò allostesso tempo nausea e un'oscurasoddisfazione. Quando pensavo aicentomila franchi che all'inizio mi eranosembrati tanti, sorridevo tra me e midicevo che quel figlio di cagna mi avevacomprato per pochissimo. La vanitàappannava l'amarezza, e il dolorechiudeva le porte alla coscienza. In unatto di superbia, rilessi quel LuxAeterna del mio predecessore, Diego
Marlasca, e poi lo consegnai allefiamme del camino. Dove lui avevafallito, io avrei trionfato. Dove lui si eraperso lungo la strada, io avrei trovatol'uscita del labirinto.
Tornai al lavoro il settimo giorno. Attesila mezzanotte e mi sedetti alla scrivania.Un foglio bianco nel tamburo dellavecchia Underwood e la città scuradietro le finestre. Le parole e leimmagini mi sgorgarono dalle manicome se avessero aspettato con rabbianella prigione dell'anima. Le paginefluivano senza coscienza né misura,senza altra volontà se non quella distregare e avvelenare i sensi e ipensieri. Avevo smesso di pensare al
principale, alla sua ricompensa o allesue esigenze. Per la prima volta nellavita scrivevo per me e non per qualcunaltro. Scrivevo per dar fuoco al mondo econsumarmi con lui. Lavoravo tutte lenotti fino a crollare esausto. Battevosulla tastiera della macchina fino aquando le dita mi sanguinavano e lafebbre mi annebbiava la vista.
Una mattina di gennaio in cui avevoormai perduto la nozione del temposentii bussare alla porta. Ero steso sulletto, lo sguardo perduto nella vecchiafoto di Cristina bambina che camminavaper mano a uno sconosciuto su quelmolo che si addentrava in un mare diluce, in quell'immagine che ormai mi
sembrava l'unica cosa bella che mirestasse e la chiave di tutti i misteri.Ignorai i colpi alla porta per diversiminuti finché sentii la sua voce e seppiche non si sarebbe arresa.
«Apra una buona volta. So che è lì e nonme ne vado fin quando non apre la portao non la butto giù io.»
Quando aprii, Isabella fece un passoindietro e mi guardò inorridita.
«Sono io, Isabella.»
Mi scostò e andò dritta in salotto aspalancare le finestre. Poi si diresse inbagno e cominciò a riempire la vasca.Mi prese per il braccio e mi trascinò fin
lì. Mi fece sedere sul bordo e mi guardònegli occhi, sollevando-mi le palpebrecon le dita e scuotendo la testa. Senzadire una parola, cominciò a togliermi lacamicia.
«Isabella, non sono dell'umore giusto.»
«Cosa sono questi tagli? Cosa si èfatto?»
«Sono solo graffi.»
«Voglio che la veda un dottore.»
«No.»
«A me non si azzardi a dire di no»replicò con durezza. «Adesso si ficca
nella vasca, ci dà dentro con acqua esapone e poi si rade la barba. Ha dueopzioni: o lo fa lei o lo faccio io. Noncreda che avrei degli scrupoli.»
Sorrisi.
«Lo so.»
«Faccia come le ho detto. Io intantovado a cercare un dottore.»
Stavo per dire qualcosa, ma lei alzò lamano e mi zittì.
«Non dica nemmeno una parola. Secrede di essere l'unico a soffrire, sisbaglia. E se non le importa lasciarsimorire come un cane, almeno abbia la
decenza di ricordare che ad altri inveceimporta, anche se in verità non soperché.»
«Isabella...»
«In acqua. E mi faccia il piacere ditogliersi i pantaloni e le mutande.»
«Me lo so fare il bagno.»
«Non si direbbe.»
Mentre Isabella andava a cercare unmedico, mi arresi ai suoi ordini e misottoposi a un battesimo di acqua freddae sapone. Non mi facevo la barba dalfunerale e il mio aspetto nello specchioera quello di un lupo. Avevo gli occhi
iniettati di sangue e la pelle di unpallore malaticcio. Indossai vestiti pulitie mi sedetti ad aspettare in salotto.Isabella tornò dopo venti minuti incompagnia di un dottore che mi erasembrato di vedere qualche volta in giroper il quartiere.
«Questo è il paziente. Non dia retta aquello che le dirà, perché è unbugiardo» annunciò Isabella.
Il medico mi squadrò con un'occhiata,calibrando il mio grado di ostilità.
«Faccia pure, dottore. Come se io non cifossi.»
Iniziò il bizantino rituale di misurazione
della pressione, auscultazioni varie,esame delle pupille e della bocca,domande di natura misteriosa e sguardidi sbieco che costituiscono la base dellascienza medica. Quando esaminò i tagliche Irene Sabino mi aveva fatto sul pettocon un coltello, inarcò un sopracciglio emi guardò.
«E questi?»
«È lungo da spiegare, dottore.»
«Se li è fatti lei?»
Scossi la testa.
«Le do una pomata, ma temo che leresteranno le cicatrici.»
«Credo che l'intenzione fosse proprioquesta.»
Il medico proseguì nella visita. Io misottomisi a tutto, docile, guardandoIsabella, che osservava ansiosa dallasoglia. Capii quanto mi era mancata equanto apprezzavo la sua compagnia.
«Bello spavento» mormorò condisapprovazione.
Il dottore mi esaminò le mani e aggrottòle sopracciglia quando vide ipolpastrelli quasi in carne viva. Me libendò a uno a uno, mormorando tra sé.
«Da quant'è che non mangia?»
Mi strinsi nelle spalle. Il medicoscambiò un'occhiata con Isabella.
«Non c'è motivo di allarmarsi, mavorrei visitarla nel mio studio domani alpiù tardi.»
«Temo che non sarà possibile, dottore»dissi.
«Ci sarà» assicurò Isabella.
«Nel frattempo le raccomando dicominciare a mangiare qualcosa dicaldo, prima brodini e poi roba solida,molta acqua, ma niente caffè o ecci-tanti,e soprattutto riposo. Prenda un po' d'ariae di sole, ma senza fare sforzi. Leipresenta un quadro classico di
esaurimento e disidratazione, e un iniziodi anemia.»
Isabella sospirò.
«Non è niente» azzardai.
Il dottore mi guardò dubbioso e si alzò.
«Domani nel mio studio, alle quattro.Qui non ho gli strumenti né le condizioniper poterla esaminare bene.»
Chiuse la valigetta e mi salutò congentilezza. Isabella lo accompagnòall'uscita e li sentii mormorare sulpianerottolo per un paio di minuti. Mirivestii e aspettai come un bravopaziente, seduto sul letto. Sentii la porta
che si chiudeva e i passi del medico giùper le scale. Sapevo che Isabella eranell'ingresso, aspettando qualchesecondo prima di entrare in camera daletto. Quando alla fine lo fece, l'accolsicon un sorriso.
«Le preparo qualcosa da mangiare.»
«Non ho appetito.»
«Non me ne importa. Adesso mangiaqualcosa e poi usciamo a prendere unpo' d'aria. Punto.»
Mi preparò un brodo in cui, facendo unosforzo, misi dei tozzi di pane e cheinghiottii con aria affabile anche sesapeva di pietre. Lasciai il piatto pulito
e lo mostrai a Isabella, che avevamontato la guardia come un sergente difianco a me mentre mangiavo. Subitodopo mi portò in camera da letto e cercòun cappotto nell'armadio. Mi mise guantie sciarpa e mi spinse fino alla porta.Quando uscimmo nell'androne c'era unvento freddo, però il cielo brillava conun sole al crepuscolo che spruzzava lestrade di ambra.
Mi prese per il braccio e cominciammoa camminare.
«Come due fidanzati» dissi.
«Molto spiritoso.»
Andammo fino al Parque de la
Ciudadela e ci addentrammo nei giardiniche circondavano il pergolato. Arrivatiallo stagno della grande fontana cisedemmo su una panchina.
«Grazie» mormorai.
Isabella non rispose.
«Non ti ho chiesto come stai» aggiunsi.
«Non è una novità.»
«Come stai?»
Isabella si strinse nelle spalle.
«I miei genitori sono felicissimi daquando sono tornata. Dicono che lei ha
avuto una buona influenza. Sesapessero... Comunque, andiamo piùd'accordo. Del resto, non è che li vedamolto. Passo quasi tutto il tempo inlibreria.»
«E Sempere? Come ha preso la mortedel padre?»
«Non molto bene.»
«E con lui come va?»
«È un brav'uomo» disse.
Isabella restò a lungo in silenzio eabbassò la testa.
«Mi ha chiesto di sposarlo» disse. «Un
paio di giorni fa, al Quatre Gats.»
Guardai il suo profilo, sereno e giàprivo di quell'innocenza giovanile cheavevo voluto vedere in lei e cheprobabilmente non c'era mai stata.
«E allora?» chiesi alla fine.
«Gli ho risposto che ci avrei pensato.»
«E lo farai?»
Gli occhi di Isabella erano persi nellafontana.
«Mi ha detto che vuole costruirsi unafamiglia, avere figli... Che vivre-monella casa sopra la libreria, e tireremo
avanti nonostante i debiti del signorSempere.»
«Be', sei ancora giovane...»
Inclinò la testa e mi guardò negli occhi.
«Lo ami?»
Sorrise con infinita tristezza.
«Che ne so? Credo di sì, anche se nontanto quanto lui crede di amare me.»
«A volte, in circostanze difficili, si puòconfondere la compassione con l'amore»dissi.
«Non si preoccupi per me.»
«Ti chiedo solo di prenderti un po' ditempo.»
Ci guardammo, al riparo di un'infinitacomplicità che non aveva più bisogno diparole, e l'abbracciai.
«Amici?»
«Finché morte non ci separi.»
4
Di ritorno a casa, ci fermammo in unnegozio di alimentari di calle Comercioa comprare latte e pane. Isabella midisse che avrebbe chiesto a suo padre diportarmi un pacco di cibi raffinati e cheavrei fatto meglio a man-giarli tutti.
«Come vanno le cose in libreria?»chiesi.
«Le vendite sono calate moltissimo. Iocredo che alla gente faccia pena venireperché si ricorda del povero signorSempere. E la verità è che, con questiconti, le cose non vanno per nientebene.»
«Come sono i conti?»
«In rosso. In queste settimane, lavorandolì, ho dato un'occhiata ai bilan-ci e hoverificato che il signor Sempere, riposiin pace, era un disastro. Re-galava libria chi non poteva pagarli. O li prestava enon glieli restituivano.
Comprava collezioni che sapeva di nonpoter vendere perché i proprietariminacciavano di bruciarle o di buttarlevia. Manteneva a forza di elemosi-ne unmucchio di poetastri di mezza tacca chenon sapevano dove andare a sbattere. Epuò immaginarsi il resto.»
«Creditori in vista?»
«Un paio al giorno, senza contare lelettere e gli avvisi della banca. La buonanotizia è che non ci mancano offerte.»
«Di acquisto?»
«Un paio di salumieri di Vic sono moltointeressati ai locali.»
«E Sempere figlio cosa dice?»
«Che del maiale non si butta niente. Ilrealismo non è il suo forte. Dice che cela faremo, che devo avere fede.»
«E non ce l'hai?»
«Ho fede nell'aritmetica, e quandofaccio i conti mi risulta che fra due mesila vetrina della libreria sarà piena disalami, budella e salsicce bianche.»
«Troveremo una soluzione.»
Isabella sorrise.
«Mi aspettavo che lo dicesse. Eparlando di conti in sospeso, mi dica
che non sta più lavorando per il suoprincipale.»
Mostrai le mani pulite.
«Sono di nuovo una persona libera»dissi.
Mi accompagnò su per le scale, equando stava per salutarmi la vidiesitare.
«Cosa c'è?» domandai.
«Avevo pensato di non dirglielo, però...Preferisco che lo sappia da me e non daaltri. Riguarda il signor Sempere.»
Entrammo e ci sedemmo in salotto
davanti al fuoco, che Isabella ravvivòmettendoci un paio di ciocchi. Le ceneridel Lux Aeterna di Marlasca eranoancora lì e la mia ex assistente mi lanciòun'occhiata che avrei potuto in-corniciare.
«Cosa mi stavi dicendo di Sempere?»
«L'ho saputo da don Anacleto, uno deivicini. Mi ha raccontato che la sera incui il signor Sempere è morto l'hasentito litigare con qualcuno in negozio.Lui stava tornando a casa e dice che levoci si sentivano dalla strada.»
«Con chi litigava?»
«Una donna. Un po' anziana. Don
Anacleto ha l'impressione di non averlamai vista da quelle parti, anche se glirisultava vagamente familiare, però condon Anacleto non si sa mai, perché glipiacciono di più gli avverbi che iconfetti.»
«Ha sentito su cosa litigavano?»
«Gli è sembrato che parlassero di lei.»
«Di me?»
Isabella annuì.
«Il figlio era uscito un momento a fareuna consegna in calle Canuda. È
stato via solo dieci o quindici minuti.
Tornando ha trovato suo padre a terra,dietro il bancone. Respirava ancora, maera freddo. Quando è arrivato il medicoera già tardi...»
Mi parve che il mondo mi crollasseaddosso.
«Non avrei dovuto dirglielo...»mormorò Isabella.
«No. Hai fatto bene. Don Anacleto nonha detto nient'altro su quella donna?»
«Solo che li ha sentiti litigare. Gli èsembrato che discutessero di un libro.Lei voleva comprarlo e il signorSempere non voleva venderglielo.»
«E perché hanno fatto il mio nome? Noncapisco.»
«Perché il libro era suo. I passi delcielo. L'unica copia che il signorSempere aveva conservato nella suacollezione personale e che non era invendita...»
Mi invase un'oscura certezza.
«E il libro...?» iniziai.
«Non c'è più. È scomparso» completòIsabella. «Ho controllato il registro,perché il signor Sempere segnava tutti ilibri che vendeva con la data e il prezzo,e non c'era.»
«Il figlio lo sa?»
«No. L'ho raccontato solo a lei. Stoancora cercando di capire cos'èsuccesso quella sera in libreria. Eperché. Pensavo che magari lei losapeva...»
«Quella donna ha cercato di portarsi viail libro con la forza, e durante la lite alsignor Sempere è venuto un attacco dicuore. Ecco cos'è successo»
dissi. «E tutto per un maledetto libromio.»
Sentii che mi si torcevano le budella.
«C'è dell'altro» disse Isabella.
«Cosa?»
«Qualche giorno dopo ho incrociato donAnacleto sulle scale. Mi ha detto disapere chi gli ricordava quella donna.Quella sera non l'aveva capito, ma glisembrava di averla già vista, tanti anniprima, a teatro.»
«A teatro?»
Isabella annuì.
«Mi ha detto di essere sicuro: la donnache ha visto quella sera in libreria eraIrene Sabino.»
Sprofondai in un lungo silenzio. Isabellami osservava, inquieta.
«Ora non sono tranquilla a lasciarla qui.Non avrei dovuto dirglielo.»
«No, hai fatto bene. Sto bene, davvero.»
Isabella scosse la testa.
«Stanotte resto con lei.»
«E la tua reputazione?»
«Quella che è in pericolo è la sua. Vadoun attimo al negozio dei miei pertelefonare in libreria e avvisare.»
«Non ce n'è bisogno, Isabella.»
«Non ce ne sarebbe bisogno se leiavesse accettato di vivere nel XX
secolo e avesse fatto mettere il telefonoin questo mausoleo. Torno fra un quartod'ora. E niente discussioni.»
In assenza di Isabella, la certezza che lamorte del mio vecchio amico Semperepesava sulla mia coscienza iniziò aghermirmi. Ricordai che il vecchiolibraio diceva sempre che i libri hannoun'anima, l'anima di chi li ha scritti e dichi li ha letti e sognati. Capii allora chefino all'ultimo istante aveva lottato perproteggermi, sacrificandosi per salvarequella carta e quell'inchiostro cheriteneva custodi della mia anima scritta.Quando Isabella tornò, carica di unaborsa di manicaretti del negozio deigenitori, le bastò guardarmi per capirlo.
«Lei conosce quella donna» disse. «Ladonna che ha ucciso il signorSempere...»
«Credo di sì. Irene Sabino.»
«Non è quella delle vecchie foto cheabbiamo trovato nella stanza in fondo?L'attrice?»
Annuii.
«E perché voleva quel libro?»
«Non lo so.»
Più tardi, dopo aver mangiato qualcheboccone dei manicaretti di Can Gispert,ci sedemmo sulla grande poltrona
davanti al camino. Ci stavamo in due eIsabella mi appoggiò la testa sulla spallamentre guardavamo il fuoco.
«L'altra notte ho sognato di avere avutoun figlio» disse. «Lui mi chiamava, maio non potevo sentirlo né raggiungerloperché ero prigioniera in un posto dovefaceva molto freddo e non potevomuovermi. Mi chiamava e io non potevocorrere da lui.»
«È solo un sogno» dissi.
«Sembrava vero.»
«Forse dovresti scrivere questa storia»azzardai.
Isabella scosse la testa.
«Ci ho pensato. E ho deciso chepreferisco vivere la vita, non scriverla.
Non se la prenda a male.»
«Mi sembra una saggia decisione.»
«E lei? La vivrà?»
«Temo che la mia vita sia già abbastanzavissuta.»
«E quella donna? Cristina?»
Respirai a fondo.
«Se n'è andata. È tornata da suo marito.
Un'altra saggia decisione.»
Isabella si scostò da me e mi guardòaggrottando le sopracciglia.
«Cosa c'è?» chiesi.
«Credo che si sbagli.»
«Riguardo a cosa?»
«L'altro giorno è venuto a trovarci donGustavo Barceló e abbiamo parlato dilei. Mi ha detto di aver incontrato ilmarito di Cristina, quel...»
«Pedro Vidal.»
«Ecco. A sentire lui, Cristina se n'era
andata con lei, non l'aveva rivista e nonne sapeva nulla da un mese o più. Ineffetti, mi ha sorpreso non trovarla quicon lei, ma non osavo chiedere...»
«Sei sicura di quello che ha dettoBarceló?»
Isabella annuì.
«Cos'ho detto adesso?» chiese Isabella,allarmata.
«Niente.»
«C'è qualcosa che non mi sta dicendo...»
«Cristina non è qui. Dal giorno in cui èmorto il signor Sempere.»
«E allora dov'è?»
«Non lo so.»
A poco a poco restammo in silenzio,rannicchiati nella poltrona davanti alcamino, e a notte inoltrata Isabella siaddormentò. La cinsi con il braccio echiusi gli occhi, pensando a tutto quelloche aveva detto e cercando di trovarciqualche significato. Quando il chiaroredell'alba incendiò la cristalliera delsalotto, aprii gli occhi e scoprii cheIsabella era già sveglia e mi guardava.
«Buon giorno» dissi.
«Ho riflettuto» azzardò.
«E allora?»
«Sto pensando di accettare la propostadel figlio del signor Sempere.»
«Sei sicura?»
«No» rise.
«Cosa diranno i tuoi genitori?»
«Ne saranno contrariati, immagino, magli passerà. Per me preferirebbe-ro unprospero mercante di salumi piuttostoche uno di libri, ma dovrannoaccontentarsi.»
«Poteva andare peggio» dissi.
Isabella annuì.
«Sì. Sarei potuta finire con unoscrittore.»
Ci guardammo a lungo, finché Isabella sialzò dalla poltrona. Prese il cappotto ese lo abbottonò dandomi le spalle.
«Devo andare» disse.
«Grazie della compagnia» risposi.
«Non se la lasci scappare» disseIsabella. «La cerchi, dovunque sia, e ledica che l'ama, anche se è una bugia. Anoi ragazze piace sentircelo dire.»
Proprio allora si voltò e si chinò per
sfiorare le mie labbra con le sue. Mistrinse forte la mano e se ne andò senzasalutare.
5
Consumai il resto di quella settimana ingiro per Barcellona alla ricerca diqualcuno che ricordasse di aver vistoCristina nell'ultimo mese. Andai neiluoghi che avevo condiviso con lei eripercorsi invano l'itinerario predilettodi Vidal per caffè, ristoranti e negozi dilusso. A chiunque incon-trassi mostravouna foto dell'album che Cristina avevalasciato a casa mia e domandavo sel'avesse vista di recente. Da qualcheparte m'imbattei in qualcuno che la
riconosceva e ricordava di averlaincrociata a volte in compagnia di Vidal.Qualcuno riusciva perfino a ricordare ilsuo nome.
Nessuno la vedeva da settimane. Alquarto giorno di ricerche iniziai asospettare che Cristina fosse uscita dallacasa della torre la mattina in cui eroandato a comprare i biglietti del treno efosse evaporata dalla faccia della terra.
Ricordai allora che la famiglia Vidalaveva una camera riservata all'HotelEspana di calle Sant Pau, dietro ilLiceo, a disposizione dei membri dellafamiglia che, nelle serate d'opera,ritenevano scomodo o non avevano
voglia di tornare a Pedralbes in pienanotte. Mi risultava che, almeno nei suoianni di gloria, lo stesso Vidal e il suosignor padre l'avevano utilizzata perintrattenersi con signorine e signore lacui presenza nella residenza ufficiale diPedralbes, sia per il basso sia per l'altolignaggio dell'interessata, avrebbe datoadito a pettegolezzi poco consigliabili.Più di una volta me l'aveva offertaquando ancora vivevo nella pensione didonna Carmen, nel caso, come dicevalui, mi fosse venuta voglia di denudarequalche signora in un posto che nonfacesse paura. Non credevo che Cristinaavesse scelto quel luogo come rifugio,se pure sapeva della sua esistenza, maera l'ultimo posto nella mia lista e non
mi veniva in mente nessun'altrapossibilità. Faceva scuro quando arrivaiall'Hotel España e chiesi di parlare conil direttore sfruttando la mia amiciziacon il signor Vidal. Quando gli mostraila foto di Cristina, il direttore, un uomoche la discrezione rendeva di ghiaccio,mi sorrise cortese e mi disse che "altri"dipendenti del signor Vidal erano giàvenuti a chiedere di quella personaqualche settimana prima e che avevadetto loro le stesse cose che diceva ame. Non aveva mai visto quella signoranel suo albergo. Lo ringraziai per la suagentilezza glaciale e m'incamminaisconfitto verso l'uscita.
Passando davanti alla porta a vetri che
dava al ristorante, mi sembrò diregistrare un profilo familiare con lacoda dell'occhio. Il principale eraseduto a uno dei tavoli, unico cliente intutto il ristorante, e degustava quelle chesembravano zollette di zucchero per ilcaffè. Stavo per sparire in tutta frettaquando si voltò e mi salutò con la mano,sorridendo. Maledissi la mia sfortuna egli restituii il saluto. Il principale mifece cenno di unirmi a lui. Mi trascinaifino alla porta del ristorante ed entrai.
«Che piacevole sorpresa trovarla qui,caro amico. Stavo proprio pensando alei» disse Corelli.
Gli strinsi la mano di malavoglia.
«La credevo fuori città» osservai.
«Sono tornato prima del previsto. Possooffrirle qualcosa?»
Scossi la testa. Mi invitò a sedermi alsuo tavolo e io obbedii. Comed'abitudine, il principale indossava uncompleto con gilet di lana nero e unacravatta di seta rossa. Impeccabilecom'era di rigore in lui, ma questa voltac'era qualcosa che non quadrava. Cimisi qualche secondo a notarlo. Nonaveva sul risvolto la spilla con l'angelo.Corelli seguì il mio sguardo e annuì.
«Purtroppo l'ho persa, e non so dove»spiegò.
«Spero che non fosse troppo preziosa.»
«Il suo valore era puramentesentimentale. Ma parliamo di cose piùimportanti. Come sta, amico mio? Misono mancate molto le nostreconversazioni, nonostante i disaccordioccasionali. È difficile incontrare buoniconversatori.»
«Lei mi sopravvaluta, signor Corelli.»
«Al contrario.»
Ci fu un breve silenzio, senza altracompagnia che quello sguardo senzafondo. Mi dissi che lo preferivo quandosi imbarcava in una conversazionebanale. Quando smetteva di parlare, il
suo aspetto cambiava e l'aria attorno alui si faceva pesante.
«Ha preso alloggio qui?» domandai perspezzare il silenzio.
«No, sono sempre nella casa accanto alPark Güell. Ho dato appuntamento qui aun amico, ma sembra sia in ritardo. Lamancanza di educazione di alcunepersone è deplorevole.»
«Credo non ci siano tante persone cheosino darle un bidone, signor Corelli.»
Il principale mi guardò negli occhi.
«Non molte. In realtà, l'unica che miviene in mente è lei.»
Prese una zolletta di zucchero e la fececadere nella tazza. La seguirono unaseconda e una terza. Assaggiò il caffè ece ne mise altre quattro. Poi ne preseuna quinta e se la portò alle labbra.
«Mi fa impazzire lo zucchero» disse.
«Vedo.»
«Non mi dice nulla del nostro progetto,amico mio?» tagliò corto.
«Qualche problema?»
«Ho quasi finito» dissi.
Il viso del principale s'illuminò di unsorriso che preferii eludere.
«Questa sì che è una grande notizia.Quando potrò averlo?»
«Fra un paio di settimane. Devorivederlo. Aggiustamenti e rifiniture, piùche altro.»
«Possiamo fissare una data?»
«Se vuole...»
«Cosa ne dice di venerdì 23? Accetteràper allora un invito a cena perfesteggiare il successo dell'impresa?»
Mancavano esattamente due settimane alvenerdì 23 gennaio.
«D'accordo» dissi.
«Allora è confermato.»
Sollevò la sua tazza di caffè stracolmadi zucchero come se brindasse e lasvuotò d'un sorso.
«E lei?» chiese come per caso. «Cosa laporta da queste parti?»
«Cercavo una persona.»
«Qualcuno che conosco?»
«No.»
«E l'ha trovata?»
«No.»
Il principale sorrise lentamente,assaporando il mio mutismo.
«Ho l'impressione di trattenerla controla sua volontà, amico mio.»
«Sono un po' stanco, nient'altro.»
«Allora non voglio rubarle altro tempo.A volte dimentico che, anche se mi piacemolto la sua compagnia, forse la mia nonè di suo gradimento.»
Sorrisi docilmente e ne approfittai peralzarmi. Mi vidi riflesso nelle suepupille, un fantoccio pallidoimprigionato in un pozzo oscuro.
«Si riguardi, Martín. Per favore.»
«Lo farò.»
Mi accomiatai con un cenno di assenso emi diressi all'uscita. Mentre miallontanavo, sentii che si metteva inbocca un'altra zolletta e la triturava con identi.
Sulla strada verso le Ramblas vidi chele pensiline del Liceo erano accese eche una lunga fila di automobilisorvegliate da un piccolo reggimento diautisti in uniforme attendeva in strada. Icartelloni annunciavano Così fan tutte emi domandai se Vidal si fosse deciso alasciare il castello per andare al suoappuntamento. Scrutai il capannello diautisti che si era formato e non tardai ad
avvistare Pep. Gli feci segno diavvicinarsi.
«Cosa ci fa qui, signor Martín?»
«Dov'è?»
«Il signore è dentro, a vedere lospettacolo.»
«Non dico don Pedro. Cristina. Lasignora Vidal. Dov'è?»
Il povero Pep deglutì.
«Non lo so. Non lo sa nessuno.»
Mi spiegò che da settimane Vidalcercava di rintracciarla e che suo padre,
il patriarca del clan, aveva perfinoassoldato diversi membri deldipartimento di polizia per localizzarla.
«All'inizio il signore pensava che fossecon lei...»
«Non ha chiamato, o mandato unalettera, un telegramma...?»
«No, signor Martín. Glielo giuro. Siamotutti molto preoccupati, e il signore,be'... Non l'ho mai visto così da quandolo conosco. Oggi è la prima sera cheesce da quando se n'è andata lasignorina, la signora, voglio dire...»
«Ricordi se Cristina ha detto qualcosa,qualunque cosa, prima di lasciare Villa
Helius?»
«Be'...» disse Pep, abbassando il tono divoce fino a ridurla a un sussurro. «Lasentivo litigare con il signore. Lavedevo triste. Passava molto tempo dasola. Scriveva lettere e ogni giornoandava a spedirle all'ufficio postale delpaseo de la Reina Elisenda.»
«Hai parlato qualche volta con lei, dasolo?»
«Un giorno, poco prima che se neandasse, il signore mi ha chiesto diaccompagnarla in auto dal medico.»
«Era malata?»
«Non riusciva a dormire. Il dottore le haprescritto delle gocce di laudano.»
«Ti ha detto qualcosa lungo la strada?»
Pep si strinse nelle spalle.
«Mi ha chiesto di lei, se avevo suenotizie o se l'avevo vista.»
«Nient'altro?»
«Era molto triste. Si è messa a piangeree quando le ho chiesto cosa succedevami ha detto che le mancava molto suopadre, il signor Manuel...»
Lo capii in quel momento e mi maledissiper non averci pensato prima.
Pep mi guardò stranito e mi chieseperché sorridevo.
«Lei sa dov'è?» domandò.
«Credo di sì» mormorai.
Mi sembrò allora di sentire una vocedall'altro lato della strada e di notareuna figura familiare che si stagliavanell'atrio del Liceo. Vidal non avevaresistito nemmeno per il primo atto. Pepsi girò un secondo per rispondere al suopadrone e quando stava per dirmi dinascondermi io ero già scomparso nellanotte.
6
Perfino da lontano avevano l'aspettoinconfondibile delle brutte notizie.
La brace di una sigaretta nell'oscuritàdella notte, sagome appoggiate al nerodei muri e volute di vapore nel fiato ditre figure che sorvegliavano il portonedella casa della torre. L'ispettore VíctorGrandes in compagnia dei suoi dueagenti da presa, Marcos e Castelo, investe di comitato d'acco-glienza. Non civoleva molto a immaginare che avevanoscoperto il cadavere di Alicia Marlascasul fondo della piscina della sua casa diSarrià e che le mie quotazioni nella listanera erano salite di parecchi punti.Appena li vidi, mi fermai e mi confusitra le ombre della strada. Li osservai
per qualche istante, assicurandomi chenon si fossero accorti della mia presenzaad appena una cinquantina di metri.Distinsi il profilo di Grandes alla lucedel lampione appeso alla facciata.Retrocedetti lentamente al riparodell'oscurità che inondava le strade em'infilai nel primo vicolo, perdendominel groviglio di passaggi e archi dellaRibera.
Dieci minuti dopo ero alle porte dellastazione Francia. Gli sportelli dellabiglietteria erano già chiusi, ma sipotevano ancora vedere diversi treniallineati sui binari sotto la grande voltadi vetro e acciaio. Consultai il ta-bellone degli orari e vidi che, come
temevo, non erano previste partenze finoal giorno successivo. Non potevorischiare di tornare a casa e diimbattermi in Grandes e compagni.Qualcosa mi diceva che stavolta lavisita al commissariato sarebbe stata apensione completa e che nemmeno ibuoni uffici dell'avvocato Valerasarebbero riusciti a tirarmi fuori tantofacilmente come la volta prima.
Decisi di passare la notte in un albergodi mezza tacca di fronte al palazzo dellaBorsa, in plaza Palacio, dove, secondola leggenda, sopravvivevano i cadaveriviventi di ex speculatori ai qualil'avidità e l'ossessione per l'aritmeticaerano esplose in faccia, a furia di
aggirarsi per casa. Scelsi quell'antroperché pensai che lì non sarebbe venutaa cercarmi nemmeno la Parca. Miregistrai con il nome di AntonioMiranda e pagai in anticipo. Il portiere,un individuo dall'aspetto di molluscoche sembrava incrostato nella garitta cheserviva da reception, distributore diasciugamani e negozio di souvenir, midiede la chiave, una saponetta marca ElCid Campeador che puzzava divarechina e che mi parve usata, e miinformò che se avevo voglia dicompagnia femminile poteva mandarmiuna domestica soprannominata laGuercia, appena fosse tornata da unavisita a domicilio.
«La rimetterà a nuovo» assicurò.
Declinai l'offerta con la scusa di unprincipio di colpo della strega e presi lescale augurandogli la buona notte. Lastanza aveva l'aspetto e le dimensioni diun sarcofago. Una semplice occhiata mipersuase a stendermi vestito sullabranda invece di infilarmi tra le lenzuolae fraternizzare con quello che c'eradentro. Mi avvolsi in una copertasfilacciata trovata nell'armadio - e che,puzza per puzza, almeno puzzava dinaftalina - e spensi la luce, immaginandodi trovarmi nel tipo di suite che potevapermettersi qualcuno con centomilafranchi in banca. A stento riuscii achiudere occhio.
Lasciai l'albergo a metà mattinata eandai alla stazione. Comprai un bigliettodi prima classe con la speranza direcuperare in treno tutto il sonno persoin quell'antro. Mancavano ancora ventiminuti alla partenza e mi diressi alla filadi cabine dei telefoni pubblici. Dettaialla centralinista il numero che mi avevadato Ricardo Salvador, quello dei suoivicini del piano di sotto.
«Vorrei parlare con Emilio, per favore.»
«Sono io.»
«Mi chiamo David Martín. Sono amicodel signor Ricardo Salvador. Mi hadetto che potevo chiamarlo a questonumero in caso di urgenza.»
«Vediamo... Può aspettare un attimo chelo avvisiamo?»
Guardai l'orologio della stazione.
«Sì. Aspetto. Grazie.»
Trascorsero più di tre minuti, poi sentiidei passi che si avvicinavano e la vocedi Ricardo Salvador mi riempì ditranquillità.
«Martín? Sta bene?»
«Sì.»
«Grazie a Dio. Ho letto sul giornale diRoures ed ero molto preoccupato.
Dove si trova?»
«Signor Salvador, ora non ho moltotempo. Devo assentarmi dalla città.»
«Sicuro che sta bene?»
«Sì. Mi ascolti. Alicia Marlasca èmorta.»
«La vedova? Morta?»
Un lungo silenzio. Mi sembrò cheSalvador singhiozzasse e mi maledissiper avergli dato la notizia con così pocadelicatezza.
«È ancora lì?»
«Sì...»
«La chiamo per avvertirla di fare moltaattenzione. Irene Sabino è viva e mi haseguito. C'è qualcuno con lei. Credo siaJaco.»
«Jaco Corbera?»
«Non ne sono sicuro. Credo chesappiano che sono sulle loro tracce estanno cercando di far tacere tutti quelliche hanno parlato con me. Mi sembrache lei avesse ragione...»
«Ma perché Jaco sarebbe tornatoproprio adesso?» chiese Salvador.
«Non ha senso.»
«Non lo so. Ora devo andare. Volevosolo avvisarla.»
«Non si preoccupi per me. Se quel figliodi puttana viene a trovarmi, saròpreparato. Sono venticinque anni cheaspetto.»
Il capostazione annunciò con un fischiola partenza del treno.
«Non si fidi di nessuno. Ha capito? Letelefono appena torno in città.»
«Grazie di avermi chiamato, Martín.Faccia molta attenzione.»
7
Il treno cominciava a scivolare lungo ibinari quando mi rifugiai nel mioscompartimento e mi lasciai cadere sulsedile. Mi abbandonai al tiepido respirodel riscaldamento e al dolce sferragliaredel convoglio. Ci lasciammo alle spallela città attraversando la foresta difabbriche e fumaioli che la circondava esfuggendo al sudario di luce scarlattache la ricopriva. Lentamente il territorioabbandonato di hangar e treni fermi suibinari morti si diluì in una superficieinfinita di campi e colline coronati dacascine e bel-vederi, boschi e fiumi.Piccole stazioni passavano velocimentre campanili e masseriedisegnavano miraggi in lontananza.
A un certo punto del viaggio miaddormentai e quando mi svegliai il pa-esaggio era completamente cambiato.Attraversavamo scoscese vallate e rupirocciose che si ergevano tra laghi eruscelli. Il treno costeggiava grandiboschi che risalivano i fianchi dimontagne che sembravano infinite.
Dopo un po' il groviglio di montagne etunnel scavati nella pietra si sciolse inun'ampia e aperta vallata di pianuresenza fine dove branchi di cavalliselvaggi correvano sulla neve e piccolivillaggi di case di pietra si scorge-vanoin lontananza. Le vette dei Pirenei siinnalzavano sull'altro lato, con i versantiinnevati accesi nel crepuscolo color
ambra. Davanti a me, un'ac-cozzaglia dicase e palazzi si assiepava su unacollina. Il controllore si affacciò nelloscompartimento e mi sorrise.
«Prossima fermata, Puigcerdà»annunciò.
Il treno si fermò esalando una tempestadi vapore che inondò la banchina. Scesie mi vidi avvolto in quella nebbia cheodorava di elettricità. Dopo un po' sentiila campana del capostazione e ilconvoglio che riprendeva la marcia.Lentamente, mentre i vagoni sfilavanosui binari, il profilo della stazioneemerse come un miraggio attorno a me.Una sottile cortina di ne-vischio cadeva
con infinita lentezza. Un sole rossastro siaffacciava da ovest sotto la volta dinuvole e tingeva la neve come piccolebraci accese.
Mi avvicinai all'ufficio delcapostazione. Battei sui vetri e lui alzògli occhi. Aprì la porta e mi rivolse unosguardo indifferente.
«Potrebbe dirmi come trovare un postochiamato Villa San Antonio?»
Il capostazione inarcò un sopracciglio.
«La clinica?»
«Credo di sì.»
Il capostazione assunse l'espressionemeditabonda di chi valuta come dareindicazioni e indirizzi ai forestieri, poi,dopo aver passato in rassegna il propriocatalogo di gesti e smorfie, mi offrì ilseguente schizzo:
«Deve attraversare il paese,oltrepassare la piazza della chiesa earrivare al lago. Sull'altro lato troveràun lungo viale fiancheggiato da ville chefinisce nel paseo de la Rigolisa. Lì,all'angolo, c'è un grande edificio a trepiani circondato da un giardino. Quellaè la clinica.»
«E conosce qualche posto dove possoaffittare una stanza?»
«Lungo la strada, passerà davantiall'Hotel del Lago. Dica che la manda ilSebas.»
«Grazie.»
«Buona fortuna.»
Attraversai le strade solitarie del paesesotto la neve, cercando il profilo delcampanile della chiesa. Lungo ilcammino incrociai alcuni abitanti delposto che mi salutarono con un cennod'intesa e mi guardarono di sottecchi.Arrivato in piazza, un paio di garzoniche scaricavano un carro di carbone miindicarono la strada che portava al lagoe, qualche minuto dopo, imboccai unavia che costeggiava una grande laguna
ghiacciata e bianca.
Imponenti case dai torrioni acuminati edall'aria signorile circondavano il lago,e un viale punteggiato di panchine ealberi formava un nastro attorno allagrande lastra di ghiaccio in cui eranorimaste imprigionate piccole barche aremi. Mi avvicinai alla riva e mi fermaia osservare lo stagno conge-lato che sistendeva ai miei piedi. Lo strato dighiaccio doveva essere spesso un palmoe in qualche punto riluceva come vetroopaco, lasciando trapelare la corrente diacque scure che scivolava sotto lacrosta.
L'Hotel del Lago era una casona a due
piani dipinta di rosso scuro sulla rivadel lago. Prima di proseguire per la miastrada, mi fermai a prenotare una stanzaper due notti e pagai in anticipo. Ilportiere m'informò che l'albergo eraquasi vuoto e mi fece scegliere la stanza.
«La 101 ha un panorama spettacolaredell'alba sul lago» mi disse. «Ma sepreferisce la vista a nord, ho...»
«Scelga lei» tagliai corto, indifferentealla nobile bellezza di quel pae-saggiocrepuscolare.
«Allora la 101. D'estate è la preferitadalle coppie in luna di miele.»
Mi tese le chiavi di quella presunta suite
nuziale e m'informò degli orari dellacena. Gli dissi che sarei tornato piùtardi e gli chiesi se Villa San Antonioera lontana. Il portiere assunse la stessaespressione che avevo visto nelcapostazione e scosse la testa con unsorriso affabile.
«È qui vicino, a una decina di minuti. Seprende il viale alla fine di questa strada,la vedrà in fondo. La trova in unbaleno.»
Dieci minuti dopo ero alle porte di ungrande giardino disseminato di fogliesecche imprigionate nella neve. Piùavanti, Villa San Antonio si ergeva comeuna cupa sentinella avvolta nell'alone di
luce dorata che emanava dai suoifinestroni. Attraversai il giardino, con ilcuore che batteva forte e le mani sudatenonostante il freddo tagliente. Salii lescale che portavano all'ingressoprincipale. L'atrio, una sala dalpavimento a scacchi, conduceva a unascalinata sulla quale vidi una ragazzavestita da infermiera che teneva permano un uomo tremante che parevaeternamente sospeso fra due gradini,come se tutta la sua esistenza fosserimasta imprigionata in un attimo.
«Buona sera» disse una voce alla miadestra.
Aveva gli occhi neri e severi, i tratti
scolpiti senza accenno di simpatia el'espressione grave di chi ha imparato anon attendersi altro che brutte notizie.Doveva sfiorare la cinquantina esebbene indossasse la stessa uni-
forme della giovane infermiera cheaccompagnava l'anziano, tutto in leimanifestava autorità e rango.
«Buona sera. Sto cercando una personache si chiama Cristina Sagnier.
Ho motivo di credere che sia vostraospite...»
Mi osservò senza battere ciglio.
«Qui non ospitiamo nessuno, signore.
Questo non è un albergo né unresidence.»
«Mi scusi. Ho fatto un lungo viaggio percercare questa persona...»
«Non si scusi» disse l'infermiera.«Posso chiederle se è un familiare o unamico?»
«Mi chiamo David Martín. CristinaSagnier è qui? Per favore...»
L'espressione dell'infermiera si addolcì.Seguirono un'insinuazione di sorrisoamabile e un cenno d'assenso. Respirai afondo.
«Sono Teresa, la capoinfermiera del
turno di notte. Se è così gentile daseguirmi, signor Martín, l'accompagnerònell'ufficio del dottor Sanjuán.»
«Come sta la signorina Sagnier? Possovederla?»
Altro sorriso lieve e impenetrabile.
«Da questa parte, per favore.»
La stanza era un rettangolo senza finestreincassato fra quattro pareti dipinte diazzurro e illuminato da due lampadeappese al soffitto che emette-vano unaluce metallica. Gli unici tre mobili chela occupavano erano un tavolo spoglio edue sedie. L'aria odorava di disinfettantee faceva freddo.
L'infermiera l'aveva descritto come unufficio, ma dopo dieci minuti cheaspettavo da solo, ancorato a una sedia,riuscivo a vedere solo una cella.
La porta era chiusa, ma nonostante ciòpotevo sentire voci, a volte urla isolate,al di là dei muri. Iniziavo a perdere lanozione del tempo trascorso lì quando laporta si aprì ed entrò un uomo fra itrenta e i quarant'anni con un camicebianco e un sorriso gelido come l'ariache impregnava la stanza. Il dottorSanjuán, supposi. Aggirò il tavolo eprese posto sulla sedia di fronte allamia. Appoggiò le mani sul ripiano e miosservò con vaga curiosità per qualchesecondo prima di parlare.
«Mi rendo conto che ha fatto un lungoviaggio e che sarà stanco, ma mipiacerebbe sapere perché non è qui ilsignor Pedro Vidal» disse alla fine.
«Non è potuto venire.»
Il dottore mi osservava senza battereciglio, in attesa. Aveva lo sguardofreddo e l'atteggiamento particolare dichi non sente, ma ascolta.
«Posso vederla?»
«Non può vedere nessuno se prima nonmi dice la verità e io non so cosa ci faqui.»
Sospirai e annuii. Non avevo fatto
centocinquanta chilometri per mentire.
«Mi chiamo Martín, David Martín. Sonoamico di Cristina Sagnier.»
«Qui la chiamiamo signora Vidal.»
«Non me ne importa di come lachiamate. Voglio vederla. Adesso.»
Il dottore sospirò.
«Lei è lo scrittore?»
Mi alzai impaziente.
«Che specie di posto è questo? Perchénon posso vederla subito?»
«Si sieda. Per favore. La prego.»
Indicò la sedia e aspettò che miaccomodassi di nuovo.
«Posso chiederle quando è stata l'ultimavolta che l'ha vista o che le ha parlato?»
«Più di un mese fa» risposi. «Perché?»
«Sa se qualcuno l'ha vista o le ha parlatodopo di lei?»
«No. Non lo so. Cosa sta succedendoqui?»
Il dottore si portò la mano destra allelabbra, calibrando le parole.
«Signor Martín, temo di avere bruttenotizie.»
Sentii che mi si formava un nodo allabocca dello stomaco.
«Cosa le è successo?»
Il dottore mi guardò senza rispondere eper la prima volta mi sembrò diintravedere un accenno di dubbio neisuoi occhi.
«Non lo so» disse.
Percorremmo un corridoio fiancheggiatoda porte di metallo. Il dottor Sanjuán miprecedeva con un mazzo di chiavi inmano. Mi parve di sentire delle voci
dietro le porte che sussurravano alnostro passaggio, soffocate tra risate epianti. La stanza era alla fine delcorridoio, il dottore aprì la porta e sifermò sulla soglia, fissandomi con unosguardo privo di espressione.
«Quindici minuti» disse.
Entrai e sentii il dottore chiudere laporta alle mie spalle. Davanti a me c'eraun locale dai soffitti alti e dalle paretibianche che si riflettevano in unpavimento di piastrelle brillanti. Su unlato c'era un letto dalla strutturametallica avvolto in una tenda di garza,vuoto. Un ampio finestrone contemplavail giardino innevato, gli alberi e, in
lontananza, il contorno del lago.
Non la notai finché non mi avvicinai diqualche passo.
Era seduta su una poltrona davanti allafinestra. Indossava un camicione biancoe portava i capelli raccolti in unatreccia. Aggirai la poltrona e la guardai.I suoi occhi rimasero immobili. Quandomi accovacciai al suo fianco non battéciglio. Quando posai la mano sulla suanon mosse un solo muscolo del corpo.Notai allora le bende che le ricoprivanole braccia, dal polso al gomito, e i lacciche la tenevano legata alla poltrona. Leaccarezzai la guancia raccogliendo unalacrima che le scorreva sul viso.
«Cristina» mormorai.
Il suo sguardo rimase imprigionato daqualche parte, indifferente alla miapresenza. Avvicinai una sedia e misedetti di fronte a lei.
«Sono David» mormorai.
Per un quarto d'ora restammo così, insilenzio, la sua mano nella mia, il suosguardo smarrito e le mie parole senzarisposta. A un certo punto avvertii che laporta si apriva di nuovo e sentiiqualcuno stringermi il braccio condelicatezza e tirarmi via. Era il dottorSanjuán. Mi lasciai condurre incorridoio senza opporre resistenza. Ildottore chiuse la porta e mi riaccom-
pagnò in quell'ufficio gelido. Mi lasciaicadere sulla sedia e lo guardai, incapacedi articolare parola.
«Vuole che la lasci solo qualcheminuto?» domandò.
Annuii. Il dottore si ritirò e socchiuse laporta mentre usciva. Mi guardai la manodestra, che stava tremando, e la chiusi apugno. A stento avvertivo il freddo diquella stanza, e non riuscii a sentire leurla e le voci che trapelavano dai muri.Seppi solo che mi mancava l'aria e chedovevo andar via da quel posto.
8
Il dottor Sanjuán mi trovò nel ristorante
dell'Hotel del Lago, seduto davanti alcamino e in compagnia di un piatto chenon avevo assaggiato. Non c'era nessunaltro nella sala, tranne una camerierache girava per i tavoli deserti e lustravacon uno strofinaccio le posate sulletovaglie. Dietro i vetri si era fatto scuroe la neve cadeva lentamente, comepolvere di vetro az-zurrino. Il dottore siavvicinò al mio tavolo e mi sorrise.
«Immaginavo di trovarla qui» disse.«Tutti i forestieri ci finiscono. Io ci hopassato la mia prima notte in paesequando sono arrivato, dieci anni fa.
Che stanza le hanno dato?»
«A quanto pare la preferita dalle coppie
in luna di miele, con vista sul lago.»
«Non ci creda. Lo dicono di tutte lestanze.»
Fuori dalla clinica e senza il camicebianco, il dottor Sanjuán si presentavapiù rilassato e affabile.
«Senza l'uniforme, quasi non l'avevoriconosciuta» azzardai.
«La medicina è come l'esercito. Senzaabito, niente monaco» replicò.
«Come sta?»
«Bene. Ho passato giorni peggiori.»
«Già. Mi è mancato prima, quando sonotornato in ufficio a cercarla.»
«Avevo bisogno di un po' d'aria.»
«Capisco. Ma contavo sul fatto chefosse meno impressionabile.»
«Perché?»
«Perché ho bisogno di lei. O meglio, èCristina ad averne bisogno.»
Deglutii.
«Penserà che sono un vigliacco» dissi.
Il dottore scosse la testa.
«Da quanto tempo sta così?»
«Da settimane. Praticamente da quandoè arrivata. Ed è peggiorata con il passardel tempo.»
«È cosciente di dove si trova?»
Il dottore si strinse nelle spalle.
«Difficile saperlo.»
«Cosa le è successo?»
Il dottor Sanjuán sospirò.
«Quattro settimane fa l'hanno trovata nonmolto lontano da qui, nel cimitero delpaese, stesa sulla lapide del padre.
Soffriva di ipotermia e delirava.
L'hanno portata in clinica perché unadelle guardie civili l'ha riconosciuta daitempi in cui era stata qui per mesi l'annoscorso per accudire il padre.
Molta gente del paese la conosceva.L'abbiamo ricoverata ed è rimasta sottoosservazione un paio di giorni. Eradisidratata e probabilmente non dormivada un bel po'. A tratti recuperava lacoscienza. Quando lo faceva, parlava dilei. Diceva che lei correva un grandepericolo. Mi ha fatto giurare di nonavvisare nessuno, né suo marito né altri,finché non avesse potuto farlo leistessa.»
«Nonostante questo, perché non haavvertito Vidal dell'accaduto?»
«L'avrei fatto, però... Le sembreràassurdo.»
«Cosa?»
«Mi sono convinto che stesse fuggendo eho pensato fosse mio dovere aiutarla.»
«Fuggendo da chi?»
«Non ne sono sicuro» disse conun'espressione ambigua.
«Cos'è che non vuole dirmi, dottore?»
«Sono solo un medico. Ci sono cose che
non capisco.»
«Quali cose?»
Il dottor Sanjuán sorrise nervosamente.
«Cristina crede che qualcosa, oqualcuno, sia entrato dentro di lei evoglia distruggerla.»
«Chi?»
«So solo che secondo Cristina ha a chefare con lei ed è qualcosa o qualcunoche le fa paura. Per questo credo chenessun altro possa aiutarla. Per questonon ho avvertito Vidal, come sarebbestato mio dovere. Sapevo che prima opoi lei si sarebbe fatto vivo.»
Mi guardò con una strana mescola dicompassione e risentimento.
«Anch'io la stimo, signor Martín. Neimesi trascorsi qui da Cristina per suopadre... siamo diventati buoni amici.Immagino che non le abbia parlato dime, e probabilmente non aveva motivoper farlo. È stato un periodo moltodifficile per lei. Mi ha confidatoparecchie cose, e anch'io a lei, cose chenon ho mai detto a nessuno. In realtà, leho perfino proposto di sposarmi, perchési renda conto che qui anche noi medicisiamo un po' fuori di testa. Naturalmenteha rifiutato. Non so perché le raccontotutto questo.»
«Ma tornerà a stare bene, vero, dottore?Si rimetterà...»
Il dottor Sanjuán sviò lo sguardo versoil fuoco, sorridendo con tristezza.
«Lo spero» rispose.
«Voglio portarmela via.»
Il medico inarcò le sopracciglia.
«Portarsela via? Dove?»
«A casa.»
«Signor Martín, mi permetta di parlarlecon franchezza. A parte il fatto che leinon è un familiare stretto né il marito
della paziente, il che è un semplicerequisito legale, Cristina non è incondizione di andare con nessuno danessuna parte.»
«Sta meglio qui, rinchiusa con lei in unavilla, legata a una sedia e dro-gata? Nonmi dica che le ha proposto di nuovo disposarla!»
Il dottore mi osservò a lungo, mandandogiù l'offesa che chiaramente gli avevanoprovocato le mie parole.
«Signor Martín, sono contento che leisia qui perché credo che, insieme,potremo aiutare Cristina. Sono convintoche la sua presenza le permetterà diuscire dal luogo in cui si è rifugiata,
perché l'unica parola che ha pronunciatonelle ultime due settimane è il suo nome.Qualunque cosa le sia successa, credoabbia a che fare con lei.»
Il medico mi guardava come se siaspettasse qualcosa da me, una rispostaa tutte le domande.
«Credevo mi avesse abbandonato»iniziai. «Stavamo per metterci inviaggio, per lasciare tutto. Io ero uscitoun momento a comprare i biglietti deltreno e a fare una commissione. Sonostato fuori solo un'ora e mezza.
Quando sono tornato a casa, Cristina sen'era andata.»
«Era successo qualcosa prima? Avevateavuto una discussione?»
Mi morsi le labbra.
«Non la chiamerei una discussione.»
«Come la chiamerebbe?»
«L'avevo sorpresa a sbirciare in certecarte riguardanti il mio lavoro e credo sifosse offesa per quella che deve averinterpretato come una mia mancanza difiducia nei suoi confronti.»
«Era qualcosa di importante?»
«No. Un semplice manoscritto, unabozza.»
«Posso chiedere di che tipo dimanoscritto si trattava?»
Esitai.
«Una fiaba.»
«Per bambini?»
«Diciamo per un pubblico familiare.»
«Capisco.»
«No, non credo che capisca. Non c'èstata nessuna discussione. Cristina si erasolo un po' infastidita perché non leavevo permesso di dargli un'occhiata,nient'altro. Quando l'ho lasciata stavabene, preparava le valigie.
Quel manoscritto non ha nessunaimportanza.»
Il dottore fece un cenno d'assenso piùper cortesia che per convinzione.
«Potrebbe darsi che mentre lei era fuoriqualcuno sia andato a trovarla a casasua?»
«Nessuno all'infuori di me sapeva cheera lì.»
«Le viene in mente qualche motivo per ilquale avrebbe potuto decidere di uscireprima del suo ritorno?»
«No. Perché?»
«Sono solo domande, signor Martín.Cerco di chiarire cosa è successo tra ilmomento in cui lei l'ha vista per l'ultimavolta e la sua comparsa qui.»
«Cristina ha detto cosa o chi le è entratodentro?»
«È un modo di dire, signor Martín. Nonè entrato nulla dentro Cristina.
Non è raro che pazienti reduci daun'esperienza traumatica avvertano lapresenza di familiari defunti o dipersone immaginarie, o che si rifuginonella propria mente e chiudano le porteall'esterno. È una risposta emotiva, unmodo per difendersi da sentimenti oemozioni inaccettabili. Questo, adesso,
non deve preoccuparla. Ciò che conta eche ci può aiutare è che, se c'è qualcunoimportante ora per Cristina, quellapersona è lei. Dalle cose che mi haraccontato a suo tempo e che sonorestate fra noi, e da quanto ho osservatoin queste ultime settimane, mi risulta cheCristina l'ama, signor Martín. L'amacome non ha mai amato nessuno, ecertamente come non amerà mai me. Perquesto le chiedo di aiutarmi, di nonlasciarsi accecare dal risentimento odalla paura e di aiutarmi, perché tutti edue vogliamo la stessa cosa. Tutti e duevogliamo che Cristina possa andarseneda qui.»
Annuii pieno di vergogna.
«Mi scusi se prima...»
Il medico sollevò la mano per zittirmi.Si alzò e si mise il cappotto. Mi tese lamano e gliela strinsi.
«L'aspetto domani» disse.
«Grazie, dottore.»
«Grazie a lei. Per essere al suo fianco.»
La mattina dopo uscii dall'hotel quandoil sole iniziava ad alzarsi sul lagogelato. Un gruppo di bambini giocavasulla riva tirando pietre e cercando dicolpire lo scafo di una barchettaimprigionata nel ghiaccio. Aveva smessodi nevicare e si potevano vedere le
montagne bianche in lontananza e grandinuvole passeggere che scivolavano nelcielo come monumentali città di vapore.Arrivai alla clinica di Villa San Antoniopoco prima delle nove. Il dottor Sanjuánmi aspettava in giardino con Cristina.Erano seduti al sole e il medico leteneva la mano mentre le parlava. Lei loguardava appena. Quando mi videattraversare il giardino, il dottore mifece cenno di avvicinarmi. Mi avevasistemato una sedia di fronte a Cristina.Mi sedetti e la guardai, i suoi occhi neimiei senza vedermi.
«Cristina, guarda chi è venuto» disse ildottore.
Le presi la mano e mi avvicinai a lei.
«Le parli» disse il dottore.
Annuii, perso in quello sguardo assente,senza trovare le parole. Il medico si alzòe ci lasciò soli. Lo vidi scomparireall'interno della clinica, non senza avereprima ordinato a una delle infermiere dinon toglierci gli occhi di dosso. Ignoraila presenza dell'infermiera e avvicinaila sedia a Cristina.
Le scostai i capelli dalla fronte e leisorrise.
«Ti ricordi di me?» domandai.
Potevo vedere il mio riflesso nei suoi
occhi, però non sapevo se mi vedeva ose sentiva la mia voce.
«Il dottore dice che presto ti rimetterai epotremo tornare a casa. Dove vorrai. Hopensato di lasciare la casa della torre edi andarcene molto lontano, come volevitu. Dove nessuno ci conosca e a nessunoimporti chi siamo e da dove veniamo.»
Le avevano coperto le mani con guantidi lana per nascondere le bende sullebraccia. Era calata di peso e avevarughe profonde sulla pelle, labbrascrepolate e occhi spenti e privi di vita.Mi limitai a sorridere e ad accarez-zarleil viso e la fronte, parlando senza tregua,raccontandole quanto mi era mancata e
che l'avevo cercata dappertutto.Trascorremmo così un paio d'ore, finchéil medico tornò con un'infermiera e laportarono dentro. Rimasi seduto lì ingiardino, senza sapere dove andare, finoa quando vidi comparire di nuovo ildottor Sanjuán sulla porta. Si avvicinò esi sedette accanto a me.
«Non ha detto una parola» spiegai. «Noncredo si sia nemmeno resa conto che eroqui...»
«Si sbaglia, amico mio» disse. «È unprocesso lento, ma le assicuro che la suapresenza l'aiuta, e molto.»
Annuii all'elemosina e alle bugie pietosedel dottore.
«Domani ci riproviamo» disse.
Era appena mezzogiorno.
«E cosa faccio fino a domani?» chiesi.
«Non è uno scrittore? Scriva. Scrivaqualcosa per lei.»
9
Ritornai in albergo costeggiando il lago.Il portiere mi spiegò come trovarel'unica cartoleria del paese, dove riusciia comprare dei fogli e una stilograficache era lì da tempi immemorabili. Unavolta armato, mi chiusi nella stanza.Spostai il tavolo davanti alla finestra eordinai un thermos di caffè. Passai quasi
un'ora a guardare il lago e le montagnein lontananza prima di scrivere una solaparola. Ricordai la vecchia fotografiache Cristina mi aveva regalato,quell'immagine di una bambina checamminava su un molo di legno protesonel mare il cui mistero era sempresfuggito alla sua memoria. Immaginai dicamminare su quel molo, immaginai chei miei passi mi conducevano dietro dilei, e lentamente le parole iniziarono aflui-re e lo scheletro di una piccolastoria si insinuò tra le righe. Seppi cheavrei scritto la storia che Cristina nonera mai riuscita a ricordare, la storia chel'aveva condotta da bambina acamminare su quelle acque rilucentitenendo per mano uno sconosciuto.
Avrei scritto la storia di quel ricordoche non era mai stato tale, la memoria diuna vita rubata. Le immagini e la luceche si affacciavano nelle frasi miriportarono nella vecchia Barcellonatenebrosa che ci aveva segnati entrambi.Scrissi fino al tramonto e fino a quandonel thermos non restò nemmeno unagoccia di caffè, fino a quando il lagogelato si accese di una luna azzurra e mifecero male gli occhi e le mani. Lasciaicadere la penna e scostai i fogli sultavolo. Quando il portiere bussò allaporta per domandarmi se scendevo acenare, non lo sentii. Mi eroaddormentato profondamente, sognandoe credendo, per una volta, che le parole,perfino le mie, avessero il potere di
curare.
Passarono quattro giorni al ritmo dellastessa routine. Mi svegliavo all'alba euscivo sul balcone della stanza pervedere il sole tingere di rosso il lago aimiei piedi. Arrivavo in clinica verso leotto e mezzo e trovavo il dottor Sanjuánseduto sui gradini dell'ingresso checontemplava il giardino con una tazza dicaffè fumante tra le mani.
«Non dorme mai, dottore?» glichiedevo.
«Non più di lei» rispondeva.
Verso le nove, il medico miaccompagnava nella stanza di Cristina e
apriva la porta. Ci lasciava soli. Latrovavo sempre seduta sulla stessapoltrona davanti alla finestra.Avvicinavo una sedia e le prendevo lamano. A stento si accorgeva della miapresenza. Poi iniziavo a leggere lepagine che avevo scritto per lei la notteprima. Ogni giorno ricominciavodall'inizio. A volte interrompevo lalettura e alzando gli occhi mi stupivoscoprendo un accenno di sorriso sullesue labbra. Passavo la giornata con leifin quando il dottore tornava al tramontoe mi chiedeva di andarmene. Poi mitrascinavo per le strade deserte sotto laneve e rientravo in albergo, mangiavoqualcosa e salivo in camera percontinuare a scrivere finché non mi
vince-va la stanchezza. I giorni smiserodi avere un nome.
Il quinto giorno entrai nella stanza diCristina come tutte le mattine, ma lapoltrona in cui mi aspettava sempre eravuota. Allarmato, mi guardai intorno e latrovai rannicchiata a terra, raggomitolatain un angolo, che si stringeva leginocchia e con il volto pieno dilacrime. Quando mi vide sor-
rise e capii che mi aveva riconosciuto.Mi inginocchiai davanti a lei el'abbracciai. Non credo di essere maistato tanto felice come in quei miserisecondi in cui sentii il suo fiato sul visoe vidi che un filo di luce le era ritor-nato
negli occhi.
«Dove sei stato?» domandò.
Quel pomeriggio il dottor Sanjuán midiede il permesso di portarla apasseggio per un'ora. Camminammo finoal lago e ci sedemmo su una panchina.Iniziò a parlarmi di un sogno che avevafatto, la storia di una bambina cheviveva in una città labirintica e oscura lecui strade e i cui palazzi si nutrivanodelle anime degli abitanti. Nel suosogno, come nel racconto che le avevoletto per diversi giorni, la bambinariusciva a fuggire e arrivava a un moloproteso su un mare sconfinato.Camminava tenendo per mano uno
sconosciuto senza nome né volto chel'aveva salvata e che adessol'accompagnava verso l'estremità diquella piattaforma di assi sporgentesulle acque dove qualcuno l'aspettava,qualcuno che non riusciva mai a vedere,perché il suo sogno, come la storia chele avevo letto, era incompiu-to.
Cristina ricordava vagamente Villa SanAntonio e il dottor Sanjuán. Arrossìraccontandomi che credeva che leavesse proposto di sposarla la settimanaprima. Il tempo e lo spazio le siconfondevano negli occhi. A voltecredeva che suo padre fosse ricoveratoin una delle stanze e che lei fosse venutaa trovarlo. Un istante dopo non
ricordava come era arrivata fin lì espesso nemmeno se lo chiedeva.Ricordava che io ero uscito percomprare dei biglietti per un treno e, atratti, alludeva alla mattina in cui erascomparsa come se fosse successo ilgiorno prima. A volte mi confondevacon Vidal e mi chiedeva scusa. Altrevolte la paura le oscurava il viso e simetteva a tremare.
«Si avvicina» diceva. «Devoandarmene. Prima che ti veda.»
Allora sprofondava in un lungo silenzio,indifferente alla mia presenza e almondo, come se qualcosa l'avessetrascinata in un luogo remoto e irrag-
giungibile. Trascorso qualche giorno, lacertezza che Cristina avesse perso laragione cominciò a penetrarmi a fondo.La speranza dei primi momenti si tinsedi amarezza e a volte, tornando di nottealla cella del mio albergo, sentivospalancarsi dentro di me quel vecchioabisso di oscurità e di odio che credevodimenticato. Il dottor Sanjuán, che miosservava con la stessa pazienza e lastessa tenacia che riservava ai suoimalati, mi aveva avvertito che sarebbeaccaduto.
«Non deve perdere la speranza, amicomio» diceva. «Stiamo facendo grandiprogressi. Abbia fiducia.»
Io annuivo docilmente e giorno dopogiorno tornavo in clinica per portareCristina a passeggio fino al lago, perascoltare quei ricordi sognati che miaveva raccontato decine di volte ma cheriscopriva di nuovo ogni giorno. Ognigiorno mi chiedeva dove ero stato,perché non ero tornato a prenderla,perché l'avevo lasciata sola. Ognigiorno mi guardava dalla sua gabbiainvisibile e mi chiedeva di abbracciarla.Ogni giorno, quando ci sepa-ravamo, midomandava se l'amavo e io lerispondevo sempre la stessa cosa.
«Ti amerò sempre» dicevo. «Sempre.»
Una notte mi svegliai sentendo bussare
alla mia stanza. Erano le tre. Mitrascinai alla porta, intontito, e sullasoglia trovai un'infermiera della clinica.
«Il dottor Sanjuán mi ha chiesto divenirla a prendere.»
«Cos'è successo?»
Dieci minuti dopo entravo a Villa SanAntonio. Le urla si sentivano fin dalgiardino. Cristina aveva bloccatodall'interno la porta della sua stanza.
Il dottor Sanjuán, con l'aria di chi nondorme da una settimana, e due infermieristavano cercando di forzarla. Dentro sisentiva Cristina che grida-va e colpivale pareti, rovesciava i mobili e faceva a
pezzi tutto ciò che trovava.
«Chi c'è lì dentro con lei?» chiesi,raggelato.
«Nessuno» rispose il medico.
«Ma sta parlando con qualcuno...»protestai.
«È sola.»
Un sorvegliante arrivò di corsa con unasbarra di metallo.
«È tutto quello che ho trovato» disse.
Il dottore annuì e il sorveglianteintrodusse la sbarra nel buco della
serratura iniziando a forzarla.
«Come ha fatto a chiudersi dentro?»domandai.
«Non lo so...»
Per la prima volta mi parve di scorgerela paura sul volto del medico, cheevitava il mio sguardo. Il sorveglianteera sul punto di forzare la serratura conla sbarra quando, all'improvviso, si fecesilenzio dall'altro lato della porta.
«Cristina?» chiamò il dottore.
Nessuna risposta. La porta alla finecedette e si aprì di colpo verso l'interno.Seguii il dottore nella stanza, immersa
nella penombra. La finestra era aperta eun vento gelido inondava la camera. Lesedie, i tavoli e le poltrone eranorovesciati. Le pareti erano macchiate daquello che mi parve un tratto irregolaredi pittura nera. Era sangue. Di Cristinanon c'era traccia.
Gli infermieri corsero sul balcone escrutarono il giardino in cerca di ormesulla neve, mentre il medico guardavadappertutto. Fu allora che sentimmo unarisata che proveniva dal bagno. Miavvicinai alla porta e l'aprii.
Il pavimento era cosparso di vetri.Cristina era seduta per terra, appoggiataalla vasca di metallo come un pupazzo
rotto. Le sanguinavano le mani e i piedi,cosparsi di tagli e schegge di vetro. Ilsuo sangue scorreva ancora lungo leincrinature dello specchio che avevafatto a pezzi con i pugni.
L'abbracciai e cercai il suo sguardo.Sorrise.
«Non l'ho lasciato entrare» disse.
«Chi?»
«Voleva che dimenticassi, ma non l'holasciato entrare» ripeté.
Il dottore si accovacciò accanto a me edesaminò i tagli e le ferite chericoprivano il corpo di Cristina.
«Per favore» mormorò, separandomi dalei. «Adesso no.»
Uno degli infermieri era corso aprendere una barella. Li aiutai ad ada-giarvi Cristina e le tenni la mano mentrela portavano in un ambulatorio, dove ildottor Sanjuán le iniettò un calmante chein pochi secondi le rubò la coscienza.Restai al suo fianco, guardandola negliocchi finché il suo sguardo divenne unospecchio vuoto e un'infermiera mi preseper un braccio e mi portò fuori. Rimasilì, in mezzo a un corridoio in penombrache puzzava di disinfettante, con le manie i vestiti macchiati di sangue. Miappoggiai al muro e mi lasciai scivolarea terra.
Cristina si svegliò il giorno dopo perritrovarsi legata a un letto con cinghie dicuoio, rinchiusa in una stanza senzafinestre e senza altra luce se non quelladi una lampadina smorta appesa alsoffitto. Io avevo passato la notte su unasedia in un angolo, osservandola, senzala nozione del tempo trascorso. Aprì gliocchi di colpo, una smorfia di dolore sulviso nel sentire le fitte delle ferite allebraccia.
«David?» chiamò.
«Sono qui» risposi.
Mi avvicinai al letto e mi chinai perchévedesse la faccia e il sorriso a-nemicoche avevo studiato apposta per lei.
«Non riesco a muovermi.»
«Sei legata con delle cinghie. È per iltuo bene. Appena viene il dottore, te letoglie.»
«Toglimele tu.»
«Non posso. Dev'essere il dottore a...»
«Per favore...» supplicò.
«Cristina, è meglio che...»
«Per favore.»
C'erano dolore e paura nel suo sguardo,ma soprattutto un chiarore e unapresenza che non avevo mai visto in
quei giorni andando a trovarla. Era dinuovo lei. Sciolsi le prime due cinghieche le attraversavano le spalle e ifianchi. Le accarezzai il viso. Stavatremando.
«Hai freddo?»
Scosse la testa.
«Vuoi che avverta il dottore?»
Scosse di nuovo la testa.
«David, guardami.»
Mi sedetti sul bordo del letto e laguardai negli occhi.
«Devi distruggerlo» disse.
«Non ti capisco.»
«Devi distruggerlo.»
«Cosa?»
«Il libro.»
«Cristina, sarà meglio che avverta ildottore...»
«No. Ascoltami.»
Mi afferrò la mano con forza.
«La mattina che sei andato a prendere ibiglietti, ricordi? Sono salita di nuovo
nel tuo studio e ho aperto il baule.»
Sospirai.
«Ho trovato il manoscritto e hocominciato a leggerlo.»
«È solo una fiaba, Cristina...»
«Non mentire. L'ho letto, David.Abbastanza per sapere che dovevodistruggerlo...»
«Non preoccuparti di questo, adesso. Tiho già detto che l'ho abbandonato.»
«Ma lui non ha abbandonato te. Hocercato di bruciarlo...»
Per un attimo, a quelle parole, le lasciaila mano, reprimendo una rabbia freddaal ricordo dei fiammiferi usati cheavevo trovato sul pavimento del-
lo studio.
«Hai cercato di bruciarlo?»
«Ma non ci sono riuscita» mormorò.«C'era qualcun altro in casa.»
«Non c'era nessuno in casa, Cristina.Nessuno.»
«Appena ho acceso il fiammifero e l'hoavvicinato al manoscritto, l'ho sentitodietro di me. Ho sentito un colpo allanuca e sono caduta.»
«Chi ti ha colpito?»
«Era tutto scuro, come se la luce delgiorno si fosse ritratta e non potesseentrare. Mi sono girata, ma era moltobuio. Gli ho visto solo gli occhi. Occhida lupo.»
«Cristina...»
«Mi ha tolto di mano il manoscritto el'ha rimesso nel baule.»
«Cristina, non stai bene. Chiamo ildottore e...»
«Non mi stai ascoltando.»
Le sorrisi e la baciai sulla fronte.
«Certo che ti ascolto. Però non c'eranessun altro in casa...»
Socchiuse gli occhi e girò la testa,gemendo come se le mie parole fosseropugnali che le squarciassero le viscere.
«Vado a chiamare il dottore...»
Mi chinai per baciarla di nuovo e mialzai. Mi avviai verso la porta, sentendoil suo sguardo sulla schiena.
«Vigliacco» disse.
Quando tornai con il dottor Sanjuán,Cristina aveva sciolto l'ultima cinghia ebarcollava per la stanza diretta allaporta, lasciando orme insanguinate sulle
piastrelle bianche. La tenemmo ferma indue e l'adagiammo di nuovo sul letto.Cristina urlava e si divincolava con unarabbia che gelava il sangue. Il baccanomise in allerta gli infermieri. Unsorvegliante ci aiutò a tenerla mentre ildottore la legava un'altra volta con lecinghie. Quando fu immobilizzata, ildottore mi guardò con severità.
«La sederò ancora. Rimanga qui e non levenga in mente di scioglierle di nuovo lecinghie.»
Restai solo con lei un minuto, cercandodi calmarla. Cristina continuava a lottareper liberarsi delle cinghie. Le afferrai ilviso e cercai di captare il suo sguardo.
«Cristina, per favore...»
Mi sputò in faccia.
«Vattene.»
Il medico tornò in compagnia diun'infermiera che portava un vassoio dimetallo con una siringa, le garze e unaboccetta contenente una soluzionegiallastra.
«Esca» mi ordinò.
Arretrai fino alla soglia. L'infermieratenne ferma Cristina sul letto e il dottorele iniettò il calmante nel braccio.Cristina urlava con voce lacerata.
Mi tappai le orecchie e uscii incorridoio.
Vigliacco, mi dissi. Vigliacco.
10
Oltre la clinica Villa San Antonio siapriva un sentiero fiancheggiato daalberi che costeggiava un canale e siallontanava dal paese. La mappaincorniciata appesa nella sala da pranzodell'Hotel del Lago lo identificava conl'appellativo mieloso di paseo de losEnamorados. Quel pomeriggio,lasciando la clinica, mi avventurai perquel cupo sentiero che, più cheamoreggiamenti, suggeriva solitudine.Camminai per quasi mezz'ora senza
incontrare anima viva, lasciandomi allespalle il paese finché il profilospigoloso di Villa San Antonio e legrandi case che circondavano il lago misembrarono ritagli di cartonesull'orizzonte. Mi sedetti su una dellepanchine che punteggiavano il sentiero econtemplai il sole che tramontavaall'altra estremità della valle dellaCerdanya. Da lì, a un duecento metri, siscorgeva il profilo di un piccolo eremoisolato al centro di un campo innevato.Senza sapere bene perché, mi alzai e mifeci strada in mezzo alla neve, direttoall'edificio. Quando ero a una dozzina dimetri, notai che l'ere-mo non avevaportone. La pietra era annerita dallefiamme che avevano divorato la
struttura. Salii i gradini checonducevano a quello che era statol'ingresso e avanzai di qualche passo. Iresti delle panche incendiate e delletravi cadute dal soffitto spuntavano dallacenere. Le sterpaglie si erano in-trufolate all'interno e si arrampicavanosu quello che era stato l'altare. La lucedel crepuscolo penetrava dalle angustefinestre di pietra. Mi sedetti su quantorestava di una panca di fronte all'altare esentii il vento sussurrare tra le crepedella volta consumata dal fuoco. Alzaigli occhi e desiderai avere anche solouna briciola della fede, in Dio o neilibri, che aveva alber-gato il miovecchio amico Sempere, per pregareDio o l'inferno di concedermi un'altra
opportunità e di lasciarmi portar viaCristina da lì.
«Per favore» mormorai, mordendomi lelacrime.
Sorrisi amaramente, un uomo ormaisconfitto che supplicava meschinità a unDio in cui non aveva mai creduto. Miguardai intorno e vidi quella casa di Diofatta di rovina e di cenere, di vuoto e disolitudine. Allora seppi che sareitornato a prenderla quella notte stessa,senza altro miracolo né benedizione senon la mia determinazione di portarmelavia e di strapparla dalle mani di queldottore pusillanime e cascamorto cheaveva deciso di farne la sua bella
addormentata. Avrei dato fuoco allaclinica piuttosto che permettere chequalcuno le mettesse di nuovo le maniaddosso. Me la sarei portata a casa permorire accanto a lei. L'odio e la rabbiaavrebbero illuminato il mio cammino.
Lasciai il vecchio eremo all'imbrunire.Attraversai quel campo d'argento chebrillava alla luce della luna e ritornai alsentiero nel bosco seguendo le traccedel canale nelle tenebre, finché avvistaiin lontananza le luci di Villa SanAntonio e la cittadella di torrioni emansarde che circondavano il lago.
Arrivato in clinica, non mi presi la brigadi tirare il campanello che c'era al
cancello. Saltai il muro e attraversai ilgiardino strisciando nell'oscurità.
Aggirai la casa e mi avvicinai a unodegli ingressi posteriori. Era chiusodall'interno, ma non esitai un istante acolpire il vetro con il gomito perromperlo e raggiungere la maniglia. Miinoltrai nel corridoio, ascoltando le vocie i mormorii, sentendo nell'aria l'aromadi brodo che saliva dalle cucine.Attraversai il piano fino ad arrivare allastanza in fondo, dove il buon dottoreaveva rinchiuso Cristina, senza dubbiofantasticando di farne la sua bellaaddormentata, prostrata per sempre in unlimbo di farmaci e cinghie.
Avevo immaginato di trovare chiusa laporta della stanza, però la maniglia micedette sotto la mano. Spinsi la porta edentrai. La prima cosa che notai fu chepotevo vedere il mio fiato fluttuaredavanti alla faccia. La seconda fu che ilpavimento a piastrelle bianche era pienodi orme insanguinate. Il finestrone chedava sul giardino era spalancato e letende ondeggiavano al vento. Il letto eravuoto. Mi avvicinai e presi una dellecinghie di cuoio con cui il dottore e gliinfermieri avevano legato Cristina.Erano tagliate di netto, come se fosserostate di carta. Uscii in giardino e vidiuna scia di orme rossastre chebrillavano sulla neve e si allontanavanoverso il muro. La seguii e tastai il muro
di pietra che circondava il giardino.C'era del sangue. Mi arrampicai e saltaidall'altra parte. Le orme, erratiche, siallontanavano in direzione del paese.Ricordo di essermi messo a correre.
Seguii le tracce sulla neve fino al parcoche circondava il lago. La luna pienaardeva sulla grande lastra di ghiaccio.Fu lì che la vidi. Avanzava lentamente,zoppicando, sul lago ghiacciato,lasciandosi alle spalle una scia di ormeinsanguinate. Il vento agitava ilcamicione che le avvolgeva il corpo.Quando raggiunsi la riva, Cristina si eraaddentrata una trentina di metri verso ilcentro del lago. Gridai il suo nome e sifermò. Si voltò lentamente e la vidi
sorridere mentre una ragnatela di crepes'intesseva ai suoi piedi. Saltai sulghiaccio, sentendo la superficierompersi al mio passaggio, e corsi versodi lei. Cristina rimase immobile aguardarmi. Le incrinature sotto i suoipiedi si espandevano come un'edera dicapillari neri. Il ghiaccio cedeva sotto imiei passi e caddi bocconi.
«Ti amo» la sentii dire.
Mi trascinai verso di lei, ma la rete dicrepe mi cresceva sotto le mani e lacircondò. Ci separavano solo pochimetri quando sentii il ghiaccio rompersie cederle sotto i piedi. Delle fauci neresi spalancarono e la inghiotti-rono come
un pozzo di catrame. Appena scomparvesotto la superficie, le lastre di ghiacciosi ricomposero sigillando l'aperturanella quale Cristina era precipitata.Spinto dalla corrente, il suo corposcivolò un paio di metri sotto la lastra dighiaccio. Riuscii a trascinarmi fin doveera rimasta imprigionata e colpii ilghiaccio con tutte le mie forze. Cristina,gli occhi aperti e i capelli ondeggiantinella corrente, mi osservava dall'altrolato di quella lamina traslucida. Picchiaisul ghiaccio fino a ridurmi inutilmente apezzi le mani. Cristina non staccò maigli occhi dai miei. Appoggiò la mano sulghiaccio e sorrise. Le ultime bolle d'ariale sfuggivano ormai dalle labbra e le suepupille si dilatarono per l'ultima volta.
Un secondo dopo, lentamente, cominciòad affondare per sempre nell'oscurità.
11
Non tornai in camera a riprendere le miecose. Nascosto tra gli alberi checircondavano il lago, vidi il dottore e unpaio di poliziotti arrivare in albergo.Attraverso le vetrate, li vidi parlare conil direttore. Al riparo di strade oscure edeserte attraversai il paese fino araggiungere la stazione sepolta nellanebbia. Due lampioni a gaspermettevano di indovinare il profilo diun treno in attesa sui binari. Il semafororosso acceso all'uscita della stazionetingeva il suo scheletro di metallo scuro.
La locomotiva era ferma; lacrime dighiaccio pendevano da leve e binaricome gocce di gelatina. I vagoni eranoal buio, i finestrini velati dalla brina.Non si vedeva nessuna luce nell'ufficiodel capostazione. Mancavano ancoraparecchie ore alla partenza e la stazioneera deserta.
Mi avvicinai a uno dei vagoni e provaiad aprire una porta. Era chiusadall'interno. Scesi sui binari e aggirai iltreno. Protetto dall'ombra, mi arrampicaisulla piattaforma di passaggio fra i duevagoni di coda e tentai la sorte con laporta che metteva in comunicazione lecarrozze. Era aperta.
Mi infilai nel vagone e avanzai nellapenombra fino a uno degliscompartimenti. Entrai e chiusi laserratura dall'interno. Tremante difreddo, mi lasciai sprofondare nelsedile. Non osavo chiudere gli occhi pertimore che lo sguardo di Cristina miattendesse sotto il ghiaccio. Passaronominuti, forse ore. A un certo punto michiesi perché mi stessi nascondendo eperché fossi incapace di provarequalcosa.
Mi rifugiai in quel vuoto e aspettai lì,nascosto come un fuggiasco, ascoltandoi mille lamenti del metallo e del legnoche si contraevano per il freddo. Scrutaile ombre dietro i finestrini fin quando il
fascio di luce di un lampione sfiorò lepareti della carrozza e sentii delle vocisulla banchina.
Aprii con le dita uno spioncino nellapellicola di vapore che appannava ivetri e vidi il macchinista e un paio dioperai che si dirigevano verso la parteanteriore del treno. A una decina dimetri, il capostazione chiacchie-ravacon la coppia di poliziotti che pocoprima avevo visto all'albergo insieme aldottore. Lo vidi annuire e tirare fuori unmazzo di chiavi mentre si avvicinava altreno seguito dai poliziotti. Mi ritrassi dinuovo nello scompartimento. Qualchesecondo dopo sentii il rumore dellechiavi e lo scatto della porta del vagone
che si apriva. Dei passi avanzaronodall'estremità della carrozza. Sollevai ilsaliscendi della serratura, lasciando laporta dello scompartimento aperta, e mistesi a terra sotto una fila di sedili,appiattito contro la parete. Sentiiavvicinarsi i poliziotti, vidi il fasciodelle torce che tracciavano aghi di luceazzurrata scivolando sulle vetrate degliscompartimenti. Quando i passi sifermarono davanti al mio, trattenni ilrespiro. Le voci si erano zittite. Sentii laporta che si apriva e gli stivali che mipassavano a un paio di palmi dallafaccia. Il poliziotto restò lì qualchesecondo, poi uscì e richiuse. I suoi passisi allontanarono lungo il vagone.
Rimasi lì, immobile. Un paio di minutidopo sentii un tramestio, e un soffiocaldo che esalava dalla grata delriscaldamento mi accarezzò il volto.Un'ora più tardi le prime luci dell'albasfiorarono i finestrini. Uscii dal mionascondiglio e guardai fuori. Viaggiatorisolitari o a coppie percorrevano labanchina trascinando pacchi e valigie.Sulle pareti e sul pavimento del vagonesi sentiva il rumore della locomotiva inmoto. In pochi minuti i viaggiatoricominciarono a salire sul treno e ilcontrollore accese le luci.
Mi sedetti di nuovo sul sedile accanto alfinestrino e ricambiai i saluti di qualchepasseggero che passava davanti allo
scompartimento. Quando il grandeorologio della stazione batté le otto, ilconvoglio iniziò a muoversi.
Solo allora chiusi gli occhi e sentii lecampane della chiesa suonare inlontananza con l'eco di una maledizione.
Il viaggio di ritorno fu funestato dairitardi. Parte della linea era fuori uso enon arrivammo a Barcellona finoall'imbrunire di quel venerdì 23
febbraio. La città era sepolta sotto uncielo scarlatto sul quale si stendeva unaragnatela di fumo nero. Faceva caldo,come se l'inverno si fosse ritrattod'improvviso e un fiato sporco e umidosalisse dalle grate delle fognature.
Aprendo il portone della casa dellatorre trovai una busta bianca sulpavimento. Scorsi il sigillo di ceralaccarossa e non mi preoccupai diraccoglierla perché sapevoperfettamente quello che conteneva: unpromemoria dell'appuntamento con ilprincipale per consegnargli ilmanoscritto quella sera stessa nella villaaccanto al Park Güell. Salii le scale albuio e aprii la porta dell'appartamento.Non accesi la luce e andai direttamentenello studio. Mi avvicinai al finestrone eosservai la stanza nel chiarore infernaledistillato da quel cielo in fiamme. Laimmaginai lì, come mi aveva raccontato,in ginocchio davanti al baule. Laimmaginai mentre lo apriva e tirava
fuori la cartellina con il manoscritto.Mentre leggeva quelle pagine maledettecon la certezza di doverle distruggere.Mentre accendeva i fiammiferi eavvicinava la fiamma alla carta.
C'era qualcun altro in casa.
Mi avvicinai al baule e mi fermai aqualche passo di distanza, come se fossialle sue spalle, a spiarla. Mi chinai inavanti e lo aprii. Il manoscritto eraancora lì, ad aspettarmi. Allungai lamano per sfiorare la cartellina con ledita, accarezzandolo. Fu allora che lavidi. Il profilo d'argento brillava sulfondo del baule come una perla sulfondo di uno stagno. La presi fra le dita
e l'esaminai alla luce di quel cieloinsanguinato. La spilla dell'angelo.
«Figlio di puttana» mi sentii dire.
Presi la scatola con il vecchio revolverdi mio padre dal fondo dell'armadio.Aprii il tamburo e verificai che eracarico. Misi la scatola di munizioninella tasca sinistra del cappotto. Avvolsil'arma in uno strofinaccio e la infilainella tasca destra. Prima di uscire mifermai un istante a contemplare losconosciuto che mi osservava dallospecchio dell'ingresso. Sorrisi, con lapace dell'odio che mi bruciava nellevene, e uscii nella notte.
12
La casa di Andreas Corelli si ergevasulla collina, stagliandosi contro unmanto di nuvole rosse. Alle sue spalleondeggiava il bosco di ombre del ParkGüell. Il vento agitava i rami e le fogliesibilavano come serpenti nel buio. Mifermai davanti all'ingresso ed esaminaila facciata. Non c'era nemmeno una luceaccesa in tutta la casa. Le imposte deifinestroni erano chiuse. Sentii alle miespalle il respiro dei cani che siaggiravano dietro i muri del parco,seguendo i miei passi. Estrassi ilrevolver dalla tasca e mi girai verso ilcancello d'ingresso, doves'intravedevano i contorni degli animali,ombre liquide che scrutavanodall'oscurità.
Mi avvicinai alla porta principale ediedi tre colpi secchi al battente. Nonaspettai la risposta. Avrei fatto saltare laserratura con il revolver, ma non ce nefu bisogno. La porta era aperta. Girai lamaniglia di bronzo fino a far scattare laserratura e la porta di rovere scivolòlentamente verso l'interno per l'inerziadel suo stesso peso. Il lungo corridoiomi si spalancava di fronte, con lo stratodi polvere sul pavimento che brillavacome sabbia fine. Avanzai di qualchepasso e mi avvicinai alla scalinata a unlato dell'ingresso che scompariva in unaspirale di ombre. Proseguii lungo ilcorridoio che portava in salotto. Decinedi sguardi mi seguivano dalla galleria divecchie foto incorniciate che
ricoprivano le pareti. Gli unici rumoriche riuscivo a percepire erano quelli deimiei passi e del mio respiro. Raggiunsila fine del corridoio e mi fermai. Ilchiarore notturno filtrava dalle impostecome lame di luce rossastra. Sollevai ilrevolver ed entrai in salotto.
Lasciai che i miei occhi si abituasseroalle tenebre. I mobili erano dove liricordavo, ma perfino nella scarsità diluce si poteva notare che erano vecchi ericoperti di polvere. Relitti. I tendaggipendevano sfilacciati e la pittura deimuri era ridotta a brandelli simili asquame. Mi diressi verso uno deifinestroni per aprire le imposte e farentrare un po' di luce. Ero a un paio di
metri dal balcone quando capii di nonessere solo. Mi fermai, raggelato, e mivoltai piano.
La figura si distingueva chiaramente inun angolo della stanza, seduta sullasolita poltrona. La luce che sanguinavadalle imposte riusciva a sve-larne lescarpe lucide e il contorno del vestito. Ilvolto era completamente in ombra, masapevo che mi stava guardando. E chesorrideva. Sollevai il revolver e glielopuntai contro.
«So quello che ha fatto» dissi.
Corelli non mosse nemmeno un muscolo.La sua figura restò immobile come unragno. Feci un passo avanti, tenendogli
il volto sotto mira. Mi parve di sentireun sospiro nell'oscurità, poi, per unistante, la luce rossa-
stra si accese nei suoi occhi ed ebbi lacertezza che mi sarebbe saltato addosso.Sparai. Il rinculo dell'arma mi colpìl'avambraccio come una martellatasecca. Una nube di fumo azzurrato sialzò dal revolver. Una mano di Corelliscivolò giù dal bracciolo della poltronaoscillando, con le unghie che sfioravanoil pavimento. Sparai di nuovo. Lapallottola lo raggiunse al petto e aprì unbuco fumante nel vestito. Rimasi fermo,impugnando il revolver con tutte e due lemani, senza osare fare un altro passo,scrutando il suo profilo immobile sulla
poltrona. Il dondolio del braccio sifermò a poco a poco finché il corpogiacque inerte e le sue unghie, lunghe ecurate, rimasero ancorate al pavimentodi rovere. Non ci fu alcun rumore né unaccenno di movimento nel corpo cheaveva appena ricevuto due proiettili,uno al viso e l'altro al petto. Arretrai diqualche passo verso il finestrone e loaprii a calci, senza staccare gli occhidalla poltrona dove giaceva Corelli.Una colonna di luce vaporosa si fecestrada dalla balaustra all'angolo dellastanza, illuminando il volto e il corpodel principale. Cercai di deglutire, maavevo la bocca secca. Il primo sparo gliaveva aperto un foro tra gli occhi. Ilsecondo gli aveva bucato uno dei
risvolti della giacca. Non c'eranemmeno una goccia di sangue. Al suoposto stillava una polvere sottile ebrillante, come quella di una clessidra,che scivolava tra le pieghe del vestito.Gli occhi gli brillavano e aveva lelabbra congelate in un sorrisosarcastico. Era un fantoccio.
Abbassai il revolver, la mano cheancora tremava, e mi avvicinailentamente. Mi chinai su quel grottescoburattino e gli accostai piano la manoalla faccia. Per un istante temetti che daun momento all'altro quegli occhi dicristallo si sarebbero mossi e che quellemani dalle lunghe unghie mi si sarebberoavventate al collo. Gli sfiorai la guancia
con i polpastrelli. Legno smaltato. Nonriuscii a trattenere una risata amara. Nonpotevo aspettarmi di meno dalprincipale. Affrontai di nuovo quellasmorfia beffarda e asse-stai al fantoccioun colpo con il calcio del revolver chelo rovesciò su un fianco. Lo vidi caderea terra e mi accanii a calci contro di lui.La struttura di legno cominciò adeformarsi finché braccia e gambe siannodarono in una posizioneimpossibile. Arretrai di qualche passo emi guardai attorno.
Osservai la grande tela con la figuradell'angelo e la tirai giù con un solostrattone. Dietro il quadro scoprii laporta di accesso al sotterraneo che
ricordavo dalla notte in cui ero rimastoa dormire lì. Saggiai la serratura. Eraaperta. Scrutai la scala che scendeva inquella cavità oscura. Andai verso ilcomò dove ricordavo di avere vistoCorelli mettere i centomila franchidurante il nostro primo incontro inquella casa e frugai nei cassetti. In unotrovai una scatola di latta con candele efiammiferi. Esitai un istante,chiedendomi se il principale avesselasciato lì anche quelli sperando che litrovassi, così come avevo trovato ilfantoccio. Accesi una candela eattraversai il salotto diretto alla porta.Diedi un'ultima occhiata al pupazzo aterra e, con la candela in alto e ilrevolver stretto nella mano destra, mi
preparai a scendere. Avanzai gradinodopo gradino, fermandomi a ogni passoper guardarmi alle spalle. Quandoraggiunsi la stanza sotterranea, tenni lacandela il più possibile lontana da me edescrissi un semicerchio con il braccio.Era ancora tutto lì, il tavolo operatorio,le lampade a gas e il vassoio con glistrumenti chirurgici. Tutto ricoperto dauna patina di polvere e ragnatele. Mac'era qualcos'altro. Si notavano altresagome contro la parete.
Immobili come quella del principale.Lasciai la candela sul tavolo e miavvicinai a quei corpi inerti. Riconobbiil domestico che ci aveva servito unasera e l'autista che mi aveva riportato a
casa dopo la cena con Corelli ingiardino. C'erano altre sagome che nonriuscii a identificare, fra cui una rivoltacontro il muro, con il viso nascosto. Laspinsi con la punta dell'arma, facendolaruotare, e un secondo dopo mi ritrovai aguardare me stesso.
Sentii un brivido che mi invadeva. Ilpupazzo che mi imitava aveva solomezza faccia. L'altra metà non avevatratti definiti. Stavo per prendere a calciquel volto quando sentii la risata di unbambino in cima alle scale.
Trattenni il respiro e a quel punto sisentì una serie di scatti secchi. Corsi super i gradini e quando arrivai al piano
terra il fantoccio del principale non erapiù sul pavimento dove l'avevo lasciato.Una scia di orme si allontanava da lì indirezione del corridoio. Armai ilpercussore del revolver e seguii quelletracce. Mi fermai sulla soglia e sollevail'arma. Le orme si in-terrompevano ametà corridoio. Cercai la figura delprincipale occulta nell'ombra, ma non cen'era traccia. In fondo al corridoio, laporta principale era ancora aperta.Avanzai lentamente fino al punto in cuile orme si fermavano. Non me neaccorsi se non qualche secondo dopo,quando notai che il vuoto che ricordavofra i ritratti della parete non c'era più.Al suo posto c'era una cornice nuova edentro, in una foto che pareva scattata
dalla stessa macchina fotografica diquelle che formavano la macabracollezione, si vedeva Cristina vestita dibianco, lo sguardo perso nell'obiettivo.
Non era sola. Due braccia lacircondavano e la sostenevano. Il loroproprietario sorrideva alla macchina.Andreas Corelli.
13
Mi allontanai giù per la collina, direttoal groviglio di strade buie di Gracia.Trovai un caffè aperto dove si erariunita una nutrita clientela che discutevafuriosamente di politica o di calcio:difficile stabilirlo. Schivai la folla eattraversai una nube di fumo e di
baccano fino a raggiungere il bancone,dove il barista mi rivolse lo sguardovagamente ostile con cui immaginaiaccogliesse tutti gli sconosciuti, che inquel caso dovevano essere tutti iresidenti in qualsiasi posto a più di unpaio di isolati dal suo locale.
«Ho bisogno di usare il telefono» dissi.
«È riservato ai clienti.»
«Mi dia un cognac. E il telefono.»
Il barista prese un bicchiere e indicò uncorridoio che si apriva in fondo allasala sotto un cartello con la scrittaLATRINE. Lì trovai una specie dicabina telefonica, proprio davanti
all'entrata dei bagni, esposta a un'intensapuzza di ammoniaca e al fracassoproveniente dalla sala. Sollevai lacornetta e attesi di avere la linea.Qualche secondo più tardi mi risposeuna centralinista della compagniatelefonica.
«Devo chiamare lo studio legale Valera,al numero 442 dell'avenida Diagonal.»
La centralinista si prese un paio diminuti per trovare il numero e mettermiin comunicazione. Aspettai lì, tenendo lacornetta con una mano e tappandomil'orecchio sinistro con l'altra. Alla fine,mi confermò che tra-sferiva la miachiamata e dopo pochi secondi
riconobbi la voce della segretariadell'avvocato Valera.
«Mi dispiace, ma l'avvocato al momentonon c'è.»
«È importante. Gli dica che mi chiamoMartín, David Martín. È questione divita o di morte.»
«So già chi è lei, signor Martín. Midispiace, ma non posso passarlel'avvocato perché non è qui. Sono lenove e mezza di sera e se n'è andato daun bel po'.»
«Allora mi dia l'indirizzo di casa.»
«Non posso fornirle questa
informazione, signor Martín. Midispiace. Se vuole, può chiamaredomani mattina e...»
Riagganciai e attesi di nuovo la linea.Stavolta diedi alla centralinista ilnumero di Ricardo Salvador. Il suovicino rispose e disse che sarebbe salitoa vedere se l'ex poliziotto era in casa.Salvador arrivò dopo un minuto.
«Martín? Sta bene? È a Barcellona?»
«Sono appena arrivato.»
«Deve fare molta attenzione. La poliziala cerca. Sono venuti qui a fare domandesu di lei e su Alicia Marlasca.»
«Víctor Grandes?»
«Credo di sì. Era con un paio diragazzoni che non mi sono piaciuti perniente. Mi pare che voglia affibbiare alei le morti di Roures e di AliciaMarlasca. È meglio che tenga gli occhiben aperti. Sicuramente la stannosorvegliando. Se vuole può venire qui.»
«Grazie, signor Salvador. Ci penserò.Non voglio metterla in altri guai.»
«Qualunque cosa faccia, occhio. Credoche lei avesse ragione: Jaco è tornato.Non so perché, ma è tornato. Ha unpiano?»
«Ora cerco di localizzare l'avvocato
Valera. Credo che al centro di tutto cisia l'editore per cui lavorava Marlasca epenso che Valera sia l'unico a sapere laverità.»
Salvador fece una pausa.
«Vuole che venga con lei?»
«Non credo sia necessario. La chiamoappena avrò parlato con Valera.»
«Come vuole. È armato?»
«Sì.»
«Sono contento di saperlo.»
«Signor Salvador... Roures mi aveva
parlato di una donna del Somorrostroconsultata da Marlasca. Una che avevaconosciuto attraverso Irene Sabino.»
«La Strega del Somorrostro?»
«Cosa sa di lei?»
«Non c'è molto da sapere. Non credonemmeno che esista, come quell'editore.Quelli di cui deve preoccuparsi sonoJaco e la polizia.»
«Ne terrò conto.»
«Mi chiami appena sa qualcosa,d'accordo?»
«Lo farò. Grazie.»
Riagganciai e passando davanti albancone lasciai qualche moneta perpagare le telefonate e il bicchiere dicognac che era ancora lì, intatto.
Venti minuti dopo ero al numero 442dell'avenida Diagonal a guardare le luciaccese nello studio di Valera in cima alpalazzo. La portineria era chiusa, mabussai finché il portiere si affacciò e siavvicinò con un'aria non moltoamichevole. Appena aprì un po' la portaper liquidarmi in malo modo, diedi unospintone e m'infilai nella portineria,ignorando le sue proteste. Andai drittoall'ascensore e, quando lui cercò difermarmi trattenen-domi per il braccio,gli lanciai uno sguardo avvelenato che
lo dissuase dal tentativo.
Quando la segretaria di Valera aprì, lasua espressione di sorpresa sì trasformòrapidamente in paura, in particolarequando infilai il piede nello spiraglioper evitare che mi chiudesse la porta infaccia ed entrai senza essere statoinvitato.
«Avverta l'avvocato» dissi. «Subito.»
La segretaria mi guardò, pallida.
«Il signor Valera non c'è...»
La presi per un braccio e la spinsi finoall'ufficio dell'avvocato. Le luci eranoaccese, ma non c'era traccia di Valera.
La segretaria singhiozzava, terrorizzata,e mi resi conto che le stavo conficcandole dita nel braccio. La lasciai e arretròdi qualche passo. Stava tremando.Sospirai e cercai di ab-bozzare un gestotranquillizzante che servì solo a farlevedere il revolver che spuntava dallacintura dei pantaloni.
«Per favore, signor Martín... Le giuroche il signor Valera non c'è.»
«Le credo. Si calmi. Voglio soloparlargli. Nient'altro.»
La segretaria annuì. Le sorrisi.
«Sia così gentile da prendere il telefonoe chiamarlo a casa.»
La segretaria sollevò la cornetta emormorò il numero dell'avvocato allacentralinista. Quando ebbe risposta, mipassò il telefono.
«Buona sera» arrischiai.
«Martín, che brutta sorpresa» disseValera all'altro capo della linea.
«Posso sapere cosa sta facendo nel mioufficio a quest'ora di notte, a parteterrorizzare i miei dipendenti?»
«Mi dispiace per il disturbo, avvocato,ma devo assolutamente localizzare il suocliente, il signor Andreas Corelli, e lei èl'unico in grado di aiutarmi.»
Un lungo silenzio.
«Temo che si sbagli, Martín. Non possoaiutarla.»
«Speravo di poter risolvere questafaccenda amichevolmente, signorValera.»
«Non ha capito, Martín. Io non conoscoil signor Corelli.»
«Prego?»
«Non l'ho mai visto e non ci ho maiparlato, e men che meno so dovetrovarlo.»
«Le ricordo che lui l'ha assunta per
tirarmi fuori dal commissariato.»
«Un paio di settimane prima avevamoricevuto un suo assegno e una lettera incui spiegava che lei era un suoassociato, che l'ispettore Grandes lastava tormentando e che dovevamoassumere la sua difesa in caso di ne-
cessità. Assieme alla lettera, c'era labusta che ci ha chiesto di consegnarle dipersona. Io mi sono limitato a incassarel'assegno e a chiedere ai miei contattinella polizia di avvisarmi se laportavano lì. Così è stato e, come benricorda, ho rispettato la mia parte delcontratto e l'ho tirata fuori mi-nacciandoGrandes di tempestarlo di problemi se
non avesse facilitato la sua liberazione.Non credo che lei possa lamentarsi deinostri servizi.»
Stavolta il silenzio fu mio.
«Se non mi crede, chieda alla signorinaMargarita di mostrarle la lettera»
aggiunse Valera.
«E suo padre?» domandai.
«Mio padre?»
«Lui e Marlasca avevano rapporti conCorelli. Doveva sapere qualcosa...»
«Le assicuro che mio padre non ha maiavuto rapporti diretti con il signorCorelli. Tutta la sua corrispondenza, sec'era, perché negli archivi dello studionon ve n'è traccia, era gestitapersonalmente dal defunto signorMarlasca. In realtà, dato che me lochiede, posso dirle che mio padre arrivòa dubitare dell'esistenza di Corelli,soprattutto negli ultimi mesi di vita delsignor Marlasca, quando iniziò ad avere,per così dire, rapporti con quelladonna.»
«Quale donna?»
«La ballerina di varietà.»
«Irene Sabino?»
Lo sentii sospirare, irritato.
«Prima di morire, il signor Marlascalasciò un fondo sotto la tutela el'amministrazione dello studio pereffettuare una serie di pagamenti su unconto corrente a nome di un certo JuanCorbera e di Maria Antonia Sanahuja.»
Jaco e Irene Sabino, pensai.
«A quanto ammontava il fondo?»
«Era un deposito in divisa estera. Misembra di ricordare che fosse attorno aicentomila franchi francesi.»
«Marlasca disse dove aveva preso queisoldi?»
«Siamo uno studio legale, non didetective. Lo studio si limitò a seguire leistruzioni secondo la volontà del signorMarlasca, non a metterle indiscussione.»
«Quali altre istruzioni aveva lasciato?»
«Niente di speciale. Semplici pagamentia terzi che non avevano alcun rapportocon lo studio né con la sua famiglia.»
«Ricorda qualcuno in particolare?»
«Mio padre si occupava di questefaccende personalmente per evitare che idipendenti dello studio avesseroaccesso a informazioni, per così dire,compromettenti.»
«E a suo padre non sembrò strano che ilsuo ex socio volesse dare quei soldi adegli sconosciuti?»
«Certo che gli sembrò strano. Moltecose gli sembrarono strane.»
«Ricorda dove si dovevano inviare queipagamenti?»
«Come vuole che lo ricordi? Sono
passati almeno venticinque anni.»
«Faccia uno sforzo» dissi. «Per lasignorina Margarita.»
La segretaria mi lanciò un'occhiataterrorizzata, a cui risposi strizzandolel'occhio.
«Non le venga in mente di metterle undito addosso» minacciò Valera.
«Non mi suggerisca certe idee» tagliaicorto. «Come va la memoria? Si starinfrescando?»
«Posso consultare le agende personali dimio padre. È tutto.»
«Dove sono?»
«Qui, tra le sue carte. Però mi civorranno delle ore...»
Riagganciai e osservai la segretaria diValera, che si era messa a piangere. Letesi un fazzoletto e le diedi una paccasulla spalla.
«Su, non faccia così, adesso me ne vado.Ha visto che volevo solo parlargli?»
Annuì atterrita, senza staccare gli occhidal revolver. Mi abbottonai il cappotto ele sorrisi.
«Un'ultima cosa.»
Alzò lo sguardo temendo il peggio.
«Mi annoti l'indirizzo dell'avvocato. Enon cerchi di imbrogliarmi, perché, sedice bugie, torno e le assicuro che lasciogiù in portineria la simpatia naturale chemi caratterizza.»
Prima di uscire chiesi alla signorinaMargarita di farmi vedere dov'era ilcavo del telefono e lo tagliai,risparmiandole così la tentazione diavvisare Valera che stavo per fargli unavisita di cortesia, o di chiamare lapolizia per informarla del nostro piccolodiverbio.
14
L'avvocato Valera viveva in una villamonumentale con pretese da ca-
stello normanno incastonata all'angolotra calle Girona e calle Ausiàs March.Immaginai che avesse ereditato dalpadre quella mostruosità insieme allostudio, e che ogni pietra che la sostenevafosse forgiata con il sangue e il sudoredi intere generazioni di barcellonesi chenon avrebbero mai sognato di metterepiede in un palazzo come quello. Dissial portiere che avevo dei documentidello studio per l'avvocato, da partedella signorina Margarita, e lui, dopoaver esitato un istante, mi lasciò salire.Feci le scale senza fretta sotto il suosguardo attento. Il pianerottolo
dell'appartamento principale era piùgrande della maggioranza delleabitazioni che ricordavo dalla miainfanzia nel vecchio quartiere dellaRibera, a pochi metri da lì. Il battentedella porta era un pugno di bronzo.Appena lo presi in mano per bussare miresi conto che la porta era aperta. Spinsileggermente e mi affacciai all'interno.L'ingresso dava su un lungo corridoiolargo circa tre metri, con le paretirivestite di velluto azzurro e ricoperte diquadri. Mi chiusi la porta alle spalle escrutai nell'intensa penombra che siintravedeva in fondo al corridoio. Unamusica tenue fluttuava nell'aria, unlamento di pianoforte elegante emalinconico. Granados.
«Signor Valera?» chiamai. «SonoMartín.»
Non avendo risposta mi avventurailentamente per il corridoio, seguendoquella musica triste. Avanzai fra i quadrie le nicchie che ospitavano statue dimadonne e di santi. Il corridoio erascandito da archi successivi velati datende. Superai veli dopo veli fino araggiungerne la fine, dove si apriva unagrande stanza in penombra. Il salotto erarettangolare, con pareti ricoperte dascaffali di libri, dal pavimento alsoffitto. In fondo si distinguevano unagrande porta socchiusa e più in là letenebre palpitanti e arancioni di uncamino.
«Valera?» chiamai di nuovo, alzando lavoce.
Una figura si profilò nel fascio di luceproiettato dal fuoco attraverso la portasocchiusa. Due occhi brillanti miesaminarono sospettosi. Un cane che miparve un pastore tedesco ma con il pelobianco si avvicinò piano.
Rimasi tranquillo, mi sbottonailentamente il cappotto e cercai ilrevolver.
L'animale si fermò ai miei piedi e miguardò, lasciandosi sfuggire un lamento.Gli accarezzai la testa e lui mi leccò ledita. Poi si voltò e si avvicinò alla portaoltre la quale brillava il chiarore del
fuoco. Si arrestò sulla soglia e miguardò di nuovo. Lo seguii.
Al di là della porta trovai una sala dilettura in cui troneggiava un grandecamino. Non c'era altra luce se nonquella delle fiamme, e una danza diombre palpitanti strisciava lungo i murie il soffitto. Al centro della stanza c'eraun tavolo con il grammofono da cuiemanava quella musica. Davanti alfuoco, di spalle alla porta, c'era unagrande poltrona di pelle. Il cane vi siavvicinò e si voltò di nuovo aguardarmi. Mi avvicinai anch'io, quantobastava per vedere la mano sulbracciolo della poltrona che reggeva unasigaretta accesa da cui esalava un
pennacchio di fumo azzurro cheascendeva lentamente.
«Valera? Sono Martín. La porta eraaperta...»
Il cane si accucciò ai piedi dellapoltrona, senza smettere di fissarmi. Miavvicinai lentamente e feci il giro dellapoltrona. L'avvocato Valera era sedutodavanti al camino, con gli occhi aperti eun leggero sorriso sulle labbra.Indossava un completo con gilet e conl'altra mano reggeva in grembo unquaderno di pelle. Mi misi di fronte a luie lo guardai negli occhi. Non battevaciglio. Allora notai quella lacrima rossa,una lacrima di sangue, che gli scendeva
lenta lungo la guancia. Mi inginocchiai epresi il quaderno. Il cane mi lanciò unosguardo desolato. Gli accarezzai latesta.
«Mi dispiace» mormorai.
Il quaderno era scritto a mano esembrava una specie di agenda conparagrafi datati e separati da una brevelinea. Valera lo teneva aperto più omeno a metà. La prima annotazione dellapagina a cui era rimasto indicava cherisaliva al 23 novembre del 1904.
Nota di cassa (356-a/23-ll-04), 7500pesetas dal fondo D.M.
Consegna da parte di Marcel (di
persona) all'indirizzo fornito da D.M.Vicolo dietro il cimitero vecchio -laboratorio di scultura Sanabre e Figli.
Rilessi quella annotazione parecchievolte, cercando di strapparle qualchesenso. Conoscevo quel vicolo dai mieianni alla redazione della "Voz de laIndustria". Era una miserabile stradinasprofondata dietro i muri del cimiterodel Pueblo Nuevo dove si accalcavanolaboratori di lapidi e sculture funerarie,e moriva sulle rive di uno dei ruscelliche attraversavano la spiaggia delBogatell e la cittadella di catapecchieche si estendeva fino al mare, ilSomorrostro. Per qualche motivo,Marlasca aveva lasciato istruzioni per il
pagamento di una somma considerevolea uno di quei laboratori.
Nella pagina corrispondente a quellostesso giorno, c'era un'altra annotazionelegata a Marlasca che indicava l'iniziodei pagamenti a Jaco e a Irene Sabino.
Bonifico bancario da fondo D.M. aconto Banco Hispano Colonial (agenziacalle Fernando) n. 008965-2564-1. JuanCorbera -
Maria Antonia Sanahuja. Primamensilità di 7000 pesetas. Stabilireprogramma pagamenti.
Continuai a sfogliare il quaderno. Lamaggior parte delle annotazioni
riguardava spese e operazioni minorirelative allo studio. Dovetti scorreremolte pagine piene di cripticipromemoria prima di trovarne un'altra incui fosse menzionato Marlasca. Dinuovo, si trattava di un pagamento incontanti attraverso quel Marcel,probabilmente uno dei tirocinanti dellostudio.
Nota di cassa (379-a/29-12-04) 15.000pesetas dal fondo D.M.
Consegna tramite Marcel. Spiaggia delBogatell, vicino passaggio a livello. Ore9. Il contatto si identificherà.
La Strega del Somorrostro, pensai.Dopo morto, Diego Marlasca aveva
distribuito rilevanti somme di denaroattraverso il suo socio. Questo con-traddiceva i sospetti di Salvador cheJaco fosse fuggito con i soldi. Marlascaaveva ordinato i pagamenti di personalasciando il denaro su un fondo tutelatodallo studio legale. Gli altri duepagamenti suggerivano che poco primadi morire aveva avuto rapporti con unlaboratorio di sculture funerarie e conqualche torbido personaggio delSomorrostro, rapporti che si eranotradotti in una grande quantità di denaroche cambiava di mano. Chiusi ilquaderno più smarrito che mai.
Stavo per lasciare la casa quando,voltandomi, notai che una delle pareti
della sala di lettura era ricoperta daritratti accuratamente incorniciati su unosfondo di velluto granata. Mi avvicinai ericonobbi il volto severo e imponentedel patriarca Valera, il cui ritratto a oliodominava ancora l'ufficio del figlio.L'avvocato compariva nella maggiorparte delle immagini in compagnia diuna serie di uomini importanti e dinobili della città, in quelle chesembravano differenti occasionimondane ed eventi civici. Bastavascorrere una dozzina di quei ritratti eidentificare la serie di personalità cheposavano sorridenti accanto al vecchioavvocato per constatare che lo studioValera, Marlasca e Sentis era un organovitale per il funzionamento di
Barcellona. Anche il figlio di Valera,molto più giovane ma chiaramentericonoscibile, compariva in qualchefoto, sempre in secondo piano, semprecon lo sguardo sepolto nell'ombra delpatriarca.
Lo sentii prima di vederlo. In un ritrattoc'erano Valera padre e figlio. La foto erastata scattata all'ingresso del numero442 della Diagonal, sotto lo studio.Accanto a loro c'era un signore alto edistinto. Il suo volto compariva in moltealtre foto della collezione, sempreaccanto a Valera. Diego Marlasca. Miconcentrai su quello sguardo torbido, suquell'espressione tagliente e serena chemi osservava da un'istantanea scattata
venticinque anni prima. Come ilprincipale, non era invecchiato di ungiorno. Sorrisi amaramente quandocompresi la mia ingenuità. Quel voltonon era lo stesso che compariva nellafoto che mi aveva dato il mio amico, l'expoliziotto.
L'uomo che conoscevo come RicardoSalvador non era altri che DiegoMarlasca.
15
La scala era al buio quando lasciai ilpalazzo della famiglia Valera.Attraversai l'atrio a tentoni e quandoaprii la porta i lampioni della stradaproiettarono all'interno un rettangolo di
chiarore azzurrato al cui termine trovailo sguardo del portiere. Mi allontanai dalì a passo svelto verso calle Trafalgar,da dove partiva il tram notturno chelasciava alle porte del cimitero delPueblo Nuevo, lo stesso che tante nottiavevo preso con mio padre quando glifacevo compagnia nel suo turno disorveglianza alla "Voz de la Industria".
Non c'erano quasi passeggeri e misedetti davanti. Via via che ci avvici-navamo al Pueblo Nuevo, il tram siaddentrava in una rete di stradetenebrose, ricoperte da grandipozzanghere velate dal vapore. C'eranosolo rari lampioni e le luci del tramandavano svelando i contorni delle cose
come torce in un tunnel. Alla fineavvistai le porte del cimitero e il profilodi croci e sculture che si stagliavasull'orizzonte sconfinato di fabbriche efumaioli che iniettavano strie di rosso edi nero nella volta del cielo. Un brancodi cani famelici si aggirava ai piedi deidue grandi angeli che sorvegliavano ilrecinto. Per un istante rimasero immobilia guardare i fari del tram, gli occhiardenti come quelli degli sciacalli, poisi dispersero nell'ombra.
Scesi dal tram ancora in marcia ecominciai a fare il giro dei muri delcamposanto. Il tram si allontanò comeuna nave nella nebbia e affrettai ilpasso. Sentivo lo scalpiccio e l'odore
dei cani che mi seguivano nell'oscurità.Quando raggiunsi il retro del cimitero,mi fermai all'angolo di un vicolo elanciai un sasso alla cieca. Sentii unlamento acuto e passi rapidi che siallontanavano nella notte. Imboccai ilvicolo, appena un passaggio incastratotra il muro e la fila di laboratori disculture funerarie che si accalcavanouno dopo l'altro. Il cartello di Sanabre eFigli ondeggiava al chiarore di unlampione che proiettava una luce ocra epolverosa a una trentina di metri didistanza. Mi avvicinai alla porta, solouna grata assicurata con delle catene eun catenaccio arrugginito che feci saltarecon una sola pallottola.
Il vento che soffiava dall'estremità delvicolo, impregnato del salnitro del mareche s'infrangeva ad appena un centinaiodi metri, si portò via l'eco dello sparo.Aprii la grata ed entrai nel laboratoriodi Sanabre e Figli. Scostai la tenda ditela scura che mascherava l'interno elasciai che il chiarore del lampione vipenetrasse. Era una navata stretta eprofonda popolata da statue di marmocongelate nelle tenebre, con i voltiscolpiti a metà. Avanzai di qualchepasso fra vergini e madonne chereggevano bambini tra le braccia, damebianche con in mano rose di marmo chealzavano lo sguardo al cielo e blocchi dipietra sui quali iniziavano a disegnarsidegli sguardi.
Si avvertiva nell'aria l'odore dellapolvere di marmo. Non c'era nessuno lì,tranne quelle effigi senza nome. Stavoper tornare indietro quando lo vidi.
La mano spuntava da dietro un retablo disculture coperto da un telo in fondo allaboratorio. Mi avvicinai lentamente e ilsuo contorno si andò rivelandocentimetro dopo centimetro. Mi cifermai davanti e contemplai quel grandeangelo buono, lo stesso che il principaleportava sul risvolto della giacca e cheavevo trovato in fondo al baule del miostudio. Doveva essere alto due metri emezzo. Osservandone il volto, nericonobbi i tratti e soprattutto il sorriso.Ai suoi piedi c'era una lapide. Incisa
sulla pietra, si poteva leggere unascritta.
DAVID MARTÍN
1900-1930
Sorrisi. Se qualcosa dovevo riconoscereal mio buon amico Diego Marlasca erail senso dell'ironia e il gusto per lesorprese. Mi dissi che non dovevostupirmi se, nel suo zelo, avevaanticipato le circostanze preparan-domiun sentito commiato. Mi inginocchiaidavanti alla lapide e accarezzai il mionome. Passi lenti e leggeri si sentivanoalle mie spalle. Mi voltai e scoprii unviso familiare. Il bambino aveva lostesso vestito nero che indossava
quando, settimane prima, mi avevaseguito sul paseo del Born.
«La signora la riceverà adesso» disse.
Annuii e mi alzai. Il bambino mi tese lamano e la presi.
«Non abbia paura» disse guidandomiverso l'uscita.
«Non ne ho» mormorai.
Mi condusse fino in fondo al vicolo. Dalì si poteva intravedere la linea dellaspiaggia, nascosta dietro una fila dimagazzini dilapidati e resti di un trenomerci abbandonato su un binario mortoricoperto dalle sterpaglie. I vagoni
erano corrosi dalla ruggine e lalocomotiva era ridotta a uno scheletro dicaldaie e ferraglia in attesa didemolizione.
In alto, la luna si affacciò dalle crepe diuna volta di nuvole plumbee. Al largo siintravedevano alcune navi da caricosepolte fra le onde e, davanti allaspiaggia del Bogatell, un ossario divecchi scafi di pescherecci e barche dipiccolo cabotaggio sputati lì dalletempeste e incagliati nella sabbia.
Dall'altra parte, come un manto di scoriedisteso alle spalle della fortezza ditenebre industriali, si estendeval'accampamento di baracche del
Somorrostro. Le onde si infrangevano apochi metri dalla prima linea di capannedi canne e legno. Pennacchi di fumobianco strisciavano fra i tetti di quelvillaggio di miseria che cresceva fra lacittà e il mare come un infinitoimmondezzaio umano. Il fetore dellaspazzatura bruciata aleggiava nell'aria.
Ci addentrammo nelle strade di quellacittà dimenticata, passaggi ricavati trastrutture messe su con mattoni rubati,fango e legna restituiti dalla marea. Ilbambino mi guidò verso l'interno,incurante degli sguardi diffidenti dellagente del posto. Lavoratori giornalierisenza lavoro, zingari espulsi da altriaccampamenti simili sorti sui fianchi del
Montjuïc o davanti alle fosse comuni delcimitero di Can Tunis, bambini e anzianiabbandonati.
Tutti mi osservavano con sospetto.Donne dall'età indefinibile riscaldavanosul fuoco acqua o cibo in recipienti dilatta davanti alle baracche. Cifermammo di fronte a una struttura di unbianco sbiadito alle cui porte c'era unabambina con la faccia da anziana chezoppicava su una gamba colpita dallapoliomielite, trascinando un secchio incui si agitava qualcosa di gri-giastro eviscoso. Anguille. Il bambino indicò laporta.
«È qui» disse.
Diedi un'ultima occhiata al cielo. Laluna si nascondeva di nuovo fra le nubi eun velo di oscurità avanzava dal mare.
Entrai.
16
Aveva il viso disegnato dai ricordi e unosguardo che avrebbe potuto a-
vere dieci o cent'anni. Era sedutaaccanto a un piccolo fuoco econtemplava la danza delle fiamme conla stessa fascinazione con cui l'avrebbefatto un bambino. I suoi capelli, delcolore della cenere, erano annodati inuna treccia. Il fisico era snello e austero,i gesti brevi e lenti. Vestiva di bianco e
portava un fazzoletto di seta annodatoalla gola. Mi sorrise calorosamente e mioffrì una sedia vicino a lei. Mi sedetti.Restammo un paio di minuti in silenzio,ascoltando il crepitio delle braci e ilrumore della marea. In sua presenza, iltempo sembrava essersi fermato el'urgenza che mi aveva condotto alla suaporta era stranamente svanita. A poco apoco l'alito del fuoco mi penetrò e ilfreddo che mi si era insinuato fin nelleossa si sciolse al riparo della suacompagnia. Solo allora distolse gliocchi dal fuoco e, prendendomi la mano,aprì bocca.
«Mia madre è vissuta in questa casa perquarantacinque anni» disse.
«Allora non era nemmeno una casa, masoltanto una capanna fatta con le canne ei relitti portati dalla marea. Perfinoquando si fece una reputazione ed ebbela possibilità di andarsene si rifiutò difarlo. Diceva sempre che il giorno in cuiavesse lasciato il Somorrostro sarebbemorta. Era nata qui, con la gente dellaspiaggia, e qui è rimasta fino all'ultimogiorno. Di lei si sono dette tante cose.Molti ne hanno parlato e pochissimil'hanno conosciuta davvero. Molti latemevano e la odiavano. Anche dopomorta. Le racconto tutto questo perchémi sembra giusto farle sapere che nonsono la persona che cerca. La personache cerca, o che crede di cercare, quellache molti chiamavano la Strega del
Somorrostro, era mia madre.»
La guardai confuso.
«Quando...?»
«È morta nel 1905» disse. «L'hannoammazzata a pochi metri da qui, vicinoalla spiaggia, con una coltellata alcollo.»
«Mi dispiace. Credevo che...»
«Sono in molti a crederlo. Il desideriodi credere sconfigge persino la morte.»
«Chi l'ha uccisa?»
«Lei lo sa.»
Tardai qualche secondo a rispondere.
«Diego Marlasca...»
Annuì.
«Perché?»
«Per farla tacere. E cancellare le suetracce.»
«Non capisco. Sua madre l'avevaaiutato... E lui in cambio le aveva datoun bel po' di soldi.»
«Proprio per questo l'ha uccisa, perchési portasse il segreto nella tomba.»
Mi osservò con un sorriso lieve, come
se la mia confusione la divertisse e allostesso tempo le ispirasse compassione.
«Mia madre era una donna semplice,signor Martín. Era cresciuta nellamiseria e l'unico potere che aveva era lavolontà di sopravvivere. Non imparòmai a leggere e scrivere, ma sapevavedere dentro le persone. Sentiva quelloche sentivano, quello che nascondevanoe quello che desideravano.
Lo leggeva nei loro sguardi, nei loroatteggiamenti, nel modo in cuicamminavano o gesticolavano. Sapevain anticipo quello che avrebbero detto efatto. Per questo molti la chiamavanoindovina, perché era capace di vedere in
loro quello che essi stessi si rifiutavanodi vedere. Si guadagnava da viverevendendo pozioni d'amore e incantesimiche preparava con l'acqua del ruscello,qualche erba e un po' di zucchero.Aiutava anime smarrite a credere in ciòche desideravano credere. Quando il suonome cominciò a diventare popolare,molta gente altolocata iniziò a farlevisita e a sollecita-re i suoi favori. Iricchi volevano diventarlo ancora dipiù. I potenti volevano più potere. Imeschini volevano sentirsi santi, e isanti volevano essere puniti per peccatiche rimpiangevano di non avercommesso per mancanza di coraggio.Mia madre ascoltava tutti e accettava illoro denaro.
Con quei soldi mandò me e i mieifratelli a studiare nelle scuole chefrequentavano i figli dei suoi clienti. Cicomprò un altro nome e un'altra vitalontano da questo posto. Mia madre erauna brava persona, signor Martín.
Non si lasci ingannare. Non si approfittòmai di nessuno, né fece credere allepersone altro che quello in cui avevanobisogno di credere. La vita le avevainsegnato che viviamo di grandi epiccole menzogne quanto dell'a-ria.Diceva che se fossimo capaci di vederesenza paraocchi la realtà del mondo e dinoi stessi per un solo giorno, dall'alba altramonto, ci toglie-remmo la vita operderemmo la ragione.»
«Però...»
«Se è venuto qui in cerca di magia, mispiace deluderla. Mia madre mi haspiegato che non c'è magia, che non c'èaltro male o bene al mondo se nonquello che immaginiamo, per avidità oingenuità. A volte, perfino per follia.»
«Non fu questo che raccontò a DiegoMarlasca quando accettò i suoi soldi»obiettai. «Settemila pesetas diquell'epoca dovevano poter comprareparecchi anni di buon nome e buonescuole.»
«Diego Marlasca aveva bisogno dicredere. Mia madre l'aiutò a farlo.
Tutto qui.»
«Credere in cosa?»
«Nella propria salvezza. Era convinto diavere tradito se stesso e quelli chel'amavano. Credeva di aver incamminatola sua vita su una strada di cattiveria efalsità. Mia madre pensò che questo nonlo rendeva diverso dalla maggioranzadegli uomini che si fermano in qualchemomento della loro vita a guardarsi allospecchio. Sono le bestiacce meschine aconside-rarsi sempre virtuose e aguardare il resto del mondo dall'alto inbasso. Ma Diego Marlasca era un uomodi coscienza e non era soddisfatto di ciòche vedeva. Per questo venne da mia
madre. Perché aveva perso la speranza eprobabilmente la ragione.»
«Marlasca disse quello che avevafatto?»
«Disse di aver consegnato l'anima aun'ombra.»
«Un'ombra?»
«Queste furono le sue parole. Un'ombrache lo seguiva, che aveva la sua stessaforma, il suo stesso volto e la sua stessavoce.»
«Cosa significava?»
«La colpa e il rimorso non hanno
significato. Sono sentimenti, emozioni,non idee.»
Mi venne in mente che nemmeno ilprincipale avrebbe potuto spiegarlo conmaggiore chiarezza.
«E cosa poteva fare sua madre per lui?»
«Niente di più che consolarlo e aiutarloa trovare un po' di pace. Diego Marlascacredeva nella magia e per questo motivomia madre pensò di do-verlo convincereche il suo cammino verso la salvezzapassava attraverso di lei. Gli parlò di unvecchio incantesimo, una leggenda dipescatori ascoltata da bambina fra lebaracche della spiaggia. Quando unuomo perde la rotta della propria vita e
sente che la morte ha assegnato unprezzo alla sua anima, secondo laleggenda, se trova un'anima puradisposta a sacrificarsi per lui,occultando il suo cuore nero, la morte,cieca, girerà al largo.»
«Un'anima pura?»
«Libera dal peccato.»
«E come si realizzava questosacrificio?»
«Con dolore, naturalmente.»
«Che specie di dolore?»
«Un sacrificio di sangue. Un'anima in
cambio di un'altra. Morte in cambio divita.»
Un lungo silenzio. Il rumore del maresulla riva e quello del vento tra lecatapecchie.
«Irene si sarebbe strappata gli occhi e ilcuore per Marlasca. Era la sua unicaragione di vita. Lo amava ciecamente e,come lui, credeva che la sua unicasalvezza fosse nella magia. All'iniziovoleva togliersi la vita e offrir-la insacrificio, ma mia madre la dissuase. Ledisse quanto già sapeva, che la sua nonera un'anima libera dal peccato e ilsacrificio sarebbe stato vano.
Glielo disse per salvarla. Per salvarli
entrambi.»
«Da chi?»
«Da se stessi.»
«Ma commise un errore...»
«Nemmeno mia madre poteva vederetutto.»
«Che cosa fece Marlasca?»
«Mia madre non volle mai dirmelo, nonvoleva che io o i miei fratelli fossimocoinvolti. Ci mandò lontano e ci separòin collegi diversi per farci dimenticareda dove venivamo e chi eravamo.Diceva che ora eravamo noi i maledetti.
Morì poco dopo, sola. Non lo venimmoa sapere per molto tempo. Quandotrovarono il suo cadavere, nessuno osòtoccarlo e lasciarono che il mare se loportasse via. Nessuno si azzardava aparlare della sua morte. Ma io sapevochi l'aveva uccisa e perché. E ancoraoggi credo che mia madre sapesse chesarebbe morta presto e per mano di chi.Lo sapeva e non fece nulla perché allafine anche lei ci credette. Ci credetteperché non era capace di accettare ciòche aveva fatto. Credette che, offrendola propria anima, avrebbe salvato lanostra, quella di questo posto. Perciònon volle andarsene, perché secondo lavecchia leggenda l'anima che si offredeve restare sempre nel luogo in cui è
stato commesso il tradimento, una bendasugli occhi della morte, incarcerata persempre.»
«E dov'è l'anima che salvò quella diDiego Marlasca?»
La donna sorrise.
«Non ci sono anime né salvezze, signorMartín. Si tratta di vecchie favole edicerie. Ci sono solo ceneri e ricordi.Ma se ci fossero, sarebbero nel luogo incui Marlasca commise il suo delitto, ilsegreto che ha nascosto in tutti questianni per prendersi gioco del propriodestino.»
«La casa della torre... Ci ho abitato per
quasi dieci anni e in quella casa non c'ènulla.»
Sorrise di nuovo e, fissandomi negliocchi, si chinò verso di me e mi baciòsulla guancia. Le sue labbra eranogelide, come quelle di un cadavere.
Il suo alito sapeva di fiori morti.
«Forse non ha saputo guardare dovedoveva» mi sussurrò all'orecchio.
«Forse quell'anima imprigionata è lasua.»
A quel punto si sciolse il fazzoletto chele copriva la gola e vidi che una grandecicatrice le attraversava il collo.
Stavolta il suo sorriso fu malizioso e isuoi occhi brillarono di una luce crudelee burlona.
«Presto spunterà il sole. Se ne vadafinché è ancora in tempo» disse laStrega del Somorrostro, dandomi lespalle e rivolgendo lo sguardo al fuoco.
Il bambino con il vestito nero comparvesulla soglia e mi tese la mano, come adirmi che il mio tempo era scaduto. Mialzai e lo seguii. Mentre mi voltavo, misorprese il mio riflesso in uno specchioappeso al muro. Vi si scorgeva il profilocurvo e ricoperto di stracci di unavecchia seduta davanti al fuoco. La suarisata cupa e crudele mi accompagnò
fino all'uscita.
17
Quando arrivai alla casa della torre,iniziava ad albeggiare. La serraturadella porta sulla strada era rotta. Spinsicon la mano ed entrai nell'atrio. Ilmeccanismo del chiavistello sul retrodella porta sprigionava fumo e un odoreintenso. Acido. Salii le scale lentamente,convinto che avrei trovato Marlasca adaspettarmi nell'oscurità del pianerottolo,o che se mi fossi vol-tato l'avrei visto lì,alle mie spalle, sorridente. Sull'ultimotratto di scale notai che anche il forodella serratura della portadell'appartamento eviden-ziava tracce di
acido. Introdussi la chiave e dovettiarmeggiare quasi due minuti persbloccare la serratura, che era rimastamutilata, ma apparente-mente non avevaceduto. Tirai fuori la chiave corrosa daquella sostanza e aprii la porta con unospintone. Me la lasciai aperta alle spallee avanzai lungo il corridoio senzatogliermi il cappotto. Estrassi ilrevolver dalla tasca e aprii il tamburo.Tolsi i bossoli dei colpi che avevosparato e li sosti-tuii con pallottolenuove, come avevo visto fare tante voltea mio padre quando tornava a casaall'alba.
«Salvador?» chiamai.
L'eco della mia voce si propagò per lacasa. Armai il percussore. Continuai ainoltrarmi nel corridoio fino ad arrivarealla stanza in fondo. La porta erasocchiusa.
«Salvador?» dissi di nuovo.
Puntai l'arma contro la porta e l'apriicon un calcio. Non c'era traccia diMarlasca all'interno, solo la montagna dicasse e vecchi oggetti ammuc-
chiati contro il muro. Sentii di nuovoquell'odore che sembrava filtrare dallepareti. Mi avvicinai all'armadio cheoccupava la parete in fondo e spalancaile ante. Tolsi i vecchi vestiti appesi allegrucce. La corrente fredda e umida che
sgorgava da quel foro nel muro miaccarezzò la faccia. Qualunque cosaMarlasca avesse nascosto in quellacasa, era dietro quella parete.
Rimisi l'arma nella tasca del cappotto eme lo tolsi. Introdussi il braccio nellafessura tra l'armadio e la parete. Riusciiad afferrare la parte posteriore con lamano e tirai con forza. Il primo strattonemi permise di guadagnare un paio dicentimetri per rafforzare la presa e tiraidi nuovo. L'armadio cedette di quasi unpalmo. Continuai a spingere versol'esterno finché la parete dietrol'armadio rimase allo scoperto ed ebbilo spazio per infilarmi-ci. Una volta lì,spinsi con la spalla e lo spostai
completamente verso la parete contigua.Mi fermai a riprendere fiato ed esaminaiil muro. Era dipinto di un colore ocradiverso dal resto della stanza. Sotto lapittura si indovinava una specie diimpasto argilloso non rifinito. Lo colpiicon le nocche.
L'eco che ne risultò non dava adito adubbi. Quello non era un muro maestro.C'era qualcosa dall'altra parte.Appoggiai la testa contro la parete e tesil'orecchio. Allora sentii un rumore.Passi in corridoio che si avvicinavano...Arretrai lentamente e allungai la manoverso il cappotto che avevo lasciato suuna sedia per prendere il revolver.Un'ombra si stagliò sulla soglia.
Trattenni il respiro. La figura si affacciòa poco a poco all'interno della stanza.
«Ispettore...» mormorai.
Víctor Grandes mi sorrise freddamente.Immaginai che mi aspettassero da orenascosti in qualche portone.
«Sta facendo lavori di ristrutturazione,Martín?»
«Metto in ordine.»
L'ispettore guardò il mucchio di vestiti escatoloni gettati a terra e l'armadiosgangherato e si limitò ad annuire.
«Ho chiesto a Marcos e Castelo di
aspettare di sotto. Avrei bussato, ma leiha lasciato la porta aperta e mi sonopreso la libertà... Mi sono detto: vuoldire che l'amico Martín mi staaspettando.»
«Cosa posso fare per lei, ispettore?»
«Seguirmi al commissariato, se è cosìgentile.»
«Sono in arresto?»
«Temo di sì. Mi renderà le cose facili odovremo ricorrere alle maniere forti?»
«No» assicurai.
«Gliene sono grato.»
«Posso prendere il cappotto?» chiesi.
Grandes mi guardò un istante negliocchi. Poi prese il cappotto e mi aiutò amettermelo. Sentii il peso del revolvercontro la gamba. Mi abbottonai concalma. Prima di uscire dalla stanza,l'ispettore diede un'ultima occhiata almuro rimasto scoperto. Poi mi fececenno di uscire in corridoio. Marcos eCastelo erano saliti fino al pianerottoloe aspettavano con un sorriso trionfante.Arrivato in fondo al corridoio, mifermai un momento per guardarel'interno della casa, che sembravaripiegarsi in un pozzo di ombre. Michiesi se l'avrei mai rivista. Castelo tiròfuori le manette, ma Grandes fece un
cenno di diniego.
«Non sarà necessario, vero, Martín?»
Scossi la testa. Grandes socchiuse laporta e mi spinse dolcemente ma confermezza verso le scale.
18
Stavolta non ci furono colpi a effetto, néscenografie cupe, né echi di celle umidee buie. La stanza era ampia, luminosa econ i soffitti alti. Mi fece pensareall'aula di una scuola religiosa di lusso,crocifisso al muro incluso. Si trovava alprimo piano del Comando di polizia eaveva ampi finestroni che permettevanodi osservare le persone e i tram che già
iniziavano la loro sfilata mattutina sullavia Layetana. Al centro c'erano duesedie e un tavolo di metallo che,abbandonati in mezzo a tanto spaziovuoto, sembravano minuscoli. Grandesmi guidò verso il tavolo e ordinò aMarcos e Castelo di lasciarci soli. I duepoliziotti si presero il loro tempo pereseguire l'ordine. La rabbia cherespiravano si poteva fiutare nell'aria.Grandes attese che fossero usciti e sirilassò.
«Credevo che mi desse in pasto aileoni» dissi.
«Si sieda.»
Obbedii. Non fosse stato per le occhiate
di Marcos e Castelo mentre uscivano,per la porta di metallo e le sbarre allefinestre, nessuno avrebbe detto che lamia situazione era grave. Finirono perconvincermi il thermos di caffè caldo eil pacchetto di sigarette che Grandeslasciò sul tavolo, ma soprattutto il suosorriso sereno e affabile. Sicuro.Stavolta l'ispettore faceva sul serio.
Si sedette di fronte a me e aprì unacartellina, da cui tirò fuori dellefotografie che mise sul tavolo, unaaccanto all'altra. Nella prima comparival'avvocato Valera sulla poltrona del suosalotto. Vicino c'era un'immagine delcadavere della vedova Marlasca, o diquello che ne restava dopo averlo tirato
fuori dal fondo della piscina della suacasa sulla carretera de Vallvidrera. Unaterza fotografia mostrava un ometto conla gola squarciata che assomigliava aDamián Roures. La quarta immagine eradi Cristina Sagnier, e mi resi conto cheera stata scattata il giorno delle nozzecon Pedro Vidal. Le ultime due eranoritratti da studio dei miei ex editori,Barrido ed Escobillas. Una volta cheebbe allineato in bell'ordine le sei foto,Grandes mi rivolse uno sguardoimpenetrabile e lasciò trascorrere unpaio di minuti di silenzio, studiando lamia reazione alle immagini, o la suaassenza. Poi, con infinita flemma, versòdue tazze di caffè e ne spinse una versodi me.
«Prima di tutto, mi piacerebbe darlel'opportunità di essere lei a raccontarmiogni cosa, Martín. A modo suo e senzafretta» disse alla fine.
«Non servirà a niente» replicai. «Noncambierà niente.»
«Preferisce un faccia a faccia con altripossibili implicati? Con la suaassistente, per esempio? Come sichiama? Isabella?»
«La lasci in pace. Lei non sa niente.»
«Mi convinca.»
Guardai verso la porta.
«C'è solo un modo per uscire da questastanza, Martín» disse l'ispettoremostrandomi una chiave.
Sentii di nuovo il peso del revolvernella tasca del cappotto.
«Da dove vuole che inizi?»
«È lei il narratore. Le chiedo solo didirmi la verità.»
«Non so qual è.»
«La verità è quella che fa male.»
Per oltre due ore, Víctor Grandes nonaprì bocca nemmeno una volta.
Ascoltò attentamente, annuendo ognitanto e annotando qualche parola sul suoquaderno di quando in quando. All'iniziolo guardavo, ma presto mi dimenticaiche era lì e scoprii che stavoraccontando la storia a me stesso.
Le parole mi fecero riandare a un tempoche credevo perduto, alla notte in cuiavevano assassinato mio padre davantialla sede del giornale. Ricordai i mieigiorni alla "Voz de la Industria", gli anniin cui avevo vissuto scrivendo raccontidel terrore e la prima lettera firmata daAndreas Corelli che mi augurava grandisperanze. Ricordai il primo incontro conil principale alla cisterna e i giorni incui la certezza di una morte sicura era
tutto l'orizzonte che mi si spalancavadavanti. Gli parlai di Cristina, di Vidal edi una storia il cui finale chiunqueavrebbe potuto intuire eccetto me. Gliparlai dei due libri che avevo scritto,uno con il mio nome e l'altro con quellodi Vidal, della perdita di quelle miseresperanze, e del pomeriggio in cui vidimia madre gettare nella spazzatural'unica cosa buona che credevo di averfatto nella vita. Non cercavo lacomprensione né la compassionedell'ispettore. Mi bastava tracciare unamappa immaginaria degli avvenimentiche mi avevano condotto in quellastanza, a quell'istante di vuoto assoluto.
Tornai in quella casa accanto al Park
Güell e alla sera in cui il principale miaveva formulato un'offerta che nonpotevo rifiutare, che non volevorifiutare. Confessai i miei primi sospetti,le scoperte sulla storia della casa dellatorre, sulla strana morte di DiegoMarlasca e sulla rete di inganni in cuiero caduto o che avevo scelto persoddisfare la mia vanità, la mia avidità ela mia volontà di vivere a qualunquecosto. Vivere per raccontare quellastoria.
Non tralasciai nulla. Nulla tranne lacosa più importante, quella che nonosavo raccontare nemmeno a me stesso.Nel mio racconto, tornavo alla clinica diVilla San Antonio in cerca di Cristina e
trovavo solo una scia di orme che siperdevano nella neve. Forse, se me lofossi ripetuto varie volte, perfino iosarei arrivato a credere che era andatacosì. La mia storia terminava quellastessa mattina, di ritorno dallecatapecchie del Somorrostro, con lascoperta che Diego Marlasca avevadeciso che la foto mancan-te nella seriedisposta sul tavolo dall'ispettore era lamia.
Terminato il racconto, sprofondai in unlungo silenzio. Non mi ero mai sentitotanto stanco in vita mia. Avrei volutoandarmene a dormire e non svegliarmimai più. Grandes mi osservava dall'altrolato del tavolo. Mi sembrò che fosse
confuso, triste, collerico e soprattuttosperduto.
«Dica qualcosa» lo esortai.
Sospirò. Si alzò dalla sedia che nonaveva abbandonato durante tutta la miastoria e si avvicinò alla finestra,dandomi le spalle. Mi vidi estrarre ilrevolver dal cappotto, sparargli nellanuca e uscire da lì con la chiave che siera messo in tasca. In sessanta secondisarei potuto essere in strada.
«Il motivo per cui stiamo parlando è cheieri è arrivato un telegramma dallacaserma della Guardia Civil diPuigcerdà con la notizia che CristinaSagnier è scomparsa dalla clinica di
Villa San Antonio e che lei è ilprincipale sospettato. Secondo il medicodel centro, lei aveva manifestato la suaintenzione di portarsela via e lui nonglielo ha concesso. Le racconto tuttoquesto affinché capisca esattamenteperché siamo qui, in questa stanza, concaffè caldo e sigarette, a chiacchierarecome vecchi amici. Siamo qui perché lamoglie di uno degli uomini più ricchi diBarcellona è scomparsa e lei è l'unicoche sa dove si trova. Siamo qui perché ilpadre del suo amico Pedro Vidal, unodegli uomini più potenti di questa città,si è interessato al caso perché a quantopare è un suo vecchio conoscente e hachiesto ama-bilmente ai miei superioridi ottenere quelle informazioni prima di
torcerle un capello e di lasciare a dopoogni altra considerazione. Non fossestato per questo, e per la mia insistenzanell'avere un'opportunità per cercare dichiarire la questione a modo mio, leiadesso si troverebbe in una cella delCampo de la Bota e invece di parlarecon me dovrebbe vedersela con Marcose Castelo i quali, per sua informazione,credono che bisognerebbe cominciare aspezzarle le ginocchia con un martello,perché tutto il resto è una perdita ditempo e mette in pericolo la vita dellasignora Vidal. E questa opinione a ogniminuto che passa è sempre più condivisadai miei superiori, convinti che io le stialasciando troppa briglia a causa dellanostra amicizia.»
Grandes si voltò e mi guardò trattenendol'ira.
«Non mi ha ascoltato» dissi. «Non hasentito niente di quello che le ho detto.»
«L'ho ascoltata benissimo, Martín. Hoascoltato come, moribondo e disperato,ha formalizzato un accordo con un piùche misterioso editore pa-rigino, di cuinessuno ha mai sentito parlare e chenessuno ha mai visto, per inventarsi,secondo le sue stesse parole, una nuovareligione in cambio di centomila franchifrancesi, solo per scoprire che in realtàera caduto in un sinistro complotto in cuisarebbero implicati un avvocato, che hasimu-lato la propria morte venticinque
anni fa, e la sua amante, una ballerina divarietà in disgrazia, per sfuggire alproprio destino, che adesso è il suo. Hoascoltato come questo destino l'ha fattacadere nella trappola di una casamaledetta che aveva già catturato il suopredecessore, Diego Marlasca, e doveha trovato la prova che qualcuno laseguiva e uccideva tutti coloro chepotevano svelare il segreto di un uomoche, a giudicare dalle sue parole, erapazzo quasi quanto lei. L'uomonell'ombra, che avrebbe assuntol'identità di un ex poliziotto peroccultare il fatto di essere vivo, hacommesso una serie di crimini conl'aiuto della sua amante, incluso quellodi aver provocato la morte del signor
Sempere per qualche strano motivo chenemmeno lei è in grado di spiegare.»
«Irene Sabino ha ucciso Sempere perrubargli un libro. Un libro che secondolei conteneva la mia anima.»
Grandes si batté la palma della manosulla fronte, come se avesse appenatrovato il quid della questione.
«Certo. Che stupido. Questo spiega tutto.Come quel terribile segreto che unamaga della spiaggia del Bogatell le hasvelato. La Strega del Somorrostro. Mipiace. Molto nel suo stile. Vediamo seho capito bene. Il Marlasca tieneprigioniera un'anima per occultare la suae sfuggire così a una specie di
maledizione. Mi dica, l'ha preso dallaCittà dei maledetti o se l'è appenainventato?»
«Non mi sono inventato nulla.»
«Si metta al mio posto e pensi secrederebbe a qualcosa di quello che hadetto.»
«Immagino di no. Ma le ho raccontatotutto quello che so.»
«Naturalmente. Mi ha fornito dati eprove concrete per verificare la ve-ridicità del suo racconto, dalla visitacon il dottor Trias al suo conto correntepresso il Banco Hispano Colonial, allasua stessa lapide mortuaria che l'attende
in un laboratorio del Pueblo Nuevo, eperfino a un vincolo legale tra l'uomoche lei chiama il principale e lo studioValera, nonché molti altri dettaglifattuali che non smentiscono la suaesperienza nella creazione di storiepoliziesche. L'unica cosa che non mi haraccontato e che, francamente, per il suobene e per il mio, speravo di sentire èdove si trova Cristina Sagnier.»
Capii che l'unico modo per salvarmi inquel momento era mentire.
Dall'istante in cui avessi detto la veritàsu Cristina, le mie ore sarebbero statecontate.
«Non lo so.»
«Mente.»
«Le ho già detto che non servirebbe anulla raccontarle la verità» replicai.
«Tranne che a farmi fare la figura dellostupido per averla voluta aiutare.»
«È questo che sta cercando di fare,ispettore? Aiutarmi?»
«Sì.»
«Allora verifichi tutto quello che le hodetto. Trovi Marlasca e Irene Sabino.»
«I miei superiori mi hanno concessoventiquattr'ore con lei. Se per allora nonconsegno Cristina Sagnier sana e salva,
o almeno viva, mi toglieranno il caso elo passeranno a Marcos e Castelo, cheda tempo aspettano l'opportunità diacquistare meriti e non lasprecheranno.»
«Allora non perda tempo.»
Grandes sbuffò ma annuì.
«Spero che sappia quello che stafacendo, Martín.»
19
Calcolai che dovevano essere le novedel mattino quando l'ispettore Grandesmi lasciò chiuso in quella stanza senzaaltra compagnia che il thermos con il
caffè freddo e il suo pacchetto disigarette. Fece appostare uno dei suoiuomini alla porta e lo sentii ordinargli dinon permettere a nessuno di entrare pernessun motivo. Cinque minuti dopo lasua partenza, sentii qualcuno bussare ericonobbi il viso del sergente Marcosritagliato nel finestrino di vetro. Nonpotevo sentire le sue parole, ma lacalligrafia delle sue labbra non lasciavaspazio ai dubbi.
Comincia a prepararti, figlio diputtana.
Passai il resto della mattinata seduto suldavanzale della finestra a osservare lagente che si credeva libera camminare al
di là delle sbarre, fumando e mangiandozollette di zucchero con lo stessogodimento con cui lo avevo visto faredal principale in più di un'occasione. Lastanchezza, o forse solo il rinculo delladisperazione, mi raggiunsero versomezzogiorno e mi stesi a terra, la facciarivolta al muro. Mi addormentai in menodi un minuto. Quando mi svegliai, lastanza era in penombra. Si era già fattoscuro e il chiarore ocra dei lampioni divia Layetana disegnava ombre di auto edi tram sul soffitto. Mi alzai, con ilfreddo del pavimento che m'im-pregnavatutti i muscoli, e mi avvicinai a unradiatore in un angolo, ma era più gelidodelle mie mani.
In quell'istante sentii che la porta siapriva alle mie spalle e mi voltai,trovando l'ispettore che mi osservavadalla soglia. A un cenno di Grandes, unodei suoi uomini accese la lampada dellastanza e chiuse la porta. La luce dura emetallica mi colpì gli occhi,accecandomi per qualche istante.
Quando li riaprii, vidi un ispettore conun aspetto brutto quasi quanto il mio.
«Deve andare in bagno?»
«No. Approfittando delle circostanze, hodeciso di pisciarmi addosso e dicominciare a fare pratica per quando mimanderà nella stanza degli orrori degliinquisitori Marcos e Castelo.»
«Sono contento che non abbia perso ilsenso dell'umorismo. Ne avrà bisogno.Si sieda.»
Riprendemmo le nostre postazioni diparecchie ore prima e ci guardam-
mo in silenzio.
«Ho cercato di verificare i dettagli dellasua storia.»
«E allora?»
«Da dove vuole che inizi?»
«Il poliziotto è lei.»
«La prima visita l'ho fatta allo studio del
dottor Trias, in calle Muntaner.
È stata breve. Il dottor Trías è mortododici anni fa e l'ambulatorio appartieneda otto a un dentista di nome BernatLlofriu, che, inutile dirlo, non ha maisentito parlare di lei.»
«Impossibile.»
«Aspetti, che il bello deve ancoravenire. Uscendo da lì, sono passatodalla sede centrale del Banco HispanoColonial. Impressionante arredamento eun servizio impeccabile. Mi è venutavoglia di aprire un libretto di risparmio.Lì ho potuto accertare che lei non ha maiavuto nessun conto nell'istituto, che nonhanno mai sentito parlare di nessun
Andreas Corelli e che nessun cliente inquesto momento ha un conto in divisaestera per un importo di centomilafranchi francesi. Vado avanti?»
Strinsi le labbra, ma annuii.
«La fermata successiva è stata nellostudio del defunto avvocato Valera.
Lì ho verificato che lei ha, sì, un contocorrente, ma non all'Hispano Colonial,bensì al Banco de Sabadell, dal quale hatrasferito fondi a favore degli avvocatiper un importo di duemila pesetas seimesi fa.»
«Non la capisco.»
«Semplicissimo. Lei ha ingaggiatoValera in maniera anonima, o almenocosì credeva, perché le banche hannouna memoria da poeta e una volta chehanno visto un centesimo volare non selo scordano più. Le confesso che a quelpunto cominciavo a prenderci gusto e hodeciso di fare una visita al laboratoriodi sculture funerarie di Sanabre e Figli.»
«Non mi dica che non ha vistol'angelo...»
«L'ho visto, l'ho visto. Impressionante.Come la lettera firmata di suo pugnodatata tre mesi fa con la quale hacommissionato il lavoro e la ricevutadel pagamento in anticipo che quel
brav'uomo di Sanabre conservava neisuoi registri. Un uomo affascinante eorgoglioso del proprio mestiere.
Mi ha detto che è il suo capolavoro, cheha avuto un'ispirazione divina.»
«Non gli ha chiesto del denaro ricevutoda Marlasca venticinque anni fa?»
«L'ho fatto. Conservava le ricevute.Riguardavano lavori di ampliamen-to,manutenzione e ristrutturazione dellacappella di famiglia.»
«Nella tomba di Marlasca c'è seppellitoqualcuno che non è lui.»
«Questo lo dice lei. Ma se vuole che
profani un sepolcro, capisce che dovràfornirmi argomenti più solidi. Ma mipermetta di proseguire nel mio ripassodella sua storia.»
Deglutii.
«Approfittando del fatto che ero lì, sonoandato alla spiaggia del Bogatell, doveper un real ho trovato almeno diecipersone disposte a rivelarmi il tremendosegreto della Strega del Somorrostro.Non gliel'ho detto stamattina quando miha fatto il suo racconto per non rovinareil dramma, ma in realtà la donnona chesi faceva chiamare così è morta dadiversi anni. La vecchia che hoincontrato non spaventa neanche i
bambini ed è prostrata su una sedia. Undettaglio che le piacerà moltissimo: èmuta.»
«Ispettore...»
«Non ho ancora finito. Non mi potrà direche non prendo il mio lavoro sul serio.Abbastanza da andare da lì alla villa chelei mi ha descritto accanto al ParkGüell. È abbandonata da almeno diecianni e mi dispiace dirle che non c'eranoné fotografie né stampe né nient'altro chemerda di gatto. Cosa gliene pare?»
Non risposi.
«Mi dica, Martín. Si metta nei mieipanni. Che avrebbe fatto lei se si fosse
trovato in questa situazione?»
«Avrei lasciato perdere, immagino.»
«Esatto. Ma io non sono lei e, come unidiota, dopo un periplo tanto fruttuoso,ho deciso di seguire il suo consiglio e dicercare la temibile Irene Sabino.»
«L'ha trovata?»
«Un po' di fiducia nelle forzedell'ordine, Martín. Certo che l'abbiamotrovata. Ridotta uno schifo in una miserapensione del Raval dove vive da anni.»
«Le ha parlato?»
Grandes annuì.
«A lungo.»
«E allora?»
«Non ha la minima idea di chi lei sia.»
«Questo è ciò che le ha detto?»
«Fra le altre cose.»
«Quali cose?»
«Mi ha raccontato di aver conosciutoDiego Marlasca a una seduta orga-
nizzata da Roures in un appartamento dicalle Elisabets dove si riunival'associazione spiritica El Porvenirnell'anno 1903. Mi ha raccontato di aver
trovato un uomo che si rifugiò fra le suebraccia distrutto per la perdita del figlioe imprigionato in un matrimonio che nonaveva più senso. Mi ha raccontato cheMarlasca era un uomo buono ma turbato,che credeva che qualcosa gli si fosseinsinuato dentro ed era convinto chesarebbe morto presto. Mi ha raccontatoche prima di morire donò un fondoaffinché lei e l'uomo che aveva lasciatoper mettersi con Marlasca, JuanCorbera, alias Jaco, ricevesseroqualcosa in sua assenza. Mi haraccontato che Marlasca si tolse la vitaperché non poteva sopportare il doloreche lo consumava.
Mi ha raccontato di aver vissuto con
Juan Corbera di quella carità diMarlasca finché il fondo si esaurì, e chel'uomo che lei chiama Jaco la lasciòpoco dopo, e di aver saputo che eramorto solo e alcolizzato mentre lavoravacome sorvegliante notturno nellostabilimento di Casaramona. Mi haraccontato di avere effettivamenteaccompagnato Marlasca da quella donnache chiamavano la Strega delSomorrostro perché era convinta che loavrebbe consolato facendogli credereche si sarebbe ritrovato con suo figlionell'aldilà... Vuole che vada avanti?»
Mi aprii la camicia e gli mostrai i tagliche Irene Sabino mi aveva inciso sulpetto la notte che lei e Marlasca mi
avevano aggredito nel cimitero di SantGervasi.
«Una stella a sei punte. Non mi facciaridere, Martín. Questi tagli può esserselifatti da solo. Non significano nulla. IreneSabino è solo una povera donna che siguadagna da vivere lavorando in unalavanderia di calle Cadena, non unafattucchiera.»
«E Ricardo Salvador?»
«Fu espulso dal corpo di polizia nel1906, dopo aver passato due anni arivangare il caso della morte di DiegoMarlasca mentre intratteneva unarelazione illecita con la vedova deldefunto. L'ultima cosa che si è saputa di
lui è che aveva deciso di imbarcarsi e diandarsene in America per iniziare unanuova vita.»
Non potei evitare di mettermi a rideredavanti all'enormità di quell'in-ganno.
«Non se ne rende conto, ispettore? Nonsi rende conto che sta cadendoesattamente nella stessa trappola cheMarlasca ha teso a me?»
Grandes mi osservava con compassione.
«A non rendersi conto di quello che stasuccedendo è lei, Martín. L'orologiocorre e lei, invece di dirmi cosa ne hafatto di Cristina Sagnier, si o-
stina a cercare di convincermi di unastoria che sembra uscita dalla Città deimaledetti. Qui c'è solo una trappola:quella che lei ha teso a se stesso. E
ogni minuto che passa senza dire laverità mi rende più difficile tirarla fuoridai guai.»
Grandes mi passò la mano davanti agliocchi un paio di volte, come se volesseassicurarsi che avevo ancora il sensodella vista.
«No? Niente? Come vuole. Mi permettadi finire di raccontarle i risultati dellagiornata. Dopo la visita a Irene Sabinoin verità ero stanco e sono tornato per unpo' al Comando, dove ho trovato ancora
il tempo e la voglia di chiamare lacaserma della Guardia Civil diPuigcerdà. Lì mi hanno confermato chelei è stato visto uscire dalle stanzedov'era ricoverata Cristina Sagnier lanotte in cui è scomparsa, che non è maitornato in albergo a prendere il suobagaglio e che secondo il responsabilemedico della clinica è stato lei a tagliarele cinghie di cuoio che legavano lapaziente. Allora ho chiamato un vecchioamico suo, Pedro Vidal, che ha avuto lacortesia di venire al Comando. Ilpover'uomo è a pezzi. Mi ha raccontatoche l'ultima volta che vi siete visti leil'ha picchiato. È vero?»
Annuii.
«Sappia che non gliene vuole. In realtà,ha quasi cercato di persuadermi alasciarla andare. Dice che deve esserciuna spiegazione. Che lei ha avuto unavita difficile. Che ha perso il padre percolpa sua. Che lui si sente responsabile.E l'unica cosa che desidera è ritrovarela moglie e non ha alcuna intenzione difare ritorsioni contro di lei.»
«Ha raccontato tutto a Vidal?»
«Non ho potuto fare altrimenti.»
Mi nascosi la faccia tra le mani.
«Cosa ha detto?» chiesi.
Grandes si strinse nelle spalle.
«Crede che lei abbia perso la ragione.La ritiene innocente e, in ogni caso, nonvuole che le succeda nulla. La suafamiglia è un altro paio di maniche. Mirisulta che il padre del suo amico Vidal,che non la può soffrire, come le ho detto,ha offerto in segreto una gratifica dicinquemila pesetas a Marcos e Castelose le strappano una confessione in menodi dodici ore.
Loro gli hanno assicurato che nel giro diuna mattinata lei reciterà perfino i versidel Canigó. »
«E lei cosa crede?»
«La verità? Mi piacerebbe credere chePedro Vidal sia nel giusto, che lei abbia
perso la ragione.»
Non gli dissi che, in quello stessomomento, anch'io cominciavo acrederlo. Guardai Grandes e notaiqualcosa nella sua espressione che nonquadrava.
«C'è qualcosa che non mi ha raccontato»dissi.
«Direi che le ho raccontato più cheabbastanza» replicò.
«Cos'è che non mi ha detto?»
Grandes mi osservò attentamente e poisi lasciò sfuggire una risata trattenuta.
«Stamattina, quando mi ha raccontatoche la sera in cui morì il signor Semperequalcuno era andato in libreria e che liavevano sentiti litigare, sospettava chequella persona volesse acquistare unlibro, un libro suo, e che al rifiuto diSempere di venderglielo fosse nata unacolluttazione e il libraio avesse avuto unattacco di cuore. Secondo lei era unpezzo quasi unico, di cui esistonopochissime copie. Come si intitolava illibro?»
« I passi del cielo. »
«Esatto. È quello il libro che, secondo isuoi sospetti, è stato rubato la sera cheSempere è morto?»
Annuii. L'ispettore prese una sigaretta el'accese. Assaporò un paio di boccate ela spense.
«È questo il mio dilemma, Martín.Credo che lei mi abbia venduto unmucchio di fandonie che si è inventatoprendendomi per imbecille oppure, enon so se è peggio, ha iniziato lei stessoa crederci a forza di ripeterle.
Tutto porta a lei, e la cosa più facile perme è lavarmene le mani e lasciarla inquelle di Marcos e Castelo.»
«Ma...»
«Ma... ed è un ma minuscolo,insignificante, un ma che i miei colleghi
non avrebbero alcun problema atrascurare, e invece a me disturba comese fosse un bruscolino di polverenell'occhio e mi fa pensare se, magari, equello che sto per dire contraddice tuttociò che ho imparato in vent'anni dimestiere, le cose che mi ha raccontatonon siano la verità, ma non sianonemmeno false.»
«Posso solo dirle che le ho raccontatociò che ricordo, ispettore. Può credermioppure no. La verità è che a volte non micredo nemmeno io. Ma è quello chericordo.»
Grandes si alzò e iniziò a girare attornoal tavolo.
«Questo pomeriggio, parlando conMaria Antonia Sanahuja, o Irene Sabino,nella stanza della sua pensione, le hochiesto se la conosceva. Ha detto di no.Le ho spiegato che viveva nella casadella torre dove lei e Marla-
sca avevano trascorso diversi mesi. Leho chiesto di nuovo se si ricordava dilei. Mi ha risposto di no. Poco dopo leho detto che lei aveva visitato lacappella della famiglia Marlasca ed erasicuro di averla vista lì. Per la terzavolta quella donna ha negato di averlamai incontrata. E io le ho creduto.
Le ho creduto finché, quando stavo perandarmene, ha detto di avere un po'
freddo e ha aperto l'armadio perprendere uno scialle di lana da mettersisulle spalle. Allora ho visto un libro suun tavolo. Ha richiamato la miaattenzione perché era l'unico libro nellastanza. Approfittando del fatto che miaveva dato le spalle, l'ho aperto e holetto una dedica scritta a mano sullaprima pagina.»
«"Per il signor Sempere, il miglioramico che un libro potrebbe desiderare,per avermi aperto le porte del mondo einsegnato ad attraversarle"» ci-tai amemoria.
«"Firmato, David Martín"» completòGrandes.
L'ispettore si fermò davanti alla finestra,dandomi le spalle.
«Tra mezz'ora verranno a prenderla e mitoglieranno il caso» disse. «Lei passeràin custodia al sergente Marcos. E io nonpotrò fare più nulla. Ha qualcos'altro dadire che mi permetta di salvarle ilcollo?»
«No.»
«Allora prenda quel ridicolo revolverche tiene nascosto da ore nel cappotto e,facendo attenzione a non spararsi a unpiede, mi minacci di farmi saltare latesta se non le consegno la chiave cheapre quella porta.»
Guardai verso la porta.
«In cambio, le chiedo solo di dirmidov'è Cristina Sagnier, se è ancoraviva.»
Abbassai lo sguardo, incapace ditrovare la mia stessa voce.
«L'ha uccisa lei?»
Lasciai trascorrere un lungo silenzio.
«Non lo so.»
Grandes si avvicinò e mi tese la chiavedella porta.
«Se la squagli, Martín.»
Esitai un istante prima di accettarla.
«Non usi la scala principale. Uscendo incorridoio, alla fine, sulla sinistra, c'èuna porta blu che si apre solo da questolato e conduce alla scala antincendio.L'uscita dà nel vicolo sul retro.»
«Come posso ringraziarla?»
«Può cominciare non perdendo tempo.Ha una trentina di minuti prima che tuttoil dipartimento si metta alle suecalcagna. Cerchi di non sprecar-
li» disse l'ispettore.
Presi la chiave e mi diressi alla porta.Prima di uscire, mi voltai un istante.
Grandes si era seduto sul tavolo e miosservava senza alcuna espressione.
«Quella spilla dell'angelo» disse,indicandosi il risvolto della giacca.
«Sì?»
«Gliel'ho vista addosso da quando laconosco.»
20
Le strade del Raval erano tunneld'ombra punteggiati di lampioni sfarfal-lanti che a malapena riuscivano agraffiare l'oscurità. Mi ci volle qualcosain più dei trenta minuti che mi avevaconcesso l'ispettore Grandes per
scoprire che c'erano due lavanderie incalle Cadena. Nella prima, quasi unagrotta in fondo a scale lucide di vapore,lavoravano solo bambini con le maniviolacee di tintura e gli occhi giallastri.La seconda, una fucina di sudiciume e dipuzza di liscivia da cui si faticava acredere che potesse uscire qualcosa dipulito, era gestita da un donnone che allavista di qualche moneta non perse tempoad ammettere che Maria AntoniaSanahuja lavorava lì sei pomeriggi allasettimana.
«Che ha combinato adesso?» domandòla matrona.
«Ha ereditato. Mi dica dove posso
trovarla e forse ci guadagna qualcosa.»
La matrona rise, però gli occhi lebrillarono di avidità.
«Che io sappia, vive nella pensioneSanta Lucia, in calle Marqués deBarberà. Quanto ha ereditato?»
Lasciai cadere qualche moneta sulbancone e uscii da quel buco immon-dosenza prendermi la briga di rispondere.
La pensione in cui viveva Irene Sabinolanguiva in un cupo edificio chesembrava costruito con ossa dissepolte elapidi rubate. Le targhette delle cassettedella posta in portineria erano ricopertedi ruggine. Ai primi due piani non
figurava nessun nominativo. Il terzoospitava una sartoria dal nomemagniloquente, La Textil Mediterránea.Il quarto e ultimo era occupato dallapensione Santa Lucia. Una scala su cui astento passava una persona saliva nellapenombra, mentre le esalazioni dellefognature s'infiltra-vano dai muri e simangiavano la pittura delle pareti comeacido. Salii quattro piani fino araggiungere un pianerottolo inclinato sulquale si affacciava una sola porta.Bussai con il pugno e dopo un po' miaprì un uomo alto e magro come unincubo di El Greco.
«Cerco Maria Antonia Sanahuja» dissi.
«Lei è il medico?» domandò.
Lo spinsi di lato ed entrai.L'appartamento non era altro che unguazzabuglio di stanze strette e buieaggrappiate ai due lati di un corridoioche moriva in un finestrone affacciato suun cavedio. Il fetore che usciva dalletubature permeava l'atmosfera. L'uomoche mi aveva aperto era rimasto sullasoglia e mi guardava sconcertato.Immaginai che si trattasse di unpensionante.
«Qual è la sua stanza?» chiesi.
Mi guardò in silenzio, impenetrabile.Tirai fuori il revolver e glielo mostrai.L'uomo, senza perdere la serenità,
indicò l'ultima porta del corridoioaccanto allo sfiatatoio del cavedio. Ciandai e quando scoprii che era chiusacominciai ad armeggiare con laserratura. Gli altri ospiti si eranoaffacciati in corridoio, un coro di animedimenticate che sembravano non averesfiorato la luce del sole per anni.Ricordai i miei giorni di miseria nellapensione di donna Carmen e mi passòper la mente che il mio vecchiodomicilio sembrava il nuovo Hotel Ritza paragone di quel miserabilepurgatorio, uno dei tanti nell'alveare delRaval.
«Tornate nelle vostre stanze» dissi.
Nessuno diede segno di avermi sentito.Alzai la mano mostrando l'arma.
Immediatamente tutti s'infilarono nelleloro stanze come roditori spaventa-ti,eccetto il cavaliere dalla triste eslanciata figura. Concentrai di nuovol'attenzione sulla porta.
«Ha chiuso dall'interno» spiegò ilpensionante. «È lì da tutto ilpomeriggio.»
Un odore che mi fece pensare allemandorle amare filtrava da sotto laporta. La colpii con il pugno diversevolte senza ottenere risposta.
«La padrona ha un passe-partout» disse
il pensionante. «Se vuole aspettare...Non credo ci metterà molto a tornare.»
Per tutta risposta, mi allontanai diqualche passo e mi lanciai contro laporta, che cedette alla seconda carica.Appena mi ritrovai nella stanza, miassalì quel fetore acre e nauseabondo.
«Dio mio» mormorò il pensionante allemie spalle.
La ex stella del Paratelo giaceva su unabranda, pallida e ricoperta di sudore.Aveva le labbra nere e, vedendomi,sorrise. Le sue mani stringevano conforza la boccetta di veleno. L'avevabevuto fino all'ultima goccia. Il fetoredel suo alito, di sangue e di bile,
riempiva la stanza. Il pensionante sitappò il naso e la bocca con la mano earretrò in corridoio. Osservai IreneSabino che si contorceva mentre ilveleno la corrodeva dall'interno. Lamorte si stava prendendo il suo tempo.
«Dov'è Marlasca?»
Mi guardò attraverso lacrime di agonia.
«Non aveva più bisogno di me» disse.«Non mi ha mai amato.»
Aveva la voce aspra e spezzata. L'assalìuna tosse secca che le strappò dal pettoun suono sdrucito, e un secondo dopo unliquido scuro le affiorò tra i denti. IreneSabino mi osservava aggrappandosi
all'ultimo soffio di vita. Mi prese lamano e la strinse forte.
«Lei è maledetto, come lui.»
«Cosa posso fare?»
Negò lentamente con la testa. Un nuovoattacco di tosse le scosse il petto. Icapillari degli occhi le si rompevano euna rete di linee sanguinanti avanzavaverso le sue pupille.
«Dov'è Ricardo Salvador? Nella tombadi Marlasca, nella cappella difamiglia?»
Irene Sabino scosse la testa. Una parolamuta le si formò sulle labbra.
Jaco.
«Dov'è Salvador, allora?»
«Lui sa dov'è lei. La vede. Verrà acercarla.»
Mi sembrò che iniziasse a delirare. Lapressione della sua mano perdeva forza.
«Io l'amavo» disse. «Era un uomobuono. Un uomo buono. Lui l'hacambiato. Era un uomo buono...»
Un rumore di carne lacerata le uscì dallelabbra e il suo corpo si tese in unospasmo. Irene Sabino morì con gli occhifissi nei miei, portandosi via per sempreil segreto di Diego Marlasca. Ora
restavo solo io.
Le coprii il volto con un lenzuolo esospirai. Sulla soglia, il pensionante sifece il segno della croce. Mi guardaiattorno, cercando qualcosa che potesseaiutarmi, un indizio su quale dovesseessere il mio prossimo passo.
Irene Sabino aveva trascorso i suoiultimi giorni in una cella di due metriper quattro. Non c'erano finestre. Labranda di ferro su cui giaceva il suocadavere, un armadio sull'altro lato e untavolino contro il muro costituiva-notutto l'arredamento. Una valigia spuntavada sotto la branda, accanto a un ormale ea una cappelliera. Sul tavolino c'erano
un piatto con briciole di pane, unacaraffa d'acqua e una pila di quelle chesembravano cartoline, ma che sirivelarono immaginette di santi e avvisifunebri. Avvolto in un panno biancoc'era quello che pareva un libro. Loscartocciai e trovai la copia dei Passidel cielo che avevo dedicato al signorSempere. La compassione risvegliata inme dall'agonia di quella donna svaporòall'istante.
Quella disgraziata aveva ammazzato ilmio buon amico per strappargli quelmaledetto libro. Ricordai allora leparole di Sempere la prima volta cheero entrato nella sua libreria: ogni libroaveva un'anima, l'anima di chi l'aveva
scritto e l'anima di quelli che lo avevanoletto e sognato. Sempere era mortocredendo a quelle parole e capii cheanche Irene Sabino, a suo modo, ciaveva creduto.
Sfogliai le pagine rileggendo la dedica.Trovai il primo segno a pagina sette. Untratto marrone sgorbiava le parole,disegnando una stella a sei punteidentica a quella che mi aveva inciso sulpetto con la lama di un rasoio qualchesettimana prima. Capii che era tracciatacon il sangue. Continuai a girare lepagine e a scoprire nuovi disegni. Dellelabbra. Una mano.
Occhi. Sempere aveva sacrificato la vita
per un miserabile e ridicolo incantesimoda baraccone.
Misi il libro nella tasca interna delcappotto e mi inginocchiai accanto alletto. Tirai fuori la valigia e la svuotaisul pavimento. C'erano solo vestiti escarpe vecchie. Aprii la cappelliera etrovai un astuccio di pelle che contenevail rasoio con cui Irene Sabino mi avevafatto i segni sul petto. All'improvvisoavvertii un'ombra che si allungava sulpavimento e mi girai di scatto, puntandoil revolver. Il pensionante dal fisicoasciutto mi guardò con una certasorpresa.
«Mi sembra che abbia compagnia» disse
lapidario.
Uscii in corridoio e andai versol'ingresso. Mi affacciai sulle scale esentii i pesanti passi che salivano. Unvolto si profilò nella tromba delle scale.
Guardava in alto, e mi imbattei negliocchi del sergente Marcos due pianisotto di me. Si tirò indietro e i passiaccelerarono. Non era solo. Chiusi e miappoggiai alla porta, sforzandomi dipensare. Il mio complice mi osservava,calmo ma in attesa.
«C'è un'altra uscita?» domandai.
Scosse la testa.
«Sul tetto?»
Indicò la porta che avevo appena chiuso.Tre secondi più tardi sentii l'impatto deicorpi di Marcos e Castelo checercavano di sfondarla. Mi allontanai,retrocedendo nel corridoio con l'armapuntata verso la porta.
«Io, magari, me ne vado nella miastanza» disse l'inquilino. «È stato unpiacere.»
«Altrettanto.»
Fissai gli occhi sulla porta, che venivascossa con forza. Il legno consumatoattorno ai cardini e alla serraturacominciò a fendersi. Andai verso il
fondo del corridoio e aprii la finestrache dava sul cavedio. Un tunnelverticale approssimativamente di unmetro per un metro e mezzo s'inabissavanell'ombra. Il bordo del lastrico sul tettos'intravedeva in alto, a circa tre metridalla finestra. Dall'altra parte delcavedio c'era uno sfiatatoio attaccato almuro con ganci marci di ruggine.L'umidità suppurante ne spruzzava lasuperficie di lacrime nere. Il rumore deicolpi continuava a rintronare alle miespalle. Mi voltai e vidi che la porta eraormai praticamente scardina-ta. Calcolaiche mi restavano appena pochi secondi.Senza altra alternativa, salii suldavanzale e saltai.
Riuscii ad aggrapparmi alle tubature e apoggiare un piede su uno dei ganci chesporgeva. Sollevai la mano per afferrarela parte superiore del tubo, ma appenafeci forza sentii che mi si sbriciolava trale mani e che un intero metro precipitavalungo il cavedio. Fui sul punto di cadereanch'io, ma mi aggrappai al pezzo dimetallo conficcato nel muro chesosteneva il gancio. La tubatura graziealla quale avevo sperato di salire sultetto era adesso completamente al difuori della mia portata. Non c'erano chedue vie d'uscita: tornare nel corridoiodove entro un paio di secondi Marcos eCastelo sarebbero riusciti a entrare,oppure scendere per quella gola oscura.Sentii la porta sbattere forte contro il
muro interno della casa e mi lasciaicadere lentamente, afferrandomi comepotevo al tubo di scarico e la-cerandomibuona parte della pelle della manosinistra nel tentativo. Ero riuscito ascendere di un metro e mezzo quandovidi le figure dei due poliziotti ritagliatenel fascio di luce proiettato dallafinestra sull'oscurità del cavedio. Ilvolto di Marcos fu il primo adaffacciarsi. Sorrise e io mi domandai semi avrebbe sparato subito, senza troppiindugi. Poi, al suo fianco, comparveCastelo.
«Tu rimani qui. Io vado al piano disotto» ordinò Marcos.
Castelo annuì senza togliermi gli occhidi dosso. Mi volevano vivo, almeno perqualche ora. Sentii i passi di Marcos chesi allontanavano di corsa. Entro pochisecondi l'avrei visto affacciarsi dallafinestra che si trovava ad appena unmetro sotto di me. Guardai in basso evidi che le finestre del secondo e delprimo piano disegnavano ritagli di luce,ma quella del terzo era al buio. Scesilentamente finché sentii il piedepoggiare sul gancio successivo. Lafinestra oscura del terzo piano era difronte a me, il corridoio vuoto con infondo la porta a cui Marcos stavabussando. A quell'ora la sartoria avevagià chiuso e non c'era nessuno. I colpialla porta cessarono e capii che Marcos
era sceso al secondo piano. Guardai inalto e vidi che Castelo continuava aosservarmi, leccandosi i baffi come ungatto.
«Non cadere, così quando ti prendiamoci divertiamo» disse.
Sentii delle voci al secondo piano ecapii che Marcos era riuscito a farsiaprire. Senza pensarci due volte, milanciai contro la finestra del terzo pianocon tutta la forza che riuscii a trovare.L'attraversai coprendomi la faccia e ilcollo con le maniche del cappotto, eatterrai in una pozzanghera di vetri rotti.Mi rialzai a fatica e nella penombra vidiuna macchia scura al-largarsi sul
braccio sinistro. Una scheggia di vetro,affilata come una daga, spuntava dasopra il gomito. La strinsi fra le dita etirai. Il freddo lasciò il posto a unafiammata di dolore che mi fece cadereginocchioni a terra. Da lì riuscii avedere che Castelo aveva iniziato ascendere lungo le tubature e miosservava dal punto dal quale erosaltato. Prima che potessi estrarrel'arma, saltò verso la finestra. Vidi lesue mani afferrarsi al telaio e, in un attoirriflesso, colpii la cornice della finestrarotta con tutte le mie forze e con tutto ilpeso del corpo. Sentii le ossa delle suedita rompersi con uno scatto secco eCastelo urlò di dolore. Tirai fuori ilrevolver e glielo puntai in faccia, ma lui
aveva già iniziato a sentire che le manistavano abbando-nando la presa. Unsecondo di terrore negli occhi e caddegiù per il cavedio, con il corpo chesbatteva sulle pareti lasciando una sciadi sangue nelle macchie di lucedisegnate dalle finestre dei pianiinferiori.
Mi trascinai lungo il corridoio indirezione della porta. La ferita albraccio pulsava con forza e mi accorsidi avere anche parecchi tagli allegambe. Continuai ad avanzare. Sui duelati si aprivano stanze in penombrapiene di macchine per cucire, bobine difilo e tavoli con grandi rotoli di stoffa.
Raggiunsi la porta e appoggiai la manosulla maniglia. Un decimo di secondodopo la sentii girare sotto le dita. Lamollai. Marcos era dall'altra parte ecercava di forzarla. Arretrai di qualchepasso. Un terribile frastuono scosse laporta, e parte della serratura schizzò viaproiettata in una nube di scintille e fumoazzurrato. Marcos avrebbe fatto saltarela serratura con il revolver. Mi rifugiainella prima delle stanze, piena disagome immobili a cui mancavano lebraccia o le gambe. Erano manichini davetrina, accatastati gli uni contro glialtri. M'infilai tra i torsi che brillavanonella penombra. Sentii un secondosparo. La porta si spalancò di colpo. Laluce del pianerottolo, giallastra e
imprigionata nell'alone di polvere dasparo, penetrò nell'appartamento. Ilcorpo di Marcos disegnò un profilospigoloso in quel chiarore. I suoi passipesanti si avvicinarono lungo ilcorridoio. Lo sentii socchiudere laporta. Mi appiattii al muro, nascostodietro i manichini, con il revolver tra lemani tremanti.
«Martín, esca» disse Marcos con calma,avanzando lentamente. «Non le farò delmale. Ho ordini di Grandes di portarlaal commissariato. Abbiamo trovatoquell'uomo, Marlasca. Ha confessatotutto. Lei è pulito. Ora non facciasciocchezze. Esca e ne parliamo alComando.»
Lo vidi camminare davanti alla sogliadella stanza e tirare dritto.
«Martín, mi ascolti. Grandes staarrivando. Possiamo chiarire tutto senzadover complicare ulteriormente lecose.»
Armai il percussore del revolver. I passidi Marcos si fermarono. Un fruscio sullemattonelle. Era dall'altra parte del muro.Sapeva perfettamente che mi trovavo inquella stanza, senza altra via d'uscita chepassargli davanti. Lentamente vidi il suoprofilo adattarsi alle ombre dell'entrata.La sua figura sì confuse nella penombraliquida, lo scintillio degli occhi eral'unica traccia della sua presenza. Era ad
appena quattro metri da me. Mi lasciaiscivolare lungo il muro fino a terra,piegando le ginocchia. Le gambe diMarcos si avvicinavano dietro quelledei manichini.
«So che è qui, Martín. La smetta con leragazzate.»
Si fermò, immobile. Lo vidiaccovacciarsi e tastare con le dita letracce di sangue che avevo lasciato. Siportò un dito alle labbra. Immaginai chesorridesse.
«Sta sanguinando molto, Martín. Habisogno di un medico. Esca el'accompagno in un ambulatorio.»
Rimasi zitto. Marcos si fermò davanti aun tavolo e prese un oggetto brillanteche giaceva tra brandelli di stoffa.Grandi forbici da telaio.
«A lei, Martín.»
Sentii il rumore delle lame delle forbiciche si aprivano e si chiudevano fra lesue mani. Una fitta di dolore miattanagliò il braccio e mi morsi lelabbra per non gemere. Marcos girò lafaccia verso il punto in cui mi trovavo.
«A proposito di sangue, le farà piaceresapere che abbiamo preso la sua puttanae prima di cominciare con il signorDavid Martín ce la spasseremo un po'con quella Isabella...»
Sollevai l'arma e gliela puntai allafaccia. Lo scintillio del metallo mi tradì.Marcos mi saltò addosso, travolgendo imanichini e schivando lo sparo. Sentii ilsuo peso su di me e il suo fiato sullafaccia. Le lame delle forbici si chiuserocon forza a un centimetro dal mio occhiosinistro. Lo colpii sul volto con lafronte, mettendoci tutta l'energia cheriuscii a trova-
re, e Marcos cadde a terra. Alzai ilrevolver e glielo puntai in faccia.Marcos, con un labbro spaccato, si alzòe mi fissò negli occhi.
«Non ne hai il fegato» mormorò.
Appoggiò la mano sulla canna e mi
sorrise. Premetti il grilletto. Lapallottola gli spappolò la mano,proiettando il braccio all'indietro comese avesse ricevuto una martellata.Marcos cadde a terra di spalle,stringendosi il polso mutilato e fumante,mentre il suo volto punteggiato dibruciature di polvere da sparo siscioglieva in una smorfia di dolore cheurlava senza voce. Mi alzai e lo lasciailì, a dissanguarsi in una pozzangheradella sua stessa orina.
21
A malapena riuscii a trascinarmi per ivicoli del Raval fino al Paralelo, dovesi era formata una fila di taxi alle porte
del Teatro Apolo. M'infilai nel primoche potei. Quando sentì il rumore dellaportiera, l'autista si voltò e, vedendomi,fece una smorfia dissuasiva. Mi lasciaicadere sul sedile posteriore ignorandole sue proteste.
«Senta, non mi morirà mica lì dietro?»
«Prima mi porta dove voglio andare,prima si libera di me.»
Il conducente bestemmiò tra sé e avviòil motore.
«E dove vuole andare?»
Non lo so, pensai.
«Lei parta e poi glielo dico.»
«Partire per dove?»
«Pedralbes.»
Venti minuti più tardi avvistai le luci diVilla Helius sulla collina. Le in-dicaiall'autista, che non vedeva l'ora disbarazzarsi di me. Mi lasciò all'ingressodella villa e quasi si dimenticò di farsipagare la corsa. Mi trascinai al portonee suonai il campanello. Mi lasciaicadere sui gradini e appoggiai la testacontro il muro. Sentii avvicinarsi deipassi e a un certo punto mi parve che laporta si aprisse e una voce pronunciasseil mio nome. Sentii una mano sulla frontee mi sembrò di riconoscere gli occhi di
Vidal.
«Mi perdoni, don Pedro» supplicai.«Non sapevo dove andare...»
Lo sentii alzare la voce e dopo un po'avvertii diverse mani che mi prendevanoper le braccia e le gambe e mi tiravanosu. Quando riaprii gli occhi ero nellacamera di don Pedro, steso sullo stessoletto che aveva diviso con Cristina neidue mesi scarsi che era durato il loromatrimonio. Sospirai.
Vidal mi osservava dai piedi del letto.
«Non parlare adesso» disse. «Il medicosta arrivando.»
«Non gli creda, don Pedro» gemetti.«Non gli creda.»
Vidal annuì stringendo le labbra.
«Certo che no.»
Don Pedro prese una coperta e me lamise addosso.
«Scendo ad aspettare il dottore» disse.«Riposati.»
Dopo un po' sentii passi e voci entrarenella stanza. Sentii che mi toglievano ivestiti e riuscii a scorgere le dozzine ditagli che mi ricoprivano il corpo comeun'edera sanguinolenta. Sentii le pinzeche frugavano nelle ferite, estraendo
schegge di vetro che si portavano viabrandelli di pelle e di carne. Sentii ilcalore dei disinfettanti e le punturedell'ago con cui il dottore ricuciva leferite. Non c'era più dolore, solostanchezza. Una volta ben-dato, ricucitoe rammendato come se fossi un pupazzorotto, il medico e Vidal mi coprirono emi fecero appoggiare la testa al cuscinopiù dolce e soffice che avessi maiconosciuto in vita mia. Aprii gli occhi etrovai il viso del dottore, un signore dalportamento aristocratico e dal sorrisotranquillizzante. Aveva una siringa inmano.
«Ha avuto fortuna, giovanotto» dissementre mi affondava l'ago nel braccio.
«Cos'è questo?» mormorai.
Il viso di Vidal si affacciò accanto aquello del medico.
«Ti aiuterà a riposare.»
Una nube di freddo si diffuse nel braccioe mi ricoprì il petto. Caddi in un pozzodi velluto nero mentre Vidal e il dottoremi osservavano dall'alto.
Il mondo si andò richiudendo fino aridursi a una goccia di luce che evaporòdalle mie mani. Sprofondai in quellapace calda, chimica e infinita, dallaquale non sarei mai voluto fuggire.
Ricordo un mondo di acque nere sotto il
ghiaccio. La luce della luna accarezzavala volta gelata lassù in alto e sirifrangeva in mille fasci polvero-si chesi agitavano nella corrente che mitrascinava. Il manto bianco chel'avvolgeva ondeggiava lentamente, ilprofilo del suo corpo visibile intrasparenza. Cristina allungava la manoverso di me e io lottavo contro quellacorrente fredda e densa. Quandorestavano pochi millimetri fra la miamano e la sua, una nube tenebrosadispiegava le ali dietro di lei el'avvolgeva come un'esplosione diinchiostro. Tentacoli di luce nera lecircondavano le braccia, la gola e ilviso per trascinarla con forza versol'oscurità.
22
Mi svegliai al suono del mio nome sullelabbra dell'ispettore Grandes.
Mi alzai di scatto, senza riconoscere illuogo in cui mi trovavo e che, seassomigliava a qualcosa, sembrava lasuite di un grand hotel. Le frustate didolore delle dozzine di ferite che mipercorrevano il torso mi riportarono allarealtà. Ero nella camera da letto di Vidala Villa Helius. Una luce di metàpomeriggio si insinuava fra le impostesocchiuse. C'era il fuoco acceso nelcamino e faceva caldo. Le vociprovenivano dal piano di sotto. PedroVidal e Víctor Grandes.
Ignorai gli strattoni e le trafitture che mimordevano la pelle e scesi dal letto. Imiei vestiti sporchi e insanguinati eranogettati su una poltrona.
Cercai il cappotto. Il revolver eraancora nella tasca. Armai il percussoree uscii dalla stanza, seguendo la tracciadelle voci fino alle scale. Scesi qualchegradino, appiattendomi contro il muro.
«Mi dispiace molto per i suoi uomini,ispettore» sentii dire a Vidal. «Stia certoche se David si mette in contatto con me,o se vengo a sapere dove si nasconde,glielo comunicherò immediatamente.»
«La ringrazio per la collaborazione,signor Vidal. Mi spiace doverla
disturbare in queste circostanze, ma lasituazione è di straordinaria gravità.»
«Me ne rendo conto. Grazie per lavisita.»
Passi verso l'ingresso e il rumore dellaporta. Passi in giardino che siallontanavano. Il respiro di Vidal,pesante, ai piedi delle scale. Scesiqualche altro gradino e lo trovai con lafronte appoggiata alla porta. Quando misentì, aprì gli occhi e si voltò.
Non disse nulla. Si limitò a guardare ilrevolver che impugnavo. Lo lasciai sultavolino in fondo alle scale.
«Vieni, vediamo se troviamo qualche
vestito pulito per te» disse.
Lo seguii fino a un immenso guardarobache sembrava un vero e proprio museodegli indumenti. Tutti gli abiti elegantiche ricordavo dagli anni di gloria diVidal erano lì. Decine di cravatte,scarpe e gemelli in astucci di vellutorosso.
«Tutte cose di quando ero giovane. Tiandranno bene.»
Vidal scelse per me. Mi tese unacamicia che probabilmente valevaquanto un piccolo appezzamento diterreno, un completo con gilet fatto sumisura a Londra e scarpe italiane chenon avrebbero sfigurato nel guarda-
roba del mio principale. Mi vestii insilenzio mentre Vidal mi osservavapensieroso.
«Un po' largo di spalle, ma dovraiaccontentarti» disse, passandomi duegemelli di zaffiri.
«Cosa le ha raccontato l'ispettore?»
«Tutto.»
«E lei gli ha creduto?»
«Cosa importa quello che credo io?»
«Importa a me.»
Vidal si sedette su una panca sistemata
contro una parete ricoperta di specchidal pavimento al soffitto.
«Dice che tu sai dov'è Cristina» disse.
Annuii.
«È viva?»
Lo guardai negli occhi e, moltolentamente, annuii. Vidal sorrisedebolmente, schivando il mio sguardo.Poi si mise a piangere, lasciandosisfuggire un gemito che gli sgorgava dalprofondo. Mi sedetti accanto a lui e loabbracciai.
«Mi perdoni, don Fedro, mi perdoni...»
Più tardi, quando il sole iniziava adeclinare sull'orizzonte, don Pedroraccolse i miei vecchi vestiti e li buttònel fuoco. Prima di consegnare ilcappotto alle fiamme tirò fuori la copiadei Passi del cielo e me la diede.
«Dei due libri che hai scritto l'annoscorso, questo è quello buono» disse.
Lo osservai smuovere i miei vestiti chebruciavano nel camino.
«Quando se n'è accorto?»
Vidal si strinse nelle spalle.
«È difficile ingannare qualcuno persempre, David; perfino uno stupido
vanitoso.»
Non riuscii a capire se nella sua voce cifosse rancore o soltanto tristezza.
«L'ho fatto perché credevo di aiutarla,don Pedro.»
«Lo so.»
Mi sorrise senza acredine.
«Mi perdoni» mormorai.
«Devi andartene dalla città. C'è unanave da carico ancorata al molo di SanSebastián che salpa a mezzanotte. È tuttoorganizzato. Chiedi del capitano Olmo.Ti aspetta. Prendi una delle auto dal
garage. Puoi lasciarla al molo. Pepl'andrà a riprendere domani. Nonparlare con nessuno. Non tornare a casatua. Avrai bisogno di denaro.»
«Ne ho abbastanza» mentii.
«Non è mai abbastanza. Quando sbarchia Marsiglia, Olmo ti accompagnerà inbanca e ti consegnerà cinquantamilafranchi.»
«Don Pedro...»
«Ascoltami. Quei due uomini chesecondo Grandes hai ammazzato...»
«Marcos e Castelo. Credo chelavorassero per suo padre, don Pedro.»
Vidal scosse la testa.
«Né mio padre né i suoi avvocatitrattano con i gradi intermedi, David.
Come credi che sapessero dove trovartitrenta minuti dopo essere uscito dalcommissariato?»
La fredda certezza mi cadde addosso,trasparente.
«Grazie al mio amico, l'ispettore VíctorGrandes.»
Vidal annuì.
«Grandes ti ha lasciato andare perchénon voleva sporcarsi le mani al
commissariato. Appena sei uscito, i suoidue uomini erano sulle tue tracce.
La tua era una morte telegrafata.Sospetto omicida fugge e muore mentrecerca di sfuggire all'arresto.»
«Come ai vecchi tempi in cronaca»disse.
«Certe cose non cambiano mai, David.Tu dovresti saperlo meglio di chiunquealtro.»
Aprì l'armadio e mi allungò un cappottonuovo, mai indossato. Lo accettai e misiil libro nella tasca interna. Vidal misorrise.
«Per una volta nella vita ti vedo benvestito.»
«A lei stava meglio, don Pedro.»
«Questo è scontato.»
«Don Pedro, ci sono molte cose che...»
«Adesso non hanno più importanza,David. Non mi devi nessunaspiegazione.»
«Le devo molto di più di unaspiegazione...»
«Allora parlami di lei.»
Vidal mi guardava con occhi disperati,
supplicando che gli mentissi. Cisedemmo in salotto, di fronte aifinestroni da cui si dominava tuttaBarcellona, e gli mentii con tutto ilcuore. Gli dissi che Cristina avevaaffittato un piccolo attico in rue deSoufflot sotto il nome di madame Vidal eche mi aveva promesso di aspettarmiogni giorno a metà pomeriggio davantialla fontana dei Jardins du Luxembourg.Gli dissi che parlava sempre di lui, chenon l'avrebbe mai dimenticato, e che iosapevo che, anche se avessi passatomolti anni al suo fianco, non sarei mairiuscito a colmare il vuoto lasciato dalui. Don Pedro annuiva, lo sguardoperso lontano.
«Devi promettermi che avrai cura di lei,David. Che non l'abbandonerai mai.Qualunque cosa succeda, le staraiaccanto.»
«Glielo prometto, don Pedro.»
Nella luce pallida del tramonto riuscii avedere in lui solo un uomo vecchio esconfitto, malato di ricordi e di rimorsi,un uomo che non aveva mai creduto e alquale adesso restava soltanto il balsamodella credulità.
«Mi sarebbe piaciuto essere un amicomigliore per te, David.»
«Lei è stato il migliore degli amici, donPedro. E molto più di questo.»
Vidal allungò il braccio e mi prese lamano. Stava tremando.
«Grandes mi ha parlato di quell'uomo,quello che chiami il tuo principale...Dice che gli devi qualcosa e chesecondo te l'unico modo per pagare iltuo debito è consegnargli un'animapura...»
«Sono stupidaggini, don Pedro. Non cifaccia caso.»
«Non ti serve un'anima sporca e stancacome la mia?»
«Non conosco davvero un'anima piùpura della sua, don Pedro.»
Vidal sorrise.
«Se potessi fare cambio con tuo padre,non ci penserei, David.»
«Lo so.»
Si alzò e contemplò il tramonto cheprecipitava sulla città.
«Dovresti metterti in marcia» disse. «Va'in garage e prendi una macchina. Quellache vuoi. Io vado a vedere se ho denaroin contanti.»
Annuii e presi il cappotto. Uscii ingiardino e mi diressi verso il garage diVilla Helius. C'erano due automobililustre come carrozze reali. Scelsi la più
piccola e discreta, una Hispano-Suizanera che sembrava non essere uscita dalì più di due o tre volte e odoravaancora di nuovo. Mi sedetti al volante emisi in moto. Uscii dal garage e aspettaiin cortile. Passò un minuto e, vedendoche don Pedro non usciva, scesi dallamacchina lasciando il motore acceso.Rientrai in casa per salutarlo e dirgli dinon preoccuparsi per i soldi, me la sareicavata. Attraversando l'ingresso ricordaidi aver lasciato lì il revolver, sultavolino accanto alle scale. Quandoandai a ripren-derlo, non c'era più.
«Don Pedro?»
La porta che dava in salotto era
socchiusa. Mi affacciai sulla soglia e lovidi al centro della stanza. Si portò alpetto la pistola di mio padre e puntò lacanna sul cuore. Corsi verso di lui ma ilfrastuono dello sparo coprì le mie urla.L'arma gli cadde di mano. Il corpos'inclinò verso il muro e scivolòlentamente sul pavimento lasciando unascia scarlatta sul marmo.
Caddi in ginocchio accanto a lui e losostenni tra le braccia. Lo sparo gliaveva aperto nel vestito un foro fumante,dal quale sgorgava a fiotti sangue scuroe denso. Don Pedro mi guardava fissonegli occhi mentre il suo sorriso siriempiva di sangue e il suo corposmetteva di tremare e cadeva a terra in
un odore di polvere da sparo e dimiseria.
23
Tornai in macchina e mi sedetti, con lemani insanguinate sul volante. A stentoriuscivo a respirare. Aspettai un minutoe poi abbassai la leva del freno. Iltramonto aveva coperto il cielo con unsudario rosso, sotto il quale palpitavanole luci della città. Partii e mi lasciai allespalle il profilo di Villa Helius in cimaalla collina. Arrivato in avenidaPearson, mi fermai e guardai nellospecchietto retrovisore. Un'auto svoltòda un vicolo nascosto e si piazzò a unacinquantina di metri da me. Non aveva
acceso i fari. Víctor Grandes.
Proseguii giù per l'avenida de Pedralbesfino a superare il grande drago di ferrobattuto che sorvegliava il porticato dellaFinca Güell. L'auto dell'ispettoreGrandes era ancora lì, a un centinaio dimetri. Arrivato sulla Diagonal, girai asinistra verso il centro. Circolavanopochissimi veicoli e Grandes mi seguìsenza difficoltà finché non decisi disvoltare a destra con la speranza diseminarlo nelle stradine strette delleCorts. A quel punto l'ispettore si eraaccorto che la sua presenza non era unsegreto e aveva acceso i fari,accorciando le distanze. Per venti minutischivammo un intreccio di strade e di
tram. M'infilai tra omnibus e carri, perritrovarmi sempre i fari di Grandes allecalcagna, senza tregua. Dopo un po', mis'innalzò davanti la collina del Montjuïc.Il grande palazzo dell'Esposizioneuniversale e i resti degli altri padiglionierano stati chiusi appena due settimaneprima, ma già si profilavano nella brumadel crepuscolo come le rovine di unagrande civiltà dimenticata. Imboccail'ampio viale che saliva fino alla ca-scata di luci fantasma e fuochi fatui dellefontane dell'Esposizione e accelerai findove ce la faceva il motore. Via via chesalivamo lungo la strada chefiancheggiava la collina e serpeggiavafino allo Stadio Olimpico, Grandesguadagnava terreno, finché riuscii a
distinguere chiaramente il suo viso nellospecchietto. Per un istante fui tentato diprendere la strada che saliva fino alcastello militare in cima all'altura, ma sec'era un posto senza via d'uscita eraproprio quello. La mia unica speranzaera raggiungere l'altro versante dellacollina che guardava verso il mare esparire in qualcuno dei moli del porto.Per farlo, avevo bisogno di guadagnareun po'
di tempo. Grandes adesso era a unaquindicina di metri. Le enormibalaustrate di Miramar ci si aprivanodavanti con la città stesa ai nostri piedi.Tirai con tutte le forze la leva del frenoe lasciai che Grandes sbattesse contro
l'Hispano-Suiza. L'impatto ci trascinòentrambi per una ventina di metri,sollevando una ghirlanda di scintillesulla strada. Mollai il freno e avanzai unpo'. Mentre Grandes cercava direcuperare il controllo, misi la retro-marcia e accelerai a fondo. Quando luisi rese conto di quello che stavofacendo, era troppo tardi. Lo investiicon la forza di una carrozzeria e di unmotore, gentile concessione dellascuderia più prestigiosa della città,note-volmente più robusti di quelli cheproteggevano lui. L'impatto lo fece sus-sultare all'interno dell'abitacolo e vidi lasua testa colpire il parabrezza, fa-cendolo crepare completamente. Unfumo bianco uscì dalla capote della sua
macchina e i fari si spensero. Innestai lamarcia e accelerai, lasciandolo indietroe dirigendomi verso il belvedere diMiramar. Dopo pochi secondi miaccorsi che l'urto aveva schiacciato ilparafango posteriore contro la ruota, cheadesso girava soffrendo l'attrito con ilmetallo. L'odore di gom-ma bruciatainvase l'abitacolo. Venti metri più avantilo pneumatico scoppiò e l'auto iniziò aserpeggiare fino a fermarsi, avvolta inuna nuvola di fumo nero. L'abbandonai erivolsi lo sguardo verso il punto in cuiera rimasta quella di Grandes.L'ispettore si trascinava fuoridall'abitacolo, rad-drizzandosilentamente. Mi guardai intorno. Lafermata della funivia che attraversava il
porto cittadino dalla collina delMontjuïc alla torre di San Sebastián eraa una cinquantina di metri da lì. Intravidiil profilo delle cabine sospese ai caviche scivolavano sullo sfondo scarlattodel crepuscolo e mi misi a correre inquella direzione.
Uno degli addetti della funivia si stavapreparando a chiudere le portedell'edificio quando mi vide arrivaretrafelato. Mi tenne la porta aperta eindicò l'interno.
«È l'ultima corsa per oggi» avvertì.«Meglio che si sbrighi.»
La biglietteria stava per chiuderequando acquistai l'ultimo biglietto della
giornata e mi affrettai a unirmi a ungruppo di quattro persone cheaspettavano fuori della cabina. Nonnotai i loro abiti fin quando l'addetto nonaprì la porta e li invitò a entrare.Sacerdoti.
«La funivia è stata realizzata perl'Esposizione Universale ed è dotata deipiù avanzati ritrovati della tecnica. Lasua sicurezza è garantita in ognimomento. Appena inizierà il percorso,questa porta di sicurezza, che può essereaperta solo dall'esterno, verrà bloccataper evitare incidenti o, Dio non voglia,tentativi di suicidio. È chiaro che convoi, eminenze, non c'è pericolo di...»
«Giovanotto» lo interruppi. «Non puòsveltire il cerimoniale, che qui si fanotte?»
L'addetto mi rivolse uno sguardo ostile.Uno dei sacerdoti notò le macchie disangue sulle mie mani e si fece il segnodella croce. L'addetto proseguì la suatiritera.
«Viaggerete nel cielo di Barcellona auna settantina di metri d'altezza al disopra delle acque del porto, godendodel panorama più spettacolare di tutta lacittà, finora riservato a rondini, gabbianie altre creature dotate di piumaggiodall'Altissimo. Il viaggio ha una duratadi dieci minuti e fa due fermate, la prima
alla torre centrale del porto o, come ame piace chiamarla, la torre Eiffel diBarcellona, o torre di San Jaime, e laseconda e ultima alla torre di SanSebastián. Senza ulteriori indugi, auguroalle vostre eminenze una buonatraversata e vi rinnovo il desiderio dellacompagnia di ri-vedervi a bordo dellafunivia del porto di Barcellona in unaprossima occasione.»
Fui il primo a salire in cabina. L'addettoallungò la mano al passaggio dei quattrosacerdoti nella speranza di una manciache non arrivò mai. Con visibiledelusione sbatté la porta e si voltò,pronto ad abbassare la leva. L'ispettoreVíctor Grandes lo aspettava dall'altra
parte, malconcio ma sorridente, con lasua tessera della polizia in mano.L'addetto gli aprì e Grandes entrò incabina salutando con un cenno del capo isacerdoti e strizzandomi un occhio.Qualche secondo più tardi, stavamofluttuando nel vuoto.
La cabina si sollevò dal terminal versoil bordo della collina. I sacerdoti sierano ammucchiati tutti su un lato,chiaramente pronti a godersi ilpanorama del tramonto su Barcellona e aignorare, qualunque essa fosse, latorbida questione che aveva riunito me eGrandes in quella cabina. L'ispettore siavvicinò lentamente e mi mostrò l'armache impugnava. Grandi nuvole rossastre
fluttuavano sulle acque del porto. Lacabina della funivia sprofondò in una diesse e per un istante sembrò che cifossimo immersi in un lago di fuoco.
«Ci era già salito qualche volta?»domandò Grandes.
Annuii.
«A mia figlia piace da matti. Una voltaal mese mi chiede di fare il viag-
gio andata e ritorno. Un po' caro, mavale la pena.»
«Con quello che le paga il vecchio Vidalper vendermi di sicuro potrà portarcisua figlia tutti i giorni, se le va. Pura
curiosità. Qual è il mio prezzo?»
Grandes sorrise. La cabina emerse dallagrande nube scarlatta e rimanemmosospesi sulla darsena del porto, mentrele luci della città si sparge-vano sulleacque scure.
«Quindicimila pesetas» rispose battendocon la palma della mano una bustabianca che gli spuntava dalla tasca delcappotto.
«Immagino che dovrei sentirmilusingato. C'è chi ammazza per quattrosoldi. E quel prezzo include anche iltradimento dei suoi due uomini?»
«Le ricordo che qui l'unico ad avere
ammazzato qualcuno è lei.»
A quel punto i quattro sacerdoti ciosservavano attoniti e costernati, in-differenti al fascino della vertigine e delvolo sulla città. Grandes li guardòappena.
«Quando arriviamo alla prima fermata,se non è troppo disturbo, chiede-rei allevostre eminenze di scendere e dilasciarci discutere dei nostri affarimondani.»
La torre della darsena si innalzava difronte a noi come una cupola di acciaioe cavi strappata da una cattedralemeccanica. La cabina penetrò sotto lavolta della torre e si fermò sulla
piattaforma. Quando la porta si aprì, iquattro sacerdoti uscirono in fretta efuria. Grandes, pistola in pugno, mi fececenno di andare in fondo alla cabina.Uno dei preti, mentre scendeva, miguardò preoccupato.
«Stia tranquillo, giovanotto, avviseremola polizia» disse prima che la porta sirichiudesse.
«Mi raccomando» replicò Grandes.
Una volta che la porta fu bloccata, lacabina riprese il tragitto. Uscimmo dallatorre della darsena e iniziammo l'ultimotratto della traversata. Grandes siavvicinò al finestrino e contemplò ilpanorama della città, un miraggio di luci
e brume, cattedrali e palazzi, vicoli egrandi viali intessuti in un labirinto diombre.
«La città dei maledetti» disse Grandes.«Più da lontano la si osserva, più bellasembra.»
«È il mio epitaffio?»
«Non l'ucciderò, Martín. Io nonammazzo la gente. Me lo farà lei ilfavore. A me e a se stesso. Sa che horagione.»
Detto fatto, l'ispettore scaricò trepallottole sul meccanismo di chiusuradella porta e l'aprì con un calcio. Losportello rimase a penzolare nel vuoto,
mentre una raffica di vento umidoinvadeva la cabina.
«Non sentirà nulla, Martín. Mi creda.L'impatto non dura nemmeno un decimodi secondo. Istantaneo. E poi, la pace.»
Guardai la porta aperta. Davanti a me,una caduta di settanta metri nel vuoto.Guardai verso la torre di San Sebastiáne calcolai che ci volevano ancora alcuniminuti per arrivarci. Grandes mi lessenel pensiero.
«Tra pochi minuti sarà tutto finito,Martín. Dovrebbe essermene grato.»
«Davvero crede che io abbia uccisotutte quelle persone, ispettore?»
Grandes sollevò il revolver e mirò alcuore.
«Non lo so e non m'importa.»
«Credevo che fossimo amici.»
Grandes sorrise e scosse la testa.
«Lei non ha amici, Martín.»
Sentii il frastuono dello sparo e unimpatto al petto, come se un martellopneumatico mi avesse colpito nellecostole. Caddi di spalle, senza fiato,mentre uno spasmo di dolore mibruciava per tutto il corpo comebenzina.
Grandes mi aveva afferrato per i piedi emi tirava verso la porta. La cima dellatorre di San Sebastián comparve tra velidi nubi. Grandes mi passò sopra e siaccovacciò dietro di me. Mi spintonòalle spalle verso la porta.
Sentii il vento umido sulle gambe.Grandes mi diede un altro spintone enotai che il mio bacino fuoriusciva dallapiattaforma della cabina. Il risuc-chiodella gravità fu istantaneo. Stavoiniziando a cadere.
Allungai le braccia verso l'ispettore egli conficcai le dita nel collo. Za-vorrato dal peso del mio corpo, Grandesrestò incastrato nel vano della porta.
Strinsi con tutte le mie forze,premendogli sulla trachea e schiac-ciandogli le arterie del collo. Cercò didimenarsi per liberarsi dalla mia presacon una mano mentre con l'altrabrancolava in cerca della sua arma.
Le sue dita trovarono la culatta dellapistola e scivolarono verso il grilletto.
Lo sparo mi sfiorò la tempia e colpì ilbordo della porta. La pallottola rim-balzò verso l'interno della cabina e gliattraversò in maniera netta la palmadella mano. Gli affondai le unghie nelcollo, sentendo che la pelle cedeva.
Grandes emise un gemito. Tirai forte emi arrampicai di nuovo fino a restare
con più di metà corpo dentro la cabina.Una volta che riuscii ad affer-rarmi allepareti di metallo, mollai Grandes e mispostai di lato.
Mi palpai il petto e trovai il forolasciato dal proiettile dell'ispettore. Misbottonai il cappotto e tirai fuori lacopia dei Passi del cielo. La pallottolaaveva attraversato la copertina, le quasiquattrocento pagine e sbucava co-
me la punta di un dito d'argento dallaquarta di copertina. Accanto a me,Grandes si contorceva a terra, tenendosidisperatamente il collo. Il suo viso eralivido e le vene della fronte e delletempie gli pulsavano come cavi tesi.
Mi rivolse uno sguardo di supplica. Unaragnatela di capillari rotti si diffondevanei suoi occhi e capii di averglischiacciato la trachea con le mani e chestava soffocando senza rimedio.
L'osservai agitarsi a terra nella sua lentaagonia. Tirai per il bordo la bustabianca che gli spuntava dal taschino. Laaprii e contai quindicimila pesetas. Ilprezzo della mia vita. Mi misi la bustain tasca. Grandes si trascinava a terraverso l'arma. Mi alzai e l'allontanai conun calcio. L'ispettore mi afferrò lacaviglia implorando misericordia.
«Dov'è Marlasca?» chiesi.
La sua gola emise un gemito sordo.
Posai lo sguardo sui suoi occhi e capiiche stava ridendo. La cabina era ormaientrata nella torre di San Sebastiánquando lo spinsi fuori dalla porta e lovidi precipitare per quasi ottan-ta metriattraverso un labirinto di cavi, leve,ruote dentate e sbarre d'acciaio che lofecero a pezzi lungo la caduta.
24
La casa della torre era sepoltanell'oscurità. Salii a tentoni i gradinidella scalinata di pietra fino alpianerottolo e trovai la porta socchiusa.La spinsi con la mano e rimasi sullasoglia, scrutando le ombre cheinvadevano il lungo corridoio. Avanzai
di qualche passo. Restai lì, immobile, inattesa.
Tastai la parete fino a trovarel'interruttore della luce. Lo feci girarequattro volte senza nessun risultato. Laprima porta sulla destra portava incucina.
Percorsi lentamente i tre metri che me neseparavano e mi ci fermai propriodavanti. Ricordai che tenevo unalampada a olio in una delle credenze.
La trovai tra barattoli di caffè ancora daaprire provenienti dall'emporio di CanGispert. Appoggiai la lampada sultavolo di cucina e l'accesi. Una tenueluce ambrata impregnò le pareti. Presi la
lampada e uscii di nuovo in corridoio.
Avanzai lentamente, la luce chesfarfallava in alto, aspettandomi divedere qualcosa o qualcuno uscire da unmomento all'altro da una delle porte chefiancheggiavano il corridoio. Sapevo dinon essere solo. Lo fiutavo.
Un fetore acre, di rabbia e di odio,aleggiava nell'aria. Raggiunsi la fine delcorridoio e mi fermai davanti alla portadell'ultima stanza. Il chiarore dellalampada accarezzò il contornodell'armadio scostato dal muro, i vestitiget-
tati a terra esattamente come li avevolasciati quando Grandes era venuto ad
arrestarmi due sere prima. Proseguiifino ai piedi della scala che conducevaallo studio. Salii lentamente,guardandomi alle spalle ogni due o trepassi, finché arrivai nella stanza. Ilrespiro rossastro del crepuscolopenetrava dai finestroni. Andai in frettaverso il muro dove si trovava il baule elo aprii. La cartellina con il manoscrittoper il principale era sparita.
Tornai verso le scale. Passando davantialla mia scrivania vidi che la tastieradella vecchia macchina per scrivere erasfasciata, come se qualcuno l'avessepresa a pugni. Scesi lentamente le scale.Imboccando di nuovo il corridoio, miaffacciai all'ingresso del salotto. Perfino
nella penombra riuscii a vedere tutti imiei libri gettati a terra e la pelle dellepoltrone ridotta a brandelli. Mi voltai edesaminai i venti metri di corridoio chemi separavano dalla porta. Il chiaroredella lampada mi permetteva di scorgerei contorni solo fino alla metà di quelladistanza. Più in là, le ombre si agitavanocome acque scure.
Ricordavo di aver lasciato aperta laporta di casa quando ero entrato.
Adesso era chiusa. Avanzai un paio dimetri, ma qualcosa mi fermò mentreripassavo davanti all'ultima stanza delcorridoio. Entrando non l'avevo no-tataperché la porta si apriva verso sinistra e
passandoci davanti non mi eroaffacciato, ma adesso, avvicinandomi, lavidi chiaramente. Una colomba biancacon le ali spiegate a croce erainchiodata sulla porta. Le gocce disangue colavano sul legno, ancorafresche.
Entrai. Guardai dietro la porta, ma nonc'era nessuno. L'armadio era ancorascostato di lato. La corrente fredda eumida che usciva dal foro nel muroinvadeva la stanza. Lasciai la lampadasul pavimento e appoggiai le mani sullostucco ammorbidito che circondava ilbuco. Iniziai a grattare con le unghie esentii che mi si sgretolava tra le dita.Cercai lì intorno e trovai un vecchio
tagliacarte nel cassetto di uno deitavolini ammucchiati nell'angolo. Infilaila lama nello stucco e cominciai ascavare. Il gesso si staccava con facilità.Lo strato non era spesso più di trecentimetri. In fondo c'era del legno.
Una porta.
Ne cercai i bordi con il tagliacarte e apoco a poco il contorno della porta sidisegnò sul muro. A quel punto avevogià dimenticato la presenza in-combenteche avvelenava la casa e restava inagguato nell'ombra. La porta non avevamaniglia, solo una serratura arrugginitache era rimasta sepolta nel gessorammollito da anni di umidità. Vi
affondai la lama e cercai invano diforzarla. Cominciai a prenderla a calcifinché lo stucco che sosteneva laserratura si sbriciolò lentamente. Finiidi liberare il meccanismo con iltagliacarte e, subito dopo, un semplicespintone buttò giù la porta.
Una ventata di aria putrefatta esalòdall'interno, impregnandomi i vestiti e lapelle. Presi la lampada ed entrai. Lastanza era un rettangolo di cinque o seimetri di profondità. I muri eranoricoperti da disegni e iscrizioni chesembravano fatti con le dita. Il tratto eradi color marrone scuro. Sangue secco. Ilpavimento era cosparso di ciò cheall'inizio scambiai per polvere, ma
quando abbassai la lampada sirivelarono frammenti di ossicini. Ossadi animali, spezzate in una marea dicenere. Dal soffitto pendevanoinnumerevoli oggetti legati a cordicellenere. Riconobbi statuette religiose,immaginette di santi e madonne con ilvolto bruciato e gli occhi strappati via,crocifissi avvolti nel filo spinato e restidi giocattoli di latta e bambole dagliocchi di vetro. La figura era sul fondo,quasi invisibile.
Una sedia rivolta verso l'angolo, sullaquale si distingueva un profilo.
Vestiva di nero. Un uomo. Le mani eranoammanettate dietro la schiena.
Uno spesso fil di ferro stringeva le suemembra alla sedia. Mi invase un freddocome non l'avevo mai provato fino aquel momento.
«Salvador?» riuscii ad articolare.
Avanzai lentamente verso di lui. Lafigura rimase immobile. Mi fermai a unpasso da lei e allungai piano la mano. Lemie dita gli sfiorarono i capelli e siposarono sulla spalla. Cercai di fargirare il corpo, ma sentii che qualcosacedeva sotto le dita. Un secondo dopoaverlo toccato mi sembrò di sentire unsussurro e il cadavere si dissolse incenere, che si sparse tra i vestiti e ilegacci di fil di ferro per poi innalzarsi
in una nuvola di tenebre che restò afluttuare fra i muri di quella prigione chel'aveva nascosto per anni. Contemplai ilvelo di cenere sulle mie mani e me leportai alla faccia, spargendomi sullapelle i resti dell'anima di RicardoSalvador. Quando aprii gli occhi, vidiche Diego Marlasca, il suo carceriere,aspettava sulla soglia della cella con ilmanoscritto per il principale in mano eil fuoco negli occhi.
«L'ho letto mentre l'aspettavo, Martín»disse. «Un capolavoro. Il principalesaprà ricompensarmi quando glieloconsegnerò a nome suo. Riconosco dinon essere stato capace di risolverel'enigma. Mi sono fermato lungo la
strada. Sono contento di vedere che ilprincipale ha saputo trovare unsuccessore con più talento di me.»
«Si sposti.»
«Mi dispiace, Martín. Creda, midispiace. Cominciavo a stimarla» disseestraendo dalla tasca quello chesembrava un manico d'avorio. «Ma nonposso lasciarla uscire da questa stanza.È ora che lei prenda il posto del poveroSalvador.»
Premette un bottone sul manico e unalama a doppio filo brillò nellapenombra.
Si scagliò su di me con un urlo di
rabbia. La lama del coltello mi squarciòla guancia e mi avrebbe strappatol'occhio sinistro se non mi fossi spo-stato di lato. Caddi di spalle sulpavimento ricoperto di piccole ossa e dipolvere. Marlasca afferrò il coltello conentrambe le mani e si lasciò cadere su dime, appoggiando tutto il suo peso sullalama. La punta si fermò a un paio dicentimetri dal mio petto, mentre con lamano destra stringevo Marlasca allagola.
Girò la faccia per mordermi il polso egli sferrai un pugno sul viso con lasinistra. Quasi non fece una piega. Lomuoveva una rabbia al di là dellaragione e del dolore, e capii che non mi
avrebbe lasciato uscire vivo da quellacella. Si scagliò su di me con una forzaincredibile. Sentii la punta del coltelloche mi perforava la pelle. Lo colpii dinuovo con tutte le mie forze. Il miopugno si schiantò sul suo volto e sentiirompersi il setto nasa-le. Il suo sanguem'impregnò le nocche della mano.Marlasca urlò ancora, indifferente aldolore, e mi affondò la lama di uncentimetro nella carne.
Una fitta di dolore mi percorse il petto.Lo colpii un'altra volta, cercandogli leorbite degli occhi con le dita, ma luisollevò il mento e riuscii a confic-carglile unghie soltanto nella guancia. Stavoltasentii i suoi denti sulle dita.
Gli affondai il pugno nella bocca,rompendogli le labbra e strappandoglidiversi denti. Lo sentii urlare e il suoimpeto si affievolì per un istante. Lospinsi di lato e cadde a terra, il voltoridotto a una maschera di sanguetremante di dolore. Mi scostai da lui,pregando che non si rialzasse. Unsecondo dopo si trascinò verso ilcoltello e cominciò a sollevarsi.
Lo afferrò e si gettò su di me con un urloassordante. Stavolta non mi colse disorpresa. Riuscii ad afferrare il manicodella lampada e gliela sca-gliai controcon tutte le mie forze. La lampada sischiantò sulla sua faccia e l'olio gli sirovesciò sugli occhi, le labbra, la gola e
il petto. Prese fuoco all'istante. In unpaio di secondi le fiamme stesero unmanto che ricoprì tutto il suo corpo. Icapelli svaporarono in un attimo. Vidi ilsuo sguardo d'odio attraverso le fiammeche gli divoravano le palpebre. Presi ilmanoscritto e uscii. Marlasca impugnavaancora il coltello quando cercò diseguirmi fuori da quella stanza maledettae cadde bocconi sul mucchio di vestitivecchi, che presero subito fuoco. Lefiamme raggiunsero il legno sta-
gionato dell'armadio e i mobiliaccatastati contro il muro. Fuggii versoil corridoio e lo vidi avanzare ancoraalle mie spalle con le braccia tese, checercava di raggiungermi. Mi portai di
corsa verso la porta, ma prima di usciremi fermai a osservare Diego Marlascache si consumava tra le fiammecolpendo rabbiosamente le pareti ches'incendiavano quando le toccava. Ilfuoco si propagò tra i libri sparpagliatiin salotto e raggiunse le tende.
Le fiamme si sparsero in serpenti difuoco sul soffitto, lambendo le cornici diporte e finestre, strisciando per le scaledello studio. L'ultima immagine chericordo è quella di quell'uomo maledettoche cadeva ginocchioni alla fine delcorridoio, perdute ormai le vanesperanze della sua follia e il corporidotto a una torcia di carne e di odioche fu inghiottita dalla tormenta di
fiamme che si propagava senza rimedioper la casa della torre. Poi aprii la portae corsi giù per le scale.
Alcuni abitanti del quartiere si eranoriuniti in strada quando avevano visto leprime fiamme spuntare dalle finestre.Nessuno fece caso a me mentre miallontanavo giù per il vicolo. Dopo unpo' sentii esplodere i vetri dello studio emi voltai per vedere il fuoco ruggire eabbracciare la rosa dei venti a forma didrago. Qualche secondo dopo miallontanai verso il paseo del Borncamminando in senso contrario a unamarea di persone che accor-revanoguardando in alto, gli occhi catturatidallo sfavillio del falò che s'innalzava
nel cielo nero.
25
Quella notte tornai per l'ultima volta allalibreria di Sempere e Figli. Alla portaera appeso un cartello con la scritta"Chiuso", ma quando mi avvicinai vidiche c'era ancora luce all'interno e cheIsabella era dietro al bancone, sola, losguardo assorto in un grosso librocontabile che, a giudicaredall'espressione del suo viso,prometteva la fine dei giorni dell'anticalibreria. Vedendola mordicchiare lamatita e grattarsi la punta del naso conl'indice, seppi che finché ci fosse statalei quel posto non sarebbe mai
scomparso. La sua presenza l'avrebbesalvato, come aveva fatto con me. Nonosai rovinare quell'istante e rimasi aguardarla senza che lei mi notasse,sorridendo tra me. All'improvviso, comese mi avesse letto nei pensieri, alzò gliocchi e mi vide. La salutai con la mano enotai che, suo malgrado, gli occhi le siriempivano di lacrime. Chiuse il libro euscì di corsa da dietro il bancone peraprirmi la porta. Mi guardava come senon riuscisse a credere che fossi lì.
«Quell'uomo mi ha detto che lei erafuggito... Che non l'avremmo mai piùrivista.»
Immaginai che Grandes le avesse fatto
una visita.
«Voglio che sappia che non ho creduto auna sola parola di quello che mi haraccontato» disse Isabella. «Mi facciaavvertire...»
«Non ho molto tempo, Isabella.»
Mi guardò, abbattuta.
«Se ne va, vero?»
Annuii. Isabella deglutì.
«Le ho già detto che non mi piaccionogli addii.»
«A me ancora meno. Per questo non
sono venuto a dirti addio. Sono venuto arestituire un paio di cose che non miappartengono.»
Tirai fuori la copia dei Passi del cielo egliela diedi.
«Questa non sarebbe mai dovuta usciredalla vetrina con la collezione privatadel signor Sempere.»
Isabella la prese e, vedendo la pallottolaancora imprigionata fra le pagine, miguardò senza dire nulla. Allora tiraifuori la busta bianca con le quindicimilapesetas con cui il vecchio Vidal avevatentato di comprare la mia morte e lalasciai sul bancone.
«E questa è per tutti i libri che Semperemi ha regalato in questi anni.»
Isabella l'aprì e contò il denaro, attonita.
«Non so se posso accettarlo...»
«Consideralo il mio regalo di nozze, inanticipo.»
«E io che avevo ancora speranze che ungiorno lei mi portasse all'altare, anchese solo come padrino.»
«Niente mi avrebbe fatto più piacere.»
«Ma deve andarsene.»
«Sì.»
«Per sempre.»
«Per un po' di tempo.»
«E se vengo con lei?»
La baciai sulla fronte e l'abbracciai.
«Dovunque vada, tu sarai sempre conme, Isabella. Sempre.»
«Non penso di sentire la sua mancanza.»
«Lo so.»
«Posso almeno accompagnarla al treno oa quello che è?»
Esitai troppo a lungo per rifiutare quegli
ultimi minuti in sua compagnia.
«Per essere sicura che se ne va davveroe che mi sono liberata di lei persempre» aggiunse.
«Affare fatto.»
Scendemmo lentamente per le Ramblas,con Isabella che mi teneva il braccio.Arrivati in calle del Arc del Teatre,imboccammo il vicolo scuro che sifaceva strada attraverso il Raval.
«Isabella, quello che vedrai stanotte nonpotrai raccontarlo a nessuno.»
«Nemmeno al mio Sempere junior?»
Sospirai.
«Certo che sì. A lui puoi raccontaretutto. Con lui non abbiamo quasisegreti.»
Aprendo la porta, Isaac, il guardiano, cisorrise e si tirò da parte.
«Era ora che avessimo una visitaimportante» disse, facendo una riverenzaa Isabella. «Immagino che preferiscafare lei da guida, Martín.»
«Se non le spiace.»
Isaac annuì e mi tese la mano. Glielastrinsi.
«Buona fortuna» disse.
Il guardiano si ritirò nell'ombra,lasciandomi solo con Isabella. La mia exassistente e fiammante nuova direttricedi Sempere e Figli osservava tutto conuna mescola di meraviglia eapprensione.
«Che specie di posto è questo?»domandò.
La presi per mano e lentamente la guidaiper il resto del tragitto fino ad arrivarealla grande sala che ospitava l'ingresso.
«Benvenuta al Cimitero dei LibriDimenticati, Isabella.»
Isabella alzò lo sguardo verso la cupoladi vetro e si perse in quella visioneimpossibile di fasci di luce bianca chetempestavano una babele di tunnel,passerelle e ponti tesi verso le visceredi quella cattedrale fatta di libri.
«Questo posto è un mistero. Unsantuario. Ogni libro, ogni volume chevedi, ha un'anima. L'anima di chi lo hascritto e di quelli che lo hanno letto evissuto e sognato. Ogni volta che unlibro cambia di mano, ogni volta chequalcuno fa scorrere lo sguardo sullesue pagine, il suo spirito cresce e sirafforza. In questo posto i libri chenessuno più ricorda, i libri che si sonoperduti nel tempo, vivono per sempre, in
attesa di arrivare tra le mani di un nuovolettore, di un nuovo spirito...»
Più tardi lasciai Isabella ad aspettareall'ingresso del labirinto e mi ad-
dentrai da solo nelle gallerie con inmano quel manoscritto maledetto chenon avevo avuto il coraggio didistruggere. Sperai che i miei passi miguidassero a trovare il posto in cuidovevo seppellirlo per sempre. Svoltaia mille angoli fino a credere di essermiperso. Poi, quando ebbi la certezza diaver già fatto quello stesso percorsodieci volte, capitai all'ingresso dellastanzetta dove mi ero ritrovato di fronteal mio stesso riflesso, in quel piccolo
specchio in cui lo sguardo dell'uomovestito di nero era sempre presente.Avvistai un vuoto tra due dorsi di cuoionero e, senza pensarci, ci infilai lacartellina del principale. Stavo perandarmene quando mi voltai e miavvicinai di nuovo allo scaffale. Presi ilvolume accanto al quale avevo confinatoil manoscritto e lo aprii. Mi bastòleggere un paio di frasi per sentireun'altra volta quella risata cupa alle miespalle. Lo rimisi a posto e ne presi unaltro a caso, dandogli una rapidaocchiata. Ne presi un altro e poi unaltro, e così via di seguito fino aesaminare decine di volumi stipati nellastanza e a verificare che tutticontenevano diverse scritte con le stesse
parole, che erano oscurati dalle stesseimmagini e che la stessa favola siripeteva come un pas de deux inun'infinita galleria di specchi. LuxAeterna.
Uscendo dal labirinto, trovai Isabellache mi aspettava seduta su un gradinocon il libro che aveva scelto tra le mani.Mi sedetti accanto a lei e Isabella miappoggiò la testa sulla spalla.
«Grazie per avermi portato qui» disse.
Capii allora che non avrei mai piùrivisto quel posto, che ero condannato asognarlo e a scolpire il suo ricordo nellamia memoria, sapendomi fortunato peraver potuto percorrerne i corridoi e
sfiorarne i misteri. Chiusi gli occhi unistante e lasciai che quell'immagine mis'incidesse per sempre nella mente. Poi,senza osare guardare di nuovo, presi permano Isabella e mi diressi all'uscitalasciandomi per sempre alle spalle ilCimitero dei Libri Dimenticati.
Isabella mi accompagnò fino al molodove mi aspettava la nave che miavrebbe portato lontano da quella città eda tutto quanto avevo conosciuto.
«Come ha detto che si chiama ilcapitano?» domandò Isabella.
«Caronte.»
«Non è divertente.»
L'abbracciai per l'ultima volta e laguardai negli occhi in silenzio. Lungo lastrada eravamo rimasti d'accordo chenon ci sarebbero stati addii, né parolesolenni né promesse da mantenere.Quando le campane di Santa Maria delMar batterono la mezzanotte salii abordo. Il capitano Olmo mi diede ilbenvenuto e si offrì di accompagnarminella mia cabina. Gli dissi che preferivoaspettare. L'equipaggio mollò gliormeggi e lentamente lo scafo si separòdal molo. Mi appostai a poppa,contemplando la città che si allontanavain una marea di luci. Isabella rimase lì,immobile, i suoi occhi nei miei, finché ilmolo si perse nell'oscurità e il grandemiraggio di Barcellona sprofondò nelle
acque buie. A una a una le luci dellacittà si spensero in lontananza e capiiche avevo già iniziato a ricordare.
EPILOGO
1945
Sono passati quindici lunghi anni dallanotte in cui fuggii per sempre dalla cittàdei maledetti. Per molto tempo la mia èstata un'esistenza di assenze, senz'altronome né presenza se non quella di unestraneo itinerante.
Ho avuto cento nomi e altrettantimestieri: nessuno di loro era il mio.
Sono scomparso in città infinite e in
villaggi così piccoli che nessuno lìaveva più passato né futuro. In nessunposto mi sono fermato più delnecessario. Più prima che poi, fuggivodi nuovo, senza avvisare, lasciando soloun paio di libri vecchi e qualche vestitodi seconda mano in stanze lu-gubri in cuiil tempo non aveva pietà e il ricordobruciava. Non ho avuto altra memoria senon l'incertezza. Gli anni mi hannoinsegnato a vivere nel corpo di unestraneo che non sapeva se avevacommesso quei crimini che potevaancora fiutare sulle proprie mani, seaveva perduto la ragione ed eracondannato a vagare per il mondo infiamme che aveva sognato, in cambio diqualche moneta e della promessa di
prendersi gioco di una morte che adessogli sembrava la più dolce dellericompense. Molte volte mi sono chiestose la pallottola che l'ispettore Grandesmi aveva sparato al cuore non avesseattraversato le pagine del libro, se nonfossi stato io a morire in quella cabinasospesa in aria.
Nei miei anni di pellegrinaggio ho vistol'inferno promesso nelle pagine scritteper il principale acquistare vita al miopassaggio. Mille volte sono fuggito dallamia stessa ombra, sempre guardandomialle spalle, sempre aspettandomi ditrovarla girato l'angolo, dall'altra partedella strada o ai piedi del letto nelle oreinterminabili che precedevano l'alba.
Non ho mai permesso a nessuno difrequentarmi abbastanza a lungo dachiedermi perché non invecchiavo,perché non si aprivano rughe sul mioviso, perché il mio riflesso era lo stessodella notte in cui avevo lasciato Isabellasul molo di Barcellona e non era unminuto più vecchio.
C'è stato un tempo in cui ho creduto diaver esaurito tutti i nascondigli delmondo. Ero così stanco di avere paura,di vivere e morire di ricordi, che misono fermato lì dove finiva la terra einiziava un oceano che, come me, sisveglia ogni giorno uguale a quelloprecedente, e ci sono rimasto.
Oggi è un anno che sono arrivato qui eho recuperato il mio nome e il miomestiere. Ho comprato questo vecchiocapanno sulla spiaggia, poco più di unatettoia che divido con i libri lasciati dalvecchio proprietario e una macchina perscrivere che mi piace credere potrebbeessere la stessa con cui avevo scrittocentinaia di pagine che non saprò mai sequalcuno ricorda. Dalla mia finestravedo un piccolo molo di legno che siprotende in mare e, legata alla suaestremità, la barca che era in venditaassieme alla casa, una barchetta con cuia volte esco in mare fino alla scoglierasu cui le onde s'infrangono e dove lacosta quasi scompare dalla vista.
Non avevo più scritto fin quando sonoarrivato qui. La prima volta che hoinfilato un foglio in macchina e ho messole mani sulla tastiera, ho te-muto di nonessere in grado di comporre un solorigo. Ho scritto le prime pagine diquesta storia durante la mia prima nottenel capanno sulla spiaggia. Ho scrittofino all'alba, come ero solito fare annifa, senza sapere ancora per chi la stessiscrivendo. Di giorno camminavo lungola spiaggia o mi sedevo sul molo dilegno davanti al capanno - unapasserella tra il cielo e il mare - aleggere i mucchi di giornali vecchi cheavevo trovato in uno degli armadi. Nelleloro pagine c'erano storie di guerra, delmondo in fiamme che avevo sognato per
il principale.
È stato così, leggendo quegli articolisulla guerra in Spagna e poi in Europa enel mondo, che ho deciso: non avevo piùniente da perdere e l'unica cosa chedesideravo era sapere se Isabella stavabene e se magari si ricordava ancora dime. O forse volevo solo sapere se eraancora viva. Ho scritto quella letteraindirizzata all'antica libreria Sempere eFigli in calle Santa Ana di Barcellonache ci avrebbe messo settimane o mesiad arrivare, sempre che fosse arrivata, adestinazione. Come mittente ho messoMr Rochester, sapendo che se la letterafosse finita tra le sue mani Isabellaavrebbe saputo di chi si trattava e, se lo
desiderava, avrebbe potuto lasciarlachiusa e dimenticarmi per sempre.
Per mesi ho continuato a scrivere questastoria. Ho rivisto il volto di mio padre emi sono aggirato di nuovo nellaredazione della "Voz de la Industria"sognando di emulare il grande PedroVidal. Ho rivisto per la prima voltaCristina Sagnier e sono rientrato nellacasa della torre per sprofonda-
re nella follia che aveva consumatoDiego Marlasca. Scrivevo damezzanotte all'alba senza tregua,sentendomi vivo per la prima volta daquando ero scappato dalla città.
La lettera è arrivata un giorno di giugno.
Il postino aveva fatto scivolare la bustasotto la porta mentre dormivo. Eraindirizzata a Mr Rochester e comemittente c'era, semplicemente, Semperee Figli, Barcellona. Per diversi minutimi sono aggirato per il capanno, senzaosare aprirla. Alla fine sono andato asedermi in riva al mare a leggerla. Lalettera conteneva un foglio e unaseconda busta, più piccola. Sullaseconda busta, invecchiata, c'erasoltanto il mio nome, David, in unacalligrafia che non avevo dimenticatononostante tutti gli anni in cui l'avevopersa di vista.
Nella lettera, Sempere figlio miraccontava che lui e Isabella, dopo
diversi anni tormentati di fidanzamento,si erano sposati il 18 gennaio 1935
nella chiesa di Santa Ana. La cerimonia,contro ogni previsione, era statacelebrata dal novantenne sacerdote cheaveva pronunciato il commiato funebreai funerali del signor Sempere e che,nonostante tutti i tentativi del vescovado,recalcitrava a morire a continuava a farele cose alla sua maniera. Un anno dopo,qualche giorno prima che scoppiasse laguerra civile, Isabella aveva dato allaluce un maschietto che si sarebbechiamato Daniel Sempere. Gli anniterribili della guerra avevano portatoogni specie di ristrettezze e poco dopola fine del conflitto, in quella pace nera
e maledetta che avrebbe avvelenato laterra e il cielo per sempre, Isabellaaveva preso il colera ed era morta tra lebraccia del marito nell'appartamentosopra la libreria. L'avevano seppellita alMontjuïc il giorno del quartocompleanno di Daniel sotto una pioggiache era durata due giorni e due notti, equando il piccolo aveva chiesto al padrese il cielo piangesse a lui era mancata lavoce per rispondergli.
La busta a mio nome conteneva unalettera che Isabella mi aveva scritto neisuoi ultimi giorni di vita. Aveva fattogiurare al marito di recapitarmela sefosse venuto a sapere dove mi trovavo.
Caro David,
a volte mi sembra di avere iniziato ascriverle questa lettera tanti anni fa e dinon essere stata ancora capace di finirla.È passato molto tempo da quando l'hovista per l'ultima volta, sono successemolte cose terribili e meschine, eppurenon c'è giorno in cui non mi ricordi dilei e non mi chieda dov'è, se ha trovatopace, se sta scrivendo, se è diventato unvecchio brontolone, se è innamorato o sesi ricorda di noi, della piccola libreriadi Sempere e Figli e della peggiorassistente che abbia mai avuto.
Temo che lei se ne sia andato senzaavermi insegnato a scrivere e non so
nemmeno da dove iniziare a mettere inparole tutto quello che vorrei dirle. Mipiacerebbe che sapesse che sono statafelice, che grazie a lei ho trovato unuomo che ho amato e che mi ha amato, eche insieme abbiamo avuto un figlio,Daniel, a cui parlo sempre di lei e cheha dato un senso alla mia vita chenemmeno tutti i libri del mondopotrebbero neanche cominciare aspiegare.
Nessuno lo sa, però a volte torno ancorasu quel molo dal quale l'ho vista partireper sempre e mi siedo un po', da sola, adaspettare, come se credessi che lei staper tornare. Se lo facesse, vedreb-beche, nonostante tutto quello che è
successo, la libreria è ancora aperta, ilterreno su cui sorgeva la casa della torreè ancora abbandonato, tutte le menzognedette su di lei sono state dimenticate e inqueste strade ci sono tante persone conl'anima talmente mac-chiata di sangueche non osano più ricordare e quando lofanno mentono a se stesse, perché nonpossono nemmeno guardarsi allospecchio. In libreria continuiamo avendere i suoi libri, ma di nascosto,perché adesso sono stati dichiaratiimmorali e il paese si è riempito digente desiderosa di distruggere ebruciare libri piuttosto che di leggerli.Sono brutti tempi e spesso credo che sene av-vicinino di peggiori.
Mio marito e i dottori credono diingannarmi, ma io so che mi resta pocotempo. So che morirò presto e chequando lei riceverà questa lettera io nonci sarò più. Per questo volevo scriverle,per farle sapere che non ho paura, che ilmio unico dispiacere è lasciare un uomobuono che mi ha dato la sua vita e il mioDaniel soli in un mondo che ogni giornomi sembra più simile a come lei dicevache fosse, e non a come io volevocredere che potesse essere.
Volevo scriverle perché sapesse che,nonostante tutto, ho vissuto e sono grataper il tempo che ho trascorso qui, gratadi averla conosciuta e di essere stata suaamica. Volevo scriverle perché mi
piacerebbe che mi ricordasse e che, ungiorno, se lei ha qualcuno come io ho ilmio piccolo Daniel, gli parlasse di me econ le sue parole mi facesse vivere persempre.
Le vuole bene
Isabella
Giorni dopo aver ricevuto quella letteraseppi di non essere solo sulla spiaggia.Avvertii la sua presenza nella brezzadell'alba, ma non volli o non poteifuggire di nuovo. Accadde unpomeriggio, quando mi ero seduto ascrivere davanti alla finestra mentreaspettavo che il sole calasseall'orizzonte. Sentii i passi sulle tavole
di legno del molo e lo vidi.
Il principale, vestito di bianco,camminava lentamente lungo il molo eteneva per mano una bambina di sette ootto anni. Riconobbi l'immagineall'istante, quella vecchia foto cheCristina aveva custodito per tutta la vitasenza sapere da dove provenisse. Ilprincipale si avvicinò alla fine del moloe si accovacciò accanto alla bambina.Contemplarono entrambi il sole che sispargeva sull'oceano in un'infinitalamina d'oro incandescente. Uscii dalcapanno e avanzai lungo il molo.Quando arrivai all'estremità, ilprincipale si voltò e mi sorrise. Sul suoviso non c'era minaccia né rancore,
appena un'ombra di malinconia.
«Mi è mancato, amico mio» disse. «Misono mancate le nostre conversazioni,perfino le nostre piccole controversie...»
«È venuto a regolare i conti?»
Il principale sorrise e scosse lentamentela testa.
«Tutti commettiamo errori, Martín. Ioper primo. Le ho rubato ciò che piùamava. Non l'ho fatto per ferirla. L'hofatto per paura. Paura che leil'allontanasse da me, dal nostro lavoro.Mi sbagliavo. Ci ho messo un po'
di tempo a riconoscerlo, ma se c'è una
cosa che non mi manca è proprio iltempo.»
L'osservai con attenzione. Il principale,come me, non era invecchiato di un sologiorno.
«Cosa è venuto a fare, allora?»
Si strinse nelle spalle.
«Sono venuto a dirle addio.»
Il suo sguardo si concentrò sullabambina che teneva per mano e che miguardava con curiosità.
«Come ti chiami?» le domandai.
«Cristina» disse il principale.
Lo guardai negli occhi e annuì. Sentii ilsangue che mi si gelava. Potevo solointuire i lineamenti, ma lo sguardo erainconfondibile.
«Cristina, saluta il mio amico David. Daadesso vivrai con lui.»
Scambiai uno sguardo con il principale,ma non dissi nulla. La bambina miallungò la mano, come se avesse provatoquel gesto mille volte, e rise piena divergogna. Mi chinai verso di lei e glielastrinsi.
«Ciao» mormorò.
«Molto bene, Cristina» approvò ilprincipale. «E che altro?»
La bambina annuì, ricordando di colpo.
«Mi hanno detto che lei è un fabbricantedi storie e di racconti.»
«Uno dei migliori» aggiunse ilprincipale.
«Ne farà uno per me?»
Esitai qualche secondo. La bambinaguardò il principale, inquieta.
«Martín?» mormorò lui.
«Certo» dissi alla fine. «Ti farò tutti i
racconti che vorrai.»
La bambina sorrise e, avvicinandosi, mibaciò sulla guancia.
«Perché non vai in spiaggia e aspetti lìmentre saluto il mio amico, Cristina?»domandò il principale.
Cristina annuì e si allontanò lentamente,girandosi a guardare a ogni passo esorridendo. Al mio fianco, la voce delprincipale sussurrò la sua maledizioneeterna con dolcezza.
«Ho deciso di restituirle ciò che haamato di più e che le ho rubato. Hodeciso che per una volta lei si metterà almio posto e sentirà ciò che io sento, non
invecchierà di un solo giorno e vedràcrescere Cristina, si innamorerà di leiancora una volta, la vedrà invecchiare alsuo fianco e un giorno la vedrà morirefra le sue braccia. Questa è la miabenedizione e la mia vendetta.»
Chiusi gli occhi, scuotendo la testa frame.
«Questo è impossibile. Non sarà mai lastessa.»
«Dipenderà solo da lei, Martín. Leconsegno una pagina bianca. Questastoria non mi appartiene più.»
Sentii i suoi passi che si allontanavano equando riaprii gli occhi il principale non
c'era più. Cristina, ai piedi del molo, miosservava attenta. Le sorrisi e lei siavvicinò lentamente, esitante.
«Dov'è il signore?» domandò.
«Se n'è andato.»
Cristina si guardò intorno, l'infinitaspiaggia deserta in entrambe le dire-zioni.
«Per sempre?»
«Per sempre.»
Cristina sorrise e si sedette accanto ame.
«Ho sognato che eravamo amici» disse.
La guardai e annuii.
«E siamo amici. Lo siamo sempre stati.»
Rise e mi prese la mano. Indicai, davantia noi, il sole che sprofondava in mare, eCristina lo contemplò con le lacrimeagli occhi.
«Me ne ricorderò un giorno?» chiese.
«Un giorno.»
Allora seppi che avrei dedicato ogniminuto che ci restava da passare insiemea renderla felice, a riparare al male chele avevo fatto e a restituirle ciò che non