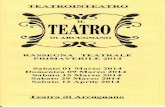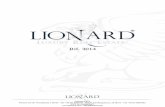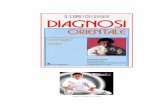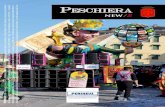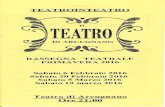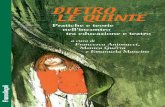c) Il teatro tradizionale - » · PDF fileLa presenza di tutti questi elementi permise al...
Transcript of c) Il teatro tradizionale - » · PDF fileLa presenza di tutti questi elementi permise al...

Mariano Fresta
Il teatro popolare tradizionale nel Sud della provincia di Siena
Indice:1) Introduzione sul concetto di teatro popolare, pag. 1;2) Le forme del teatro popolare: a) La Maggiolata, pag. 2;3) Le forme del teatro popolare: b) La Vecchia, pag. 74) Le forme del teatro popolare: c) Il Bruscello, pag. 10
1) Introduzione sul concetto di teatro popolare
In Italia è stato merito di Paolo Toschi aver interpretato le forme teatrali alla luce degli studi antropologici sul rito1, specie quelli di Frazer, dando agli studiosi nuovi strumenti di inter-pretazione e di comprensione del fenomeno. Grazie a questo approccio teorico e metodologico, il Toschi poté studiare il teatro tradizionale non più basandosi esclusivamente sui testi, come aveva fatto per primo il D'Ancona2, ma analizzando gli elementi della performance (composi-zione del gruppo di attori - tutti uomini -, costumi, oggetti scenici, processione, tipo di danza, ecc.). La presenza di tutti questi elementi permise al Toschi di poter inserire il teatro tradiziona-le nel contesto delle religioni arcaiche, e di interpretarlo, con risultati convincenti, come residuo di antichi riti precristiani, legati al culto degli alberi, della fecondità e della fertilità.
Da parte sua, Piëtr Bogatirëv, in un saggio del 19733, precisò le modalità di svolgimento degli spettacoli popolari tradizionali, individuandone le diversità di linguaggio che li differen-ziano sostanzialmente da quelli culti (rapporto attori-pubblico, assenza di unità di luogo, man-canza di realismo narrativo, ecc.).
C'è, dunque, oggi la convinzione scientifica che, oltre ad avere un linguaggio proprio, il teatro popolare tradizionale ha svolto una funzione magica e rituale; tanto è vero che esso è ca-lendarizzato, nel senso che lo spettacolo non si svolge quando si vuole, ma quando si deve, in un periodo ben definito, che generalmente coincide con il cambio delle stagioni, soprattutto con il passaggio dall'inverno alla primavera4. Esso non ha un luogo fisso ed uno spazio o edificio proprio: lo spettacolo avviene in una radura di un bosco, in una piazza pubblica; spesso è itine-rante, si riproduce più volte nella stessa serata, in casa di famiglie che lo ospitano.
Non ci sono biglietti d'ingresso, ma c'è una questua e gli spettatori hanno il dovere di ri-pagare gli attori con un'offerta in cibi, come uova (anch'esse cibo rituale, simbolo della vita che si riproduce), farina, vino, con i quali il gruppo degli attori, alla fine del periodo in cui il rito si deve svolgere, approntano e consumano una cena, che in Val d'Orcia e nelle zone limitrofe è costituita generalmente da un buon piatto di pastasciutta e da un'enorme frittata. La richiesta di questi doni alimentari fa parte essenziale del rito perché, senza la donazione delle famiglie ospitanti o degli spettatori presenti nella piazza (in questo caso si tratta di denaro), verrebbe a
1 Si veda P. Toschi, Le origini del teatro italiano, Torino, Einaudi 1956.2 A. D'Ancona, Origini del teatro italiano, Firenze, Barbera 1896.3 P. Bogatirëv, Semiotica del teatro popolare, in Ricerche semiotiche, a cura di J.M. Lotman e B. A. Uspenskij, Torino, Einaudi 1973; Bogatirëv, però, si era occupato di teatro popolare fin dal 1923 (si veda: ID, Semiotica della cultura popolare, Verona, Bertani 1982)4 Il passaggio dall'inverno alla primavera non ha, nel folklore, una data precisa: esso può avvenire tra il 13 dicem-bre (in Svezia) e il primo di gennaio (il nostro Capo d'anno), nell'approssimarsi dell'equinozio di primavera, la not-te del 30 aprile, la notte della vigilia di S. Giovanni , 23/24 giugno. In un ognuno di questi periodi si svolgono riti particolari, per indurre la buona stagione a tornare e ad offrire un abbondante raccolto.
1

mancare alla cerimonia quell'elemento che riguarda la fertilità e la fecondità della terra e quel-l'aspetto relativo alla augurabile abbondanza dei raccolti. Così, se il gruppo degli attori, dopo la performance, non riceve i doni, o se, recatosi ad eseguire lo spettacolo in un casolare di mezza-dri, il capo di casa (il capoccia) non concede loro il permesso di entrare, impedendo di svolgere la cerimonia col rischio di non far tornare la primavera, ecco allora che contro la famiglia ino-spitale è scagliata una serie di maledizioni o "accidenti", come la seguente:
… e ti morisse le bestie vaccinee ti entrasse la volpe nel pollaioe ti mangiasse tutte le galline;e la perniciosa venga alla tua figliae un accidenti a tutta la famiglia!
Altre caratteristiche del teatro popolare tradizionale sono avere delle parti cantate (quan-do non è cantato nella sua interezza) ed essere agito solo da attori uomini, anche per le parti femminili, come avveniva per il teatro classico greco-latino e come è avvenuto anche per il tea-tro culto fino all'età moderna. C'è infine da spiegare il ruolo degli attori; questi non sono profes-sionisti, ma contadini più o meno giovani, che in un determinato periodo dell'anno si incaricano di svolgere una cerimonia rituale, a nome di tutta la comunità; essi non hanno bisogno di costu-mi particolari, perché basta loro un mantello e una spada di legno, se si tratta di teatro epico, o di una barba finta e di abiti dismessi, se si tratta di teatro comico, per calarsi nei personaggi. Gli spettatori non danno peso al fatto che gli attori, sotto il lieve mascheramento, indossano gli abi-ti di tutti i giorni e sono riconoscibilissimi: le cose importanti non sono le tecniche e gli stili della recita, ma la recita stessa, cioè il rito. Pertanto, poiché molti degli spettatori sono stati at-tori negli anni precedenti o lo potrebbero diventare negli anni successivi, non esiste nessuna di-stanza tra quelli che si muovono sulla scena e quelli che stanno a guardare.
Per sottolineare meglio la differenza tra teatro popolare tradizionale e teatro culto, pos-siamo riferirci all'esperienza dei Maggi drammatici della Toscana settentrionale, molto più complessi e formalizzati degli spettacoli presenti nella Val d'Orcia. Lì il luogo della rappresen-tazione è in una radura di un bosco, entro un recinto nel quale stanno gli attori che recitano e quelli che momentaneamente sono fuori scena; questi ultimi se ne stanno seduti in un angolo, dal quale si allontanano, per recarsi al centro del recinto, quando tocca a loro cantare, e al quale ritornano subito dopo. Finita la propria scena, l'attore può tranquillamente bere un bicchiere di vino e fumarsi una sigaretta, senza che il pubblico si scandalizzi. Così, se l'azione drammatica prevede la morte di un personaggio, questi non cade a terra, per fingere l'atto, ma si mette a se-dere per non sciupare il costume. Poiché lo spettacolo è lungo (dura circa quattro ore) e gli atto-ri non sono riusciti ad imparare a memoria tutto il testo, sulla scena compare il suggeritore (l'indettatore) che, in giacca e cravatta, segue, palesemente, tutti gli attori suggerendo loro la parte: gli spettatori, sapendo che la sua presenza è indispensabile, fanno finta di non vederlo.
2) Le forme del teatro popolare: la Maggiolata.
Nel territorio meridionale della provincia di Siena, comprendente anche la Val d'Orcia, sono state attestate ben tre forme di teatro popolare: il Bruscello, che trattava generalmente di temi epici, la Vecchia, che aveva carattere comico, e la Maggiolata o Maggio, che appartiene, invece, alle cerimonie rituali proprie delle feste di primavera.
2

La Valdorcia, rispetto ad altre zone anche contermini, possiede tutti e tre i fenomeni di teatro tradizionale, dimostrando di essere stata più conservativa; difatti, nella zona di fondo val-le e nelle colline confinanti con la Val di Chiana sono stati attestati sia il Bruscello, sia la Vec-chia, che sono scomparsi con la fine della mezzadria; nella zona collinare occidentale e alle pendici del Monte Amiata, invece, la tradizione della Maggiolata è durata fino agli anni '60 ed è ancora viva nel territorio di Castiglione d'Orcia.
A proposito di questa tradizione si può dire, con buone probabilità di essere nel vero, che si tratta della forma più antica e più diffusa, non solo in Italia, ma in tutta l'Europa e quella che si è rinnovata meno negli ultimi cinque secoli. Impossibile stabilire data e luogo di nascita, ma ri-spetto a Bruscello e Vecchia, le sue prime attestazioni si trovano, per quanto riguarda l'Italia, nella letteratura latina. Legata alle feste di primavera, di inizio d'anno, era piuttosto sentita come un momento di felicità e di buon auspicio, come ci ricorda lo stesso Dante nel primo can-to dell'Inferno, quando afferma che l'ora del mattino e la «dolce stagione», il fatto, cioè, di tro-varsi nel momento dell'ingresso astronomico della primavera, gli davano la speranza di poter uscire dalla selva oscura. Nel corso del Quattrocento la festa del Maggio o di Calendimaggio diventa un fatto culturale importante, specie a Firenze, dove Lorenzo il Magnifico e Angelo Po-liziano trasformano questo rito agrario in una festa cittadina e nell'espressione festiva più rap-presentativa non solo del mondo popolare fiorentino, ma anche dei ceti borghesi ed aristocratici di quel tempo. E' nota a tutti la canzone del Poliziano che comincia con i seguenti versi:
Ben venga Maggio e il gonfalon selvaggio;
ben venga Primavera che vuol l'uom s'innamori, ecc.
che è la trascrizione dotta di un genere di canto della tradizione popolare, ben nota al grande umanista, come ci documenta una sua lettera del 1488 nella quale ci dà un breve resoconto di come si svolgeva, in forme non cittadine, il rito del maggio in Acquapendente (città in qualche modo contigua alla Val d'Orcia e collegata con essa dalla via Cassia)5 .
Ma se il Poliziano e Lorenzo il Magnifico rappresentano forse la punta più alta delle te-stimonianze dotte, si possono trovare, a partire dalla letteratura greca classica per arrivare a quella del tardo Medio Evo, decine e decine di riferimenti indiretti relativi alle cerimonie agra-rie primaverili. Il D'Ancona, nell'Appendice I (La rappresentazione drammatica del contado toscano) delle sue Origini del teatro Italiano, ci sottopone una messe ricca di questi documenti; e successivamente, nella sua opera più su ricordata, Paolo Toschi cita, tra gli altri numerosi, an-che il Leopardi delle Ricordanze:
Se torna maggio e ramoscelli e suoni van gli amanti recando alle fanciulle…
Le prime attestazioni dirette della Maggiolata risalgono alla fine del Seicento e si trova-no in un manoscritto, ancora inedito, in possesso della Contrada della Pantera di Siena. In que-sto codice sono conservati trentatré testi di Maggio, di varia provenienza, tra i quali ben sette ri-guardano il «Maggio in suffragio delle anime del Purgatorio», di cui rimanevano rare e labili tracce. L'aspetto più importante di questi testi è dato dal fatto che essi ci fanno vedere come ne-gli ultimi tre secoli la tradizione si sia conservata quasi integralmente in tutti i suoi elementi6 .
5 La notizia si trova in una lettera che il Poliziano spedì da Acquapendente a Lorenzo de' Medici il 2 Maggio 1488; la lettera è stata pubblicata da I. Del Lungo in A. Poliziano, Prose volgari inedite e poesie latine e greche edite e inedite, raccolte e illustrate da I. Del Lungo, Firenze 1867, pp. 74-75.6 Il manoscritto, la cui edizione critica, corredata da un'introduzione, è stata curata da me, è stato pubblicato col titolo Il “cantar Maggio” delle Contrade di Siena nel secolo XVII, Edizioni Cantagalli, Siena 2000.
3

Una testimonianza meno lontana da noi, risalente al 1803, si trova in un manoscritto, anch'esso rintracciato a Siena, contenente anche l'altra forma di spettacolo, il Bruscello; si trat-ta di otto quartine di ottonari che sembrano essere i capostipiti di quelle che ancora oggi canta-no a Castiglione d'Orcia7 e che, per un confronto diretto, si riportano in appendice insieme con le strofe del Maggio odierno.
Tutte queste testimonianze, indirette e dirette, riguardano però soltanto i testi; probabil-mente, gli elementi della festa ed i modi in cui si svolgeva erano così diffusi e conosciuti che nessuno di quelli che ci hanno trasmesso i testi dei canti ha sentito la necessità di descriverli per noi posteri. Parlare, dunque, della Maggiolata che si celebra a Castiglione d'Orcia ci permetterà di capire cosa essa sia e come si realizza.
Col nome di Maggio o Maggiolata si indica una cerimonia rituale con la quale si invita il sole a fare ritorno dopo il suo letargo invernale e la natura ad essere generosa di messi con gli agricoltori. Il rito si svolge tra la sera del 30 aprile e la mattina del primo di maggio; esso può essere eseguito in tanti modi, dai più semplici, come, per esempio, accendere dei falò (cosa che succedeva nella Valdichiana senese fino a qualche anno fa), a quello più complesso che presup-pone una certa organizzazione più o meno istituzionalizzata: si tratta, infatti, di un gruppo di persone che gira per le campagne, andando a trovare i contadini che abitano nei casolari sparsi nel territorio e presso i quali cantano delle strofe augurali, ricevendo in cambio doni alimentari. Per questo, presso gli studiosi di tradizioni popolari italiani, la Maggiolata è definita «canto ce-rimoniale itinerante con questua».
Il Comune di Castiglione d'Orcia, posto sulle colline ad occidente della valle, ha un ter-ritorio molto vasto che, seguendo in buona parte il corso del fiume, si stende verso Ovest a guardare le prime propaggini dell'alta maremma grossetana. Fino al 1950 circa, perché tutto il territorio potesse essere interessato alla cerimonia dell'arrivo del Maggio, da Castiglione parti-vano due gruppi di maggiaioli, uno la mattina del trenta di aprile, che faceva il giro più lungo, e l'altro nel pomeriggio dello stesso giorno, per il giro più corto. Tutti e due i gruppi rientravano in paese il mattino del primo di maggio. Oggi, con lo spopolamento delle campagne avvenuto dopo la fine della mezzadria e con l'avvento di un'agricoltura meccanizzata, c'è solo un gruppo di maggiaioli, che percorre solo una parte del territorio, cambiando zona ogni anno, in modo che nel giro di quattro o cinque anni quasi tutte le famiglie residenti nella campagna possano essere visitate. Di tutte le frazioni del Comune di Castiglione, oltre al capoluogo, solo Rocca e Gallina partecipano della festa, mentre rimangono escluse le frazioni di San Filippo Bagni, Campiglia d'Orcia e Vivo d'Orcia, perché il loro territorio fa già parte del Monte Amiata ed ha caratteristiche del tutto diverse da quello di fondo valle e delle colline; tra l'altro, a Vivo, fino al 1960 circa, c'era una propria tradizione del Maggio, con un tipo di canto diverso, con testi di-versi e con una colorazione politica sconosciuta a Castiglione, in quanto la festa del Maggio agrario si sposava con quella del Primo Maggio, festa del Lavoro.
Nel primo pomeriggio di ogni trenta aprile, dunque, presso un bar del paese, una ventina di persone si ritrova per dar via al Maggio. Il gruppo da circa trenta anni ha una stabile organiz-zazione, che non impedisce la sua continua trasformazione: vanno via i più anziani o quelli che si sono stancati, al posto dei quali subentrano altri, specie giovani. C'è un capomaggio, che svolge almeno due funzioni importanti: durante lo svolgimento della festa egli intona il pri-mo verso della strofa e poi, finita la visita, va a ricevere il dono della famiglia ospitante, che oggi consiste solamente in una somma di denaro. Il capomaggio, inoltre, nonostante il giro da compiere sia predisposto da tutti i partecipanti nelle settimane precedenti, impone le sue scelte sulle famiglie da visitare, privilegiando quelle che, grazie alla sua amicizia, possono offrire una somma più consistente o uno spuntino, o addirittura la cena, ad un certo punto dell'itinerario ce-rimoniale.
7 Il ms. è stato edito da Ivaldo Patrignani nel volume Il Bruscello, una gloria dei Rozzi, (a cura dell'Università Po-polare Senese, Siena 1993, p. 138.
4

Tra le venti persone che compongono il gruppo, sei/sette sono incaricati di porgere il canto, mentre gli altri formano una piccola orchestrina di fiati. Una volta il gruppo musicale consisteva in un violino, una o più chitarre e un mandolino; oggi, dato che molti dei maggiaioli fanno parte della banda del paese, la musica è eseguita da clarinetti, sassofoni, trombe, trombo-ne, basso. Dopo aver fatto qualche breve prova e scaldato le voci, il gruppo si avvia, in automo-bile, verso la campagna, dove abitano le famiglie da visitare.
Giunti sul luogo della prima tappa, i maggiaioli si dispongono in cerchio e cantano in-neggiando alla primavera e all'arrivo prossimo della buona stagione, con strofe come le seguen-ti8:
Ecco maggio che ritornacol profumo dei suoi fiori,l'arcipresso si nascondeché non pol cambiar sua foglia,ecco maggio che ritorna.
Sotto questi ramuscellirinverdiscono le foglie;l'usignolo il canto scioglie,fa tenore agli altri augelli,sotto questi ramuscelli.
La citazione, nel canto, di alberi, fiori e fronde rimanda alle cerimonie proprie del culto degli alberi, che ci riportano alle fasi primitive della società agraria. Ma accanto a questi ele-menti, ce ne sono altri che si collegano con riti similari riguardanti la fertilità e la fecondità del-la natura, sia quella vegetale, sia quella animale, compresa l'umanità. Spesso, infatti, i maggia-ioli, rivolgono i loro voti augurali alle donne, alle madri e soprattutto alle fanciulle cui si augura di diventare presto spose, così come si può vedere nella strofa seguente:
Su da capo a queste porteci sta un albero fiorito:tre ragazze da marito,Dio le dia la buona sorte:su da capo a queste porte.
Dopo il canto della prima strofa, la piccola banda esegue un brano musicale, tratto dal repertorio dei ballabili di fine Ottocento e dei primi del Novecento, probabili ricordi di vecchi brani bandistici, quali polke, valzer, mazurche, ecc. L'accostamento tra il canto del Maggio, che si rifà a moduli e a scale musicali medievali, e i ballabili ottocenteschi crea effetti di grande estraniamento.
Nel frattempo dalla casa escono gli abitanti, con i quali i maggiaioli scambiano conve-nevoli, battute scherzose, chiacchiere amichevoli; poi, la massaia tira fuori il fiasco del vino ed i bicchieri e tutti bevono. In qualche famiglia sono offerti anche dolciumi, oppure pane e pro-sciutto o salame. Quindi si canta qualche altra strofa e, dopo che il capomaggio ha riscosso la ricompensa, il gruppo si avvia verso un'altra abitazione, dove la scena si ripete negli stessi modi, mentre le strofe sono sostituite da altre del repertorio tra quelle che sono più adatte ai membri della casa visitata.
Tra le strofe ci sono quelle dirette a propiziare l'abbondanza dei raccolti, altre augurano alla massaia (la donna che amministra la casa) che gli animali da cortile non subiscano aggres-
8 Altre strofe sono riportate nell'appendice di questo capitolo. Nella stessa appendice è riportata pure la melodia su cui si cantano questi versi.
5

sioni da parte delle volpi e delle faine; altre, come la seguente, auspicano buoni guadagni con gli animali da stalla:
O capoccia del podere,state allegro e non temeteché il bestiame ce l'avete,guadagnate nelle fiere;o capoccia del podere.
Molte sono, poi, le strofe che chiedono i doni ed infine ci sono anche quelle di commia-to come la seguente:
Noi di qui ce ne andiamo,noi di qui si fa partenza;noi facciamo riverenza,riverenza che noi facciamo:noi di qui ce ne andiamo.
Finito il giro della campagna, dopo aver visitato una ventina di famiglie, il gruppo ritor-
na in paese e precisamente alla Rocca, piccolo centro oggi praticamente unito al paese di Casti-glione (ma anche anticamente i due paesi distavano solo qualche centinaio di metri: da Casti-glione alla Rocca, dal naso alla bocca, dice un motto del luogo). Qui la Maggiolata si trasfor-ma: ormai è mezzanotte, la gente dorme, le strade sono silenziose, così il rito protreptico della primavera diventa una lunga serenata notturna. Al passaggio dei maggiaioli si accende qualche lampadina, si apre qualche finestra, ma in genere la gente ascolta il canto e le musiche, ormai affievoliti per la stanchezza e le abbondanti libagioni, standosene comodamente a letto. Tra le altre strofe notturne, c'è anche questa:
Buona notte o vaga stella,buona notte innamorata,che da Dio sei rammentatae mi sembri la più bella;buona notte o vaga stella.
Dopo la Rocca, è il paese di Castiglione ad essere percorso per intero, fino ad arrivare alla sommità del castello, un tempo vigile sentinella e forte difesa del villaggio, oggi solo un ammasso di ruderi. Sono le sei del mattino, circa, e ad oriente sta per sorgere il sole, cui i mag-giaioli rivolgono il saluto, con l'ultima strofa del loro repertorio:
Spunta l'alba e si veste il sole,se le mette le scarpe d'oro,nella bocca c'ha un bel fiore,spunta l'alba e si veste il sole;spunta l'alba e si veste il sole.
Nella tarda mattinata del primo di maggio, in Italia giorno festivo, il capomaggio co-mincia il giro di tutte le famiglie della Rocca e di Castiglione per la questua; ogni famiglia dà qualcosa, a seconda delle proprie disponibilità. Con il ricavato dell'intera questua, qualche setti-mana dopo, di domenica, è approntato un ricco pranzo per i maggiaioli, le loro famiglie, i loro amici, le autorità cittadine e tutti coloro che hanno contribuito alla festa con generose donazioni di denaro.
6

3) Le forme del teatro popolare: La Vecchia
Insieme con la Maggiolata questa forma di spettacolo comico, chiamato «la Vecchia» in Toscana e «segavecchia» altrove, è quella che ha conservato maggiormente ed in modo eviden-te la sua origine magico-rituale ed il suo legame strettissimo con i riti agrari di passaggio dal-l'inverno alla primavera. Il suo nucleo ritualistico originario ha una diffusione indoeuropea, come hanno confermato gli studi di W. Liungman9; sue testimonianze, talora frammentarie, si trovano, infatti, in Francia, Germania, Romania, nei Paesi Slavi, nell'India settentrionale, pur se ogni regione lo sviluppa e celebra in tempi e in modalità diversi
In Italia si ha una documentazione sporadica che risale al secolo XVIII, quando a Siena, per esempio, si "segava la monaca"10; più ricche le testimonianze di epoche vicine a noi che ci fanno affermare che il «segare» o «bruciare» la vecchia era patrimonio di tutte le regioni italia-ne; ai nostri tempi quest'uso, che cade nel periodo di mezza quaresima, è ancora vivo in Lom-bardia, nel Veneto e nell'Emilia-Romagna. In queste regioni, però, la festa di mezza quaresima si attua con un fantoccio, che rappresenta la Vecchia, adorno di collane di frutta secca ed espo-sto in piazza, che alla fine viene segato o bruciato, come ci ha fatto vedere Federico Fellini nel suo film Amarcord.
Questa cerimonia rituale era presente anche in alcune zone della Toscana e dell'Umbria caratterizzate dalla mezzadria, ma qui essa assumeva forma drammatica; la variante toscana, inoltre, si caratterizzava per essere tutta cantata. Vediamone ora le modalità di svolgimento.
Nei giorni di mezza quaresima, gruppi di giovani mascherati percorrevano le strade del-le campagne per andare a cantare la Vecchia nelle grandi cucine contadine. I gruppi erano com-posti da otto/dieci giovani, tutti uomini, dei quali uno suonava la fisarmonica e un altro portava un paniere. Apriva il corteo quello con la fisarmonica; seguivano poi un vecchio e una vecchia, quindi tutti gli altri. Quando arrivavano sull'aia di un podere, qualcuno di loro (talora il capo-compagnia, che prendeva il nome di "caporale") gridava a quelli di casa: «La fate passà la vec-chia?». Se la risposta era affermativa, e quasi sempre lo era, il gruppo entrava nella cucina, dove nel frattempo era stato addossato alla parete il grande tavolo, per fare spazio. Il fisarmoni-cista prendeva posto sulla madia, quindi aveva inizio la rappresentazione, la cui trama era que-sta:
Un vecchio si lamenta della moglie, che è diventata troppo vecchia e bisbetica; pensa addirittura di ucciderla per prenderne una più giovane. Anche il figlio vuole ammazzare la ma-dre che lo ostacola nella scelta della moglie. Messisi d'accordo, padre e figlio chiamano i se-gantini perché con la sega la taglino in due. La vecchia prima resiste, poi acconsente a farsi uc-cidere, a patto, però, che vengano chiamati il notaio, cui affidare il testamento, e il prete per confessarsi. Usciti di scena questi personaggi, entrano i due segantini che, cantando, segano la vecchia; questa cade a terra esanime. Ma a questo punto il vecchio e il figlio si pentono del de-litto commesso, anche perché i carabinieri, saputo il fatto, vogliono arrestarli. Mandano a chia-mare un medico: questi arriva e con strane ed assurde medicine riesce a far resuscitare la vec-chia. Tutti si perdonano reciprocamente, il figlio sposa la ragazza che vuole e tutti, contenti per come sono andate a finire le cose, si mettono a ballare il trescone.
Finita la rappresentazione, il porta-ova, cioè quello con il paniere, faceva il giro, chie-dendo la ricompensa che era costituita principalmente da uova. Il gruppo, quindi, partiva per andare a recitare in un altro podere. In una serata, dalle tre del pomeriggio fino a quasi mezza-
9 Si veda la sua opera Traditionswanderungen Euphrat-Rhein - Studien zur Geschichte der Volksbräuche, Helsinki 1937-38, 2 voll.10 Si veda G. Catoni, L'oscena polenta del 1773, «Il Carroccio di Siena», nov.-dic. 1993, pp. 27-29.
7

notte, la compagnia riusciva a visitare da dieci a quindici famiglie contadine. Poiché la rappre-sentazione non durava più di venti minuti, è chiaro che la trama poco sopra riportata rappresen-ta un modello che assomma tutte le varianti riscontrate; in realtà, il notaio, il prete, il medico, i carabinieri difficilmente comparivano insieme.
I testi della Vecchia erano composti dagli stessi giovani, basandosi su quelli (spesso mandati a memoria) degli anni precedenti; talora si facevano aiutare da qualcuno più dotato di «estro poetico» tra i contadini di loro conoscenza, oppure dal pievano. Comunque, non era dif-ficile preparare un testo di Vecchia: la trama era sempre quella, bastava aggiungere qualche va-riante, suggerita dalla vis comica di qualcuno del gruppo, e soprattutto bastava sovrapporre po-chi versi alla buona su una melodia tradizionale da tutti conosciuta.
Nelle settimane antecedenti la mezza quaresima si svolgevano le prove, con l'assegna-zione delle parti, a secondo del timbro di voce, delle caratteristiche somatiche degli attori e del-la loro capacità di stare sulla scena. Gli attori erano tutti uomini, anche per le parti femminili (oltre alla vecchia talora comparivano una figlia e la nuora). Nessuna difficoltà c'era per l'at-trezzeria scenica: erano sufficienti un bastone e un po' di stoppa a rappresentare la barba per il vecchio, una grossa sega intelaiata senza denti per segare la vecchia, una siringa per spruzzare lo zolfo usata dal medico per iniettare le medicine alla vecchia, ecc.. Anche i costumi erano fa-cilmente reperibili, perché si trattava degli abiti giornalieri, ma usati in maniera grottesca: pan-taloni con le toppe, mutande lunghe e vecchie sottane per i personaggi femminili, vecchi scar-poni scalcagnati, fiocchi di nastri colorati alle spalline della giacca, giubbe militari smesse, ecc.
Dopo due o tre giorni di rappresentazioni, il gruppo di giovani aveva raccolto decine di coppie di uova, forse anche qualche salame e altre cibarie che venivano vendute. Con il ricava-to della vendita si organizzava, a casa di uno della compagnia, una cena; più spesso, per la cena erano utilizzate le stesse uova questuate, come si può arguire dai versi di una delle strofe che servivano ad introdurre lo spettacolo:
Buona sera, signore e signori,siam venuti a portarvi una nuova:se ci date la coppia dell'ovala frittata più bella si fa.
Se la cerimonia della Maggiolata può essere letta semplicemente come un invito alla primavera a tornare e se i doni alimentari che vengono dati ai maggiaioli possono essere inter-pretati, secondo una concezione magica, ispirata alla similarità e all'omeopatia, come augurio di un abbondante raccolto, lo spettacolo della Vecchia suggerisce interpretazioni più complesse. Che si tratti di un residuo di un antico rito agrario, non v'è dubbio, perché in essa possono esse-re individuati almeno tre elementi specifici: 1) il periodo di rappresentazione, che coincide con il passaggio dall'inverno alla primavera, con il tempo, cioè, in cui gli antichi ponevano la fine e il principio dell'anno11, quando la resurrezione del mondo agricolo era preparata dal sacrificio cruento di un uomo; 2) il sacrificio umano, che nello spettacolo tradizionale diventa la metafora della vecchia che deve essere segata; 3) infine, la "resurrezione" della vecchia che simboleggia la natura che, finito il letargo invernale (che può essere paragonato alla sua morte), ritorna a fiorire12.
Queste ipotesi sono abbastanza convincenti, ma insufficienti a spiegare, nella sua inte-rezza, il fenomeno che, invece, si presenta molto complesso. Intanto, i residui ritualistici, alme-no negli ultimi secoli e soprattutto negli ultimi anni di sopravvivenza della festa, hanno perso l'antica loro valenza, tanto che nemmeno gli ultimi informatori riescono ad individuare nella
11 Si ricorda che fino all'inizio dell'epoca moderna a Firenze l'anno cominciava il 21 di marzo, giorno dell'ingresso astronomico della primavera.12 Su questi aspetti ritualistici ha insistito Tullio Seppilli, Le feste contadine di segalavecchia in Umbria, Istituto di Et-nologia e di Antropologia culturale, Facoltà di Lettere, Università di Perugia, 1959.
8

morte e nella resurrezione della vecchia il trasferimento simbolico della morte apparente della natura e della sua «resurrezione» in primavera. Inoltre, lo spettacolo, nel corso della sua secola-re esistenza, ha assunto altri elementi, presumibilmente ripresi dalle feste di carnevale: non solo, infatti, il periodo in cui si esegue è ancora quello carnevalesco, ma la condanna a morte e l'esecuzione della vecchia si inseriscono nell'ambito delle feste di eliminazione del male, tipi-che del carnevale, durante le quali un personaggio legge il testamento o la confessione e poi viene ucciso, o bruciato, o fucilato, ecc.. Se, inoltre, noi confrontiamo la Vecchia con altre for-me drammatiche della tradizione toscana, come il Maggio della Garfagnana e della Lucchesia, oppure lo stesso Bruscello, possiamo vedere come in questi ultimi domina l'elemento atempora-lizzato del "cavaliere", inteso come eroe, simbolo del bene che sconfigge il male; nella Vecchia, invece, domina la rappresentazione di «se stessi» (il vecchio, la vecchia, il figlio), o la rappre-sentazione di funzioni interne alla compagnia (il porta-ova, il caporale). Nel primo caso si chia-ma a raccolta la gente perché assista alla rappresentazione di un conflitto-simbolo, non quoti-diano, di valori tendenzialmente metatemporali; nel secondo caso è la gente di campagna che, tramite il gruppo della Vecchia, rappresenta se stessa ed i personaggi ad essa noti e in qualche rapporto con la sua vita, come il prete, il notaio, il dottore, i carabinieri. Ed è proprio in questi personaggi che si manifesta lo spirito carnevalesco dello spettacolo: il vecchio, la vecchia, i fi-gli rappresentano in maniera grottesca ed autoironica la famiglia contadina. L'autoritarismo del capofamiglia, del "capoccia", è messo alla berlina: egli, nello spettacolo, non comanda su nes-suno, addirittura la moglie gli rivela d'averlo tradito, i figli non lo rispettano. Anche l'autorità della madre è messa in discussione: la vecchia "massaia", la "suocera" che aspettava sull'uscio la nuora per indicarle, consegnandole la scopa ed il grembiule, il suo nuovo ruolo e il suo nuo-vo status nella famiglia acquisita, nello spettacolo non può nemmeno esprimere il suo parere sulla futura sposa del figlio, ché anzi, proprio da questa viene beffeggiata. Come si vede, con il comportamento di questi personaggi siamo già dentro il clima del «mondo alla rovescia».
Ma lo spirito carnevalesco e dissacratore, in alcuni testi addirittura di stampo rabelaisia-no, insieme con una forte carica di oppositività nei confronti del mondo del padronato e della cultura egemone, si manifesta soprattutto in alcuni elementi di "abbassamento" e di ironizzazio-ne delle autorità e del mondo cittadino. Infatti, i personaggi del prete (di cui si sottolinea l'indo-le licenziosa e venale), del dottore (che porta in scena grotteschi strumenti medici e che si af-fanna a trovare paradossali rimedi per far rinvenire la vecchia), dei carabinieri (che vanamente cercano di imporre la loro autorità), sono rappresentati in modo caricaturale, quasi per una ri-vincita sulla cultura e sul potere della classe dominante.
La Vecchia, poi, insieme con la Maggiolata, è anche uno «spettacolo itinerante con que-stua», aspetto poco valutato in passato dagli studiosi, ma che può suggerire qualche riflessione tendente a spiegare il perché, pur avendo perso di vista la fondamentale ed originaria funzione magico-ritualistica, queste due espressioni tradizionali siano durate così a lungo. Abbiamo visto come l'istituto della mezzadria costringesse le famiglie contadine all'isolamento economico e sociale: la comunità contadina era frazionata in una miriade di insediamenti sparsi che indeboli-vano, e talora cancellavano del tutto, i legami collettivi. Le sole occasioni d'incontro era offerte dalle veglie serali e, in maniera più ampia, dalle fiere e dai mercati, in cui le famiglie si recava-no frequentemente13. Per il resto, ogni famiglia conduceva una vita autonoma, spesso su posi-zioni di frontiera nei confronti dei nuclei vicini con i quali poteva entrare in concorrenza per l'assegnazione di un podere più ricco.
In un siffatto contesto, il gruppo che "agisce" la festa, della Maggiolata o della Vecchia, sembra svolgere una particolare funzione, quella di celebrare il rito di una comunità disgregata che invece vuole dichiararsi unita. Il gruppo, infatti, che parte da un determinato punto di una
13 Spesso la letteratura filopadronale si lamenta di questa mania dei mezzadri di frequentare con assiduità tutte le fiere, anche le più lontane, con perdita di molte giornate di lavoro durante l'anno. L'abitudine alla frequenza di mercati e fiere in Toscana è ancora oggi molto forte, pur essendoci molte altre occasioni di socializzazione e molto più accessibili attività commerciali.
9

contrada e va a ritrovare le famiglie che vi abitano, realizzando con esse uno scambio (il grup-po offre il canto, o lo spettacolo; gli ospiti ricambiano con beni alimentari), e che infine ritorna al punto di partenza, dove il rito si conclude con una cena, compie nel suo itinerare un circolo simbolico. Questo circolo può definirsi come «comunità», che la compagnia percorre e ricon-nette ed infine celebra nella sua unità ricomposta.
Anche l'elemento della questua merita un discorso a parte. Nella Maggiolata e nella Vecchia l'accatto di beni alimentari (uova, farina, vino) non può essere visto solo come un com-penso per le prestazioni offerte dai maggiaioli o dal gruppo della Vecchia; si tratta, bensì, di uno scambio cerimoniale e rituale, come si può desumere dalle seguenti constatazioni:
1) la prestazione-spettacolo è anch'essa un bene: essa, infatti, oltre a celebrare la volon-tà di unire la comunità geograficamente frazionata, ha carattere propiziatorio ed è auspicio di buona sorte;
2) lo scambio non è volontario, ma vincolante, come abbiamo visto a proposito della Maggiolata, e come si può dedurre dalle formule di richiesta presenti anche in tutti i testi di Vecchia:
a) Voi fratelli e voi sorelle…chiedo un soccorso,siete obbligati tutti a far lo sborso.
b) Si ringrazia tutti quanti,il capoccia e la massaiaci dan le ova a centinaiaed il vino a volontà.
Per tentare di spiegare questo aspetto, occorre ritornare al contesto economico-sociale della mezzadria. Come abbiamo visto in precedenti capitoli di questo studio sulla mezzadria to-scana e in Val d'Orcia, le condizioni materiali di esistenza dei mezzadri erano piuttosto preca-rie, perché caratterizzate da una limitatezza di beni, sia alimentari, sia di altro genere. In una si-tuazione di questo tipo, dunque, la "cerimonia" del mangiare e del bere è possibile solo per il tramite di un gruppo a ciò delegato, ma non per tutti indistintamente. Ed ecco allora che la compagnia della Vecchia, o dei maggiaioli, come rappresenta simbolicamente la comunità ri-condotta alla sua unità, così mangia e beve, durante la cena organizzata con il ricavato della questua, in nome di tutta la comunità. «In termini molto banalizzati», scrive Pietro Clemente, «e unificando livello simbolico e livello materiale: con cinque uova o un salame, oppure con mille lire, non si fa festa, ma con la somma di tali beni offerta da tante famiglie contadine, un gruppo limitato può far festa in nome dei donatori dei beni»14 .
.
3) Le forme del teatro popolare: il Bruscello.
14 Su tutta la questione della rappresentatività del gruppo come "comunità ricomposta" e su quella più problemati-ca dello scambio cerimoniale si è soffermato a lungo Pietro Clemente, delle cui interpretazioni ci siamo serviti am-piamente; si vedano di lui almeno i seguenti due contributi: Maggiolata e segalavecchia: note di festa, rito, spetta-colo in due «cerimonie» tradizionali studiate nel senese e nel grossetano, in Festa: antropologia e semiotica a cura di C. Bianco e M. Del Ninno, Firenze 1981, pp. 46-57; La circolazione di uomini, attività e beni nei «canti di questua». Riflessioni teorico-metodologiche, in Vecchie segate ed alberi di maggio, a cura di M. Fresta, Montepul-ciano 1983, pp. 125-158.
10

Dalla fine dell'Ottocento fino a pochi anni fa, si è ritenuto che il termine Bruscello deri-vasse, per metatesi, da arbuscello15; la spiegazione, però, era in qualche modo condizionata dal fatto che gli attori contadini che recitavano il dramma portavano sulla scena un ramo di albero. Se, invece, si tengono di conto i testi più antichi di Bruscello, risalenti alla seconda metà del se-colo XVI, il termine potrebbe avere un'altra spiegazione e tutta la vicenda di questo spettacolo tradizionale del contado toscano potrebbe essere letta in maniera diversa.
Per il Toschi, cui si deve una radicale svolta di metodo negli studi sul teatro popolare, il termine bruscello derivava dal fatto che il gruppo di attori o portava un ramo o addirittura reci-tava il dramma attorno ad un ramo che veniva piantato in mezzo alla scena. La presenza di que-sto elemento botanico e il tema del contrasto e della lotta, che caratterizzava come genere epico questo tipo di dramma, erano interpretati dal Toschi come residui degli antichi riti agrari. Sen-nonché, accanto alle numerose attestazioni di questi bruscelli "epici", c'erano notizie più o meno frammentarie di altre forme di bruscelli, i cui temi non erano vicende epiche, ma vicende di nozze ostacolate e poi portate a termine, oppure vicende di caccia. Nel suo intento di classifi-care tutto, il Toschi teorizzò la presenza di tre tipi diversi di Bruscello: quello epico, quello mo-gliazzo o mariazo, ed infine il bruscello-caccia 16. Questa classificazione, però, oltre a basarsi su una constatazione ovvia dei fenomeni, non teneva in nessuna considerazione il fatto che i primi documenti, risalenti alla fine del secolo XVI e riguardanti questa forma di spettacolo, non parlavano né di eroi né di nozze contrastate, ma, usando un linguaggio oscenamente allusivo, di vicende di caccia notturna, attuata per mezzo del frugnuolo o bruscello, termini con cui si indi-cava la lanterna che serviva ad abbagliare gli uccelli colti nel sonno.
Questi documenti sono due dialoghi di un membro dell'Accademia dei Rozzi di Siena, soprannominato il Falòtico17, il primo intitolato Il Bruscello di Codera e Bruco (1571) e il se-condo Il Boschetto (1574)18 . Tenendo proprio in considerazione questi due componimenti ed altri cinque testi di Bruscelli da lui rintracciati negli archivi di Siena, Ivaldo Patrignani ha affac-ciato un'altra ipotesi, secondo la quale il bruscello non era che una farsa contadina del periodo di carnevale, ripresa e recitata in città dai Rozzi di Siena fino a quando le censure politiche e re-ligiose permisero una certa libertà di espressione. Sul finire del Settecento e agli inizi dell'Otto-cento, infatti, nei bruscelli si parla di caccia, ma non più con tutte le allusioni oscene dei periodi precedenti; inoltre, in alcuni di essi compare il termine bruscello come ramo di albero e come metafora sessuale (il bruscello va "rizzato" o va "piantato"). Secondo l'opinione del Patrignani, questi testi sono l'ultimo segno di vita di ciò che rimane dell'autentico bruscello, che sarebbe continuato a vivere nelle campagne, ma clandestinamente ed ormai trasformato e strumentaliz-zato dalla cultura della classe dominante che avrebbe obbligato gli autori (contadini o cittadini) ad immettere nelle loro rappresentazioni contenuti moraleggianti, ispirati a vicende agiografi-che o a personaggi della letteratura popolareggiante. Per il Patrignani, addirittura, queste rap-presentazioni ottocentesche, sulle quali si è appuntata l'attenzione degli studiosi, dal D'Ancona fino a tutti coloro che se ne sono occupati nel Novecento, solo arbitrariamente possono essere definite come bruscelli19 .
Le tesi del Patrignani sono senza dubbio accettabili per quanto riguarda l'etimologia del termine bruscello. La caccia notturna, come si diceva più sopra, avveniva mediante una lanter-na con cui abbagliare gli uccelli colti di sorpresa nel sonno, fra le macchie. Questa lanterna
15 Si vedano G. Nerucci, Saggio di uno studio sopra i parlari vernacoli della Toscana, Milano 1865, p. 98; e N. Caix, Studi di etimologia italiana e romanza, Firenze 1878, p. 89.16 Su tutta la questione si veda P. Toschi, Le origini… op. cit., capp. X e XI.17 Secondo I. Patrignani il Falotico andrebbe individuato nel grossetano Ansano Mengari, socio dell'Accademia dal 1544; sennonché il secondo testo, Il Boschetto, riporta come Autore un certo Giovanni Battista sarto, detto il Falòtico; si veda I. Patrignani, Il Bruscello, una gloria dei Rozzi, Siena 1993.18 I due Bruscelli sono stati pubblicati da H.U. Ganz, I due Bruscelli più antichi, in «Lares» giugno 1962, pp. 28 sgg.; e successivamente da I. Patrignani, Il Bruscello, op. cit.19 «Perché l'altro bruscello, quello che conosciamo ancor oggi, non entra in questa affascinante vicenda essendo cosa del tutto diversa , e nella forma e nella sostanza, dall'antico», Patrignani, Il Bruscello… op. cit. p. 12.
11

prendeva, nell'area fiorentina, il nome di frugnuolo, che deriva dal latino parlato furneolum, di-minutivo di furnus, ("forno"/"fornello"); nel senese invece si chiamava bruscello, (da "bruciare", visto che nella lanterna bruciava spesso un pezzo di legna resinosa), nome, fa osser-vare il Patrignani, mai registrato dal purismo fiorentineggiante dell'Accademia della Crusca e per questo non contenuto nemmeno nei moderni dizionari etimologici più importanti. Ancora qualche decennio fa, nelle campagne di Pienza, che è il centro più importante della Val d'Orcia, praticare la caccia notturna, muniti di lume ed altri strumenti per impaniare gli uccelli, era detto «andare a bruzzello»20 .
Inoltre il Patrignani, basandosi sul lessico e sulla coloritura dialettale della lingua usata nei testi cinquecenteschi, avanza anche l'ipotesi che il bruscello abbia avuto la sua culla proprio nella Val d'Orcia, dalla quale si irradiò fino alla città di Siena e poi da qui verso altre zone della Toscana; ma quest'ultima tesi e quella, secondo la quale tutti i Bruscelli che sono stati prodotti dal 1808 (data dell'ultimo testo da lui rintracciato) fino alla metà del Novecento derivino dal bruscello carnascialesco, sono tutte da dimostrare con dati di fatto che, nella disamina del Patri-gnani, mancano del tutto. E' anche vero che per tutto l'Ottocento la classe dirigente toscana pro-dusse uno sforzo immenso per tirar fuori delle sue tradizioni il popolo mezzadrile, con l'uso di molteplici mezzi di comunicazione popolare a cominciare dai proverbi, coniati appositamente ed inseriti nei Lunari e negli Almanacchi, fino ai dialoghi di Lapo dei Ricci e di altri autori, de-stinati ad un pubblico di contadini21; ma perché, viene da chiedersi, l'operazione di ripulitura morale ed ideologica avvenne solo con il bruscello-caccia e non anche con la Vecchia, che per allusioni oscene e per spirito di dissacrazione non era da meno?
Già Sebastiano Lo Nigro, in due convegni del 197422 , era intervenuto per segnalare che gran parte dei testi del teatro popolare toscano dell'Ottocento era stata prodotta dalla piccola «borghesia delle zone rurali, di cui facevano parte il fattore dell'azienda agricola, il piccolo pos-sidente, il parroco, il maestro elementare e il medico condotto; questi ultimi saranno anzi i veri operatori culturali delle campagne toscane e gli artefici primi di quella produzione letteraria a carattere popolare, di cui i libretti dei Maggi costituiscono la sezione più cospicua e interessan-te»23. Successivamente, le ricerche di altri studiosi confermavano in buona parte, anche per il Bruscello, quanto affermato da Lo Nigro per i Maggi, ma senza poter giungere alla conclusione definitiva che ci fosse stata una mutazione genetica del Bruscello, da rappresentazione oscena della caccia a quella di vicende di eroi senza macchia e senza paura.
La ricerca degli anni '70 e '80, infatti, condotta in Val di Chiana e in Val d'Orcia ed in tutto il senese sul teatro popolare tradizionale, anche se mise in luce che molti autori di bruscel-li erano stati i preti, i parroci e i pievani delle piccole comunità, rivelò, in modo piuttosto evi-dente, che erano esistiti anche autori contadini, persone appena istruite che avevano però le ca-pacità di tradurre in versi e in scene teatrali le letture preferite. E d'altra parte, anche se l'autore del testo era un appartenente alla piccola borghesia paesana, non bisogna dimenticare che lo spettacolo popolare era «agito per lo più da contadini, mezzadri, braccianti, e sentito come sca-denza propria, propria festa, non come imposizione esterna … Vi è quindi un fatto di "soggetti-vità" che si polarizza intorno a un linguaggio "proprio" ancorché composito, a una propria con-cezione dello spettacolo, benché influenzata da agenti esterni»24.
20 Debbo l'informazione al Prof. Franco Caporali di Pienza.21 Sulla questione la letteratura è molto ampia, per cui si danno qui solo le indicazioni indispensabili: Carpi U., Letteratura e società nella Toscana del Risorgimento, Bari 1974; Clemente P. et Alii, Mezzadri, letterati, padroni, Palermo198022 S. Lo Nigro, Genesi e funzione dei Maggi drammatici in Toscana, in La drammatica popolare nella Valle Pa-dana, Firenze 1976; e Il teatro popolare dei Maggi e la cultura borghese nella Toscana del Risorgimento, in Tea-tro popolare e cultura moderna, Firenze 1978, pp. 211-21423 Lo Nigro, Il teatro popolare dei Maggi…op. cit., pp. 213.24 P. Clemente, Il cavaliere e il contadino: note sullo spettacolo popolare nel senese, in Teatro popolare e cultura mo-derna, a cura del teatro regionale toscano, Firenze 1978, p.
12

In conclusione, la questione dell'origine del Bruscello è ancora tutta da definire, non po-tendo dire a tutt'oggi se i tre tipi di bruscello individuati dal Toschi (epico, mogliazzo, caccia) discendano da un unico nucleo (il bruscello carnevalesco, di cui quelli del Falòtico sarebbero le copie cittadine dei "prototipi"), oppure se i tre generi abbiano avuto origine distinta. La docu-mentazione in nostro possesso è ancora insufficiente e non permette di dare una risposta defini-tiva alla domanda. Possiamo, però, dire che, sebbene il mondo contadino appaia immobile nelle sue condizioni materiali di vita e nelle sue tradizioni, la circolazione culturale, anche in epoche apparentemente conservatrici, vi continuò ad agire più o meno profondamente. Contenuti nati ed elaborati altrove sono stati ripresi e trasformati dalla cultura tradizionale; fenomeni di cosid-detta ascesa e discesa di materiali culturali sono sempre avvenuti, anche se non ne abbiamo più le tracce. Sappiamo, però, della presenza dei cantastorie che rielaboravano materiali dotti per le loro storie da raccontare e da vendere nelle fiere e nei mercati; si pensi, per esempio, a tutta la frenetica e molteplice attività di Giulio Cesare Croce che, tra '500 e '600 produsse una quantità enorme di canti e di storie, inventando ex-novo o rielaborando da altri25, diffondendoli median-te opuscoli e fogli volanti. Tra l'altro, di questi fenomeni di circolazione culturale sono esempio gli studi di Carlo Ginzburg sulla società contadina del Friuli del tardo Cinquecento26 , e tutte le ricerche condotte da Rudolf Schenda sulla letteratura di colportage e sulla circolazione dei fatti culturali nel mondo popolare europeo27.
Per concludere, appare chiaro che i fenomeni di teatro popolare tradizionale che noi oggi conosciamo non sono altro che il risultato di un continuo lavoro di incorporazione attorno ad un nucleo originario, talora nemmeno più riconoscibile, di elementi risalenti ad epoche e a culture diverse.
Nella Val d'Orcia, le poche testimonianze rintracciate proprio nel territorio tra la Foce, Pienza e Monticchiello, riguardano il bruscello epico (Guerrin Meschino), mentre nelle zone contermini c'è anche la sporadica presenza del mogliazzo. L'ultima testimonianza relativa al Sud della provincia di Siena del bruscello-caccia fu raccolta, invece, da Knisella Farsetti nel 189928.
Ma sotto la denominazione di "bruscello epico" sono compresi, oltre a quelli di argo-mento epico-cavalleresco, tratti dai Reali di Francia29 o dalla Gerusalemme liberata del Tasso, anche quelli che rappresentano episodi della Bibbia, vite di santi, vicende e personaggi della storia antica e recente, leggende e novelle varie come quelle della Pia de' Tolomei o di Geno-veffa di Brabante. Ogni area aveva i suoi temi preferiti: nella Val di Chiana predominavano i temi cavallereschi (Fioravante, Buovo d'Antona, Rizieri, tratti dai Reali di Francia); sull'Amia-ta le vite dei santi e vicende della storia romana antica (Sant'Eustachio, Gli Orazi e i Curiazi, Nerone, Coriolano, ecc.); nella zona del Monte Cetona erano preferiti temi e personaggi tratti dalla Bibbia (Giuseppe Ebreo, Giuditta e Oloferne).
Il Bruscello era rappresentato nel periodo di mezza quaresima: un gruppo di attori, tutti uomini anche per le parti femminili, con indosso costumi talora anacronistici rispetto alla vi-cenda da rappresentare e quasi sempre presi in affitto presso i teatri delle città vicine, si recava in corteo sul luogo della recita, preceduto dai suonatori che dovevano richiamare il pubblico; con gli attori c'erano anche delle persone addette, alla fine della recita, all'accatto e alla vendita dei fogli volanti con il testo del bruscello. Con il ricavato della questua e della vendita dei fogli volanti, si organizzava una cena per il gruppo dei bruscellanti.
25 Si veda P. Camporesi, La maschera di Bertoldo, Torino 1976.26 C. Ginzburg, Il formaggio e i vermi, Torino 1976.27 Di R. Schenda si vedano: Volk ohne Buch, Frankfurt/M. 1970; Folklore e letteratura popolare: Italia - Germa-nia - Francia, Roma 1986.28 K. Farsetti, Quattro bruscelli senesi, Firenze 1899.29 Questo romanzo si deve ad Andrea Mengabotti da Barberino (1370-1431); in esso si narra la storia favolosa del-la casa di Francia, da Fiovo, figlio dell'imperatore Costantino, fino a Carlomagno. Insieme con il Guerrin Meschi-no e la Bibbia, costituiva la biblioteca di lettura delle famiglie contadine.
13

Arrivati sulla piazza prestabilita o sul sagrato di una chiesa, dopo la Messa, cominciava la recita. Anticamente la rappresentazione era piuttosto statica; scrive la Farsetti: «I personaggi si dispongono in circolo … indi il personaggio a cui tocca, si fa innanzi, e, terminato che abbia la sua parte si ritira, lasciando che si presenti quegli che deve cantare la strofa seguente. Così seguitano fino a che il dramma non ha il suo scioglimento»30. In tempi più recenti, forse su sug-gestione del cinematografo, le azioni erano più mosse, specie quelle dei duelli fra l'eroe buono ed il cattivo.
La forma metrica preponderante di tutti i Bruscelli era l'ottava incatenata in endecasilla-bi, ma non mancano l'esastico, il tetrastico e il distico. Spesso c'era un coro iniziale ed uno fina-le in quartine di ottonari, di cui l'ultimo tronco. La melodia su cui erano cantati i versi era unica per tutti i Bruscelli e per tutti i personaggi, ed era abbastanza simile a quella su cui si cantano tutte le ottave, anche quelle dei contrasti. Per evitare la monotonia dovuta all'uso della stessa frase musicale, gli attori-cantori, e per questo dovevano essere bravi, ora rallentavano, ora acce-leravano il ritmo, sfruttando la varia accentazione dell'endecasillabo e tenendo comunque pre-sente lo stato psicologico del personaggio interpretato. Il coro iniziale e quello finale (quartine di ottonari) erano cantati su un'aria di ritmo ternario, la cui matrice musicale era utilizzata an-che per la Vecchia (quartine di decasillabi).
Le vicende rappresentate, a prescindere dei personaggi e della loro collocazione spaziale e temporale, simboleggiavano valori ritenuti eterni, quali il Bene e il Male, l'Amore e l'Odio, ecc.; il bruscello, in effetti, si basava su di un "codice forte" che traduceva immediatamente qualsiasi storia in conflitto tra entità metatemporali, antagonistiche. Questa astrattezza faceva sì che quelle dei bruscelli fossero sentite come vicende realmente storiche e come modelli di comportamento etico.
Come la Vecchia, anche il Bruscello è scomparso con la fine della mezzadria; se della Vecchia, a partire dal 1974, c'è stata una ripresa che è durata fino quasi al 1990, lo spettacolo epico non ha avuto rappresentazioni dopo il 1950; qualche sporadico tentativo di rimetterlo in piedi si è avuto in zone lontane dalla Val d'Orcia, nel Chianti oppure a Piazze, nella zona del Monte Cetona. In Val d'Orcia, e precisamente a Monticchiello, il bruscello del Guerrin Me-schino è stato ricordato in un autodramma del "Teatro Povero": durante una scena, alcuni attori, rievocando alcune esperienze della loro gioventù, tra le quali quella della recita del bruscello, intonarono alcune ottave della rappresentazione.
Bibliografia
Bogatyrëv P., Semiotica del teatro popolare, in Lotman - Uspenskij, Ricerche semiotiche, Tori-no 1973Bogatyrëv P.- Jakobson R., Il folclore come forma di creazione autonoma, «Strumenti critici», n. 3, 1967Bonaccorsi A., Folklore musicale in Toscana, Firenze 1956Clemente, Coppi, Fineschi, Fresta, Pietrelli, Mezzadri, letterati e padroni, Palermo 1980Corazzini F., Componimenti minori della letteratura popolare italiana, Benevento 1877D'Ancona A., Origini del teatro italiano, Torino 1891 (ora in ristampa anastatica, Roma 1966)Farsetti K., Quattro bruscelli senesi, Firenze 1899Farsetti K., Befanate del contado toscano, Firenze 1900Fresta M., Il Bruscello e la Vecchia nel Sud della provincia di Siena, «Lares», XLV, n. 4, 1979, pp. 531-557Fresta M. (a cura di ), Vecchie segate ed alberi di maggio, Montepulciano 1983Giannini G., Teatro popolare toscano, «Curiosità popolari tradizionali», XIV, Palermo 1885-99 (ristampa anastatica, Bologna 1968)
30 K.Farsetti, Quattro bruscelli…op. cit., p. XXIII.
14

Patrignani I., Il Bruscello, una gloria dei Rozzi, Siena 1993Teatro popolare e cultura moderna, atti del Convegno di Montepulciano 1974, Firenze 1978Toschi P., Le origini del teatro italiano, Torino 1955.
(Tratto da La Val d’Orcia di Iris. Storia, vita e cultura dei mezzadri, Le Balze, Montepulciano 2003)
15