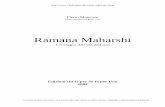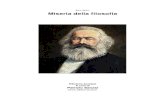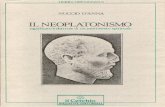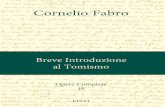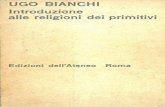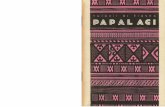Breve introduzione all'Ebraismo (Gianfranco Bertagni)
-
Upload
gianfranco -
Category
Documents
-
view
17 -
download
1
description
Transcript of Breve introduzione all'Ebraismo (Gianfranco Bertagni)

Ebraismo Di Gianfranco Bertagni Elementi del monoteismo ebraico "Ebraismo" indica, in senso ampio, la storia del popolo ebraico e, in senso più specifico e tecnico, tutto ciò che afferisce alla religione della comunità ebraica. Si è soliti definire l'ebraismo un'ortoprassi, cioè una tradizione religiosa che si sostanzia soprattutto nell'aderire a una serie di regole e norme. Forte è nel giudaismo il rapporto tra religione e popolo, così forte che è impossibile parlare di una istituzione religiosa che non sia anche un aspetto dell'identità del popolo di Israele, tanto da accostare l'ebraismo quasi a una forma di religione etnica. Come accennavamo nel precedente paragrafo, l'insegnamento centrale dell'ebraismo è la sua fede monoteista. Il dio dell'ebraismo è un dio onnipotente, che ha creato l'universo e che interviene in esso; egli porterà alla salvezza Israele, il suo popolo, il popolo eletto. I suoi fedeli, da parte loro, devono osservare la Legge di Dio, in sostanza i dieci comandamenti che egli ha rivelato a Mosè sul monte Sinai. Attraverso questo patto tra Dio e Israele, se i singoli e la comunità tutta si atterranno a quel comportamento fatto di rispetto delle prescrizioni della Legge divina, giungerà l'epoca messianica, cioè il pieno avvento del regno di Dio sulla terra. Il particolare monoteismo ebraico si sviluppa e si pone in polemica costante contro il politeismo della terra promessa in cui si insedierà Mosé, Caanan. Certamente la storia della religione ebraica non può essere tutta considerata monoteistica, essendo questo un tratto tipico della rivoluzione mosaica e di tutto l'ebraismo che la seguì. Precedentemente a questa rivoluzione, si deve pensare a una religione tipica dei popoli primitivi pastori, quali gli ebrei erano, e cioè caratterizzata dalla credenza in un Essere supremo celeste, il quale non è considerato solo (trovano infatti spazio venerazioni di altri esseri sovraumani, quali antenati, spiriti, ecc.) e che si differenzia dalle caratteristiche tipiche del dio unico di cui si accennava precedentemente. Questo Essere supremo è considerato, nelle religioni in cui egli viene pensato, come il garante di tutto ciò che alla società è necessario ma che dalla società non è gestibile (la malattia, la morte, la meteorologia e tutti quegli eventi fondamentali nella vita della comunità che non sono sotto il controllo degli uomini). Questo Essere è solitamente considerato abitante dei cieli. E questo aspetto pre-monoteistico lo rintracciamo facilmente nei testi ebraici. Dio dimora in cielo - ci viene ricordato; si manifesta servendosi di fulmini, tuoni, temporali; è colui che porta la pioggia; a volte è caratterizzato anche da una personalità non totalmente "buona" (altro tratto caratteristico degli Esseri supremi celesti), datore cioè di bene e male senza una motivazione particolare. Questo tipo di religione caratteristica dei popoli pastori nomadi si sarebbe poi - sembra - trasformata in un vero e proprio monoteismo attraverso il contatto, confronto e rifiuto del politeismo caananeo. Dobbiamo anche rilevare che nei testi presenti nell'Antico Testamento, di vero e proprio monoteismo (cioè la dichiarazione dell'esistenza di un unico dio a esclusione degli altri), non si può parlare se non dal Deutero-Isaia (questo nome si riferisce all'autore dei capitoli 40-66 del libro di Isaia, scritti circa tra il 550 e il 539 a.C., durante l'esilio di Babilonia). In testi precedenti a questi troviamo a volte, ad esempio, affermazioni che vanno nella direzione non di un monoteismo sistematico, ma di quell'idea - che non raramente rintracciamo in certe concezioni vicino-orientali - secondo la quale così come Israele ha il suo dio Jahve, così anche altri popoli hanno i loro dei. Per esempio troviamo scritto in Giudici 11, 23-24, ciò che il giudice Iefte fece sapere al re degli Ammoniti, nel tentativo di annullare le loro ostilità verso Israele: "Ora il Signore, Dio d`Israele, ha scacciato gli Amorrei davanti a Israele suo popolo e tu vorresti possedere il loro paese? Non possiedi tu quello che Camos tuo dio ti ha fatto possedere? Così anche noi possiederemo il paese di quelli che il Signore ha scacciati davanti a noi". È un tratto questo, comunque, che definisce bene il carattere tipicamente ebraico - che rimase anche successivamente - di rapporto esclusivo tra il popolo e il suo dio, che ha guidato la sua storia: Jahve e Israele. Il dio dell'antico ebraismo non è

dunque quel dio universale, quel dio di tutti che è proprio del monoteismo più "maturo", ma è il dio di Israele, il dio che si schiera dalla parte di Israele contro gli altri popoli, il dio che punisce Israele quando Israele si allontana da lui, non ubbidendogli. Tra l'altro, è da notare, a proposito di questa dimensione di alleanza tra Dio e il suo popolo contro il nemico, che la cosiddetta "guerra di Jahve" fu uno di quei collanti tra le varie tribù d'Israele nella fase del loro insediamento nella 'terra promessa', che le unì (all'interno di una religione condivisa) contro il nemico comune all'insegna del dio Jahve per la realizzazione del suo piano: la conquista, appunto, della terra promessa. Un'unità - quella delle diverse tribù - conquistata dunque nello stesso periodo delle lotte contro i popoli nemici e - in un certo senso, paradossalmente - grazie proprio ad esse. Il profetismo Il rapporto così stretto tra il popolo e il suo dio è espresso, tra l'altro, dal fenomeno del profetismo. Il profeta è il "canale" attraverso il quale Dio comunica con il popolo e rivela i suoi piani per esso. Il profetismo nasce nel momento nel quale il passaggio dalla vita nomade a quella sedentaria conduce politicamente a una monarchia e religiosamente alla creazione del Tempio di Gerusalemme, con la relativa concentrazione della vita religiosa su di esso. Con il culto del tempio e la monarchia, il monoteismo ebraico assume una dimensione regale prima sconosciuta: si frapponeva ora, tra i capi del suo popolo e Dio, l'istituzione regale e il culto templare. Con il profetismo c'è il tentativo, da parte di una certa sensibilità ebraica, di ricondurre il rapporto tra Dio e il suo popolo a quell'immediatezza delle origini, quell'immediatezza nei confronti della quale (tipico assunto del profetismo che si pone in una condizione potenzialmente - e non solo potenzialmente - in contrasto con l'istituzione monarchica) il re viene obbedito nella misura nella quale e solo se la sua azione è in linea con la volontà divina. Le fonti La fonte più importante di cui noi disponiamo per la ricostruzione della più antica religione ebraica è costituita da quella collezione di testi canonici che la tradizione cristiana ha chiamato Antico Testamento (che insieme al Nuovo Testamento forma la Bibbia cristiana). Già intorno al II sec. a.C. la maggior parte degli scritti che vanno a costituire il canone della religione ebraica era formata e riconosciuta, una collezione di testi suddivisa in: la Legge (in ebraico Torah), che comprende i cinque libri che compongono il Pentateuco (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio), i Profeti (Giosuè, Giudici 1, Giudici 2, Samuele, 1 Re, 2 Re, Isaia, Geremia, Ezechiele, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonía, Aggeo, Zaccaria, Malachia) e gli Scritti (Salmi, Giobbe, Proverbi, Ruth, Cantico dei Cantici, Qohelet, Lamentazioni, Ester, Daniele, Esdra, Neemia, 1 Cronache, 2 Cronache). Riguardo al Pentateuco, nell'antichità sia cristiani che ebrei ritenevano esserne l'autore Mosé: infatti questa raccolta di testi veniva definita comunemente i "Cinque libri di Mosè". In realtà la persona di Mosè in questi libri è menzionata in terza persona, non in prima; inoltre ci viene narrata nel Pentateuco la morte di Mosè, oltre a contenere passi scritti già dopo l'insediamento degli Ebrei nella terra promessa di Canaan, a cui Mosè - morto appunto precedentemente - non giunse mai. Già alcuni eruditi del XVIII secolo ritenevano impossibile che il Pentateuco fosse stato scritto da un solo autore, riscontrando nei suoi libri contraddizioni, diverse versioni degli stessi episodi, ecc. Si escludeva quindi che vi fosse dietro un unico autore - e men che meno che tra questi autori potesse figurare Mosè. Se dunque i vari libri dell'Antico Testamento che via via vennero inclusi come canonici dal punto di vista teologico-ebraico sono ritenuti parola di Dio, dal punto di vista storico sono la testimonianza delle varie forme che l'esperienza religiosa del popolo ebraico assumeva durante i vari secoli della sua storia antica. Inoltre si tratta di testi che hanno subito diversi rimaneggiamenti e nessuno di essi è collocabile in un periodo anteriore a quello in cui gli ebrei erano già insediati solidamente in Canaan, anche se certamente troviamo in essi conservate tradizioni più antiche.

Il Pentateuco ci presenta la storia ebraica aprendosi con la creazione del mondo e concludendosi con l'arrivo degli Ebrei nella terra promessa, la terra che Dio aveva garantito ad Abramo, il primo patriarca. Vi ritroviamo racconti mitici che, tra l'altro, trovano spesso paralleli analoghi in altre tradizioni: la narrazione stessa della creazione del mondo, della prima coppia umana, il motivo del peccato originario che causa la separazione tra Dio e gli uomini e che è a fondamento della condizione umana attuale (fatta di mortalità, di riproduzione, di lavoro, di dolore), il tema del diluvio. Temi che trovano analogie in altre religioni. Ad esempio a proposito del mito del primo essere umano, spesso le singole comunità religiose hanno prodotto miti relativi al primo uomo, distinto dal suo creatore perché non crea, ma genera gli uomini da cui discenderà l'intera umanità e che produce, con il suo comportamento - compresi i suoi errori - quel modello a cui gli uomini successivi dovranno adeguarsi. Quindi il primo uomo non è solo l'antenato comune a tutti, ma anche l'uomo prototipico a tutti gli uomini che lo seguiranno. Oppure si pensi al tema del diluvio, che ritroviamo descritto nella cosiddetta epopea mesopotamica di Gilgamesh. Ciò che invece distingue la narrazione pentateutica e che la caratterizza rispetto a molte narrazioni di altri contesti religiosi è la sua forma, fatta di un intero sviluppo delle vicende che individuano la storia degli ebrei, che sono presentate attraverso il susseguirsi di generazione in generazione, secondo lo sviluppo cronologico e che tendono tutte verso quell'evento centrale di cui si presentano come la fondazione: cioè l'entrata di Israele nella terra promessa da Jahvè. Anche questo tratto evidenzia il rapporto stretto - proprio dell'ideologia ebraica - tra il popolo eletto e il suo Dio che agisce nella storia. Le feste I documenti di cui disponiamo riguardo alla storia degli ebrei ci dicono che fin dal periodo più remoto il tempo era diviso in settimane, nelle quali il settimo giorno (sabato) aveva carattere festivo. Questo numero simbolico del sette ricorreva anche in altre festività: giorni festivi erano la settima settimana dopo la festa Massot (la festa dei pani azzimi), il primo giorno del settimo mese; inoltre ogni sette anni le terre non si coltivavano e ogni 49 anni (7 x 7) si festeggiava il giubileo. Facile comprendere il perché del ruolo simbolico e sacro del numero sette: proprio sulla base dell'istituzione settimanale già esistente, si è sviluppata la narrazione mitica della creazione, avvenuta appunto - secondo la narrazione dei primi capitoli della Genesi - nell'arco di sei giorni più il settimo, dedicato al riposo di Dio. Conferma del fatto che il modello settimanale era precedente e funzionò come prototipico rispetto al racconto biblico è data dalla considerazione che le opere che ci viene narrato essere state quelle del dio creatore sono in numero di otto - e non sei, come ci si potrebbe aspettare - e che per inquadrarle nel numero dei giorni 'lavorativi' della settimana, si è reso necessario l'accorpamento di quattro di queste opere nell'unità di due giorni (la creazione della terra e delle piante da una parte e quella degli animali terrestri e dell'uomo dall'altra). Le tre grandi festività annuali che venivano celebrate fin dall'antichità dagli Ebrei (la cui istituzionalizzazione ritroviamo nei libri dell'Esodo, al cap. 23) e del Deuteronomio (cap. 16) sono di chiara ispirazione agraria. Durante Massot vigeva il divieto di mangiare pane lievitato, essendo quindi permesso solo il cibarsi di pani azzimi. Questa festa si celebrava al principio della mietitura dell'orzo. Il senso del divieto viene motivato dal periodo con cui ha inizio l'esodo, quando cioè, a causa del necessario e repentino allontanamento dall'Egitto da parte degli ebrei, non ci sarebbe stato tempo necessario per la lievitazione del pane. Riscontriamo in realtà una particolare forma di divieto che si inserisce in quei tabu rituali che ritroviamo non raramente nelle feste agrarie di capodanno, il cui tipico motivo soggiacente è quello di mettere in atto elementi anormali (in questo caso il mangiare pane non lievitato), perché in connessione con il periodo mitico precedente all'ordinazione del cosmo (in una classica associazione tra caos e rottura delle abitudini sociali). Sette settimane dopo Massot si collocava la festa delle settimane (Shabuot): qui ritroviamo elementi primiziali - probabilmente in connessione con la conclusione dei lavori legati alla cerealicoltura. Infine abbiamo la festa dei tabernacoli (Sukkot), a conclusione dell'anno agrario (associata al termine della vendemmia), istituita come ricordo della vita della tribù di Isreale nel

deserto. Oltre a questi elementi di carattere tipicamente agrario, possiamo però rintracciare un sostrato ancor precedente, cioè pastorale. Ad esempio il primo giorno di Massot coincide con la festa di Passah - la pasqua ebraica che, con il suo sacrificio dell'agnello primogenito – e denuncia appunto il suo carattere eminentemente pastorale.