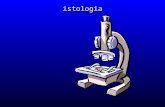Atomo
description
Transcript of Atomo

Università della Calabria
l’Atomo
TESI PAS 2014Relatore Prof. Giuseppe Chidichimo
Candidato Cristian Tavano
CH
IMIC
A F
ISIC
A

Modelli AtomiciDescriviamo brevemente alcuni modelli atomici
storicamente più importanti
Modello di Dalton 1803
Modello di Thomson 1897
Modello di Rutherford 1909
Modello di Bohr 1913

L'ipotesi che la materia sia formata da atomi risale a Democrito (400 a.c.). Atomo, in greco, significa "non divisibile". L'idea atomistica fu però avversata da Aristotele che, successivamente, divenne il filosofo "ufficiale" della chiesa. Per questo motivo dobbiamo aspettare addirittura fino al 1800 perché gli scienziati riprendessero in considerazione l'ipotesi atomica.

Nel 1803 Dalton spiegò i ben noti fenomeni chimici secondo i quali le sostanze sono formate dai loro componenti secondo rapporti ben precisi fra numeri interi, ipotizzando che la materia fosse costituita da atomi.
1. La materia è formata da atomi piccolissimi, indivisibili e indistruttibili. 2. Tutti gli atomi di uno stesso elemento sono identici e hanno uguale massa. 3. Gli atomi di un elemento non possono essere convertiti in atomi di altri elementi. 4. Gli atomi di un elemento si combinano, per formare un composto, solamente con numeri
interi di atomi di altri elementi. 5. Gli atomi non possono essere né creati né distrutti, ma si trasferiscono interi da un composto
ad un altro.

IL MODELLO ATOMICO DI THOMSON (1898)
J.J. Thomson (1856 – 1940)
E’ la prima struttura atomica che tiene conto della carica elettrica
L’atomo è una minuscola sfera omogenea, dotata di carica positiva diffusa, entro cui sono incorporati gli elettroni in numero sufficiente da rendere nulla la carica totale
Tale modello è stato anche definito a panettone: la massa della pasta rappresenterebbe la carica positiva diffusa, mentre gli elettroni corrisponderebbero all’uvetta.

BATTERIA
CATODO ANODO
+▬
+▬
Se emergono dal catodo allora sono negativi?
Quale è la natura dei raggi catodici?
L’ESPERIENZA DI THOMSON (1897)

BATTERIA
CATODO ANODO
+▬
+▬
+
▬
+ ++ + ++ +
▬ ▬ ▬▬ ▬ ▬ ▬
L’ESPERIENZA DI THOMSON (1897)
Aggiungiamo una forza elettrica
Ogni raggio catodico porta una carica elettrica negativa

1909: Esperimento di Rutherford
Il modello di Thomson è SBAGLIATO!!
Previsione
Risultato
Nel 1909 Rutherford fece un esperimento cruciale per mettere alla prova il modello di Thomson. Bombardò un sottilissimo foglio di oro con raggi alfa (atomi di elio completamente ionizzati, ciò privati degli elettroni). L'esperimento portò alla constatazione che i raggi alfa non erano quasi mai deviati. Essi attraversavano il foglio di oro senza quasi mai esserne disturbati. Solo alcuni raggi alfa (1 %) erano deviati dal foglio di oro e lo erano in modo notevole (alcuni, addirittura, venivano completamente. respinti).

Sufficientemente piccole e penetranti, le particelle si rivelano un buono strumento per sondare la struttura dell’atomo
LE ESPERIENZE DI RUTHERFORD
Bombardamento con particelle di sottilissime lamine di oro
Ernest Rutherford ( 1871 – 1937)

Cosa ci si aspettava?
Se la massa, in accordo con Thomson, era distribuita uniformemente tutte le particelle dovevano attraversare la lamina indisturbate

Cosa ottenne?
“Fu il fatto più incredibile che mi fosse capitato…Era così incredibile come se sparando un proiettile di 15 pollici
su un foglio di carta esso tornasse indietro e vi colpisse…”

+
IL MODELLO ATOMICO DI RUTHERFORD (1911)
La carica positiva e quasi tutta la massa sono racchiuse nel nucleo centrale
Gli elettroni ruotano intorno al nucleo come i pianeti intorno al Sole
Il nucleo è piccolissimo (10-15m) in confronto al resto dell’atomo (10-10m)
L’atomo è praticamente vuoto

Sulla base di questo fondamentale esperimento, Rutherford propose un modello di atomo in cui quasi tutta la massa dell'atomo è concentrata in una porzione molto piccola, il cosiddettonucleo (caricato positivamente) e gli elettroni gli ruotano attorno così come i pianeti ruotanoattorno al sole.

Modello Modello planetarioplanetario
+nucleonucleoorbitaorbita
elettroneelettrone-
pianetapianeta
solesoleorbitaorbita

MODELLO “PLANETARIO” DELL’ATOMO
22
rqQeFel
2
r
mMGFgr
Il nucleo è così concentrato che gli elettroni gli ruotano attorno a distanze relative enormi. Il modello di Rutherford ha però un grande "difetto" che lo mette in crisi. Secondo la teoria elettromagnetica una carica in movimento accelerato (non in moto rettilineo uniforme) emette onde elettromagnetiche e quindi perde energia. Per questo motivo, gli elettroni dell'atomo di Rutherford, perché ruotano su orbite circolari, dovrebbero emettere onde elettromagnetiche e quindi, perdendo energia, cadere nel nucleo cosa che invece non accade, perché gli atomi sono oggetti molto stabili (la materia appare normalmente stabile).

Modello planetario di RutherfordModello planetario di Rutherford
+ -

L’ATOMO DI BOHR
Bohr 1913
Questa idea, non compatibile con le leggi della fisica classica (di Newton), si basa sulle idee della nascente meccanica quantistica.

L’atomo di Bohr
Bohr considera l’atomo formato da un nucleo centrale, nel quale risiede quasi tutta la massa, e dagli elettroni che ruotano intorno al nucleo descrivendo orbite ben precise (stazionarie). Gli elettroni possono acquistare o cedere energia per passare da un orbita all’altra, la quantità di energia acquistata o ceduta è pari alla differenza di energia esistente tra le due orbite.
Nella figura accanto sono rappresentate le sette orbite stazionarie ipotizzate da Bohr. Secondo Bohr l’elettrone emette o assorbe energia soltanto se questa gli consente di passare da un orbita stazionaria all’altra.

Secondo la teoria di Bohr, nel passare da un orbita all’altra, l’elettrone dovrebbe emettere una determinata quantità di energia:
E21 =E2 – E1=h21
E31 =E3 – E1=h31
E32 =E3 – E2=h32
E1
E2
E3
Le frequenze delle radiazioni emesse variano al variare della quantità di energia. Nell’esempio sopra riportato si dovrebbero avere tre radiazioni diverse, ognuna di esse con una determinata frequenza e quindi con una ben determinata lunghezza d’onda.

Teoria atomica moderna
Molti studiosi tra cui Heisenberg, non si trovavano d’accordo con quelle teorie che consideravano l’elettrone come un corpuscolo, essi ritenevano che, date le piccole dimensione e l’elevata velocità con cui si muoveva, fosse più corretto considerarlo come una nuvola. Secondo la teoria atomica oggi accettata gli elettroni non descrivono delle orbite intorno al nucleo ma si trovano sugli orbitali. L’orbitale viene definito come la zona dello spazio intorno al nucleo dove si ha la maggiore probabilità di trovare l’elettrone. La teoria atomica moderna si base su un equazione matematica nota come Equazione di Schrödinger. I numeri quantici sono soluzioni di questa equazione e consentono di definire forma, dimensioni ed energia degli orbitali.

Grazie per la Cortese Attenzione