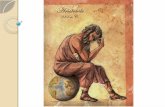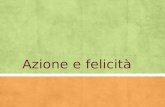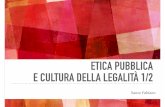Aristotele-Etica
-
Upload
dannagiuse -
Category
Documents
-
view
352 -
download
0
description
Transcript of Aristotele-Etica

Aristotele (384, 383 a. c.-322 a. c.) e l'Etica
I testi di Etica attribuiti ad Aristotele sono tre Etica Nicomachea, Etica Eudemia e la Grande Etica (Magna Moralia). Quest'ultima non pare sia autentica e sembra piuttosto essere stata composta dopo la morte di Aristotele. Le altre due etiche sono chiamate così in virtù di chi ne curò la pubblicazione: Nicomaco, figlio di Aristotele nel primo caso e Eudemo di Rodi, un discepolo, nel secondo caso.
La trattazione più completa dell'Etica aristotelica – quella più celebre e fortunata – è quella Nicomachea. Lo scopo dell'etica è eminentemente pratico: essa non serve semplicemente a conoscere, ma a renderci migliori.
Scrive infatti Aristotele in Etica Nicomachea, II, 2, 1103 b 26-28:
“La presente trattazione non è, come le altre, intrapresa a fini teorici – perché conduciamo questa indagine non per sapere che cosa è il bene, ma per diventare uomini buoni”
La filosofia pratica di Aristotele, allora, esattamente come quella spinoziana, ha un orientamento teleologico: ciò verso cui tutto tende è il bene (questo il finalismo che domina l'intero pensiero aristotelico); tuttavia è necessario determinare con maggior precisione il concetto di fine. I fini umani, infatti, sono molteplici e Aristotele non è un riduzionista; egli, vale a dire, non cerca di ridurre immediatamente il pluralismo che caratterizza il mondo umano all'unità, come invece, aveva fatto Platone con la sua idea di BENE. Intanto perché, per Aristotele le idee non esistono, e poi perché se anche esistesse il BENE come realtà autonoma e indipendente, non sarebbe comunque realizzabile e conseguibile da parte dell'uomo. Ad Aristotele interessa invece il bene umano, quello alla portata dell'uomo. Dunque possiamo subito affermare che l'etica di Aristotele non è fondata su un'idea assoluta, oggettiva e universale di bene. Aristotele lascia sussistere una molteplicità di fini e una molteplicità di beni, anche se ciò non significa che non esista un fine principale a cui gli altri in qualche modo si orientano. Questo fine che orienta tutte le nostre azioni è la felicità; l'etica di Aristotele, allora, non è fondata sul dovere (non è, vale a dire, 'normativa'), ma si basa sulla ricerca della felicità. Proprio perché non

fa leva sul dovere, inoltre, l'etica aristotelica non è PRESCRITTIVA, ma DESCRITTIVA; essa, cioè, 'descrive' i vari comportamenti possibili per raggiungere il fine principale dell'uomo, indicando quelli che sono più appaganti e possono meglio orientare gli altri. L'etica di Aristotele consiste, dunque, nell'analisi dei caratteri e delle indoli umane. Questo è il motivo per il quale l'etica non può aspirare allo stesso grado di certezza della filosofia naturale; i comportamenti umani non sono sempre previdibili in senso assoluto, possono solo essere osservati e classificati in tipologie generali.
Se la felicità, inoltre, è il fine ultimo di ogni azione, dovremmo stabilire in che cosa consista.Essa non corrisponde al possesso di qualcosa, perché possedere è passività, e quando si è passivi è come se si dormisse; d’altro canto, quando si dorme, non si è né felici, né infelici. Allora la felicità è in primo luogo attività (enèrgheia). Ma che tipo di attività?Essa è l’attività dell’anima secondo virtù. ‘Virtù’, in questo caso, è resa dal termine greco aretè, che non significa agire in conformità a leggi morali, ma piuttosto ECCELLERE NELLO SVOLGERE UNA FUNZIONE. Virtù di un buon chitarrista è suonare bene la chitarra, per esempio. Essere virtuosi, allora, vuol dire compiere nel modo migliore la funzione o l’opera che ci si è proposti o per cui si è PORTATI. Si possono compiere tante opere e, dunque, si possono ottenere molteplici felicità. Per individuare la forma prioritaria di felicità, quella più propriamente umana, bisogna individuare in che cosa consiste la funzione specifica dell’uomo. Cosa distingue l’uomo dagli altri animali? Il fatto di avere un’anima razionale. Dunque la felicità sarà un’attività dell’anima, dell’anima intellettiva. Ma qual è l’attività specifica dell’anima intellettiva? Pensare! La felicità dell’uomo consiste, di conseguenza, nell’esercitare nel modo più eccellente l’attività che gli è più propria: il pensare appunto.
Vanno fatte tre considerazioni: nel pensare l'uomo non realizza solo ciò che gli è proprio, ma partecipa della stessa natura divina, dal momento che il divino, in Aristotele, è puro atto del pensiero: l'attività umana è dunque già divina. Per Aristotele “Il pensare è il divino che è in noi”. In secondo luogo, se il pensare è la felicità più alta, essa non annulla le altre. In fondo questa è la felicità dei filosofi, i quali devono per forza

essere felici, dal momento che si occupano del pensiero. Aristotele tuttavia sa che non tutti possono o debbono essere filosofi. La vita filosofica, in realtà, è una scelta come tante altre forme di vita, ognuna delle quali avrà una sua felicità corrispondente, nella misura in cui verrà condotta in modo eccellente: un falegname sarà davvero felice se saprà creare mobili perfetti; un panettiere se saprà fare pane eccellente. La felicità speculativa del filosofo è certo la più alta, la più speculativa, ma, come abbiamo detto, non è l'unica. Subito dopo di essa si colloca la felicità politica, dal momento che uno dei tratti fondamentali dell'essere umano è quello di essere un 'animale politico'. La felicità politica, in realtà, è meno piena di quella speculativa perché più condizionata dall'esterno: i progetti politici, infatti, sono legati alle condizioni esterne della loro realizzabilità.Inoltre Aristotele sa bene che per dedicarsi alla vita speculativa c'è bisogno di godere di alcune condizoni minime esterne:
1) non si deve essere poveri (servono i mezzi di sopravvivenza necessari per potersi dedicare al pensiero senza preoccupazioni)
2) non bisogna avere preoccupazioni famigliari (un matrimonio infelice o altri guai famigliari guasterebbero la serenità speculativa)
3) bisogna avere un minimo di ricchezze e di schiavi4) bisogna poter contare su buoni amici
Si può allora dire che per Aristotele è indubbio che la ricchezza, i piaceri e la salute concorrano alla felicità, ma solo in quanto strumenti di felicità maggiori. Aristotele non disprezza le condizioni materiali agiate perché sa che fanno parte dell'umano e che contribuiscono a facilitare l'attività speculativa.Insomma non è vero che i soldi non fanno la felicità, ma non in quanto li si possiede. Se la felicità, infatti, consiste nell'azione, allora ricchezza, salute, amici e piaceri contribuiranno a renderci felici se e solo se ci faranno agire in una direzione speculativa capace di eccellere.

Virtù etiche e virtù dianoetiche
Le virtù dell'anima razionale sono molteplici e A. le suddivide in due gruppi: 1) quelle che appartengono all'anima razionale nel senso più stretto, ovvero le virtù dianoetiche (dianoia indica il pensiero, la ragione) 2) le virtù che appartengono alla parte appetitiva dell'anima, ovvero le virtù etiche o del carattere. Aristotele, infatti, sostiene che l'anima ha tre facoltà: quella vegetativa, la quale presiede alla funzioni della nutrizione, della crescita e della riproduzione; quella sensitiva, che presiede alle sensazioni e alla funzione appetitiva (quando si percepisce qualcosa, si associano a ciò che è percepito anche gioia e dolore e a queste associazione si collega la tendenza a cercare l'uno e a evitare l'altro) e, infine, l'anima razionale o intellettiva che presiede al pensiero e che è posseduta solo dall'essere umano. Le virtù etiche, allora, si riferiscono indirettamente all'anima razionale perché la parte appetitiva segue ciò che la ragione le indica.
Secondo A., in generale, noi seguiamo ciò che la ragione ci propone: l'etica aristotelica, dunque, è un'etica intellettualistica. Una virtù etica è per Aristotele
“uno stato abituale (una disposizione) che produce scelte, consistente in una medietà rispetto a noi, uno stato determinato razionalmente e come verrebbe a determinarlo l'uomo saggio” (Etica Nicomachea, II, 6, 1106 b 36 – 1107 a 2).
Virtù di questo tipo sono il coraggio, la temperanza, la liberalità, la magnanimità, la giustizia.
Per A. la virtù non è innata, ma è il frutto dell'abitudine e dell'educazione: è infatti la ripetizione abituale di determinati atti a creare quella data disposizione che è la virtù. Le virtù, allora, sono disposizioni stabili del carattere.Ogni virtù, inoltre, presuppone una medietà; essa, vale a dire, si colloca tra l'eccesso ed il difetto. Non si tratta semplicemente dell'ovvio detto: in medio stat virtus, secondo il quale la virtù è sempre l'equilibrio. Per Aristotele significa piuttosto che non esistono modelli assoluti di virtù e che il comportamento corretto va sempre valutato in base alle

circostanze effettive.Facciamo l'esempio della liberalità (generosità), che è il medio tra l'avarizia e la prodigalità. In questo caso la virtù consiste nella capacità di dare risposte adeguate, misurate, calibrate sugli eventi: uno stesso atto (per esempio ritirarsi da un combattimento) può essere un vizio (la viltà), o una scelta saggia a seconda delle circostanze. Dal momento che l'etica aristotelica non fornisce risposte oggettive, il criterio del comportamento è dato dall'ipotizzare come si comporterebbe, con equilibrio, un saggio in quella data circostanza. In questo contesto Aristotele distingue anche tra la saggezza (phrònesis) e la sapienza (sophia). La loro differenza dipende dalla differenza degli oggetti verso i quali sono dirette: la sapienza, infatti, è sempre diretta alla conoscenza disinteressata della realtà, mentre la saggezza si concentra su ciò che può essere fatto dall'essere umano. La sapienza è superiore, divina, ma il sapiente non arriverebbe a nulla se non fosse in grado di fare scelte equilibrate, dunque se non fosse anche saggio. La saggezza, allora, permette il compimento di ogni virtù e la giusta collocazione di ogni bene; essa è fondamentale al sapiente per raggiungere quella tranquillità necessaria affinché egli si dedichi alla contemplazione. Anche la saggezza si apprende tramite l'insegnamento, ma soprattutto attraverso l'esperienza di vita, ovvero con la frequentazione di altri uomini saggi. Il saggio, dunque, fulcro dell'etica aristotelica, è colui che sa comportarsi in tutte le situazioni. Questa è la risposta dinamica e umanologica di Aristotele alla dottrina delle idee platoniche dimoranti nell'iperuranio.