Appunti sull'Antigone Di Lacan
-
Upload
13thsoviet -
Category
Documents
-
view
153 -
download
7
description
Transcript of Appunti sull'Antigone Di Lacan

Appunti a partire dall’articolo L’Antigone di Lacan: il limite del desiderio di Alberto Lucchetti.
L’interpretazione data da Lacan della grande tragedia sofoclea dimostra ancora una volta l’importanza (e da un certo punto di vista l’attualità) del fenomeno cui siamo soliti riferirci con il nome tragedia. Da qui è poi facile e ovvio passare a parlare della forma della società e della civiltà greca come hanno fatto tutti, da Hegel e Nietzsche fino a Vernant e Vidal-Naquet. Qui, però, non si tratta di vedere nella tragedia greca una semplice testimonianza di un mondo che fu, quanto piuttosto di andare a cogliere il sostrato ontologico che fa da presupposto alla costruzione della soggettività dell’uomo. Per Lacan, infatti, proprio quest’ultima, in tutta la complessità delle sue dinamiche, è in gioco nell’Antigone. Non a caso le lezioni sulla tragedia sofoclea trovano spazio all’interno di un seminario intitolato L’etica della psicoanalisi. Una volta definita la teoria del soggetto che possiamo vedere all’opera nella tragedia proprio nella figura di Antigone, è definibile una teoria della cura e una teoria etica della fine e dei fini dell’analisi.
Per evidenziare dapprima il modello di soggettività che Lacan ha in mente dobbiamo fare i conti con delle complicate questioni di filosofia del linguaggio. Attenzione, però, che quest’ultima non è intesa in senso meramente analitico, cioè come indagine volta a enucleare le condizioni che sostengono la coerenza di un discorso quale che sia senza che questo scada nella vuota metafisica, ma (più hegelianamente, se vogliamo) come un’indagine concentrata sul rapporto tra soggetto e linguaggio. È in questa cornice che Lacan ribalta il discorso di De Saussure sul rapporto tra significato e significante. Posto che il significante è un’immagine acustica rappresentata dalla psiche e il significato è il concetto cui essa corrisponde, per De Saussure il significante esprime il significato e costituisce con esso un tutt’uno indivisibile, mentre per Lacan avviene l’incontrario. È il significante a governare il significato, il discorso del soggetto e, di conseguenza, anche il soggetto stesso. L’essere umano, sostiene Lacan, non si serve del linguaggio come mero strumento comunicativo, anzi è sin da principio collocato nell’orizzonte del linguaggio e determinato da esso: egli è un parlessere. Il soggetto è, dunque, agito e costituito dal linguaggio; la sua ultima essenza giace nell’altro (il grande Altro) che Lacan definisce come il “tesoro dei significanti”, il rapporto con il quale è sostenuto solo dalla parola. L’io è un altro.
Un altro termine di confronto per la costruzione lacaniana del soggetto è, ovviamente, la concezione freudiana del desiderio. Il desiderio è per Freud un pulsione che proviamo e che cerca il proprio soddisfacimento in un oggetto originario. Essendo il desiderio (a differenza del bisogno) reinvestimento di segni del primo soddisfacimento e del suo oggetto, esso non può trovare la propria soddisfazione nella realtà concreta ed è perciò sublimato. Dunque, esisterà sempre e comunque uno sfalsamento tra il desiderio e l’oggetto concreto. Da questo vuoto, da questa distanza incolmabile, parte proprio l’analisi di Lacan, nella quale il desiderio diventa “potenza della pura perdita”, elemento motore e risorsa essenziale dell’apparato psichico. La mancanza fondamentale è creata dallo scarto che c’è tra il bisogno e la domanda, l’articolazione del bisogno nel significante, il “diaframma” che separa irrimediabilmente dal bisogno stesso. Questa dinamica è ricostruibile proprio a partire dalla vita del bambino (in quanto infans, non parlante): questi, infatti, prima di essere in grado di parlare è parlato, è immerso in un universo di

significanti provenienti dall’altro che ne plasmano la domanda aprendo, nello scarto che si produce tra domanda e bisogno, lo spazio del desiderio. Questo desiderio, impigliato nella rete dei significanti dell’altro attraverso cui il bisogno si articola in domanda, si struttura come desiderio di un oggetto impossibile al di là dell’oggetto del bisogno, come desiderio del desiderio dell’altro1. Ma il soggetto è passivo rispetto al desiderio, che ne struttura la soggettività intrinsecamente scissa secondo una duplice alienazione (immaginaria e simbolica). Il soggetto è dunque preda dell’universo di significanti imposto dal Grande Altro ed è attivo solo in quanto è agito da un desiderio di cui cerca disperatamente una impossibile soddisfazione.
La prima alienazione del soggetto ha luogo proprio quando il bambino nel primo anno e mezzo di vita vive il rapporto del riconoscimento della propria immagine nello specchio2. Se prima egli è scisso e vive in unità con il corpo della madre, quando è posto davanti allo specchio dapprima stenta a riconoscere sé stesso, poi lentamente si accorge delle somiglianze ed, infine, riconosce nell’immagine che vede una rappresentazione del proprio corpo. Il soggetto dunque riconosce sé stesso nello specchio, ma allo stesso tempo subisce la tirannia dell’immagine esterna. Egli, per la propria formazione, si deve alienare in un doppio nel quale si può riconoscere solo a scapito della perdita temporale e spaziale di sé. Il soggetto, ancora una volta, non si esaurisce in sé stesso e non è irriducibile all’io: l’io è un altro.Con questa prima alienazione si assiste alla prima spaccatura tra l’io e il soggetto; una scissione che per Lacan è e rimane incolmabile. Ma le cose non si fermano qui. Il bambino nello stadio dello specchio si identifica con l’oggetto immaginario del desiderio: ciò che conta è essere apprezzato dalla madre, supplire a una mancanza di lei per riceverne l’approvazione e l’amore, essere oggetto del suo desiderio (in poche parole: essere riconosciuto). L’oggetto del desiderio materno è ciò che Lacan chiama “fallo”, intendendo con esso ciò che manca nell’altro e, pertanto, il significante del desiderio della madre3. L’alienazione simbolica e, con essa, l’ingresso del soggetto nella dialettica del desiderio – bisogno – domanda avviene attraverso il passaggio dalla triangolazione immaginaria (madre, bambino, fallo) alla triangolazione edipica (bambino, madre, padre) con il conseguente slittamento del fallo dalla sua funzione immaginaria di oggetto del desiderio della madre alla sua funzione simbolica di significante rimosso di questo desiderio. Il fallo, per essere più chiari, passa da essere un semplice oggetto immaginario significante del desiderio materno ad essere il simbolo dell’autorità paterna e, in questo passaggio dall’immaginario al simbolico, vediamo la seconda alienazione fondamentale che concorre alla formazione del soggetto.
1 E’ evidente qui l’influenza dell’interpretazione data da Kojeve della dinamica del riconoscimento presente nella “dialettica servo-padrone” della Fenomenologia dello Spirito Hegel. Cosa risaputa è, infatti, che Lacan abbia seguito i corsi sulla Fenomenologia hegeliana tenuti da Kojeve tra il 1933 e il 1939 e che ne sia stato profondamente influenzato.2 In questo processo di riconoscimento è ancora evidente la dialettica servo-padrone riletta da Kojeve. Cfr. Lacan, Lo stadio dello specchio come formatore della funzione dell’io, in Lacan, Scritti. Volume I, a cura di Giacomo B. Contri, Einaudi, Torino, 2002, pp. 87-94.3 Cfr. Lacan, La significazione del fallo: Die Bedeutung des Phallus, in Lacan, Scritti, volume 2, a cura di Giacomo B. Contri, Einaudi, 2002, pp.682-693.

Nella relazione immaginaria dell’infante con la madre interviene prepotentemente la dimensione simbolica che determina il passaggio dialettico dall’essere il fallo all’averlo o non averlo: avviene la sostituzione del Nome-del-Padre all’oggetto del desiderio materno. Nominando il padre il bambino continua a conservare e in un certo senso sublima l’oggetto fondamentale del suo desiderio, ma lo nomina ormai solo metaforicamente, perché il significante di questo oggetto è ormai divenuto inconscio. L’oggetto fondamentale del desiderio permane ma, attraverso l’alienazione simbolica che si ha con l’intervento del Nome del Padre, si trasferisce in un altro luogo (l’inconscio). Questa alienazione del soggetto nel proprio discorso è quella che Lacan chiama referente: una rifenditura, una fenditura cioè che reitera e raddoppia la divisione nell’immaginario tra soggetto ed Io, tra l’Io e l’immagine esterna ed invertita con cui si identifica. In questo senso il soggetto è un effetto del significante e non una sua causa. Si capisce dunque come mai Lacan definisca il linguaggio come la condizione dell’inconscio. L’inconscio, che è il desiderio dell’Altro ed è strutturato come un linguaggio, non è altro che il discorso dell’Altro (genitivo soggettivo e oggettivo). Per rappresentare graficamente questa divisione del soggetto che non è causa del linguaggio, ma ne è l’effetto Lacan utilizza una S sbarrata. La barra che separa il significato dal significante è anche quella che divide il soggetto. Perciò il soggetto, in quanto alienato e perso nella catena dei significanti, è costitutivamente soggetto del desiderio e soggetto dell’inconscio.
Il desiderio è definito da Lacan in relazione ad una mancanza, la quale che occorre anche nel linguaggio. Il rapporto tra il desiderio (inteso come pura pulsione verso il nulla) e l’ordine simbolico, in quanto cornici istituzionali nelle quali si inscrive il discorso lacaniano sul soggetto, è stato articolato in maniere diverse dallo psicoanalista francese. Queste diverse configurazioni sono principalmente tre4: a) nel primo periodo troviamo una forte influenza della Fenomenologia dello Spirito di Hegel e della concezione hegeliana del linguaggio che in essa trova posto. L’idea, infatti, che la parola sia cosa morta sostiene l’idea lacaniana che non appena la realtà prova a essere simbolicamente rappresentata attraverso il linguaggio subentra un abisso tra la parola e l’oggetto reale rappresentato che rende l’essenza di quest’ultimo inattingibile. b)in un secondo periodo il linguaggio è indagato da Lacan come struttura sincronica (il discorso quindi da una matrice fenomenologica/hegeliana assume una matrice strutturalista). La pulsione di morte è in questa fase identificata con l’ordine simbolico, mentre il livello immaginario è governato dal principio del piacere. Quando l’uomo è perso nella catena dei significanti, questa ha un effetto mortifero su di lui. C’è un al di là del principio del piacere che condiziona ogni altro ambito.c)in un terzo periodo (da fine anni ’50) l’attenzione di Lacan si sposta sul Reale come Impossibile. In questa fase è, invece, il principio del piacere ad essere identificato con l’ordine simbolico. La svolta avviene proprio nel seminario che da qui prendiamo spunto: L’etica della psicoanalisi. L’inconscio è strutturato come un linguaggio il cui processo primario è governato dal principio del piacere. Ciò che si nasconde dietro a questo linguaggio non è tanto l’ordine simbolico, quanto piuttosto un nucleo reale, un cuore traumatico. Per definirlo Lacan ricorre al termine freudiano Das Ding (La Cosa). La cosa
4 Per questa panoramica cfr. S. Zizek, The sublime object of ideology, Verso, New York-London, 2008, pp. 145-148. Zizek è poi convinto che queste tre fasi scansionano anche la cura del paziente dello psicoanalista.

rappresenta l’incarnazione reale dell’impossibile soddisfazione del desiderio. Nel cuore dell’ordine simbolico troviamo, allora, questa forza estranea e traumatica che si rifiuta di essere simbolizzata. Lacan per questa forza conia il neologismo l’extimité. A questo livello la pulsione di morte assume una nuova configurazione: essa è l’esatto opposto dell’ordine simbolico, cioè la possibilità di una seconda morte, la radicale distruzione dell’ordine simbolico che costituisce la realtà. L’esistenza di un ordine simbolico porta con sé (quasi direi, dialetticamente) la possibilità della sua distruzione: non, dunque, la semplice morte (prima morte) di un oggetto reale la cui essenza (e il cui posto nella realtà) giace e risulta unicamente comprensibile nell’ordine simbolico, ma la morte (seconda morte) dell’ordine simbolico stesso. Questa è una via attraverso la quale possiamo rileggere l’interpretazione di Lacan dell’Antigone. Antigone, infatti, sa di andare incontro a morte certa e, a prescindere da questo, è animata da una strana forza distruttrice che per noi non è facilmente tematizzabile né comprensibile. A conferma di questo, possiamo banalmente dire che la prima cosa che vien da chiedersi e a cui difficilmente possiamo rispondere quando leggiamo la tragedia è: “Ma che cosa vuole realmente Antigone?”. Questa svolta nel pensiero di Lacan però ci conduce anche oltre, se seguiamo le conseguenze del discorso che abbiamo per ora solamente abbozzato. Abbiamo visto affermarsi una radicale incompatibilità del desiderio con la parola e profilarsi, al di là della parola e del Grande Altro, un reale muto, una mancanza irriducibile sia all’immaginario che al simbolico. Questo buco è, appunto, la Cosa (che Lacan definisce anche come oggetto a). Questo vuoto è la mancanza che causa il desiderio, che è fondamentalmente desiderio di una mancanza, e di conseguenza desiderio di morte, di niente. Il registro di questa mancanza è la pulsione di morte. Questo interno non si sa di chi sia e (assieme alla soddisfazione del desiderio, al godimento) è inaccessibile al soggetto. La barriera che ne delimita l’accesso è quella del bene/beni e del bello. Sul limite di questo campo del desiderio è insorta l’idea di collocarvi, al posto dell’essere, la donna in quanto oggetto del desiderio. Su questo limite si colloca, secondo Lacan, anche Antigone.L’Antigone, infatti, è importante non soltanto in quanto tragedia (cioè, sin da Aristotele, in quanto rappresentazione connessa con tematiche fatte proprie anche dalla psicoanalisi quali le passioni e la catarsi), ma anche perché ciò che colpisce il lettore/spettatore è il forte fascino della protagonista, la sua bellezza. La bellezza di Antigone dipende proprio dal fatto che il suo personaggio abbatte la tradizionale distinzione tra vita e morte: “una vita che sta per confondersi con la morte certa, morte vissuta anticipatamente, morte che sconfina sul campo della vita, vita che sconfina sulla morte”. In questa zona riflettente il raggio del desiderio è da collocare l’effetto tragico. “È nella traversata di questa zona che il raggio del desiderio si riflette e allo stesso tempo si ritrae, arrivando a darci la cosa più profonda di quest’effetto così particolare, cioè l’effetto del bello sul desiderio”5.Questo essere collocati tra la vita e la morte è, secondo Lacan, caratteristico di molti personaggio sofoclei che sono “a fine corsa”.
Gli elementi in gioco nella tragedia si situano a tre diversi livelli:-l’immagine di Antigone-il coro che esprime ed elabora le emozioni e le passioni sollecitate dalla vicenda
5 J. Lacan, Seminario VII. L’etica della psicoanalisi 1959-1960, Einaudi, Torino, 1994, p.316.

-l’azione, ovvero tutto ciò che avviene attorno al punto di mira del desiderio che sorregge l’intera tragedia.
Secondo Lacan, l’azione tragica non deve essere letta dicendo – come ha sostenuto anche Goethe – che il nucleo principale della rappresentazione sta nell’equilibrio tra timore e pietà incarnato dai personaggi principali. Anzi, né Creonte né Antigone conoscono timore e pietà. In particolare Antigone, perché se Creonte è alla fine preso dal timore, lei, dimostrandosi così il vero eroe, è assolutamente priva di queste passioni. La cosa fondamentale che impreziosisce la figura di Antigone agli occhi di Lacan è proprio il suo eccesso, il suo andare oltre in ogni modo alla legge che trova il proprio rappresentante in Creonte, il quale commette l’errore di giudizio di voler fare del bene una legge di tutti e senza limiti: “Così, prima ancora del percorso etico che, da Aristotele a Kant, ci porta a enucleare l’identità ultima della legge e della ragione, lo spettacolo tragico non ci mostra forse l’obiezione prima? Il bene non può affatto regnare su tutto, senza che compaia anche un eccesso, delle cui conseguenze fatali la tragedia ci avverte”6. Il limite oltre il quale non può andare la legge è difeso da Antigone. Eppure, la funzione tragica di Antigone non si limita a questa funzione di difesa delle leggi divine non scritte.
Il limite su cui si colloca Antigone e il cui riflesso è quello del bello è ciò che Lacan chiama la seconda morta, come abbiamo detto sopra. Un limite che la vita umana non può oltrepassare troppo a lungo e che nella tragedia trova l’incarnazione linguistica migliore nell’Ate. Collocata proprio su questo limite invalicabile, Antigone è qualcosa di inumano, non semplicemente mostruoso, ma inflessibile (omos) e crudo. Il comportamento di Antigone è qualcosa di fortemente perturbante per il lettore/spettatore, proprio perché è una rivendicazione dei diritti dell’individualità assoluta nell’orizzonte della legalità. Essa dice: “mio fratello è quello che è, ed è perché è quello che è, e che non c’è che lui non possa esserlo, che avanza verso questo limite fatale. Chiunque altro con cui potrei avere una relazione umana, mio marito, i miei figli, è rimpiazzabile, si tratta di relazioni, ma (…) questo fratello è qualcosa di unico, ed è soltanto questo a motivare che io mi opponga ai vostri editti”7.
La posizione di Antigone è sorretta da questa difesa dei valori dell’unicità: “Antigone non richiama nessun altro diritto se non quello che sorge nel linguaggio dal carattere incancellabile di ciò che è. (…) Ciò che è, è, ed è a questo, a questa superficie, che si fissa la posizione infrangibile, invalicabile di Antigone. (…) Questo valore è essenzialmente il linguaggio. Fuori dal linguaggio non si potrebbe nemmeno concepirlo e l’essere di chi ha vissuto non potrebbe distaccarsi da così da tutto ciò che egli in bene e in male, come destino, come conseguenza per gli altri, ha veicolato con sé. Questa purezza, questa separazione dell’essere da tutte le caratteristiche del dramma storico che ha attraversato, è proprio questo il limite, l’ex nihilo, intorno a cui Antigone si mantiene. Non è altro che il taglio che la presenza stessa del linguaggio instaura nel momento della vita dell’uomo”8.
6 ibid., pp. 327-328.7 Ibid., p.352.8 ibid., pp.352-353.

Antigone si colloca sul limite tra due forme di legalità: quella delle leggi umane tradizionali e quella per cui non contano i valori morali incarnati o meno da un uomo (in questo caso il fratello Eteocle). Ed è proprio ponendosi su questo limite che Antigone inizia il suo lamento sulla vita e su ciò che perde. Non appena varca la soglia tra vita e morte Antigone leva il suo lamento, il rimpianto della vita, di ciò che non potrà vivere (il matrimonio, dei figli, ecc.).La bellezza di Antigone produce una sorta di accecamento, ed è identificabile con quell’inanimato che già Freud aveva individuato come la forma dell’istinto di morte. In questo senso, Antigone si presenta come autonomos, “puro e semplice rapporto dell’essere umano con ciò di cui si trova ad essere miracolosamente portatore, cioè il taglio significante che gli conferisce il potere inviolabile di essere, a dispetto di tutto, ciò che lui è”9. Antigone, pertanto, è a fine corsa, perché porta fino al limite “il compimento di ciò che si può chiamare il desiderio puro, il puro e semplice desiderio di morte come tale. Questo desiderio, lei lo incarna”10. Questo desiderio, infatti, non ha un oggetto ed è causato da una mancanza: è puro e semplice desiderio di niente.La “seconda morte”, sul cui limite si colloca Antigone, è per Lacan “l’uomo in quanto il linguaggio esige da lui di rendere conto di questo – che egli non è”11. Questo è il rapporto con il significante nella sua forma più radicale. Il soggetto, poi, tocca con mano come il desiderio sia fondamentalmente desiderio di niente, rapporto dell’uomo con il suo non essere e, quindi, con la morte, e dal quale si tutela circondandolo con il campo del bene e dei beni. Ma per Lacan la vera barriera che ferma il soggetto davanti al campo innominabile del desiderio è il fenomeno estetico “in quanto identificabile con l’esperienza del bello (…). È evidentemente per il fatto che il vero non è tanto carino da vedere che il bello ne è, se non lo splendore, perlomeno la copertura”12.Il bello ci trattiene dal valicare il limite oltre il quale troviamo quel cuore traumatico che è il desiderio puro in quanto pulsione di morte, ma allo stesso tempo ce ne indica la direzione: il bello ha per effetto di sospendere, di disarmare il desiderio intimidendolo. Se la funzione del desiderio sta fondamentalmente in rapporto con la morte, per Lacan l’analisi si concluderebbe mettendo il soggetto di fronte alla realtà della condizione umana, cioè a quel rapporto con sé stesso che è la seconda morte. Mentre l’etica tradizionale giudica le azioni del soggetto sulla base del servizio che egli presta alla sfera dei beni, l’etica della psicoanalisi, invece, fonda l’etica sul posto occupato dal desiderio, determinandone un rovesciamento che mette al centro una misura incommensurabile, una misura infinita, il desiderio. In questa prospettiva l’unica cosa di cui si può essere colpevoli per Lacan è “aver ceduto al proprio desiderio”. Di conseguenza non c’è altro bene che quello che può servire a pagare l’accesso al desiderio, quella libbra di carne pagata dalla vita per farne il significante dei significanti, segno del desiderio che si impone come condizione assoluta, effetto dell’essere del linguaggio, che è il non-essere degli oggetti e del soggetto.
9 Ibid., p. 356.10 Ivi.11 Ibid., p. 374.12 Ibid., p. 275.

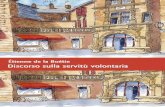



![Jacques Lacan «Il Seminario» Libro IV La relazione ... · Jacques Lacan «Il Seminario» Libro IV La relazione oggettuale [1956-1957] Einaudi, Torino 1997 Per solo uso interno,](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5fea5a18dc048408ab016e0c/jacques-lacan-il-seminario-libro-iv-la-relazione-jacques-lacan-il-seminario.jpg)













