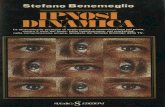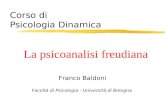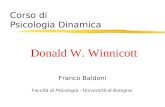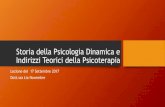Appunti Psicologia Dinamica
Transcript of Appunti Psicologia Dinamica
-
8/17/2019 Appunti Psicologia Dinamica
1/12
OPsonline.it: la Web Community italiana per studenti e professionisti della PsicologiaArticoli, annunci di lavoro, formazione, forum di discussione, agenda eventi, finanziamenti, appunti, temi esame di stato, ecc..
http://www.opsonline.it 2001-2007®
Cap 9 LA NASCITA DEL PENSIERO: WILFRED R. BION
1. IL MODELLO BIONIANO DI MENTEFilo conduttore del pensiero di Bion è un modello biopsicologico di mente che vede una strettacontinuità fra somatico e psichico. La psichicità è la messa in forma attraverso il pensiero (che legai vissuti e dà loro un significato) di vissuti emotivi di per sé dirompenti, per energia si intende
proprio questa messa in opera, en-ergon, messa in forma, che se non realizzata porta la mancatarealizzazione del soggetto e nei casi più gravi la disgregazione per psicosi. Bion non concorda conl’idea di crescita lineare, ma di una maturazione attraverso “trasformazioni” passanti per momentidi catastrofe e di ritorno all’origine. Nei suoi studi sui gruppi identifica un livello protomentale,cioè un assetto originariamente grippale della mente di ciascuno, che spiega le transizioni frasomatico e psichico. La crescita è per bion, a partire dai bisogni psicologici,lo sviluppo del pensiero edelle funzioni mentali (psicosi = crollo di queste funzioni mentali), grazie all’assetto grippale lamadre può elaborare i vissuti del bambino in vece sua (reverie)Confronto con Freud: condivide l’idea che la psichicità in principio è caratterizzata da stimolo e statiemotivi che non trovano immediato riscontro in un oggetto mentale. Mentre Freud però segmentaquesta psichicità in pulsioni che cercano oggetti su cui soddisfarsi, Bion lavora sull’idea che questapsichicità vada organizzata in un pensiero attraverso funzioni. L’oggetto mentale ne è il risultato.
Confronto con la Klein: passa in secondo piano l’immagine della mete fatta di oggettiinterni.L’oggetto è il risultato di una funzione di sintesi e di trasformazione, un oggetto di pensiero,non oggetto-cosa.In clinica ne deriva più attenzione al contesto che alla cosa detta, senza ricerca diequazioni simboliche. Bion inventa una griglia g r i d per inquadrare dopo la seduta il tipo dimateriale (forme di pensiero)e il tipo di uso, questo serve per cogliere il vero significato delleaffermazioni e non quello “standard”, il simbolo diviene cosi puramente una congiunzionericonosciuta come costante dal gruppo o singolo.
2. LA GRUPPALITÀ ORIGINARIA DELLA PERSONAStudi sui gruppi (1943 – 1952): doveva riabilitare soldati affetti da nevrosi di guerra.Negli anni ’60 torna a recuperare molte intuizioni maturate studiando i gruppi => terapia di gruppoe non in gruppo; il gruppo è considerato come se fosse un soggetto unico viene usato il metodo non
direttivo.Bion riuscì così a osservareuna serie di stati emotivi collettivi che chiama mentalità digruppo. Individua così gli Assunti di Base (AdB): 3 configurazioni tipiche e ricorrenti delle mentalitàdi gruppo:
AdB lotta e fuga: il gruppo si sente minacciato da un pericolo reale o immaginario; AdB dipendenza: quando il gruppo attende da un leader di tipo carismatico la miracolosa
soluzione dei problemi affioranti nel gruppo; AdB accoppiamento: quando spera che dall’unione di alcuni membri del gruppo possa venir
fuori un’idea solutiva. Il capo del gruppo proviene dall’AdB attivo al momento.Cercando di capire come si forma la mentalità di gruppo e dove stanno gli AdB elabora la nozione disistema proto-mentale: area a cavallo fra mente e corpo; il carattere confusivo dell’emozione chedomina il proto-mentale, spiega il carattere collettivo delle emozioni e delle reazioni presenti. Ètransindividuale, gli individui agiscono come un unico individuo,si radica nella struttura dei singoli, siconfigura anche come i gruppalità interna all’individuo, propensione a essere tutt’uno col gruppo.Nella vita di ognuno c’è un momento biologico iniziale e grippale che precede la nostraindividuazione. Gli AdB possono essere d’ostacolo al gruppo poiché danno luogo alla dominanzadell’emozione e alla mancanza di senso critico; possono però anche essere funzionali, quandodiventa incentivo alla creazione di gruppi di lavoro specializzati, più simili all’esperienza dellaresponsabilità individuale.
3. FORMAZIONE DEL PENSIERO COME CARDINE DELLO SVILUPPOLa crescita della personalità consiste nell’elaborazione del pensiero in forme + mature.Diversi tipi di pensiero: elementi alfa, pensieri onirici e i miti, preconfezioni, concetti, sistemascientifico deduttivo, calcolo algebrico. => il pensiero scientifico sarebbe la forma più evolutapsicologicamente.A ogni livello vi è un intreccio con la sfera emotiva => esperienza si riferisce all’esperienza emotiva
da cui il soggetto è preso prima ancora di riflettere. Alla costruzione del pensiero concorrono dunque
-
8/17/2019 Appunti Psicologia Dinamica
2/12
-
8/17/2019 Appunti Psicologia Dinamica
3/12
OPsonline.it: la Web Community italiana per studenti e professionisti della PsicologiaArticoli, annunci di lavoro, formazione, forum di discussione, agenda eventi, finanziamenti, appunti, temi esame di stato, ecc..
http://www.opsonline.it 2001-2007®
5. SVILUPPO COME TRASFORMAZIONE“Trasformazioni” (1965) e “Attenzione e interpretazione” (1970) il problema della crescita si
radicalizza: da una parte Bion insiste sulle ristrutturazioni e al dolore necessarie in ognicambiamento, dall’altra sulla necessità di recuperare l’origine, entrando in quel contesto che Bionchiama “O”. Non essendo più sufficienti le trasformazioni in K , occorre rinunciare a K e ripassare perO. Le trasformazioni in O riguardano la realtà sostanziale anteriore alla conoscenza, perciò appaiono
prioritarie e più radicali rispetto alle trasformazioni in K.O è definito come verità assoluta, perché è e si dà anteriormente a ogni pensatore: il soggettopensante ha ancora da venire rispetto a quanto accaduto in O. O in se stesso è un vissutoinesprimibile, nel senso che eccede la parola. Quando si vuol esprimere O lo si trasforma (passaggioda O in K). Con la teoria della trasformazione in O Bion introduce come essenziale l’idea che losviluppo non necessariamente è lineare, né assicurato. Un processo di passaggio in O lo deve fare ilsoggetto in analisi, e anche l’analista, partecipando con il paziente, anche psicotico, ai momenti diterrificante destrutturazione che comporta l’esperienza di O, là dove il contenimento in un pensiero,che dia senso alle emozioni, ha ancora da venire.
6. LA PSICOPATOLOGIAAnni ’50 cura analitica di soggetti psicotici: si occupa del tranfert negativo della psicosi : più che
attaccare ‘analista come oggetto cattivo, il paziente stravolge ciò che fa rapporto con lui, distorce lacomunicazione linguistica. Bion estende la tesi dell’attacco al legame al rapporto infantile coigenitori, al rapporto con le persone dell’ambiente familiare, al rapporto del paziente con i suoi stessioggetti interni. In gioco non è una dinamica di oggetti cattivi scissi, ma una disgregazione dellafunzione di contenere α. Anni ’50-’60 lo psicotico appare come un soggetto sopraffatto da una seriedi elementi beta collegati a un senso di catastrofe. La responsabilità della catastrofe psicotica è daattribuirsi al fallimento o alla carenza a suo tempo della reverie materna.Gli elementi beta incapaci di un processo trasformativi in alfa, danno luogo allo schermo beta(agglomerazione di vissuti non elaborati): ne risulta uno pseudoapparato mentale, che non distingueveglia e sonno, né percezione e allucinazione, né esterno e interno. Questo apparato costruisceancora oggetti complessi, ma l’inversione della funzione alfa porta alla produzione di peculiariformazioni deliranti, che Bion chiama oggetti bizzarri (costrutto psicotico, cui concorrono elementi
beta e parti della personalità scisse e proiettate). Nevrosi: qui il conflitto è tra un insieme di idee eun altro (conscio e inconscio); nella nevrosi il soggetto è giunto a formulare un pensiero che peròrespinge, mentre nella psicosi gli elementi beta rimangono cose in sé, vissuti non pensati soggetti aevacuazione. Rispetto all’impostazione freudiana e kleiniana, la destrutturazione delle funzionimentali non è vista come mera regressione; Bion è portato a vedere, dietro le manifestazioni dellafollia, delle rilevanti virtualità inespresse o male articolate, una maggiore vicinanza a O. Le ultimetesi relative alle trasformazioni, hanno grosse conseguenze nella teoria e pratica della cura:- L’analista deve lasciarsi andare al coinvolgimento tot della sua persona nella trasformazione in O;- Per Bion non ha senso che l’analista mantenga una parte di sé, come spettatrice indipendente eneutrale dei processi transferali, e un’altra collusiva con gli stessi, al fine di capire i processi emotividell’analizzando; Serve l’identificazione proiettiva:identificarsi con l’altro su base transindividuale.- Un’analisi basata sul controtransfert finisce in un disastro, o comunque fallisce, perché tutte leinterpretazioni hanno molto a che vedere con l’analista e poco con il paziente. Il modelle bioninanodi mente non lavora tanto sulle categorie interno/esterno, ma su quella di trasformazione. - Analista e analizzando sono un gruppo a 2, le cui dinamiche assomigliano a quelle di un gruppoAdB così l’analista aiuta il paziente a dare forma di narrazione alle emozioni, all’atmosfera sorgivanel vivo dell’interazione tra i due.
-
8/17/2019 Appunti Psicologia Dinamica
4/12
OPsonline.it: la Web Community italiana per studenti e professionisti della PsicologiaArticoli, annunci di lavoro, formazione, forum di discussione, agenda eventi, finanziamenti, appunti, temi esame di stato, ecc..
http://www.opsonline.it 2001-2007®
Cap 11 IL MONDO RAPPRESENTAZIONALE: JOSEPH SANDLER
Uno dei temi che caratterizzano questo autore è la verifica delle congruenze tra teorie e datiosservativi (progetto Hapstead: sistematizzazione e verifica del corpo concettuale psicoanalitico).Ha introdotto così in psicoanalisi un nuovo modello, più che una teoria, cercando di far coesistereteoria pulsionale classica e approcci relazionali, anche se non ha funzionato.
1. CONFRONTO FRA TEORIA PULSIONALE E T. DELLE RELAZIONI OGGETTUALILa teoria pulsionale è il cuore della metapsicologia freudiana; la pulsione è la forza motricedell’apparato psichico,si genera all’interno dell’apparato mentale e crea instabilità, si scaricaprocurando piacere e restaurando l’omeostasi, ha origine somatica ma meta e oggetti psichici(componente psichica della pulsione = rappresentante psichico), oggetto è ciò attraverso cui lapulsione giunge a meta,tramite necessario x realizzare il desiderio (es: madre = oggettonecessario). Successivamente la teoria pulsionale viene contestata e nasce il concetto di relazionioggettuali (Klein, fairbainr, interazionisti). Per oggetto qui si intende nient’altro che “L’altro da se,soprattutto l’altro interiorizzato” come esso esiste nella mente del soggetto (oggetti interni,introietti, personificazioni), ciò che distingue questo approccio dalla teoria di freud è larivendicazione per gli oggetti di una forza motivante di per se, ricerca dell’oggetto in quanto tale,
desiderio di entrare in rapporto. Sandler partendo da posizioni classiche si avvicinerà sempre d più aposizioni relazionali.
2. IL MONDO RAPPRESENTAZIONALEQuesto concetto è il > contributo di Sandler, il termine rappresentazione è usato sia per intenderel’operazione conoscitiva di rappresentarsi un oggetto, sia il contenuto mentale. Va dal pianoesperienziale, sensoriale fino all’astrazione del concetto vero e proprio. È un concetto molto presentenel pensiero freudiano, usato almeno in tre modi: come parola del linguaggio quotidiano, cometermine filosofico e come termine freudiano, quando si articola coll’affetto prima e con il concetto dipulsione poi. Si distingue prima una registrazione passiva, percezione, poi una registrazionementale, traccia mnesica, più tracce infine si uniscono a formare la rappresentazione. Questa può
essere inconscia o cosciente, costituiscono il versante psichico della pulsione, e grazie ad essa lepulsioni si esprimono come desideri che cercano una scarica, ce può venire bloccata ad opera delledifese,che permettono la progressione solo a patto di una deformazione del contenuto ideativi,questo derivato può giungere alla coscienza. Secondo Hartmann il mondo rappresentazionale puòessere il luogo per la sperimentazione e simulazione mentale; questo ha portato a considerare iconcetti di sé e dell’altro come porzioni interiorizzate di modelli di relazione.Il concetto era nato nel progetto Hampstead dopo aver rilevato difficoltà nell’uso di alcuni terminicome introiezione o identificazione era stato proposta la nozione di “mondo soggettivo” del b.Secondo questa visione gli oggetti che esistono inizialmente per il bambino sono soltanto esternisuccessivamente egi crea e organizza nel suo mondo percettivo, o rappresentazionale, immaginiinterne che col tempo diventano stabili e acquisiscono funzione anticipatoria, queste immaginiinsieme formano le rappresentazioni. L’ identificazione è definita come una modificazione del sésulla base di un’altra rappresentazione generalmente un oggetto, assunta come modello.L’ introiezione invece avviene quando il bambino reagisce in assenza dei genitori come se fosseropresenti. Sandler vede l’apparato psichico come solutore di problemi con funzione adattativi.Distingue successivamente fra ambito esperienziale e non esperienziale, il primo è l’insieme deicontenuti (percezioni, sentimenti, fantasie) che posssono apparire su uno schermorappresentazionale e essere valutate e conosciute, l’ambito non esperienziale riguarda invece imeccanismi mentali che non possono essere diventare coscienti. Gli oggetti e il se del bambinoappaiono sul palcoscenico del teatro (l’IO) come protagonista e personaggi, i macchinari di scenainvece restano nascosti (meccanismi mentali). L’esistenza del mondo rappresentazionale èessenziale per le successive esperienze; inizialmente le prime sono essenzialmente sensazionipiacevoli e spiacevoli, molto indifferenziate, che sono i primi oggetti del bambino, il quale reagiscecon gioia o angoscia, poi altre esperienze di natura percettiva si uniscono alle prime e si formano leprime rappresentazioni, per Sandler il b. ha una “intersoggettività innata” e al fine di mantenere
sicurezza e benessere desidera entrare in rapporto con l’oggetto (≠ da pulsione xkè desiderio “di”
-
8/17/2019 Appunti Psicologia Dinamica
5/12
OPsonline.it: la Web Community italiana per studenti e professionisti della PsicologiaArticoli, annunci di lavoro, formazione, forum di discussione, agenda eventi, finanziamenti, appunti, temi esame di stato, ecc..
http://www.opsonline.it 2001-2007®
comprende una rappresentazione di sé, dell’oggetto e della relazione la risposta dell’oggetto fa partedel desiderio di gratificazione quanto l’azione del soggetto). Sandler sostiene quindi che la metapulsionale va integrata con il desiderio di interazione, infatti è stata ipotizzata una forzamotivazionale intrapsichica nel bisogno di sicurezza, l’oggetto è cmq secondario, diversamentesarebbe se la motivazione fosse posta nella relazione. Il concetto di rappresentazione e desideriosono dunque strettamente legati. Le rappresentazioni oggettuali interiorizzate riflettono le
caratteristiche dei genitori, ma possono essere anche assai diverse a causa del modo di interpretarela realtà. La rappresentazione può essere un insieme di regole o schema che organizza le percezionie quindi non esperienziale e in conoscibile, può essere tuttavia anche un contenuto: l’immagineinterna dell’oggetto
3. IL DESIDERIO E LA RELAZIONE DI RUOLOIl desiderio si evolve con l’evolversi dell’io. Il lattante sperimenta una gestalt di sensazioni esentimenti (es fame), successivamente il desiderio si amplia includendo una rappresentazione di sein relazione con l’oggetto (madre che nutre), a questo punto è diventato “desiderio di una specificarelazione”. Non tutti i desideri derivano dalle pulsioni, alcuni dalla ricerca di benessere. La “fantasiadi desiderio” è un passo verso la gratificazione del desiderio, una soluzione di compromesso per
gratificarne diversi insieme. Nella fantasia di desiderio i personaggi assumono dei ruoli determinati.Quando proviamo un desiderio attiviamo una fantasia che stata in passato gratificante, per quantopossa essere patologica (identità di percezione). Il soggetto può poi agire nella realtà per farrealizzare la fantasia e adotterà un comportamento inteso a provocare una certa risp negli altri e sericerca la gratificazione vissuta in contesti patogeni allora si assiste al dispiegarsi di comportamentipatologici, ad es. cercare contatto con un genitore sadico xkè vissuto in passato come l’unico chedesse sicurezza o aizzare negli altri questi comportamento (attualizzazione: sforzo di fare in modoche la realtà corrisponda a ciò che si desidera sia). Anche gli oggetti interni possono essere amati oodiati come quelli esterni, questo provoca un continuo rapporto interno - esterno, caratteristico degliumani che includono nelle loro fantasie un interazione fantasticata con l’oggetto, il sé e la suarappresentazione si adattano all’oggetto e alla sua rappresentazione. Lo scopo di mettere in attocomportamento patogeno è di mantenere sentimenti di benessere e sicurezza.
4. IL CONFLITTO PSICHICOSandler ha anche operato una revisione del concetto di conflitto, onnipresente in Freud. Egli ne dadiverse formulazioni: la prima come conflitto fra ricordo incompatibile con i suoi desideri e l’iocosciente attraverso le difese, la nevrosi nasceva da vie alternative di espressione di questi affetti.Nella 2° fase con l’importanza della fantasia,veniva visto come conflitto fra parti di personalità (ioideale o coscienza vs. desideri istintuali depositati nell’inconscio) infine con la teoria strutturale ilconflitto viene visto come intersistemico fra richieste dell’Es, del Super-io e della realtà all’io sededel conflitto. Sandler ritiene che il modello topografico sebbene sia stato superato da quellostrutturale possa tornare utile e che entrambi vadano usati in modo flessibile. Spesso i conflittiattuali nascono dall’esigenza di venire a patti con soluzioni di conflitti precedenti. Sandlerconcepisce il conflitto come scontro fra tendenze perentorie infantili (soluzioni di conflittiprecedenti) e tendenze al rinvio (impedire l’espressione degli impulsi perentori); questi ultimi sonospeso stati ricondotti alle pulsioni ma in realtà non sempre lo sono, sono soluzioni precedenti che,pur accettabili nell’infanzia, non lo sono in età adulta e vengono quindi rimosse e quando compaionovengono trattate come impulsi istintuali
5. L’INCONSCIOIl termine inconscio viene spesso usato per indicare concetti diversi: L’Inconscio della prima topicafreudiana è quella località dell’apparato mentale che non è cosciente. L’inconscio della secondateorizzazione diventa un aggettivo, una qualità dei contenuti e delle operazioni mentali, infine vi èl’uso comune che indica tutto ciò che non è cosciente, anche se parte del sistema preconscio. Freudvedeva, nella prima topica, l’apparato mentale come diviso in tre aree: Inconscio, Preconscio,
Conscio che hanno ≠ modi di funzionare; nell’inconscio gli atti si realizzano secondo il processo
-
8/17/2019 Appunti Psicologia Dinamica
6/12
OPsonline.it: la Web Community italiana per studenti e professionisti della PsicologiaArticoli, annunci di lavoro, formazione, forum di discussione, agenda eventi, finanziamenti, appunti, temi esame di stato, ecc..
http://www.opsonline.it 2001-2007®
primario, in assenza di logica, temporalità riconoscimento della realtà. Il preconscio ha la massimaorganizzazione di un livello non cosciente, segue il “processo secondario” razionale. Ai confini fra learee ci sono dei sistemi di censura che permettono ai contenuti di progredire solo a patto di esseredeformati. Nella seconda teoria diventano qualità e la mentè viene divisa in ES (inconscio) IO(conscio solo in parte) e SUPER-IO. Per freud è inconscio ciò che è stato rimosso. Accanto a questaconcezione di inconscio rimosso se n’è sviluppata un’altra da ricerche neurologiche di inconscio
strutturale, di inconscio come processi e strutture. Per Sandler è utile distinguere fra inconsciopassato e presente. Il passato è costituito da desideri perentori,che possono avere originepulsionale, impulsi e modalità di risposta formate nei primi anni di vita, create per risolvereproblemi,che acquistano carattere perentorio e si manifestano ogni volta che si presentano angosciae dolore; è il mondo interno del bambino nell’adulto, dominato da forme di pensiero e meccanismi didifesa primitivi che sono divenute egodistoniche con lo sviluppo e sono inaccettabili, quindiesprimibili solo in maniera distorta, l’inconscio passato è qualcosa che possiamo concepire ma nonpercepire. L’ inconscio presente, simile al sistema preconscio, agisce allo scopo di mantenerel’equilibrio nel presente e cerca di difendersi dall’inconscio passato operando in fantasia delletrasformazioni difensive (es proiettando la sua aggressività su un altro sogg) la fantasia cosìtrasformata può diventare facilmente cosciente, i contenuti dell’inconscio passato sono recuperabilisolo attraverso ricostruzioni, quelli dell’inconscio presente sono più facilmente accessibili, vi sono
tuttavia anche in questo caso delle resistenze dovute alla 2° censura tra preconscio e conscio con ilcompito di evitare imbarazzo e vergogna, erede dell’apprendimento del comportamento sociale edelle ansie ad esso collegate, permette quindi l’accesso solo a contenuti plausibili e non sciocchi, haa che fare con sentimenti narcisistici.
6. RIFLESSIONI SUL “MONDO RAPPRESENTAZIONALE” E PRATICA CLINICASandler sostiene che si possa vedere la teoria psicoanalitica come un sistema compatto, guardandola in modo conservatore, ma questo per quanto stabilizzante può divenire rigido, egli propone invecedi vederlo come un corpo di idee flessibile, i cambiamenti avvengono quando accanto alla teoriaufficiale, che viene appresa attraverso l’insegnamento, l’analista sviluppa nel suo lavoro teorieparziali che possono non coincidere con quelle ufficiali, cambia così la tecnica psicoanalitica, e
bisogna forzare i concetti affinché siano ancora utili, si arriva così a una nuova formulazione teoricache successivamente diventerà ufficiale. Il bisogno degli analisti è di avere teorie che spieghino laclinica e che possano essere modificate da essa. Sandler ha avuto alcune brillanti intuizioni,giungendo a esporre in modo semplice alcuni concetti che erano già nella mente di molti, che hannoavuto conseguenze nel dibattito psicoanalitico. Lavorando sulla verifica di molti concetti si è resoconto che alcuni di questi potevano essere sostituiti o aggiornati, anche se ha propeso sempre perquesta seconda opzione: ha mantenuto la teoria delle pulsioni, anche se ne ha limitato l’uso; hamesso in rilievo l’interazione del bambino con il suo ambiente, si è avvicinato alla teoria dellerelazioni oggettuali, ha descritto le complesse rappresentazioni del sé e dell’oggetto come modellatedall’esperienza e gli ha attribuito un ruolo centrale. È giunto così a ipotizzare che i pattern infantilipossono essere attualizzati e agiti nelle relazioni adulte. Sandler ha quindi dato la possibilità dilegare queste nuove posizioni con la psicoanalisi classica: ha posto il bisogno di sicurezza fra lemotivazioni infantili in modo non diverso da Bowlby, ammettendo che il bambino arrivi al mondo conun bagaglio di capacità e tendenze a instaurare relazioni col caregiver. Il concetto di mondorappresentazionale è un ingegnoso esempio di adattamento dei concetti metapsicologici alla clinica,di fronte alle difficoltà riguardanti l’introiezione ha ipotizzato l’esistenza di un mondo interno, ilversante intrapsichico della relazione oggettuale. Attraverso questa formulazione è transitato dallateoria pulsionale a quella oggettuale senza aver mai rotto con la prima, attraverso una visioneelastica, pragmatica e funzionale.
-
8/17/2019 Appunti Psicologia Dinamica
7/12
OPsonline.it: la Web Community italiana per studenti e professionisti della PsicologiaArticoli, annunci di lavoro, formazione, forum di discussione, agenda eventi, finanziamenti, appunti, temi esame di stato, ecc..
http://www.opsonline.it 2001-2007®
Cap 13 LA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO: JOHN BOWLBY
Bowlby ha molto influenzato la psicologia attuale, in analisi con Riviere e Klein, basa le sue idee suetologia e teoria Darwiniana, il suo > contributo consiste nell’analisi del sistema di attaccamentocome sist.motivazionale e molte ricerche empiriche,in ambito psicologico, non psicanalitico.
1. LE PREMESSENegli anni ’30 numerosi ricercatori si occuparono degli effetti patologici dell’istituzionalizzazione,Bowlby viene incaricato dall’OMS di studiare la salute mentale dei bimbi senza famiglia e pubblica lamonografia “Cure materne e igiene mentale” (1951) che ebbe grande risonanza aiutato dai filmatidi Spitz e Robertson, ne deriva da parte sua un notevole interesse per l’osservazione diretta. Inquesto lavoro giunge a conclusione che: “Si ritiene essenziale per la salute mentale che il bambinosperimenti un rapporto caldo, intimo e ininterrotto con la madre(o con un sostituto maternopermanente) nel quale entrambi possano trovare soddisfazione e godimento”. Sollevò critiche daparte degli psicanalisti che ritenevano attribuisse troppa importanza al reale e non al fantastico edagli psicologi del apprendimento per scarsità di prove di come la “carenza materna” produca ildisturbo psichico e cosa sia questa carenza. Bowlby ipotizza che sia la perdita della figura materna inconcomitanza con altre variabili non identificate a dare processi psicopatologici.
2. L’ATTACCAMENTOBolby attinge alla cibernetica, l’etologia (concetto di imprinting e di bisogno di calore), l’approcciopiagetiano, quello evoluzionistico,la teoria dei sistemi (bambino come sistema con processi diregolazione e retroazione, non opera linearmente) e la psicoanalisi (adatta alle spiegazionipsicopatologiche). Da qui giunge a definire il comportamento di attaccamento: “Quello che mostrauna persona nel mantenere la prossimità e vicinanza con un’altra ritenuta più in grado di affrontareil mondo, si manifesta in situazioni di spavento e si attenua con le cure, ha funzione biologica di
protezione” quindi ha motivazione in sé e non è conseguenza del soddisfacimento dei bisogniprimari. Può essere sicuro (sentirsi protetti) o insicuro (miscellanea di emozioni: paura del rifiuto,vigilanza, dipendenza, irritabilità). L’attaccamento è qualcosa che perdura nel tempo, non èinfluenzato dalla situazione ed è specifico verso certe persone, il comportamento di attaccamento,
invece, is riferisce a varie forme di comp. Messe in atto per mantenere la prossimità, innescato dallaseparazione, mediato da vari apparati a seconda dell’età (percettivo occhi, efferente mani piedi, disegnalazione pianto sorriso) e può manifestarsi verso varie persone. Il sistema dei comportamenti diattaccamento è analogo a un sistema fisiologico omeostatico, un modello del mondo in cui vengonorappresentati se e gli altri significativi e le loro interrelazioni. La teoria è basata su lungheosservazioni e non più sulle ricostruzioni dei vissuti dei pazienti. La Ainsworth attraverso studiempirici con la Strange Situation descrive per la prima volta tre modelli di attaccamento:sicuro(fiducia nel genitore sensibile e disponibile), resistente ambivalente(non certo delladisponibilità mostra angoscia da separazione), evitante(si aspetta di essere rifiutato) vi è poi unquarto schema: disorganizzato. Altro concetto chiave è quello di MOI(Modello operativo interno) dise stesso e degli altri basato su ripetute esperienze interattive usato per predire il mondo, erelazionarsi, è dinamico e quelli di bambino e pater sono complementari.
3. LA PSICOPATOLOGIABowlby doveva trovare connessioni fra eventi cruciale come la mancanza di cure e i sintomipsichiatrici, egli ritiene che il bambino svilupperà un legame adeguato o patologico in virtù del tipo diambiente genitoriale e di attaccamento. Inizialmente collega i disagi infantili con le fobieadolescenziali e patologie adulte come agorafobia, depressione e dist. Psicopatici e ipotizza chel’attaccamento insicuro sia precursore di difficoltà nello sviluppo. In un 1° tempo considera l’ansiadovuta a disgregazioni infantili come morte o divorzio dei genitori o a carenze dovute alladepressione mat, cmq comportamenti eclatanti,i successori diedero + attenzione ai comportamentipiù sottili e all’aspetto qualitativo della relazione. In 3 modi le difficoltà possono portare a disturbi:
La rottura o disgregazione del legame è causa di disturbo L’internalizzazione di mod. di attaccamento disturbati influenza le successive relazioni La percezione delle proprie relazioni attuali può rendere la persona vulnerabile alle difficoltà
-
8/17/2019 Appunti Psicologia Dinamica
8/12
-
8/17/2019 Appunti Psicologia Dinamica
9/12
OPsonline.it: la Web Community italiana per studenti e professionisti della PsicologiaArticoli, annunci di lavoro, formazione, forum di discussione, agenda eventi, finanziamenti, appunti, temi esame di stato, ecc..
http://www.opsonline.it 2001-2007®
Cap 15 IL MODELLO DI SVILUPPO IN PSICOANALISI: STERN
Attualmente ci si è resi conto che non si può considerare il comportamento in se, ma semprerispetto al contesto intersoggettivo, molto criticato è stato il modello di Freud che ipotizzacambiamenti più di tipo a gradino piuttosto che con continuità, con uno stretto parallelismo fracrescita corporea e rappresentazione mentale,per cui lo sviluppo psichico è dettato dalle vicendecorporee e l’adolescenza è il capolinea dello sviluppo. Tutte le teorie psicoanalitiche postulanol’esistenza di un periodo precoce di indifferenziazione tra sé e l’altro, numerosi sono stati gli studiUsa sulla comprensione delle tappe del ciclo vitale che il soggetto deve elaborare. I nuovi studisull’attaccamento portano a vedere l’affettività del bambino come prodotto di un sistemamutuamente regolato. Sandler ipotizza che il comportamento umano possa essere spiegatoattraverso lo stile affettivo inteso come temporanea attivazione di un funzionamento caratteristico,una coerenza nell’organizzazione dell’organismo. Il fluire degli stati affettivi è influenzabile emodificabile dall’esterno, i pattern relazionali sono unici per ogni coppia affettiva creando così uncoordinamento durevole, per Stern la costruzione dell’esperienza interna è legata al riconoscimentodi sé come capaci di risperimentare gli stati affettivi come familiari; la sintonizzazione degli affettiriplasma l’evento e sposta l’attenzione su ciò che sta dietro al comportamento. I bambini sono in
grado di influenzare il contesto e i genitori sono predisposti alla socializzazione con i figli, i quali aloro volta cercano di autoregolarsi nel caso manchi la risp. dell’ambiente, un equilibrio ristabilito conun “costo” ogni volta che fallisce la reciprocità.
1. LA CRITICA AL CONCETTO DI NARCISISMO PRIMARIOStern elabora un modello di sviluppo al confine fra psicoanalisi e psicologia evolutiva nell’infantresearch, cercando di dare una teoria dello sviluppo psichico aderente ai dati delle ricerche, eglisostiene la necessità di superare il punto di vista patomorfo e retrospettivo della psicoanalisi,avvalendosi di osservazioni naturali e sperimentali. Queste lo portano a sviluppare una critica dellaconcezione Mahaleriana del narcisismo, dell’autismo primario e della simbiosi, ciò che contesta è unosviluppo a tappe con la possibilità di fissazioni e regressioni, ma soprattutto del narcisismo primariofreudiano con la concezione di sviluppo per tappe in sequenza predeterminata in cui ogni punto
rappresenta una organizzazione dell’esperienza che ingloba quelli precedenti e non coesiste, c’èquindi la possibilità di fissazioni e regressioni.Per Stern questi concetti non sono adeguati in quanto non hanno un’effettiva funzione biologicaadattiva, quindi vi contrappone il concetto di equifinalità che presuppone la tendenza innataall’autocorrezione del percorso evolutivo, problemi rilevanti del paradigma tradizionale, comell’oralità o la simbiosi vengono quindi estesi a tutto l’arco vitale. Capovolge completamente l’ideadell’esperienza del sé e dell’altro non più come conquista da uno stato iniziale di indifferenziazione(Mahler primi 2 mesi fase artistica normale), propone invece un modello che sostiene la precocecapacità del bambino di sperimentare un sé coeso e una differenziazione dall’altro attraverso studiosservazionali. Emerge un bambino attivamente alla ricerca di stimoli e in grado di regolarnecarenze e eccessi grazie all’aiuto materno;attraverso la percezione amodale e degli affetti vitalisperimenta l’emergere di un’organizzazione interna; è predisposto all’interazione sociale e le fantasie
di tipo fusionale sono possibili solo in periodi successivi dopo il consolidarsi della differenziazione e lasimbolizzazione.
2. IL MODELLO DI COSTRUZIONE CONTINUA DELLO SVILUPPOStern riconosce l’importanza dei cambiamenti nei primi 2 anni e dell’emergere di compiti adattivirisolvibili solo con la rinegoziazione del sistema diadico, è un modello di costruzione continuadello sviluppo, che ipotizza una sequenza di successivi cambiamenti biocomportamentali,con periodi distinti da nuovi livelli organizzativi e capacità qualitativamente nuove e > complessità,adattamento congiunto m-b (prospettiva relazionale dello sviluppo) davanti a nuovi compitievolutivi, il bambino passa quindi da un organizzazione biologica e diadica e una psicologica eindividuale. Viene qui sottolineata l’importanza delle transazioni continue fra individuo e ambiente ocontesto evolutivo, il sogg è quindi parte di un sistema internazionale, il protrarsi del processointerattivo dinamico crea una continuità temporale che perdura come coerenza di se e dei patternrelazionali, a differenza del mod fissazione-regressione non specifica dunque il punto di origine delle
-
8/17/2019 Appunti Psicologia Dinamica
10/12
OPsonline.it: la Web Community italiana per studenti e professionisti della PsicologiaArticoli, annunci di lavoro, formazione, forum di discussione, agenda eventi, finanziamenti, appunti, temi esame di stato, ecc..
http://www.opsonline.it 2001-2007®
varie forme di psicopatologia, che possono emergere in qualsiasi momento, nuovo oggetto di studioè quindi la diade, stern si focalizza sui primi processi interattivi dove il b. crea modelli di esperienzasoggettiva e di relazione (non sempre aderenti alla realtà) prototipo per successivi scambi, lapartecipazione attiva è data dal bagaglio comportamentale comunicativo di cui M e B dispongonoseguendo il modello di “tema con variazioni” (ripetitività e alterazioni moderate dei gesti), ha unruolo determinante nello sviluppo perché regola la stimolazione ottimale e e permette al B di
organizzare l’esperienza sulla base di costanti: isole di coerenza necessarie per definire sé e glialtri, crescendo il B amplia il suo repertorio di ricordi interiorizzati e modelli (tendenza innataall’organizzazione globale e coerente, principi organizzatori dell’esperienza sono i sensidel sé). L’identificazione di caratteri invarianti posta a una progressiva categorizzazionedell’esperienza (creazione prototipi)EVENTI ------------------------> RICORDO---------------------> SCENARIO (prototipo)MOMENTI V(issuti)--------->MOMENTI M(emorie)-------->MOMENTO R(appresentazione): coerentisegmenti di esperienza interattiva generalizzata con sensazioni,affetti, obb.vi e percezione di se.In assenza di coerenza e stabilità delle esperienze relazionali le strutture interiorizzate assicurano ilbisogno di coerenza del sé. Con l’acquisizione del livello simbolico il bambino ha > capacità diproblem solvine motivazionale e la rappresentazione simbolica è passibile di > cambiamenti e sensodi continuità
3. LO SVILUPPO DEI SENSI DEL SÉI sensi del sé sono esperienze soggettive organizzanti, che danno coerenza e continuità,emerge neiprimi 3 anni di vita,ognuno emerge in congiunzione con nuove capacità,al loro insorgere possonocostituire momenti sensibili, ma non sono fasi in quanto operano continuamente e simultaneamentex tutta la vita, si accompagnano alla comparsa di nuovi campi di relazione.
0-2mesi
Sensodel sè
EMERGENTE
Il bambino non sa ancora integrare in maniera complessa l’esperienzasoggettiva,ma ha innata capacità di costruire connessioni che gli consente
di sperimentare il precoce processo di integrazione dell’esperienza,modalità di fare esperienza di sé e dell’altro
2-6mesi
Sensodel Sé
NUCLEARE
Consolidarsi delle prime integrazioni di elementi ≠, sperimentazione di un
senso del sé e dell’altro organizzato primo organizzatore di spitz(sorrisosociale), interazioni favorite da innata preferenza per volto e voce, visono risp materne corrispondenti molto coerenti con tema con variazioniche provocano il riconoscimento di isole di coerenza,senso del sé ancoraal di fuori della consapevolezza, si basa sulla capacità di percepirsi comeun entità fisica coesa,continua con volontà e affetti, autore delle proprie
azioni, distinzione sé e altro nucleare, gli stimoli che vengono dal sehanno struttura diversa da quelli che vengono dall’altro; costanza degli
affetti attraverso il riconoscimento della costellazione di eventi chesperimenta in concomitanza a un’emozione. Memoria senza parole non
consapevole,motoria e percettiva che aiuta questi processi
7-15mesi
Sensodel se
SOGGETTIVO
Salto maturazionale, nuove capacità del bambino: intenzionalità
permanenza dell’oggetto, anticipazione, attaccamento inizia a potercondividere le esperienze, l’attenzione e gli stati affettivi, questo crea ilsenso del sé soggettivo, compaiono comp di puntare il dito, riferimento
sociale, questo presuppone una teoria delle menti separate che entrano incomunicazione con la sintonizzazione, per la mahler inizio della fase
simbiotica,per stern della relazione interpersonale.La sintonizzazione è importante per l’empatia, il rispecchiamento ecc, ora
c’è corrispondenza non solo del comp ma degli stati affettivi e interni.
15-18mesi
Sensodel sé
VERBALE
Il bambino comincia ad essere consapevole di sé in modo autoriflessivo,si guarda allo specchio, usa i pronomi gioca e usa il linguaggio in modosimbolico e comunicativo, entra nel campo della relazione verbale, in cui
si crea attraverso il linguaggio un universo di significati condivisi oraportà:verbalizzare l’esperienza e si creerà una discrepanza fra realtà
sperimentata soggettivamente e quella comunicabile selezionata x essere
-
8/17/2019 Appunti Psicologia Dinamica
11/12
OPsonline.it: la Web Community italiana per studenti e professionisti della PsicologiaArticoli, annunci di lavoro, formazione, forum di discussione, agenda eventi, finanziamenti, appunti, temi esame di stato, ecc..
http://www.opsonline.it 2001-2007®
verbalizzata.
3-4anni
Sensodel sé
NARRATIVO
Il bambino trasforma la capacità di usare il linguaggio come sistema percostruire una narrazione della propria storia, ciò ha un effetto
organizzante trasformativi sull’esperienza e sulla sua rappresentazionemodalità mai inglobata con le altre modalità di fare esperienza.
4. LA PSICOPATOLOGIALa base concettuale della teoria della psicopatologia di Stern si fonda su un modello di svilupporelazionale; l’esperienza intrapsichica, oggetto centrale di indagine, è ritenuta risultantedall’interiorizzazione dei modelli di relazione, la psicopatologia tradizionale sottolineava invece iprocessi interni fantasmatici. Per Stern all’interno delle interazioni M-B va indagata la funzionalità opatologia delle relazioni, il parametro fondamentale è l’ elasticità delle regolazione (sincronia,reciprocità, scambio affettivo), entrambi i partecipanti contribuiscono alla relazione, vi sonofluttuazioni per eccesso e per difetto, normali, per trovare il giusto livello di interazione, queste nondevono però diventare troppo ampie o rigide, questi difetti se protratti possono essere base per lapatologia. Questo indica difficoltà ad adattarsi da parte di entrambi i patner (depressione mat otemperamento bambino), ognuno dei due può farlo in una certa misura, ma se ad es. la madre èeccessivamente interferente nell’autoregolazione può stabilizzarsi il difetto della regolazione. Gli
“schemi di essere con” (esperienza rappresentata del vedersi in interazione con un altro in uncerto modo) possono costituire terreno patogeno, così con una madre depressa il bambino potrebbesperimentare delle microdepressioni come schema di essere con la madre oppure riuscire arianimarla per un breve momento e usare questo rinforzo diventando un animatore o ammaliatore;d’altra parte lo sforzo della madre per uscire dalla depressione può esprimersi in comportamentiadeguati ma eccessivamente forzati, mancanza di spontaneità che spinge il bambino che ha cmq unforte desiderio a intraprendere un comportamento forzato di interazioni fra due falsi sé. L’importanzadegli schemi di “essere con” risiede anche nelle ricadute che hanno nelle costruzioni dei sensi del sé,modelli interattivi patogeni prolungati provocano patologie del carattere e della personalità, qui nonesiste un origine storica precisa della patologia, solo nelle nevrosi attuali in cui è presente un precisoevento traumatico.
5. PASSATO E PRESENTE: L’OTTICA NARRATIVAGrazie al modelli evolutivo è possibile individuare l’origine storica della patologia, ma per stern èimportante capire anche quella narrativa, lo sviluppo dei sé e dei loro campi aiuta in questo, poiché,pur non essendo fasi ordinate, i sé al loro sviluppo sono simili a periodi critici in cui eventi patogenipossono avere un’incidenza particolare.Danni al sé emergente 0-2 mesi provocano deficit nella capacità di usare la percezione amodale onella regolazione dell’arousal.Danni al sé nucleare 2-6 mesi scacchi alla formazione delle 4 costanti di questo periodo: azione,coesione, affettività, continuità, si disgrega la percezione organizzata di sé, in forme estreme si ha lapsicosi, la continua iperstimolazione può portare il b. a operazioni di coping difensive (voltare latesta) oppure adattarsi e perdere la capacità di autoregolazione, ipostimolazione=labilità del sé.
Danni al sé soggettivo 8-18 mesi Campo della relazione intersoggettiva,della sintonizzazionenecessaria x l’intersoggettività quindi si può creare:assenza di sintonizzazione (psicosi);sintonizzazioni non autentiche (automaticità del comportamento materno), sintonizzazioni imperfette(m. sintonizzata poi cambia lo stato affettivo dall’interno), sintonizzazione selettiva (x i suoi desideriil genitore riconosce solo alcuni stati affettivi e altri li ignora, il bambino si crea un falso séesagerando i primi e negando i secondi - scissione)il linguaggio può ratificare questi sbagliDanni al sé verbale 15-18 mesi discrepanza tra esperienze vissute e comunicate, non tuttetrovano espressione linguistica, certe sono relegate nel sé privato,questo meccanismo può essereusato per relegare certe parti del sé su cui è mancata sintonizzazione, voce data solo al falso sé.Danni al sé narrativo 3-4 anni la capacità di narrare la propria storia crea un mondorappresentazionale a livello gerarchicamente superiore ai modelli operativi di regolazione, ladiscrepanza fra i due può essere ambito di psicopatologia,questo è il campo di lavoro della terapia.Identificato un conflitto in una parte del sé, non è detto che questo si sia verificato nei primi tre annixkè i sensi del sé continuano a svilupparsi per tutta la vita e sono soggetti a trasformazioni.
-
8/17/2019 Appunti Psicologia Dinamica
12/12
OPsonline.it: la Web Community italiana per studenti e professionisti della PsicologiaArticoli, annunci di lavoro, formazione, forum di discussione, agenda eventi, finanziamenti, appunti, temi esame di stato, ecc..
http://www.opsonline.it 2001-2007®
6. QUALE INGRESSO E QUALE BERSAGLIO?Stern attenua l’idea di isomorfismo fra evento e ricordo (refiguration: si può andare avanti e indietroliberamente fra molteplici schemi). Le rappresentazioni non sono categoriali, riferite ioè al tale padreo tale madre, ma procedurali di sé in interazione con il patner. L’emergere della personalità deve
essere visto all’interno del concetto di reciprocità e interaffettività, le memorie di astratti episodigeneralizzati delle relazioni vengono elaborati in scenari nella forma mobile e plastica dellarappresentazione. Le esperienze di ripetute interazioni portano al formarsi di schemi dell’”esserecon”, esprimono punti di vista soggettivi, schemi sensomotori, script, sentimenti, quindi esperienzerappresentate (RIG), è un livello più complesso rispetto al “momento emergente”, quindi esperienzavissuta ed è il presupposto delle esperienze raffigurate, quindi evocate o agite. La fantasia consistein una rifigurazione in cui si passa dalla storia alla narrazione, attraverso la ricombinazione dei varischemi. Fondamentale è prestare attenzione non solo alla realtà dell’interazione, ma anche aglischemi rappresentazionali che impostano l’ingaggio della situazione, resta sempre una discrepanzafra eventi reali e mondo rappresentazionale. Stern presuppone dunque nella terapia dei bambini conun mondo rappresentazionale non pienamente sofisticato, di sfruttare un ingresso attraverso ilmondo rappresentazionale del genitore e anche attraverso le interazioni reali, il bersaglio sarà
rispettivamente il mutamento della rappresentazione o la modifica delle regole pragmatiche dellarelazione che potrà influenzare il mondo rappresentaz.
7. CONCLUSIONIUna forte critica è portata da Stern ala concezione del bambino come asociale e inerme, il bambinopassa attraverso cambiamenti biocomportamentali che pongono compiti evolutivi affrontaticongiuntamente nella relazione madre-bambino, ciò implica capacità innate nel b. di rappresentarsil’esperienza in modo globale e unitario, questi processi sono permessi dalla percezione amodale edalla percezione degli affetti vitali. I disturbi psichici quindi non sono risultato di un conflittointrapsichico fissazione-regressione, ma di modelli relazionali disturbati interiorizzati quindi bisognainserire nell’intervento clinico anche la popolazione clinica dei bambini e genitori con problemirelazionali. L’area motivazionale è spostata dal dominio delle pulsioni a quello dei bisogni di
adattamento e il formarsi delle funzioni psichiche dipende dalla qualità delle relazioni interpersonali,si è ripreso così a studiare la qualità delle relazioni reali e il ruolo del contesto e dei suoi significatiindividuali.