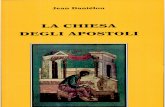La costruzione dell identità in un contesto multiculturale PIME- 2013 Dott. Manuela Tomisich.
APOSTOLI nel Quotidiano (new) - PIME Italia
Transcript of APOSTOLI nel Quotidiano (new) - PIME Italia

Dal libro Apostoli nel quotidianoL'avventura straordinaria di sette missionari laici del PIME
1. L’OPERAIO DELLA PRIMA ORA
Giovanni Sesana (1828-1867), originario di San Giovanni alla Castagna (Lecco). Partì nel 1855 con la prima spedizione PIME per il Bengala Centrale, e vi profuse 12 anni di indefesso impegno.
Al paesino di San Giovanni alla Castagna, in provincia di Lecco, lo si vedeva a volte sgattaiolare dalla piccola officina paterna per sfuggire ai ceffoni che mulinavano nell’aria quando combinava qualche guaio. Giovanni era obbediente e placido ma il padre, indurito da una vita immiserita trascorsa tra il maglio e l’incudine, non era affatto comprensivo e per un’innocente ragazzata andava facilmente in escandescenza.
Il giovane doveva quindi schizzare via più velocemente delle pesanti mani del genitore e ringraziare qualche santo, come santa Lucia, che nel fervore del sentimento religioso popolare, attraverso un voto espresso dalla famiglia, lo aveva miracolosamente guarito dai problemi di deambulazione.
Nel periodo dell’infanzia la salute di Giovanni fu molto cagionevole, si liberò delle grucce solo dopo aver partecipato a una processione alla quale lo condusse il padre, che poi non perse tempo ad avviarlo al mestiere di fabbro, non appena il figlio ebbe raddrizzato la spina dorsale e irrobustito le gambe.
Così iniziò a lavorare a nove anni nell’officina di famiglia, che necessitava di innesti nuovi per aumentare la produzione e far fronte ai debiti contratti con alcuni fornitori. Al contempo cresceva nel ragazzo il desiderio di dedicare la propria vita alle missioni, nondimeno il padre si rifiutava di dare il suo consenso.
Fortunatamente l’officina riuscì a risalire la china, a rimettere in sesto il bilancio e Giovanni Sesana, nato nel 1828, fu libero di entrare nel seminario del PIME per prepararsi alla missione. A 27 anni, il 19 febbraio del 1855, conclusa la necessaria formazione, il missionario lasciò l’Italia con destinazione il Bengala centrale: per la seconda volta consecutiva gettava a terra le grucce, per camminare lontano e non tornare più.
In viaggio verso il BengalaNei documenti redatti dalla Compagnia delle Indie e presentati al governo britannico,
che all’epoca formavano una specie di diarchia sulla regione, il Bengala era definito la “tomba dell’uomo bianco”, una pianura caratterizzata da un clima caldo umido e densamente popolata, solcata da fiumi imponenti, martoriata da periodiche carestie, pestilenze, cicloni, terremoti e inondazioni: un posto che metteva i brividi solo a pensarci.
Il vicariato apostolico del Bengala era esteso da Calcutta alla Birmania e al Tibet. Istituito nel 1834 venne diviso nel 1850 in Bengala occidentale (Calcutta) e Bengala orientale (Chittagong), ma nonostante quella separazione le due regioni continuavano a essere troppo vaste. Il Vaticano decise di erigere una propria rappresentanza apostolica nel Bengala centrale e la offrì a tre congregazioni già operanti in India, le missioni estere di Parigi, i salesiani di Annecy e i carmelitani scalzi, ma tutti e tre si rifiutarono di raccogliere questa nuova sfida.
Dopo il fallimento della missione in Oceania, dove l’evangelizzazione aveva incontrato difficoltà insormontabili, tanto che i missionari dovettero rientrare in Italia, il PIME accettò la proposta di Roma inviando in Bengala tre padri, Albino Parietti, Luigi Limana e Antonio Marietti, accompagnati da fratel Giovanni Sesana. Il gruppo sbarcò a Calcutta all’inizio di giugno del 1855 e già il 17 raggiunsero Berhampur.
1

Cominciarono una vita claustrale fatta di preghiera e studio serrato dell’hindi, del bengalese e dell’inglese che dovevano perfezionare. Vivevano in una povertà estrema e, visto il lavoro e l’enorme territorio a loro affidato, non appena riuscirono a comunicare decisero di andare ognuno in una direzione diversa.
Parietti rimase a Berhampur, Marietti andò a Jessore e Limana a Krishnagar con Giovanni. In tutte e tre le stazioni missionarie i quattro del PIME dovettero subire le angherie, le calunnie e i tentavi di cacciarli da parte dei protestanti che erano arrivati in Bengala decenni prima: questa ostilità sintetizza significativamente l’alto rischio che rappresentava essere venuti in quella parte di mondo così inospitale.
Gioie e dolori della missioneA Krishnagar la missione aprì una scuola femminile diurna con dieci ragazze assistite
da donne bengalesi e un orfanotrofio che ospitava alcuni ragazzi, seguiti da Giovanni nella preparazione scolastica e religiosa oltreché nel lavoro: “Ogni giorno poi, fino alle sette devo attendere al lavoro dei ragazzi, che è zappare, portar terra, o altri simili lavori materiali; io devo essere presente sia per mostrar loro come devon fare, sia per la pace e il buon ordine. Alle sette essi mangiano il riso ed io metto mano a un qualche altro lavoro vicino alla mia camera, che è annessa alla scuola e dormitorio dei ragazzi, ho formato una piccola bottega, in cui faccio lavori soprattutto di falegname per i bisogni della casa, e di fabbro ferraio per quello che posso fare adesso che non ho officina ma solamente alcuni pochi arnesi. Alle otto faccio scuola di bengalese ai ragazzi, fino alle undici, poi do una mano a qualche lavoro e nello stesso tempo attendo anche ai ragazzi. A mezzogiorno Angelus Domini in comune. Alle due scuola, come sopra, fino alle quattro, indi pranzo. Dopo pranzo fin sera ora lavoro, ora leggo qualche libro. Appena arriva sera, orazioni ed esame di coscienza in comune, poi un giorno sì l’altro no faccio il catechismo”.
A Jessore invece il lavoro non procedeva bene. Una sera, tornando a casa dopo due giorni di assenza, il missionario Marietti non trovò più nessun ragazzo a scuola: i protestanti avevano pagato i genitori affinché li portassero a casa.
Nell’aprile del 1857 padre Parietti scrisse ai superiori di Roma rassicurandoli che i missionari non erano minacciati da pericoli mortali, ma che erano però affranti e frustrati per aver trovato un ambiente così arido e poco promettente: “Ci vogliono missionari pronti ai lavori forzati e contenti della minima messe”.
Anche Giovanni nelle lettere che inviava in Italia raccontava la solidarietà che teneva unito il gruppo missionario, e la solitudine che sentiva facendo il catechista in un contesto in cui l’inserimento era lento e pieno di insidie: “Io mi trovo in ottima salute benché un po’ scoraggiato, trovandomi solo nella mia categoria senza poter cambiare parole con alcuno. Del resto sono contentissimo e mi trovo in buona armonia coi buoni missionari… Se lo può immaginare un povero figlio che sempre ha amato la società, trovandosi solo soletto, del resto non ho di che lamentarmi: i buoni missionari mi amano qual loro caro fratello... I giorni passano lavorando ora in cucina, osservando come vanno le cose, ora in chiesa, o al Bazar, il restante del giorno un poco l’ago, il martello, la penna… Attendo molto coi missionari allo studio della lingua hindi… vado già al Bazar, a comprare, parlo col cuoco delle faccende di cucina… Nei primi giorni ero alquanto turbato, il perché era lo straordinario cambiamento di molte cose, di luoghi, costumi, lingua, non sapendo dir parola se non coi missionari, ma ormai queste (cose) piccolezze sono passate”.
Guerra colonialeNella primavera del 1857 ci fu la rivolta dei sepoys, i soldati indigeni dell’esercito
britannico di stanza in India e in Bengala. Scoppiarono disordini e massacri contro gli europei, la situazione poteva precipitare da un momento all’altro e la paura di perdere quei possedimenti indusse la corona inglese a passare da una politica moderata e commerciale
2

a una politica rigidamente coloniale: la Compagnia delle Indie fu abolita e la regina Vittoria incoronata imperatrice.
I moti di ribellione iniziarono a Meerut per poi incendiare tutta la regione settentrionale dell’India. A quel tempo l’esercito coloniale contava 280.000 uomini, di cui 44.000 erano inglesi e il resto indigeni. Le cause dell’insurrezione erano certamente politiche, in quanto miravano a sovvertire l’ordine costituito, ma anche religiose. Molti ribelli si scagliarono contro gli europei, aizzati da una capillare propaganda anticristiana fomentata dai movimenti estremisti indù che non tolleravano la presenza di cattolici e protestanti, e che di conseguenza si macchiarono di violenze sugli indiani convertiti.
La rivolta fu domata dall’esercito di Sua Maestà grazie anche al dispiegamento di forze irregolari nepalesi e musulmane del nord-ovest, dopo un anno di guerra con grande spargimento di sangue da entrambe le parti. L’ultimo gran Moghul, Bahadur Shah II, massima autorità nella tradizione indiana, che era stato assunto dai ribelli come loro bandiera, fu costretto definitivamente all’esilio in Birmania.
Durante gli scontri i civili inglesi residenti in Bengala scapparono. In un primo momento Giovanni e gli altri missionari restarono uniti nella preghiera all’interno delle chiese, poi però per timore di assalti notturni scelsero di nascondersi nella foresta. Altri missionari del PIME, che si erano aggiunti ai quattro della prima spedizione, si rinchiusero nel forte della città di Agra, insieme ai civili inglesi e ai pochi convertiti.
I ribelli devastarono la città ma non riuscirono a espugnare il forte, difeso con il coltello tra i denti dai soldati inglesi. Nel terribile assedio morì di colera il catechista Giuseppe Beltrami, missionario laico come Giovanni, a soli 34 anni.
Si evidenziavano già in quel periodo due diverse concezioni di apostolato in India e in Bengala: molti missionari pensavano che fosse più giusto impegnarsi tra i non cristiani e andare incontro ai loro bisogni, mentre altri, una minoranza, preferirono assistere i molti militari cattolici, i funzionari civili della colonia e le loro famiglie (irlandesi, inglesi, indiani del Kerala e Tamil).
Finita la rivolta, in Bengala tornò la calma e la missione poté svilupparsi nelle tre aree iniziali. A Berhampur (200 chilometri a nord di Calcutta), presidio militare con un forte contingente inglese, padre Parietti si fece conoscere come cappellano dell’esercito.
A Krishnagar (100 chilometri a nord di Calcutta, a metà strada per Berhampur), padre Luigi Limana e fratel Giovanni Sesana proiettarono la missione verso i non cristiani; gli alunni e le alunne delle scuole-orfanotrofio ricevevano il battesimo e formavano famiglie cristiane. Inoltre molti credenti, che si erano orientati verso i protestanti perché rimasti senza sacerdote per lunghi anni, fecero ritorno alla missione cattolica.
Tuttavia in alcune lettere Giovanni ancora raccontava di essere alle prese con i disagi dell’inserimento in un ambiente a volte per lui totalmente incomprensibile e avverso: “ In verità per un povero giovane celibe, nell’età più vigorosa, il trovarsi in questi paesi è assai pericoloso: occasioni cattive, oggetti, gesti che ogni momento passano sotto gli occhi, cibi così accaloranti, ecc. La tentazione della carne si fa sentire assai. Qualche volta col p. Limana, parlando di questi paesi, mi dice che l’India pare sia stata fatta per scala onde scendere all’inferno; volendo dire che qui tutto pare propizio al male e contrario al bene”. Infine il terzo distretto missionario era Jessore (attualmente in Bangladesh, 100 chilometri a est della linea ferroviaria che andava da Calcutta a Krishnagar), in cui si ottennero buoni risultati nonostante la forte opposizione dei protestanti.
Un dialogo difficileIl popolo non faceva distinzione fra cattolici e protestanti, ma i pregiudizi diffusi contro i
protestanti (giunti in questa regione 30-40 anni prima dei missionari del PIME) danneggiavano molto anche i cattolici. La propaganda anticristiana faceva da sfondo al
3

conflitto tra le due missioni, che non nasceva da divergenze dottrinali, bensì consisteva in diversi metodi operativi che non si potevano conciliare
I protestanti, che conservavano interamente lo stile di vita europeo, condannavano le caste come intrinsecamente negative e ogni “segno di superstizione”, quindi anche le immagini sacre, le medaglie e i crocefissi da mettere al collo. Da parte loro i missionari cattolici vivevano alla bengalese, dunque in povertà, però tolleravano le divisioni in caste, anche durante le funzioni, e d’altra parte diffondevano ampiamente i simboli religiosi che la gente riceveva volentieri.
Bisogna giustamente anche ricordare che i missionari italiani di quel periodo non erano abituati al clima ecumenico dell’Inghilterra, per cui interpretavano rigidamente il principio che “fuori della Chiesa non c’è salvezza”, e lo predicavano con fermezza e intransigenza, troncando sul nascere ogni tipo di dialogo con le chiese riformate.
In questo clima di intolleranza, di incomprensioni e maldicenze, nel maggio 1859 Giovanni Sesana informò i superiori di Roma che la salute lo assisteva, sebbene i medici gli ordinarono di non esporsi al sole, e soprattutto che l’orfanotrofio di Krishnagar stava acquistando fama e che i suoi bambini facevano ben sperare.
Ma anche lui cadde nella trappola della contrapposizione. All’inizio di quell’anno alcuni protestanti vennero dal missionario per chiedergli se fosse stato disponibile ad aprire e gestire una scuola nella loro zona, presso il villaggio di Daerenapore, nella quale avrebbero mandato i figli.
Giovanni giudicò quella richiesta una buona occasione per rasserenare gli animi, fino però ad accorgersi che in realtà si trattava di un trabocchetto, in quanto il vero fine dei protestanti era di non pagare dei debiti ai loro correligionari. Quando scoprì l’inganno era già troppo tardi. I protestanti giunsero a capovolgergli la barca su cui trasportava il materiale per la costruzione della scuola e a rifiutarsi di fornirgli l’acqua del fiume, che doveva essere attinta di soppiatto. Malgrado tutti i boicottaggi subiti, egli mise comunque in piedi una comunità cristiana di 22 ragazzi e 25 ragazze, una vera enclave all’interno di un territorio controllato dai protestanti.
A servizio dei poveriA complicare la situazione in quei giorni si verificò un’epidemia di colera. Giovanni si
prese cura degli ammalati, affiancato da padre Luigi De Conti, trasferitosi dalla missione di Agra, il quale riuscì miracolosamente a predisporre un farmaco che comportò la guarigione in diversi tempi di molte persone anche colpite in modo grave. Da quel momento, e grazie alle cure tempestive, cessarono anche le ostilità con i protestanti.
Durante l’emergenza, per l’intera comunità di Daerenapore, Giovanni diventò ancora di più il loro “ciota saeb”, che in bengalese significa “piccolo padrone”, imparando a fare un po’ di tutto: medico, farmacista, infermiere ed economo. Attraverso questa esperienza a contatto diretto con la popolazione, prese coscienza altresì di una piaga sociale molto comune in Bengala, e in tutta l’India, ossia l’infanticidio.
I neonati illegittimi o con malformazioni venivano lasciati fuori di casa, dentro a un coccio di stoviglia, per essere divorati dagli sciacalli. Purtroppo la solidarietà dei missionari non riusciva a salvare quanti bambini avrebbero voluto, in quanto le divisioni di caste tendevano a occultare certi comportamenti e di conseguenza era difficile venire a conoscenza di chi era condannato a essere sbranato dalle fiere.
L’omertà, le diffidenze e le barriere culturali rappresentavano solo una parte dei problemi, in quanto innanzitutto bisognava fare i conti con le miserevoli condizioni di vita. Inoltre le calamità naturali, fenomeni spaventosamente frequenti, colpivano in primo luogo gli strati più degradati della società, ai quali appartenevano i cattolici.
4

Inondazioni, cicloni, terremoti, pestilenze, carestie e fame seminavano senza tregua la morte, a tal punto che si temeva che i decessi superassero le nascite. Una notevole porzione delle scarse risorse finanziarie della missione era utilizzata per ricostruire le abitazioni e le chiese distrutte e per dare da mangiare ai poveri. Un elemento di ulteriore preoccupazione era la mancanza di personale da mandare in missione, nonché le tante morti premature.
I pericoli della vita in BengalaDal 1864 al 1884 su 55 giovani missionari inviati dal PIME in varie zone dell’Asia, ben
30 morirono in Bengala o furono rimpatriati per non morire di gravi malattie. La vita di estrema indigenza, la denutrizione, la mancanza di cure adeguate e di riposo erano le cause principali di questa emorragia di giovani forze, di uomini pieni di volontà e di fede.
L’arrivo di padre De Conti era stato dunque per Giovanni una vera consolazione e si rivelò un forte supporto, in quanto da solo non riusciva a fare tutto e la solitudine stava diventando una tenaglia insopportabile. Quando padre De Conti arrivò a Daerenapore, il giovane missionario aveva appena superato una crisi d’identità che lo trascinò sull’orlo di un abisso di depressione e paura a causa di tutte le difficoltà incontrate.
In una lettera ai superiori in Italia si liberò di tutti i fantasmi che lo tormentavano: “Quanto alla mia salute fisica, questi paesi non mi sono più propizi, e ne ho sempre qualcuna, quando non sono due o tre o più. In quanto poi alle altre miserie, oh! Quante ne avrei mai da dire! Qualunque cosa faccia per raccontarle i malanni e le angustie ella non arriverà mai a farsene una giusta idea. È come il male di mare che non si può farsi un’idea senza averlo provato. Oh quante volte mi sono provato pieno di angosce in modo tale che se il Signore non vi avesse messo mano, io ero lì lì per voltarmi indietro. Sa che per un povero giovane sono pur anche cattivi questi paesi. La posizione del catechista (come erano comunemente chiamati a quel tempo i missionari laici, ndr) è più pericolosa di quello che ci immaginiamo noi in Europa. Se io potessi ritornare a casa senza dispiacervi ed espormi a grandi pericoli di perdere l’anima mia, non esiterei un momento a partire di qui; tanto più che al momento non si vede fra i nativi che finzioni, ipocrisie, ingratitudini. Dagli adulti non c’è speranza alcuna, e dai piccoli, quando si allontanassero dalla scuola, oh che miseria”. Le ore buie del dubbio e della prova lo costrinsero a rimettere in discussione le fondamenta della sua scelta missionaria. Avrebbe avuto tante ottime ragioni umane per lasciare “quell’inferno”, ma, pur soffrendo nel cuore, lui non cedette e rimase fedele al suo progetto di vita.
La via della povertàCon la presenza di padre De Conti, Giovanni prese coraggio e non si fece irretire dalla
tentazione di lasciare la missione. I bengalesi avevano una bassa considerazione della religione cristiana, eppure con il sacrificio, la cultura e il tempo si sarebbero potuti ottenere ottimi risultati in una terra così ostica e angusta.
Nel novembre del 1861 il vicario apostolico mons. Stefano Charbonneaux (vicario apostolico nel Mysore) mandò in Bengala i suoi due segretari, che nelle loro relazioni finali elogiarono il carisma dei missionari del PIME: “Abbiamo trovato dei missionari degnissimi di questo nome, pii, dediti al loro ministero, che si occupano attivamente ed efficacemente della conversione degli indigeni, industriosi nel cercare e trovare i mezzi per procurare questa conversione, poveri, viventi poveramente e risoluti a perseverare in questa via della povertà apostolica. Sono, senza smentita, i migliori missionari del nord dell’India… Questa è, di tutte le missioni del nord dell’India, quella nella quale ci si occupa seriamente e il più efficacemente alla formazione di cristianità indigene”. Mentre il secondo si rivolse direttamente ai missionari: “Molti fanno voto di povertà, ma voialtri, senza farlo, lo osservate. Voi ci avete assai edificati”.
5

Gli encomi dei due emissari apostolici furono una robusta e bella iniezione di fiducia anche per Giovanni Sesana, che vedeva spesso sprecate le sue energie di catechista e per questo si disperava quando soprattutto i bambini abbandonavano l’orfanotrofio.
Nel periodo successivo a quello in cui esplose l’epidemia di colera, Giovanni fu trasferito insieme a padre De Conti nel villaggio di Fulbarry. La nuova stazione missionaria era meno comoda perché mancava di tutto, bisognava mandare a prendere anche il pane una volta la settimana a Krishnagar, situata a quindici miglia di distanza. A Fulbarry rimasero fino all’ottobre del 1862, dopodiché Giovanni fu chiamato a prendere servizio nel distretto di Jessore, con la mansione di catechista e di amministratore della missione.
Con i catechisti indigeni andava nei piccoli villaggi, addestrava gli orfani nel laboratorio di falegnameria e li preparava al battesimo e alla prima comunione. Con loro lavorava sodo, ma la sera si faceva sempre festa, poi nei periodi di carestia battezzava i bambini che certamente sarebbero periti.
Per meglio attirare i giovani, progettò di formare una piccola banda musicale, infatti tra le varie richieste che presentò ai superiori “di fazzoletti di tela per il naso e un diamante per tagliare il vetro”, inserì anche “un manuale semplice da consultare per imparare a suonare il violino”.
Intanto la missione stava cambiando i propri connotati. La direzione del PIME decise di perseguire due obiettivi complementari: esplorare più capillarmente il territorio e mutare metodo di evangelizzazione. Accanto ai distretti più grandi, furono sviluppate stazioni secondarie, dove i missionari stabilirono la loro residenza per avere rapporti più stretti e frequenti con la popolazione. Nel distretto di Krishnagar fu costruita una casa che ospitava sia il missionario sia alcune famiglie; in un altro villaggio, Bhoborpara, si convertirono i Nikri, pescatori musulmani e vicino a Jessore, a Jogdanandakati, abbracciarono la religione cattolica i Muci, scorticatori di animali e artigiani del cuoio, una delle caste più umili e disprezzate.
La condivisione come scelta di vitaFurono promossi orfanotrofi e scuole, la missione venne estesa fino a raggiungere
regioni sempre più lontane, come le Sunderbunds, dove il Gange si riversa nell’oceano indiano dividendosi in mille rivoli, lungo terre ricoperte da una fitta e rigogliosa foresta.
La missione si indirizzò con rinnovato dinamismo verso i più poveri e dimenticati, comunità di uomini semplici la cui unica fonte di sostentamento era legata alla condotta dei bufali selvatici, poiché non ci sarebbe stato nulla di cui cibarsi se questi avessero distrutto il riso seminato nelle buche. Uomini indifesi che andavano nella foresta a tagliare la legna sfidando l’aggressività dei leopardi, delle tigri e dei rinoceronti. Molti morivano, compreso qualche missionario.
Un altro elemento di novità introdotto in quegli anni fu la decisione di alcune suore di visitare a piedi i villaggi, sostando alcuni giorni nelle capanne, occupandosi dell’istruzione di donne e ragazze, curando gli infermi con attenzione e disponibilità d’ascolto verso ogni casta e ogni religione. Mutò anche il modo di presentarsi alla gente. I missionari abbandonarono la veste clericale italiana per indossare il turbante e il longhi, l’indumento tipico bengalese.
Fratel Giovanni fu uno dei primi ad arrivare nel Bengala, tra i chiamati della prima ora a lavorare in una vigna aspra e turbolenta. La scelta di mescolarsi alla popolazione, di condividere la vita con gli ultimi, di mettersi realmente nei panni degli altri furono segni inequivocabili di un cammino lungo e difficile, ma progressivo, verso l’inculturazione, l’armonia e la pace tra le varie anime della comunità bengalese.
Andando avanti su questo cammino Giovanni Sesana molto spesso si sentì solo, si disperò, commise anche degli errori proprio per la normale fallibilità del genere umano,
6

tuttavia ogni suo tentativo di servire la missione produsse le prime crepe nel muro delle divisioni che impediscono agli uomini di riconoscersi nello stesso impasto.
Nei primi giorni di febbraio del 1867, dopo solo 12 anni di missione, si ammalò gravemente per una forte infiammazione al fegato che investì anche la milza. Non volle farsi curare da un medico inglese e preferendo la medicina indiana si sentì meglio, riprese a mangiare e a passeggiare. Tentò perfino un viaggio a Fulbarry per riabbracciare un suo figlioccio di nome Lorenzo, che aveva però nel frattempo lasciato l’orfanotrofio per seguire i protestanti.
Questa cocente delusione, le escursioni termiche notturne e la debilitazione fisica concorsero ad aggravare la malattia che nel giro di pochi giorni gli procurò la morte (il 6 aprile). In quello stesso anno, dalla sua città natale in Italia dove si stava riposando, padre Luigi Limana, l’artefice dei recenti cambiamenti di rotta che diedero nuovo impulso alla missione, scrivendo al superiore generale lo ricordava così: “Sentii poi con grandissimo dispiacere la morte di Giovanni Sesana. Era un ottimo catechista, zelante e, nello stesso tempo, buon artista. La povera nostra missione va sempre a perdere i migliori. Se Iddio mi darà la salute, l’anno venturo ritornerò all’India e, se per quel tempo potesse preparare un catechista, io me lo condurrei via volentieri, perché a Jessore hanno reale bisogno”.
Il dono della vitaQui finisce l’avventura di un uomo semplice e gracile, ma proprio per questo anche
ingegnoso e forte. È la storia di un giovane operaio che ha solcato i mari e si è impegnato, anche con i suoi limiti personali che non ha mai nascosto, in una scelta di vita difficile e al contempo straordinaria. La grandezza di Giovanni Sesana non è misurabile solo nelle opere e nelle attività che ha saputo avviare, ma nella sua capacità di ricominciare da capo, con determinazione e coerenza, dopo i momenti di difficoltà.
Anche per lui il fantastico Bengala è diventato la sua nuova terra e la sua tomba. La sua è una storia straordinaria per la fedeltà nel restare sulla breccia anche quando il pericolo consigliava il contrario. Ma è anche la vita ordinaria di “un artigiano” che ha messo a frutto le sue capacità e conoscenze umane, tecniche e spirituali perché gli altri potessero crescere.
N.B.: Nell’archivio del PIME si conserva un manoscritto “Biografia del Catechista Giovanni Sesana”, scritto da mons. Giovanni Scurati, che fu superiore generale dell’Istituto.
Dal libro Apostoli nel quotidianoL'avventura straordinaria di sette missionari laici del PIME
2. UN MAESTRO NELLA FORESTA
Pompeo Nasuelli (1850-1927), originario di Pregnana Milanese (MI), è partito per la Birmania (oggi Myanmar) nel 1872, e vi lavorò indefessamente per 55 anni.
Dopo un viaggio di oltre due mesi che lo portò ad Hong Kong, Aden, Singapore e Penang, Pompeo Nasuelli, classe 1850 di Pregnanza in provincia di Milano, raggiunse Rangoon, capitale della Birmania. Era il mese di febbraio del 1873. Qui non c’erano strade
7

percorribili né trasporti regolari, dovette quindi attendere l’alta marea per risalire il fiume Sittang verso nord alla volta della sua destinazione finale: Toungoo, nella regione di Pegu.
Risalendo il grande fiumeQuella notte aspettò la luna nuova e con essa il tempo in cui l’acqua del Mare delle
Andamane avanza e incontra il fiume lasciando passare le barche, formando un unico e immenso percorso acquatico.
Il fruscio dei remi di bambù che affondavano nell’acqua si mescolava alle parole bisbigliate di Pompeo, alle sue orazioni e alle brevi frasi in birmano che stava tentando di imparare.
L’imbarcazione procedeva silenziosamente sotto un cielo madido di stelle mentre l’esiguo equipaggio - il giovane missionario laico, assieme a padre Fedele Adrasti pure missionario del PIME e alcuni rematori del luogo - scivolava dentro la foresta monsonica che in certe zone degradava in una savana dominata da felci e come un lungo braccio oscuro si distendeva verso Toungoo, ormai prossima a essere raggiunta.
Pompeo rimase tutta la notte incantato da quello spettacolo notturno, di ombre mute che delineavano i profili dei giganteschi alberi immobili, lungo le sponde del Sittang, ormai rese invisibili dal livello dell’acqua. Alla luce flebile di una candela, iniziò a prendere appunti e a cercare le parole per spiegare quello che stava ammirando, pensando alle persone che aveva lasciato in Italia.
Quella fiammella dentro a un ambiente naturale buio e dai contorni incerti assomigliava un po’ al suo stato d’animo, poiché si sentiva minuscolo e contemporaneamente acceso di fronte alla missione che stava per aprirsi, proprio come la foresta nel momento in cui accoglie il passaggio del fiume nella sua intricata e secolare storia.
L’indomani, con le primi luci del mattino, la pianura iniziava a vivere, emanando nell’aria il suo verde incontaminato e profumato, segno di una fertilità solcata da corsi d’acqua e ricca di essenze pregiate. Tuttavia, dopo il momentaneo riposo per riprendersi dalle fatiche del viaggio e per ambientarsi al nuovo clima, non c’era tempo per specchiarsi in quella purezza.
I primi flagelli: topi ed epidemieInfatti già il mese successivo Pompeo partì per il villaggio di Leikthò, situato sui monti
abitati dai Karen, con l’immediato proposito di studiare e apprendere il ghebà, la lingua locale, che non era ancora stata scritta, il cui primo abbecedario sarebbe venuto alla luce solo qualche anno più tardi.
Sfortunatamente, verso la fine del 1873, l’arrivo di Pompeo fu segnato dall’invasione dei topi che a milioni distrussero i raccolti portando inevitabili carestie ed epidemie.
L’emergenza umanitaria durò tre anni, costringendo tutta la popolazione, compresi i missionari, a cibarsi perfino delle radici degli alberi. Per provvedere ai primi bisogni i Karen vendettero i loro chisi, tamburi di bronzo, e con il ricavato comprarono del riso. Ma assai presto le scorte alimentari furono esaurite e allora ricominciarono i problemi.
Alcuni, abbandonate le famiglie, scesero dai monti fino ai villaggi della pianura e si offrirono come schiavi alla più potente comunità dei Birmani, quelli che invece rimasero sulle montagne vendettero figli, figlie e la moglie al prezzo di dieci rupie, in cambio delle quali potevano al massimo ricevere 40 misure di riso che poi sparivano in un momento.
Costruttore e contestatorePer il milanese Pompeo, l’impatto con la missione fu indubbiamente drastico, tuttavia la
drammaticità della situazione non lo scoraggiò. Iniziò dunque a visitare le famiglie stremate e a distribuire alimenti, seppur scarsi, come anche medicinali. Si diede inoltre da fare per riparare la residenza dei missionari, avendo imparato in Italia il mestiere di
8

falegname, introducendo elementi architettonici come porte, finestre e tavoli che da quelle parti erano decisamente delle novità.
Poté esprimere liberamente le sue competenze professionali quando, in un secondo momento, gli fu affidata la costruzione della chiesa di Leikthò, per la quale ebbe carta bianca sia per quanto riguardava le scelte stilistiche, sia per questioni di grandezza.
In quel contesto di prostrazione, la sua generosità gli permise di entrare in amicizia con il popolo che giorno dopo giorno imparava ad apprezzarne le qualità, a tal punto da riservargli il nome di Sarà Pè, che in lingua ghebà significa “Maestro Pompeo”. Attorniato dal calore della gente, Pompeo iniziò a muoversi in solitudine e a piedi all’interno del distretto missionario toccando numerosi villaggi, la maggioranza dei quali aveva già conosciuto l’opera evangelizzatrice delle chiese anglicane, molto attive in Birmania come nella vicina India.
I poveri Karen impararono subito ad amare la bontà di Pompeo, e lo seguivano ovunque andasse nel tentativo di esporgli la situazione in cui versavano. Ma vedendo che non riuscivano sempre a farsi capire, un giorno lo presero per 27 un braccio e lo portarono a vedere i resti di un campo coltivato a riso divorato dalle scorribande dei topi.
Quella visione di devastazione e quei visi in lacrime scuoterono la sensibilità del giovane missionario laico, e furono i primi segni della terribile carestia che si stava abbattendo sulla popolazione che per tre anni dovette combattere con la fame e con i topi, la cui furia nessuno riusciva ad arrestare.
Una mattina salì a Leikthò un ufficiale della monarchia birmana a riscuotere le tasse. La carestia stava allentando la sua morsa, così i villaggi poterono finalmente raccogliere un po’ di riso, vera manna dal cielo. Ma per pagare le tasse al re avrebbero dovuto vendere anche quel poco di riso che erano riusciti a salvare e che era il loro unico sostentamento.
Pompeo non poteva tollerare quell’ingiustizia, con fermezza si oppose alle richieste dell’ufficiale, mostrandogli un pugno di terra come se fosse il simbolo di ciò che i Karen avrebbero messo nello stomaco se avessero pagato i balzelli regi. L’ufficiale si arrese davanti all’ostinazione del missionario e all’evidenza e con molto buon senso ritornò in città, dove chiese e ottenne l’esenzione dalle tasse per alcuni anni per tutti quelli che erano stati colpiti dalla carestia.
La pedagogia di PompeoLa carità che Pompeo mostrò verso tutti gli affamati diede luogo a vere e proprie
conversioni di massa. In mancanza di autentici e preparati catechisti, i padri del PIME diedero a lui l’incarico di evangelizzare i villaggi incastonati sulle montagne.
Benché in Italia si fosse fermato alla licenza elementare, aveva ugualmente ricevuto il mandato di insegnare il Vangelo e difatti si rivelò un ottimo divulgatore delle sacre scritture e quando si imbatteva in qualche disputa teologica con i catechisti protestanti, che come lui si aggiravano soli per le montagne, non lesinava dotte argomentazioni formulate con stile efficace a difesa delle sue convinzioni.
Si fermava in un posto quel tanto che era necessario per la prima istruzione sommaria del catechismo e per insegnare le preghiere. Radunava la gente due volte al giorno nella capanna più grande che esisteva nel villaggio, finché non avesse preparato con l’aiuto della gente una cappella dalle pareti di stuoie e il tetto di paglia.
Circondato dai suoi catecumeni spiegava con similitudini appropriate le parabole del Vangelo e appena fu in grado di battezzare i più influenti del paese, li incaricava di completare l’istruzione degli altri per passare poi in altri villaggi.
Gli spostamenti erano pesanti, soprattutto durante il periodo delle piogge, quando a causa dei temporali improvvisi e del vento freddo i saliscendi che collegavano le varie zone montane diventavano delle piste lisce come il ghiaccio, tanto che non era raro vedere Pompeo affrontare una salita con le mani a terra o misurare una discesa
9

addirittura, come lui stesso racconta con sano umorismo in una lettera, con il deretano appiccicato al suolo.
Nella borsa con cui girava per le montagne e la foresta, Pompeo teneva una buona provvista di medicinali, disinfettanti, pillole e rimedi più comuni e più urgenti, ma anche libri di medicina e un taccuino, su cui annotava i casi più disperati che incontrava lungo il cammino e che poi esponeva a qualche missionario più esperto.
Sconquassati dai monsoni, avvolti dalla canicola e lacerati dai morsi della fame, gli indigeni, che con lui condividevano la vita di stenti nella foresta, si stupivano sempre di più della creatività di quel giovane tenace e coraggioso.
I miracoli del “Dottor Pè”Con le erbe che le foreste potevano offrire, Pompeo riusciva a ottenere delle sostanze
che davano ottimi risultati contro certe malattie. Per di più, mettendo in pratica le ridotte ma utilissime conoscenze nel campo della chirurgia, capitava che ammaliasse letteralmente gli abitanti dei villaggi che andava a trovare. Tra le montagne correva voce che dopo aver disinfettato la ferita ad un uomo quasi maciullato dalla potenza di un bufalo, lo avesse fatto rinvenire facendogli annusare dell’ammoniaca e somministrandogli un liquore tonificante di sua produzione. La sua fama di guaritore aumentava e lo precedeva aprendogli molte porte sul suo cammino.
Non erano però le scornate a terrorizzare i Karen, bensì il vaiolo e la peste, considerati alla stregua di maledizioni divine. Per tradizione, quando si registrava un caso di contagio, i villaggi venivano evacuati e i moribondi lasciati al loro destino. Animato da grande affetto per i malati e da uno spirito instancabile di carità cristiana, Pompeo, che si era ormai acquisito la fama di “santo guaritore” protestò sempre contro tale pratica. Pur nel rispetto della sapienza popolare non si arrese mai davanti ai pericoli e alle difficoltà, ma seppe affrontarle con coraggio e dedizione, memore delle parole evangeliche di poter “nel nome di Gesù superare le malattie e i morsi dei serpenti”.
Un giorno capitò nel villaggio fantasma di Pepolì, da poco svuotato dei suoi abitanti, dove tra le capanne non si aggirava anima viva né si sentiva una voce umana. Il missionario allora si mise a gridare in quel silenzio duro di morte. Uscì dunque dal villaggio e dopo aver vagato per un’ora incontrò delle persone che gli dissero che era scoppiato il vaiolo e che qualcuno ne era rimasto colpito.
Pompeo chiese loro di indicargli dove si trovava il moribondo ma quelli erano talmente spaventati che svelarono il luogo della capanna solo dopo una certa insistenza. Bastava l’idea del vaiolo per scatenare una psicosi generale, al primo apparire della terribile malattia la gente fuggiva a gambe levate e lasciava dietro di sé i malati, anche se sono figli o genitori.
Pompeo arrivò alla capanna e trovò l’uomo ormai morto. Lo avvolse in una stuoia, scavò una fossa poco lontano, lo seppellì sotto una semplice croce. Dopo essersi disinfettato ritornò tra quei paurosi e li rimproverò per la loro poca carità.
Essi non si curarono un granché delle parole di Pompeo, piuttosto lo tenevano alla larga, temendo che anche il loro missionario prima o poi avrebbe manifestato i sintomi della malattia. Ma vedendolo i giorni seguenti in buona salute si persuasero che quell’occidentale, che aveva osato sfidare il male, fosse una specie di essere soprannaturale.
In quel delirio di superstizione e miseria, tale credenza non durò molto poiché le epidemie erano così frequenti e devastanti che anche lui si ammalò, seppure in forma lieve, a forza di soccorrere chi veniva contagiato.
A quei tempi il morbo compariva spesso, non risparmiava nessun villaggio, spargendo il terrore nella foresta e sulle montagne. Pompeo era sempre pronto ad accorrere e a
10

prendersi cura dei poveri abbandonati. Li visitava continuamente, disinfettava le loro pustole puzzolenti e marciose, riuscendo a salvarne molti da una morte dolorosa e soprattutto in solitudine. Quando invece non poteva fare nulla per evitare il decesso, se li portava al cimitero e spargeva su di loro preghiere e lacrime di carità.
Anche a Leikthò, la sede dei missionari del PIME, comparve il vaiolo. Un ragazzo ospite dell’orfanotrofio, costruito nel frattempo da Pompeo, fu preso da febbre e coperto in breve tempo da un lenzuolo di foruncoli purulenti. Il villaggio e lo stesso orfanotrofio in un baleno si svuotarono, poiché tutti si nascosero nei boschi. Rimase solo Pompeo che onde evitare la propagazione dell’infezione isolò il malato in una piccola capanna di bambù fuori del villaggio.
Qui lo curò con amore e non lo abbandonò nemmeno un istante. Pochi giorni più tardi, non appena il piccolo fanciullo mostrò i primi segni della guarigione, il nostro missionario laico cominciò anche lui a sentirsi addosso i sintomi della malattia. Per fortuna fu colpito da una forma lieve, così poté in fretta riprendere il suo servizio di infermiere. Questo incrementò la sua fama non solo di medico, ma anche di “maestro di saggezza e di vita”.
Fra i tanti poveri montanari curò un uomo dell’etnia Tabarà, la quale non aveva frequenti contatti con i missionari. Questi era sceso a Toungoo per fare delle commissioni e sulla via del ritorno, nei pressi di Leikthò, stramazzò a terra, febbricitante. Appena si accorsero che si trattava di vaiolo, i suoi compagni lo lasciarono steso sull’erba, inghiottito dalla fitta boscaglia, che strozzava le sue grida disperate.
Avvertito da qualcuno, Pompeo accorse immediatamente da quell’uomo, gli somministrò i rimedi più urgenti e infine lo trasportò presso il villaggio dove lo curò così bene che in pochi giorni rinsavì completamente.
Quel misero Tabarà non conosceva il missionario e mai avrebbe immaginato di incontrare tanto spirito caritatevole. Strappato sul ciglio del burrone verso la morte, era come se fosse rinato. Si convertì perché comprese la forza e il significato di quella salvezza e in seguito i due coltivarono un affetto reciproco che durò tutta la vita.
Erano nel frattempo trascorsi vari anni dal primo spostamento sul fiume Sittang, durante i quali il missionario a poco a poco si era immerso completamente nella storia del popolo, senza roboanti proclami ma semplicemente con atti di quotidiana e concreta solidarietà. Fu un periodo di sofferenze e di privazioni, durante il quale accadde una circostanza significativa che testimonia il grande carisma di Pompeo, grazie al quale penetrò nell’anima della comunità.
Un incontro provvidenzialeNel 1885 gli inglesi, che già da vent’anni dominavano sulla Birmania meridionale, si
spinsero verso nord, conquistando l’antica capitale Mandalay. Il re birmano Thibaw cadde prigioniero e venne relegato in una città dell’India. La popolazione non era in grado di reagire all’ingerenza britannica, così a parte qualche sporadica protesta di piazza e fragili momenti di resistenza armata, l’esercito usurpatore portò il confine della colonia addirittura fino alla Cina. Per sedare qualsiasi tentativo nazionalistico di rivolta, l’autorità britannica impose il divieto del porto d’armi su tutto il Paese, solo gli europei erano liberi da tale provvedimento.
In questo clima di repressione si colloca l’amicizia tra il missionario italiano e il sovrano del regno Shan di Pekkong, situato nel nord-est della Birmania. Il re, all’oscuro delle disposizioni restrittive del governo coloniale, marciando in pellegrinaggio verso la pagoda di Rangoon, luogo sacro del buddhismo, con al seguito molte guardie armate, incappò in una pattuglia inglese che gli sbarrò la strada. Gli fu ordinato di consegnare le armi e di attendere il nulla osta per continuare il viaggio.
Costretto a disarmarsi e ad accamparsi preso Leikthò si trovò a fare i conti con una perdurante carestia, in quanto, come spesso accadeva, l’ultimo raccolto di riso era stato
11

assai scarso. Con il passare del tempo le scorte di cibo si esaurirono e il permesso per proseguire il tragitto non arrivava, il re e il suo sparuto esercito iniziarono a soffrire la fame, punzecchiati da un crescente nervosismo.
Pompeo, venuto a conoscenza della situazione, mandò a quegli affamati varie porzioni di riso senza pretendere nessuna ricompensa. Il mattino seguente, meravigliato per quel gesto di gratitudine, il re andò a portare di persona i suoi ringraziamenti.
Con in tasca il tardivo lasciapassare, prima di ripartire, il re visitò tutta la missione di Leikthò, si mostrò molto interessato al lavoro dei padri e dei laici, fece domande e chiese spiegazioni; non riusciva a capacitarsi del fatto che degli stranieri potessero prendersi cura di orfani, poveri e malati.
Quando, dopo parecchi anni, il vicario apostolico mons. Rocco Tornatore, insieme ad altri sacerdoti, nei suoi giri pastorali giunse a Pekkong, il sovrano superò l’iniziale diffidenza ricordandosi proprio dell’aiuto ricevuto da Pompeo. Ascoltate le prediche dei padri, alcuni suoi sudditi gli espressero il desiderio di abbracciare la religione cattolica e di diventare catechisti.
Sulle prime il re non era per nulla persuaso della convenienza della loro scelta, infatti li ammonì sul pericolo che gli stranieri si potevano spesso rivelare meschini truffatori e ciarlatani. Gli aspiranti catechisti risposero che non avevano intenzione di disobbedire alle leggi del regno, bensì che volevano convertirsi a una religione che reputavano più rispondente ai loro desideri rispetto agli antichi principi del buddhismo.
Il re allora chiese loro se perlomeno sapessero da dove questi stranieri venivano, e quando seppe che avevano la loro residenza a Leikthò ruppe tutti gli indugi poiché gli venne in mente il cuore buono di Pompeo.
Quell’atto di carità rivolto a un uomo così potente e venerato fu davvero di buon auspicio, poiché nel 1934, in uno dei primi libri sulla vita dei missionari del PIME, Giovanni B. Tragella sottolinea che nel regno Shan di Pekkong si contava il maggior numero di cristiani della missione birmana.
Lo scontro con la tigre del BengalaTra i suoi numerosi impegni, fratel Pompeo riusciva anche a trovare un po’ di tempo per
andare a caccia, che se da una parte non era un’attività rilassante, dall’altra era giudicata necessaria per la difesa dagli attacchi dei numerosi animali feroci, ed anche per procurarsi il cibo necessario per la sopravvivenza. Nella fitta vegetazione della foresta monsonica, oltre che rischiare di perdere la direzione si poteva incontrare una vasta gamma faunistica: elefanti, cervi, daini, lupi, cinghiali, antilopi, orsi, iene, leopardi, pantere, serpenti velenosi e la temutissima e leggendaria tigre del Sud-est asiatico. Su questo argomento la storia e le leggende si sovrappongono mostrando comunque quanto l’ambiente vitale fosse così poco accogliente per le popolazioni prive di mezzi adeguati.
Un giorno, nel corso di una perlustrazione nella foresta, accompagnato da un indigeno, Pompeo si scontrò proprio con una tigre. In quel frangente, l’accompagnatore svenne per lo spavento mentre il missionario, terrorizzato e impietrito dalla paura, emise un flebile suono che si articolò in una disperata invocazione alla Madonna. A quelle semplici parole, la bestia rispose con un ruggito spaventoso, chinò la testa e sparì nel gorgo cupo delle liane e degli alberi giganteschi.
Se la vicenda si svolse effettivamente in questa maniera non si seppe mai con certezza, sta di fatto che la notizia si diffuse tra la popolazione così rapidamente che valse più di ogni predica o guarigione. Molte persone si avvicinarono maggiormente a questa persona che aveva incontrato la tigre e non era stata uccisa, e si convertirono al cristianesimo.
L’unica cosa certa fu che da quel momento iniziò la caccia sistematica alla tigre che minacciava la vita delle persone nei villaggi, e almeno 14 furono soppresse, usando delle
12

trappole che contenevano la stricnina. Una volta che l’animale stramazzava al suolo per aver ingerito il veleno, Pompeo si assicurava del decesso con qualche scarica di fucile alla testa, dopodiché con le forbici tagliava i lunghi baffi e li bruciava, in quanto secondo la cultura locale erano considerati nocivi alla salute dell’uomo. I Karen si prendevano la carcassa e al missionario veniva lasciata la pelle che in seguito rivendeva per 60 rupie agli inglesi di stanza a Toungoo.
Tradizione e astronomiaMolti altri episodi che illustrano le tradizioni locali vengono poi riportati dallo stesso
Pompeo nelle cronache missionarie del tempo. Durante i primi anni di vita missionaria, Pompeo si trovò una sera nel villaggio di Iociopoli, ancora un po’ inesperto in riferimento al modo di pensare dei Karen. Nel bel mezzo della notte fu svegliato di soprassalto da un’improvvisa scarica di fucilate e dalle grida di molte persone. Balzò in piedi e in un batter d’occhio si trovò fuori della capanna armato del suo fucile, cercando di orientarsi per capire da dove venisse il pericolo.
Avrebbe potuto essere uno scontro a fuoco tra bande rivali e invece vide sul piazzale del villaggio un ammassarsi di gente che urlava, batteva dei recipienti di latta provocando un rumore assordante e infine sparava all’impazzata verso il cielo. Pompeo chiese subito il motivo di tutto quello schiamazzo e come risposta ottenne: “Sarà Pè, spara anche tu al daino che sta mangiando la luna, se lo lasciamo fare, in poco tempo se la inghiottirà, invece se spariamo il daino si spaventerà e fuggirà via nei boschi”.
Pompeo cercò in tutti i modi di spiegare loro che non si trattava di un daino, bensì di una semplice eclissi lunare. Questi lo liquidarono con parole di compassione e di scherno.
Quando poi l’eclissi finì, la gente applaudì e scoppiò in una festa fragorosa, il daino s’era difatti dileguato a causa degli spari e la luna era ricomparsa poiché l’animale l’aveva vomitata. Pompeo tornò nella sua capanna triste e afflitto per tanta ignoranza e superstizione, ma si promise di trovare l’occasione propizia per spiegare ai suoi amici karen come stavano veramente le cose. Non molto tempo dopo ebbe notizia di una imminente eclissi solare, visibile anche in Oriente e subito l’annunciò ai Karen. Come era normale da prevedere per le conoscenze di queste popolazioni, nessuno gli prestò fede. Pompeo non si scoraggiò per così poco.
Alla vigilia dell’eclissi ripeté l’appello e preparò diversi vetri affumicati affinché si potesse osservare lo svolgimento del fenomeno. All’ora stabilita cominciò a farsi scuro, i Karen spaventati ed eccitati volevano imbracciare i fucili e sparare, Pompeo li bloccò e con grande fatica li indusse a guardare il sole attraverso i vetri.
Essi rimasero stupefatti in quando videro esattamente ciò che il loro Sarà Pè aveva predetto. A quel punto si convinsero e rigettarono l’idea tramandata lungo i secoli dalle tradizioni tribali che il cielo fosse dominato da daini affamati di lune e di soli.
Maestro di vitaCosì, con perseveranza e senso pratico, il missionario era riuscito a insegnare
qualcosa, a scalfire una pittoresca credenza, pur avendo profondo rispetto per la cultura dei Karen e grande sensibilità per il modo di vivere del popolo delle montagne, così estraneo a tutto ciò che veniva dall’esterno e anche fiero e combattivo rispetto alla proprie tradizioni.
Con il passare degli anni sempre nuovi villaggi venivano toccati dal Vangelo, che grazie all’opera missionaria avanzava per i sentieri delle montagne. Il vicario apostolico pensò allora di accogliere a Leikthò alcuni giovani, soprattutto ragazzi abbandonati, per impartire loro i rudimenti del catechismo e mandarli poi a insegnare tra le tribù più sperdute.
Non essendoci alcun padre che potesse assumersi tale responsabilità, il compito venne affidato a Pompeo. Ma il lavoro si presentò subito arduo. Quantunque il missionario laico
13

cercasse di accattivarsi in tutti i modi la disponibilità dei giovani karen, dovette lo stesso registrare molte sconfitte, in quanto pochi avevano la forza di perseverare nello studio.
Quei piccoli abitanti delle foreste, abituati a scorrazzare liberi fra i dirupi, non potevano sopportare alcuna disciplina. La libertà senza limiti di cui godevano, le emozioni della caccia, le feste gioiose che usavano fare intorno alla preda esercitavano su di loro un’attrazione naturalmente irresistibile, più di qualsiasi discorso morale o religioso che Pompeo tentasse di pronunciare.
Con una pazienza davvero santa e amore per quei giovani, molti dei quali orfani, il missionario fu costretto a ricominciare daccapo ogniqualvolta doveva rassegnarsi nel vedere molti di quei ragazzi scappare nella foresta dopo aver ricevuto vestiti e libri.
Ma dopo anni di tentativi e di disillusioni, la scuola cominciò a dare i primi frutti, furono formati eccellenti animatori e catechisti che svolsero un meraviglioso lavoro di promozione umana e spirituale tra i villaggi nascosti tra le montagne.
Con l’aiuto di quelle giovani braccia, Pompeo avviò anche la coltivazione di una piantagione di caffè che prosperò per molti anni. Questa intelligente iniziativa portò nelle casse della missione nuova linfa e inaugurò un cammino promettente per l’asfittica economia dei Karen, che non poteva assolutamente sperare di reggersi solo attraverso il commercio di pelli pregiate e per di più sottopagate, poiché poi rivendute nei mercati europei a un prezzo centuplicato, imposto dalle regole del colonialismo.
La forza della preghiera e del servizioL’amore verso quei giovani fratelli era stato dunque premiato. Per lui era naturale amare
il prossimo, e gli altri allo stesso modo gli mostravano un genuino sentimento di affetto.Nella missione di Leikthò Pompeo era solito alzarsi all’alba e pregare in chiesa, dove si
mostrava disponibile per qualsiasi faccenda. Dalla mattina alla sera non si fermava un attimo, andava avanti e indietro per dare supporto a qualche catechista, per portare medicinali in qualche villaggio, per organizzare lavori di falegnameria o in qualche risaia e non girava mai solo, era sempre attorniato da uomini, donne e bambini che gli chiedevano qualcosa o che lo ringraziavano per la sua generosità.
E lui per loro soffriva quando vedeva che mancava tutto, igiene, scuole, cibo, petrolio per mandare avanti la rudimentale tecnologia che era arrivata tra le foreste dei monti. La sofferenza aumentava perché le tribù che i missionari raggiungevano durante le loro spedizioni erano davvero dimenticate da tutti, nessuno si occupava di quei relitti confinati in zone selvagge e inaccessibili, condannati all’oblio e al perpetuo sottosviluppo.
La condivisone con la popolazione locale e l’impegno nel sollevarla dalla sofferenza erano per Pompeo la concreta realizzazione del Vangelo, e per lui questo significava rimanere fedele alla sua vocazione missionaria, che non si era spezzata durante la dura vita che aveva trovato sui monti. Anzi, questa vocazione si era rinnovata, facendolo diventare un vanto e un esempio per tutti i missionari del PIME, un sicuro approdo per i viandanti che passavano per i Leikthò e un sincero fratello per i suoi amati Karen.
Dopo vent’anni di servizio disinteressato in ambito sociale, tecnico e umano tra le popolazioni martoriate delle montagne Karen, e di assistenza pastorale alle comunità cristiane per le quali aveva costruito cappelle e chiesette grazie al suo genio di falegname, nel 1893 il vicario apostolico trasferì Pompeo a Toungoo, sede principale della missione del PIME.
Infatti da Toungoo oltre alle informazioni, alle direttive e alle istruzioni dei superiori, partivano anche tutti gli approvvigionamenti per i missionari sparsi sulle montagne. Nell’ufficio amministrativo occorreva una persona che conoscesse sia le diverse lingue karen per trattare con i portatori sia l’inglese per districarsi al mercato. Per tale importante responsabilità fu scelto Pompeo.
14

Il missionario lasciò con dispiacere i piccoli orfani di Leikthò, ma si consolava ugualmente in quanto ne avrebbe trovati molti di più a Toungoo, dove da tempo si era sviluppata una scuola media promossa e gestita dalla missione. I giovani karen, dopo aver frequentato le prime classi nei loro villaggi abbarbicati sui monti, scendevano a valle e si iscrivevano a quella scuola dei missionari, in cui si abilitavano per esercitare varie professioni come l’insegnante, l’impiegato o l’ufficiale. Altri invece si indirizzavano verso la via del catechismo, del seminario e del noviziato.
Una scuola specialePompeo ricevette l’incarico di supervisore della scuola sulla quale esercitò un’influenza
indelebile e carismatica. Il missionario incaricato della sorveglianza distribuiva tutti i giorni il riso, il pesce, la verdura, inoltre assegnava i compiti giornalieri. Quando Pompeo suonava la tromba tutti i ragazzi scattavano per svolgere le loro mansioni, oppure si radunavano per le preghiere, lo studio, le lezioni e il pranzo comunitario. Nei giorni di vacanza vi era libera uscita per due ore, nelle quali gli studenti approfittavano per recarsi alla spicciolata al mercato e comprare del curry e dei peperoni.
Tutte le domeniche, nel pomeriggio, Pompeo teneva loro una piccola conferenza su qualche nozione del catechismo, parlava in maniera naturale, semplice e sentita, riusciva a farsi capire da quella folta schiera di ragazzi, talvolta superiore a cento, di cui molti senza famiglia, con precisi riferimenti alla vita dei santi.
Una volta acquisito il diploma, i giovani partivano da Toungoo per differenti destinazioni, e benché fossero lontani, Pompeo li seguiva sempre come se fossero stati suoi figli. Essendo Toungoo l’ultimo ufficio postale ai piedi dei monti Karen, il missionario riceveva le lettere dei suoi giovani indirizzate ai loro parenti e i vaglia che essi mandavano ai villaggi d’origine, dopodiché mandava tutto a destinazione utilizzando i portatori che scendevano di tanto in tanto dalle montagne.
La maggior parte degli ex studenti aveva intrapreso la carriera militare e, dopo aver provveduto ai loro cari, se ancora li avevano, riuscivano a mettere da parte un po’ di denaro per il loro futuro matrimonio o per altre eventualità, usando fratel Pompeo come depositario, il quale scrupolosamente aspettava che i soldati tornassero in licenza per restituire loro il gruzzoletto che si andava accumulando nelle sue fedeli mani.
Esempio di vita coerenteNel periodo di Toungoo aveva il suo letto, com’era usanza in quel periodo storico per i
convitti, nel dormitorio dei ragazzi e conservava i pochi effetti e i libri in un semplice cesto. All’occorrenza cedeva volentieri il proprio giaciglio per andarsi a sistemare alla buona sui banchi della scuola. Conduceva una vita morigerata, austera e regolare. Per esempio, per fargli accettare l’ormai necessaria dentiera ci volle tutta l’autorità del vescovo, giacché se fosse dipeso da lui avrebbe impiegato quei soldi per sfamare i poveri o curare gli ammalati.
I padri del PIME lo descrivevano come un lavoratore indefesso, era il primo ad alzarsi e l’ultimo a coricarsi, pregava e si dava da fare per ogni problema di ordine pratico, aiutava in chiesa e intratteneva rapporti con tutti. Quando stava male si preparava la sua personale medicina, un tozzo di pane inzuppato in una tazza contenente solo acqua salata, e il giorno dopo immancabilmente lo si vedeva ristabilito, pieno di vigore.
Non apprezzava le convenzioni e non era per niente loquace, tuttavia il fatto di conoscere non solo l’inglese e il birmano ma anche vari dialetti tribali lo favoriva nei rapporti umani.
A volte, la sua espressione seria e burbera di uomo di fatica che non si tira indietro davanti a nessuna difficoltà veniva addolcita da qualche barzelletta che amava raccontare tra un discorso e l’altro. Quella misteriosa allegria, che si celava sotto una pelle indurita da
15

una vita tutta spesa ad aiutare gli ultimi, era anche mista a una sana preoccupazione, un’ansia ed una energia che portava Pompeo a non riposarsi mai, a testimoniare il suo amore per gli emarginati della storia attraverso la dedizione al lavoro.
Per le sue mani passava tutta la corrispondenza che settimanalmente giungeva alla residenza di Toungoo. Lui stesso aveva da anni instaurato un rapporto epistolare con i superiori del PIME a Roma, attraverso il quale descriveva i progressi della missione. Infatti Pompeo era un cronista impareggiabile. Nei ritagli di tempo, nelle lunghe serate di studio dei ragazzi, alle quali sempre presiedeva e assisteva, dopo aver fatto l’appello, si metteva in un banco a scrivere le sue note.
Non gli sfuggiva nulla, annotava tutto, ricordava e voleva che ogni anniversario venisse festeggiato. Quando arrivava qualche sacerdote nuovo, lui si informava subito sulle date importanti da celebrare: finché visse fratel Pompeo nessun missionario sperduto sui monti si sentì separato dalla residenza madre di Toungoo.
Arrivò poi il giorno della sua grande festa, il 9 febbraio 1923, per i cinquant’anni della suo arrivo in Birmania. Fra i regali che più lo commossero vi fu la generosa offerta in denaro che i suoi amici karen raggranellarono tra mille difficoltà, essendo per l’ennesima volta flagellati dalla carestia. Ma non potevano farsi sfuggire quell’occasione per manifestare al loro Sarà Pè quanto lo amavano. Quella somma era costata un cumulo di privazioni e sacrifici, perciò Pompeo, pur accettandola con gratitudine, non ci pensò due volte e la destinò completamente agli orfani abbandonati sulle montagne, denutriti e infelici.
Sulla breccia fino alla fineBenché avesse superato la settantina, era sempre in moto, impiegato in numerose
attività. Per alleggerirgli il peso della vecchiaia gli avevano affiancato il giovane missionario laico Carlo Gusmaroli, nell’intento di vederlo riposare almeno qualche ora ogni giorno. Invece così facendo si sentì mortificato, poiché il servizio era diventato per lui un bisogno, al quale non sapeva rinunciare.
Per tutto il periodo di permanenza in Birmania Pompeo non stette fermo un minuto, solo la malattia lo fermò, purtroppo in maniera definitiva.
Era il 4 luglio 1927, quando cadde bocconi a terra, tra spasmi e dolori atroci all’addome. Il medico di Toungoo gli alleviò il dolore con qualche calmante, poi all’ospedale si decise di operarlo, nonostante la sua età avanzata, in quanto lui insisteva convinto che grazie all’operazione avrebbe ripreso a lavorare.
Dopo l’intervento chirurgico in effetti gli tornarono le forze e l’appetito, ma fu un periodo di effimera serenità: il 24 settembre 1927, a 77 anni e dopo 55 anni di lavoro in Birmania, Pompeo morì.
L’ultima sua iniziativa fu la manutenzione di un pozzo con l’installazione di una pompa fatta venire da Milano. I bambini ci giocavano intorno, erano contenti di vedere fuoriuscire da quel buco acqua pura e cristallina, per loro era una festa, era una benedizione per le loro gole secche sotto il ferro zincato della cattedrale di Toungoo, uno dei pochi rifugi dove trovare l’ombra quando il sole infierisce senza tregua.
La festa di quei bambini risuonava lungo i corridoi della residenza dei missionari anche negli ultimi giorni di quel settembre, mentre i padri assistevano Pompeo sul letto di morte, colpito da un male incurabile, più invadente del vaiolo e più aggressivo della tigre.
Si dice che prima di spirare espresse un mormorio di sollievo per il fatto che gli veniva data finalmente la possibilità di riposarsi, ascoltando come un riverbero indistinto proveniente da fuori la festa dei bambini che continuava intorno al pozzo, intorno alla vita.
Un giornale chiamato “Pompeo”
16

A ricordo del servizio che Pompeo aveva organizzato per far circolare le informazione tra i missionari sparsi sui monti, fu realizzato a Toungoo subito dopo la sua morte un bollettino diocesano ufficiale di informazione che chiamarono rispettosamente «Il Pompeo».
La sua è stata una delle figure tra le più significative della missione in Birmania. Si considerava un “soldato semplice a servizio di tutti”, non per impreparazione, ma per desiderio di servizio. Al vigore del suo carattere ha saputo mescolare una sana allegria e ironia. Sembra che il suo portamento e la sua corporatura non favorissero un facile approccio. Tuttavia ha saputo trasformare queste caratteristiche in elementi utili alla formazione dei giovani Karen.
Non aveva lauree o diplomi, ma fu un “maestro” in molte discipline, che approfondì come autodidatta e imparando dall’esperienza. Con ingegnosità, forza di volontà e costanza, seppe risolvere con i pochi mezzi a disposizione grandi problemi. Ha saputo affrontare carestie ed epidemie. Oggigiorno gli avrebbero dato un premio, ma lui ha preferito agli onori la compagnia dei poveri e degli emarginati. Il premio glielo hanno dato in Paradiso.
Dal libro Apostoli nel quotidianoL'avventura straordinaria di sette missionari laici del PIME
3. IL CORAGGIO DEL MURATORE
Pasquale Sala (1908-1977), originario di Curno (Bergamo), dal 1938 lavorò in India per 26 anni ininterrotti. Costretto a rimpatriare per grave malattia nel 1964, morì a Lecco nel 1977.
“Sei destinato ad Hyderabad, in India, addetto alla costruzione della missione. Parti subito per Roma, dove si trovano già tutti gli altri partenti”. Emozionato e confuso, Pasquale Sala, nato a Curno, provincia di Bergamo, nel 1908, teneva in mano il biglietto proveniente dalla direzione generale del PIME, visibilmente stordito da quelle poche righe, tanto gradite quanto inaspettate.
Un impegno per la vitaIn quel momento si prefisse di iniziare il nuovo cammino con umiltà, ma anche con la
determinazione di non fermarsi mai davanti alle difficoltà e allo scoraggiamento, come aveva promesso solennemente quando aveva fatto il “Giuramento” di fedeltà alle missioni e all’Istituto. Non sapeva ancora che questa promessa, alcuni anni dopo, lo avrebbe aiutato a superare grosse difficoltà.
Sin da giovane aveva manifestato il desiderio di partire, in particolare da quando, durante una predica nella sua parrocchia, sentì parlare per la prima volta delle missioni e dei missionari.
Le parole di chi aveva fatto un’esperienza di evangelizzazione all’estero alimentarono nel ventenne Pasquale una chiarissima vocazione, a tal punto che il desiderio di spingersi verso luoghi lontani cresceva con la pericolosità delle situazioni che i missionari cercavano di far immaginare attraverso i loro racconti di vita. Seguendo il richiamo di questa passione, Pasquale fece domanda per entrare nel PIME, dove nel 1929 fu ammesso a partecipare ai corsi che abilitavano a impegnarsi come missionari laici. Non furono facili i dieci anni di formazione, oltretutto lui scalpitava per partire e di certo lo studio teorico non rappresentava l’ambito più congeniale per le sue qualità, ma aveva una capacità straordinaria nell’assimilare tutto ciò che facesse parte dell’arte della manualità.
17

Una dura preparazioneA lui sarebbe piaciuto iscriversi alla scuola di architettura, ma i superiori del PIME lo
vedevano meglio in mansioni meno intellettuali, così lo avviarono alla cura degli ammalati. Le giornate erano piene di impegni, la mattina a fare pratica in ospedale, il pomeriggio nel laboratorio del calzolaio e la sera, ormai affaticato, sui banchi di scuola.
Un giorno il professore di lettere gli rifilò un tre con il quale lo invitò a desistere dal frequentare le lezioni di grammatica. Dopo molti anni, quel docente severo ed esigente (p. Augusto Lombardi), divenuto superiore generale dell’Istituto, visitò la missione in cui operava Pasquale; e constatando i progressi realizzati si rivolse al suo ex allievo, con un tono sardonico che tuttavia celava una fraterna soddisfazione: “Fratel Pasqualino, vedo che lei ha approfittato molto dei miei insegnamenti. Ha imparato benissimo i verbi attivi e passivi, transitivi e intransitivi.” “Padre” gli rispose il missionario, “non ci capisco ancora niente”.
In grammatica non era un’aquila, ma in questioni di pronto soccorso se la cavava molto bene, riuscendo a strappare alla commissione esaminatrice uno splendido trenta quando, per ottenere la qualifica di infermiere, fu interrogato su come ci si deve comportare in caso di tubercolosi, insolazione e tigna, tutte eventualità alquanto frequenti in terra di missione.
A dispetto di tutta questa preparazione, il destino lo dirottò senza preavviso su un’altra strada, che del resto si intersecava con l’aspirazione originaria di diventare architetto: sei destinato alla costruzione della missione.
In nave verso l’IndiaIl 18 agosto del 1938 Pasquale si imbarcò a Genova e dopo un viaggio di undici giorni
attraverso il canale di Suez, il Mar Rosso e il Golfo arabico, sbarcò a Bombay. Il primo impatto con l’India fu traumatico. Lo turbò la vista di quella massa di diseredati vestita di stracci e rinsecchita che ciondolava sfinita sotto l’ombra malsana di palazzi opulenti.
La sera stessa appoggiò la testa ancora invasa da pensieri tristi sul finestrino del treno che lo portava a Hyderabad. Ad attenderlo c’era tutta la comunità in festa, con le ghirlande di fiori di calendula al collo e intorno alle loro teste l’eco delle campane che si moltiplicava nell’aria umida. Pasquale si unì a quella processione chiassosa e allegra che si dirigeva verso la chiesa, la tristezza si stava sciogliendo, lasciando il posto a una crescente gioia per un sogno che si era finalmente realizzato.
La prima esigenza da affrontare era dedicarsi a tempo pieno allo studio dell’inglese, importante viatico per entrare in contatto con la nuova realtà, con il quale venivano scritti i vocabolari e le grammatiche delle lingue indigene come l’urdu, il telegu e il tamil. Nel frattempo l’India prendeva forma davanti agli occhi esterrefatti e curiosi di Pasquale, insieme alla vita della gente, le case, gli abiti, i sistemi di lavorare la terra e di costruire, gli animali in piena libertà per le strade, i negozietti stracolmi di merci di cui lui non sapeva nemmeno l’esistenza. Dopo le impressioni iniziali e i primi approcci con la lingua, il vescovo mons. Dionigi Vismara comunicò al missionario che si doveva recare nella zona di Kanchanapally.
I cento chilometri da Hyderabad alla nuova destinazione furono percorsi in parte dentro a un treno malandato e il resto sopra un bandy, il tradizionale carro da trasporto indiano trainato da 2 buoi, fatto di legno a due ruote e a telaio rigido, di una lentezza esasperante e in balia di continui scossoni. Fu durante questo primo spostamento attraverso la campagna che Pasquale intuì la vera consistenza della realtà missionaria. La sua mente ritornò alla giovinezza e al lungo periodo trascorso in Italia per prepararsi alla partenza. L’ideale missionario era stato raggiunto e rimaneva intatto anche se in quella calura indiana veniva temprato dalla realtà del dovere quotidiano.
L’impatto con la povertà
18

Il carro procedeva molto lentamente, il paesaggio si estendeva monotono: terra brulla disseminata di sterpi e di rari alberi, palme, capanne di paglia e terra battuta che si confondevano con l’ambiente circostante di risaie e piccoli appezzamenti e dappertutto la sensazione di una miseria immensa, rassegnata, apparentemente invincibile. L’idioma del popolo assomigliava a un vortice di suoni indecifrabili e il cibo produceva un certo sconquasso nello stomaco; nonostante ciò Pasquale era felice in quanto aveva finalmente toccato la terra della sua missione.
Il lungo viaggio per raggiungere Kanchanapally era stato pesante e il missionario si sentiva travolto e intontito nel vedere quella sterminata fila di persone denutrite che solcavano la terra spaccata dal sole, che tendevano incessantemente la mano per chiedere l’elemosina. Sarebbe stato più consono fermarsi e riposarsi, invece il padre Albino Mazzola che accompagnava Pasquale volle continuare.
Dopo altre due ore di viaggio, trovarono in un misero villaggio alcuni malati di febbre malarica deturpati da piaghe e tormentati da infezioni di varia natura. Vi ritornarono per tre giorni, applicando le nozioni del tirocinio milanese con i medicinali che avevano a disposizione. La determinazione con cui venne affrontata l’emergenza sbriciolò la stanchezza: Pasquale non aveva avuto paura davanti alle vene aperte dell’India.
In breve tempo, da un villaggio all’altro, si sparse la voce della sua abilità medica che, per questa popolazione abbandonata da tutti, rappresentava una risorsa inestimabile. Frotte di reietti si misero in cammino per raggiungere la residenza del missionario, dando vita a un bussare ininterrotto per ottenere a qualunque ora un po’ di sollievo. Nei tre mesi che restò a Kanchanapally Pasquale si prese cura di loro con dedizione e competenza. Gli studi assimilati con fatica qualche anno prima si rendevano utili per un servizio alla gente più povera. Era questo in fondo che Pasquale aveva sempre sognato e bramava di realizzare.
Solo successivamente, obbedendo a un ordine superiore, si trasferì a Reddipalem, dove il padre Mazzola che seguiva la comunità cristiana era anziano e in più si doveva costruire una casa per le suore indiane.
Una vita movimentataIl trasferimento nella nuova missione fu fissato per l’8 dicembre, giorno della festa
patronale di Reddipalem. I bagagli e le scatole di medicinali furono sistemati su un carro trainato da buoi lenti e magri, gli scossoni e i cigolii erano sovrastati dalle grida dei conducenti che incitavano gli animali nei punti più irregolari e faticosi, mentre Pasquale e un altro padre precedettero il carico in bicicletta, pedalando lungo una stradina assolata e piena di buche.
I due “ciclisti” giunsero a destinazione prima di mezzogiorno, giusto in tempo per preparare la festa. Terminato di decorare le strade e le capanne del villaggio con festoni di carta colorata e di addobbare la chiesa parrocchiale, verso l’imbrunire tutta la comunità con tamburi e pifferi uscì in processione.
Il mattino seguente fu occupato dalle funzioni religiose, dalle cresime e dall’ascolto delle richieste di aiuto della popolazione. A mezzogiorno la missione offrì un pranzo sociale per lunghe file di persone accovacciate per terra che usavano pezzi di foglie di banano come piatto e le dita al posto delle posate. Le celebrazioni continuarono al pomeriggio con l’offerta delle candele alla Madonna da parte non solo di cristiani ma anche di indù e musulmani.
I devoti, ordinati in processione e raggiunta l’entrata della piazza della chiesa, avanzavano ginocchioni sul ruvido terreno con le candele accese in mano per offrirle alla statua sacra esposta solennemente davanti all’altare tra centinaia di luccichii e fiori. Nella sua fede, quella povera gente si genufletteva per sciogliere i voti che aveva fatto durante
19

l’anno: voti per guarigioni da gravi malattie, per essere scampati alla siccità, di donne sterili per avere avuto il dono di un figlio.
Alla sera, tra preghiere e fuochi d’artificio, si mosse la processione con la statua della Madonna a cui partecipò una folla estasiata venuta per la festa anche dai villaggi lontani: cristiani, indù e musulmani tutti insieme in comunione. Per fratel Pasquale la missione non poteva incominciare in un modo più simbolico e significativo: la missione come preghiera, condivisione e servizio, nella buona come nella cattiva sorte.
A Reddipalem rimase per un anno a svolgere mansioni di ogni tipo legate allo sviluppo della comunità e della missione, fino al settembre del 1939, quando il vescovo Vismara gli inviò un telegramma: “C’è bisogno di te a Bramanapally. Mettiti subito in viaggio”.
Da dottore a pazienteArrivato nella sua nuova destinazione visse una “avventura” che lo aiutò a capire molte
cose delle tradizioni e usanze indiane. Stava per iniziare la stagione delle piogge, che immancabilmente portava con sé svariate malattie tra cui una forma di congiuntivite granulosa, molto infettiva e dolorosa, causata oltre che dalla sporcizia da un piccolissimo insetto. Gli occhi si arrossano, bruciano fortemente e le palpebre si gonfiano fino a chiudersi quasi completamente. Durante quell’autunno del 1939, dopo aver curato dall’infezione più di duecento persone, anche Pasquale cadde malato, per fortuna solo all’occhio destro. Si lavò con acqua e collirio ma non ci fu nulla da fare poiché il bruciore continuava e il gonfiore si faceva preoccupante: era ormai sera e il dolore era lancinante.
In ogni villaggio indiano operavano dei guaritori i cui strumenti erano intrugli vari e strani accompagnati con oscure formule magiche. Pasquale era pronto ad accettare qualunque cosa che potesse calmare il suo male e così cedette al consiglio del maestro del villaggio, il quale mandò a chiamare una donna famosa per i suoi poteri taumaturgici.
La donna si presentò con due palline della grandezza e del colore di un chicco di caffè. Da un aiutante si fece consegnare una “cugia”, vaso di terracotta per l’acqua potabile, e dentro vi sfregò le due palline fino a trasformarle in una polvere fine e rossastra. Poi la raccolse con la punta dell’indice, si avvicinò a Pasquale e con una mano gli aprì l’occhio e con l’altra vi strofinò sopra la misteriosa sostanza.
Dopo nemmeno un secondo un calore terribile e un male insopportabile fecero sobbalzare il missionario che per tutta la notte non riuscì a placare quel tormento. Erano ormai le due del mattino quando i capi del villaggio, riunitisi in consiglio, decisero di provare una nuova cura.
Uno tornò con una zappa nuova, un altro aveva raccolto delle erbe portando con sé un sasso bianco granuloso come sale. Gli uomini pestarono il sasso insieme alle erbe e ne fecero una poltiglia che misero a scaldare sulla zappa già rovente sul fuoco. Poi la spalmarono non direttamente sull’occhio di Pasquale ma sulla fronte e sulle palpebre. Appena conclusa questa operazione il bruciore e il gonfiore si fecero più sopportabili e il missionario poté quindi prendere sonno e riposare per qualche ora. Solo dopo alcuni giorni, quando l’occhio ormai si era completamente ristabilito, Pasquale venne a sapere che la sostanza usata dalla prima guaritrice non era altro che pepe. Imparò dunque la lezione di non fidarsi dei rimedi alquanto pasticciati di aspiranti stregoni, comunque divenne in seguito amico di quella donna, che gli fece sperimentare, senz’altro in maniera rocambolesca, un esempio della mentalità indiana. Ma capì anche che l’India era custode di una grande tradizione medica che meritava di essere studiata e rispettata, in modo da poterla associare, quando necessario, alle diagnosi e ai rimedi di quella occidentale. Attraverso questa osmosi si sarebbero ottenuti i risultati migliori: a spese del suo occhio aveva capito una regola d’oro di grande saggezza.
Un’avventura pericolosa
20

Nel giugno del 1940 Pasquale stava per iniziare una nuova pittoresca avventura. Infatti si trasferì a Silveru, un villaggio dove operava padre Peter, un sacerdote indiano, con il mandato del vescovo di fare un sopralluogo e di scoprire perché la chiesa che vi si stava costruendo fosse in parte caduta. L’edificio, in muratura e a forma di croce latina di circa trenta metri per dieci, arrivava al tetto, quasi del tutto coperto, quando un violento temporale fece crollare completamente la facciata, due dei principale archi centrali e quattro archi laterali.
Terminata la sua ricerca, il missionario laico relazionò al vescovo che lo incaricò di mettersi subito all’opera per rifondare la chiesa. Ottenuto il nuovo compito, Pasquale preparò gli attrezzi, ingaggiò il personale necessario e alle cinque di sera, insieme a tre falegnami indiani, partì in treno arrivando all’imbrunire alla stazione di Giadcerla. Qui salirono sulla corriera per Silveru. Il tragitto avrebbe dovuto essere di soli tre quarti d’ora ma, all’improvviso, dopo alcune fermate, il bigliettaio, senza specifiche spiegazioni, li avvertì che dovevano scendere. La corriera riprese la corsa mentre loro si ritrovarono avvolti nella più completa oscurità, alterati da un certo sbigottimento e per di più ignari del luogo dove erano capitati: stava per iniziare un’avventura che non avrebbero mai immaginato.
Il sentiero che Pasquale aveva percorso pochi giorni prima e che conduceva a Silveru era stata arato e quindi non era più praticabile. Il missionario si consultò con i tre operai e alla fine imboccarono un altro sentiero che a mala pena si distingueva, fiduciosi che non mancassero più di venti minuti di cammino per arrivare a destinazione. Scivolando sullo sterrato, infangati, stanchi, bagnati di sudore e da una pioggia fine che aveva cominciato a cadere, decisero di fare una sosta in quanto erano già passate due ore e del villaggio non si scorgeva nemmeno una capanna.
Qualche minuto dopo essersi seduti sotto un albero, non molto lontano baluginò una luce di una lanterna e mentre uno rimase a guardia dei bagagli, Pasquale e gli altri due cercarono di avvicinarsi per scoprire che cosa fosse quel lume, attraversando campi e piccoli argini pieni d’acqua. Giunti sufficientemente prossimi per essere sentiti, lanciarono un richiamo ma l’uomo che teneva il lume scomparve rapidamente nel buio, forse impaurito perché stava semplicemente rubando il fieno ammassato da qualche contadino.
Perso quel fragile aggancio per potersi orientare e raggiungere il villaggio, con la paura di essere morsi da serpenti e scorpioni, mentre in lontananza il verso delle iene e degli sciacalli si faceva minaccioso, decisero di ritornare indietro e di disporsi a corona intorno a una palma con la schiena appoggiata al tronco in attesa dell’alba. Alle cinque di mattina passò un viandante che li svegliò e con grande meraviglia e disappunto si accorsero che quel benedetto villaggio, che era stato per tutta la notte la loro disperazione, distava non più di cinquecento metri.
Per ricostruire la chiesa Pasquale impiegò circa sette mesi, turbati dai sentori di un evento tragico e incombente. Da qualche settimana il governo Mussolini aveva dichiarato guerra all’Inghilterra e l’India era sotto dominazione inglese. In quei giorni un tenente di polizia accompagnato da alcuni militari si presentò alla missione che fu ispezionata e il missionario interrogato sulla sua attività. Al termine di quell’operazione gli notificarono l’interdizione a oltrepassare il limite di cinque chilometri nell’area circostante. Pasquale non si impressionò, congedò il graduato con gentilezza e si rimise a lavorare. Lo scontro bellico riversò tutta la sua ferocia anche sull’India e sulle missioni, ma solo in una seconda fase.
Nel frattempo anche a Silveru Pasquale ebbe modo di conoscere più in profondità la cultura indiana.
Per superare le “caste tradizionali”
21

All’inizio della stagione dei monsoni, e quindi delle piogge torrenziali, Pasquale sospese momentaneamente i lavori della chiesa, e si dedicò a curare i malati, tra i quali vi erano molti paria, gli intoccabili, i fuoricasta, i reietti della società indiana. A un certo punto Pasquale fu avvicinato da uno dei quattro capi cristiani del villaggio, appartenente alla casta reddy, una delle suddivisioni della casta degli agricoltori, denominata sudra: “Noi cristiani di casta reddy non possiamo sopportare che tu faccia iniezioni e dia medicinali a questa gentaccia; essi sono considerati da tutti come esseri disprezzabili, tanto che nemmeno la loro ombra deve sfiorare il nostro corpo di sudra e perciò…”.
Pasquale interruppe quella predica piena di credenze millenarie, ma che riflettevano il disprezzo verso uomini ritenuti inferiori perché nati in una casta inferiore, e con tono fermo ribatté: “Per me non esistono né reddy né paria né sudra. Per me voi siete tutti uguali. Non solo, ma le stesse medicine che i poveri non possono pagare io a loro le do gratis, mentre voi di casta superiore, se le volete, dovete pagarvele. Se ti accomoda è così, altrimenti vattene che in questo momento ho da fare per curare chi sta peggio di te ”. Quel diverbio fece il giro dei villaggi e da allora nessuno tentò di ostacolare i modi di fare di Pasquale. Aveva capito che a volte i diritti dei più abbandonati si scontrano con schemi antichi di disuguaglianza e di ingiustizia, ma d’altronde il vero missionario deve servire tutti con amore fraterno, senza discriminazioni. Solo agendo in questa maniera Pasquale avrebbe potuto ambire a realizzare i valori del Vangelo e contemporaneamente essere in armonia con il paese che lo accoglieva. Ma capiva che non sarebbe stato certamente facile e semplice, e ciò che successe in seguito ne fu la prova.
Ricercato dalla poliziaUn giorno venne in chiesa un pezzo grosso della polizia indiana, una specie di capitano,
che pregò Pasquale di seguirlo a casa sua, dove il figlio giaceva gravemente malato già da diversi giorni. Il suo villaggio distava però circa nove chilometri, di conseguenza il missionario si vide costretto con dispiacere a rifiutare, a causa del divieto impostogli dal governo. A quel punto il capitano insistette e lo rassicurò, affermando che si poteva considerare sotto la sua protezione e inoltre aggiunse: “Io sapevo che tu avevi una macchina fotografica e che il giorno prima dell’ispezione venne un uomo a dirti di nasconderla o meglio di consegnarla momentaneamente a un operaio, non è vero?”.
Pasquale con un po’ di sconcerto rispose che era vero e il capitano con molta calma proseguì: “Ebbene, devi sapere che quell’uomo è un mio subalterno e siccome non volevo che tu avessi grane con le autorità, pensai bene di farti avvertire, dato che tu fai molto bene al no
La dimora del capitano era una costruzione decente, muri di fango e di mattoni crudi, intonaci di calce secondo la tradizione indiana, tetto coperto di tegole curve. Sdraiato su una stuoia posta sul pavimento di terra battuta, in una piccola stanza laterale, buia e non arieggiata, c’era il corpo di una ragazzo in preda al delirio e con febbre molto alta. I familiari tolsero dal soffitto un coperchio rotondo e subito la stanza si rischiarò. Pasquale vide immediatamente i segni della meningite cerebrale, praticò quindi al giovane un’iniezione e inoltre gli diede un calmante. Tornò ancora e dopo quattro giorni di cure intensive i medicinali fecero effetto, la febbre diminuì e i periodi di lucidità diventarono sempre più stabili e lunghi. 55 Il giorno in cui il ragazzo uscì definitivamente dallo stato delirante, il capitano fece sedere Pasquale sul rialzo di fango all’ingresso della casa e dopo un momento di esitazione gli chiese se la madre del ragazzo poteva vederlo. A quella bizzarra richiesta Pasquale cadde dalle nuvole, dicendo che non ci vedeva nulla di male se la madre assisteva il figlio convalescente. Il capitano lo informò che prima che lui arrivasse nella sua casa, il figlio era in cura dal guaritore del villaggio che aveva proibito alla madre e a qualsiasi altra donna di avvicinarsi al ragazzo per non attirare sulla comunità le ira degli dei.
22

Pasquale non riuscì a celare uno scanzonato sorriso. Il capitano allora si convinse che poteva tirare la grande tenda che divideva la stanza dal resto della casa, dietro la quale le donne della famiglia avevano fino a quel momento spiato Pasquale ogni qualvolta veniva a visitare il malato.
Tirata la tenda apparve una fila di diciotto donne. Il missionario chiese chi erano e il capitano rispose che la prima era la moglie che la sua famiglia gli aveva scelto, le altre quattro erano le mogli scelte direttamente da lui e le restanti tredici le figlie nate dai vari matrimoni. Pasquale si congratulò per quella famiglia così numerosa, le incoraggiò a entrare nella stanza e a non avere paura di accudire il loro giovane congiunto.
Da quell’episodio non passò molto tempo che paure e sospetti intorno alle iniezioni del missionario scomparvero, infatti tutte le famiglie del villaggio, sia indù che musulmane, lo volevano a casa loro. Pasquale era riuscito a vincere le diffidenze e a superare antiche barriere, grazie all’amore e alla dedizione verso i più bisognosi. Il popolo aveva compreso le buone intenzioni del suo impegno e questo non poteva non accendere di felicità l’animo del missionario che vedeva ripagati tanti sacrifici. L’ideale di fare del bene si stava materializzando nei visi e nei corpi di quella gente, che era diventata la sua nuova comunità, in cui aveva introdotto con pazienza e laboriosità il seme della collaborazione tra gli uomini, dando per primo un vivo esempio del disegno di Dio.
Il figlio del capitano si ristabilì completamente, così il villaggio organizzò una grande festa per ringraziare Pasquale e gioire dell’insperata guarigione. Il missionario si ritrovò in sella a un cavallo con al collo una grande ghirlanda e due braccialetti ai polsi composti di fiori bianchi e profumati, in mezzo al baccano di un’orchestra con pifferi e tamburi e a vassoi di pasticcini che passavano di mano in mano. Sospeso tra quei dolci flutti e frastornato per il calore umano che avvertiva intorno a sé, indirizzò per un istante il suo pensiero a due persone che avrebbe voluto vedere festanti a quel convivio di musica e allegria.
Uno era un vecchio indù minato dal cancro allo stomaco, deceduto alcuni giorni prima, che aveva chiesto in punta di morte di essere battezzato. L’altra persona a cui andava il sentimento di Pasquale era una bambina musulmana affetta da tubercolosi a cui di recente aveva auscultato i polmoni. Sarebbe morta due giorni dopo aver ricevuto il battesimo con il nome di Pierina, la madre di Pasquale: anche il cuore ha bisogno della sua parte.
Il contatto con la popolazione è pressoché sincero e profondo, nell’anima del missionario lascia un segno indelebile, tuttavia la missione non è sempre una festa. Per un “fratello” laico, che rinuncia a tutto per diventare uno strumento d’amore tra gli uomini in terre lontane e difficili, poter dare il battesimo accresce la fiducia e la forza per sopportare il distacco dalla propria famiglia e dalla propria gente.
Problemi da risolvere con pazienza, coraggio e tanta fedeIntanto il lavoro di ricostruzione della chiesa di Silveru era stato portato a termine,
quando per l’ennesima volta Pasquale ricevette dal vescovo l’ordine di fare fagotto e trasferirsi prima a Dornakal e poi a Khammam, dove c’era bisogno di erigere le nuove abitazioni parrocchiali per alcuni padri. Appena la popolazione seppe del suo trasferimento tutti, cristiani, indù e musulmani, decisero di inviare una delegazione dal vescovo per chiedere l’annullamento di quel provvedimento, ma la loro civile protesta non produsse nessun risultato. Anche loro dovettero capire che il missionario non appartiene a nessuna terra perché appartiene a tutte le persone che hanno bisogno.
Tra Dornakal e Khammam Pasquale trascorse circa un anno, occupato in lavori di progettazione e carpenteria, dedicandosi altresì ai malati che amava tanto e ai battesimi: in quel periodo battezzò sei neonati in pericolo di vita dopo un parto complicato, dei quali solo una bambina sopravvisse. La sera, dopo una giornata faticosa e dolorosa quando la
23

morte colpisce, il missionario si poteva consolare pregando e pensando a quella creatura, segno vivo della sua missione che come una goccia scende lentamente e senza far rumore si fa strada all’interno della roccia, scavando rifugi di amore e solidarietà, dove si può davvero sperimentare una storia nuova fatta non più di egoismi, di chiusure e di privazioni, bensì di rispetto, di aperture e di generosità.
Il missionario laico in terra di missione è un persona che si sente “fratello di tutti” scavalcando il perimetro della propria esistenza per aiutare gli altri, in forma gratuita, così da contribuire a cambiare la sua singola e piccola storia e la storia più grande dei rapporti con gli altri popoli. Anche quando il peso di certi eventi irrompe nelle nostre scelte di uomini, con una tale violenza che si tende ad arrendersi a una storia che resterà sempre ancorata a un porto rosso di sangue e di oppressione.
Nel campo di concentramentoEra il febbraio 1942 quando il governo coloniale inglese ordinò ai missionari italiani di
rimanere confinati nelle loro residenze, consci che da un momento all’altro sarebbero stati deportati in un campo di concentramento. Passarono sei mesi di ansiosa attesa, poi puntualmente a fine settembre ai missionari del PIME fu intimato di salire su un treno che li avrebbe portati a Kota per poi proseguire in autobus fino al campo di prigionia di Deoli, situato in una vasta zona desertica nel nord-est dell’India. Dopo un viaggio di quattro giorni, giunti nella stazione di Kota, rimasero a dormire nella carrozza, con la tristezza nel cuore per aver assistito poco prima al pestaggio di un servo indiano da parte di un sergente inglese.
L’ordine era di trovarsi pronti al mattino seguente alle sette. I padri si alzarono all’alba per avere il tempo di celebrare la messa, sapendo che ogni ritardo o tentativo di disubbidienza sarebbe ricaduto con severità esemplare su tutto il gruppo. Così alle sette in punto tutti i prigionieri si trovarono con le valigie pronte davanti alla stazione per continuare il tragitto su una corriera.
Il viaggio da Kota a Deoli durò quattro ore e mezzo attraverso un paesaggio mozzafiato, tra colline azzurre e file di cammelli che si spostavano da un villaggio all’altro, alcuni attorniati da mura antiche, vestigia di un passato sontuoso. Nell’ultimo tratto la corriera percorse una strada che ai lati aveva grandi campi recintati di filo spinato con baracche basse e allineate, di mattoni e cemento: erano i campi di concentramento riservati ai prigionieri militari e civili, dove vennero rinchiusi anche francescani, carmelitani, gesuiti, salesiani e tutti i missionari del PIME, compresi quelli di stanza in Birmania e in Bengala.
Espletati i controlli dei documenti e dei bagagli, gli uomini vennero condotti alle baracche in cui avrebbero trascorso la loro prigionia, inibiti da sinistri reticolati e guardati a vista da poliziotti con i fucili spianati.
Anche per Pasquale la libertà era ormai una disperata illusione che si allontanava come rapita da un vento teso e implacabile al di là del filo spinato. Questo periodo disumano si protrasse per due anni, nei quali lo spirito missionario malgrado le varie costrizioni continuò a vivere. Costretti a una inerzia obbligata, abituati a lavorare duramente e a mettere giornalmente a frutto le loro capacità, i missionari si sentivano morire, come dei leoni in gabbia. Furono la solidarietà, la preghiera e la pietà che scacciarono via i demoni dello scoramento dalla mente dei prigionieri. A ognuno era stato affidato un compito, per esempio Pasquale fece prima il lavandaio e poi il cuoco. La vita segregata assunse così un ritmo monotono che procurava avvilimento nelle persone che erano state costrette a interrompere la missione, il loro umile e quotidiano lavoro a fianco dei più poveri.
Per difendersi dal caldo torrido del deserto circostante, che tra l’altro portava nel campo tremende nubi di sabbia, i missionari erano soliti riunirsi al tramonto, quando l’aria si faceva meno afosa, in momenti conviviali che spezzavano la dura monotonia della loro condizione di reclusi. La sera dell’8 agosto 1943, memoria di san Domenico, festa quindi
24

per i padri domenicani, Pasquale e altri organizzarono una festicciola con caffè e dolci. Tra una risata e l’altra il tempo era passato in fretta, tutto scorreva così fluido e leggero che non si accorsero di aver oltrepassato di molto il limite imposto dal regolamento.
Adirato come non lo avevano visto mai, il responsabile militare del campo uscì dalla sua stanza e si mise a sbraitare contro i partecipanti alla baldoria che furono puniti per quella infrazione: d’ora in avanti tutte le libere uscite di un giorno alla settimana sarebbero state negate. Quel giro di vite rese la prigionia ancora più snervante, il tempo questa volta veniva percepito come un corpo paralizzato, senza più senso né dignità.
Passarono mesi tristi, nei quali l’immobilismo coatto aveva sedimentato nell’animo dei missionari un certo pessimismo. Contemporaneamente in Europa la guerra stendeva i suoi ultimi tragici veli sulle popolazioni, gli eserciti e le città, le forze anglo-americane conquistavano posizioni e la capitolazione di Berlino era ormai cosa di pochi mesi. Mano a mano che dal teatro di guerra europeo giungevano dispacci che davano per imminente la fine del conflitto, le autorità del campo concedevano ai missionari di fare ritorno scaglionati alle loro comunità e ai loro villaggi.
25

La ripresa dei cantieri di vita e di lavoroIl 18 dicembre 1944 venne il turno di Pasquale. Rivedere la sua gente fu una gioia
immensa, giacché equivaleva a ricominciare da zero il lavoro intrapreso a servizio dei poveri e degli ammalati, l’unica missione che conferiva un significato alla sua esistenza.
Ritornato a Secunderabad iniziò subito a creare e a costruire, senza sosta e a pieno ritmo, invitato anche fuori diocesi. Mise in piedi molte residenze missionarie, chiese, campanili e saloni parrocchiali. Inoltre trovò anche il tempo, l’ingegno e la forza per restaurare due chiese storiche, una inaugurata dai cattolici di Goa in stile coloniale portoghese, l’altra risalente alla metà dell’Ottocento, eretta dai cattolici tamilici provenienti da Madras, al seguito degli ufficiali inglesi come cuochi e servi.
In tutti i distretti missionari assegnati al PIME, Pasquale diresse i lavori per la costruzione di numerose scuole, dove si iscrissero più di tredicimila indiani, senza distinzioni di casta, razza e religione.
I cantieri e gli impegni quindi si moltiplicavano, il volume di lavoro aumentava giorno dopo giorno a un punto tale che i carri trainati dai buoi non ce la facevano più a fornire in tempo il materiale agli operai. Appurata la situazione, il vescovo acconsentì all’acquisto di un autocarro e di una motocicletta che avrebbe sostituito la sgangherata bicicletta usata fino ad allora da Pasquale. Si apriva anche per le missioni l’occasione e l’opportunità di fare un altro difficile salto di qualità. L’era della modernizzazione richiedeva ai missionari un nuovo sforzo di intelligenza e buon senso per non creare altri emarginati.
La comunità cristiana era un manciata di riso in quella galassia sterminata di indù e musulmani, eppure cresceva come un bell’albero dalle radici solide e sicure. Il suo carisma si diffondeva perché tutte le opere della missione erano tese a favorire l’armonia tra i vari gruppi e far progredire l’intera società partendo dagli ultimi, dagli strati più bassi, dagli emarginati che bivaccano con la loro sudicia stuoia sui marciapiedi della periferia della storia.
La grande sfida della scuolaL’impegno e l’investimento nella scuola, ad esempio, furono un’intuizione e una scelta
fondamentali per scardinare le catene di un’ignoranza secolare che causò l’oppressione di tanti uomini e di tante donne. Rappresentava dunque uno strumento formidabile per il riscatto di un’intera generazione ferma nelle sabbie mobili dell’analfabetismo.
La cultura del missionario Pasquale non derivava certo dalla frequentazione di biblioteche o dalle dotte dissertazioni nelle aule universitarie, era semplicemente il frutto di una dolce alchimia, di una miracolosa miscela di buon senso, intelligenza, senso pratico, sensibilità e amore per il Vangelo.
Nel 1953, per volontà della Santa Sede, la diocesi di Hyderabad (che comprendeva Secunderabad) fu affidata al clero locale, che ormai era sufficientemente numeroso e organizzato per poter assolvere un compito di tale portata. Pertanto i missionari del PIME furono dislocati in una zona più a oriente, più povera e priva di strutture, che avrebbe costituito la nuova diocesi di Warangal. In questa nuova avventura la Provvidenza aveva i suoi piani.
Ripartire da zeroLa fondazione della nuova missione implicava l’acquisto di un appezzamento di terreno
che fu individuato all’incrocio delle strade che conducevano alla città. Le trattative però non giunsero mai a conclusione, anzi si trascinarono per mesi e mesi a causa della guerra scoppiata tra i Razakars, truppe islamiche, e le milizie comuniste che avevano instaurato un governo illegittimo in alcune province.
Le speranze di ottenere questo terreno erano pressoché svanite quando si presentò un’altra occasione che per motivi burocratici venne affondata in poco tempo. Dopo
26

estenuanti tira e molla, il PIME riuscì a ottenere l’assenso di un grosso latifondista che pose la sua firma su un contratto di compravendita riguardante un altro terreno. Apparentemente il terreno era troppo esteso per le esigenze dei missionari, ma aveva il vantaggio di essere a un prezzo davvero conveniente e, nel giro di pochi anni, avrebbe costituito la base logistica della nuova diocesi.
Concluso l’affare Pasquale fu spedito in ricognizione. Il 18 agosto 1949, caricati su un autocarro la motocicletta, la bicicletta, una tenda, tre maialetti e altre piccole cose necessarie, assieme a un giovane indiano, partì per Warangal. Arrivarono all’imbrunire e si trovarono davanti agli occhi un vastissimo terreno, su cui si poteva intravedere soltanto una capanna, il resto era pietrisco e boscaglia composta da alberi di varie dimensioni, regno incontrastato di serpenti, iene, sciacalli e leopardi che nottetempo si avvicinavano famelici alla città in cerca di prede, di rifiuti e di cibo.
Cominciava a scendere la notte e pioveva a dirotto. Davanti a quello spettacolo di solitudine e abbandono Pasquale ebbe un attimo di scoraggiamento. Ma durò poco perché si ricordò dell’impegno solenne che aveva fatto prima di partire per l’India, quando aveva deciso di non indietreggiare mai davanti alle difficoltà. Nel giro di poco tempo questa promessa sarebbe stata messa più volte a dura prova.
La fatica del quotidianoCon la solita determinazione con cui affrontava i sacrifici, il mattino seguente piantò la
tenda stando ben attento che la parte inferiore non toccasse terra perché le formiche bianche non la rovinassero: diede inizio alla fondazione della nuova missione, con nel cuore il brivido della nuova frontiera e nell’anima l’eco della preghiera che lo aiutava nei momenti difficili.
I primi tempi furono duri, pioveva di continuo e Pasquale faceva spesso la spola tra il terreno e Warangal per comprare cibo e il materiale da costruzione, pali, sassi, mattoni, blocchi e sabbia. Una notte, dopo ventiquattro ore di pioggia torrenziale, improvvisamente una raffica di vento fece volare via la tenda. Non era il caso di mettersi a puntellare di nuovo la tenda sotto quella cascata d’acqua e in quel terreno ormai quasi allagato, allora Pasquale decise di andare a dormire nella cabina dell’autocarro.
Sotto la tenda di giorno si bruciava dal caldo e la notte si gelava per il freddo e inoltre non era uno strumento efficace per difendersi dai cobra che infestavano la boscaglia tutt’intorno. In più l’autocarro poteva essere solo un’alternativa per qualche notte. Occorreva dunque costruire perlomeno una capanna di legno che Pasquale eresse rapidamente, non senza qualche grattacapo.
La sua presenza infatti aveva attirato l’attenzione della popolazione dei villaggi vicini, che si era subito mostrata insofferente. Si opposero in ogni modo al lavoro di Pasquale, si rifiutarono di collaborare anche dopo l’offerta di un salario, gli facevano dispetti di ogni sorta fino a che una notte, mentre dormiva, giunsero al punto di dare fuoco alla sua capanna di legno. C’era d’aver paura: un uomo solo e per di più straniero contro una popolazione così poco favorevole.
Un’altra persona avrebbe rinunciato e invece il missionario insistette, un po’ perché aveva ormai la pazienza allenata, un po’ per testardaggine e tanta speranza che non poteva certo inabissarsi davanti a un atto intimidatorio. Ma non era una sfida motivata dall’orgoglio personale, era un atto di fedeltà e ottimismo verso il futuro. Di conseguenza si mise al lavoro per costruire una baracca con un bagno, però per evitare che gliela bruciassero decise di fare i muri di fango e coprirli con tendoni acquistati dai militari a poco prezzo.
Aveva iniziato da poco tempo, giacché i muri del bagno non erano ancora giunti all’altezza stabilita per pensare al tetto, che vide arrivare con grande foga un ispettore del mu- 64 nicipio di Warangal, certamente avvertito dalla popolazione, il quale prima ancora
27

di rivolgergli la parola diede ordine ai tre uomini che lo accompagnavano di abbattere tutto quello che Pasquale aveva costruito, poi inveì contro di lui intimandogli di presentarsi lo stesso giorno in municipio a chiarire la sua posizione: da quel momento iniziò la lotta con la farraginosa burocrazia indiana. Pasquale si raccomandò a tutti i santi che conosceva, ma sapeva anche che la Provvidenza che l’aveva destinato a questo progetto non l’avrebbe lasciato da solo.
Gli scherzi della ProvvidenzaPasquale si recò dall’ispettore dell’ufficio costruzioni e dopo un breve battibecco per il
progetto dei fabbricati che aveva già presentato da sei mesi e sottoposto alla loro approvazione senza mai ricevere una riga come risposta, si sentì dire che sul terreno della missione non si poteva edificare perché l’autorità municipale lo aveva destinato ad altre opere pubbliche. A volte, si disse, la Provvidenza ha i suoi tempi e se avesse cambiato i piani originari non poteva certamente che adeguarsi, anche se con qualche dispiacere. Bisognava forse avere solo un po’ di fede in più. Decise quindi di aspettare il seguito dell’avventura. E le sorprese non mancarono di certo.
Tornato a Secunderabad, il missionario scrisse ai superiori del PIME informandoli della situazione di stasi in cui la missione si era venuta a trovare. I superiori si adoperarono per rimuovere tutti gli ostacoli e per districare tutte le pastoie burocratiche, ma non ci fu nulla da fare, per il momento gli indiani non arretrarono di un millimetro dal loro diniego.
Questo stato di cose, fra incertezze e sospensioni, durò più di un anno. Intanto Pasquale stava ugualmente preparando il materiale per le future costruzioni, quando ricevette l’ordine di cessare ogni attività in quanto il terreno era da considerarsi perduto. Di nuovo la missione si trovava bloccata in un vicolo cieco, e con essa fratel Pasquale era impigliato in una tela di ragno che gli instillava nell’anima solo depressione.
Per il missionario quell’immobilismo evocava implacabilmente la morte di ogni ideale. Una favolosa occasione per scrollarsi di dosso il torpore che lo avviliva gli venne dalla Compagnia Parastatale dei trattori, che volendo aprire una sua agenzia nella città di Warangal, gli chiese di diventare il loro agente e rappresentante. Pasquale accettò e dopo dieci giorni vide arrivare da Hyderabad quattro trattori con i rispettivi aratri e il personale addetto.
Fece arare una parte del terreno che avrebbe dovuto essere assegnato alla missione e poi affittò i mezzi agricoli ai numerosi indiani che glieli chiedevano. Praticamente per circa un anno si portò avanti con il lavoro malgrado il divieto delle autorità locali e dei superiori del PIME. Non era nella sua indole restare con le mani in mano e per di più la speranza che un giorno la questione si sarebbe risolta in positivo gli dava coraggio di andare avanti anche da solo, lontano dall’appoggio degli altri missionari rimasti nelle diverse sedi.
Faccia a faccia con la guerriglia armataNel frattempo in India si stavano realizzando profonde trasformazioni. Il Paese aveva
ottenuto l’indipendenza dall’Inghilterra e le truppe del nuovo governo appena insediato non persero tempo per occupare lo stato del Nizam, zona musulmana nella regione dell’Andhra Pradesh. Si venne a creare un periodo di instabilità, insanguinato da vendette trasversali. Alcuni signorotti locali e vari alti funzionari governativi furono uccisi, e gruppi di guerriglieri si diedero alla macchia nella foresta, tramando contro il governo, pronti alla minima occasione favorevole a uscire per le loro scorribande.
In quel clima di violenza Pasquale continuava a procurarsi il materiale per le costruzioni: occorreva molto legno per le porte, le finestre, le capriate dei tetti, le verande e soprattutto bambù per le impalcature. Sostenuto dalla speranza e dal senso del dovere, riuscì a mantenere la calma e a farsi guidare dalla saggezza, anche se intorno a lui si stava scatenando una piccola guerra civile. Per risparmiare andava con il suo autocarro sulle
28

piste della foresta e non aveva paura se doveva inoltrarsi anche di parecchi chilometri tra la boscaglia fitta e intricata pur di valorizzare al meglio le risorse economiche per la missione.
Un giorno, mentre girava nel labirinto verde della meravigliosa vegetazione tropicale, intento a schivare gli alberi e gli anfratti, dopo una decina di chilometri si dovette arrestare davanti alla sponda di un imponente affluente del Godavery, il fiume principale che attraversava il territorio. Alcuni minuti dopo aver spento il motore, un rumore misto a un misterioso vocio che progressivamente aumentava squarciò il silenzio placido della foresta, da dietro una schiera di alti bambù sbucarono fuori uomini armati di fucili, pistole e pugnali: era la famigerata guerriglia che si opponeva al governo indiano.
Nella testa di Pasquale passò come una scarica elettrica il lugubre pensiero che fosse giunta la sua ora. I guerriglieri lo circondarono, gli puntarono la canna di un fucile sul petto e iniziarono a tempestarlo di domande sul suo paese d’origine, sul motivo della sua presenza in India e se fosse stato coinvolto nelle attività del governo. L’interrogatorio finì solo quando gli uomini armati si resero conto che Pasquale non era un loro nemico e quindi lo lasciarono andare.
I fucili si abbassarono, gli uomini si distrassero in un movimentato conciliabolo e non fecero quasi caso al fatto che il missionario si stava accomiatando, con un sorriso sereno sul viso marchiato dal sole, un impasto di pelle, fatica e sottili rughe intorno agli zigomi, di allegria e di tristezza.
I guerriglieri erano ormai lontani, Pasquale si era appena ripreso dallo shock e stava guidando sulla strada principale, con l’ansia di arrivare in tempo per guadare il fiume, visto che sopra la sua testa si stavano gonfiando pericolose nuvole cariche di pioggia. Quando lambì il lago morto di Bussapura l’acqua torrenziale correva all’altezza di circa venticinque centimetri e già sull’argine del fiume Chiaurati Gerripotu, il più pericoloso e insicuro, erano incolonnati corriere di passeggeri e alcuni autocarri di militari governativi.
Tornare indietro non si poteva perché alcune persone riferirono che anche il fiume alle loro spalle si era ingrossato. La notte fu dunque terribile. Tutti furono costretti a trovare riparo ammassati come sardine dentro le corriere e gli autocarri, insonni per il frastuono che producevano all’unisono la pioggia battente, il vento e la corrente impetuosa del fiume.
Solo a mezzogiorno del giorno dopo, stremato dalla fame e da un leggero attacco di malaria, Pasquale riuscì a guadare il fiume e far ritorno alla base, alla baracca che aveva costruito, sempre minacciata dalle prevaricazioni delle autorità, sul terreno che aveva scatenato la discordia tra il PIME e il municipio di Warangal.
Passarono i giorni e il missionario riprese le sue incursioni nella foresta per il solito rifornimento di legname e di bambù, imperterrito e guardingo nell’evitare le imboscate dei ribelli. Nei pressi di un bungalow adibito anni prima a ospitare gli ufficiali inglesi fu fermato da una pattuglia di poliziotti indiani che gli chiesero se fosse stato disponibile a trasportare in città due agenti e un gruppetto di prigionieri stanati dai loro nascondigli nella foresta, alcuni dei quali facevano parte della squadra che lo aveva interrogato alcune settimane prima.
Pasquale accettò con un po’ di apprensione in quanto lo spazio era esiguo e angusto, comunque fece salire i poliziotti nella cabina dopo che questi ultimi ebbero sistemato i guerriglieri, legati a una lunga e pesante catena, nella parte posteriore dell’autocarro, appollaiati sopra le cataste di bambù.
Faceva un caldo infernale e il sole sembrava avesse la forza di bruciare le ossa, Pasquale decelerò e poi si fermò, chiedendo ai poliziotti se gli concedevano il permesso di dare da bere ai detenuti che sicuramente avevano la gola secca come il deserto. I due poliziotti lo guardarono inorriditi, non potevano concepire di alleviare le sofferenze di nemici che si erano macchiati di delitti atroci, tuttavia dissero che si poteva fare, con molto
29

disappunto. Per Pasquale non c’era differenza tra esercito e guerriglia, e il missionario non poteva perdere un’occasione come quella per fare del bene a dei poveri disgraziati, per perdonare e sentire pietà per qualsiasi persona, poiché prima di tutto viene la dignità umana che deve essere sempre difesa.
Quello strano viaggio fu portato a termine, e arrivati al comando generale della polizia i prigionieri scesero scortati dai poliziotti. Pasquale salutò tutti e ripartì, con in testa il solito, drammatico assillo: quando le autorità indiane, che continuavano a essere irremovibili, avrebbero concesso il nulla osta per l’acquisizione definitiva e l’utilizzo completo del terreno?
Il “miracolo” della Madonna Pellegrina di FatimaDalla sua base solitaria di Warangal il missionario tornava qualche volta a
Secunderabad per incontrarsi con il vescovo e con i padri e seguire i lavori di altre costruzioni. Fu durante una di queste visite che il discorso cadde sulle feste che in molte parti dell’India si facevano in onore della Madonna, in occasione della visita della statua della Madonna di Fatima in pellegrinaggio attraverso le diocesi.
Tutti insieme discussero dell’opportunità di far arrivare la statua anche nella loro diocesi, sebbene alcuni sacerdoti espressero delle perplessità, invitando alla prudenza, dal momento che la diocesi in cui operava il PIME sorgeva su una zona ad alta concentrazione di musulmani. Tuttavia, a seguito di ponderate riflessioni, i dubbi furono definitivamente accantonati e il risultato fu che la Madonna Pellegrina fece visita alle varie parrocchie della diocesi dal 13 al 14 maggio 1950.
La statua fu collocata su un autocarro guidato da Pasquale, illuminato e addobbato, e portata in processione tra due ali di tutto il popolo in giubilo: cristiani, musulmani e indù. Ad ogni stazione i padri tenevano discorsi in inglese, tamil, indi e telegu, per spiegare il significato di quel simbolo religioso e la sua storia.
Durante i due giorni di processione si verificarono numerosi miracoli e guarigioni misteriose: una donna da tempo muta riacquistò di colpo la parola e una Parsi si sentì inspiegabilmente guarita da una grave malattia alla spina dorsale.
Furono giorni intensi, di preghiera, di canti e di gioia, nei quali le varie comunità religiose della diocesi si diedero appuntamento per dare vita a un vero inno a Dio e alla fratellanza. Purtroppo quel momento di furori mistici e di profonda civiltà si dissolse in fretta, ma un disegno misericordioso, anche se ancora poco visibile, cominciava a realizzarsi a dispetto di tutte le difficoltà burocratiche e umane.
Dopo il trionfo della Madonna Pellegrina, Pasquale ritornò nel suo avamposto solitario a Warangal, inviso al potere municipale che lo teneva bloccato tra le zolle secche del terreno oggetto della contesa.
Una mattina il postino gli consegnò una lettera da Hyderabad. Pasquale si lamentò per il ritardo di diciotto giorni sul timbro della data di emissione e il postino si difese adducendo che era stato difficile scovarlo visto che la baracca del missionario si trovava su un terreno senza nome. In effetti il solerte funzionario non aveva tutti i torti.
Dunque Pasquale si affrettò a inventarsi un indirizzo, perlomeno per evitare grane con l’ufficio postale. Dopo vari tentativi scelse il nome di Fatimanagar, “città di Fatima”, in onore del recente pellegrinaggio della statua della Madonna e del suo indimenticabile carisma che aveva pervaso la popolazione.
Da quella festa erano passati cinque mesi e lo stato giuridico del terreno versava sempre nelle stesse condizioni di immobilismo e inerzia. Improvvisamente, senza motivi umanamente prevedibili, il superiore del PIME si recò dalle autorità municipali per trattare della questione. Questa volta, miracolosamente e in barba a qualsiasi pronostico, l’ispettore dell’ufficio urbanistico del municipio approvò senza riserve il progetto della missione e firmò il permesso di avviare i lavori di costruzione.
30

Fu dunque unanime tra i missionari riconoscere l’intervento della Madonna di Fatima in questo insperato e radicale ribaltamento della situazione.
Dopo tanta fatica, dopo aver superato da solo prove difficili e momenti amari, finalmente Pasquale poteva accogliere gli altri missionari che si trasferirono definitivamente nella nuova sede.
In un tripudio di canti, preghiere e di festa, la diocesi di Warangal fu inaugurata il 13 maggio 1953. Su quel terreno, durante questa seconda avventura missionaria, Pasquale costruì l’episcopio, le scuole, le chiese, le parrocchie e infine l’ospedale, che, in un certo senso, fu proprio lui a inaugurare. Dove un tempo regnava incontrastata la boscaglia e tutto era lasciato a un triste destino di trascuratezza, ora sorgeva una comunità viva e produttiva.
La purificazione della malattiaEra dal lontano 18 agosto del 1949 che Pasquale conduceva una vita dura. Dal giorno
in cui, caricato il suo autocarro, aveva lasciato Secunderabad per impiantarsi sul terreno nuovo, innumerevoli erano stati gli spostamenti, le notti insonni, la febbre malarica, i pasti affrettati e insufficienti, il lavoro, la pioggia, il caldo, le preoccupazioni e la paura di non essere amato dalla popolazione.
Da tempo sentiva forti dolori allo stomaco e al fegato e appena aperto l’ospedale si manifestò un forte attacco di itterizia che lo costrinse a ricoverarsi.
Da quel primo ricovero si riprese, e con la salute di nuovo ristabilita ritornò al lavoro quotidiano, con lo stesso ideale che in principio lo aveva portato in India, cioè quello di cercare di fare la volontà di Dio in qualsiasi occupazione: Pasquale era convinto che non è tanto importante il ruolo che si ricopre, sia esso di capo o di manovale, ma lo spirito con il quale lo si vive.
Intanto la nuova missione si stava dunque consolidando, anche grazie ad altre attività come la coltivazione di tabacco, riso, peperoni e arachidi e all’allevamento di bufali, buoi e maiali. Era stato proprio Pasquale a intraprenderle e a farle girare a pieno regime, e così il ricavato della commercializzazione dei prodotti agricoli e del bestiame poteva essere utilizzato per l’acquisto dei materiali da costruzione.
Nel 1964 la salute però gli giocò un brutto tiro. Su consiglio dei superiori accettò di tornare in Italia, dopo ventisei anni di continuo servizio missionario, per riposarsi e sottoporsi ad alcuni controlli medici in quanto gli acciacchi di una vita spesa con dedizione e spirito di sacrifico si erano ormai accumulati. La notizia della sua imminente partenza fece subito il giro della missione, giungendo fino a Hyderabad, capitale dello stato dell’Andhra Pradesh.
Una risposta da saggioDopo tante battaglie e avventure, Pasquale era diventato un personaggio famoso e
conosciuto tanto che il ministro Hayagriva Ciari, avvertito dell’improvviso rimpatrio del missionario, spedì un suo collaboratore a Fatimanagar per organizzare una festa.
Alla cerimonia, oltre al ministro, parlarono anche i rappresentanti delle tre comunità islamica, induista e cristiana. Nei loro discorsi sottolinearono il genio pratico e creativo di Pasquale che, anche se aveva conseguito solo il diploma di terza elementare, aveva sempre manifestato un grande spirito di fratellanza verso ogni indiano con il quale aveva condiviso la vita, senza fare distinzioni. In quel clima di festa, di unità e di riconoscenza, tutti si auguravano di rivederlo presto di nuovo in India rigenerato nel fisico e nell’anima.
Alla domanda del ministro, vestito elegantemente sul palco degli oratori, su dove e come avesse imparato a fare i calcoli del cemento armato, il missionario rispose che mai nessuno gli aveva insegnato nulla in materia di ingegneria civile, ma lui si dilettava a farli
31

di notte, semplicemente perché c’era il silenzio adatto ad applicarsi senza paura di essere disturbato per qualche emergenza.
Qualunque fosse stata la risposta a quella domanda, era certo che la gioia della missione l’avesse ripagato di tutti i sacrifici, dell’obbedienza mostrata in ogni occasione e della rinuncia a vivere con la famiglia nel suo paese natale.
La cerimonia volgeva al termine, una luce obliqua e arancione illuminava la fronte dei partecipanti, il refrigerio della sera si posava sui loro corpi accaldati e nella mente di Pasquale prese forma un pensiero accompagnato da una visione.
Fratel Pasquale intuiva che non avrebbe fatto più ritorno nella sua cara India, infatti, a causa dell’aggravarsi della malattia, i medici e i superiori lo bloccarono in Italia, ma iniziò a pregare e sperare che, in futuro, altri giovani missionari laici, provenienti da altri Paesi, avrebbero scelto di lasciare tutto per continuare l’opera da lui intrapresa in India, come nuovi mattoni per una sola casa di tutti.
Fratello di tuttiIn quanto missionario laico sapeva che la sua opera doveva essere una testimonianza
della cultura della solidarietà, sempre al servizio dell’uomo, anche il più lontano, quello che con la sua povertà, la sua malattia o semplicemente la sua diversità culturale ci mette a disagio perché destabilizza le nostre sicurezze legate al nostro egoismo e al nostro benessere.
In bicicletta o a cavallo di una moto, in un cantiere aperto o circondato dalla tristezza di un filo spinato, Pasquale seppe condividere questo cammino di servizio e di amore con gli indiani, con lungimiranza, con umiltà e ben consapevole di avere in mano solo piccoli semi da sparpagliare nel terreno dello sconfinato progetto di Dio di edificare la pace tra gli uomini e le nazioni.
Il sogno di Pasquale si è avverato e vari altri missionari laici hanno continuato a lasciare la loro terra animati anche loro dall’ideale di “fraternità” che lui aveva realizzato con grande ingegnosità durante gli oltre ventisei anni di ininterrotta condivisione di vita con i popoli dell’India. Non solo, ma sull’esempio di Pasquale e di altri, anche alcuni giovani indiani hanno iniziato a lasciare la loro terra per andare a fare quello che avevano visto vivere dai missionari: il sogno di Pasquale continua a realizzarsi.
Fratel Pasquale Sala moriva a Rancio di Lecco il 9 febbraio 1977, e fu sepolto nel cimitero del PIME a Villa Grugana (LC).
Dal libro Apostoli nel quotidianoL'avventura straordinaria di sette missionari laici del PIME
4. GENIO E VANGELO
Davide Giani (1908-1983), nato a Milano, entrò nel PIME a 19 anni, munito di licenza artistica presso l’Accademia di Brera. Partì nel dicembre 1934 per l’India, dove morì nel 1983.
Come tante figure eccezionali, anche Davide Giani ebbe una vita travagliata. Ci sono infatti delle persone che fin dall’infanzia devono vivere con un’ombra sulla loro esistenza. Quando nacque a Milano il 18 novembre 1908, il padre naturale non lo riconobbe. Visse quindi nella sua nuova famiglia di adozione costruendo la propria personalità con un
32

carattere a volte scontroso e introverso, ma soprattutto desideroso di spazi e di libertà. Con il trascorrere degli anni le sue aspirazioni andavano verso nuove e più ampie realtà.
Architetto alla ricerca del cieloA Milano, ottenuta la licenza artistica presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera, si
distinse subito per estro ed eccellente tecnica. Tuttavia la passione per l’arte non fu sufficiente per distoglierlo da una profonda crisi spirituale, che iniziò a superare grazie al consiglio di un amico che lo incamminò verso alcuni incontri di meditazione e preghiera. Il disegno di Dio su di lui passava ancora una volta da un periodo buio.
Durante quei momenti di riflessione, si manifestò in lui assai prepotentemente il desiderio di andare in missione. Nel 1927 entrò nel PIME, dove accettò la mansione di tuttofare in tipografia, benché avesse una professionalità che lo avrebbe potuto gratificare molto di più. Concluso un biennio preparatorio, il suo servizio all’Istituto in Italia durò sette anni, dopodiché Davide, nel 1934, fu mandato in India, dove diventò ben presto direttore delle costruzioni della diocesi di Vijayawada. Cominciò per lui un lungo periodo in cui mise le sue capacità e competenze al servizio della sua nuova terra di adozione. Qui finalmente poté respirare con serenità e iniziare a studiare come coniugare la spiritualità indiana e cristiana con la tradizione e le nuove forme artistiche legate alla modernità. Non ebbe certo tempo da perdere, perché ben presto tutti si sarebbero rivolti a lui.
In India ci sono centinaia di santuari grandi e piccoli dedicati a Maria. Nell’estremo sud del Paese si può incontrare il santuario di Nostra Signora di Kuravilangad, risalente al III secolo dopo Cristo, circa cento anni prima che in Occidente l’imperatore Costantino concedesse ai cristiani la libertà di culto.
Allo stesso modo, nel santuario della Madonna di San Tommaso, posto su uno sperone di roccia nella pianura di Coromandel (Tamil Nadu), c’è un piccolo quadro di legno, attribuito a san Luca, raffigurante Maria: si ipotizza che si tratti dell’immagine più antica della Madonna e che sia stata portata in Oriente proprio dall’apostolo Tommaso.
Costruttore genialeFacendo un salto temporale di diciannove secoli si arriva a Gunadala, periferia di
Vijayawada, che da poco era divenuta diocesi. Su questa collina che domina la città Paolo Arlati, missionario del PIME, fece erigere nel 1924 un santuario per accogliere la statua della Madonna di Lourdes. E qui, oltre dieci anni dopo, arrivò Davide, missionario laico e architetto.
Fratel Davide cominciò ingrandendo la cattedrale, la casa del vescovo, quella delle suore, costruì inoltre una grande scuola, un ospedale con 300 letti e in seguito tutti e nove gli ospedali della diocesi di Vijayawada.
A causa della seconda guerra mondiale fu internato nel campo di concentramento di Deoli, come gli altri missionari, con il compito di lavorare nella dispensa, salvo la breve parentesi concessagli dagli inglesi perché andasse a completare l’ospedale di cui avevano bisogno. Tornato in libertà alla fine della guerra, si lanciò in nuovi progetti anche in altre diocesi, a Guntur, Vizagapatan, Calicut, Bangalore: collegi per gli studenti, noviziati per i gesuiti, chiese e cappelle. Nel 1950-52 venne la volta del complesso universitario dell’Andhra Loyola College di Gunadala. L’università statale dell’Andhra gli commissionò l’aula magna per trecento posti, poi l’Engeneer College, cinque residenze studentesche, il Politecnico, il salone per il cinema e il palazzo degli uffici.
Intanto in tutto il Paese infuriava la sanguinosa lotta tra musulmani e indù che portò alla divisone tra India e Pakistan. Vijayawada, città con molti musulmani, venne risparmiata dalla violenza fratricida grazie al clima di umana comprensione che si instaurò intorno alla statua della Madonna visitata in pellegrinaggio da tante persone delle due comunità.
33

Creare ponti di solidarietàIl lavoro di Davide era anche di attivare un ponte di solidarietà e convivenza tra le varie
fazioni. Il tempio di Tirupati dedicato a Shiva lo incaricò di costruire collegi, case per i professori, un teatro all’aperto e la Montessori School. Le Missionarie dell’Immacolata di Milano gli affidarono il progetto del loro noviziato, così come i protestanti uniti (luterani, battisti e chiese riformate dell’India) gli commissionarono il loro seminario, con annesse le case per gli aspiranti pastori.
Nei luoghi dove veniva chiamato costruiva non solo chiese e conventi ma anche sale per il cinema e il divertimento: alla fine dei suoi trentaquattro anni di missione in India aveva realizzato ben seicento opere.
Nel 1957 Davide fece sorgere la St. Joseph’s Missionary Brothers, una congregazione di fratelli laici indiani specializzati nell’insegnamento e nelle costruzioni. Questa sua piccola creazione gli consentì di penetrare più a fondo nella cultura popolare. Sul piano squisitamente tecnico introdusse il rivestimento in lastre di pietra, che fino ad allora servivano solo per i pavimenti, allo stesso tempo innovò esteticamente e funzionalmente sia i soffitti che i servizi igienici.
Le sue opere sono quasi tutte in stile moderno e caratterizzate da una varietà sorprendente, sia nell’insieme che nei singoli elementi, che rivela un’inesauribile vena creativa con la quale Davide riusciva ad amalgamare in modo mirabile semplicità, grazia e imponenza.
I pieni e i vuoti, i giochi d’ombra e di luce sono ammirevoli, mentre l’armonia delle parti, l’equilibrio del complesso e il senso della misura esprimono lo spirito di una India nuova, che iniziava ad aprirsi al mondo esterno. Davide non emulò nessun architetto famoso, seguì solo la sua genialità, le necessità dei committenti locali e le finanze, purtroppo sempre un po’ scarse.
Qualche volta per motivi nostalgici dovette echeggiare nelle linee del progetto la chiesa natale di alcuni benefattori italiani, che volevano in questo modo rendere visibile il loro amore e il loro contributo alla missione.
Per superare le divisioni socialiAnche sul piano sociale fratel Davide si inventò delle novità, infranse le regole delle
caste insegnando con infinita pazienza e maestria la professione a tutti, senza nessun pregiudizio. La maggior parte degli indiani convertiti al cristianesimo sono dei fuori casta e in quanto paria non potrebbero fare i muratori, ma solo i manovali.
Inoltre, malgrado l’introduzione di una legislazione più moderna, i paria venivano ugualmente relegati fuori dei luoghi sacri come imponeva l’antica tradizione. Per questo motivo, abbracciando il cristianesimo, essi desideravano una comunità religiosa nella quale si potevano sentire uguali agli altri. Pertanto il lavoro di Davide fu preziosissimo, in quanto diede una possibilità di riscatto ai tanti diseredati che conquistarono la loro dignità umana diventando lavoratori specializzati, e contemporaneamente regalò alla chiesa locale in continua crescita tanti luoghi dove celebrare e pregare.
Ne sono esempi la chiesa realizzata a croce per il lebbrosario di Eluru, la chiesa nella foresta sulle rive del grande fiume Godavary, la chiesa circolare che raccoglie le preghiere dei giovani studenti, cristiani e indù, del collegio universitario dei gesuiti a Vijayawada, la linearità e la leggerezza dell’edificio della parrocchia a Eluru, i lavori di fine architettura per completare con il granito il già ricordato santuario della Madonna di Lourdes sulle colline di Gunadala.
Fratel Davide costruì per tutti, cattolici, protestanti, indù e musulmani, in varie parti dell’India: cappelle, chiese, cattedrali, abitazioni di ogni grandezza, scuole, ospedali, lebbrosari, ambulatori, università, collegi, centri sociali.
34

Costruì persino il Parlamento per i deputati dello stato dell’Andhra e addirittura gli fu permesso di lavorare sulla collina sacra di Tirupati, vicino al tempio dedicato a Venkateswara (manifestazione di Vishnù) il cui perimetro era proibito ai paria e ai bianchi.
Davide era un fiume in piena, sempre disponibile e aperto a nuove sfide, la sua creatività e le sue doti umane gli consentirono di eludere barriere culturali che duravano da migliaia di anni nella mentalità popolare.
I sogni infrantiNonostante i successi conseguiti e il grande onore ricevuto nella società indiana, la sua
vita è macchiata da due piccole delusioni, due desideri che non riuscì a soddisfare, proprio lui che aveva letteralmente conquistato le vette più alte sul piano missionario.
Uno di questi sogni negati fu il mancato riconoscimento, mediante adozione, da parte del padre naturale, un uomo benestante che aveva sostenuto economicamente Davide durante gli studi e in missione ma che si rifiutò fino al giorno della morte di riconoscerlo come figlio legittimo.
L’altro suo piccolo tormento fu di non poter diventare sacerdote. Alle sue richieste di entrare in seminario, i superiori del PIME risposero sempre con giudizi negativi. Alla fine accettò serenamente di vedere per sé serrate le porte del sacerdozio, dopo l’ennesimo parere contrario proveniente dall’Italia.
Tuttavia in quell’occasione, ormai anziano e appagato per quello che aveva fatto in missione e secondo il suo carattere franco e incline alla dialettica risoluta e scevra di bizantinismi, approfittò per esprimere senza veli e censure il suo intimo pensiero.
Ne è testimonianza una sua lettera datata 9 giugno 1979, spedita da Gunadala e indirizzata al superiore generale (p. Fedele Giannini), che mette in rilievo lo straordinario desiderio del missionario di mettersi in gioco e di ricercare sempre nuovi obiettivi: “Rev.mo Padre, è da due settimane che ho qui sul tavolo la sua lettera del 1° maggio 1979 e speravo che venisse il monsone e così senza questa atmosfera a 48 gradi, all’ombra, avrei potuto rispondere senza tanto calore. Se le è dato di vedere mons. (Alfonso) Beretta, saprà da lui che non è una chiamata a 70 anni, perché sino dal ’40, ’50 e ’60 ho sempre cercato di rispondere alla chiamata del sacerdozio. Così pure può trovare nell’archivio (se sono ancora conservate) le mie lettere ai diversi superiori generali. Non sono così ignorante da credere che il sacerdozio sia dato come un cavalierato del lavoro, anzi per questo quando mons. Lourdhuswami mi ha promesso una onorificenza pontificia, io ho scosso le spalle ed ho rifiutato per non sentirmi dire dopo dal Signore che avevo già ricevuto la mia mercede. Ancora: se è pure vero che le mansioni nella casa del Padre sono molte, è pure vero che il Signore può chiamare all’undicesima ora e per di più non guarda alla miseria dell’individuo, anzi più questo sarà miserabile, più risplenderà la potenza di Dio. Non solo, ma secondo le nostre costituzioni e lo spirito di esse, noi siamo a disposizione delle nuove chiese indigene per integrare ed aiutare il loro lavoro e il PIME non è mai stato superato da nessuno in questa generosità. Ora se un vescovo, dove crede bene di chiamare un membro laico del PIME al sacerdozio per il bene maggiore della sua diocesi, non capisco perché ci deve essere un veto da parte di questa direzione, tanto più che la chiamata del vescovo è segno certo di vocazione e se il soggetto è stato fedele per quasi mezzo secolo al suo umile ruolo di fratello cooperatore, sarà fedele al suo ruolo di sacerdote per i pochi anni che gli restano a vivere. Sappia Rev.mo Padre che il (precedente) Superiore Generale mi ha assicurato che da parte sua era più che disposto al mio grande passo, ma mi ammoniva a non farmi illusioni perché sapeva quanto il Consiglio di Roma fosse contrario a questi passaggi di casta da paria a bramino. In quanto a me, Rev. Padre, Le assicuro che non sono rattristato, anzi mi sento libero di un pesante peso, poiché a 70 anni non è facile trovare il coraggio di cambiare vita ed una vita di santità quanta ne richiede il sacerdozio. Ma è pure vero che ormai mi sento stanco di
35

costruire le chiese e non la Chiesa. E sebbene ad ogni chiesetta cerco (secondo le finanze) di erigerla più bella che posso, non ci sarà mai un paragone della bellezza di un ‘Ego te absolvo a peccatis tuis…’ che trasforma un’anima nel più bel Tempio di Dio. Restituirò i libri di ‘Catholic Dogma and Moral Theology’ su cui ho sudato lo scorso anno e cercherò di mettermi il cuore in pace, tutto contento di essere ancora libero dalla grave responsabilità del sacerdozio…”.
Una fede sulla rocciaAgli inizi degli anni ’80 rientrò in Italia per essere operato di stenosi. Confessò agli amici
di non sentirsi più nel proprio ambiente, dopo tanti anni trascorsi all’estero, tuttavia i medici gli suggerirono di non tornare in India. Il superiore regionale dell’epoca, p. Domenico Vivenzi, scriveva: “Ciò che in fratel Giani risaltava con luce inconfondibile era l’amore per la sua missione, dove fu mandato 49 anni fa e dove volle morire ed essere sepolto”. Infatti il suggerimento dei medici fu disatteso, tanto che Davide non resistette al richiamo interiore della missione. Difatti ritornò a Vijayawada, dove in breve tempo si dovette arrendere alla malattia (5 maggio1983).
Volle rivedere per l’ultima volta la terra che lo aveva accolto e che lui contribuì a impreziosire e a far crescere con ingegno e dedizione. Una terra magica, Gunadala, dove per la festa della Madonna si danno appuntamento ogni anno decine di migliaia di persone. Per tradizione la statua è incoronata nel giorno della festa da un musulmano, mentre migliaia di fedeli di ogni religione si fanno tagliare i capelli, adempiendo il voto che avevano fatto di non tagliarseli se non dopo aver compiuto un pellegrinaggio.
La statua è posta in alto sulla collina e può essere raggiunta percorrendo due grandi scale. Per tre giorni pieni, con la luce e con il buio, si assiste a un continuo salire e scendere di devoti che vogliono toccare i piedi di Maria e che offrono fiori, incenso, candele e cibo.
Fratel Davide, che per tutta la vita spese il proprio talento per gli altri e che non ottenne mai dal padre il riconoscimento come proprio figlio, si fece seppellire in seno alla comunità che considerava la sua vera famiglia. L’India, in case cristiane e non, e persino nei templi indù, espone immagini della Madonna. Un bramino spiega con parole semplici l’origine di questa stupefacente devozione: “Il cristianesimo è amore e Maria è la madre anche di noi indiani”. Davide, uomo inquieto e un po’ brusco, ma anche artista e spirito libero, seppe vivere e accettare le contraddizioni numerose incontrate sul suo cammino. Con i mattoni e le pietre non costruì barriere, ma ponti e luoghi di preghiera comuni alle diverse comunità. Questo è il messaggio che ci viene trasmesso da una persona che pur soffrendo nel suo cuore seppe guardare verso il cielo. Le sue opere servono a ricordare che la bellezza e l’utilità di queste costruzioni sono fondamentali e schiette declinazioni di quell’amore che con una mano sembra togliere e che invece con l’altra dona generosamente e unisce tutti gli uomini.
36

Dal libro Apostoli nel quotidianoL'avventura straordinaria di sette missionari laici del PIME
5. UNA VITA LUNGO IL FIUME
Francesco Galliani (1925-1997), superati gravi problemi di salute, partì per la missione del PIME a Parintins (in Amazzonia) alla fine del 1956, e vi si prodigò per oltre 40 anni. Era originario di Roccafranca (Brescia).
Francesco sapeva già dal mese di giugno che sarebbe partito per la missione dell’Amazonas, in Brasile. In una lettera a un amico confessa: “Scrivo la presente con l’animo pieno di esaltazione e di riconoscenza verso il Signore che nella sua bontà si è degnato di concedermi la tanto sospirata grazia di essere destinato per la missione. Qui in Italia ho cercato di imparare il mestiere del falegname, spero possa essere utile alla missione alla quale sono stato destinato”.
La partenza sembrava non arrivasse mai, in quanto durante la preparazione Francesco Galliani, nato a Roccafranca (Brescia) nel 1925, aveva avuto seri problemi di salute, artrosi e disturbi del sonno. Con il tempo e le cure appropriate gli impedimenti iniziali furono superati e nel settembre del 1956 fratel Francesco partì in nave per il Brasile.
Quando arrivò a Rio de Janeiro era un giorno nuvoloso, con una caligine fitta che impediva di vedere la bellezza della città, compreso il famoso Cristo redentore che accoglie con le braccia aperte chi sbarca in terra brasiliana. Il missionario faceva parte di un gruppo di dodici persone tra padri e fratelli.
Ad attenderli al porto c’erano i responsabili regionali del PIME, uno dei quali venne ricoverato d’urgenza proprio in quei giorni per un problema al pancreas. Francesco lo assistette in ospedale per venti giorni, durante i quali gli infermieri si sbellicavano dalle risate sentendolo imitare in un portoghese maccheronico le richieste che gli faceva il padre malato sul letto della degenza.
Tra una risata e le nuove amicizie che nacquero lungo le corsie dell’ospedale, l’emergenza al pancreas rientrò, così fratel Francesco poté continuare il viaggio fino a Parintins, la sede della sua missione, dove arrivò pochi giorni prima di Natale.
A differenza delle zone costiere, che per tradizione hanno avuto intensi rapporti con il resto del mondo per via di una fitta e consolidata rete di scambi commerciali, Parintins si trova nel cuore della regione amazzonica, sulle rive del Rio delle Amazzoni, geograficamente e culturalmente separata dalla cosiddetta civiltà moderna, piccolo centro che all’epoca dell’arrivo di Francesco contava cinquemila abitanti, con le case quasi tutte di legno o di paglia.
Iniziò lo studio della lingua, che perfezionò stando a contatto con la gente, soprattutto con i muratori. Mise in piedi una falegnameria rudimentale nella quale fece le porte e le finestre nuove per la residenza dei missionari. Intervallò questa attività con l’insegnamento della cucina italiana alla gioiosa cuoca brasiliana: insomma si diede da fare per bruciare i tempi di inserimento.
La missione affidata ai missionari del PIME esisteva già da sette anni, era stata fondata nel 1948, e si basava prevalentemente su un servizio umanitario e spirituale fra gli indios e i poveri caboclos, i meticci nati dalla mescolanza dei bianchi con le popolazioni indigene. I missionari partivano dalla loro residenza e visitavano i villaggi affastellati lungo il corso del fiume che penetra maestosamente la foresta, con lo scopo di ascoltare e apprendere le lingue locali e poi formare le prime comunità cristiane che si facevano carico dei problemi sociali ed educativi.
37

Impegnato nel socialeIniziava in quel periodo un profondo e lungo processo di vita comunitaria e di
coscientizzazione che avrebbe successivamente costituito un argine solido contro l’ingordigia delle grandi aziende, che a mano a mano si stavano spartendo il polmone verde del mondo, sempre più agguerrite per lo sfruttamento indiscriminato delle risorse dell’Amazzonia.
Furono gettate le premesse per la creazione di cooperative, di sindacati rurali e di scuole di alfabetizzazione che unirono la gente nella rivendicazione e poi nella difesa dei propri diritti. Contrariamente a ciò che accadde in altre parti del Brasile, dove l’annosa questione del possesso della terra si acuì in uno scontro cruento, a Parintins gli zelanti avvocati del grande capitale, difesi da sgherri mercenari, trovarono la popolazione già organizzata con in mano i contratti di proprietà e la guardia ben alta a proteggersi da manovre fuorilegge
A Parintins si era realizzata sin dagli anni ’50 una pastorale di formazione dei laici all’apostolato, attraverso le “Congregazioni mariane” e le “Signore dell’apostolato della preghiera”, che mandavano i laici nei villaggi a svegliare la coscienza del popolo e a preparare le fondamenta delle comunità di base, la risposta cristiana alla speculazione che minacciava tutta la regione.
Francesco divenne protagonista di questa storia di liberazione e di giustizia, nella quale il Vangelo si impastò inevitabilmente con la rabbia e l’ansia di riscatto di una popolazione da secoli irrisa e calpestata dagli interessi legati al denaro. Fu una sorta di lotta di Davide contro Golia, una vera epopea missionaria, che fece della diocesi di Parintins un luogo di partecipazione e di battaglia civile contro la prepotenza dei ricchi e gli abusi di potere.
Tra gli indios del Rio delle AmazzoniFinito il periodo di adattamento, il superiore regionale mandò Francesco tra gli indios
del Marao, insieme a padre Iseo, anche lui un missionario del PIME italiano. L’area indigena alla quale furono destinati era vasta e contava quasi cinquanta villaggi spersi nella foresta e lungo le ramificazioni del grande fiume. Scelsero un luogo e vi costruirono la loro casa completamente di paglia, con la quale conquistarono subito la simpatia degli indigeni perché aveva porte, finestre e divisioni interne che loro non avevano mai visto.
Successivamente costruirono una scuola che utilizzarono anche come cappella. Padre Iseo dava lezioni basandosi sul programma delle elementari e celebrava la messa, mentre Francesco insegnava agricoltura, culinaria, orticoltura e catechismo. Si occupava anche di un piccolo laboratorio che avevano costruito per impartire medicazioni e distribuire medicinali.
L’obiettivo della loro presenza tra gli indios era anche di mitigare l’influenza dei protestanti che si approfittavano dell’ignoranza delle tribù nello scambio delle merci. Una sera si presentò da Francesco un indio che, sapendo che lui doveva recarsi al mercato di Mauès, gli portò delle pelli da vendere, perché con il ricavato comprasse dei prodotti di prima necessità.
Al ritorno il missionario gli diede riso, zucchero, caffè e alcune padelle. L’indio, che non era molto avvezzo al commercio, chiese come avrebbe potuto pagare tutta quella roba e Francesco gli rispose che non doveva sborsare nulla, perché tutto era stato già pagato con il ricavato della vendita delle sue pelli.
La voce di quel guadagno miracoloso passò di villaggio in villaggio e nel giro di pochi giorni molti indios si recarono da Francesco a chiedere di vendere i loro prodotti. Fu allora che lui organizzò una specie di cooperativa: caricava i manufatti su un barcone a motore e con alcuni indigeni andava in città a venderli.
La cooperativa andò avanti per i primi tempi con il suo aiuto, in seguito divenne un’organizzazione autonoma in mano agli abitanti dei villaggi. Contro questa impresa
38

commerciale, che conferiva per la prima volta agli indios potere decisionale sulle loro risorse, non mancarono i delatori, e vi fu chi tentò di mettere il bastone tra le ruote al missionario: alcuni trafficanti lo denunciarono al tribunale, che per fortuna non diede mai credito a tali accuse, per sfruttamento degli indios, e altri lo minacciarono di morte, in quanto aveva osato intromettersi nei loro loschi affari.
L’attenzione ai sofferentiDopo tre anni trascorsi nel Marao, Francesco fece ritorno a Parintins, dove c’era
bisogno di tutto, soprattutto in campo sanitario. C’era un ospedale nuovo con trenta letti e una sala operatoria completa, ma mestamente chiuso per mancanza di medici e infermieri. Funzionava una piccola farmacia, gestita da una certa Dona Nena, che vendeva un po’ di medicinali che riusciva a racimolare qua e là. Inoltre faceva qualche medicazione o iniezione e se qualcuno si feriva lo ricuciva lei alla bell’e meglio.
Il primo aiuto lo diedero i missionari del PIME, che fecero arrivare medicinali, latte in polvere per i bambini e una grande quantità di vitamine. Istituirono anche un corso di igiene e di infermieristica al quale partecipavano ragazze e signore desiderose di imparare. Anche fratel Francesco fu tra quelli che diedero vita a questi corsi. Avevano portato dall’Italia manuali e dispense, fatto venire altresì strumenti per piccoli interventi, mostrando durante le lezioni quello che avevano imparato alla Scuola di medicina per missionari di Milano.
I primi ambulatori furono le barche a motore dei missionari, vere case itineranti. Con i missionari collaboravano un anziano medico giapponese e soprattutto Valdir, un indio che poteva essere definito una via di mezzo tra uno stregone e un erborista.
Per i casi più complicati, come ricorda lo stesso Francesco: “C’era solo il buon Dio”. In quel tempo la gente in Brasile moriva anche di lebbra. Quasi definitivamente scomparsa in Europa, in Brasile mieteva ancora vittime dal XVI secolo, quando fu portata dalla colonizzazione portoghese. I lebbrosi erano scacciati da tutti, perché erano considerati un pericolo pubblico, buttati fuori dalle famiglie e dai villaggi. Con questi “esclusi dal mondo e dagli uomini” Francesco stava per iniziare un cammino difficile, ma anche meraviglioso, che avrebbe dato una svolta alla sua vita.
In guerra contro la paura e l’indifferenzaUn giorno un collaboratore di Francesco gli disse che nel fiume c’era una canoa arenata
sulla riva e sopra di essa un vecchietto che sembrava morto. Il missionario mandò il suo amico a prenderlo ma quello tornò spaventato: “No, non lo tocco, è un lebbroso”.
Francesco si fece coraggio, poiché la lebbra intimoriva anche lui, ma prese lo stesso in braccio quel vecchio e se lo portò nella residenza della missione, dove lo pulì, lo nutrì e lo mise a letto. Quel lebbroso era stato messo in una canoa e spinto nel fiume dalla sua stessa famiglia, che voleva mandarlo a morire nelle rapide del Rio delle Amazzoni.
All’inizio però non fu facile ospitare un lebbroso, in quanto se la notizia si fosse diffusa per i villaggi nessuno sarebbe più andato alla missione. Allora Francesco gli costruì una capanna nella foresta, dove andava ogni giorno a portargli da mangiare e a curarlo: da quel giorno vennero altri lebbrosi e il missionario che era venuto in Brasile come falegname divenne il loro vero e unico aiuto.
“Nel momento in cui decisi di assistere il malato del fiume era come se andassi incontro a una nuova chiamata del Signore”, diceva Francesco quando gli domandavano del suo servizio a favore dei lebbrosi. Innanzitutto si recò in Spagna per un corso specialistico di tre mesi, poi ingrandì quella semplice capanna, trasformandola in un luogo più adatto ad ospitare i malati, dandogli il nome di “Isola della Pace”, dove a causa delle modeste dimensioni poteva in un primo momento accogliere solo sei o sette persone. Il lavoro
39

principale consisteva nel visitare a domicilio i pazienti, cercare nuovi casi e portare medicinali alle persone già schedate nelle rispettive unità sanitarie.
Un giorno uno dei ricoverati dell’Isola della Pace aveva bisogno di fare esami e cure per un disturbo al cuore. Francesco andò all’ospedale governativo a chiedere assistenza per quell’uomo, ma i dottori gli risposero che non era possibile, poiché loro non accettavano lebbrosi. Il missionario quindi prese in braccio quel corpo deturpato dalle piaghe e lo portò sulla soglia dell’ospedale, attraversando a piedi la città perché tutti lo vedessero.
Poi entrò, appoggiò il malato sopra il primo letto libero e ai medici e agli infermieri che gli si erano accalcati intorno disse gridando: “Quest’uomo è brasiliano, ha diritto come gli altri ammalati di essere curato”. Il primario accorse subito e per placare l’ira di Francesco gli concesse di lasciare il malato in una stanza singola e lo autorizzò a venire tutti i giorni: “Qui nessuno vuole prendersi cura di questo lebbroso. Venga lei, gli dia da mangiare, lo curi e noi le insegneremo come fare”. Cominciava così la sua battaglia contro l’emarginazione e la paura, a favore dei lebbrosi e di tutti quelli che, come loro, venivano esclusi. Sapeva che il cammino che stava per iniziare avrebbe messo anche lui dalla parte di chi non conta niente per la società. Ma il suo animo era pronto ad affrontare con volontà e coerenza di vita un percorso che percorrerà fino alla fine dei suoi giorni a Parintins.
Francesco andò quindi in ospedale tutti i giorni, due volte al giorno, per circa tre mesi. Tuttavia non poté impedire la degenerazione della malattia, arrivata ormai ad una fase troppo avanzata. Al momento della morte di quell’uomo era presente anche il primario, che si commosse vedendo la mano del moribondo cercare in un estremo segno di amicizia quella del missionario: “Fratel Francesco, lei ha vinto la sua battaglia e ha rotto le barriere che ci dividevano dai lebbrosi. Il nostro ospedale prima non li accoglieva. D’ora in avanti può portare tutti i lebbrosi che vuole, li curiamo noi”.
La mano della ProvvidenzaQuella prima battaglia era stata vinta ma non la guerra contro il pregiudizio. Quando si
iniziò a costruire un ricovero più grande, la gente venne a sapere che era un’opera destinata ai lebbrosi e logicamente ebbe paura. Così non solo il terreno si svalutò, ma fu anche abbandonato dagli abitanti presi dal panico. Il PIME, invece, decise di sostenere il progetto, acquistare il terreno e di avviare i lavori di costruzione. Francesco si diede da fare per ottenere le risorse economiche necessarie a quest’opera di carità, ma gli aiuti non giunsero con la rapidità che ci si aspettava. Inevitabilmente i lavori subirono dei rallentamenti, in quanto i finanziamenti arrivavano a singhiozzo. Tuttavia la sua fede nella Provvidenza e nella bontà di questo servizio agli ultimi non venne mai meno. Sapeva che non stava combattendo per un suo progetto personale e quindi “Dio avrebbe fatto la sua parte”.
Mentre Francesco stava lavorando all’ampliamento dell’Isola della Pace, veniva sovente il superiore regionale a dirgli: “Fratello, ferma i lavori, perché siamo andati in rosso. Riprenderemo quando arriveranno altre offerte”. I giorni successivi il missionario e i lebbrosi pregavano affinché la situazione si sbloccasse e, con un tempismo incredibile, dopo poco tempo il superiore ritornava dicendo: “Adesso vai pure avanti, è arrivata la Provvidenza”.
Comunque, in mezzo a continui rinvii e successive riprese, l’Isola della Pace si trasformò da semplice rifugio in un ambulatorio degno di questo nome, una risposta convincente alla mancanza cronica di assistenza sanitaria tra queste popolazioni amazzoniche.
Alla fine degli anni ’60 la missione di Parintins poteva considerarsi una tra le più attive nel lavoro pastorale e sociale, attraverso il quale la realtà di sottosviluppo venne per la prima volta concretamente attaccata. Un ostacolo all’opera di evangelizzazione e di promozione umana era rappresentato però dalle distanze. Le varie comunità si trovavano
40

molto lontane tra loro e un missionario, anche se avesse rispettato puntualmente la tabella di marcia e non ci fossero stati contrattempi, avrebbe potuto visitarle al massimo quattro volte l’anno.
Sulle onde del Rio e della radioPoiché nessun missionario poteva permettersi di avere contatti regolari con le comunità
disseminate sul territorio, la formazione di operatori pastorali laici sul posto divenne una priorità. Uno strumento formativo importante fu radio Alvorada (Aurora), che nel 1967 iniziò a trasmettere dalle sei del mattino alle dieci di sera programmi educativi ascoltati in ogni parte dell’Amazzonia: insegnamento dell’agricoltura, lezioni sull’organizzazione di comunità, catechesi, sindacalismo rurale, alfabetizzazione per ragazzi e adulti, ed anche informazione e formazione igienico-sanitaria utili per raggiungere tutte quelle zone che erano troppo isolate per poter usufruire del servizio sanitario itinerante di Francesco.
All’inizio degli anni ’70 partì il progetto di fondare colonie agricole sulle “terre alte”, nel tentativo di convincere i caboclos ad abbandonare il fiume, almeno come luogo di abitazione e come sistema di vita. Le “terre alte” sono al sicuro dalla piena delle acque, invece le “terre basse” lungo i fiumi, su cui i caboclos vivevano dediti alla pesca e alla coltivazione della juta (una pianta dalla cui macerazione si ricava una fibra tessile), erano periodicamente inondate.
Un esperimento esemplare: agricoltura ed educazioneNel 1973 le colonie agricole erano 37, con circa 10.000 caboclos coinvolti nel progetto.
Ogni colonia era formata da 20 a 40 famiglie, che vivevano in case costruite l’una accanto all’altra, secondo una pianta circolare, con al centro la piazza. Ogni famiglia riceveva due ettari di terreno per la coltivazione di prodotti ad uso privato (miglio, fagioli, manioca, frutta, verdura), mentre il resto del terreno era sotto la giurisdizione del consiglio della comunità e veniva coltivato comunitariamente con prodotti per l’esportazione: guaranà (bacche per bevande rinfrescanti), seringa (albero della gomma), riso e aranceti.
L’esperienza delle colonie agricole fu una vera rivoluzione nella storia dell’Amazzonia, in quanto per la prima volta i caboclos divennero responsabili del loro lavoro e i veri artefici del loro futuro.
Durante l’organizzazione del progetto, Francesco si trovò a Urucarà, un villaggio situato nelle “terre alte”, quando il governatore di Manaus, capitale dell’Amazzonia, venne a visitare le colonie. Il politico rimase stupito di come i missionari stavano operando: “Viene un padre dall’Italia, mantiene la gente legata alla propria terra, fa la scuola agricola, convince le famiglie a spostarsi nell’interno, insegna ai giovani l’agricoltura, educa ragazzi e ragazze. Noi abbiamo Manaus che scoppia di gente che viene dall’interno e non siamo capaci di farla restare nei villaggi”.
Francesco che era lì vicino gli disse: “Scusi, ma perché non fate anche voi queste colonie e queste scuole agricole? Date a questi caboclos la proprietà della terra, l’assistenza sanitaria, la scuola, i trasporti, l’assistenza tecnica per coltivare la terra ed essi vi seguiranno”. Il governatore lo guardò e gli sussurrò in un orecchio: “Non è facile, non è facile”.
Malgrado un potere politico generalmente cieco e sordo nei confronti delle esigenze delle classi sociali più deboli, la missione tra le popolazioni dell’Amazzonia, nonostante le difficoltà oggettive dell’ambiente e quelle soggettive delle persone che vi erano impegnate, proseguiva dando anche buoni frutti. E Francesco si distinse sempre come instancabile lavoratore, impegnato a realizzare quello che ormai considerava lo “scopo della sua vita: occuparsi dei lebbrosi e degli emarginati”.
41

Le ore buie dell’incomprensioneTale determinazione portò anche a inevitabili tensioni e incomprensioni all’interno della
realtà missionaria ed ecclesiale. Come ogni grande meta che si rispetti il cammino per raggiungerla porta sempre una parte di fatica e dolore. Anche per Francesco era arrivata quest’ora buia di solitudine.
Nel 1970 partì da Roma una lettera con destinazione Amazzonia, nella quale i superiori dell’istituto chiedevano a fratel Francesco di spiegare il motivo per il quale si era ostinato a rimanere a Parintins nonostante avesse ricevuto l’ordine di rientrare in Italia. Bisogna sapere che in quegli anni erano nate, su iniziativa della diocesi, diverse attività di formazione professionale per la gioventù. Per seguire tutte queste attività i missionari si erano fatti aiutare da alcuni volontari cristiani inviati da organismi di volontariato che si stavano sviluppando con grande rapidità in Italia. Era un’iniziativa all’avanguardia e quindi incontrò solo pareri favorevoli. Le attività andarono avanti per anni, avviando anche una collaborazione tra volontari e missionari laici, entrambi dedicati a testimoniare il Vangelo con la loro vita e il loro lavoro. Francesco si trovò quindi coinvolto in questa evoluzione del metodo di lavoro missionario, e non sempre fu facile capire e farsi capire.
Rispondendo alla lettera giunta da Roma, Francesco si discolpò dicendo che i suoi superiori del Brasile gli avevano assicurato che avrebbero risolto la questione e invece non l’avevano fatto, forse per mancanza di tempo, visto che in missione gli impegni erano sempre tanti e l’Italia troppo lontana.
Al di là del disguido, in quella occasione egli raccontò per la prima volta che il suo servizio principale consisteva nell’amministrazione delle officine e della fabbrica di mattoni, ma non disse nulla del lebbrosario che aveva inaugurato.
Forse influenzato dai tempi, visto che erano gli anni successivi al Concilio Vaticano II, anni quindi di fermento e di confronto, si permise di enucleare al superiore generale il suo pensiero in modo da poter assicurare la continuità della missione: “Voglio fare una proposta. Lei conosce bene la situazione dei laici volontari, non durerà molto tempo. Le officine: tipografie, elettrotecnica, meccanica e falegnameria sono attrezzatissime, basta sostituire ai laici volontari i fratelli. Sarebbe una buona opportunità per formare la comunità dei fratelli, avendo tutte le possibilità per fare ciò: c’è una casa con sette stanze, lavoro in officina, apostolato in città, o nelle comunità nell’interno: Villa Amazona, Macurany, Aninga, Parananema. Tutto dipende dal vescovo, ma sembra che anche lui sia del parere e che l’esperienza dei laici abbia insegnato a tutti molte cose”. La posizione di Francesco, pur comprensibile, non ricevette l’appoggio della maggioranza della comunità missionaria, e quindi per lui furono anni di amarezza e purificazione. La vita in missione non riserva solo successi, ma anche delusioni, e, come solevano dire i missionari con decenni di lavoro sulle spalle, “non c’è rosa senza spine”.
Da quella lettera un po’ sgrammaticata, condizionata dalla lunga permanenza in Amazzonia, passarono altri quattro anni, poi Francesco dovette ritornare in Italia
Giunto a casa, fremeva per ripartire e con la scusa che gli scadeva il visto fece ritorno in Brasile con l’intenzione di rimanervi. Questo benevolo sotterfugio prese un po’ alla sprovvista i suoi superiori, che fecero buon viso a cattiva sorte e accettarono la sua volontà di riprendere a lavorare nella missione di Parintins.
Dalla parte dei lebbrosiAl suo rientro in missione nel 1976 si mise subito a lavorare in modo quasi esclusivo per
rafforzare l’ambulatorio. Intanto il governo federale approvò la sua opera e gli concesse anche l’autorizzazione a esercitare a norma di legge nel campo sanitario: della lebbra si continuava a sapere poco o nulla e le istituzioni pubbliche continuavano ad essere refrattarie a trattare la malattia. Francesco, dopo anni di incomprensioni, cominciava a
42

raccogliere qualche frutto della sua scelta di servizio per i lebbrosi. D’altra parte la sua intraprendenza sapeva avvalersi delle risorse che la Provvidenza gli offriva.
Alla fine degli anni ’70 un giovane padre appena arrivato in Brasile morì accidentalmente. Colpito da quella improvvisa dipartita, Francesco volle intitolare la sua attività a quel missionario sfortunato. Nacque così la casa “Padre Vittorio Giurin”, che nei primi anni ’80 si occupava dell’assistenza costante di 30 lebbrosi e di alcune centinaia di persone, sparse per il distretto missionario, affette da svariate patologie.
Per dare sempre nuova energia alla sua opera, Francesco si doveva destreggiare tra mille difficoltà per trovare i soldi necessari per un microscopio decente o per attrezzature di fisioterapia. Così si moltiplicarono le lettere d’aiuto che spediva in Italia per sensibilizzare sulla sua attività e ricevere finanziamenti. Anche il numero delle carrozzelle non bastava mai e perciò, in modo quasi spietato, date le condizioni generali, era costretto ad aspettare la morte di qualche paziente per recuperarne qualcuna.
Il declino del guerrieroAd ogni modo, nonostante i numerosi ostacoli, il lavoro proseguì senza sosta ancora
per parecchi anni, ogni giorno coordinato dal missionario. Però con il 1996 iniziò drammaticamente il declino fisico di Francesco, anche se il suo rude temperamento, che lo contraddistingueva, gli diede la tenacia di sostenere in silenzio il dolore
I medici diagnosticarono una cirrosi epatica, conseguenza di un’epatite divenuta cronica a causa di un trattamento inadeguato. Insorsero dunque delle complicazioni dovute a insufficienza cardiaca e a un versamento di liquido nell’addome. I suoi collaboratori cercarono con molta discrezione, per non urtare la sua sensibilità, di accompagnarlo e di alleviargli le sofferenze.
Nel 1997 la situazione clinica si compromise e si decise di farlo tornare in Italia per tentare nuovi rimedi. Il 12 ottobre, festa di Nostra Signora di Nazarè, patrona della comunità cristiana vicina, in occasione dell’imminente partenza di Francesco per l’Italia, la processione sfilò davanti alla casa Padre Vittorio per porgere l’ultimo saluto a chi si era sempre prodigato per la salute degli abitanti di Parintins.
Fu al contempo terribile ed emozionante vedere il missionario affacciato alla finestra, che a stento si reggeva in piedi e che, commosso, riuscì a dire un semplice “obrigado, grazie”, mezzo soffocato dalle lacrime e dal magone che gli serrava la gola.
L’uomo, scontroso e per niente gentile, che aveva sofferto e che aveva consumato la sua vita in quel luogo sperduto del
Stava lasciando tutto per partire nuovamente, ma questa volta ciò che lasciava era la vita intera trascorsa in mezzo al popolo dell’Amazzonia, 41 anni di missione. Alla processione parteciparono anche gli indios del Marao, che ogni anno, da quarant’anni, gli portavano un sacco di arance dicendogli: “Questo è il frutto delle piante che hai piantato per noi”.
La sua opera continuaFrancesco morì il 25 ottobre 1997, dopo un ultimo e disperato ricovero in Italia. Ma la
sua opera continua con la presenza di missionari laici del PIME che, proprio per continuare lo spirito del “suo fondatore”, hanno ristrutturato gli edifici e sviluppato le attività sanitarie. Attualmente la Casa Padre Vittorio, infatti, attende oltre ai lebbrosi anche ai malati di AIDS che sono ormai considerati i “lebbrosi del nuovo millennio”.
Quella che era nata come una fragile e improvvisata baracca è ormai diventata una piccola ma moderna struttura ospedaliera, con una sala operatoria, un laboratorio analisi e un centro fisioterapico. Ogni giorno un centinaio di persone vengono curate, ed è garantita anche l’assistenza domiciliare. Una volta all’anno viene organizzato un corso sulla lebbra della durata di un mese, al quale partecipano infermieri, paramedici, fisioterapisti e medici
43

da tutta l’Amazzonia. Da sottolineare la prevenzione e la cura dell’AIDS che si sta promuovendo e sviluppando gradualmente sul territorio regionale. Infine, proprio seguendo l’intuizione di fratel Francesco, che circa quarant’anni prima volle costruire un laboratorio di analisi cliniche a Parintins, la sua opera è diventata la sede dove vengono promossi e organizzati corsi per tecnici di laboratorio di analisi.
Forse questi momenti formativi sono il segno più tangibile e prezioso dell’eredità di Francesco, che quel giorno presso il fiume non ebbe paura di abbracciare il lebbroso abbandonato sulla canoa, dando vita a una missione che davvero trasformò gli uomini. E su una facciata esterna della Casa, scritte su piastrelle colorate che luccicano tra l’ombra tranquilla e la luce soffusa, ci sono ancora le sue parole: “Amare tutti, specialmente i nostri nemici, i poveri, gli ammalati e gli emarginati”.
Dal libro Apostoli nel quotidianoL'avventura straordinaria di sette missionari laici del PIME
6. DALLE SCARPE AI PENNELLIMichele De Pascale (1917-2010), originario di Avellino ed entrato nel PIME a 19 anni, nel 1952 fu assegnato all’Amazzonia, dove servì la causa missionaria per oltre 30 anni.
L’artista delle scarpePadre Gerardo Brambilla, anziano missionario con una certa esperienza di uomini,
guardava con meraviglia, mista ad un pizzico di perplessità, quel giovanotto mingherlino proveniente da un orfanotrofio di Avellino che aveva fatto venti ore di treno in 3a classe per venire a Milano alla sede del PIME. Infatti qualche settimana prima Michele De Pascale aveva risposto con rapidità alla lettera inviata dal Missionario; e alla domanda: “Quale mestiere conosci?”, aveva scritto: “Sono un artista delle scarpe”, intendendo con un po’ di enfasi che faceva il ciabattino.
Un inizio pittorescoD’altra parte Michele non sembrava volesse fare il gradasso, e, dalle poche parole che
era riuscito a scambiare, sembrava pure simpatico. Dato che aveva fatto un lungo viaggio, di oltre 800 chilometri, e continuava a ripetere di voler diventare “fratello” missionario laico, tanto valeva metterlo subito alla prova.
Era il 1936 quando il diciannovenne Michele De Pascale fu accettato ed iniziò il cammino verso quella missione che sognava da adolescente. Non sapeva ancora che altre circostanze particolari avrebbero ritardato la sua partenza, ma lui era ormai sicuro di aver preso la strada giusta.
A quei tempi una buona parte della formazione consisteva non solo nell’apprendere e migliorare la spiritualità missionaria e comunitaria, ma nel saper mettere a servizio della comunità le proprie competenze professionali. Dato che era un “artista delle scarpe” il superiore fu ben felice di aver trovato una soluzione alla riparazione delle calzature di tutti i 70 seminaristi, 40 padri e 40 fratelli che componevano la “comunità allargata” della Casa Madre del PIME di via Monte Rosa a Milano.
Facendo un semplice calcolo Michele aveva circa 300 paia di scarpe da sorvegliare, e quindi ogni settimana attraversava il cortile con una carriola piena di scarpe rotte che, qualche giorno dopo, riconsegnava riparate e lucidate ai “suoi clienti”. Bisogna dire che in
44

qualche mese il superiore si rese conto che Michele il lavoro lo sapeva fare bene, e lo faceva pure in fretta e con allegria.
Aveva anche cominciato a capire che questo giovanotto non era un ingenuo o uno sprovveduto, ma il suo atteggiamento era frutto di una ricerca di servizio umile, nascosto, “all’ultimo posto”. Questa serena umiltà, assieme alla genialità “napoletana”, sono sempre state le caratteristiche della lunga storia di Michele.
La scoperta della sua stradaNato nel 1917, essendo orfano di padre aveva trascorso tutta la sua infanzia presso un
orfanotrofio di Avellino gestito da una congregazione religiosa. Dopo aver frequentato le scuole elementari venne messo “a bottega” da un artigiano calzolaio. La sua vocazione iniziò quando a 17 anni incontrò un frate questuante, uno di quei religiosi che ancora giravano di casa in casa per chiedere l’elemosina per i bisogni dei poveri e del convento.
Era un fraticello con tanto di saio e bisaccia, che trasmetteva serenità e pace. Michele ne fu subito attratto: “Padre, io vorrei fare come voi che girate per tutti i paesi e siete sempre sereno e contento”. Con uno sguardo benevolo il fraticello gli rispose: “Non sono un prete, ma un semplice fratello questuante”. Questa risposta stupì Michele, che non riusciva a capire questa distinzione a lui finora sconosciuta: “Se uno aveva una veste o il saio da frate doveva per forza celebrare messa”.
Continuò quindi a fare altre domande fino a quando capì: per aiutare gli altri non era necessario aver studiato tanto e diventare sacerdote, ma era indispensabile avere la pace nel cuore e vivere con semplicità il Vangelo. Si era aperto un nuovo cammino praticabile per lui, quello di camminare a fianco delle persone che, come lui stesso, avevano ricevuto poco o niente dalla vita, ma quel poco volevano metterlo a disposizione degli altri.
Questa convinzione lo portò a ricercare la strada più valida per realizzare questo desiderio che ormai non lo lasciava più tranquillo. La prima tappa lo portò appunto da Avellino a Milano, dai missionari del PIME.
Il bernoccolo della pitturaPur non avendo avuto l’occasione di studiare molto, Michele era un ragazzo che amava
conoscere e capire il mondo nelle sue diverse espressioni. Le scarpe erano il suo mondo, ma a lui piaceva guardare il cielo, i paesaggi e i volti delle persone. Era anche affascinato dai grandi quadri che vedeva nelle chiese. Si domandava spesso come avevano potuto degli uomini normali fare degli affreschi così belli e complicati.
Finalmente decise di confidarsi con il superiore che lo aveva accolto a Milano e gli chiese di aiutarlo a capire queste cose più grandi di lui. Il padre, non sapendo bene come rispondere, ebbe l’eccellente intuizione di mostrare a Michele alcuni libri della biblioteca che spiegavano la storia e le opere di alcuni grandi pittori italiani del Rinascimento.
Da quel giorno, quando aveva un po’ di tempo libero, Michele andava a rifugiarsi nella biblioteca per leggere e capire la pittura e la scultura. Ma questo non gli bastava, voleva anche lui disegnare. Iniziò a riprodurre questi capolavori su fogli di carta. Chiese quindi consiglio al superiore, che lo autorizzò a sviluppare questo suo desiderio, che, gli spiegò, poteva essere anche un dono di natura.
Mise però due condizioni: di non tralasciare di riparare le scarpe, e di andare ad imparare da chi ne sapesse qualcosa in più di lui. A Michele non sembrava vero, e scoppiò in un pianto di gioia. In segno di riconoscenza, si mise in ginocchio davanti al saggio missionario che lo lasciò sfogare e gli fece infine promettere di impegnarsi con costanza, pazienza e serietà: “perché questo è il segreto di un buon missionario”.
Queste parole non lo lasciarono mai più e divennero il suo ritornello quando, molti anni più tardi, divenne lui stesso un “maestro” per gli altri.
45

Intanto in Italia arrivò la guerra e Michele, ormai diventato fratello missionario laico nel PIME, non poté partire subito per le missioni e fu assegnato a diverse mansioni di servizio presso le case missionarie in Italia. Ma non fu tempo perso per lui che seppe migliorare, pur sempre come autodidatta, le sue capacità artistiche, senza tralasciare la “nobile professione di calzolaio”, come amava chiamarla.
A fianco di un grande missionario: p. Paolo MannaTuttavia le sue competenze dovevano ancora allargarsi ad un ulteriore settore, grazie a
una coincidenza provvidenziale. Infatti, in quegli anni, il mondo missionario aveva potuto usufruire dell’opera e degli scritti di un eccezionale missionario come p. Paolo Manna, soprannominato per il suo ardente spirito missionario “Anima di fuoco”.
Al termine di una vita come missionario in Birmania e poi come superiore generale del PIME, ormai malato, si era ritirato a vivere a Ducenta, cittadina vicino a Napoli. P. Manna era nativo di Avellino, proprio come Michele, al quale i superiori del PIME pensarono bene di chiedere un servizio per assistere il loro ex superiore generale.
Michele ammirava questo grande missionario e ritenne un onore e una gioia stare a fianco di p. Manna, che considerava come un “vero padre per lui”. Il suo affetto era ricambiato dal padre quando chiamava affabilmente Michele “il miglior ciabattino del mondo e unico infermiere per me”.
Seguirono anni di stretta condivisione di vita tra due personalità molto diverse tra loro per carattere, cultura ed età, ma che si seppero capire e apprezzare. Al suo fianco Michele seppe acquisire un ardente spirito missionario, sostenuto da un forte spirito di preghiera.
Il “caso” di una statua… senza testaDopo la morte di p. Manna (1952), Michele fu assegnato alla missione sul Rio delle
Amazzoni, in Brasile e precisamente nella diocesi di Parintins. A 36 anni cominciava una nuova vita e una nuova avventura, quella che aveva sognato la prima volta nell’orfanotrofio di Avellino. Per lui fu una svolta, anche perché in terra brasiliana smise rapidamente di essere “l’artista delle scarpe” per iniziare a diventare un “maestro pittore” per tanti piccoli allievi.
Tutto cominciò quasi per caso quando si presentò alla casa del vescovo, mons. Arcangelo Cerqua, un’anziana signora brasiliana che abitava all’interno della foresta. In una mano teneva una piccola statuetta di gesso senza testa, e nell’altra due piccole teste, una con lineamenti maschili e l’altra femminili, provenienti da qualche altra statua rotta.
Chiese al vescovo di aiutarla a capire quale fosse la testa giusta per la sua statuetta decapitata, e poi di rimettere la testa appropriata al suo posto originario. Il vescovo sapeva che per l’anziana signora non era tanto una questione artistica, quanto di venerazione popolare. Però lui certamente non aveva molto tempo da dedicare a questo problema, e soprattutto non aveva alcuna conoscenza artistica o manuale.
Bisognava quindi trovare una soluzione a questa delicata questione, e ciò avrebbe richiesto tempi non proprio brevi.
Affidò quindi il tutto al fidato Michele, incaricandolo di trovare comunque una soluzione positiva per l’anziana signora. Il missionario esaminò minuziosamente la statuetta e le due teste e, dopo aver chiesto tutte le informazioni del caso, congedò la signora assicurandole che dopo 15 giorni le avrebbe riconsegnato la statuetta nello splendore iniziale.
Rimasto da solo, Michele andò nel laboratorio e con i pochi attrezzi disponibili che vi trovò iniziò il lavoro di ripulitura, sistemazione, aggiustamento, limatura e incollaggio della testa. Poi prese i colori che si era procurato in città, e in pochi giorni terminò l’opera. Quella che, qualche tempo prima, non si riusciva a capire bene chi fosse era stata trasformata in una bella statua della Vergine Maria.
46

Un insegnamento preziosoLa fama di questo miracolo procurò a Michele molto lavoro e apprezzamento da parte
della popolazione locale, per la sua capacità di trovare soluzioni utilizzando le poche risorse che trovava sul posto. Ma non solo, se lui era capace di tanto, perché non poteva insegnarlo ai loro figli? Michele sarebbe stato contento di farlo, ma non sapeva dove farlo. Il vescovo allora, avendo contribuito alla nascita di questa nuova avventura, non poté tirarsi indietro e, non potendo disporre di altro, gli lasciò utilizzare la tettoia dove era parcheggiata la sua motocicletta.
Venne inaugurata, quindi, sotto una tettoia di lamiera, una scuola professionale di pittura e scultura che in oltre 35 anni di attività ha avviato al lavoro e alla vita molti bambini di Parintins. Michele, da buon autodidatta, aveva un suo metodo di insegnamento sia per l’arte che per l’organizzazione della scuola.
Sicuramente non aveva letto molto di pedagogia, ma si ricordava quanto, molti anni prima, gli aveva suggerito il missionario che lo aveva incoraggiato sul cammino della pittura: costanza, pazienza e serietà. Se servivano a fare un buon missionario, sarebbero certamente state utili per far nascere dei futuri pittori o scultori. Così fece e non se ne pentì.
Accettava una trentina di studenti al giorno, tra bambini e ragazzi, suddivisi in due turni in modo che ci fosse la possibilità per tutti di frequentare le sue “lezioni”. Questo perché in Brasile, dato che il numero degli alunni è molto alto e le scuole non sono molto numerose, si fanno normalmente due turni, uno al mattino e l’altro al pomeriggio. In questo modo chi frequentava la scuola al mattino andava da Michele al pomeriggio, e chi frequentava al pomeriggio imparava i rudimenti di pittura al mattino.
Così per tutta la settimana gli “apprendisti” pittori e scultori disegnavano, scolpivano, imbrattavano tutto quello che era possibile reperire: dalla carta ai muri, al legno, ai gusci di tartaruga, ai pesci imbalsamati e, naturalmente, statuette rotte e decapitate.
C’era però una particolarità interessante che Michele aveva introdotto. Quando si riparavano statue sacre o si facevano dipinti religiosi tutti recitavano assieme e ad alta voce il rosario. “Perché”, spiegava il Maestro Michele, “se non si prega non si può disegnare o scolpire bene qualcosa di sacro”. Quando poi qualche allievo gli chiedeva delle spiegazioni troppo complicate, lui rispondeva che: “Nella pittura, come nella vita, quello che è più importante per migliorare è conoscere e seguire l’esempio di uno più bravo di noi”.
Queste frasi sono ancora ricordate dagli allievi più adulti, dei quali alcuni si sono poi affermati come pittori professionisti in Brasile. In tutti questi anni di lavoro e insegnamento nella semplicità, Michele ha decorato innumerevoli chiese e ha dipinto moltissimi quadri sacri, che si possono ancora ammirare nella diocesi di Parintins.
Mani e cervelloMichele realizzò anche opere più piccole, che venivano vendute ai numerosi visitatori
che passavano dalla tettoia dove faceva scuola ogni giorno. Anche il suo modo di rapportarsi con i visitatori aveva qualcosa di particolare e fuori dal comune.
A tutti spiegava il significato di questa attività semplice e nascosta offerta gratuitamente ai giovani di questa terra. Non chiedeva mai direttamente degli aiuti per sostenere le spese della scuola, ma non perdeva neppure occasione per offrire agli altri l’opportunità di fare del bene: “Questa è un’opera della Provvidenza. Io metto solo le mani e un po’ di cervello”. Un giorno ricevette la visita di un suo amico proveniente dall’Italia. Dopo aver a lungo guardato l’esposizione, chiese di poter acquistare qualche oggetto di artigianato preparato da Michele o dagli allievi. L’amico aveva alcuni biglietti da 100 dollari e pensava di scegliere diversi pezzi per arrivare ad un totale di 150 dollari. Non sapeva poi come lasciare un piccolo dono senza farglielo pesare.
47

Fece quindi una scelta accurata guardando i prezzi affissi su ogni oggetto e infine chiese il conto. Michele cominciò a prendere in mano i diversi oggetti e a calcolare ad alta voce la somma totale: “Allora sono 150 dollari! Questo è il prezzo per gli sconosciuti e i clienti anonimi. Ma so che sei un amico e allora, perché tu non faccia pazzie di generosità, facciamo più 30% per l’amicizia che ci lega e arrotondiamo a 200 dollari”. L’amico scoppiò in una risata e lasciò altri 100 dollari in più per premiare l’arguzia e il buon senso di quest’uomo saggio che non gli aveva fatto pesare un gesto di carità e di amicizia.
Il passaggio di testimoneNel 2005 Michele compie 88 anni ed è ancora sulla breccia, sempre sulla riva del
grande Rio delle Amazzoni. Ha ridotto di molto le sue attività di insegnamento, ma gli abitanti di Parintins hanno voluto mantenere vivo il suo ricordo intitolandogli una vera scuola di “belle arti”. Non solo. Nel 2002, nella tradizionale “Festa del Bue” che ogni anno si celebra negli ultimi giorni di giugno, una delle canzoni che accompagnano la sfilata dei carri allegorici e dei danzatori abbigliati con costumi folcloristici è stata dedicata proprio all’opera di “Fratel Michele”, missionario laico con il talento artistico.
n questa canzone si ricorda la storia di un uomo semplice e silenzioso venuto da lontano sul grande fiume. Un uomo saggio che sapeva valorizzare le piccole cose e dar loro vita attraverso il colore. Quest’uomo non ha tenuto per sé questo segreto, ma lo ha insegnato ai figli dell’Amazzonia perché facessero altrettanto.
La vita di Michele è la prova che ogni cristiano, quando prende sul serio il Vangelo, arriva lontano, e non solo in senso geografico. Nessuno all’orfanotrofio di Avellino avrebbe scommesso molto su quel giovane calzolaio. Dio invece aveva grandi progetti su di lui, come per tante altre persone. Michele ha saputo recepire nella sua storia i segni di una “chiamata” particolare. Il suo lavoro, calzolaio prima e pittore poi, è stato lo strumento, comune e nello stesso tempo privilegiato, per testimoniare che Dio è Padre e vive accanto a tutti i suoi figli. Ed è un mezzo a disposizione di tutti.
Michele ne era convinto, e al contempo affaticato; per questo continuò sulla riva del Rio che qualcuno andasse a sostituirlo.
Fu la malattia a costringerlo a rimpatriare, e concluse la sua lunga e laboriosa giornata a Rancio di Lecco il 3 settembre 2010.
Dal libro Apostoli nel quotidianoL'avventura straordinaria di sette missionari laici del PIME
7. LEBBROSO COME LORO
Massimo Teruzzi (1902–1963), nato a Lesmo (MI), partì per il Bangladesh come missionario laico PIME alla fine del 1928, e vi spese la vita curando i più abbandonati, dai quali ha contratto la lebbra.
Massimo Teruzzi era un missionario laico innamorato dei poveri e degli ammalati, degli ultimi della società. È stato l’unico missionario del PIME in Bangladesh che ha contratto la lebbra lavorando fra i malati del lebbrosario di Dhanjuri. Ma, mentre i confratelli dell’Istituto erano preoccupati per questo, Massimo era sereno e diceva: “La lebbra è una malattia come le altre. Se il Signore mi aiuta guarirò, altrimenti non sarò il primo missionario che muore lebbroso”.
La veloce preparazione48

Massimo era nato a Lesmo, in provincia di Milano, il 14 ottobre 1902. Avrebbe desiderato studiare dopo le scuole elementari, ma la sua famiglia era povera e dovette andare a lavorare all’età di undici anni. Incominciò ad aiutare i muratori, portando calce e mattoni, poi, dopo il servizio militare, continuò in questo lavoro faticoso. Al mattino, dopo una visita in chiesa per fare la comunione, lo si incontrava per le strade del paesino con un panino avvolto in un giornale per il pranzo a mezzogiorno. Lavorava molto, ma era anche un giovane riflessivo che leggeva e si istruiva da autodidatta.
Non si sa come sia maturata la sua vocazione missionaria. Veniva da una famiglia di profonda vita religiosa e aveva respirato in casa propria, oltre che in parrocchia, gli insegnamenti del Vangelo. Meditando le parole di Gesù: “Chi pensa soltanto a salvare la propria vita la perderà; chi invece è pronto a sacrificare la vita per me e per il Vangelo la salverà”, Massimo decise di mettersi a disposizione della missione, per testimoniare il Vangelo ovunque sarebbe stato mandato.
Dopo un solo anno di preparazione nel PIME di Milano, il 15 agosto 1928, a 26 anni, partì per la missione di Dinajpur, non ancora membro effettivo dell’Istituto, col solo giuramento temporaneo di fedeltà alla vita missionaria. I superiori volevano metterlo alla prova mandandolo in Bengala, allora ritenuto “la tomba degli europei”, perché c’era bisogno di uno della sua tempra. Diventerà successivamente membro effettivo dell’Istituto, nel 1932, emettendo il giuramento perpetuo.
Vicino ai bengalesiGiunto in missione nel novembre 1928, dapprima pensò che il suo mestiere di muratore
fosse il più utile alla missione e si mise di buona lena a costruire chiesette in serie, tetto di lamiera su muri di fango e anche qualche edificio in muratura. Ben presto però s’accorse della miseria enorme imperante nel Paese. Troppi erano gli ammalati inesorabilmente condannati a morte per la mancanza di medicinali o per l’impossibilità di comperarli.
Fratel Massimo abbandonò definitivamente gli strumenti del muratore e si mise a studiare i libri popolari di medicina, iniziando poi a praticare in dispensari improvvisati con bambù e paglia. Si sentiva male alla vista di tanta povera gente e non si dava riposo finché non aveva visitato tutti. Non c’era orario per lui: gli ammalati poveri erano i suoi padroni e potevano presentarsi anche di notte.
Questa sua appassionata dedizione agli ultimi della società bengalese lo segnalò ai superiori, che lo mandarono a Dhanjuri, dove a quel tempo stava nascendo il lebbrosario. Nel 1926 padre Luigi Brambilla scriveva a proposito delle epidemie che colpivano alcune tribù bengalesi: “Tra i Santal la lebbra è una malattia molto comune, è raro trovare un paese che non ne sia infetto. Il problema che noi missionari ci siamo posti fin da quando siamo entrati in contatto con la tribù dei Santal è questo: cosa possiamo fare per i poveri disgraziati infetti dalla lebbra? Qui a Dhanjuri l’idea di un lebbrosario potrebbe essere tradotta in pratica con poca difficoltà. Dhanjuri è situata in piena foresta, nei pressi di un lago. I lebbrosi, pur vivendo un po’ isolati, potrebbero darsi alla pastorizia, alla pesca, alla caccia prediletta dai Santal”.
Nel 1929 padre Giuseppe Obert comprò un vasto terreno sulle rive del lago e non lontano dalla missione di Dhanjuri, luogo ideale per un lebbrosario. L’anno seguente Massimo Teruzzi costruì le prime abitazioni per i lebbrosi, mentre praticava quella poca arte medica che conosceva.
Quando nel 1934 arrivarono le suore di Maria Bambina, come infermiere diplomate per la cura dei lebbrosi, fratel Massimo anzitutto costruì il loro convento, poi si limitò a osservarle mentre lavoravano per imparare da loro l’assistenza agli ammalati.
Le suore gli volevano bene e lo ammiravano, in quanto era sempre disponibile per qualsiasi servizio, ma soprattutto le commuoveva la sua totale dedizione ai lebbrosi, che
49

erano i suoi prediletti. Però lo rimproveravano spesso perché non teneva conto dei principi di igiene e di prevenzione dalla lebbra che loro stesse praticavano.
La vita spirituale di Massimo era davvero profonda e forse pochi lo intuirono, data la sua natura introversa. Voleva vivere con i lebbrosi e come i lebbrosi, proprio per un motivo spirituale: vedeva in loro l’immagine più toccante del sacrificio di Gesù, per cui mangiava, fumava, giocava e scherzava sempre in loro compagnia.
Non aveva certamente dimestichezza con la teologia eppure seppe mettere in pratica alla perfezione la frase di San Paolo: “Farsi giudeo con i giudei, greco con i greci”, facendosi bengalese con i bengalesi, Santal con i Santal, lebbroso con i lebbrosi.
L’esperienza della lebbraNegli anni ’30 del secolo scorso, al lebbrosario di Dhanjuri non c’era ancora
l’attrezzatura disponibile adesso. Fratel Massimo puliva col bisturi le piaghe dei lebbrosi all’ingresso della capanna. In un momento di stanchezza e di disattenzione il bisturi impregnato di pus e di sangue del malato produsse un taglio nel braccio del missionario. Il batterio della lebbra, come un nemico vendicatore che non perdona, si infiltrò immediatamente nel suo sangue. Tuttavia Massimo non si scompose e, come se già fosse preparato a quell’evento, preparò la sua valigetta e andò a bussare alla porta dell’ospedale di Calcutta, in quel tempo il più moderno presidio indiano contro la lebbra. Lui, direttore e “medico” di un lebbrosario, diventa un lebbroso, un numero di letto in un lebbrosario.
Il suo fisico allora era forte e, seguendo con scrupolo le cure più moderne, in pochi anni la progressione della malattia fu fermata, neutralizzando il suo potenziale infettivo. Massimo ringraziò i dottori, rifece la sua valigia e ritornò ai suoi ammalati con un’esperienza medica in più, fatta sul suo corpo. L’anima si affinò nella comprensione della sofferenza e lui riprese senza riserve il proprio posto accanto al popolo sofferente.
Durante la seconda guerra mondiale, nel 1942, dovette subire, perché italiano, le “delizie” del carcere militare: pidocchi, fame e sporcizia. Meravigliava tutti, inglesi e bengalesi, con la sua testimonianza di vita coerente, la sua bontà e serenità anche in quelle deplorevoli condizioni. Rimase in carcere solo pochi mesi, poiché gli inglesi si convinsero che non rappresentava alcun pericolo per il governo di Londra.
50

Con le ultime forzeDopo 24 anni ininterrotti di lavoro in Bengala, nel 1953 ritornò in Italia per una breve
vacanza. Qualcuno, vedendo quella lunga barba bianca, quegli occhi stanchi, quelle spalle ormai curve, gli consigliò di restare. “No - rispondeva fermo in un modo che non ammetteva replica - il mio posto è là, tra i miei poveri”.
In effetti nel 1953 fratel Massimo non godeva più di buona salute: oltre alla lebbra aveva un’ernia, soffriva molto di asma, era debole di cuore e aveva una bronchite cronica, per non parlare dei parassiti intestinali, della sciatica e dell’ulcera gastrica. Non è possibile enumerare tutti i suoi malanni: era un ospedale ambulante, ma non si lamentava mai. Anzi, ripartì per il Bengala. La sua nuova missione fu Ruhea, più povera della precedente: nell’estremo nord del Paese, dov’era allora parroco padre Cesare Pesce.
I missionari del Bangladesh ricordano che padre Pesce realizzò il gesto forse più bello ed eroico della sua vita missionaria accogliendo fratel Massimo a Ruhea nel 1956, quando tutti sapevano che era lebbroso, correndo così coscientemente il pericolo di contrarre lui stesso, inavvertitamente, la terribile malattia, in anni in cui la lebbra era quasi incurabile. E faceva paura a tutti.
Suor Franca Nava, missionaria dell’Immacolata giunta in Bangladesh nel 1953 in veste di infermiera, ricorda che fratel Massimo, quando fu dimesso dal lebbrosario di Dhanjuri, andò a Ruhea, dove lo accolse padre Pesce mentre altri lo rifiutavano, per non creare problemi alla loro missione, in quanto avere in casa un lebbroso, a quei tempi, era un fatto terrificante per tutti. Quando la suora arrivò a Dhanjuri, tutti dicevano che Massimo si era infettato perché lo voleva, nel senso che viveva a stretto contatto con i lebbrosi e desiderava quindi condividere la loro vita sentendosi loro fratello. “Per me, che in quegli anni ero nel lebbrosario”, afferma suor Franca, “padre Pesce ha fatto uno dei gesti più eroici proprio nell’accogliere Massimo come un fratello. La loro condivisione di vita è stata per tutti noi un esempio e una testimonianza di dedizione”.
Condividendo la vita dei bisognosiA Ruhea, dapprima in una capanna di paglia, poi in una casetta angusta e soffocante,
fratel Massimo seppe portare avanti la sua opera, per tutti i giorni che gli restavano. Padre Pesce, in un articolo apparso dopo la morte di fratel Massimo, avvenuta nel 1963, usava queste parole per esprimere il senso di smarrimento dei tanti poveri, d’ogni razza e credo religioso, che con tristezza si assieparono intorno alla tomba del loro fratello missionario: “Io penso, e non temo di sbagliare, che l’uomo più amato di Ruhea e dintorni fu proprio il ‘Brother’ (fratello). La sua fama di bontà e abilità medica era giunta lontano. Da Tetulia, da Dinajpur, venivano i malati poveri, i lebbrosi, i disperati della scienza medica: il ‘Brother’ era diventato l’ultima loro speranza. E lui, burbero benefico, a tentare e ritentare con successo, con insuccesso. Con quegli occhiali più vecchi di lui sul naso, a rincuorare con barzellette nel dialetto del paese che aveva appreso alla perfezione. Una figura indimenticabile”.
E così, come è vissuto se ne è andato, con semplicità, senza mai lamentarsi, anche durante gli ultimi giorni che si trasformarono in un vero supplizio. Non ne poteva più, ormai trascinava le gambe doloranti, sembrava un vecchio di cent’anni, ma al confratello che amabilmente lo redarguiva e lo invitava al riposo rispondeva sempre: “Riposerò dopo...”. L’ultimo giorno di lavoro, era un giovedì, tra gli ammalati del suo dispensario “Don Orione” di Ruhea respirava a fatica e confessò ai suoi collaboratori e amici: “Basta, stavolta è proprio finita”. Il sabato mattina fece chiamare i suoi poveri, vuotò le tasche e l’armadio di quei pochi spiccioli che rimanevano e in silenzio, senza importunare alcuno, andò a Dinajpur all’ospedale cattolico. Pochi giorni di degenza, sempre allegro e sorridente fino alla notte di giovedì 18 luglio 1963. “Non ce la faccio più” disse, e col nome di Maria sulle labbra spirò all’alba del venerdì, dopo aver ricevuto i sacramenti.
51

A quella massa di poveracci, di rifiuti della società che continuarono ad affluire al dispensario di Ruhea, padre Pesce fu costretto ad annunziare: “Nulla da fare, il dottor Massimo se n’è andato, non a Dinajpur a comperare le medicine per voi, come aveva fatto tante volte nel passato; se n’è andato per sempre, non tornerà più, mai più”.
In quei giorni di afflizione, gli sciancati, i lebbrosi, le vedove e i poveri di ogni genere avevano mille ragioni di piangere mentre tornavano più volte alla missione e si aggiravano in ogni angolo del dispensario quasi a cercarlo, non sapendo capacitarsi di tanta perdita. E se è vero che il pianto è un balsamo, è altrettanto vero che il balsamo non riempie il vuoto del cuore, poiché rappresenta una grande fortuna poter incontrare sul proprio cammino un fratello generoso; e sostituirlo, soprattutto quando la morte dell’uomo della carità fa precipitare tanta gente nello sconforto più sincero, è davvero un’impresa ardua da compiere.
Nel suo articolo di commemorazione, padre Pesce concluse con una riflessione che è, ancor oggi, di irresistibile attualità: “Fratel Massimo ha lasciato l’esempio di una vita interamente spesa nell’amore del prossimo nel nome di Gesù. Il bengalese, ignaro del senso di pura carità e gratuità, ha avuto una scossa da questo esempio: forse non diventerà cristiano, ma sarà più buono perché ha constatato che soltanto il cristianesimo può produrre uomini così”.
Una vita spesa per gli altriMolti fratelli e molti padri del PIME conobbero Massimo, e a distanza di tanti anni
custodiscono nella memoria l’immagine di questo uomo che sapeva donare a tutti una porzione del suo tempo e delle sue energie. Nel periodo in cui egli prestò servizio a Ruhea, molte persone venivano anche da lontano perché avevano saputo che trattava bene tutti e li aiutava come poteva. Il suo dispensario era una capanna di fango e paglia, non in muratura, giacché allora le costruzioni in muratura erano poche.
Purtroppo il grande affetto che lo circondava non fu sufficiente a preservarlo dagli effetti letali della malattia, che lo condussero alla morte nell’ospedale di San Vincenzo a Dinajpur. “Quando l’ho saputo”, racconta con viva emozione fratel Luigi Brun, “ho preso la moto e sono corso a Dinajpur. Mi hanno detto che era molto debole e che durante la stagione dei monsoni era andato a lavarsi sotto una specie di cascata che spioveva da un tetto; il freddo e la debolezza gli hanno procurato una bronco-polmonite. Allora molti dicevano che era morto il santo protettore dei lebbrosi e degli ammalati”.
Dopo tanti anni spesi accanto ai più deboli, si era creato intorno alla figura del missionario laico un alone di profonda ammirazione; tuttavia fratel Massimo conservò sempre l’umiltà propria dell’autodidatta qual era, infatti, pur non avendo alcun diploma di medico o infermiere, tutti lo chiamavano “dottore”, tanto che molti medici andavano da lui a chiedere pareri e consigli. Per Massimo anteporre i suoi malati a tutto il resto era un obbligo supremo, per cui quando gli dicevano che si doveva riposare, scrollava le spalle e tirava avanti per la sua strada, lungo la quale sacrificava anche la domenica.
Testimonianza della povertàFratel Massimo è stato un apostolo degli ammalati e anche dei poveri. Adorava i poveri,
li aveva sempre con sé. Uomini e donne di ogni razza, buoni e cattivi, che anche dopo la sua morte continuavano - il quale spesso, oltre ai medicinali, dava loro anche qualche spicciolo per nutrirsi - li avesse abbandonati per sempre.
Soccorreva i poveri col poco che aveva. Quando nel 1962 fu pubblicato un articolo che parlava di lui, giunsero al PIME delle offerte che gli furono trasmesse. Quasi non si riusciva a convincerlo che ci fossero dei benefattori che pensavano a lui. Quando infatti partì per la missione, non poteva avvalersi di un gruppo di persone disposte a sostenerlo finanziariamente. Le uniche offerte erano quelle dei suoi fratelli. Eppure trovava modo di
52

dare ugualmente: dando del suo, di ciò che era a lui destinato dai superiori, privandosi del proprio legittimo “stipendio”.
Quando nel 1954 celebrò il suo 25° di missione, padre Luigi Verpelli, che allora era con lui, dovette comprargli un paio di scarpe e di calze, perché ne era privo, mentre durante il periodo trascorso a Ruhea padre Mario Alvigini lo convinse ad accettare una sua veste bianca, dato che quella che aveva era ormai ridotta in condizioni pietose. Massimo non aveva neppure un letto, ma dormiva su un intreccio di nodose canne di bambù, per coperte e lenzuola usava addirittura dei sacchi vecchi: padre Alvigini li sostituì con qualcosa di più decente.
Identica operazione il padre la fece con la zanzariera - residuo dell’esercito americano nell’ultima guerra - che Massimo si sforzava di rattoppare con dei grandi cerotti. Infine, in luogo di una scrivania funzionale, si accontentava di usare una cassa da imballaggio.
Quando qualcuno gli dava una maglietta o un uovo in più da mangiare, nel 99% dei casi trovava subito il modo di disfarsene. Se gli veniva fatto notare questo suo eccesso di zelo, ribatteva che ormai era troppo vecchio per cambiare e il risultato era che faceva la carità il più nascostamente possibile.
Un gigante di umanitàQualche volta anche fratel Massimo, tra malanni e ristrettezze, era di malumore, ma
appena si presentava la prospettiva di ricevere dall’Italia qualche cassetta di medicinali, si metteva a cantare e a scherzare come un bambino. I medicinali erano la sua passione, nonostante ciò non sono valsi a salvarlo da quella che egli diceva fosse un semplice raffreddore e che invece si rivelò una polmonite; e neppure gli giovò il trasporto all’ospedale di Dinajpur, dove andò allegro e scherzando con tutti.
Infatti, pochi giorni dopo il ricovero, senza troppo soffrire e senza dar fastidio a nessuno, se ne andò al cielo, a ritrovare, come padre Mauro Mezzadonna scrisse nel suo necrologio, “tanti ex poveri ed ex ammalati diventati ricchi per opera sua”.
Da questo insieme di ricordi e riflessioni si evince che fratel Massimo Teruzzi è stato universalmente stimato e ammirato, un gigante di umanità che nella pratica quotidiana della modestia, della fede e dell’obbedienza ha saputo donare con vera letizia la propria vita per il prossimo: un modello di cui si avverte la necessità, ora e sempre
È sempre stato così, dal giorno in cui Gesù donò la sua vita sulla croce per gli altri: “L’umile sarà esaltato, la sua memoria passerà in benedizione”. Fratel Massimo, con la sua umiltà, col suo disprezzo di tutto ciò che sapeva di egoismo, con la sua dedizione alla carità, ha scritto una pagina autenticamente gloriosa nella storia dei missionari del PIME.
Insomma, come il servo laborioso di cui parla il Vangelo…
53