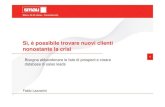Anna Lazzarini
-
Upload
guendamaria -
Category
Documents
-
view
85 -
download
0
description
Transcript of Anna Lazzarini

Anna Lazzarini (http://www.youtube.com/watch?v=7qct3jW0U6Q)
Polis in fabula. Metamorfosi della città contemporanea
La città, luogo in cui si condensa e si esprime l’esperienza umana, è soprattutto uno spazio vissuto. Oggi però frammentata, un po’ disseminata, parleremo poi della città infinita, e senza centro, questa città non sembra più riconoscibile. La città contemporanea è infatti travolta da cambiamenti inediti e che riguardano davvero gli ultimi anni. Si ridisegna lo spazio, si modificano le modalità stesse dello stare insieme e si ridefiniscono anche i suoi confini, la città si diffonde e si fa evanescente, moltiplica e sparpaglia e diffonde i suoi centri, disegnando forme ancora impensate. Eppure, nello stesso tempo, noi continuiamo a rappresentarci la città come un disegno unitario, come una totalità capace di garantirci senso di riconoscimento e senso di appartenenza. Quali sono i tratti distintivi che definiscono la città? Per capire se sono rintracciabili anche nella città contemporanea. Gli incessanti mutamenti a cui è sottoposta ma, soprattutto, il superamento dei suoi confini nell’orizzonte globale compromettono ogni tentativo di fissarla in un’immagine, in una forma, in una definizione possibile? Oggi, nel contesto globale, soprattutto per le trasformazioni del ruolo degli Stati nazionali, le città diventano proprio l’epicentro della riorganizzazione delle dinamiche degli spazi, dei tempi, delle dinamiche sociali, delle dinamiche culturali. È come se venissero a costituire una lente specifica dove poter guardare per capire come prendono corpo i processi globali. Per questo la città costituisce oggi uno spazio privilegiato di osservazione e di analisi. Nelle città si delineano nuove forme di convivenza umana, per questo la città sembra essere davvero il laboratorio più interessante in cui questi dinamiche prendono forma(3:10).
Che cosa è la città?
È un campo di forze contrapposte, un luogo dove forme e principi e dinamiche sono in conflitto. La città è segnata fortemente dal conflitto. Nella forma urbana, infatti, da sempre, si esprimono con forza alcune grandi tensioni, sono quella tra il radicamento, il patto che sono simbolizzate dalla tensione tra polis e civitas, fra stasi e movimento, fra molteplici differenze e fra memoria e destinazione (4:50).
La prima tensione è quella tra polis e civitas. L’esperienza urbana, passata e presente e futura, si fonda su questa tensione che è una tensione originaria fra l’idea greca di città e l’idea romana. Il termine greco polis e il termine latino civitas non hanno nulla in comune. Polis e civitas infatti assumono significati profondamente differenti e dunque le due esperienze di città sono esperienze profondamente differenti. Cambia specificamente il rapporto tra la città e i suoi abitanti nel contesto greco e nel contesto romano. Allora ci domandiamo di quale idea di città siamo maggiormente debitori. Qual è il riferimento della forma urbana attuale? Polis designa innanzitutto la sede, la dimora, il luogo delle proprie radici. Il termine esprime appunto un’idea molto forte di radicamento. La polis è il luogo dove una stirpe, determinata e specifica per lingua, tradizioni, costumi ha la propria sede, ha il proprio ethos. Questo radicamento genealogico, territoriale presente nella polis è del tutto assente nella civitas romana e questa differenza è radicale(6:30).
A Roma, al contrario, il termine da cui partire non è la città come spazio territoriale, ma è il cittadino, il civis. C’è un’analisi linguistica interessante di un linguista Emile Benveniste che mostra proprio questo rapporto dal punto di vista linguistico che in questo momento non possiamo affrontare. Vi basti sapere che cambia completamente il punto di vista se il punto di partenza è il
1

cittadino e non il luogo territoriale in cui prende forma la vita urbana. Civis, quindi, è il termine fondamentale e civitas è ciò che deriva dalla realtà dei cittadini, o meglio, ciò che deriva dall’essere insieme, dal mettersi insieme dei cittadini e infatti non si usa quasi mai cives ma cum cives che è già concittadini. Perché? Perché la civitas è il prodotto, ciò che emerge dai cittadini e dal loro convenire insieme, in uno stesso luogo, dal fatto di darsi le medesime leggi. Ecco il mito fondativo di Roma, la grande idea romana della città formata di gente diversa, che viene da tutte le parti, che ha lingue diverse, costumi e religioni diversi, ma si da un’unica legge, un imperatore, un senato e poi un impero. Allora, addirittura Roma viene formata da persone bandite dalla loro città, esuli, profughi, che confluiscono in quel luogo e quindi l’idea romana di cittadinanza, contrariamente a quella greca, non ha alcuna radice di tipo etnico, territoriale e religioso. La promulgazione della costituzione antoniniana di Caracalla sancisce, infatti, un principio che è già presente nel mito fondativo per il quale tutti i cittadini liberi che abitano dentro i confini dell’impero diventano cives romani. Allora la civitas non è l’origine ma è il fine, il risultato di quel processo che conduce alla convivenza di popoli diversi sotto le medesime leggi, non un legame di stirpe ma un patto, un patto di convivenza. Da qui l’idea che la città non è ferma, non è costituita di elementi fissi, stabili ma si muove continuamente, è un divenire senza fine, il carattere quasi programmatico della civitas è quello di crescere, di svilupparsi, di complicarsi, estrema dinamicità data dal confluire di una molteplicità di popolazioni. Il fine di questo confluire sarà poi appunto l’espansione, sarà poi l’impero. La civitas si sviluppa grazie alla capacità di accogliere ed integrare i pellegrini, i vinti ed anche i nemici.
(10:30) Il problema della polis, al contrario, era uno stretto controllo territoriale, la polis non doveva crescere troppo, non doveva sconfinare eccessivamente. La caratteristica di Roma è invece quella di crescere, di superare continuamente i propri confini. (11:00)L’esperienza della civitas è quindi il risultato di un processo, ciò che emerge da un processo, che indubbiamente è un processo faticoso di integrazione, è l’esperienza che risulta da questi sconfinamenti, da una crescita territoriale e da una conseguente integrazione di popolazioni. Se ci pensiamo, il problema della città contemporanea è una rinnovata tensione tra polis e civitas, una tensione tra una volontà di crescita, di espandersi, di accogliere popoli diversi ma anche la strenua difesa che diventa anche paura, la strenua difesa dei nostri confini, confini territoriali ma anche confini identitari. Ci sentiamo appunto in balia di altri e sentiamo di avere un’identità in qualche modo minacciata(12:15).
La seconda tensione è quella tra stasi e movimento (12:20). La città è in parte il luogo in cui ritrovarci, riconoscerci come comunità, la città è la dimora, deve essere il luogo accogliente, intimo, la casa. Dall’altra, la città è anche una funzione, un dispositivo, una macchina, che ci permette senza troppa fatica, di svolgere liberamente i nostri affari, da un lato la città luogo di ozio, e dall’altra è un luogo dove svolgere i propri negozi. Lo spirito della città è negoziante, negoziatore e questo registro si pone diversamente rispetto all’immagine della città come una casa, la città commercia, mercanteggia, cerca di rimuovere gli ostacoli che impediscono il movimento, è aperta da tutte le parti, impegnata nello scambio e nella circolazione nei traffici. Il problema da cui nasce appunto la tensione è che cosa domandiamo alla città. La tensione e il conflitto nasce dal fatto che noi alla città domandiamo entrambe le cose. Le domandiamo di avere cura dei luoghi della dimora, di custodire, di proteggere i luoghi simbolici disposti all’accoglienza e all’incontro, ma nello stesso tempo le chiediamo di facilitare i nostri spostamenti, i nostri affari, di costruire spazi di transito adatti al passaggio di ogni genere di flussi. Capite che questa è una tensione che ci riguarda da
2

vicino (15:05) nel senso che chiediamo tranquillità dei nostri luoghi, chiediamo pace e cura ma chiediamo di poter andare ovunque con la macchina per spostarci più velocemente, per fare affari. È una tensione densa e ricca di significati che continua ad abitare le città.
(15:40) La terza tensione viene dal fatto che la città è esperienza di tutte le differenze, la città è un ricettacolo di tutte le differenze che convivono e confliggono su più livelli. La cittá nasce storicamente come incontro e scontro di differenze. È l’esperienza della possibilitá dell’incontro con gli altri. L’esito è il proliferare di codici, di scambi, di linguaggi, di culture, di modalità di organizzazioni sociali che tuttavia richiama la necessità e il dovere di condividere norme, forme e significati.
(22:11) I fenomeni migratori che muovono singole popolazioni dalla periferia verso il centro, in un incessante movimento di confini, costituiscono proprio una sfida alla presunta omogeneità culturale degli stati. Ma anche il nuovo contesto storico impone di spostare lo sguardo dalle differenze appunto fra le culture alle differenze all’interno di ogni cultura e alle modalità possibili delle loro interazioni. Ripeto, questo è molto importante, le culture non sono blocchi (22:45) identitari omogenei ma presentano differenziazioni al loro interno, nella loro struttura simbolica e nelle loro modalità di significare di rappresentare. In questo senso, il fatto da cui partire non è tanto il pluralismo, la molteplicità è già il meticciato, l’ibrido, non per questo si deve rimuovere la reale natura di questi incontri che si configurano spesso come conflitti veri e propri perché le formazioni sociali, le individualità che si confrontano presentano dissonanze anche molto significative. Anzi, direi che il riconoscimento del conflitto è un aspetto molto importante. Il conflitto come incommensurabilità di principi, di valori, di significati, tuttavia, il conflitto deve essere assunto in una prospettiva dinamica che quindi non si arresta all’impossibilità della ricomposizione ma che lavori all’incontro (24:00) fra mondi culturali diversi, eterogenei, riconoscendo nelle differenze anche possibilità creative entro il processo stesso della comunicazione. Lo spazio comune emerge allora come contesto in cui mettere in atto pratiche e politiche di traduzione dei linguaggi, delle culture e pratiche di negoziazione dei comportamenti. La traduzione è un compito che costringe a stare in un’area intermedia, in un’area instabile tra le lingue e le culture. In questo spazio intermedio, che è ovviamente uno spazio simbolico, possono avvenire errori, violazioni, lì si sperimentano i limiti, gli insuccessi, lì si annida la possibilità del malinteso, lì si esercita o si subisce il potere, lì però si fa esperienza dell’incontro con l’altro. Al cuore della traduzione c’è senz’altro un’esperienza di estraneità, di sradicamento che provoca spaesamento.
(26:15) L’ultima tensione è quella tra memoria e destinazione. La città e la sua storia vivono, evidentemente, quest’altra tensione. L’esperienza della città si dispiega da una parte tra memorie, storie e tradizioni che diventano, ad esempio, monumenti. E dall’altra, però, vive della sua proiezione nel futuro, della necessità di pensarsi continuamente e entro una dimensione di ulteriore destinazione. Proprio in questo scarto, fra ciò che è stata e sarà, fra la trama dei significati che sono stati condivisi e il futuro, il disegno che progetta di perseguire, ecco, in questo scarto si apre la dimensione autenticamente politica della città.
La città, come afferma Derida, si situa tra memoria e promessa.
Quali sono le trasformazioni in atto? La città infinita; rapporto tra flussi e luoghi; lo spazio pubblico.
3

(33:25) Vediamo ora quali sono le trasformazioni in atto. La rete e le dinamiche globali modificano profondamente i processi di produzione, di diffusione e di scambio così come le forme dell’esperienza, della comunicazione e della cultura stessa. I processi globali trasformano non solo la vita economica, sociale, culturale e politica della città, essi generano e assumono precise configurazioni spaziali, temporali, incidono sulle forme stesse della città. La prima, la città contemporanea si espande, si dissemina sul territorio, nuove definizioni e nuove metafore si sono imposte. L’abbiamo chiamata la città infinita, estesa, diffusa, indifferenziata. L’infinità però non riguarda tanto o soltanto l’estensione territoriale del territorio occupato, quanto la complessa articolazione di insediamenti, comparti produttivi, logistici o distributivi, infrastrutture, centri commerciali, spazi per il tempo libero. La diffusione della città infinita si manifesta in questo continuum urbanizzato e nel fatto che si costituiscono delle densità nella sua densificazione attorno ad alcuni poli produttivi o insediativi, in questo modo si assiste a una specie di specializzazione dei territori, di alcune aree dei territori, che si organizzano attorno ad alcune attività peculiari, come il commercio, il tempo libero, la sanità. Il territorio si fa così multipolare, ha tante polarità diverse (35:35).
Cambiano i rapporti centro/periferia.
I centri cambiano ma la città non rinuncia al centro, si moltiplicano.
(40:40) La seconda è il fatto che la città prende forma tra flussi e luoghi. La distinzione tra luoghi e flussi è indispensabile per descrivere la grande trasformazione in corso, stiamo infatti vivendo il passaggio da un’epoca, da una società che era dotata di scarsa capacità di spostamento dei capitali, di lavoro, di informazioni, e anche segnata da una relativa stabilità territoriale a una società contrassegnata dalla fluidità dei ruoli, da una mobilità geografica di persone, merci, imprese, e dalla velocità delle comunicazioni da un punto all’altro del sistema globale. La città è proprio questo punto di intersezione fra globale e locale, fra flussi e luoghi e questa tensione tra flussi e luoghi non è che una delle espressioni di quella tensione costitutiva di cui parlavamo prima, quella tra stasi e movimento, fra l’abitare, la custodia dei luoghi e la necessità dello scambio, la necessità di superare i propri confini (42:40).
(45:40) Il terzo passaggio è sullo spazio pubblico. La città è la scena primaria dello spazio pubblico. Dall’epica omerica alla storia e alla filosofia, l’agorà e il teatro sono i luoghi in cui l’esperienza della città cresce e si consolida. La dimensione pubblica della città concerne sia l’articolazione degli spazi quindi parliamo anche di forme architettoniche di luoghi, ma concerne anche la qualità delle relazioni, delle esperienze della vita urbana che in essi si svolge perciò piazze, strade, cortili, mercati, teatri, parchi sono spazi pubblici in cui la città, la civitas, esprime compiutamente se stessa quando favorisce l’incontro con gli altri. Questi luoghi sono pubblici perché non hanno un significato eminentemente funzionale, sono pubblici perché esprimono valore sociale, perché sono spazi di incontro e di aggregazione, sono pubblici perché consentono esposizione, perché sono spazi di rappresentazione, di compresenza, spazi di socialità. Lo spazio pubblico è quel mondo in comune che nasce dalla tessitura delle relazioni fra le persone, per questo Hannah Arendt diceva che parlare e agire in pubblico sono impensabili senza una pluralità di persone che partecipano, rispondono, si confrontano, reagiscono o confliggono. L’essere insieme, la presenza degli altri, l’essere parte di questa trama di gesti, di sguardi, di parole, definisce proprio la condizione dell’uomo. Lo spazio, composto di cose e di oggetti che gli uomini hanno in comune è
4

uno spazio relazionale, uno spazio vissuto, che possiede proprio tutta la consistenza, la materialità delle relazioni. Pubblico è allora il mondo stesso, il mondo dice Hannah Arendt come ogni in fra mette in relazione e separa gli uomini nello stesso tempo. Lo spazio pubblico però è anche il luogo dove vengono segnalati, nominati, interpellati i problemi, in cui si sperimentano le tensioni, i conflitti, si ricercano le soluzioni attraverso l’articolazione della parola, l’azione, il confronto, il progetto. Lo spazio pubblico è anche il luogo di osservazione critica riflessiva attraverso cui i membri di una comunità, di una società possono produrre e rappresentare una realtà condivisa, possono condividere rappresentazioni, significati, il suo valore dipende dalla capacità politica di costruire una sfera di mediazione tra individui, comunità, differenze. Si alimenta allora lo spazio pubblico della capacità che è individuale ma anche collettiva di ricercare e perseguire il vincolo sociale, di ristabilire significazioni comuni, riferimenti, simboli, rappresentazioni. Non è dunque una realtà precostituita ma è una costruzione fragile, impegnativa, e anche provvisoria. Oggi questa costruzione deve confrontarsi con dei cambiamenti e con dei problemi inediti. Il rapporto tra la sfera pubblica e la sfera privata ha subito una profonda trasformazione soprattutto per lo sviluppo delle nuove tecnologie della comunicazione e della informazione, questi mezzi moltiplicano i luoghi, i codici e gli strumenti della sfera pubblica svincolandoli però dalla forma assembleare. La sfera pubblica moderna si era costruita intorno alle istituzioni rappresentative, democratiche. Oggi, proprio queste stesse istituzioni manifestano i segni di una grave crisi. La sfera pubblica fatica a configurarsi come luogo di democrazia deliberativa. Lo stato, che fino a qualche decennio fa era il punto di riferimento imprescindibile per l’articolazione fra la società, la sfera pubblica e la politica oggi deve ridefinire il suo ruolo proprio a motivo dei cambiamenti globali. Anche le forze sociali, seppure molto attive, non riescono a disegnare prospettive da sole all’altezza della attuale situazione del quadro sociale. In questo senso, proprio la città può costituire uno spazio politico di grande interesse. Le città sono la principale messa in scena della società, sono lo spazio privilegiato della convivenza tra estranei, sempre conflittuale ma anche ricco di significati. Lo spazio pubblico intreccia una dimensione fisica, spaziale con una dimensione relazionale, sociale. È costituito di forme costruite, quindi di spazi naturali e artificiali, ma anche di forme sociali, di organizzazioni di gruppi, di persone. Per questo pensare lo spazio pubblico significa pensare insieme gli spazi e chi li abita, le città e le cittadinanze, le identità e le dinamiche di identificazione, significare comprendere le diverse forme sociali e il loro rapporto con le disposizioni spaziali perché esiste un rapporto. La sfera pubblica infatti, anche in tempi di immaterialità elettronica e di social network, necessita di configurazioni materiali in cui l’interazione sia sociale che politica possa svolgersi. L’esperienza umana continua a svolgersi nei luoghi e ad essere condivisa nei luoghi. Le trasformazione della società, della politica, dell’architettura fanno allora riferimento a uno spazio fisico relazione, uno spazio vissuto, un terzo spazio. È uno spazio intermedio, lo spazio delle interazioni sociali che si alimenta anche grazie al continuo flusso di informazioni, di simboli, di immagini che cambiano, modellano i linguaggi. (53:10) La città svolge un ruolo decisivo nell’articolazione dello spazio pubblico, tuttavia, oggi da una parte la città è il principale terreno di questa sfida della rigenerazione dello spazio pubblico, dall’altra ci sono alcuni processi minacciano o indeboliscono questa capacità della città e sono la privatizzazione degli spazi pubblici urbani, alcuni luoghi sono diventati semplici vincoli spaziali oppure sono diventati percorsi di attraversamento o sono stati consegnati a una sola funzione in genere di tipo economico. L’omogeneizzazione progressiva dei gruppi fino alla segregazione spaziale cioè la chiusura di alcune categorie sociali entro spazi particolari, emblema della frammentazione è l’etnicizzazione degli spazi urbani. Naturalmente queste forme di
5

segregazione subite o indotte promuovono proprio il contrario di ciò che intendevano perseguire, cioè la sicurezza, invece di promuovere la sicurezza promuovono l’esatto contrario, l’insicurezza diffusa, l’esclusione sociale e la rabbia che poi può innescare dinamiche violente auto propulsive. La paura diffusa nell’organizzazione nell’uso degli spazi, nelle forme architettoniche ma anche nella cultura e nei comportamenti quotidiani, senza la qualità integratrice dei ruoli, la distanza fisica ma soprattutto la distanza relazionale di vita viene vissuta come rifiuto e alimenta appunto esclusione e quindi possibilità di violenza.
Quindi, da un lato la città sembra per questi versi aver perso la capacità di dar corpo alla società, di integrare differenze, eppure ci sono altre e opposte dinamiche che possono essere individuate entro gli spazi urbani ridisegnati dalla rete e dai flussi cominciano infatti a mostrarsi alcune nuove esperienze di sfera pubblica a esprimersi forze sociali e anche attori tradizionalmente esclusi dai circuiti formali del riconoscimento. Si tratta di modalità di aggregazione in forme che si esprimono in forme nuove, inedite, di partecipazione, sono movimenti non sempre legati a identificazioni forti, rivendicano spesso il diritto di essere riconosciuti nella loro presenza. Saskia Sassen individua in questi processi ciò che chiama le pratiche degli esclusi.
(57:00) La città si trova oggi di fronte alla sfida di ricercare punti di incontro, di mediazione tra i vissuti, tra i mondi culturali e simbolici. In questo senso, nella Babele globale, essa diventa lo spazio privilegiato della traduzione ed è qui che la posta in gioco diventa proprio la rigenerazione dello spazio pubblico. La città è quel ricettacolo di differenze ma può essere anche la matrice del loro incontro, della possibilità effettiva della loro relazione. Allora conflitti, confronti, traduzioni, negoziati possibili richiedono non solo incontri, scambi di esperienze, narrazioni ma chiedono anche, e chiedono soprattutto alla politica, luoghi e sedi fortemente connotati in senso simbolico, momenti opportuni, informazioni e conoscenze utili a formalizzare le alternative, a prevedere i progetti, a valutare. Le diverse culture urbane devono trovare tempi e spazi di reciproca composizione.
Quali sono le conseguenze per quanto riguarda il governo della città.
6