Alfeev, I., La Forza Dell'Amore, Magnano, Qiqajon, 2003
-
Upload
piero-pertusati -
Category
Documents
-
view
166 -
download
16
Transcript of Alfeev, I., La Forza Dell'Amore, Magnano, Qiqajon, 2003

Nella stessa collana SPIRITUALITÀ ORIENTALE
P. Deseille, Il vangelo nel deserto. Un itinerario di spiritualità G. Bunge, La paternità spirituale. Nel pensiero di Evagrio G. Bunge, Vino dei draghi e pane degli angeli. Dall'ira alla mitezza I. Hausherr, Philautia. Dall'amore di sé alla carità Ignazio e Teodosio di Manjava, Sottomessi all'evangelo. Vita di Iov di Maniava,
Testamento di Teodosio, Regola dello skytyk Paisij Velickovskij, Autobiografia di uno starec S. Salvestroni, Dostoevskii e la Bibbia P. Evdokimov, Serafim di Samv, uomo dello Spirito N. Arseniev, V. Lossky, Padri nello Spirito. La paternità spirituale in Russia ]. B. Dunlop, Amvrosii di Optina P. A. Florenskij, Il sale della terra. Vita dello starec Isidoro Matta el Meskin, L'esperienza di Dio nella preghiera Matta el Meskin, Comunione nell'amore AA.VV., Paisii, lo starec AA.VV., San Serafim: da Sarov a Diveevo AA.VV., Silvano dell'Athos
Invieremo gratuitamente il nostro Catalogo generale e i successivi aggiornammti a quanti ce ne faranno richiesta.
AUTORE: Ilario n Alfeev CURATORE: Riccardo Larini, monaco di Base TITOLO: La forza dell'amore SOTTOTITOLO: L'universo spirituale di !sacco il Siro COLLANA: Spiritualità orientale FORMATO: 20 cm PAGINE: 384
PREFAZIONE: Kallistos (Ware), vescovo di Diokleia TITOLO ORIG.: L'univers spirituel d'Isaac le Syrien, Abbaye de Bellefontaine, Bégrol
les-en-Mauges 2001
TRADUZIONE: dal francese a cura di Augusto De bave IN COPERTINA: !sacco il Sim, miniatura (1389), particolare, Codice Mosca, Biblioteca
statale di Russia
© 2003 EDIZIONI QIQAJON COMUNITÀ DI BOSE 13887 MAGNANO (BI)
Te!. ors.679.264- Fax ors.679.290
ILARION ALFEEV
LA FORZA DELL'AMORE
L'universo spirituale di !sacco il Siro
EDIZIONI QIQAJON COMUNITÀ DI BOSE

PREFAZIONE
Ricordo peifettamente il giorno in cui mi imbattei per la prima volta nel nome di [sacco il Siro, circa quarant'anni fa. Scorrendo un'antologia divulgativa, in margine a una citazione di Spinoza lessi queste parole di Isacco: "Cbe cos'è un cuore misericordioso? ... È un cuore cbe arde per tutta la creazione, per gli uomini, gli uccelli, gli animali, i demoni e ogni creatura", e prosegue descrivendo le lacrime versate da un uomo misericordioso quando il suo cuore è pieno di tristezza e compassione per tutte le creature viventi: "Grazie alla misericordia possente cbe gli stringe con forza il cuore e all'intensa compassione, la sua anima è umiliata e non sopporta di sentire o vedere un'offesa qualsiasi o la minima afflizione patita dalle creature"1•
1 I, 71 (p. 344) = Touraille 81 (p. 395); PR 74 (pp. 507-508). I testi della prima parte dell'opera di Isacco sono stati tradotti a partire dal libro russo dell'autore, che a sua volta ha adottato la traduzione russa corrente (Sergiev Posad 19rr); essi sono indicati nelle citazioni con la cifra iniziale romana I, seguita dal numero del discorso e tra parentesi dalla pagina della traduzione americana di Dana Miller; poiché la numerazione dei discorsi nella versione francese di Touraille e nell'edizione di Bedjan del 1909 non corrisponde a quella di Miller, accanto alla prima numerazione sono indicate anche le numerazioni alternative e le pagine ad esse corrispondenti. I testi della seconda parte dell' opera di Isacco (indicati nelle citazioni con la cifra iniziale romana II) sono stati tradotti dalla versione dello stesso Alfeev, basata sull'edizione critica siriaca di Sebastian Brock (Leuven 1995), pubblicata a Mosca nel 1998, con l'eccezione delle quattro Centurie di conoscenza, corrispondenti a Isacco II,3, tradotte a cura di André Louf in francese dal ms. Teheran, Issayi 4· L'edizione francese del presente libro è stata accresciuta rispetto a quella russa (Mosca 1998) e inglese (Kalamazoo zooo), essendo l'autore venuto a conoscenza di alcuni testi di Isacco rimasti fino a quel momento inaccessibili; di conseguenza è su di essa che è stata condotta la presente traduzione italiana [N.d.T.].
5

Allora mi chiesi: "Chi è questo Isacco che parla di compassione con un sentimento così forte dell'unità cosmica?". per lì la mia curiosità non fu soddisfatta, ma decisi di tenere presente il nome di Isacco il Siro nell'ambito delle mie indagini.
Non passò molto tempo prima che lo incontrassi di nuovo, citato più volte nel libro di Vladimir Lossky sulla teologia mistica della chiesa orientale. Mi colpirono soprattutto le parole riportate da Lossky sui tormenti dell'inferno: secondo Isacco, le anime che sof frano nell'inferno non sono castigate né dalla collera di Dio, né da un suo desiderio di vendetta -giacché in Dio non c'è posto per la crudeltà o per la rappresaglia ma dalla '1rusta dell'amore". "La sofferenza che colpisce il cuore a causa dei peccati contro l'amore è più terribile di qualsiasi altro castigo", scrive Isacco. "Sarebbe fumi luogo pensare che i peccatori nella geenna siano privati dell'amore di Dio ... Ma la forza dell'amore ha un duplice effetto: tormenta i peccatori ... e richiama a sé quelli che pagano il loro debito "2•
Commenta Lossky: "L'amore di Dio diventa una tortura intollerabile per quelli che non lo possiedono dentro di sé"3•
Ancora una volta, come per la citazione del "cuore misericordioso", si spalancava inaspettatamente una grande finestra nel mio animo, e tutto il mio mondo interiore era inondato di luce. Sentivo che questa era l'unica spiegazione convincente del giudizio finale e dell'inferno. Dio è amore, e il suo amore è inesauribile; dunque il suo inesauribile amore non ha mai fine, nemmeno all'inferno. An-che se questo amore in due modi" ...
Il mio te1·zo incontro con Isacco il Siro fu dovuto a un m·ticolo dello studioso cattolico Irénée Hausherr circa l'insegnamento dì Isacco sull'incarnazione4. Isacco sostiene che la nascita di Cristo a
Touraille sur la de l'Eglise d'Orient, Aubier, Paris I944·
naucsneJ:r, "Un précurseur théologie scotiste sur la fin de l'Incarna-tion", in Recherches sciences religieuses 22 (1932), pp. 316-320, ripreso in Id., Étu-des de spiritua!ité orientale, Pro, Roma r969, pp. r-5.
6
Betlemme fu l'evento più felice di tutta la storia del mondo. Ma non era assurdo che la cagione dell'avvenimento più gioioso fosse un fatto che non avrebbe assolutaniente potuto e, in fin dei conti, neppure dovuto verificarsi, cioè il peccato dell'uomo? No, il motivo principale dell'avvento del Salvatore fra noi non fu negativo ma positivo, non il peccato dell'uomo ma l'amore di Dio: "Dio ha fatto tutto questo al solo scopo di mostrare al mondo il suo amore". Si è incarnato "non per riscattarci dal peccato né per altre ragioni, ma unicamente perché il mondo conoscesse l'amore che Dio porta alla sua creazione"5•
Ancora una volta fui colpito dalla profondità delle parole di Isacco. L'incarnazione non deve essere considerata unicamente un "progetto sub condicio ne", escogitato da Dio in risposta alla caduta; essa è invece espressione della natura eterna di Dio e del suo amore spinto fino al sacrificio. Nel pensiero di Isacco trovai inaspettatamente conferma della dottrina di Duns Scoto sulla causa dell'incarnazioné. Compresi però che Isacco non si era chiesto se l'incarnazione avrebbe avuto luogo senza il peccato dell'uomo: è un problema irreale, perché il mondo esistente, che noi conosciamo per esperienza personale, è un mondo successivo alla caduta, rito dal peccato, nel quale i padri generalmente non si ponevano domande ir-reali. Non si chiedevano "che cosa sarebbe successo se ... ?", ma facevano teologia a partire da una realtà che è ancora la nostra. Con la discrezione caratteristica dei padri della chiesa, Isacco si limita ad affermare che la causa dell'incarnazione fu l'amore di Dio.
Nei primi tre jncontri con Isacco fui colpito sempre dallo stesso tema: l'amore. E l'amore che spiega - nei limiti del possibile la
5 Centurie di conoscenza IV, 78. 6 La stessa conferma si trova presso un contemporaneo di Massimo il Con-
fessore. Cf. G. Florovskij, '"Cur Deus Homo?'. The Motive of Incarnation", in Tbe Co!!ected Works of Georges Florovsky III, Nordland, Belmont 1976, pp. r63-I70; 3 I0-3 14.
7

creazione del mondo e l'incarnazione di Cristo. È sempre l'amore e nient'altro che ci rende capaci di abbracciare con la compassione i dolori del mondo e trasformar/i. Ed è ancora la logica dell'amore di Dio che ci offre una chiave di comprensione dell'oscuro mistero dell'inferno. Mi colpiva non solo il fatto che Isacco ponesse l'amore al centro del suo pensiero teologico, ma anche il suo modo diretto, semplice e vigoroso di parlare dell'ordine divino e dell'amore. Prima di lui, escluse le sacre Scritture, non ho mai trovato nessuno capace di dire così tanto in così poche parole.
Non molto dopo i miei primi tre incontri con [sacco, mi imbattei nella traduzione inglese dei suoi discorsi ad opera di Arent fan Wensinck. Li leggevo saltuariamente, non senza difficoltà ma sempre con vivo interesse. Trascrivevo le citazioni su schede, fino a costruirmi uno schedario completo. A lavoro quasi finito, e benché avessi già letto più di quattrocento pagine, mi restava una sete inestinguibile di saperne di più. Grazie alla prefazione di Wensinck e ad altre fonti appresi che [sacco era un monaco vissuto in Mesopotamia nell'viii secolo e che aveva occupato per breve tempo la sede episcopale di Ninive, per poi ritirarsi sui monti a vivere da eremita. Sapevo che era appartenuto alla chiesa d'oriente detta comunemente "nestoriana" ma, come appresi a poco a poco, ciò non significava che il suo insegnamento né quello della comunità ecclesiale di cui faceva parte potesse essere tacciato d'eresia.
Decenni più tardi, seguendo il percorso delle mie letture, raccolsi come tessere di mosaico tutto ciò che potei trovare di propedeutico alla lettura di [sacco. Ma oggi finalmente, con mia grande gioia, disponiamo di una monografia e di un'analisi equilibrata ed esauriente della vita e della dottrina di Isacco e del contesto storico e teologico in cui egli visse7. Padre Ilarion Alfeev ha dato prova di saggia
7 Alla quale si è recentemente aggiunto il libro di S. Chialà, Dall'ascesi eremitica alla misericordia infinita. Ricerche su Isacco di Ninive e la sua fortuna Leo S. Olschki Firenze 2002 [N.d.T.]. ' '
8
ispirazione dando sovente la parola a [sacco stesso. Il suo libro contiene una ricca silloge di citazioni scelte con cura, nelle quali possiamo ascoltare chiara e viva la voce di Isacco. Padre Ilarion ha avuto il grande vantaggio di potersi avvalere della seconda parte della sua opera, data a lungo per persa e solo recentemente scoperta e pubblicata da Sebastian Brock.
"Non voglio contare e ricontare le pietre miliari lungo il cammino, ma raggiungere la camera nuziale dello sposo", scriveva [sacco. "Per arrivarci più in fretta prendo tutte le scorciatoie "8
• Queste parole non sono prive di legame con la sua esperienza spirituale: egli non ci propone le pietre miliari o le mappe di una geografia spirituale; questi scritti non costituiscono un itinerario dettagliato del percorso spirituale del cristiano tappa per tappa. [sacco è un intuitivo, non sistematizza. La sua opera è piena di ripetizioni e digressioni inattese in cui i vari temi collidono, di aforismi e di pensieri talora oscuri. Ma dietro questa apparente mancanza di sistematicità si cela un ins~gnamento spirituale straordinario per armonia e logica interiore. E proprio questo l'aspetto che viene più particolarmente evidenziato nel libro di padre Ilarion: raggruppando in un sistema saldamente articolato i punti fondamentali dell'insegnamento di Isacco sulla vita in Cristo, esso mostra con chiarezza l'unità e la coerenza che ne caratterizzano la visione spirituale.
Se [sacco fu un asceta e visse da eremita sui monti, non per questo la sua opera è priva di portata universale. Essa si rivolge non solo agli eremiti ma anche agli uomini delle città; non solo ai monaci ma a tutti coloro che credono in Cristo. Isacco parla in modo estremamente vivo di un punto essenziale per ogni cristiano: il pentimento, l'umiltà, le diverse forme della preghiera orale e interiore, la vita solitaria e la vita in comune, il silenzio, il rapimento e l'estasi. Insiste poi sull'amore "illuminato", insieme al quale sviluppa altri due temi caratteristici della sua descrizione del percorso mistico del
8 I, 75 (p. 366) = Touraille 28 (p. r82); PR So (p. 548).
9

cristiano: il senso di Dio come mistero vivente e la sua profonda devozione per il Cristo salvatore.
Quando nel XIV secolo Gregorio il Sinaita, monaco e autore spirituale, volle consigliare delle letture ai suoi discepoli, diede particolare rilievo a Isacco: "Leggi sempre ciò che riguarda il silenzio e la preghiera, in particolare san GùJVanni Climaco, sant'Isacco e san Massimo ... "9.
E quando nel XIX secolo il filosofo slavo/ilo Ivan Kireevskij volle individuare un autore in cui si incarnasse la spiritualità ortodossa nel suo complesso, scelse Isacco il Siro, i cui scritti, secondo lui, si distinguevano da quelli degli altri padri della chiesa per un'eccezionale profondità spirituale10 .
Chi leggerà il libro di padre Ilarion non stenterà a capire perché Gregorio il Sinaita e Ivan Kireevskij abbiano di Isacco il Siro una così alta stima.
fB Kallistos (Ware) vescovo di Diokleia
9 Gregorio il Sinaita, La quiete e i due modi della preghiera I I. 10 I. Kireevskij, Polnoe sobranie soCinenij II, Tip. imp. Mosk. Univers., Moskva
I9II, pp. II8·II9.
IO
Introduzione ISACCO DI NINIVE,
AUTORE SPIRITUALE DELLA CHIESA D'ORIENTE
Mar I sacco parla la lingua degli esseri celesti ... Giovanni Ibn N usai
La storia del cristianesimo di lingua siriaca si basa su tre principali tradizioni ecclesiastiche e teologiche risalenti all'epoca dei concili ecumenici (rv-vrr secolo )1. C'è in primo luogo la chiesa siro-ortodossa, nota anche come chiesa siro-occidentale o giacobita 2, che si considera erede della cristologia di Cirillo di Alessandria e Severo di Antiochia e rifiuta il concilio di Calcedonia (451). C'è poi la chiesa siro-orientale 3 che rifiuta il concilio di Efeso (431) e considera suo teologo e dottore principale Teodoro di Mopsuestia. Infine, bisogna citare alcune comunità di lingua sh·iaca in Siria e nel Libano, che accolsero la cristologia di Calcedonia e si divisero poi in due gruppi: i melchiti, che accettarono il sesto concilio ecumenico ( 68o), e i maroni ti che lo rifiutarono.
1 Cf. S. Brock, "The Syriac Background", in Archbishop Theodore. Commemorative Studies 011 Hù Life and Influence, ed. by M. Lapidge, Cambridge University Press, New York-Cambridge I995, pp. }O·} I.
2 Essa prende il nome da uno dei suoi capi più eminenti: Giacomo Baradeo (v secolo). Dai suoi avversari teologici viene anche chiamata "monofisita".
1 Chiamata anche "nestoriana" dai suoi avversari.
II

!sacco di Ninive o !sacco il Siro apparteneva alla chiesa siro-orientale, i cui confini allora coincidevano press'a poco con quelli dell'impero persiano dei Sassanidi (attuali Iraq e Iran). Questa chiesa era davvero nestoriana, come sostenevano i suoi nemici? Bisognerà rispondere alla domanda per accertare se !sacco fosse nestoriano o no.
In questo capitolo introduttivo ripercorreremo brevemente la storia della chiesa orientale e le principali correnti teologiche presenti in Siria nel corso del VII secolo. Analizzeremo quindi le informazioni in nostro possesso sulla vita e gli scritti di !sacco, per concludere con un richiamo alle fonti principali della sua teologia.
La chiesa d'oriente al tempo di Isacco
Comunità cristiane sono esistite in Persia fin dai primi secoli della nostra era 4• Il cristianesimo vi si era diffuso in un primo momento fra gli ebrei e successivamente fra gli originari della Persia che praticavano la religione di Zoroastro. Da parte del clero di questa religione nel m e IV secolo i cristiani di Persia subirono crudeli persecuzioni; particolarmente dura fu quella che ebbe luogo verso la metà del IV secolo, sotto il regno di Shabur II.
Per molti secoli la chiesa persiana ebbe scarsi contatti con le chiese dell'impero romano. Nei primi tempi l'isolamento geografico contribuì in buona parte a determinare il corso della sua storia, giacché proprio in tale ambiente si svilupparono le sue
' Il compendio storico della chiesa siriaca contenuto in questo capitolo è principalmente ispirato al ricercatore ortodosso americano Dana Miller, nella postfazione della sua traduzione inglese della prima parte delle opere di Isacco.
12
peculiari tradizioni liturgiche, furono fondate le sue scuole teologiche e venne elaborato un vocabolario teologico specifico.
Un altro fattore che contribuì ulteriormente alla specificità del cristianesimo persiano furono gli stretti legami tra chiesa e sinagoga, che si protrassero molto più a lungo che in occidente. Le radici semitiche di questo cristianesimo sono ancora molto evidenti in Afraat, per esempio, detto il "Saggio persiano", che scrisse in siriaco nella prima metà del IV secolo. Le ventiquattro Dimostrazioni che conosciamo come di suo pugno sono caratterizzate da "un'espressione della fede semplice e biblica, l'assenza totale di qualsiasi influenza di formule derivate dal pensiero greco e un interesse costante per gli insegnamenti e i costumi ebraici" 5 .
È importante notare che il siriaco parlato allora in Persia apparteneva alla famiglia delle lingue semitiche, più precisamente era un dialetto dell'aramaico, la lingua di Gesù e degli apostoli. È per questo motivo che la traduzione dei vangeli in antico siriaco, del II o m secolo, riflette le radici semitiche del cristianesimo più fedelmente dell'originale greco. Pertanto, la tradizione teologica della lingua siriaca ha saputo conservare una stretta affinità con la lingua della Bibbia, molto più a lungo - segnatamente - della tradizione in lingua greca, che subì l'influenza del platonismo, del neo-platonismo e del pensiero filosofico greco in generale.
Per tutta la tradizione cristiana siro-orientale, quella che sarà chiamata "scuola dei persiani" (vale a dire dei rifugiati persiani) fu un centro teologico di grande importanza; venne fondata nel IV secolo a Edessa, e la sua influenza sullo sviluppo della teologia siriaca non sarà mai abbastanza sottolineata. Oggetto principale degli studi di questa scuola era la sacra Scrittura: i discepoli
' "Translator's Epilogue", in Tbe Ascetica! Homilies of Saint Isaac tbe Syrian, tr. by D. Miller, Holy Transfiguration Monastery, Boston 1984, p. 484.
I}

ascoltavano il maestro e prendevano nota delle sue interpretazioni6. La scuola era frequentata tanto dalla gioventù di lingua riaca, a Edessa e nei dintorni, quanto dagli immigrati provenienti dalla Persia 7 • I commenti biblici di sant'Efrem, che coprono solo una parte della Bibbia, sono stati utilizzati come modelli di esegesi per tutto il IV secolo e fino alla metà del v.
Tuttavia, dal momento che i commenti di non riguar-davano che una piccola parte delle sacre Scritture, si decise nel corso del v secolo di tradurre dal greco l'intero corpus dell' opera esegetica di Teodoro di Mopsuestia. ragione principale fu che Teodoro aveva commentato uno dopo l'altro quasi tutti i libri della Bibbia, adottando il metodo dell'esegesi letterale allora diffuso ad Antiochia; lo scopo di questi commenti era di rendere più chiaro il testo in sé e per sé, evitando con cura le interpretazioni allegoriche. Una volta portata a termine la traduzione delle sue opere, Teodoro di Mopsuestia divenne il commentatore biblico per eccellenza della tradizione siro-orientale: tutti gli autori spirituali facenti capo a questa tradizione, !sacco incluso, si riferivano a lui come al "beato Interprete".
La traduzione delle opere di Teodoro ebbe un'importanza cruciale il cristianesimo siriaco: insieme all'esegesi della Bibbia, anche le sue concezioni teologiche furono incorporate nella tradizione siro-orientale, comprese le opinioni cristologiche. In particolare Teodoro afferma che il Verbo di Dio ha "assunto" l'uomo Gesù; che lui- che non ha principio- è venuto a risiedere nell'uomo Gesù nato dalla Vergine; che abitava nel Cristo come in un tempio, ed era avvolto dalla natura umana come da una veste; che l'uomo Gesù era stato unito al Verbo e aveva ricevuto la dignità di Dio grazie alla sua opera redentrice e alla morte sulla croce. In fondo, Teodoro parlava del Verbo e dell'uo-
6 Cf. G. Florovskij, Vizantijskie otcy \T·VIIIvekov, YMCA Press, Paris 1933, p. 227. 7 Cf. D. Miller, "1hnslator's Epilogue", p. 489.
mo Gesù come di due soggetti la cui unione nell'unica figura del Figlio di Dio incarnato non era né antologica né essenziale, ma solamente di ragione ed esistenziale in rapporto al nostro modo di comprendere: quando adoriamo il Cristo, siamo noi che facciamo l'unione delle due nature, professando non già "due figli" ma un solo Cristo, Dio e uomo.
Negli anni 'zo del v secolo questo insegnamento divenne elemento fondante dell'insegnamento cristologico di Nestorio, patriarca di Costantinopoli, contro il quale si Cirillo di Alessandria. Il punto cruciale della sua polemica contro il nestorianesimo concerneva l'unità della persona divina: il Verbo eterno è identico alla persona di Gesù nato dalla Vergine. N o n si può dunque parlare del Verbo e di come se si trattasse di due soggetti differenti. La cristologia di Cirillo fu confermata dal terzo concilio ecumenico che condannò Nestorio. Più tardi, nel quinto concilio, fu condannato a sua volta Teodoro di Mopsuestia in quanto "padre del nestorianesimo" 8. Ma agli occhi dei cristiani siro-orientali egli sarebbe rimasto per sempre un'autorità indiscussa in campo teologico. Questo spiega come la chiesa dei persiani, con tutta la tradizione teologica siro-orientale nel suo insieme, abbia finito con l'essere chiamata "nestoriana", appellativo di cui essa stessa non si era mai servita, ben consapevole di non aver avuto alcun legame storico con Nestorio.
Nel489la "scuola persiana" fu chiusa per ordine dell'imperatore Zenone. Alcuni anni prima il suo capo, Narsai, accompagnato dai propri discepoli, si era trasferito a Nisibe, avvenimento che si sarebbe rivelato di capitale importanza per gli sviluppi successivi della chiesa di Persia. Alla fine del v secolo la scuola
' I punti di vista dei patrologi moderni sul nestorianesimo di Teodoro di Mopsue-stia, come del resto su quello di Nestorio stesso, sono Una ricostruzione completa della cristologia dei due autori non sarebbe qui e inoltre esulerebbe dall'ambito della presente opera. Per la cristologia di Nestorio si soprattutto A. de Halleux, "Nestorius. Histoire et doctrine", in Irénikon 66 (r993l, pp. 38-5r; r63-I78.

di Nisibe diventerà uno dei principali centri teologico-spirituali di tale chiesa.
Alla fine del VI secolo Henana, divenuto capo della scuola nel 572, tentò di sostituire i commenti biblici di Teodoro con i propri, basati sul metodo allegorico di Origene. Il tentativo non ebbe successo, e il concilio locale del 585 confermò l'autorità incontestabile di Teodoro, al punto da diffidare chicchessia dal "criticare in pubblico o segretamente questo dottore della chiesa o confutare i suoi santi libri". Poco più tardi, nel596 e nel 6os, altri due concili condannarono i commenti di Henana e rinnovarono gli anatemi contro coloro che "mettono in discussione i commenti, le esegesi e gli insegnamenti del 'dottore infallibile', il beato Teodoro l'Interprete, e cercano di introdurre esegesi nuove ed estranee, piene di sciocchezze e di bestemmie" 9 • La fede della chiesa di Persia era diventata "la fede di Teodoro", o quella di "Teodoro e Diodoro", giacché nella tradizione siro-orientale il nome di Diodoro di Tarso era circonfuso di un'eguale aura di santità e di autorevolezza teologica.
La fine del VI secolo e l'inizio del VII furono segnati dall'attività teologica di Babai il Grande, che scrisse a lungo su temi cristologici. La sua cristologia attua una sorta di sintesi tra quelle di Teodoro, di Diodoro e di Nestorio 10 • Essendo uno dei capi del partito conservatore che rivendicava rigorosa fedeltà agli insegnamenti di Teodoro, Babai fu in prima linea nell'opposizione al concilio di Calcedonia. Egli insistette sulla teoria dei due qnome nel Cristo incarnato, utilizzando un temine - qnoma, che è maschile in siriaco - usato per rendere il greco hyp6stasis, ma che in lui acquistava un significato un po' diverso 11 . L'allusione
9 Ci t. in D. Miller, "Translator's Epilogue", p. 503. 10 Cf. G. Chediath, Tbe Cbristology of Mar Babai tbe Great, Pontificia Università
Lateranense, Roma 1982, p. 194. 11 Si veda la trattazione sulla terminologia cristologica siriaca nella sezione seguente
di questo capitolo.
r6
di Babai a due qnome aveva tutta l'apparenza di un conflitto frontale con la definizione di Calcedonia che era approdata alla formula "una hyp6stasis (qnoma in siriaco) in due nature". Nello sviluppare le concezioni cristologiche di Teodoro, Babai utilizzò in parte Nestorio, specialmente il suo Libro di Eraclide, un'apologia scritta dopo la condanna ad opera del concilio di Efeso e tradotta in siriaco verso la metà del VI secolo 12 • Cent'anni dopo i nomi dei "tre dottori", cioè Diodoro, Teodoro e Nestorio, furono inseriti nei dittici della chiesa d'oriente 13 , e da allora vi furono costantemente menzionati.
La cristologia della chiesa d'oriente
Si deve concludere che la chiesa cui Isacco apparteneva fosse nestoriana? Per rispondere, dobbiamo interrogarci sulle ragioni che spinsero questa chiesa a non accettare i concili di Efeso e di Calcedonia.
Si sa che le controversie cristologiche del v secolo portarono alla luce punti di vista diversi circa la relazione tra l'umanità e la divinità di Gesù Cristo. In particolare i rappresentanti della scuola di Antiochia, Diodoro di Tarso, Teodoro di Mopsuestia e Nestorio di Costantinopoli, usavano per esprimere l'unità fra le due nature delle formule di questo tipo: Dio, il Verbo, "assunse" l'uomo Gesù; il Verbo non generato di Dio "abitava" in colui che nacque da Maria; il Verbo dimorava in quest'uomo come nel suo "tempio"; il Verbo si rivestì della sua natura umana come di una "veste". L'uomo Gesù era unito al Verbo e aveva as-
12 Benché Babai non citi mai Nestorio, la sua conoscenza del Libro di Eraclide appme evidente; cf. D. Miller, "Translator's Epilogue", p. 504.
13 Cf. D. Miller, "Translator's Epilogue", pp. 507·508.
17

sunto la dignità di Dio. Se si fosse loro domandato: "Chi ha patito sulla croce?", avrebbero risposto "la carne del Cristo", "l'umanità di Cristo", la sua "natura umana" o "ciò che vi era in lui di umano" 14• Essi tracciavano in tal modo una linea nettissima tra le due nature, divina e umana. Nel corso della vita terrena di Gesù le due nature avevano conservato ciascuna le sue caratteristiche proprie. Volendo dunque parlare oggi dell'unità delle due nature, essa sarebbe d'ordine piuttosto che antologico: essa esiste nel nostro modo di comprendere il Cristo, nel nostro modo di rivolgergli un culto, quando noi costituiamo l'unità delle due nature per venerare un solo Cristo, Dio e uomo nello stesso tempo.
La corrente alessandrina, entrò in conflitto con Nestorio nella persona di Cirillo di Alessandria, oppose allo schema antiocheno un altro modo di comprendere l'unità delle due nature: il Verbo nel farsi uomo qualcosa di più che semplicemente assumere la natura umana; il Verbo non-generato di Dio è la stessa persona di Gesù nato da Maria; così inteso è Dio il Verbo in persona che "ha sofferto nella carne" (épathen sarki) 15 . Pertanto c'è un solo Figlio, una sola ipostasi, "un'unica natura del Dio Verbo fatta carne" (mia physis tou theoù l6gou sesarkoméne). Quest'ultima frase, di Apollinare di Laodicea, valse a Cirillo dì Alessandria il sospetto di la "mescolanza" e la "confu-sione" delle due nature. cristologia di Cirillo fu confermata dal concilio di (43 r), ma rifiutata dalla tradizione teologi-ca siro-orientale, alla terminologia cristologica di Teodoro e Diodoro.
Il concilio di Calcedonia (451) tornò alla più rigorosa distinzione antiochena tra le due nature, ma evitò i termini di "inabitazione" della divinità nell'umanità e di "assunzione" della na-
Unily and Cbl'istian Divìsions. Tbe Cburcb, 45o-68o AD,
Crestwood r989, p. 191. ruessaJtun.a, Lettera J a Nestorio.
tura umana da parte della natura divina. L'intento della definizione di Calcedonia era di riconciliare le due parti, alessandrina e antiochena, mettendo contemporaneamente l'accento sull'u-nità dell'ipostasi di e sull'esistenza delle due natme:
All'unanimità noi a confessare un solo e medesi-mo Figlio: il nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua divinità e sua umanità, vero Dio e vero uomo ... uno e Cristo Signore unigenito; da riconoscersi in due nature, senza confusione, immutabili, indivise, inseparabili, non venuta meno la distinzione delle nature a causa della loro unione, ma essendo stata, anzi, salvaguardata la di ciascuna natura, e concorrendo a formare una sola persona e ipostasi 16•
Questa formulazione, approvata dallo stesso Nestorio 17, non ebbe successo siriaco. Gli autori del periodo imme-diatamente come Babai il Grande, la cui cristologia è affine a quella Isacco di Ninive, continuarono a parlare di "inabitazione" della divinità nell'umanità, come pure della natura umana come "tempio" o "veste" della divinità.
Perché la tradizione siro-orientale non accettò il concilio di Efeso? La risposta non va cercata nella personalità di Nestorio, di cui in fino al VI secolo si conosceva a mala pena il nome. Se le conclusioni del concilio non furono adottate dalla chiesa persiana piuttosto dalla procedura da esso seguita. Tale procedura era stata stabilita da Cirillo di Alessandria e da quanti si riconoscevano nella sua dottrina, in assenza di Giovanni di Antiochia che, non appena arrivato a Efeso, scomunicò Ci-
16 Definizione della fede del concilio di Calcedonia, in Decisioni dei concili ecumea cura dì G. Alberigo, UTET, Torino 1978, p. r64. Nel Nestorio, ancora in vita, diede la sua approvazione al Tomo a Flaviano di
che fu preso come punto di partenza per la definizione cristologi-

rillo. La posizione cristologica del concilio di Efeso fu esclusivamente alessandrina e non tenne alcun conto di quella antiochena. Ora, quest'ultima (e non, si badi bene, quella "nestoriana") era appunto la cristologia più comunemente diffusa nella chiesa d'oriente.
Più difficile è spiegare perché i siro-orientali non abbiano accettato il concilio di Calcedonia. La formula "una ipostasi in due nature" avrebbe dovuto riuscire gradita alle due fazioni opposte. In tale contesto la parola greca byp6stasis riguardava la persona specifica di Gesù Cristo, Dio il Verbo, mentre la parola phjsis (natura) si riferiva alla divinità e all'umanità di Cristo. Purtroppo nella traduzione siriaca la diversità dei due
non trovò corrispondenza adeguata, perché il siriaco qnoma (byp6stasis) rappresentava un'espressione concreta e individuale della kymza (natura). Gli autori di lingua siriaca erano
indotti a parlare comunemente delle nature e dei loro qnome. Così, quando Severo di Alessandria, monofisita, pensava che una sola ipostasi dovesse implicare un'unica natura, gli autori sostenevano che due nature dovessero riflettersi in due ipostasi 18 .
la stessa logica il catholicos Isho'yahb II (6z8-646) modo seguente le ragioni per cui la chiesa d'oriente
non poteva accettare la definizione calcedonese della fede:
Coloro che si riunirono nel sinodo di. Calcedonia, benché avessero l'intenzione di restaurare la vera fede, tuttavia se ne allontanarono: la loro terminologia difettosa, avviluppata in significati oscuri, costituì uno scoglio per molti. Pur ritenendo nell'animo di conservare la vera fede professando le "due nature", la loro formula di "un solo qnoma" sembra essere stata occasione di tentazione per le menti deboli. Alla fine si
18 S. Brock, "The 'Nestorian' Church. A Lamentable Misnomer", in Bulletin of the John Ryland's Library 78 (1996 [1997]), pp. 53-66.
20
trovarono di fronte a una contraddizione, perché con la formula "un solo qnoma" avevano corrotto la professione delle "due nature", e con quella delle "due nature" avevano to e confutato quella di "un solo qnoma". Trovandosi così a un bivio, esitarono e abbandonarono le schiere beate degli ortodossi, pur senza unirsi alle accolte degli eretici ... Non saprei proprio da che parte collocarli, giacché la loro terminologia non sta in piedi, come testimoniano la natura e la Scrittura, per le quali è possibile incontrare molti qnome in una sola "natura", ma non si è mai dato il caso che diverse "nature" possano sussistere in un unico qnoma, e nessuno ne ha mai sentito parlare19 •
Queste parole mostrano chiaramente perché la definizione calcedonese della fede fosse inaccettabile a orecchie siriache: essa aveva tutta l'apparenza dell'illogicità. È interessante notare come Isho'yahb non accusi di eresia i padri di Calcedonia: riconosce le loro buone intenzioni, ma sostiene che non sono riusciti a conciliare la tradizione di Antiochia con quella di Alessandria a causa di un compromesso terminologico che fa torto alla verità. Alla fine, il rifiuto di Isho'yahb a collocare i padri di Calcedonia o fra ortodossi o fra gli eretici mostra come quel concilio al quale la sua chiesa non aveva voluto partecipare -contasse ben poco agli occhi dei catholicos d'oriente. Quando parliamo di accettazione o non accettazione di certi concili ecumenici da parte dell'oriente esterno all'Impero romano, bisogna rammentare dal IV al vn secolo, si tennero tutti all'in-terno imperiale, e pertanto non riguardavano di-rettamente le poste al di fuori di quei confini. La chiesa d'oriente, situata nell'Impero persiano, non aveva alcun legame diretto con i mondo bizantino. Se alcuni concili han-no finito con riconosciuti dall'oriente non bizantino, ciò
19 Ci r. in S. Brock, "The 'Nesrorìan' Church".
2!

di solito è avvenuto molti anni dopo la loro celebrazione. Così, per esempio, il primo concilio ecumenico (Nicea, 325) fu riconosciuto dalla chiesa di Persia a non meno di ottantacinque anni dalla sua effettiva celebrazione20 .
Dopo questo necessariamente rapido excursus nella storia del-· le controversie cristologiche del v secolo, possiamo infine dare una risposta al problema del "nestorianesimo" della chiesa d'oriente. Se per "nestorianesimo" si intende la dottrina combattuta da Cirillo di Alessandria, quella che predicava l'esistenza di due persone differenti nel Figlio di Dio e che si sarebbe spinta fino a riconoscere "due figli" 21, ebbene, tale dottrina era totalmente estranea alla tradizione siro-orientale. Tuttavia i teologi di questa tradizione, non avendo accettato l'insegnamento di Calcedonia su "una ipostasi in due nature", parlano sempre di due qnome-ipostasi nel Figlio di Dio incarnato. Essi si trovano pertanto in opposizione verbale con la chiesa di Bisanzio. Dal v all'viii secolo hanno continuato a usare il vocabolario teologico di Teodoro di Mopsuestia e di Diodoro, vocabolario che l'oriente di lingua greca identificava generalmente con il nestorianesimo. La chiesa d'oriente continuava così a far menzione di Teodoro e Diodoro dopo che essi erano stati scomunicati a Bisanzio, e inseriva nei suoi dittici persino il nome di Nestorio molto tempo dopo la sua condanna. Tutto ciò dimostra che la chiesa di Persia, pur non essendo "nestoriana" nel senso stretto del termine, aderiva alla stessa corrente di pensiero teologico e cristologico alla quale Nestorio era vicino.
Verso la fine del VII secolo gli avvenimenti politici avevano praticamente finito con il tagliar fuori la chiesa d'oriente dal mondo bizantino, al punto che quest'ultimo non sembrava più riguardarla. Bisogna però osservare che il crescente isolamento
2° Cf. S. Brock, "The 'Nestorian' Church". 21 Anche se N es torio stesso rifiutava nettamente l'idea dei "due figli", ritenendola
il risultato di una cattiva lettura della sua cristologia.
22
della chiesa d'oriente non condusse affatto a un declino teologico o spirituale. Al contrario, fu proprio nel VII e VIII secolo che essa conobbe la più bella fioritura della sua teologia. Fu il periodo in cui autori come Martyrios Sahdona (sostenitore di Calcedonia), Dadisho', Simone di Taibuteh22 (il Misericordioso), Giuseppe Hazzaya (il Veggente) e Giovanni di Dalyata vissero e pubblicarono le loro opere. Essi erano tutti autori essenzialmente spirituali e non si occupavano di questioni cristologiche. Benché poco conosciuti fuori della tradizione siro-orientale, sono stati i principali artefici di quella che può essere chiamata "l'età dell'oro della tradizione cristiano-siriaca". Di questa età dell'oro un solo rappresentante divenne conosciuto in tutto il mondo: !sacco di Ninive.
Vita di !sacco di Ninive
I dati biografici essenziali su Isacco si ricavano da due fonti siriache: il Liber castitatis - raccolta di brevi biografie di asceti persiani ad opera dello storico siro-orientale Isho'denah vescovo di Basra - e un documento siro-occidentale di datazione e origine incerte.
Il capitolo r 24 del libro di Isho'denah si intitola: "Intorno al santo Mar !sacco, vescovo di Ninive, che lasciò l'episcopato e scrisse dei libri sulla disciplina della vita solitaria". Ecco in che termini si parla di lui:
22 Il possibile autore del Libro della grazia, che la tradizione manoscritta slavona attribuisce a Isacco. Per i dettagli del dibattito, si veda D. Miller, "Translator's Introduction", in T be Ascetica! Homilies, pp. LXXXI-Lxxxv; d. anche A. Viiobus, "Eine neue Schrift von Ishaq von Ninive", in Ostkircblicbe Studien 21 (1972), pp. 309-312, e G. E unge, "Mar Isaac of Nineveh and His Relevance Nowadays", in Christian Oriettt 4 (1986), pp. 193-195·
2}

È stato consacrato vescovo di Ninive dal catholicos Giorgio nel monastero di Bet 'Abe. Ma dopo aver ricoperto la carica di pastore di Ninive per cinque mesi ... si dimise per una ragione che solo Dio sa, e andò ad abitare sulle montagne ... Salì al monte Matut, che è circondato dalla regione di Bet Huzaye, e lì visse nella solitudine presso alcuni eremiti che si trovavano nei dintorni. In seguito si recò al monastero di Rabban Shabur. Era straordinariamente versato nelle divine Scritture, al punto di perdere la vista a causa delle letture e dell'ascesi. Penetrò a fondo nei misteri divini e scrisse libri sulla disciplina divina della vita solitaria. Tuttavia, tre sue proposizioni da molti non furono accettate: Daniele Bar Tubarrita, vescovo del Garmai, si oppose alle tre proposizioni in questione. Abbandonò questa vita temporale in età molto avanzata, e il suo corpo fu deposto nel monastero di Shabur. Isacco era nativo di Bet Qatraye, e credo fosse oggetto di gelosia da parte di coloro che abitavano le regioni interne della Persia23 .
La fonte siro-occidentale contiene indicazioni analoghe. Essa non fa cenno delle controversie che hanno accompagnato le proposizioni teologiche di !sacco, ma ne completa il ritratto con alcuni elementi nuovi. In particolare, segnala che furono i suoi discepoli a metterne gli insegnamenti per iscritto, dopo che !sacco fu diventato cieco:
Lo chiamavano un secondo Didimo. In effetti era sereno, amabile e umile, e le sue parole erano gentili. Non mangiava che tre pani alla settimana con un po' di verdura e si asteneva rigorosamente dai cibi cotti. Scrisse cinque volumi giunti fino ai giorni nostri, pieni di soavi insegnamenti 24
.
23 Isho'denah di Basra, Li ber castitatis 63-64. 24 Studia syriaca I, ed. L Rahmani, Seminarium Scharfense, Monte Libano 1904,
pp. }2-33·
La provincia del Qatar in cui !sacco vide la luce si trova sulla costa occidentale del Golfo persico (il Qatar fa oggi parte degli Emirati Arabi Uniti). I sacco passò dunque gli anni della sua giovinezza vicino al mare, e nei suoi scritti le immagini marine abbondano. Ama evocare navigli, capitani con le loro ciurme, tempeste, tuffatori e ostriche strappate agli abissi. Ecco uno di questi passi:
Quando vedi che la tua barca naviga felicemente verso il porto, che una brezza deliziosa e piacevole spira costante, che nelle tue mani i commerci prosperano a meraviglia, è allora che ti devi preoccupare di più e gemere per paura di una fine improvvisa della tua libertà 25 , che devi temere un rovesciamento della situazione, facendo in modo che la vigilanza osservata durante tutto il viaggio non finisca con l'essere vanificata dall'esserti abbandonato, per via delle circostanze, a un rilassamento della volontà 26
.
Ed ecco un altro testo analogo:
Se il tuffatore trovasse una perla in ogni ostrica, chiunque sarebbe subito ricco! E se appena tuffato ne riportasse una alla superficie, senza venire sbattuto qua e là dalle onde, senza incontrare squali, senza dover trattenere il respiro fin quasi a soffocare, senza privarsi dell'aria fresca di cui tutti godono, senza dover scendere negli abissi del mare, se così fosse, le perle sarebbero numerose e frequenti come il lampeggiare di un temporale lontano 27
•
2 ' È possibile un'altra traduzione: "per paura che la tua libertà subisca un cambiamento a causa della tua quiete"; la quiete infatti può "far addormentare" l'asceta.
26 Centurie di conoscenza II,96. 27 Il,34.4·

Quest'ultima citazione mostra fino a punto Isacco avesse familiarità con il mestiere del tuffatore. Non è da escludere che lui stesso, da giovane, sia andato a pesca di
La chiesa cristiana del Qatar era allora sottoposta al catholicos d'oriente. Verso il 648 i vescovi del Q a tar si separarono dal catholicos di Persia, dando così origine a uno scisma che durò fino al 676, quando il catholicos Giorgio al Qatar e riconciliò i vescovi con la sua chiesa. Può darsi Isacco, noto per il rigore della sua vita ascetica, sia stato consacrato vescovo di Ninive in questa occasione.
Ebbe poco successo nell'incarico. Una leggenda .,.u·u-,_,~~'-u"''"''conservata in traduzione araba fornisce qualche informazione sulle sue dimissioni. Il giorno successivo alla consacrazione Isacco stava seduto in casa quando due litiganti entrarono nella sua stanza. Uno reclamava dall'altro il rimborso di un prestito: "Se costui rifiuta di restituirmi ciò che mi appartiene, sarò costretto a trascinarlo in giudizio". Isacco rispose: "Poiché il santo evan-gelo ci insegna a non riprendere ciò che è stato dato, si la-sciare a quest'uomo almeno un giorno di tempo per la restituzione". L'uomo gli rispose: "Lascia da parte, per ora, insegnamenti dell'evangelo", e Isacco di rimando: "Se qui vangelo non ha valore, che cosa ci sono venuto a fare?", e do il ministero pastorale avrebbe turbato la sua vita solitaria "il sant'uomo rinunciò alla carica di vescovo e fuggì nelr~ac<>>rrn di
Quest'ultima precisazione contraddice quanto sappiamo dalla cronaca di Isho'denah precedentemente citata, la quale sostiene
Isacco si sulle montagne dello Huzistan, non in rl"''''"'r''" di Scete. Sembra poi inverosimile che le sue dimis
siano state provocate da quell'unico e tutto sommato
:Spirituatity in the Syriac Tradition, SEERI, Kortayam 1989, p. 33; D. Introduction", pp. LXVIII-LXLX.
gnificante episodio. È più probabile che la nomina di Isacco, originario di una diocesi di provincia come il Qatar che si era trovata in una situazione di per quasi trent'anni, sia stata accolta male dagli abitanti di Ninive. città era all'epoca uno dei centri più attivi dei giacobiti, ai quali ci si aspettava che Isacco come vescovo si opponesse29 . Poco attratto dalle argomentazioni di carattere dogmatico, egli avrà preferito andarsene da Ninive, destinata d'altronde a diventare teatro di conflitti.
Quali fossero le tre "proposizioni" attribuite a !sacco, e per quale preciso motivo Daniele Bar Tubanita gli si fosse opposto, resta un enigma. Sappiamo Daniele compose "una risposta alle questioni sollevate dal quinto volume di Mar !sacco di Ninive" 30
• Ma la sola testimonianza a noi conservata di questa opera di Daniele è dovuta a un autore siro-orientale del IX secolo, Ha-nun Ben Yuhanna Ibn as-Salt, il quale la visita resa dal catholicos Giovanni Ibn Narsai a un monaco. Il metro-polita aveva portato con sé gli scritti Isacco e li lesse ad alta voce, "senza alzare la testa, fino al tramonto del sole". Quando ebbe finito, il monaco gli chiese quali più degni di fede, quelli di !sacco o quelli che Daniele aveva scritto per confutarlo. Il metropolita rispose: "Com'è possibile che uno come te mi faccia una domanda del genere? Mar !sacco parla la lingua degli esseri celesti, Daniele quella dei 31
Isacco passò gli ultimi anni della sua vita monastero di Rabban Shabur sul monte Shushtar32• Non conosciamo la data
29 D. Miller, "Translator's Introduction", pp. LXIX-LXX. 30 G. S. Assemani, Bibliotheca orientalis, III,r. De scriptoribus syris nesto1ianis, Typis
Sacrae Congregatìonìs de Propaganda Fide, Romae 1728, p. ro4. 31 Tivités religìeux, pbilosopbìques et moraux. Extraits des oeuvres d'Jsaac de Ninive
par Ibn as-Salt, éd. par P. Sbath, Impr. al-Chark, Le Caire 1934. pp. 32 Cf. Isacco di Ninive, Disco1~i spilituali. Capitoli sulla conoscenza. n<:lmtc.r<:.
templazìone sull'argomento della gebenna. Alfi-i opuscoli, a cura di P. Base r8. Questa montagna è situata nel Kurdistan settentrionale. ce ai
27

precisa della sua morte, né quella della nascita. È probabile che sia stato venerato come santo ancora in vita, e la sua gloria aumentò dopo la morte, con il progressivo diffondersi delle sue opere. Giuseppe Hazzaya, nell'viii secolo, lo chiama "celebre fra i santi" 33 . Un altro autore siria co parla di lui come di un "maestro e dottore di tutti i monaci e salvezza dell'universo intero"34. Nel corso dell'xi secolo Isacco divenne molto noto nell'oriente di lingua greca grazie alla traduzione delle sue opere: nell' Everghetin6s, celebre antologia di testi ascetici, i passi tratti da "abba !sacco il Siro" stanno alla pari dei classici della spiritualità bizantina antica. È così che un semplice vescovo "nestoriano" originario di una remota provincia della Persia riuscì a diventate un "santo padre della chiesa ortodossa d'orientamento calcedonese ", fenomeno più unico che raro nella storia del cristianesimo d'oriente 35 .
Gli scritti di Isacco
L'anonima fonte siro-occidentale che abbiamo precedentemente citato parla di "cinque volumi" di pugno di !sacco. Un autore del XIII secolo che ci ha lasciato un elenco degli autori siro-orientali, 'Abdisho' di Ninive, riporta sette libri di !sacco "sul tema della disciplina spirituale, dei misteri divini, dei giudizi, e sulla provvidenza" 36 . Impossibile sapere se si tratta di
33 A. Mingana, Woodbroke Studies, VII. Ear!y Christian Mystics, W. Effer and Sons, Cambridge I934. p. 268.
"].-B. Chabot, De S. Isaaci Ninivitae vita, scriptis et doctrina, ex. Lefever F. et S., Parisiis-Lovanii I 892, p. VII.
" La festa di sant'Isacco il Siro, vescovo di Ninive, si celebra il IO febbraio (28 gennaio secondo il calendario antico), contemporaneamente a quella di sant'Efrem.
36 G. S. Assemani, Bib!iotbeca orienta!is III, I, p. I74·
una diversa ripartizione dello stesso corpus di testi, o se alcune opere di !sacco sono a tutt'oggi perdute. Per ora, siamo in possesso di due gruppi di opere, il primo dei quali oggi ampiamente conosciuto e tradotto in molte lingue, il secondo invece ignoto fino alla sua recentissima scoperta 37 .
Il testo originale del primo gruppo è giunto a noi in due recensioni differenti, una orientale e una occidentale38 . La prima è stata edita da Paul Bedjan, in una pubblicazione che è l'unico testimone a stampa della prima parte dell'opera di Isacco39; la seconda si trova in numerosi manoscritti, il più antico dei quali risale al IX o x secolo40 . Ecco le differenze principali tra le due recensioni: r) l'orientale contiene molti passi, tra cui otto interi discorsi, che non figurano in quella occidentale; z) l'occidentale contiene alcuni passi non presenti in quella orientale; 3) nella recensione orientale compaiono citazioni di Teodoro di Mopsuestia e Diodoro di Tarso che in quella occidentale vengono attribuite ad altri padri. Senza dubbio è la recensione orientale quella che riflette il testo originale di !sacco, mentre l'occidentale rappresenta una lettura siro-ortodossa dei suoi scritti 41 .
La traduzione greca di !sacco - fine VIII, inizio IX secolo - fu condotta sulla recensione occidentale ad opera di Abramo e Patrizio, due monaci della laura di San Saba in Palestina. In essa le citazioni di Evagrio furono attribuite a Gregorio di Nazianzo, mentre alcune omelie e alcuni passi oscuri furono omessi.
37 La prima parte delle opere di Isacco, edita da Pau! Bedjan, contiene 82 discorsi, la seconda 41. Poiché due discorsi della prima parte sono riprodotti pari pari nella seconda, l'insieme degli scritti di Isacco consta di I 2 I discorsi. Tenendo conto del fatto che la più antica traduzione araba della sua opera (rx secolo) ne conta I22 (cf. l'introduzione alla traduzione russa delle opere di Isacco, edita a Sergiev Posad nel I9II), è molto probabile che gli scritti di Isacco che ci sono pervenuti in lingua siriaca rappresentino la totalità del corpus (anche se alla luce delle più recenti ricerche il quadro si presenta oggi più complesso: cf. S. Chialà, Dall'ascesi eremitica, pp. 65-83 [N.d.T.]).
38 Cf. D. Miller, "Translator's Introduction", pp. LXVII-LXXVIII. 39 Nelle note del presente libro questa edizione è indicata con la sigla PR. 4° Cadex Sinaiticus syriacus 24. 41 Cf. D. Miller, "Translator' s Introduction", p. LXXVill.

D'altro canto, vi furono incluse quattro omelie di Giovanni di Dalyata42 , come pure la cosiddetta Lettera a Simeone, che in realtà è opera di un autore siro-orientale del V-VI secolo, Filosseno di Mabbug43
. Questa traduzione greca è abbastanza letterale e conserva pertanto molti passi poco chiari dell'originale siriaco. Sembra addirittura che in certi punti il traduttore non abbia capito il senso dell'originale, e ciò spiegherebbe i numerosi errori di questa traduzione 44 che, stampata per la prima volta a Lipsia nel 1770 45
, vide in seguito numerose ristampe. A partire dal greco, l'opera di Isacco fu tradotta in georgiano
(x secolo), slavone (xiv) e latino (xv); dal latino in portoghese, spagnolo, catalano, francese e italiano (xv e XVI secolo). Più tardi, sulla base dell'edizione greca a stampa, Isacco fu tradotto in rumeno (1781), russo (1854 e 191 1), greco moderno (187I), francese (1981) e inglese (1984); nonché dal russo in giapponese (1909). Nell'antichità la sua opera fu tradotta in arabo (Ix secolo) e in etiopico (prima del XIV secolo) sulla base del siriaco; poi, in epoca moderna, parzialmente in tedesco (1876), quindi in in-
42 I, discorsi 15, 16, 17 e 31 dell'edizione greca a stampa. 43 E la lettera 4 nell'edizione greca di !sacco, ma corrispondente in realtà alla Lette
ra a Patrizio di Filosseno; cf. La lettre à Patricius de Pbi!oxène de Mabboug, éd. par R. Lavenant, Firmin-Didot, Paris 1963 (Patrologia orientalis 30,5).
44 Si veda il giudizio di Filarete di Mosca: "Il traduttore probabilmente non era un erudito; ignorava le regole grammaticali e quindi mischiò le parole e al posto delle espressioni appropriate mise parole scorrette e oscure, che potrebbero ancl~e essere opera dei copisti, al punto di moltiplicare gli errori e le inverosimiglianze" (Zizneopisaniia otecestvemzycb podviinikov b!agocestiia xvm-xrx vv., Sentjabr', Moskva 1909, p. 497); cf. anche Georgij Florovskij; "Questa traduzione è spesso scorretta ... Nel testo siriaco c'è meno ordine e più spontaneità" (Vizantiiskie otcy, p. r86).
45 Con il titolo Toz2 bosfou patròs bemfm Isaàk episk6pou Nineuì tot2 Syrou tà beuretbénta asketikd. La citazione completa si trova in bibliografia. Chi scrive ha avuto modo di lavorare sui manoscritti greci di !sacco conservati nel monastero di Santa Caterina del Sinai, nella Biblioteca nazionale di Parigi e nella Biblioteca vaticana. La tradizione manoscritta delle opere di !sacco in greco ha avuto una diversa evoluzione. Un'analisi preliminare di questa tradizione rivela che sono esistite almeno due redazioni del testo di !sacco; una redazione primitiva (che apparve verso l'viii-IX secolo) e una più tarda, collegata al risveglio esicasta a Bisanzio (xm-xrv secolo). Le edizioni a stampa del testo greco rispecchiano la redazione più tarda, che ha cambiato l'ordine e la numerazione dei discorsi.
30
glese (192 1) 46, e ancora parzialmente in italiano (1984). Da sola,
questa lista di traduzioni (certamente incompleta) mostra in modo evidente la grande popolarità di cui hanno goduto fino a oggi gli scritti di Isacco, soprattutto negli ambienti monastici.
Come abbiamo visto, la maggior parte di queste traduzioni si sono basate sul testo greco, che non solo rifletteva la recensione siro-occidentale di Isacco, ma era a sua volta una rilettura ortodossa di questa recensione, ritenuta dai traduttori greci "monofisita". In altre parole, per dieci secoli il mondo ha conosciuto solo un Isacco "riveduto e corretto", inizialmente travestito da "nestoriano" in "monofisita", e infine da "monofisita" in "ortodosso" 47 .
Oggi siamo in grado di scoprire il vero Isacco grazie alla pubblicazione della prima parte ad opera di Bedjan, e più ancora grazie alla seconda parte scoperta di recente. Bedjan ne conosceva l'esistenza e ne aveva pubblicato alcuni frammenti nella sua edizione della prima parte48
, servendosi di un manoscritto che poi (nel 1918) sarebbe andato perduto. Fortunatamente nel 1983 Sebastian Brock poté identificare la seconda parte nella sua interezza in un manoscritto della Biblioteca bodleiana di Oxford, risalente al x o XI secolo 49 • L'identità dell'auto-
46 Mystic Treatises by Isaac o/ Nineveb, ed. by A. J. Wensinck, Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam 1923.
47 Mettiamo questi termini tra virgolette per sottolineare il carattere di ambiguità che essi presentano nella tradizione siriaca.
48 Si veda PR, pp. 585-6oo. Bedjan fornisce anche alcuni estratti di una terza parte (PR, pp. 6or-6z8), ma questi di fatto appartengono a Dadisho' Qatraya (VII secolo). Cita inoltre il Libro della grazia, da lui attribuito a !sacco, ma la cui autenticità è messa in dubbio dall'odierna ricerca; Miller sostiene che non sia di mano di !sacco ma piuttosto di Simone di Taibuteh ("Translator's Introduction", pp. LXXXI-LXXXV).
49 Oxfozd, Bodleian Lib. sir. e. 7, proveniente dal monastero di Mar 'Abdisho', appartenente a Rabban Isho' del villaggio di Bet Shrift, scritto in caratteri siro-orientali chiamati estrangbe!a. Il nome del copista è Marco. Il manoscritto fu acquisito dalla Biblioteca bodleiana nel 1898. Una copia del manoscritto, datata r895, si trova nella biblioteca dell'arcivescovo caldeo di Teheran, Mar Yuhannan Issayi, recentemente scomparso (Teheran, Issayi 4). Il testo integrale della seconda parte di !sacco si trova parimenti nei mss. Paris, Bibl. Nat. sir. 298 e Hmvmd sir. 57 (ma solo una parte di
3I

re non dà adito a dubbio: lo stile, la lingua, la grammatica e la sintassi, il vocabolario e i temi affrontati tradiscono con tutta evidenza la mano di Isacco. Fra l'altro, in molti luoghi l'autore rimanda ai discorsi della prima parte. E ancora, i discorsi r 7 e 2 della seconda parte sono identici ai 54 e 55 della prima. Si può osservare che, ad onta della minore diffusione e del fatto di non essere stata tradotta in greco, questa seconda parte era tuttavia nota oltre i confini della chiesa d'oriente, anche fra alcuni monaci calcedonesi: un manoscritto appartenente al monastero di Santa Caterina del Sinai, datato XI secolo, ne contiene dei frammenti 50
.
La seconda parte è costituita da quarantun capitoli, il terzo dei quali a sua volta contiene quattro Centurie di conoscenza, che rappresentano quasi la metà del testo recentemente scoperto. Paolo Bettiolo ne sta preparando l'edizione critica e una traduzione italiana è già disponibile 51 . I capitoli dal4 al4r sono stati pubblicati con traduzione inglese da Sebastian Brock nel Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium52
• Ha inoltre appena visto la luce una traduzione russa dei discorsi r-2 e 3-4, frutto delle nostre fatiche 53
.
Il presente libro è la prima monografia contemporanea sulla teologia di Isacco il Siro che abbia potuto prendere in esame
questi due manoscritti è conservata). Tra i manoscritti che hanno conservato qualche discorso o frammento di discorso della seconda parte si possono menzionare il Bagbdlld, Monastero caldeo di Dawra, sir. 68o; il Vaticano sir. 509; il Birmingham, Mingana sir. 6or; Londra, British Lib. Add. r4632 e Add. 14633· Per ulterion dettagli sui manoscritti più importanti, si veda S. Brock, "Introduction", in Isaac of Nineveh (Isaac the Syrian), "Tbe Second Part", Cbapters IV·XU, ed. and tr. by S. Brock, Peeters, Lovanìi 1995 (CSCO 554-555), vol. I, pp. Xll-JGU(V.
;o Cf. S. Brock, "St. Isaac the Syrian: Two Unpublished Texts", in Sobomost 19,1 (1997), pp. 7-8.
51 Cf. Isacco di Ninive, Dìscorsi spirituali. 52 Cf. Isaac of Nineveh (Isaac the Syrian), "Tbe Second Part"; d'ora in poi quest'ope
ra sarà citata soltanto con la sigla della collana esco seguita dal pumero del volume. '' Prepodovnyj Isaak Sirin, O boiestvennicb tajnacb i o ducbovnoj :f.i:wi, ed. Ilarion
Alfeev, Zai':at'evskij Monastyr', Moskva r998.
.32
i testi recentemente scoperti. Esso è il risultato di uno studio dell'eredità spirituale di Isacco che si è prolungato per molti anni. Il nostro lavoro si rivolge non tanto ai teologi di professione quanto a una larga cerchia di lettori per i quali la lettura di Isacco costituisce il "pane quotidiano" indispensabile alla loro salvezza, e non solo un oggetto di curiosità scientifica. Per questo motivo abbiamo deliberatamente rinunciato a un' espo~zione in cui ogni frase dell'autore fosse supportata da riferimenti a studi eruditi, come usa nelle opere destinate a un pubblico di specialisti. L'apparato scientifico è modesto e i rimandi ad altri studi sono ridotti al minimo. Contenuto principale del libro sono le parole stesse di Isacco, alle quali l'autore non ha voluto aggiungere altro che i commenti strettamente indispensabili.
Abbiamo un profondo debito di riconoscenza nei confronti di Sebastian Brock per il suo preziosissimo aiuto nella comprensione di molti passi difficili della seconda parte degli scritti di Isacco. La nostra particolare gratitudine va anche a padre André Louf, non solo per essersi assunto l'ingrato compito di tradurre questo libro in francese, ma anche per la possibilità che ci ha dato di utilizzare la sua traduzione delle opere di !sacco.
fonti della teologia di Isacco
Prima di tentare un'analisi della teologia di Isacco, bisogna spendere due parole sui suoi predecessori, coloro che esercitarono una qualche influenza su di lui. Isacco frequentò assiduamente la letteratura ascetica, e non mancò di citare autori antichi, siriaci o greci, o di far loro riferimento.
Secondo Sebastian Brock il vocabolario e la terminologia di Isacco devono molto soprattutto a due autori: Giovanni il Soli-
33

tario ed Evagrio54• Gli scritti del primo (inizio v secolo) hanno
esercitato una profonda influenza non solo su Isacco ma su un buon numero di autori ascetici posteriori al v secolo 55 . Pur non nominandolo mai, Isacco utilizza molte formule tratte da lui. Quanto a Evagrio (rv secolo), egli era la principale autorità in materia spirituale per tutti gli autori di lingua siriaca: i suoi scritti erano stati tradotti in quella lingua e godevano di grande popolarità 56 • Isacco lo nomina e lo cita frequentemente; a imitazione dei Capitoli gnostici (Kephdlaia gnostikd) di Evagrio ha voluto a sua volta scrivere quattrocento "capitoli gnostici" (le quattro Centurie di conoscenza). Agli occhi di !sacco, E vagrio era "un vaso di rivelazioni spirituali illimitate" 57 , "colui che definì la forma appropriata di ogni nostra attività" 58, cioè colui che gettò le fondamenta della comprensione teologica di tutti gli aspetti della vita ascetica.
Oltre a Giovanni di Apamea (detto anche "il Solitario"), !sacco conosceva altri autori siriaci, in particolare Afraat ed Efrem, espressamente citati, ma anche, benché non nominati nei suoi scritti, Narsai e Babai il Grande. Fra le traduzioni patristiche, !sacco conosceva il corpus delle opere di Dionigi l'Areopagita, le Omelie dello Pseudo-Macario, gli Apoftegmi dei padri, gli scritti di Marco l'Eremita, di abba Isaia, di Nilo di Ancira (v secolo), come pure un certo numero di documenti appartenenti alla letteratura agiografica, ascetica e dogmatica.
Nel campo della dogmatica e dell'esegesi, Teodoro di Mopsuestia e Diodoro di Tarso erano le sue autorità principali, come lo erano per la tradizione siro-orientale nel suo insieme. !sacco
54 Cf. S. Brock, "Intrcducdon", pp. XXXVII·XXXVIII.
" Ibid., p. xvrr. 56 Ibid., p' XXII.
" II,J5, I 2. 50 I,8 (p. 68) PR 8 (p. ro6). Cf. PR 9 (p. IIJ), I9 (p. r6o), 22 (p. r68) e 44
(p. 319).
.34
fa spesso appello a Teodoro chiamandolo il "beato Interprete" e scagliando l'anatema contro i suoi nemici:
Che nessun fanatico, convinto che il suo zelo abbia a che fare con la causa della verità, osi immaginare che noi di nostra iniziativa ci apprestiamo a introdurre novità delle quali i padri ortodossi nostri predecessori non abbiano mai parlato, come se proponessimo un'opinione non conforme alla verità. Chi vuole può andarsi a vedere gli scritti del beato Interprete, uomo che aveva ricevuto in abbondanza i doni della grazia, al quale erano stati confidati i misteri nascosti delle Scritture autorizzandolo a insegnare a tutta la comunità della chiesa ll cammino verso la verità, e soprattutto uomo che ha illuminato noi orientali [cioè i siro-orientali] di sapienza. La vista della nostra mente non è in grado di sostenere il fulgore della sua opera ispirata dallo Spirito divino. Sicché, lungi dal respingere le sue parole - Dio ce ne guardi! - noi le accogliamo come quelle di un apostolo, e tutti coloro che vi si oppongono, insinuano dubbi sulle sue interpretazioni o esitano di fronte alle sue affermazioni, noi li consideriamo alla stregua di estranei alla comunità della chiesa e di erranti riguardo alla verità 59.
Quanto a Diodoro di Tarso, !sacco parla di lui con il massimo rispetto, chiamandolo di volta in volta "testimone degno di de", "persona di grande intelligenza", "sorgente alla quale si è dissetato Teodoro stesso, la cui parola risuona con tanta chiarezza", "grande dottore della chiesa", "mirabile fra tutti gli insegnanti e maestro di Teodoro" 60 •
È evidente che Isacco nella sua scelta di autori, sia nel campo del dogma sia in quello dell'ascesi, è stato fedele alla tradizione della sua chiesa e merita pertanto di essere considerato un autore
"II,39,7· Si può sentire in questo passo l'eco degli anatemi lanciati contro Henana dai concili locali del585, 596 e 6o6.
""II,J9, IO-I I.
35

--
tradizionale. Al tempo stesso si rivela uno degli autori più originali non solo della tradizione siro-orientale, ma della letteratura mistica cristiana universale. La sua originalità non consiste in una concezione della mistica opposta a quella tradizionale, ma piuttosto nel fatto che, benché erede della stessa tradizione e della stessa esperienza dei suoi predecessori, egli sia riuscito a distillarla in un linguaggio nuovo e originale e persino a proporre, in alcuni casi, soluzioni nuove ad antichi problemi. Come potremo constatare nel corso di questo studio, !sacco non aveva alcun timore reverenziale nell'esprimere opinioni personali in materia ascetica o dogmatica: in certi casi fu anzi decisamente audace, sempre però sforzandosi di suffragare le sue idee con il sostegno della tradizione dei padri. Non aveva paura di parlare apertamente della sua esperienza di vita ascetica, ma era sempre attento a cercarne conferma nell'esperienza degli altri, sia predecessori sia suoi contemporanei.
!sacco visse in armonia con la sua chiesa, riuscendo a conciliare con la tradizione ecclesiale un'assoluta libertà di pensiero. In tale accordo della sua esperienza e della sua teologia personale con la tradizione sta il segreto della straordinaria popolarità di cui l'opera di !sacco ha goduto nei secoli. Di epoca in epoca, nuove generazioni di cristiani trovano in lui un grande maestro la cui esperienza spirituale non perde mai di attualità.
I DIO, L'UNIVERSO E GLI UOMINI
Il mondo è stato mescolato a Dio, e la creazione e il Creatore sono diventati uno!
Uno studio su !sacco deve cominciare dall'analisi della sua dottrina su Dio, creatore e rettore dell'universo, e della sua concezione del modo in cui Dio si rivela attraverso il mondo creato. Studieremo inoltre l'antologia di Isacco, cioè il suo insegnamento sulla struttura dell'essere creato, come pure la cristologia, la dottrina riguardante la redenzione del mondo da parte del Verbo incarnato di Dio. Tale analisi ci permetterà di collocare meglio il nostro autore nella tradizione teologica orientale e di precisarne la posizione personale di fronte ai dogmi cristiani fondamentali.
L'amore di Dio si rivela attraverso il mondo creato
Dio, come Isacco lo concepisce, è in primo luogo "più abbondante dell'oceano"\ Amore senza misura e senza limitF.
1 Cf. Centurie di conoscenza III, ì 2. 2 Il tema dell'amore di Dio è universalmente presente in tutta la tradizione teolocri-
ca di lingua siriaca: cf. S. Brode, Spitituality in the Syriac Tradition, p. 84. "
37

L'idea di Dio come amore è centrale e preponderante nel suo pensiero: essa costituisce la fonte principale delle sue opinioni teologiche, delle raccomandazioni ascetiche e anche delle intuizioni mistiche. Al di fuori di questa idea fondamentale, il suo sistema teologico resterebbe incomprensibile.
L'amore divino trascende ogni umana comprensione e descrizione attraverso la parola. È riflesso nell'agire divino sia in rapporto al mondo creato sia in rapporto agli uomini: "Fra tutte le sue opere, non ve n'è alcuna che non sia tutta quanta opera di misericordia, d'amore e di compassione: ecco l'inizio e la fine di tutta la sua attività in rapporto a noi" 3 . La creazione del mondo e la venuta di Dio sulla terra dentro una carne umana non avevano entrambe che un sol fine: "Rivelare al mondo il suo amore senza limiti" 4 . L'amore di Dio è dunque la ragione principale della creazione dell'universo:
Il motivo dell'esistenza del mondo e quello della venuta di Cristo nel mondo sono identici: la manifestazione del grande amore di Dio che li mise entrambi in moto affinché esistessero. Lo specchio della forza dell'amore di Dio per la creazione è la venuta di Cristo nel mondo; lo specchio dell'amore di Cristo sono le diverse forme della sua umiliazione. Come Dio ha fatto conoscere l'alto amore con il quale ha portato i mondi all'esistenza riproducendolo in favore nostro nell'economia di salvezza riguardante il Cristo, così, ripetendolo nel Cristo, ha reso palese che ne offrirà una spiegazione lampante agli esseri razionali nel mondo a venire 5 .
Questo stesso amore rimane oggi la principale forza propulsiva che sta dietro alla creazione del mondo 6, all'atto della quale l'amore di Dio si è rivelato in tutta la sua pienezza:
3 II,39,22. 4 Centurie di conoscenza IV,79· 5 Centurie di conoscenza IV, 79-Sr. 6 Cf. P. Bettiolo, "Avec la charité camme but: Dieu et création dans la méditation
d'Isaac de Ninive", in Irénikon 63 (r990), pp. 323-345.
Che cos'è questo Essere invisibile la cui natura non contempla inizio, unico in se stesso, per natura al di là della conoscenza intellettuale e della percezione degli esseri creati, oltre il tempo e lo spazio- poiché essi sono stati creati da lui-; che si è manifestato come per allusioni ed è stato conosciuto per segni quando la creazione, al suo inizio, fu interamente fissata; che si è fatto sentire attraverso la sua opera, affinché così fosse conosciuta la sua essenza di Signore fonte di nature innumerevoli? Questo Essere è nascosto perché, avendo abitato il proprio essere per secoli senza numero né limite né inizio, piacque alla sua bontà di dare inizio al tempo e portare all'esistenza i mondi e gli esseri creati. Consideriamo un istante la magnificenza di ricchezza che fu l'oceano del suo atto creatore, e la moltitudine delle cose create che appartengono a Dio, e come egli sostenga ogni cosa con misericordia, e con quanta provvidenza agisca quando guida la creazione, con quale amore incommensurabile abbia fondato il mondo e dato inizio alla creazione, e fino a che punto sia pieno di compassione e pazienza, e come ami la creazione sostenendola, sopportandone con bontà difetti, peccati e cattiverie e persino le spaventose bestemmie dei demoni e degli uomini malvagF.
L'amore di Dio è la continua messa in opera della sua potenza creatrice, rivelazione infinita della divinità nel suo atto creatore. È il fondamento dell'universo, governa il mondo e lo condurrà a quell'esito glorioso nel quale verrà interamente "consumato" da Dio:
O profondità di ricchezze, o spirito elevato e alta sapienza di Dio! Che bontà piena di compassione, che benevolenza sovrabbondante è quella del Creatore! Quale non fu la sua intenzione, quale non fu il suo amore quando creò questo mondo e lo portò all'esistenza! Che mistero non aveva concepito
7 II,ro,r8·r9.
39

--
nel portare la creazione alla luce! ... È per amore che ha fatto esistere il mondo, per amore lo condurrà a questa trasformazione meravigliosa e sempre per amore il mondo sarà inghiottito nel grande mistero dell'autore di tutto. È infine l'amore che governa ogni cosa nella creazione 8 •
Questa volontà piena d'amore di Dio è la prima fonte di tutto ciò che esiste nell'universo:
È lui che, dimorando nella luce della sua natura, ha voluto che tutta la creazione si avvicinasse alla nube oscura della sua eterna gloria, è lui che ha donato la corona della sua eternità alla creazione sprigionata dalle sue mani ... è lui che è all'origine della pienezza che ha deciso di condividere nell'eternità del suo regno, lui che è l'Essere e il Signore, esaltato al di là di ogni nozione secondaria, la cui volontà è la fonte delle nature, dal quale defluiscono come da una sorgente i mondi, gli esseri creati e le nature, illimitate e innumerevoli9
.
L'amore di Dio è la ragione per la quale siamo in grado di conoscerlo, giacché tutto quello che sappiamo di lui ci viene da quanto lui stesso ci ha rivelato attraverso il suo divino Nome, e dalle diverse rivelazioni menzionate dalla Scrittura.
Ciò di cui si può avere coscienza, ciò che si può conoscere di Dio è quello che egli, nel suo amore, ha preso su di sé per il nostro bene. Queste realtà sono l'oggetto delle dimostrazioni sensibili attraverso le quali la sacra Scrittura fa conoscere ai nostri sensi quanto è conoscibile del mondo non sensibile, benché tali realtà non lo facciano conoscere in ciò che gli è proprio, ma nel modo in cui Dio disse a Mosè: "Io sono il Signore che si è rivelato ad Abramo, Isacco e Giacobbe co-
8 Il,j8,I·2. 9 Il,r0,24.
me Dio El Shaddaj, ma non ho indicato loro il mio nome" (Es 6,3). La differenza che intercorre tra "Dio El Shaddaj" e "Ehyeh asher ehyeh" 10 e che è in rapporto con la distinzione tra due tipi di discepoli, vale anche per la differenza tra quanto ci viene detto affinché noi conosciamo Dio in verità e la verità [profonda] di questa conoscenza11 .
Dio non è solo il creatore dell'universo e la sua forza motrice. Egli è prima di tutto un "vero padre per gli esseri dotati di ragione, da lui generati attraverso la grazia affinché diventino eredi della sua gloria nel tempo a venire, ed egli possa mostrare loro la sua opulenza, che sarà la loro delizia senza fine" 12 . Nel suo immenso e smisurato amore supera ogni cosa in tenerezza paterna13 •
Il suo atteggiamento verso il mondo creato è dunque caratterizzato da un'incessante sollecitudine provvidenziale per tutti i suoi abitanti, per gli angeli e i demoni, per gli uomini e gli animali. La sua provvidenza è universale e abbraccia tutto 14 . Nessuna creatura è esclusa dallo sguardo della sua amante provvidenza, ma l'amore del Creatore si riversa egualmente su tutte le cose:
Nella conoscenza del Creatore non c'è nessuna natura che stia al primo o all'ultimo posto della creazione, ma tutto ciò che egli ha portato all'esistenza si trova da sempre nella sua coscienza. E non ce n'è una che egli abbia conosciuto prima delle altre, né altre prima di essa; nessuna fu prima, nessuna
10 "Io sono Colui che sono" (Es j,r4), in ebraico nel testo. 11 Con la sua dottrina sulla duplice interpretazione del N ome di Dio I sacco si inse
risce in una tradizione esegetica rappresentata prima di lui da Isho'dad di Merw nel suo commento a Es 6,3. Accanto all'interpretazione "sensibile" di questo Nome, adattato alla nostra reale capacità di comprensione, c'è l'interpretazione "intelligibile" o "spirituale", riservata al mondo a venire, la sola che svela la verità profonda. La stessa duplice interpretazione influenza tutto quello che può essere detto a proposito di Dio [N.d.T. francese].
12 Il,r,r. lJ Cf. I,j2 (p. 254) = PR )I (p. J6I). 1'1 Cf. I,7 (p. 6j) = PR 7 (p. IOJ).

fu dopo nemmeno per un istante. Parimenti, non c'è né prima né dopo nel suo amore per le creature, né amore più grande né più piccolo da parte sua verso di esse. Al contrario, così come la sua conoscenza è sempre la stessa, sempre uguale è il suo amore 15 .
Tutte le creature viventi esistevano nello spirito di Dio prima della loro creazione. Prima di essere portate all'esistenza ticevettero un posto nella struttura e nella gerarchia dell'universo, posto che non è mai stato loro tolto, nemmeno se sono cadute lontane da Dio:
Quanto al rango nell'amore, ciascuno ha il proprio posto unico e immutabile nell'economia salvifìca di Dio, secondo la forma che Dio vedeva in lui prima di crearlo con le altre creature, cioè nel tempo precedente l'attuazione del progetto del mondo secondo la sua eterna economia di salvezza ... Dio non conosce che un solo grado di amore, totale e senza parzialità per nessuno, e ha una sola sollecitudine e una sola premura sia nei confronti di quelli che sono caduti sia di quelli che non lo sono 16•
La sollecitudine della provvidenza di Dio e il suo amore si estendono agli angeli primo frutto della sua attività creatrice -e includono quelli che, caduti lontano da Dio, sono diventati demoni. Secondo I sacco, l'amore del Creatore verso gli angeli decaduti non è assolutamente diminuito a seguito della loro caduta, e non è affatto inferiore all'amore che egli porta agli altri angeli17:
Sarebbe ignobile e del tutto blasfemo sostenere che in Dio sussistano odio e risentimento, anche solo verso i demoni; o
"IIas,3. 16 I!,40,}. 17 Cf. II,4o,2.
immaginarsi qualsiasi altra debolezza o passione, o che alla sua natura gloriosa possa confarsi anche implicitamente una qualche idea di remunerazione del bene o del male sotto ma di retribuzione. Dio piuttosto agisce su di noi per vie che sa esserci favorevoli; siano causa di sofferenza o sollievo, gioia o tristezza, insignificanti o gloriose, tutte sono orientate verso gli stessi beni eternP 8.
Sostenere che l'amore di Dio diminuisca o scompaia a causa della caduta di una creatura equivarrebbe a "ridurre la natura gloriosa del Creatore alla debolezza e al cambiamento" 19 . Sappiamo infatti che
non c'è presso il Creatore né cambiamento né intenzioni anteriori o successive; non c'è odio né risentimento nella sua natura, né posto più grande o più piccolo nel suo amore, né prima né dopo nella sua conoscenza. Giacché, se tutti credono che la creazione è venuta alla luce come conseguenza della bontà e dell'amore del Creatore, sappiamo che questa causa prima non diminuisce né muta nella natura del Creatore per via di un andamento disordinato della creazione 20 •
Niente di ciò che avviene nella creazione potrebbe alterare la natura del Creatore che è "alta, nobile, gloriosa, perfetta, compiuta nella sua conoscenza e intera nel suo amore" 21 .
Per questa ragione Dio ama allo stesso modo i giusti e i peccatori, e non fa nessuna distinzione fra loro. Dio conosceva la vita peccaminosa che l'uomo avrebbe condotto già prima di crearlo, eppure lo creò22
• Dio conosceva tutti prima che diventassero
43

giusti o peccatori, ma il suo amore non mutò a causa del cambiamento che essi avrebbero subito23 . Anche le azioni riprovevoli sono da lui misericordiosamente accolte, e "i loro autori perdonati senza biasimo da un Dio che conosce tutto e al quale ogni cosa è rivelata prima che accada, e che conosceva i limiti della nostra natura prima di crearci. Giacché Dio, che è buono e pieno di compassione, non ha l'abitudine di giudicare le debolezze della natura umana o delle azioni che si compiono necessariamente, benché riprovevoli" 24 .
Anche quando castiga, Dio lo fa per amore o mirando alla salvezza del punito piuttosto che per sanzionare. Dio rispetta la libera volontà dell'uomo e non desidera contrastarla:
Dio castiga con amore, non per vendicarsi- tutt'altro! -ma per cercare di portare a compimento la sua immagine. Non prova collera - a meno che la correzione risulti impossibile -perché non cerca vendetta. Tale è l'intento dell'amore: il castigo per amore mira alla correzione, non alla sanzione ... Chi considera Dio come un vendicativo che dà in tal modo prova della sua giustizia, a guardar bene lo accusa di scarsa bontà. Non piaccia a Dio che in quella fonte d'amore e in quell'oceano debordante di bontà possa mai essere riconosciuta la vendetta25 !
Così presso !sacco l'immagine del Dio-giudice è completamente eclissata da quella del Dio-amore (pubba) e del Dio-misericordia (raf?me).
Dio non vuole giudicare nessuno. Al contrario, desidera essere il padre di tutti: "Dopo la venuta di Cristo e oltre, le rivelazioni ci hanno fatto conoscere il suo ruolo di padre, come
44
23 Cf. II, 38a. 24 II,I4,I5. 25 1,48 (p. 230).
veramente è, non avendo più alcun desiderio di essere per noi né signore né giudice" 26
. Agli occhi di !sacco, la misericordia (mraf?manuta) è incompatibile con la giustizia (kinuta):
La misericordia si oppone alla giustizia. La giustizia consiste nell'uguaglianza tra due piatti di una bilancia che si mantengono in equilibrio, perché essa dona a ciascuno ciò che merita . . . mentre la misericordia è un rammarico e una pietà provocati dalla bontà. Essa fa pendere la bilancia dalla parte di tutti, non punisce chi pure lo meriterebbe e accorda a chi ne ha diritto una ricompensa doppia. Ecco perché, se è evidente che la misericordia fa parte della rettitudine, la giustizia fa parte della malvagità. Proprio come erba e fuoco non possono coesistere nello stesso luogo, così giustizia e misericordia non possono coabitare nella stessa anima.
È quindi assolutamente impossibile parlare di o-iustizia di Dio; bisogna semmai parlare di una misericordia eh; oltrepassa qualsiasi giustizia:
Come il peso di un granello di sabbia è nulla di fronte a una gran massa d'oro, parimenti l'uso che Dio fa della aiustizia è nulla rispetto alla sua misericordia. Davanti allo spirito di Dio i peccati della carne sono una manciata di sabbia gettata nel vasto mare; e come una fonte che sgorga impetuosa non può essere fermata da un pugno di polvere, così la misericordia del Creatore non è ostacolata dai vizi delle sue creature27.
Dopo aver respinto così vigorosamente l'idea della sanzione !sacco mostra che la concezione veterotestamentaria di un Di~ che punisce i peccatori, "che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione"
26 II,r,q. 27
I,5r (p. 244) ~ Touraille 58 (p. 312); PR 50 (p. 345).
45

(Es 34,7; cf. Nm I4,I8), non corrisponde alla rivelazione che abbiamo ricevuto nel Nuovo Testamento attraverso l'intercessione di Cristo. Benché David nei salmi chiamasse Dio "giusto e retto nei suoi giudizi" (cf. Sal II9,I3]), di fatto egli è buono e misericordioso. Cristo stesso ha confermato questa "ingiustizia" di Dio nelle sue parabole, specialmente quelle dei lavoratori dell'undicesima ora e del figlio prodigo (cf. Mt zo,I-I5; Le r5, I I-32), e ancor più con la sua incarnazione a causa dei peccatori: "Dov'è dunque la giustizia di Dio, dal momento che Cristo è morto per noi mentre eravamo peccatori?" 28 •
Isacco dunque sostiene che non bisogna interpretare alla lettera i passi che attribuiscono al Creatore sentimenti quali collera, sdegno, odio e altri analoghi. Se nelle scritture si incontrano simili espressioni antropomorfiche, esse sono usate in senso fi
gurato, poiché Dio non agisce mai per collera o per odio, sentimentì totalmente estranei alla sua natura. Non si deve prendere alla lettera tutto ciò che è scritto, ma piuttosto vedere la provvidenza nascosta e la conoscenza eterna di Dio dissimulate sotto il velo corporeo dei racconti dell'Antico Testamento29 • "Temi Dio per amore, non per la reputazione di severità che gli è stata attribuita" 30 .
Se Dio è amore per natura, colui che ha raggiunto un amore pieno e una misericordia rivolta all'intera creazione diventa simile a Dio: lo stato di pienezza d'amore verso la creazione che gli è proprio è lo specchio nel quale può contemplare l'immagine verace e la somiglianza dell'essenza dìvina31 . Tutti i santi "cercano per sé il segno della somiglianza totale con Dio: raggiungere la pienezza nell'amore del prossimo" 32 • Caratteristico
28 I,5r (p. 25r) Touraille 6o (p. 324); PR 50 (p. 35B). 29 Cf. II,;9,19. 30 I,sr, (p. 25r) = Touraille 6o (p. 324); PR 50 (p. 35B). 11 Cf. !,64 (p. 3r2) Touraille 34 (p. 2rsl; PR 6s (p. 455). 12 I,7I (p. 346) Touraille Br (p. 397); PR 74 (p. 5ro).
in questo senso è il celebre testo di Isacco in cui viene descritto il "cuore misericordioso" grazie al quale l'uomo può diventare simile a Dio:
Ma cos'è un cuore misericordioso? È un cuore che arde per tutta la creazione, per gli uomini, gli uccelli, gli animali, i demoni e ogni creatura. Quando l'uomo misericordioso pensa a loro, i suoi occhi versano copiose lacrime. Grazie alla misericordia possente che gli stringe con forza il cuore e all'intensa compassione, la sua anima è umiliata e non sopporta di sentire o vedere un'offesa qualsiasi o la minima afflizione patita dalle creature. Per questo motivo egli offre incessantemente preghiere e lacrime, anche per gli animali privi di ragione, per i nemici della verità e per coloro che gli fanno dei torti, affinché siano protetti e ricevano misericordia. Nello stesso modo prega anche per la stirpe dei serpenti, a causa della grande compassione che, a immagine di Dio, arde smisuratamente nel suo cuore 33 •
Nell'uomo, il "cuore misericordioso" è dunque l'immagine precisa della misericordia di Dio, che abbraccia l'insieme della creazione: uomini, animali, serpenti e demoni. In Dio non c'è odio per nessuno bensì un amore che abbraccia tutto, che non fa differenza tra giusto e peccatore, tra amico della verità e suo nemico, tra angelo e demone. Ogni essere creato è prezioso agli occhi di Dio. Egli si prende cura di tutte le creature e ciascuna trova in lui un padre pieno d'amore. Se noi voltiamo le spalle a Dio, lui non le volta a noi: "Se noi manchiamo di fede, egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso" (zTm z, I 3). Qualsiasi cosa possa accadere agli uomini o all'intera creazione, quale che sia il loro grado di allontanamento da Dio, egli resta fedele al suo amore che non può né vuole rinnegare.
JJ I,7r (pp. 344-345) Touraille Br (p. 395); PR 74 (pp. 507-50B).
47

Struttura del mondo creato
Secondo la rivelazione biblica, la creazione comprende a un tempo il mondo invisibile degli spiriti incorporei e il mondo visibile della materia. Al primo appartengono gli angeli e i demoni, al secondo l'insieme dell'universo con gli uomini, gli animali e tutti gli oggetti inanimati.
Ecco come la storia biblica della creazione viene compendiata da Isacco:
Il primo giorno furono create otto nature spirituali, sette silenziosamente e una, la luce, con una parola di comando. Il secondo giorno fu creato il firmamento; il terzo, Dio riunì le acque e fece germogliare le erbe; al quarto ebbe luogo la separazione della luce; al quinto furono creati gli uccelli, i rettili e i pesci; il sesto giorno gli animali e, infine, l'uomo 34
•
A proposito della struttura del mondo angelico, Isacco espone la dottrina delle nove classi gerarchiche, ripresa da Dionigi l'Areopagita che a sua volta si fonda sui nomi degli angeli nell' Antico Testamento. Ecco che cosa scrive, rifacendosi al testo biblico:
I libri sacri hanno attribuito nove nomi a queste essenze spirituali, suddividendole in tre gruppi di tre classi ciascuno. Il primo gruppo è costituito dai "troni", grandi, sublimi e santi al sommo grado, dai "cherubini" dagli innumerevoli occhi e dai "serafini" dalle sei ali; il secondo gruppo comprende "dominazioni", "virtù" e "potestà"; il terzo "principati", "arcangeli" e "angeli". I loro nomi sono così interpretati: in
"I,z6 (p. 132) ~ Touraille 67 (p. 349); PR 25 (pp. r87-r88).
ebraico,. serafini significa fervidi e ardenti, cherubini vuol dire grandi per conoscenza e saggezza, i troni sono le dimore di Dio e si riposano 35
••. Questi ordini hanno ricevuto i loro nomi in base all'attività che svolgono. I troni sono così chiamati perché un tempo venivano realmente onorati; le dominazioni perché hanno autorità su tutto il regno; i principati perché governano l'atmosfera; le potestà perché è stato loro dato potere su tutte le nazioni e tutti gli uomini; le virtù perché erano una volta grandi potenze dall'aspetto terribile; i cherubini perché sono esecutori; gli arcangeli in quanto vigili guardiani e gli angeli perché messaggeri 36 .
Secondo Isacco, Dio creò gli angeli
dal nulla e in un solo istante ... come i mondi innumerevoli dell'alto, potenze illimitate, legioni di serafini fiammeggianti, terribili e veloci, meravigliosi e forti, che hanno la facoltà di eseguire la volontà dei disegni onnipotenti, spiriti semplici, luminosi e incorporei, che parlano senza bocca, vedono senza occhi, sentono senza orecchie, volano senz'ali ... Non si affaticano né provano debolezza, sono rapidi nei loro movimenti, non rimandano mai le loro azioni; terribili all'aspetto, il cui compito è degno di ammirazione, ricchi di rivelazioni, elevati nella contemplazione, che scrutano il luogo della Shekinah 37
dell'Invisibile, delle essenze gloriose e sante, essi sono stati suddivisi in nove classi dalla sapienza che tutti li ha creati ... I loro movimenti sono di fuoco, la loro intelligenza è acuta, la loro conoscenza mirabile, assomigliano per quanto è possibile a Dio 38 .
15 Segue a questo punto la citazione dello Pseudo-Dionigi l'Areopagira, Sulla gerar
chia celeste 7, 2. 16 I,26 (pp. r3r-rvl ~ Touraille 67 (p. 349); PR 25 (pp. r87-r88). 17
Il termine ebraico Sbekinab significa "presenza", "gloria". Lo ritroviamo presso molti autori di lingua siriaca e nei loro testi liturgici: cf. S. Brock, n. 5 a II, ro,24, in esco 555, p. 46.
38 II,ro,24.
49

Gli angeli assomigliano dunque a Dio e ne recano in sé l'immagine: nei loro esseri il Creatore, che è al di sopra di ogni cosa, ha posto per quanto è possibile una somiglianza con se stesso39
.
Gli angeli, dice Isacco,
sono esseri invisibili il cui compito è di commuoversi alle lodi di Dio nella grande quiete che si estende sul loro mondo, cosicché, a partire da queste lodi, possano elevarsi nella contemplazione della natura gloriosa della Trinità e restare attoniti alla visione della maestà di quella gloria ineffabile 40
•
Gli angeli sono dunque in uno stato di continua meraviglia di fronte ai misteri divini, "a causa delle rivelazioni che vengono loro fatte in diversi modi" 41 . Paragonati allo stato attuale degli uomini, essi sono più elevati e più santi, perché non sottostanno alle passioni. Sono gli assistenti di Dio, e partecipano della sua luce e della sua gloria:
L'economia di salvezza che Dio ha attuato a favore di questi mondi elevati e i misteri loro rivelati sono infinitamente più grandi di quelli rivelati fra di noi, benché la causa di tutto ciò derivi da noi. Sono poi tanto più elevati e sottili nelle loro nature e dimore, e più prossimi a Dio, quasi fossero dietro a lui, luci dietro a luce, come camerieri del re e legioni di fuoco accampate davanti al palazzo, pronte a obbedire ai suoi desideri e capaci di penetrare, senza l'impaccio della carne, i misteri della santità. Remoti da ogni passione, somiglianti a Dio per quanto è concesso a creatura, primi servitori dei misteri di Cristo, intermediari nell'opera di santificazione interiore conformemente alla sua economia di salvezza, assistenti al suo trono di fuoco tra i mormorii rispettosi che li santifica-
" II,2o,9. 4o II,r2,r. 41 II,8,6.
no, elevati al di sopra del mondo corporale, mantello naturale della gloria e della luce invisibile, impronta della luce delle origini 42
Le idee di Isacco su Satana e i demoni sono del tutto tradizionali. Quanto alla caduta di Satana, egli segue l'opinione comune dei padri secondo la quale Satana era inizialmente una creatura di luce e di gloria, ma opponendosi a Dio e disobbedendogli per orgoglio divenne malvagio. Isacco sottolinea che tutto ciò avvenne "}n un batter d'occhio", in modo improvviso e imprevedibile. E dal diavolo che deriva tutto il male che esiste:
Da ll è venuta, nella natura spirituale, la decisione del [di commettere iJ] male. La "stella del mattino, sorta all'aurora" (Is q, r 2 LXX) appariva infatti sminuita ai propri occhi perché sottomessa alla regola fissata per le creature. Da quel momento, la forza che la sosteneva l'ha abbandonata, ed è piombata come folgore (cf. Le ro,r8) fuori della sua gloria. È a partire da quel desiderio di essere liberi che il pensiero del male si è insinuato nelle creature e nelle schiere infinite delle due legioni delle nature spirituali, l'una delle quali è chiamata degli arconti, l'altra dei principati e delle dominazioni. Una di esse in un batter d'occhio è precipitata fuori della gloria della sua natura luminosa e felice, fuori della sua dimora vicino ai cieli dove abitava con gli esseri superiori. Come uno spregevole rettile della terra è strisciata giù nell'abisso 43 .
Quanto ai demoni, essi sono "estremamente sudici" e incapaci, nel loro stato di impurità, di vedere gli ordini angelici soprastanti44. I demoni possiedono le stesse qualità degli angeli, ma la luce divina non è loro accordata perché sono portatori di tene-
42 Centurie di conoscenza IV,86. 43 CentUiie di conoscenza III,87-88. 44 Cf. I,26 (p. 130) = Tourailie 67 (p. 346); PR 25 (p. r84).

bra45• La volontà dei demoni è di rovinare e distruggere l'essere
umano; tuttavia non possono nuocergli finché Dio lo impedisce loro 46 . I demoni sono dunque totalmente sottomessi a Dio e non possono agire senza un permesso o un ordine da parte sua. In particolare, quando siamo legati a Dio da un amore sincero, Dio non permette ai demoni né agli animali selvaggi né ai serpenti di farci il minimo male, ma "al contrario, in nostra presenza essi si comportano pacificamente, in quanto esecutori della volontà di Dio" 47 • Ma se noi siamo attaccati al peccato, Dio ordina a uno dei demoni di "fustigarci duramente", non per spirito di vendetta, ma perché "non abbiamo a traviarci, in un modo o nell'altro, lontano da lui" 48 .
Se il mondo invisibile degli angeli è stato creato allo scopo di lodare la gloria e la potenza di Dio, il mondo materiale è chiamato a sua volta a testimoniar ne l' onnipotenza. Esso è stato costruito come un tempio magnifico che rivela e riflette la bellezza di Dio. La cosmologia di !sacco corrisponde alle concezioni scientifiche del suo tempo: Dio ha steso il mondo come un pavimento e gettato il cielo come una "volta"; ha fissato "il secondo cielo come un cerchio aderente al primo"; ha creato l'oceano "come una cintura" che circonda cielo e terra; "vi ha posto montagne eccelse che toccano il cielo, e ha ordinato al sole di percorrere il suo cammino dietro le montagne lungo la linea della notte: all'interno delle montagne ha collocato il grande mare, che domina sulla metà o un quarto della terra emersa" 49 •
A sua volta l'essere umano è stato creato per essere tempio di Dio, dimora della divinità50 . Questa abitazione di Dio nel suo tempio si realizzò il più pienamente possibile nella persona del
45 Cf. I,28 (pp. 137-r38) = Touraille 84 (p. 4rr); PR 27 (p. r96). 46 Cf. I,54 (p. 270) = Touraille 33 (p. 207); PR 53 (p. 386). 47 II,9,6. 4s II,9,I2. 49 I,26 (p. rvl = Touraille 67 (p. 349); PR 25 (p. r87). >o Cf. II,5,6.
Cristo, Dio diventato uomo. Ritorneremo più avanti in modo particolareggiato sulla cristologia di Isacco e su come egli comprese la divinizzazione della natura umana operata da Gesù Cristo. Per il momento, ci limitiamo a sottolineare che secondo !sacco la natura umana è stata creata capace di accogliere la pienezza della divinità.
La natura umana ha anche la facoltà di esistere infinitamente a immagine di Dio 51
. Il fine ultimo dell'uomo è la divinizzazio~ ne: gli esseri umani, come le altre creature dotate di rao-ione
b ' debbono diventare dèi, somiglianti al solo e unico vero Dio. Nell'affrontare questo tema !sacco ripropone una posizione comune a tutta la tradizione patristica orientale:
Eèco quanto oso affermare: l'oggetto finale di ciò che sarà contemplato nel mondo futuro è visibile nell'essenza dei santi angeli, quando noi saremo tutti dèi per grazia del Creatore. Tale fu infatti il suo scopo fin dall'inizio: portare tutta la creazione degli esseri dotati di raerione a una totale eeruaglianza
o o ' nella quale non ci sarà più differenza tra erli uni e erli altri tra
o o ' un uomo doppio e uno semplice, senza però che il corpo na-turale sia abolito 52.
Il fatto che gli esseri umani siano predestinati alla deificazione ad onta delle loro infedeltà è la prova più convincente dello smisurato amore di Dio:
È attraverso la grazia che Dio ha portato il mondo alla luce, è con l'amore che ne governa le vicende. Mentre noi diamo ogni giorno motivo di amarezza alla sua bontà con la nostra follia che si volge verso il male, il suo amore non cessa mai di progettare ogni giorno grandi beni in nostro favore e di
51 Cf. II,r8,r8. 52 II,r,62.
53

aumentare i soccorsi a noi destinati, come se fosse convinto poterei innalzare [un giorno] ai costumi della vita futura. allora che conosceremo la ricchezza dell'amore sublime del
quando, dopo la condotta quaggiù] che aumen-ta i frutti della distruzione, in attesa della perdizione tota-le oh, non so proprio come ... dopo tutto ciò, a quale grado eccelso innalzerà la nostra creazione a partire dalla polvere, a quale somiglianza e a quale gloria gioiosa ci trascinerà tutti e ci condurrà a diventare dèi e figli di Dio"!
L'uomo occupa un posto speciale nella gerarchia degli esseri creati, il cui scopo è un progresso senza verso una comunione sempre più completa con Dio. !sacco ha potuto ricavare tale concetto di progresso infinito dai padri greci, come Gregorio di N issa e Dionigi l'Areopagita, dei quali conosceva le opere. Egli mette a confronto la gerarchia esistente nel mondo creato con una scala grazie alla quale gli uomini e le creature simili a loro si innalzano verso Dio:
Tra tutti gli ordini delle nature spirituali alcuni salgono, giorno dopo giorno, ma nessuno A questa ascesa non è fissato alcun termine, dal più antico e dal primo tra gli ordini fino all'ultimo. Essi salgono giorno, dal momento della loro creazione fino a
Ogni persona umana è stata fornita di cinque "grandi e incomparabili doni" 55 : la vita, la sensoriale, la ragione, la libera volontà e l'autorità. Quando parla della persona umana, !sacco si richiama alla sua divisione in spirito, anima e corpo, divisione tradizionale nell'antropologia dei filosofi greci e in
54
53 Centurie di conoscenza II l, 70. 54 II,:z,jo. 55 ll,r8,r8.
quella dei pa~ri56: Egli a~otta altr~sì la divisione dell' anirr:a in tre parti: des1deno, pass10ne e rag10ne (refJmta, ,tnana, mlzluta, che corrispondono ai tò epithymetik6n, tò tbymoeidés, tò logbistik6n)57
. Questa concezione deriva dall'antropologia platonica con la quale !sacco messo in contatto attraverso Giovanni il Solitario e BabaP8
.
In !sacco non troviamo un'analisi dottrinale approfondita della caduta e del peccato originale responsabili, secondo la tradizione cristiana, della perdita della somiglianza divina originaria e dei danni inferti a una natura umana ormai corrotta. Tuttavia l'insegnamento di !sacco sulle passioni e il peccato corrispondono perfettamente a questa dottrina. Secondo lui, le passioni caratterizzano l'uomo suo stato attuale, susseguente alla caduta. Dio non ha imposto alla nostra natura né il né le passioni59
. L'anima per sua natura ignora le passioni: inizialmente era caratterizzata dall'impassibilità, che la rendeva simile a Dio, e solo molto più tardi le passioni entrarono in lei60 . Sia il corpo che l'anima furono assoggettati alle passioni quando persero ciò che apparteneva loro per natura e si trovarono così al di fuori della loro condizione normalé1 •
Tuttavia !sacco sembra contraddirsi quando afferma che esistono delle passioni sono state donate da Dio, passioni dell'anima e del corpo introdotte nell'uomo per il suo bene e la sua cresdta62
. La contraddizione si spiega con il fatto che la parola sìriaca pasbsba, proprio come il corrispettivo greco pdtbos, significa tanto "passione" quanto "sofferenza". Così, il senso della contraddizione di !sacco consiste nel sottolineare che le passioni
56 Cf. S. Brock, "The Syriac Background". 57 Cf. Il,I9,I; Il,I7,I. 58 Cf. S. Brock, n. 2 a Il,rt,r, in CSCO 555, p. 9r. 59 Cf. I,3 (p. r9) Tomaille 83 (p. 407); PR 3 (p. 26). 6° Cf. I,3 (p. n) Touraille 83 (p. 406); PR 3 (p. 2r). 61 Cf. 1,.3 (p. 19) Touraille 84 (p. 407); PR 3 (p. 25). 62 Cf. !,3 (p. 19) Touraille 84 (p. 407); PR 3 (p. z5).
55

--
peccaminose sono contro natura, mentre le sofferenze mandate da Dio possono essere utili alla crescita spirituale. Un'altra spiegazione potrebbe trovarsi nella tradizione patristica, che conosce due modi di intendere il pathos: da una parte un desiderio peccaminoso dell'anima, dall'altra la sua naturale capacità di orientarsi verso il bene o verso il malé3
. Può darsi che scrivendo i testi che abbiamo or ora citato !sacco abbia avuto in mente questi due modi di intendere il pdthos.
Contrariamente alle sofferenze che vengono da Dio, le passioni peccaminose provocano danni alla natura umana. Scrive I sacco:
Chi non si ritira volontariamente dalle cause delle passioni si lascia involontariamente travolgere dal peccato. Ed ecco le cause del peccato: il vino, le donne, le ricchezze e una robusta salute fisica. Non che queste cose siano peccaminose in sé, ma a causa loro la natura inclina spesso e volentieri verso passioni peccaminose. Ecco perché l'uomo deve guardarsene con grande attenzione 64
.
L'incarnazione
Dopo la caduta dell'uomo c'era un solo mezzo per distoglierlo dal suo stato passionale e rimetterlo nella condizione benedetta delle origini: l'incarnazione del Figlio di Dio. Il tema dell'incarnazione, che sta al cuore del messaggio del Nuovo Testamento, è dominante anche nell'opera di !sacco.
63 Cf. K. Ware, "The Meaning of 'Pathos' in Abba Isaias and Theodoret of Cyrus", in Studia patristica 20 (r989), pp. 3r5-322.
64 I,5 (pp. 4r-42) = Touraille 5 (p. 76); PR 5 (p. 6r).
s6
Poiché la sua cristologia si conforma nell'espressione alla tradizione siro-orientale, caratterizzata da una presunta terminologia "nestoriana" (di fatto quella di Teodoro di Mopsuestia, ereditata dal suo discepolo Nestorio), un gran numero di passi cristologici di !sacco non è stato tradotto in greco ed è rimasto fino a oggi sconosciuto. Il solo scritto dell'Isacco "greco" che tratti direttamente temi cristologici è la Lettera a Simeone, la quale però, come è stato dimostrato, è opera di Filosseno di Mabbug. Essa contiene d~nque una cristologia che è agli antipodi di quella di !sacco. E solo dopo la recente scoperta della seconda parte della sua opera che un'analisi accurata della cristologia di !sacco è diventata possibile. Ma prima di dedicarci a questa parte ormai disponibile, citiamo dalla prima alcuni passi caratteristici nei quali i temi cristologici fanno la loro comparsa. Prima di tutto bisogna soffermarsi con attenzione su numerosi passi delle Centurie di conoscenza che hanno come oggetto l'incarnazione. In uno di questi Isacco tratta dell'unione tra umanità e divinità in Cristo servendosi di una terminoloaia affine a t•
quella del concilio di Calcedonia. Egli evita in particolare qual-siasi allusione ai due qnome, mentre menziona le due kyane e l'unica pa~supa in Cristo (omissione, secondo noi, probabilmente non intenzionale):
Il Signore Cristo è sia il Primogenito sia il Figlio unico, perché le due cose non si incontrano in una sola natura. È diventato primogenito di una moltitudine di fratelli, ma è figlio unico perché nessuno è stato generato né prima né dopo di lui. Queste due realtà si verificano in un Dio e in un uomo, uniti entrambi in una sola persona (par~upa), senza che le proprietà di ciascuna delle due nature (kyane) siano confuse a causa dell'unione 65 .
6' Centurie di conoscenza I,49.
57

Un altro passo di !sacco è ancor più dipendente dal vocabolario tradizionale della cristologia siro-orientale, specie quando sostiene che la natura divina si è "annessa ciò che aveva preso da noi". In tal modo egli presenta Cristo come mediatore tra Dio e gli uomini, e afferma che scopo dell'incarnazione era il rinnovamento completo della natura umana:
Gloria a colui che è diventato per noi mediatore di questi beni, grazie al quale siamo stati resi degni di ricevere, conoscere e provare nella fede ciò che l'occhio non ha visto né l'orecchio udito, e che i sensi dell'anima non hanno potuto penetrare (cf. rCor 2,9); tutti beni che si trovano nel Primogenito, che proviene da noi ed è in verità l'immagine dell'Invisibile (cf. Col r,rs). Giacché la natura divina ha incorporato quello che aveva preso da noi in vista della speranza degli esseri dotati di ragione, il cui fine era stato custodito presso Dio fin dall'inizio, e che ora egli ha reso pubblicamente manifesto. Così ci ha fatto conoscere una parte di quel fine, per renderei consapevoli di ciò che resta ancora (celato) ed è a noi riservato, in vista del rinnovamento che la nostra costituzione umana riceverà allora per suo tramite66 .
Un altro passo dello stesso scritto di !sacco solleva la questione del significato del termine "primogenito" in relazione a Cristo: !sacco lo intende riferito alla nascita unica di Cristo, non paragonabile a nessun'altra nascita, né angelica né umana:
Sta scritto: "Generato prima di ogni creatura" (Col r,rs), di_ quelle dotate di ragione, delle visibili e delle invisibili, perché, quando sorse dalla tomba, egli fu il primo nato alla vita dell'altro mondo. Egli è il primogenito in rapporto a noi, e a buon diritto, perché prima di lui nessuno era nato per l'aldilà. Ma è giusto che sia chiamato primogenito in rapporto non so-
66 Centurie di conoscenza II,r9.
lo a noi ma anche alle nature incorporee, perché la loro creazione non è senza relazione con questa nascita67
•
Nelle Centurie di conoscenza i passi più sorprendenti sull'incarnazione sono quelli in cui !sacco parla dell'amore di Dio per la sua creazione, principale e unica ragione, secondo lui, della discesa del Figlio sulla terra e della sua morte sulla croce: qui si manifesta nel modo più chiaro il suo amore per l'umanità; da questo momento in poi gli uomini sono chiamati a rispondere all'amore di Dio con il loro amore:
Il Signore Dio ha consegnato suo figlio alla morte sulla croce a causa del suo amore ardente per la creazione ... Avrebbe potuto benissimo riscattarci in altro modo, ma ha voluto così mostrarci il suo traboccante amore come insegnamento per noi, e attraverso la morte dell'unico figlio ci ha riavvicinato a sé. Sì, se avesse avuto qualcosa di più prezioso ce l' avrebbe donato, affinché la nostra stirpe diventasse sua proprietà. Per via del suo grande amore non desiderava assolutamente fare violenza alla nostra libertà, pur potendolo; ma ha preferito che ci riavvicinassimo a lui attraverso l'amore di ciò che avremmo potuto comprendere. A causa del suo amore per noi e per obbedienza al Padre, Cristo ha accettato con gioia gli oltraggi e lo sconforto ... Allo stesso modo i santi, quando raggiungono la pienezza, la acquistano tutti nel medesimo grado e, riversando copiosamente il loro amore e la loro compassione su tutti gli uomini, assomigliano a Dio 68 .
È così che l'incarnazione ha avuto luogo a causa dell'amore del Padre e del Figlio per gli uomini; parimenti, è a causa di questa incarnazione che un uomo può ora pervenire a un grado di amore che lo rende somigliante a Dio.
67 Centurie di conoscenza II,65-66. 68 I,7r (pp. 345-346) = PR 74 (pp. 509-510).
59

Per !sacco l'incarnazione costituisce la nuova rivelazione su Dio. Al tempo dell'Antico Testamento, prima dell'incarnazione, gli uomini erano incapaci di contemplare Dio e di intenderne la voce. Dopo l'incarnazione è diventato possibile:
La creazione non lo poteva guardare prima che ne prendesse una parte presso di sé per conversare con lei, dal momento che neppure essa poteva intendere la sua voce quando le parlava faccia a faccia. I figli d'Israele non erano nemmeno in grado di sentire la sua voce quando si rivolgeva loro dalla nube (cf. Dt 5,23 ss.) ... Per diventare degni di ascoltare la voce di Dio e contemplarne la rivelazione, dovevano osservare tre giorni di castità secondo il comandamento mosaico (cf. Es 19,15); tuttavia, quando venne il momento, non poterono sostenere la vista della sua luce né la forza della sua voce mista al tuono. Ma ora che con la sua venuta ha riversato la sua grazia sul mondo, egli è disceso non già in mezzo a un terremoto o a un turbine di fuoco, né con fragore spaventoso e potente (cf. 1Re I9,II-I2), ma dolcemente, come pioggia sulla lana, come gocce di pioggia che cadono sulla terra (cf. Sal7z,6), ed è stato visto conversare con noi sotto altra forma. Tutto ciò è avvenuto dopo che ha dissimulato la sua maestà dietro il velo della carne (cf. Eb Io,zo) come in un tesoro, e ha conversato con noi e in mezzo a noi, nel corpo che si è voluto forgiare dalle viscere della Vergine 69
.
Quando il Verbo si è fatto carne le porte della contemplazione e della visione si sono aperte in Gesù non solo per gli uomini ma anche per gli angeli, giacché prima dell'incarnazione, come afferma !sacco, non era loro possibile penetrare questi misterF0
.
69 I,77 (pp. 38r-382) = Touraille 20 (pp. I37-q8); PR 82 (pp. 574-575). 7° Cf. I,28 (p. r39). Questo testo non compare nella recensione siro-orientale, ma si
trova in quella siro-occidentale (e quindi nella versione greca).
6o
Nella prima parte delle sue opere incontriamo un altro passo in cui !sacco spiega come le due nature di Cristo siano messe in evidenza nella sacra Scrittura. Per lui, la Scrittura usa spesso le parole in senso figurato: per esempio "quello che appartiene al corpo è detto dell'anima", e viceversa.
Analogamente, qualità appartenenti alla divinità del Signore e incompatibili con un corpo umano sono predicate rispetto al suo santissimo corpo, mentre qualità inferiori, pertinenti alla sua umanità, sono attribuite alla sua divinità. Molti, non comprendendo l'intenzione delle parole divine, incespicano su questo punto e non si risollevano più dalla caduta 71 .
Tra questi !sacco, da buon diofisita, include molto probabilmente i monofisiti. Egli dunque sottolinea la necessaria distinzione fra natura divina e natura umana di Cristo, benché la Scrittura non vi insista poi molto.
Questi sono i passi cristologici più importanti della prima parte. Volgendoci ora alla seconda, dobbiamo prestare attenzione a uno dei capitoli delle Centurie di conoscenza in cui !sacco tratta dell'incarnazione. Egli sottolinea di nuovo il fatto che l'amore di Dio per la creazione fu la ragione principale e unica della discesa sulla terra del Figlio di Dio e della sua morte in croce:
Se al risanamento dell'umanità fosse bastato lo zelo, perché Dio, con bontà e umiltà, si sarebbe rivestito di un corpo allo scopo di ricondurre il mondo al Padre suo? E perché si sarebbe steso sulla croce a causa dei peccatori, consegnando il suo santo corpo alla sofferenza a beneficio del mondo? Io personalmente affermo che Dio ha fatto tutto questo per una sola ragione: far conoscere al mondo il suo amore, affinché, co-
71 I,3 (p. r8) = Touwille 83 (p. 406); PR 3 (p. 24).
61

noscendolo, noi ce ne lasciassimo catturare, dato che un più grande amore sarebbe provenuto da noi quando, grazie alla morte del Figlio, egli avrebbe messo in atto la manifestazione della forza e della potenza del regno dei cieli72
.
Secondo !sacco, l'incarnazione del Salvatore e la sua morte sulla croce avrebbero avuto luogo
non già per riscattarci dal peccato, né per altri motivi, ma unicamente perché il mondo si rendesse conto dell'amore che Dio porta alla sua creazione. Se questo avvenimento sorprendente si fosse realizzato solo per il perdono dei peccati, qualsiasi altro mezzo sarebbe potuto servire per il riscatto. Quale ostacolo gli avrebbe impedito di portare a compimento il suo proposito attraverso una morte normale? Ma egli non ha voluto una morte normale, affinché tu potessi renderti conto della natura di questo mistero. Ha trovato invece la morte tra i crudeli tormenti della croce. Che bisogno c'era degli oltraggi e degli sputi di cui fu coperto? La sola morte sarebbe bastata alla nostra redenzione - soprattutto la sua morte - senza tutto ciò che vi si aggiunse. Com'è grande la sapienza di Dio! E come è piena di vita! Ora puoi comprendere tu stesso perché la venuta di nostro Signore sia stata accompagnata da tutti questi altri avvenimenti, e renderti conto del motivo per cui egli stesso espose personalmente e chiaramente il suo progetto: "Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito" (Gv 3,r6), riferendosi all'incarnazione e al rinnovamento che ne consegue 73
•
Lo stesso tema è sviluppato nel passo seguente, in cui Isacco tratta del "vero motivo" dell'" economia di salvezza" (mdabbranuta) di Dio:
62
72 Centurie di conoscenza IV, 7 8. 7
' Ibid.
Il mistero nascosto nell'economia di salvezza di nostro Signore, miei amati, è più eccelso della remissione dei peccati o dell'abolizione della morte. Fratelli, la speranza che per il momento ci è nascosta è più sorprendente ed eminente di ciò che ne possi~mo comprendere oggi, per contribuire alla nostra crescita. E per mezzo di realtà imperfette che bisogna comprendere ciò che è rimandato a più tardi, giacché non tutti possiedono una conoscenza piena della fede né osservano una buona condotta filiale: molti infatti devono ancora apprendere realtà che fanno paura e umiliano. Come infatti molti nomi e similitudini sono troppo banali e inadeguati alla realtà (che significano), simili a parole inficiate da passioni quali collera, rabbia e voglia di giudicare, e come lo è anche, non appena per effetto dello Spirito si viene innalzati alla vera contemplazione, il carattere materiale di certe definizioni formulate in base all'economia salvifica della creazione, allo stesso modo molti testi delle Scritture relativi alla causa della venuta di Cristo sono manchevoli e insufficienti rispetto al vero motivo del sua economia di salvezza per il mondo. Ne danno testimonianza le nature spirituali, quelle che nemmeno conoscono i peccatori, non hanno mai militato nelle loro file e sono state innalzate al grado in cui si trovano dalla rivelazione di Cristo ... Unico è il suo amore, per noi come per i santi angeli, per i peccatori come per i giusti. n fatto che nostro Signore sia stato assunto di mezzo a noi lo dimostra 74.
L:u~co motivo dell'incarnazione del Verbo era dunque l'amore d1 Dw, e non la necessità di riscattare l'umanità dal peccato. Questa affermazione di !sacco sembra contraddire l'opinione corrente sul motivo dell'incarnazione, e potrebbe anche essere tacciata di deviazione rispetto alla tradizione comune delle chiese. Qualcuno potrebbe spingersi a sostenere che, sottolineando con tanta forza il ruolo dell'amore, Isacco rischi di scalzare

alla base il dogma della redenzione che sta al cuore della fede cristiana. Ma una tale conclusione sembra dipendere da una concezione tipicamente occidentale della redenzione, considerata come il riscatto di una colpa e la "soddisfazione" offerta alla "giustizia" di Dio. Se consideriamo attentamente i passi appena citati inserendoli nel contesto dell'universo mentale di !sacco e alla luce della teologia orientale la conclusione cui aiungiamo è
' ......., ' o ben diversa. E evidente che Isacco non mette minimamente in dubbio la redenzione, ma la intende in un modo particolare. Ai suoi occhi essa significa prima di tutto la restaurazione di quel primato dell'amore che esisteva alle origini fra Dio e il mondo creato. Tale primato fu abolito dalla caduta, poiché l'uomo non si comportava più come figlio di Dio ma come servo disobbediente. Nondimeno, Dio è rimasto suo padre, e il suo amore di padre richiama gli uomini a quello stato originario. L'amore di Dio, dunque, e non la necessità di riscattare l'uomo dal peccato, fu l'unico motivo dell'incarnazione del Verbo: poiché ha voluto che gli uomini tornassero a rivolgersi a lui come a un padre, Dio stesso si è fatto uomo, come spiega !sacco nel capitolo 40 della seconda parte:
Quando tutta quanta la creazione ebbe abbandonato e dimenticato Dio e gli uomini ebbero perpetrato ogni sorta di nequizie, Dio volontariamente e senza alcuna sollecitazione discese presso le loro case e visse fra loro nel loro corpo come uno di loro. Come un mendicante, con un amore che oltrepassava ogni conoscenza o possibilità di descrizione da parte di qualsiasi essere creato, li supplicò di ritornare a lui, mostrando loro la gloriosa costituzione del mondo a venire e l'intenzione che aveva avuto, prima di tutti i secoli, di introdurre una tale felicità nella creazione: fece loro conoscere la sua esistenza, perdonò tutti i peccati da essi in precedenza commessi, confermò la sua benevolenza con segni e miracoli autorevoli e con la rivelazione dei suoi misteri, e si abbassò al punto di farsi chiamare "padre" da una natura umana pec-
catrice, fatta di polvere della terra, e da esseri umani miserabili. Cose simili si possono forse compiere senza un grande amore 75?
Affrontiamo ora il capitolo I I, in cui I sacco espone la propria cristologia con tutta la precisione necessaria. In questo capitolo, consacrato in gran parte alla croce, si è subito colpiti dal gran numero di termini tipicamente siro-orientali usati da !sacco per presentare la sua concezione del Cristo. Per lui la croce è il simbolo dell'uomo "che diventa tutto intero un tempio" 76 di Dio; il credente che fa il segno della croce lo fa in nome "dell'uomo nel quale abita la divinità" 77
; l'umanità di Cristo è "la veste della sua divinità" 78 • Sono termini tipici di tutta la tradizione siro~orientale che si può definire fortemente diofisita. Già Efrem aveva presentato l'umanità di Cristo come una "veste", e questa terminologia fu conservata dagli autori siro-orientali successivi, mentre fu espunta dalla tradizione siro-occidentale79 . Nella traduzione siriaca del simbolo niceno la parola greca esark6the (si è incarnato) è resa con lbesh pagra: "si è rivestito di un corpo".
Tuttavia, pur utilizzando la terminologia tradizionale della propria chiesa, !sacco resta lontano dalla concezione diofisita più estrema della persona del Cristo, che sosteneva non potersi attribuire a Cristo in quanto Dio le proprietà di Cristo uomo. Egli sottolinea come, ad onta del fatto che Cristo possieda due nature, noi le veneriamo entrambe, cioè adoriamo un solo Cristo in due nature; quindi attribuiamo a Gesù uomo gli stessi nomi che a Dio il Verbo:
" II,40, I4. 76 II,II,I2. La parola "tempio" si riferisce a Gv 2 I9. 77 II,II,I}. ' 78 II,II,24. 79 Cf. S. Brock, n. I a II,I I,24, in esco 555, p. 6o; Id., "Clothing Metaphors as a
Mea!ls ~f Theological Expression in Syriac Tradition", in Typus, Symbol, Allegorie bei den ostltcben Vatern und tbren Parallelen im Mittelalter, hrsg. von M. Schmidt, Pustet, Regensburg I982, pp. I I-38.

Non esitiamo a chiamare "Dio", "Creatore" e "Signore" l'umanità di nostro Signore, lui che è veramente uomo; o ad applicare divinamente a lui l'affermazione che "per sua mano sono stati costituiti i mondi (cf. Eb I ,2) e tutto è stato creato". Perché colui al quale tutte queste cose si riferiscono ha abitato volontariamente in lui, accordandogli l'onore della sua divinità e l'autorità su tutte le cose a causa dei benefici che la creazione avrebbe ricevuto grazie a lui, l'inizio dei quali ebbe luogo sulla croce. Chiese persino agli angeli di adorarlo, secondo le parole del beato Paolo: "Quando introduce il primogenito nel mondo, dice: lo adorino tutti gli angeli di Dio" (Eb I ,6). Gli concesse di essere adorato con lui, senza distinzione, attraverso un unico atto di adorazione, mirando allo stesso modo all'uomo che divenne Signore e alla divinità, poiché entrambe le nature sono conservate ciascuna con le sue proprietà, senza che vi sia distinzione nell'onore reso 80
•
È così che Dio "ha abitato volontariamente" nell'uomo Gest1, e che l'uomo Gesù "è diventato" Dio e ha avuto potere sull'intera creazione, grazie alla sua morte sulla croce. A causa della croce, l'uomo Gesù è stato innalzato fino a Dio il Verbo:
Giacché noi crediamo che tutto quello che si applica all'uomo sia stato elevato fino al Verbo che l'accetta per se stesso, avendo voluto che l'uomo prendesse parte a tale onore. Tutto questo è stato reso a noi manifesto sulla croce; grazie ad essa, che i non credenti giudicano spregevole, noi abbiamo acquisito una conoscenza esatta del Creatore 81 .
Può sembrare che questo modo decisamente diofisita di intendere la persona di Gesù Cristo nel pensiero teologico di Isac-
Bo II, I I ,2 r. Isacco usa qui il vocabolario dei sinodi siro-orientali del 554 e del 612 - che parlano entrambi delle proprietà delle due nature -, il primo dei quali riflette senza dubbio la definizione di Calcedonia: cf. S. Brock, n. 3 a II,rr,21, in CSCO 555, p. 59·
'' II,II,22.
66
co divida in due l'immagine del Gesù storico, ma non è così. !sacco intende correttamente Cristo come una sola persona, Dio sceso in un corpo umano. L'umanità di Cristo è altrettanto reale che quella di ciascuno di noi; nel contempo l'uomo Gesù è simultaneamente Dio il Verbo, creatore dell'universo:
O meraviglia! Il Creatore, rivestito di un essere umano, entrò nelle case dei pubblicani e delle prostitute, e quando si volsero a lui li esortò e procurò loro, grazie al suo insegnamento, l'assicurazione e la riconciliazione con lui. Poi suggellò la parola di verità con testimonianze credibili, consistenti in segni e prodigi. In tal modo l'intero universo, attratto dal suo amore e dalla bellezza della sua visione, era indotto a professare l'unico Dio Signore di tutte le cose, e così la conoscenza dell'unico Creatore fu disseminata dappertutto~2 •
Il significato universale della venuta di Dio sulla terra e del suo insediamento in un corpo umano viene messo così in piena
evidenza. Quali sono le conseguenze soteriologiche della cristologia di
!sacco e della sua insistenza sulla distinzione tra le due nature di Cristo? Implica essa forse il rifiuto di un concetto tradizionale del pensiero teologico orientale, cioè che l'umanità sia stata salvata attraverso la deificazione della natura umana grazie alla sua unione con la divinità nella persona del Cristo? Nella tradizione alessandrina in particolare la deificazione era considerata quale risultato dell'unione delle due nature in Cristo: come il ferro unito al fuoco diventa fuoco, così l'umanità unita alla divinità è stata resa divina. Se questa unità non è reale ma solo condizionale "in occasione del culto", come si può ancora parlare di deificazione della natura umana?
81 Il,rr,z8.

---
Abbiamo visto poc'anzi che Isacco non respingeva l'idea di una deificazione dell'uomo, tutt'altro: vedeva anzi in essa il fine ultimo della vita umana. Ma il suo modo di spiegare come Cristo l'abbia resa possibile differisce da quello della tradizione alessandrina. Per lui l'uomo Gesù, ascendendo a Dio dopo la resurrezione, ha elevato la natura umana allivello della divinità. Inoltre la passione, la morte, la resurrezione e l'ascensione di Cristo hanno aperto alla natura umana la possibilità di salire fino a Dio:
In mezzo a uno splendore ineffabile, il Padre lo innalzò al cielo al proprio fianco, a un posto al quale nessun essere umano si era ancora spinto ma dove, attraverso la sua attività, Dio aveva invitato tutti gli esseri razionali, angeli e uomini, a quell'ingresso beato, per gioire nella luce divina della quale era rivestito l'uomo 83 che è ripieno di tutto ciò che è santo e che si trova ora con Dio in una gloria e un onore ineffabili84.
Si tratta dunque di un approccio soteriologico diverso da quello degli alessandrini, in cui però l'essenza del messaggio cristiano è salvaguardata: l'uomo è salvato da Cristo attraverso l'unione della natura umana con la divina. La via per la quale l'uomo Gesù è salito dalla terra al cielo e dall'umano al divino è
83 La sintassi della frase consente due interpretazioni: o si tratta della "luce di cui era rivestito l'uomo (il Cristo-uomo)", oppure della luce nella quale stava colui che aveva rivestito la natura umana (il Cristo-Dio-e-uomo). Quest'ultima lettura non contraddice l'uso fatto qui da Isacco né la tradizionale dottrina siro-orientale; ma la prima interpretazione corrisponde meglio al senso del passo.
84 II, I I ,29. Notiamo come tale concezione sia vicina ai testi della liturgia bizantina. Cf. per esempio questo canto della festa dell'Ascensione: "Dolce G_esù, senza abbandonare il seno del Padre tu sei vissuto come un uomo sulla terra; oggr, al monte degli Ulivi, sei stato innalzato nella gloria e,. nella tua misericordia, hai f~;to ~scen?er~ nella gloria la nostra natura decaduta e l'har fatta sedere accanto al Padre (Sttcbera der Vespri); "Dio eterno e senza inizio, tu hai assunto la natura umana, tu l'hai misteriosamente divinizzata e tu l'hai fatta salire ai cieli" (Mattutino).
68
ormai, dopo la sua resurrezione, aperta a tutti. La deificazione è qui intesa in senso dinamico, come ascesa dell'essere umano e insieme di tutto l'universo creato verso la gloria divina, la santità e la luce.
Oltre al capitolo 9, un altro luogo fondamentale per la cristologia di !sacco è il capitolo 5 della seconda parte, che contiene molti passi cristologici. Vi si trova in particolare una preghiera che adotta la terminologia del "tempio" e che parla di "colui che vi abita":
Signore, io lodo la tua natura santa, perché tu hai fatto della mia natura un santuario per nasconderti e un tabernacolo per i tuoi misteri, un luogo dove puoi abitare e un santo tempio per la tua divinità, cioè per coltù che tiene lo scettro del tuo regno, che governa tutto quello che tu hai fatto esistere, il tabernacolo glorioso del tuo essere eterno, la fonte di rinnovamento per le schiere fiammeggianti che ti servono, la strada per conoscerti, la porta che permette di vederti, la ricapitolazione del tuo potere e della tua grande sapienza: Gesù Cristo, l'unico generato dal tuo seno, e il "resto" che fu raccolto a partire dalla tua creazione visibile e spiritualé5 .
L'idea dell'ascesa dell'uomo verso Dio grazie all'incarnazione del Verbo si ritrova in quest'altra preghiera:
O Mistero elevato al di sopra di ogni parola e di ogni silenzio, che ti sei fatto uomo per rinnovarci grazie a un'unione volontaria con la carne, svelami la strada attraverso la quale io possa essere innalzato fino ai tuoi misteri, e che passa per la via del silenzio di tutti i pensieri del mondo. Raccogli la mia mente nel silenzio della preghiera, tacciano in me i pensieri
85 II,j,6. Le allusioni scritturistiche fanno riferimento a Gv ro,9 (''porta"), Gv r,I8 (''seno"), Is 1,9 e Rm 9,29 (''resto").

dissipati, grazie alla frequentazione illuminata e piena di misteri della preghiera e dello stupore 86
•
Possiamo qui notare l'espressione "unione volontaria", ricorrente in Nestorio e Babai e caratteristica della tradizione siro-orientale87.
La redenzione è intesa come il sacrificio del Figlio di Dio che, offerto a causa dell'amore di Dio Padre per il mondo, unisce il mondo creato a Dio. È interessante osservare che !sacco chiama l'unione di Dio con il mondo una "mescolanza", espressione che la tradizione siro-orientale non avrebbe mai ammesso se si fosse trattato delle due nature di Cristo:
Tu hai dato tutto il tuo tesoro al mondo, facendogli dono, per il bene di tutti, del tuo unico Figlio, generato dal tuo seno e proveniente dal trono del tuo essere. Cosa possiedi ancora che tu non abbia donato alla tua creazione? Il mondo è stato mescolato a Dio, e la creazione e il Creatore sono diventati uno 88 !
Parlare di una "mescolanza" tra il mondo e Dio non è forse un modo, sia pure inconsapevole, di superare gli aspetti più estremi del diofisismo? In altri termini, un'affermazione del genere annulla i netti confini tra Dio e creazione che caratterizzano la posizione diofisita intransigente della chiesa orientale. Se Teodoro di Mopsuestia e i suoi discepoli potevano essere accusati di mantenere tra le nature divina e umana una distinzione che portava a dividere in due l'immagine di Cristo, si può forse nutrire lo stesso sospetto nei confronti di !sacco il Siro il quale, pur rappresentando la stessa corrente teologica, fa intravede-
70
86 II,5,7· 87 Cf. S. Brock, n. r a II,5,7, in CSCO 555, p. 8. 88 II,5,r8.
re una certa rottura con il diofisismo estremo? !sacco non parla di unità essenziale, men che meno di "confusione" tra le due nature di Cristo, ma parla di una "mescolanza" di Dio con la creazione89 . Tale modo di esprimersi rivela che la linea di demarcazione tra divino e umano, così netta nella scuola di Teodoro, lo è molto meno in !sacco.
Se !sacco non esita a parlare di "mescolanza" ((;u~tana) di Dio - con la creazione attraverso l'incarnazione del Verbo di Dio 90
, è proprio perché il Verbo increato di Dio e l'uomo creato Gesù sono una medesima e unica persona. Nella sua preghiera !sacco si rivolge dunque a una sola persona, che è al tempo stesso Dio e
uomo:
O Cristo, avvolto di luce come di un manto (cf. Sal 104,2), che a causa mia sei stato nudo davanti a Pilato, rivestimi di quella forza la cui ombra ha protetto i santi, e grazie alla quale essi hanno conquistato questo mondo di lotte. Possa la tua divinità, o Signore, compiacersi in me e condurmi al di là del mondo insieme a te, o Cristo, che i cherubini dai molti occhi non riescono a contemplare a motivo della gloria del tuo viso, benché tu vi abbia ricevuto sputi per via del tuo amore: cancella la vergogna dal mio volto e permettigli di stare scoperto davanti a te nell'ora della preghiera 91
.
89 Il tema della "mescolanza" di Dio con la creazione è caratteristico di Efrem quando parla dell'incarnazione e dell'eucaristia, e ritorna continuamente nei suoi inni.
9° Cf. II,7,3, dove Isacco parla della "mescolanza perfetta" dei santi con Dio, simbolo e tipo dell'unione di Cristo nella santa Trinità. Questa è una terminologia evagriana: cf. S. Brock, n. 6 a II,7 ,3, in CSCO 555, p. 25.
91 II,5,22-23.
7!

Ricapitolando quanto abbiamo detto sulla teologia di !sacco il Siro, possiamo ancora una volta sottolineare come l'insieme del suo pensiero teologico derivi dall'idea che Dio si rivela al mondo come amore ineffabile, un amore che ha creato il mondo e lo guida sulla via che conduce a Dio. Per amore della creazione e per la salvezza dell'umanità Dio ha assunto un corpo umano ed è morto sulla croce, al fine di rinnovare la natura umana e offrirle un accesso al regno dei cieli. La salvezza di una persona altro non è che la sua ascesa verso la luce e l'amore divini, alla sequela del Cristo che era sì uomo, ma un uomo che, innalzato allivello della divinità, ha reso divina la natura umana.
II LA VIA DEL SOLITARIO
Vuoi conoscere l'uomo di Dio? Impara a riconoscerlo dal suo silenzio continuo, dalle lacrime, dall'attenzione che presta costantemente a se stesso.
Centurie di conoscenza IV,76
Ama tutti gli uomini, ma tieniti a distanza da tutti.
In questo capitolo ci proponiamo di affrontare uno dei tratti più caratteristici di !sacco: l'ascetismo siria co. In primo luogo vedremo come la vita ascetica è da lui considerata una vita di solitudine, lontano dal mondo e dalle passioni. Quindi illustreremo i suoi insegnamenti sulla rinuncia al mondo richiesta al cristiano che intraprende la via dell'ascesi, sull'amore di Dio e del prossimo, sulla quiete come una delle condizioni principali per conseguire la pace dello spirito. Nella maggior parte dei casi ci occuperemo di aspetti della vita monastica e solitaria, ma tratteremo anche altri temi cari a Isacco riguardanti la vita cristiana in generale, come il suo insegnamento sulla realizzazione dei comandamenti di Dio e sulla lotta alle passioni. Questa indagine ci permetterà di circoscrivere l'individualità specifica di !sacco e di apprezzarne l'originalità nell'affrontare alcuni temi-chiave dell'ascesi cristiana.
73

Solitudine e rinuncia al mondo
Protagonista degli scritti di !sacco è lo i~idaya, il "solitario", o più letteralmente il "singolo" (affine all'ebraico ya~id, "singolare"). Al tempo di I sacco questo termine designava il monaco eremita in opposizione al dayraya, il cenobita. Il significato etimoloaico del temine è tuttavia molto più ampio: esso indica l'u-
o . nità di una persona all'interno di se stessa, come pure la sua um-tà con Dio. È così che nella pshitta (versione siriaca della Bibbia) la parola i(Jidaya era stata usata come epiteto di Adamo, creato a immagine di Dio: "La sapienza ha custodito il primo padre, l'ihidaya, che era stato creato nel mondo" 1
. Per il Nuovo Testam~nto, i~idaya è innanzi tutto l'epiteto di Gesù Cristo, e traduce il greco monoghenés, l"'Unigenito" o Figlio unico. Negli scritti siriaci del rv secolo il termine è già usato con riferimento agli asceti i quali, poiché non si sposano, assomigliano agli angeli. Solitario è chi vive in Cristo, "il Figlio unico (i(Jidaya) del Padre che ralleara tutti i solitari (ihidaye)", come spiega Afraat 2
• b •
Per !sacco solitudine non è sinonimo di celibato o vita eremi-tica. La parola denota innanzi tutto un'esperienza di unione con Dio. La maggior parte della gente trova la solitudine difficile da sopportare e la considera un'esperienza totalmente negativa di
1 Sap IO,I syr. Cf. il Targum palestinese nella sua versione si:iaca: "Guarda il p~imo Adamo che io ho creato che è sincrolo (ibiclay) nel mondo come lO sono smgolo nel! alto dei cieli" (ci t. in S. Ab~uZavd, IbfdayutiJa. A Study of tbe Life o/ Singleness in tbe Syrian Orient/rom Ignatius o/ Antio.cb to Cbalcedon, 45I 11D, ARAM Society for Syro-Mesopotarnian Studies, Oxford I993, p. 169; cf. anche S. Brock, The Lummous Eye. Tbe Spmtual World Vision o/ St. Epbrem, Cistercian Publications, Kalamazo? I?~2, p. II1. . .
2 Dimostrazioni 6,6. Per una discussione più globale sul s1gruhcato della solitudine nella tradizione siriaca, si veda S. H. Griffith, "Monks, 'Singles' and the 'Sons of the Covenant'. Reflections o n Syriac Ascetic Terminology", in Eulogema. Studies in Honor o/ Robert Taft sf, Pontificio Ateneo Sant'Anselm?, Roma I993, J?P· I4I-I6~; Id. "Asceticism in the Church of Syria. The Hermeneut!CS of Early Synan Monastlcis~", in Asceticism, ed. by V. L. Wimbush and R. Valantasis, Oxford University Press,
Oxford-New York I995, pp. 11o-245·
74
isolamento, di abbandono e di assenza dell"'altro" con cui dividere le gioie e le pene della vita di quaggiù. Per !sacco al contrario la solitudine è esperienza della presenza di Dio, che è più vicino di qualsiasi amico e si prende sempre cura dell'uomo. "Dio non ha mai lasciato percepire la sua azione altro che in un ambiente di quiete, nel deserto, o in luoghi appartati, lontano dagli incontri occasionali con gli uomini o lontano dalla confusione
..... delle loro dimore" 3 • Chi vive nel deserto, lontano dalla gente, può star sicuro di avere in lui un custode che non lo lascerà mai solo 4. L'anima di colui che è separato dal mondo e conduce una vita di quiete è elevata verso Dio, piena di meraviglia, colta dallo stupore, e dimora con Dio 5
.
La solitudine è l'esperienza interiore di chi vive con se stesso si ritira nella propria interiorità, condizione necessaria per
unirsi a Dio. Al tempo stesso, è l'esperienza della rinuncia all"'altro", amico o parente che sia. Essa è infine un'esperienza di ritiro dal mondo e di rinuncia, allo scopo di unirsi a Dio. La solitudine può essere dolorosa e piena di sofferenze interiori; tuttavia, senza farne esperienza, nessuno si avvicina alla pienezza della vita in Dio, alla comunione con lo Spirito santo e all'illuminazione spirituale: "La solitudine ci fa comunicare con lo Spirito divino e in breve, senza incontrare ostacoli, ci avvicina alla limpidezza del pensiero" 6 .
Agli occhi di !sacco rinunciare al mondo per vivere da solitari in Dio è la condizione necessaria per intraprendere la via che conduce a lui: "La liberazione dalle cose materiali precede il legame con Dio" 7 • "Nessuno può avvicinarsi a Dio se non si è separato dal mondo. Ma io chiamo separazione non il distac-
'I, p (p. 355) = Touraille I9 (p. I33); PR 77 (p. 53 I). 'Cf. I,54 (pp. 2 7o-z 7 I) = PR S3 (p. 386). 5 Cf. I,3 (p. I6) = Touraille 81 (p. 403); PR 3 (pp. 20-2 I). 6 Centw1e di conoscenza II,3 I. 7 I, I (p. 7) = Touraille I (p. 63); PR I (p. 7).
75

co del corpo, bensl il distacco dalle faccende del mo~do"~. In questo contesto, "mondo" è "un nome collettivo che s1 apphca a ciò che chiamiamo passioni" 9 . Uscire dal mondo e monre a esso vuoi dire liberarsi delle passioni e dello "spirito della carne" (cf. Rm 8,7), cioè di tutto quello che, nel corpo o nella materia, pone ostacoli sulla strada della vita spirituale 10 . Essendo l'amore del mondo incompatibile con l'amore di Dio, bisogna liberarsi del primo per acquisire il secondo: "L'anima che ama ~io trova in lui solo la sua pace. Dapprima sciogli te stesso da ogmlegame esteriore, poi sforzati di legare il tuo cuore a Dio, giacché l'unione con Dio è preceduta dal distacco dalla materia" 11
.
Questa rinuncia al mondo procede per gradi. Comincia con il desiderio di giungere alla contemplazione di Dio e comporta una disciplina sia del corpo che dell'anima. D'altra parte c'è una corrispondenza tra grado di rinuncia e capacità acquisita di immergersi nella contemplazione di Dio:
Benedetta sia la maestà di Dio che apre davanti a noi una porta, affinché nostra unica aspirazione sia desiderarlo! Allora noi lasciamo ogni cosa, e la nostra mente avanza nella ricerca unicamente del Signore, senza altre preoccupazioni che possano impedirgliene la contemplazione. Miei cari fratelli, più la mente abbandona il pensiero delle cose visibili e non si dedica ad altro che alla speranza delle cose a venire ... più si affina e diventa trasparente nella preghiera. E più il corpo è liberato delle cose del mondo, più la mente a sua volta se ne affranca ... Ecco perché il Signore ci ha comandato di badare, prima di ogni altra cosa, a non possedere nulla e a ritrarci dagli affanni del mondo liberandoci dalle cure abituali degli uomini. Ha
'1,I (pp. 3-4) = Touraille I (p. 59); PR I (p. 2). 9 1,2 (p. I4) = Touraille 30 (p. I93); PR 2 (p. I8). 1° Cf. I,2 (p. I5) = Toumille 30 (pp. I93-I94); PR 2 (p. I9). 11 I,4 (p. 29) = Touraille 23 (p. I5I); PR 4 (p. 40).
detto: "Chi non rinuncia completamente alla sua condizione di uomo e a tutto ciò che gli appartiene e non rinnega se stesso, non può essere mio discepolo" (cf. Le r4,33Jl2 .
Rinunciare al mondo e vivere secondo una severa disciplina di corpo e di spirito non è da tutti. Molti si sono dimostrati incapaci di condurre a buon fine una simile impresa e, dopo aver cominciato, hanno poi abbandonato la via dell'ascesi per ritornare al mondo. Isacco ne parla con profondo rammarico:
In effetti molti hanno cominciato tra le fatiche, la povertà, la mortificazione delle cose che passano, la continua preghiera, le lacrime, le molte prostrazioni, una vita umile e senza passioni, la clausura prolungata, la quiete, la condizione di stranieri fra gli uomini, insomma tutte le cose che ho appena enumerato, ma poi hanno finito per lasciarsi andare alla rilassatezza, a una certa celebrità, ai rapporti con i ricchi e all'allegra compagnia con la gente del mondo: e sono diventati procuratori, giudici, consiglieri e mediatori di affari importanti, chi tra i monaci, chi tra i secolari. Altri ancora hanno accettato la vista delle donne, i loro consigli e insegnamenti, e le loro celle sono diventate luoghi di ritrovo e di incontro per gli abitanti del villaggio. Al posto delle mortificazioni di prima hanno scelto una vita tumultuosa e la loro condotta è sprofondata nella cecità. Hanno concluso la vita nelle pratiche del corpo, dopo tanto rigore nell'osservanza delle regole e dopo la nobile vita di un tempo, quando non osavano nemmeno guardare un volto mortale e si rendevano simili alla vita futura nell'emulazione degli esseri incorporei, grazie allo zelo nell'osservanza di una vita di quiete 13 .
L'ideale di una totale rinuncia al mondo è attecchito nella prassi del romitaggio monastico dei primi tempi. Gli asceti di
12 1,63 (pp. 302-303) = Touraille 35 (p. 2I8); PR 63 (pp. 437-438). " Centurie di conoscenza II,97.
77

.---
una volta si ritiravano nel deserto per evitare i conflitti suscitati dalla vicinanza delle cose terrene:
Finché uno non si allontana da ciò che il suo cuore teme, l'Avversario ha sempre un punto di vantaggio su di lui ... I padri che hanno percorso questa strada prima di noi sapevano bene che il nostro intelletto non gode sempre di una salute di ferro ... Quindi, considerando saggiamente le cose, si sono rivestiti della rinuncia al possesso come di un'armatura ... si sono ritirati nel deserto, dove non c'era niente che potesse dare occasione alle passioni ... Voglio dire che non c'era posto per la collera, la cupidigia, il ricordo dei torti subiti, né per la gloria, e che tutte queste e altre simili cose erano rese inoffensive dal deserto. Lì infatti, come in una torre, protetti da un bastione inespugnabile, essi potevano portare a termine la loro lotta nella solitudine, dove i sensi non trovavano nulla che desse manforte al nostro Avversario attraverso l'incontro con gli oggetti che ci feriscono 14
.
Ecco perché monaci fuggivano il mondo: per non creare occasioni di contatto con le passioni, i peccati e i pensieri colpevoli. Inoltre, nel monachesimo di tipo eremitico troviamo la ricerca di un tale distacco dagli uomini da rifiutare in certi casi qualsiasi contatto con essi. La vita monastica diventa così una vita in solitudine nel senso letterale della parola. Isacco ritiene che la solitudine completa sia superiore alla vita in una comunità monastica, che lui accetta unicamente come preparazione alla vita solitaria. Quando si è imparato a vivere con gli altri, è preferìbile ritirarsi completamente da ogni contatto con le persone, ad eccezione del proprio padre spirituale:
Non è bene che chi ne è all'altezza e possiede una forte aspirazione a Dio, una volta abbandonato il mondo resti a lungo
'"I,73 (pp. 358-359) = Touraille 6 (p. 9'o); PR 78 (pp. 536-538).
in comunità, in mezzo al viavai di tante persone. Appena avrà i~ parato con;' è la vita in fraternità, il grado e lo scopo dell'a~lto (monastlco) e le varie umiliazioni che esso comporta, si nsolva a restare solo nella propria cella 15, sia per non fare 1' abitudine alla vita in comune sia perché la semplicità dei suoi esordi non si trasformi in ipocrisia, vivendo in mezzo a certi fratelli disinvolti che si trovano fra noi. Ne ho visto tanti che puri e innocenti all'inizio del loro ritiro dal mondo e all'arri: vo nella casa dei fratelli, dopo un po', a causa di una conviv_enza eccessiva, _sono diventati ipocriti e arroganti, senza più ntrovare la loro mnocenza di prima. Per questo motivo decidi di frequentare un solo anziano di cui tutti riconosc~no la bella condotta di vita e la conoscenza della quiete. Dovrai vedere solo lui per esercitarti e imparare da lui la condotta della quiete 16
: Da questo momento in poi non frequentare nessun altro, e m breve sarai degno di gustare la conoscenza 17.
Lo stesso tema è sviluppato nel passo seguente, in cui Isacco parla della sfera delle virtù che egli giudica inferiori a quelle cui può giungere un solitario, completamente ritirato dal mondo e da ogni commercio con la gente:
Non confrontare l'insieme delle regole e le fatiche mirabili che esse comportano con la mancanza di notorietà, l'assenza dell_a fama e la fuga da tutto ... Pochi sono convinti, pochi cap1sc?no che noi, i solitari, ci sbarriamo dietro una porta nel chmso della nostra interiorità non già per praticare la virtù,_ ma al_ contrario per morire alla virtù stessa ... Infatti, se no1 cerchiamo la virtù a partire dalla quiete e i nostri fratelli s?erimentati dalla vita comune fanno altrettanto, perché aggmngere questa fuga e seppellirsi in una cella? No, noi ci
15 Letteralmente: "capanna". 16
Si .n?ti l'importanza che !sacco attribuisce all'accompagnamento spirituale, mostra~do:r In ta! r;nodo fed_ele alla secolare tradizione monastica che ritiene la vita monas;;ca rmpossrbile senza il competente aiuto di un anziano ricco di esperienza.
Centune dz couoscenza IV,7r.
79

aspettiamo di ricevere dalla quiete qualcosa che è impossibile raggiungere tra la folla, nemmeno impegnandosi allo stremo delle forze 18 . Se fossimo dediti all'opera della virtù, in che modo la coabitazione con molti ci sarebbe di ostacolo? La coabitazione non ha mai impedito né il digiuno, né la liturgia, né l'elemosina, né altre simili opere; anzi, essa darebbe modo di praticarle ancora di più. D'altro canto, non sappiamo se la virtù esista all'infuori di queste cose ... Le delizie spirituali dispensate dall'opera nascosta non sono contate come virtù, ma quest'opera è più importante della virtù stessa 19
. La virtù è qualsiasi opera compiuta a causa di Dio, in pubblico e con l'aiuto dei sensi corporei. Ecco perché pratichiamo la virtù in una comunità e, ammaestrati da essa, entriamo nella quiete, aspettando però di esserne diventati degni. È chiaro che anche il canto degli uccelli turba la quiete: a maggior ragione lo faranno le persone che entrano ed escono in continuazione e che siamo costretti a vedere! Sappiamo che molti padri spirituali ai quali il corpo non permette più di praticare le opere della virtù non vogliono minimamente ridurre la loro quiete: prostrati faccia a terra dentro le loro celle, con la porta chiusa, rimangono soli nella quiete. Sarebbe giusto diminuire la loro quiete per il fatto che non sono in grado di praticare le fatiche dell'ascesi? La dolcezza della solitudine non permette loro di essere continuamente esposti agli sguardi di un'assemblea. Giacché una sola preghiera offerta a Dio in solitudine, prostrati nell'intimo del cuore, nella dolcezza del dolore e dell'umiltà, è ben più deliziosa di mille fatiche e preghiere offerte a Dio fuori della cella, e ben più dolce anche di quanto di meglio si veda e si pratichi assiduamente nella vita comune, e più ancora di tutte le ricreazioni e le feste. Il fine della virtù [praticata nella vita comune] è il rapporto solitario con Dio e la meditazione silenziosa e spirituale su di lui. Per il solitario non ci sono feste
1' Letteralmente: "nemmeno se restassimo appesi per le palpebre", immagine che suggerisce uno sforzo estremo.
19 Letteralmente: "è signora della virtù".
So
sulla terra. Il pentimento è la sua festa, e in luogo delle fatiche dell'ascesi, di cui altri si gloriano non senza qualche compiacimento, egli conosce il peso della quiete 20 •
Questa fuga da tutti gli esseri umani non ha altro fine che favorire l'unione con Dio: il solitario non ama essere distratto dal suo stare al cospetto di Dio. !sacco trova accenti severi per denunciare il danno che il solitario ricava dall'incontro con la
gente:
Oh, che danno per il solitario la vista e la frequentazione della gente! Come il soffio improvviso del gelo avventandosi sulle tenere gemme degli alberi le trafigge e le brucia, così i contatti con gli altri, anche brevi, anche apparentemente ispirati da buoni motivi, fanno appassire i fiori della virtù appena schiusi nell'aria temperata della quiete che protegge con delicata dolcezza l'albero fruttifero dell'anima, piantato lungo i ruscelli del pentimento. E come il freddo glaciale assalendo i nuovi germogli li brucia, così le conversazioni con la gente aggrediscono e distruggono le radici di una mente da cui è appena spuntata qualche tenera gemma di virtù. E se può nuocere all'anima il commercio con persone che, pur controllate in un campo particolare, in altri conservano qualche difetto di minor conto, quanto più dannose saranno la vista e le chiacchiere degli ignoranti e degli sciocchi 21 !
Nel trattare della necessità di fuggire il mondo e gli uomini, !sacco porta spesso a esempio gli asceti d'altri tempi, specialmente Arsenio il Grande, che gli era particolarmente caro, del quale racconta il seguente aneddoto: Arsenio, vedendo un visitatore che si avvicinava al suo deserto, scappò via. "Aspettami, padre mio - gridò il monaco - perché io ti rincorro a causa di
2° Centurie di conoscenza II,4r.43-44· 21 I,r9 (p. 99) = Touraille 13 (p. 112); PR r6 (pp. I3I-IJz).

Dio"; "E a causa di Dio io ti fuggo", replicò Arsenio 22. In un'al
tra occasione Arsenio si prostrò davanti a un monaco che era venuto a trovarlo dicendo: "Non mi alzerò finché non te ne sarai andato". Quando gli fece visita un arcivescovo in cerca di insegnamento spirituale, Arsenio rispose: "Dovunque tu senta dire che si trova Arsenio, non andarci". Un giorno, richiesto del motivo per cui evitava tutti, rispose: "Dio sa che vi amo, ma non posso stare nello stesso tempo con Dio e con gli uomini". Questo era il modo in cui Arsenio osservava il comandamento ricevuto da Dio: "Arsenio, fuggi gli uomini e sarai salvato" 23
•
Secondo I sacco, la rinuncia alle persone dev'essere radicale e assoluta. Ogni relazione o legame di amicizia e di affetto dev'essere troncato. La rinuncia ai genitori e ai parenti è uno dei temi più tradizionali della letteratura monastica. Per spiegarlo Isacco porta l'esempio di un santo monaco che non andava mai a trovare il fratello, monaco anch'esso. Quest'ultimo, in punto di morte, gli mandò un messaggio per chiedergli che venisse a dirgli addio. "Ma non per questo, nemmeno nell'ora in cui la natura è solita mostrare compassione al prossimo, il sant'uomo si lasciò convincere a oltrepassare i limiti che si era volontariamente imposti. 'Se esco- disse- il mio cuore non sarà più puro al cospetto di Dio'. Il fratello dunque morì senza vederlo" 24
. La storia, che suona crudele a orecchi moderni, mostra quale grado di rinuncia il monachesimo primitivo si aspettasse dai monaci.
A volte Isacco parla non solo di fuga dalla gente ma anche di morte rispetto alla gente. Morire agli uomini è condizione del morire al mondo ed è indispensabile per raggiungere lo stato della limpidità spirituale:
22 I,n (p. II2) = Touraille 79 (p. 39I); PR I8 (pp. I53·I54l- Cf. Palladio, Storia lausiaca I 6.
23 !,44 (pp. 2I8·2I9) = Touraille, Lettere I (p. 453); PR 4I (pp. }09·3IO). Gli episo· di qui riportati sono tratti dagli Apoftegmi dei padri (cf. Arsenio I; 7; q; 37; e altri ancora).
24 !,44 (p. no)= Touraille, Lettere I (p. 454); PR 4I (p. }I2).
82
Quante volte succede che il solitario senta i propri pensieri muoversi al di là della carne, a partire dall'allontanamento dalla sua dimora, anche se le fatiche sono modeste! Questo perché egli è del tutto morto agli uomini. Nella misura in cui si lascia alle spalle la vita nel mondo addentrandosi in territori abbandonati e deserti e il suo cuore si accorge che gli uomini sono lontani, allora riceve la quiete dei pensieri. Giacché nel deserto, fratello mio, a forza di lottare contro i pensieri, la fatica e il tormento che vengono da essi non sono poi così grandi. In realtà la semplice vista del deserto mortifica naturalmente gli impulsi mondani del cuore e lo mette al riparo dai loro assalti. Come la vista di chi sta vicino al fumo, se non si allontana, non può essere chiara, così non è possibile acquisire purezza di cuore e quiete di pensiero senza la solitudine, lontano dai fumi del mondo che salgono davanti ai sensi e accecano gli occhi dell'anima 25 .
Per raggiungere la pienezza della sua vita in Dio, il monaco deve riuscire non solo a dimenticare gli altri e a cancellarne in sé ogni rimembranza, ma anche ad abbandonare qualsiasi preoccupazione per loro e rinunciare a ogni gesto di bontà nei loro confronti:
Se vuoi attenerti rigorosamente alla quiete, diventa come i cherubini, che non accolgono alcun pensiero su nessun argomento di questa vita, e mettiti nell'ordine di idee che, all'infuori di te e di Dio, non esista nessun altro sulla terra del quale tu debba curarti, come hai appreso dai padri che ti hanno preceduto. Finché un monaco non avrà indurito il proprio cuore costringendolo a trattenere la compassione, così da essere immune da qualsiasi preoccupazione per gli altri- a causa di Dio o di una qualche necessità materiale - e finché non saprà perseverare nella sola preghiera nei tempi stabiliti, sen-
25 Centurie di conoscenza IV,50·52.

za che alcun attaccamento o ansietà per gli altri si insinui nel suo cuore, egli sarà incapace di vivere nella quiete libero da turbamenti e preoccupazioni 26 •
Benché l'esigenza di limitare i gesti di misericordia riguardi solo i tempi specificamente previsti per la preghiera, è tuttavia evidente che agli occhi di Isacco la vita in quiete è più elevata della vita attiva al servizio degli altri. Per questo motivo egli insiste tanto sulla necessità di rinunciare, almeno in certi periodi, a ogni attività filantropica, se si vuole raggiungere il fine della vita nella quiete.
Amore di Dio e amore del prossimo
In che modo una così radicale insistenza sulla rinuncia agli uomini si concilia con il comandamento dell'amore del prassimo? Questa fuga dagli uomini non è al tempo stesso una fuga da Cristo, lui che ha detto: "Amerai il prossimo tuo come te stesso" (Mt 22,39)? Un tale isolamento non conduce alla perdita o all' assenza di ogni amore per gli altri, a un'indifferenza egoistica verso tutto ciò che è diverso da sé?
Sono domande alle quali Isacco si affretta a rispondere negativamente, sostenendo che, al contrario, fuggire gli uomini paradossalmente accresce l'amore verso di essi. Il comandamento di amare Dio è universale e include pertanto quello di amare il prossimo:
Il comandamento che dice: "Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua
26 I,21 (p. 1I2) = Touraille 79 (p. 39r); PR r8 (p. 153).
mente" (Mt 22,37), al di sopra del mondo, della natura e di quanto vi appartiene, è adempiuto quando tu perseveri pazientemente nella quiete. E il comandamento che tratta dell'amore del prossimo è incluso nel primo. Vuoi acquisire nell'anima, secondo il comandamento dell'evangelo, l'amore per il prossimo? Allontanati da lui, e il calore e la fiamma dell'amore per lui arderanno in te e gioirai alla vista del suo aspetto esteriore come se contemplassi un angelo di luce. Se poi desideri che quelli che ti amano abbiano sete di te, fa' in modo di vederli solo a giorni fissi. Ma tutto questo si impara con l'esperienza 27
•
Qui occorre sottolineare, per i lettori che potrebbero essere urtati da un tale atteggiamento verso il prossimo, che Isacco così parlando non intende proporre raccomandazioni universalmente applicabili, giacché i suoi scritti si rivolgono prevalentemente a eremiti ed egli parla a un pubblico del tutto particolare. Inoltre, non dice nulla che non parta dalla sua personale esperienza di solitario per vocazione, e che non tenga conto dell'esperienza di altri solitari che vivono o sono vissuti nelle vicinanze. Pertanto qui si tratta proprio della via monastica nel senso più stretto, quella che consiste nell'acquisire l'amore degli altri eliminando ogni contatto con loro.
Isacco è convinto che il compito principale di un cristiano sia la purificazione dell'uomo interiore, compito ben più importante dei rapporti con gli altri o di qualsiasi attività alloro servizio. Tale attività, d'altro canto, è particolarmente rischiosa quando il cuore del monaco non è del tutto purificato e vi albergano ancora le passioni. Molti, ricorda Isacco, divennero celebri per la loro attività filantropica, ma non dedicarono sufficienti cure alla loro anima per il fatto di trovarsi costantemente nel mondo, in mezzo alle sue passioni e alle sue tentazioni:
27 l,44 (p. 220) = Touraille, Lettere r (p. 455); PR 4r (pp. 312-313).

Molti hanno compiuto imprese di grande prestigio, hanno risuscitato morti, si sono prodigati nel convertire gli erranti, hanno operato grandi miracoli e molti, per merito loro, sono stati portati alla conoscenza di Dio. Ma in seguito proprio loro che avevano incoraggiato gli altri sono caduti in preda a passioni infami e abominevoli e si sono completamente adulterati, diventando pietra di scandalo per molti, una volta che la loro condotta fu rivelata. Questo perché la loro anima era ancora malata, e invece di prendersi cura della propria salute, si sono gettati nel mare del mondo per curare quella altrui, quando proprio loro erano infermi; così, come ho detto, hanno perduto se stessi e la loro speranza in Dio. La fragilità dei loro sensi non era in condizione di far fronte o resistere alla fiamma delle cose che sogliano far incrudelire le passioni28 .
Isacco dunque non condanna le buone azioni, ma sottolinea la necessità di godere di un'ottima salute spirituale prima di affrontare il mondo con l'intento di guarire gli altri. Chi sia spiritualmente solido e abbia acquisito la necessaria esperienza della vita interiore sarà più utile al suo prossimo. L'attività esteriore, anche quella apostolica utile agli altri, non potrà mai sostituirsi alla profondità interiore:
86
Insegnare agli altri ciò che è buono e prodigarsi assiduamente per liberarli dall'illusione e avvicinarli alla conoscenza della vita, è cosa eccellente. Questa è stata la via percorsa da Cristo e dagli apostoli, una via molto nobile. Ma se uno avverte che, a causa di questa via e del continuo rapporto con la gente, la sua coscienza si indebolisce alla vista delle cose esteriori, la sua serenità è turbata e la conoscenza si offusca ... che per voler guarire gli altri è sul punto di perdere la propria salute, che la sua mente è scossa e ha abbandonato la casta libertà della volontà, allora ... ritorni sui suoi passi, per non dover sentire
28 1,4 (p. 32) = Touraille 23 (p. 155); PR 4 (p. 46).
dalla bocca del Signore le parole del proverbio: "Medico, cura te stesso" (Le 4,23). Si condanni da solo e abbia cura della propria salute. Invece di parole, uno stile di vita nobile prenda il posto dell'insegnamento, e invece del suono della bocca siano di esempio agli altri le sue opere, cosicché, avendo conservato la salute dell'anima, per mezzo di questa possa rendersi utile agli altri. Giacché quando è lontano dagli uomini può essere loro più utile per il fervore delle sue buone azioni che attraverso le parole, visto che lui stesso è infermo ed è bisognoso di cure più di loro. Infatti "Se un cieco guida un cieco, cadranno entrambi nel fosso" (Mt 15 ,14)29.
Agli occhi di !sacco è dunque necessario che il solitario guarisca innanzitutto la propria anima, prima di prendersi cura di quelle degli altri. La vita interiore in Dio è più elevata di qualsiasi attività filantropica o missionaria:
Ama il disimpegno della quiete più dell'impegno per la fame nel mondo o per la conversione di masse di pagani. È meglio per te liberarti delle catene del peccato che liberare degli schiavi dalla loro servitù. È meglio per te fare la pace con te stesso che rappacificare le persone in disaccordo. Giacché, come ha detto Gregorio il Teologo, "è buona cosa parlare delle cose di Dio a causa di Dio, ma è meglio per l'uomo purificare se stesso davanti a Dio" 30 • Dedicarti ali' innalzamento della tua anima, morta a causa delle passioni, verso le intuizioni su Dio, ti è più utile che resuscitare un morto 31 .
Questo non vuole affatto dire che !sacco disapprovi le attività caritatevoli nel loro insieme; egli vuole solo sottolineare che esse non costituiscono il compito principale degli eremiti, e meglio si
29 1,6 (p. 57)= Touraille 56 (pp. }OO-}or); PR 6 (p. 89). 30
Gregorio di Nazianzo, Disco1!i 3,r2; citazione mancante nella versione siro-orientale 31 1,4 (p. 32) = Touraille 23 (p. 154); PR 4 (pp. 45-46). .

confanno ai secolarP2 . Per questi ultimi le opere di carità sono un dovere; quanto agli eremiti, il loro primo compito è di vegliare sui loro pensieri interiori e purificare la loro mente:
Infatti l'adempimento dei doveri della carità nell'ambito del benessere materiale costituisce il compito dei secolari nel mondo, e anche dei monaci, ma solo degli imperfetti fra loro, quelli che non vivono nella quiete o che mescolano la quiete con l'intesa fraterna e un continuo viavai. Per tutti costoro, l'attività caritatevole è buona e degna di ammirazione. Ma chi ha scelto di ritirarsi dal mondo, nel corpo e nella mente ... non deve servire nell'organizzazione delle cose materiali e nella giustizia visibile ... ma al contrario, mortificando le proprie membra che appartengono alla terra, secondo le parole dell'Apostolo (cf. Colj,)), deve offrire a Dio il sacrificio puro e immacolato dei propri pensieri, le primizie del proprio servizio come pure le sofferenze del corpo, sopportando pazientemente i pericoli a causa della sua speranza futura. Giacché la disciplina monastica rivaleggia con quella degli angeli, e non è giusto che noi abbandoniamo questo servizio celeste per aderire a cose materiali33
•
Quando parla all'infuori di un contesto eremitico, !sacco sottolinea la necessità delle buone azioni a favore del prossimo. Avendogli detto un monaco che "i monaci non sono tenuti a distribuire elemosine", egli ribatté che solo il monaco "che non possiede niente sulla terra, non guadagna nulla per sé a partire dalle cose materiali, non cerca di acquistare niente e ha l'animo libero da ogni attaccamento alle cose visibili" 34 si trova effet-
32 Cf. 1,54 (p. 270) = Touraille 33 (p. 209); PR 53 (p. 385). "1,2r (p. 109) = Touraille 78 (p. 387); PR r8 (pp. 147-148). Questa distinzione tra
i "solitari" e gli "altri" potrebbe richiamare quella tra "perfetti" e "giusti" nel Liber graduum. Secondo questo testo i perfetti devono assomigliare agli angeli che non vestono gli ignudi, non danno da mangiare agli affamati e non si curano dei loro fratelli (cf. Liber gradu11m 25,8).
"1,2r (p. no)= Touraille 79 (p. 388); PR r8 (pp. I48·r49).
88
tivamente in quella condizione. Ma i cenobiti non sono dispensati dalla necessità di fare l'elemosina e compiere atti di filantropia in favore dei loro vicini. Quanto agli eremiti, non devono fare elemosina bensì misericordia, una misericordia che si manifesta non tanto nelle opere buone quanto attraverso la loro intercessione in favore del mondo intero. Tuttavia essi non possono evitare certe iniziative concrete, soprattutto in situazioni che richiedono un intervento immediato in soccorso di chi soffre:
Benedetto è l'uomo di misericordia, perché troverà misericordia (cf. Mt 5, 7), non solo nell'aldilà ma quaggiù, in modo mistico. Invero, si dà misericordia più grande di quella di chi, per compassione del prossimo, ne condivide le sofferenze? Nostro Signore affranca l'anima di costui dall'oscurità delle tenebre -che è la geenna spirituale- e la guida alla luce della vita, colmandola di delizie ... Quando è in tuo potere di liberare l'empio dal male, non trascurare di farlo. Non penso tu debba lanciarti in un'impresa del genere quando la cosa è molto distante, giacché una simile attività non appartiene al tuo modo di vita. Se però la cosa è a portata di mano e rientra nelle tue capacità ... guardati allora dall'essere partecipe del sangue dell'empio per non aver voluto fare lo sforzo di liberarlo ... Invece di essere un vendicatore, sii un liberatore; invece di un avvocato di parte, un pacificatore; invece di un traditore, un martire; invece di un accusatore, un difensore. Supplica Dio per i peccatori affinché trovino misericordia 35 .
Quindi in certe circostanze anche gli eremiti, il cui compito non è di dedicarsi alle opere buone, hanno il dovere di agire come liberatori e difensori degli uomini. Più in generale, devono sforzarsi di acquisire l'amore del prossimo come una qualità interiore, un amore universale e pieno di misericotdia per tutti gli

uomini e tutte le creature. Essendo pieni di misericordia no guarire se stessi, pensa Isacco, aggiungendo così una IJ""-i·>l:l.
zione importante alla sua tesi secondo cui non è opportuno plicarsi a opere di carità prima che la propria anima sia Se le opere buone non sono in grado di guarire l'anima di chi le compie, lo farà la misericordia interiore:
Dentro di te sia sempre il piatto della misericordia quello pende di più, finché tu riconosca in te la che Dio ha per il mondo. Questo stato diventi lo nel quale vediamo in noi stessi la e vera-ce di ciò che appartiene per natura all'essenza divina. Per mezzo di queste e simili cose siamo illuminati in modo tale da essere spinti a Dio con intelletto limpido. Un cuore duro e senza pietà non sarà mai L'uomo misericordioso è medico di se stesso da sé le della pas-sione come per effetto di un vento impetuoso36
.
L'amore universale di cui parla non si raggiunge con atti di filantropia né in attraverso sforzi umani: è un dono che riceviamo direttamente da Dio. L'insegnamento di !sacco sul modo di acquisire l'amore del prossimo può essere così illustrato: se uno si ritira dalla compagnia dei suoi simili per vivere in solitudine e nella acquista l'amore ardente di Dio, ed è questo amore nascere in lui "l'amore luminoso" ({mbba shapya) per gli uomini. Isacco prende l'espressione aprestito dalle Omelie dello Pseudo-Macario, da Giovanni il Solitario e da altri autori , quindi la sviluppa nel capitolo ro della seconda parte:
90
36
"
e frequenta la conoscenza raggiungerà "f·"''-'"'·""·"1.'- l'amore di Dio, grazie al quale si
Touraìlle 34 (p. 2r5); PR 65 (p. 455). n. I a II,r0,34, in esco 555, p. 49·
avvicinerà ali' amore perfetto per gli uomini, suoi pross1m1. Nessuno si è mai potuto accostare a questo amore luminoso per gli uomini senza essere stato precedentemente giudicato degno dell'amore meraviglioso e inebriante di Dio 38
•
Lo schema così concepito da Isacco differisce da quello della Prima lettera dì Giovanni: "Chi non ama il proprio fratello vede, non può amare Dio che non vede" (rGv 4,20). Secondo Isacco bisogna prima di tutto amare Dio che non si e quindi, grazie a tale amore, avvicinarsi all'amore per il prossimo che si vede, o piuttosto non si vede, poiché ci si è deliberatamente proibiti di vederlo. La conquista dell'amore attraverso le opere buone è altrettanto impossibile che la conquista dell'amore di Dio attraverso l'amore del prossimo:
Arrivare all'amore luminoso per uomini a partire dalla fatica e dalla lotta contro i pensieri, e a da questo amore essere innalzati fino all'amore di Dio portare a compimento un tale processo nel corso della anche prolungan-dolo fino all'ora del congedo mondo tutto ciò è impos-sibile per l'uomo, quale che sia la sua lotta. Grazie ai coman-damenti e al discernimento, tenere a freno i propri pensieri e purificare la propria rispetto ad essi [agli uomini], e può persino alcune opere buone in loro favore. Ma quanto a l'amore luminoso degli uo-mini attraverso la lotta, io non sono affatto convinto che sia possibile: nessuno vi è mai arrivato in questo modo e nessuno mai vi arriverà in questa vita, percorrendo una strada del genere. Senza bere vino non d si può ubriacare e far sobbalzare il cuore di gioia; parimenti, senza l'ebbrezza in Dio nessuno raggiungerà, attraverso lo sviluppo naturale delle cose, una virtù che non gli né essa dimorerà in lui serenamente e senza
9I

Si tratta di una forma particolare di amore del prossimo, la più elevata, chiamata da !sacco amore "luminoso" o "perfetto", che è dono di Dio, estraneo alla natura umana. Esso dunque non è assolutamente l'amore naturale degli uomini, degli animali domestici, degli uccelli, delle bestie selvatiche, e via dicendo, che si trova in molti 40 , ma un amore sovrannaturale che nasce dall'ebbrezza causata dall'amore di Dio41 . L'amore luminoso del prossimo è l'amore sacrificale che rende somiglianti a Dio, che ama peccatori e giusti allo stesso modo:
Chi è stato giudicato degno di gustare l'amore divino ((JUbba alabaya) 42 dimentica tutto per la sua dolcezza, perché a paragone di quel sapore tutte le altre cose sensibili appaiono vili, e la sua anima si accosta gioiosamente all'amore luminoso degli uomini senza distinzioni tra peccatori e giusti. Una tale persona non è mai sopraffatta né turbata dalle debolezze che incontra nella gente, ma si comporta come i beati apostoli i quali, in mezzo a tutte le offese che dovettero sopportare dagli uomini, erano però assolutamente incapaci di odiarli o di smettere di mostrare amore per loro. Questo si manifestava attraverso le azioni, perché accettarono persino la morte affinché gli altri fossero salvati; ed erano quegli stessi discepoli che poco prima avevano domandato a Cristo di far scendere la folgore dal cielo sui samaritani solo perché si erano rifiutati di accoglierli nel loro villaggio (cf. Le 9,54)! Ma una volta ricevuto e assaporato l'amore di Dio, divennero perfetti anche nell'amore per i malvagi, sopportando ogni sorta di male allo scopo di accattivarseli, incapaci di odiarli. Da qui vedete bene come l'amore perfetto del prossimo non possa essere conquistato con la semplice osservanza dei comandamenti 43 •
"Cf. ibid. " Il tema dell'"ebbrezza" sarà discusso nel capitolo "La vita in Dio" (d. in/ra, pp.
259-319). 42 Espressione caratteristica di Giovanni il Solitario: cf. S. Brode, n. r a II,ro,J6,
in esco sss. p. so. "II,ro,J6.
92
È per questo che, basandosi sull'insegnamento dell'evangelo riguardante i due maggiori comandamenti, !sacco ne offre un'interpretazione personale e propone una sua via particolare per giungere all'amore di Dio e del prossimo. Ma questa via non è destinata alla maggioranza degli uomini: essa riguarda unicamente quelli che hanno seguito la solitudine come percorso di vita, hanno rinunciato al mondo e si avvicinano a Dio attraverso la vita nella quiete.
Vivendo lontano dalla gente e restando interiormente solo, il solitario può e deve mostrare il suo amore per gli altri:
Gioisci con chi è nella gioia (cf. Rm 12,r5), perché questo è il segno della limpida purezza. Soffri con i malati e sii triste con i peccatori, rallegrati con chi si pente. Sii amico di tutti, ma resta solo nella tua mente. Condividi le pene di tutti, ma tieni il tuo corpo distante da tutti. Non respingere nessuno, non insultare nessuno, nemmeno coloro che vivono in modo malvagio. Stendi il tuo mantello su chi cade e coprilo. E se non puoi prendere i suoi peccati su di te né ricevere il castigo al suo posto, almeno soffri la sua vergogna e non farlo arrossire ... Sappi, fratello, che se dobbiamo restare chiusi dietro la porta della nostra cella, è per non sapere le azioni malvagie degli uomini, ed è cosl che, vedendoli tutti buoni e santi, raggiungeremo la purezza della mente44 .
Così l'amore luminoso per il prossimo, che non ci fa vedere i peccati e le debolezze altrui ma solo le loro qualità, nasce in un cuore purificato e in una mente che dimora nella quiete, totalmente libera dalle faccende del mondo.
44 I,51 (p. 247) = Touraille 58 (p. 316); PR 50 (pp. 349-350).
93

Quiete e silenzio
In che cosa consiste dunque questa "quiete" (shelya) di cui !sacco parla continuamente? È una volontaria rinuncia al dono della parola, al fine di creare un silenzio interiore in cui si senta la presenza di Dio; consiste nel restare senza p~sa al cospetto di Dio in perfetto silenzio e in stato di preghiera. E il ritiro da ogni attività di parola e pensiero, per conquistare il silenzio e la pace dello spirito:
Ecco la definizione di quiete (d-shelya): silenzio (shelyuta) in ogni cosa. Se nella quiete ti ritrovi pieno di affanno, se tormenti il corpo con il lavoro manuale e l'anima con le preoccupazioni, giudica allora tu stesso che genere di quiete stai praticando, dal momento che ti occupi di tante cose per piacere a Dio! È ridicolo che parliamo di quiete se non abbandoniamo ogni cosa e non ci stacchiamo da ogni preoccupazione 45 •
!sacco distingue due specie di quiete: esteriore e interiore. Quella esteriore consiste nell'osservare il silenzio della lingua e della bocca; l'interiore nel silenzio dell'intelletto, nella pace del pensiero, nella calma del cuore. La quiete interiore è più elevata di quella esteriore, ma se manca la prima, l'altra non serve: "Se non puoi essere silenzioso nel tuo cuore, osserva almeno il silenzio della lingua" 46
. La quiete interiore è scavata da quella esteriore e l'asceta deve sempre praticare la seconda per realizzare la prima:
94
Ama il silenzio sòpra ogni altra cosa, poiché ti rende simile a un frutto che la lingua non può esprimere. Costringiamoci al
45 1,2r (p. ru) = Touraille 75 (p. 392); PR r8 (p. 154). 46 1,5r (p. 247) = Touraille 58 (p. 316); PR 50 (p. 350).
silenzio, e da esso nascerà qualcosa che condurrà verso il silenzio stesso [vale a dire il silenzio interiore]. Possa Dio concederti di provare almeno una parte di ciò che nasce dal silenzio! Se intraprenderai questa pratica, non so dirti tutta la luce che ne ricaverai. Quando Arsenio, uomo meraviglioso, restava in silenzio - si dice di lui che durante le visite che i padri gli facevano stesse seduto con loro e li congedasse senza aver proferito parola - non credere, fratello, che lo facesse volontariamente se non all'inizio, quando vi si costringeva. Dopo qualche tempo, una certa dolcezza nasce nel cuore a partire dall'esercizio di questa fatica, che forza il nostro corpo a perseverare nella quiete ... Il silenzio è anche un cammino verso il silenzio ... Quando Arsenio si accorse che, per via dell'ubicazione della sua dimora, spesso gli era impossibile stare lontano dagli uomini e dai monaci che abitavano nei dintorni allora apprese dalla grazia quel percorso di vita che è il sile~zio ininterrotto. E se talvolta la necessità lo costringeva ad aprire la porta a qualcuno, questi era già felice per il solo fatto di vederlo: la conversazione e lo scambio di parole tra loro erano diventati superflui 47 •
L'esperienza di un silenzio che è assenza di parole è un'esperienza di partecipazione alla vita del mondo a venire. Come scrive !sacco, "il silenzio è il mistero del secolo a venire, ma le parole sono gli strumenti di questo mondo" 48 .
Il silenzio esteriore produce frutti nell'interiorità dell'io, mentre l'incapacità a tenere a freno la lingua porta all'offuscamento spirituale:
Fratello, se trattieni la lingua Dio ti concederà il dono della compunzione del cuore; contemplerai la tua anima e avrai così accesso alla gioia spirituale. Ma se la lingua avrà la meglio
47 1,64 (pp. 3I0-3rr) = Touraille 34 (p. 213); PR 65 (pp. 450-452).
48 1,65 (p. 321) = Touraille, Lettere 3 (p. 46r); PR 66 (p. 470).
95

su di te ... non sarai mai in grado di sfuggire all'oscurità. Se il tuo cuore non è puro, che almeno lo sia la bocca49 .
La natura della quiete interiore sarà sviluppata in maggior dettaglio nel capitolo del presente studio dedicato alla "vita in Dio", che verterà sulla "quiete della mente", uno dei gradi più elevati del cammino spirituale. Per il momento ci limitiamo a indicare i diversi frutti interiori della "vita nella quiete", cioè della forma eremitica della vita monastica. Isacco tratta la questione in una lettera a un amico anonimo, nella quale raccoalie le testimonianze degli asceti del suo tempo su questo tema. Queste testimonianze menzionano numerosi frutti della quiete, in particolare:
- Come una tale vita conduca a una concentrazione della mente e a un approfondimento dell'attività spirituale dell'intelletto: "Ecco il vantaggio che io ricavo dalla quiete: quando lascio la mia dimora, la mia mente è priva di qualsiasi preparazione alla lotta e si applica a un'attività superiore".
- Come questa vita porti alla dolcezza spirituale, alla gioia, alla tranquillità interiore e a una perdita estatica dell'attività dei sensi e dei pensieri: "Io corro verso la quiete affinché i versetti della mia lettura si riempiano per me di dolcezza. E quando la mia lingua tace per la soavità prodotta dalla loro comprensione, cado in una sorta di sonno, in uno stato in cui i sensi e i pensieri cessano da ogni attività. Quando poi, dopo un silenzio
Prolunaato il mio cuore è reso calmo e privo di turbamento ... "' ' onde di gioia si accostano alla navicella della mia anima e la
immergono nella quiete che esiste in Dio, come in un vero e proprio stupore".
- Come la quiete cancelli i ricordi che fanno torto alla mente, e come essa sia così in grado di ritornare al suo stato naturale.
49 l,48 (p. 236) = Touraille 73 (pp. 375-376); PR 46 (p. 334).
- Come la quiete aiuti a liberare la mente e a concentrarsi sul pentimento e la preghiera: "Quando si vedono molti volti e si ode ogni sorta di voci estranee alla meditazione spirituale ... la mente non è abbastanza libera per contemplare se stessa segretamente, rammentarsi dei suoi peccati, ridurre al nulla i pensieri, fare attenzione a ciò che le viene in mente e dedicarsi alla preghiera nascosta".
- Come la quiete aiuti a "sottomettere i sensi al dominio dell'anima" 50 •
La vita di quiete e silenzio ridesta nell'interiorità dell'anima quell"'uomo nascosto del cuore" di cui parla san Pietro (d. rPt 3,4). Tale processo si sviluppa in proporzione al grado di mortificazione dell'uomo esteriore, che deve affrontare le lotte nel mondo:
Al dire di Basilio, la quiete è l'inizio della purificazione dell'anima51. Giacché, quando le membra cessano da ogni loro attività esterna e la dispersione che ne deriva ha termine, la mente si distoglie dalle distrazioni e dai pensieri che errano al di fuori della sua sfera, e si colloca tranquillamente all'interno di se stessa, finché il cuore si risveglia per esprimere le riflessioni che ha dentro ... Se la purezza non è altro che l'oblio di un modo non libero di vivere e l'abbandono delle proprie abitudini, come e quando potrà l'uomo purificare la sua anima che, per sua o altrui attività, rinnova in lui il ricordo delle consuetudini di un tempo? Se il cuore si macchia ogni giorno, quando sarà lavato dalle sue lordure? E se non riesce a resistere all'azione delle cose esterne, come potrà purificarsi nel bel mezzo dell'accampamento e nell'incalzare quotidiano dei rumori di guerra? Ma ritirandosi da tutto ciò potrà a poco a poco far cessare questo primo tumulto interiore ... Solo quando entra nella quiete l'anima può discernere le passioni ed esa-
'0
I,65 (pp. vo-vr) = Touraille, Lettere 3 (pp. 459-46r); PR 66 (pp. 468-470). '
1 Lettera 2 (a Gregorio di Nissa).
97

e, giorno per giorno, ""~"~""~" nascosta che fiorisce nella sua
i sensi esteriori e ravviva i moti interiori, mentre lo di vita esteriore fa il contrario: ravvi-va i sensi esteriori e uccide i moti interiori 52 •
Osserviamo come anche quando
sia del tutto coerente con se stesso la priorità dell'attività interiore su
Ma contemporaneamente constatiamo l'imposla quiete interiore della mente senza il si-
quella sibilità di lenzio modo, il della vita
della lingua, dei sensi e dei pensieri. In questo ,,.~·~u·''"u sopra ogni altra cosa" diventa la prima legge
stato di """""'"·"'""'"'
Senza di esso non solo non si raggiunge lo ma non si è nemmeno in grado di fare i primi conduce a Dio.
Un cammino monastico verso Dio
"Sappi che una vita breve nella giustizia conformemente al desiderio di Dio è preferibile a molti giorni passati a provocare la sua collera", scrive Isacco. Merita di essere vissuta solo una
poco importa se breve o lunga - che conduce all'unione con Dio. Tale è la vita del monaco, che non persegue altro fine. splranLdOSl alla similitudine di san Paolo (cf. 1Cor 9,24-25),
riprende l'immagine dell'atleta che corre nello stadio per il modo in cui l'intelletto dell'uomo si dirige verso
alll~grez<~a spirituale di Cristo, coronamento della vita solita-
ria53 • A volte paragona la vita spirituale a una navigazione per mare 54 ; più spesso a una scala 55 , affatto tradizionale nella letteratura cristiana56. ascesa è senza fine, poiché la sua meta è Dio, che è
La fine di questo non può essere mai raggiunta, al punto che anche i santi sentono piamente il bisogno della sapienza perfetta, il verso la sapienza non ha fine. La sale tanto in alto da unire a Dio colui che la persegue. proprio questo il segno che le intuizioni della sapienza sono illimitate: la sapienza è Dio in persona57 •
Il solo cammino Isacco conobbe per ascendere a Dio fu quello monastica ed eremitica. Non è quindi sorprendente le sue raccomandazioni ascetiche siano rivolte prima di tutto ai monaci, benché molte di esse abbiano portata universale. l'inizio della vita con Dio come la conclusione di un'alleanza (qyama) con lui per separarsi dal mondo:
Quando l'uomo a Dio, conclude con lui un'alleanza per staccarsi da tutto. Con ciò intendo non vedere volto di donna, non contemplare lo splendore di cose o persone e il loro o abiti, non curare la compagnia dei secolari né ascoltarne le parole né volerne sapere di loro 58
.
Qui non si tratta di voti monastici, ma piuttosto di una deci-sione di rinuncia al mondo e a quanto vi appartiene, ri-tirandosi completamente dalla società degli uomini.
5J
54 (p. 1 n) Touraille 79 (p. 392); PR r8 (p, 225). (p. u) Touraille 30 (p. 189); PR 2 (p. 12), e passìm.
56 ricordarsi dell' Inte1pretazìone delle Beatitudini di Gregorio di N issa e della Scala del paradiso di Giovanni Clirnaco.
57 (p. r63) Touraille 85 (p. 4r7l; PR 35 (p. 225). 5' (p. 169) = Touraille 85 (p. 422); PR 35 (p, 235).
99

Il tema dell'"alleanza" con Dio è uno dei più importanti nella letteratura protomonastica di lingua siriaca. Raggiunge particolare sviluppo presso Afraat che menziona un gruppo di asceti nell'ambito della chiesa siriaca detti "figli dell'alleanza" o "alleati" (bnay qyama)59
• Si trattava di laici il cui comportamento non differiva in nulla da quello degli altri cristiani di Siria, se si eccettuano i voti di celibato, di povertà e di servizio della comunità parrocchiale60 • In seguito il termine di alleanza fu attribuito al monachesimo siriaco che aveva sviluppato le aspirazioni ascetiche dei "figli dell'alleanza". In particolare, l'idea che gli eletti fossero ben distinti dagli altri - idea assai diffusa fra gli "alleati" - avrebbe avuto pieno sviluppo nella tradizione monastica posteriore, alla quale Isacco appartiene.
In questa tradizione il monachesimo si opponeva radicalmente al resto dell'umanità e i monaci si consideravano una schiera di eletti:
I figli di Dio sono quindi separati dal resto dell'umanità: essi vivono nell'afflizione mentre il mondo gode del lusso e degli agi. Giacché Dio non vuole che coloro che lo amano vivano negli agi finché risiedono nella carne. Egli piuttosto desidera che durante tutta la loro vita terrena abitino nell'afflizione, nell'oppressione, nella fatica, in povertà, nudità, isolamento, nel bisogno, nella malattia, l'abiezione e la difficoltà, nello strazio del cuore, nel rigore corporale, nella rinuncia ai famigliari e nel pensiero del pentimento. Egli desidera per loro un aspetto diverso da quello del resto della creazione e dimore dissimili da quelle degli altri; vuole che si stabiliscano in luoghi solitari e tranquilli, ignoti a sguardo umano e privi di tutto ciò che rende gradevole la vita. Essi piangono, ma il mon-
59 Cf. S. H. Griffith, "Monks, 'Singles' and the 'Sons of the Covenant"', pp. 141 ss.; G. Nedungatt, "The Covenanters of the Ea1ly Syrian-speaking Church", in Orientalia cbristianaperiodica 39 (r973), pp. I9I ss.
60 S. AbouZayd, Ibidayutba, p. IDI.
IOO
do ride; sono tristi, ma il mondo gioisce; digiunano, ma il mondo sguazza nei piaceri. Di giorno soffrono, di notte si costringono a lotte ascetiche aspre ed estenuanti61 .
Nella società cristiana il monachesimo svolge un ruolo del tutto peculiare e vi penetra fino al cuore. Per !sacco ogni monaco doveva essere irreprensibile e dare un buon esempio ai secolari in tutto ciò che riguarda la sua vita:
Il monaco (i~idaya, solitario), nel suo aspetto e in tutto ciò che fa, dev'essere di incoraggiamento a chi lo guarda. Così, grazie alle molte sue virtù che brillano come i raggi del sole, i nemici della verità che lo vedono ammetteranno, loro malgrado, la speranza della salvezza che è ferma e incrollabile nei cristiani, e accorreranno a lui come a un rifugio ... Giacché la vita monastica è la gloria della chiesa62 .
Agli occhi di Isacco la via del monaco è un martirio invisibile, che ha per meta la corona della santità63 . Essa è anche un modo di "prendere la propria croce" ed è quindi incompatibile con la ricerca degli agi: "Il cammino di Dio è la croce di tutti i giorni. Nessuno è salito al cielo per una strada agevole ... " 64
• Prendere la propria croce significa condividere le sofferenze di Cristo:
O lottatore, assapora dentro di te le sofferenze di Cristo, per essere giudicato degno di assaporarne la gloria. Giacché se
61 I,6o (pp. 293-294) = Touraille 36 (p. 223); PR 6o (pp. 424-425). 62 I, II (p. n)= Touraille IO (p. ID3); PR II (p. rr9). Questa concezione della vita
monastica è caiatteristica di tutto l'oriente cristiano nei secoli VII e vm. Essa era ancor più marcata a Bisanzio, dove il monachesimo aveva un ruolo dirigente all'interno della chiesa, particolarmente nel periodo successivo alla crisi iconoclasta. Nella Scala del paradiso di Giovanni Climaco (c. 26) si leggono frasi simili alle affermazioni di Isacco sui monaci: "Gli angeli sono una luce per i monaci, e la vita monastica è una luce per tutti gli uomini. Che i monaci si sforzino dunque di diventale un buon esempio in tutto".
63 Cf. I,37 (p. I7J) = Touraille 85 (p. 426); PR 35 (p. 424). 6
' I,59 (p. 290) = Touraille 4 (p. 75); PR 59 (p. 4I8).
IOI

noi soffriamo con lui saremo glorificati con lui. L'intelletto non è glorificato con Gesù se il corpo non soffre con lui 65 .
La vita sulla terra è quindi sentita dal monaco come una crocifissione:
Finché hai mani, tendile al cielo nella preghiera prima che le braccia ti si stacchino dalle giunture e non smettere mai, anche se vorresti. Finché hai dita, segnati nella preghiera prima che la morte venga a sciogliere la forza dei loro tendini. Finché hai occhi, riempili di lacrime, prima dell'ora in cui la polvere coprirà la tua veste nera 66 .
La via che porta a Dio sarà diversa per ciascun monaco, ma il punto di partenza è uno solo per tutti: l'ascesi, che implica preghiera e digiuno 67 . !sacco attribuisce una funzione importante al digiuno e ad altri mezzi che mirano a disciplinare il corpo:
Il digiuno, le veglie e la vigilanza nel servizio di Dio per resistere alla dolcezza del sonno, crocifiggendo il corpo giorno e notte, costituiscono la via santa di Dio e il fondamento di ogni virtù. Dì tutto ciò il digiuno è il campione: principio della lotta, corona dell'astinente, splendore della verginità e della santità, sfavillio della purezza, inizio del cammino del cristiano, fonte della sobrietà e della prudenza, signore della quiete e precursore di tutte le opere buone. Come il godimento della luce procede di pari passo con la sanità degli occhi, così il desiderio della preghiera accompagna il digiuno praticato con discernimento ... Anche il Salvatore, al momento di manifestarsi al mondo presso il Giordano, da lì prese le mosse. Infatti, dopo il battesimo ... digiunò quaranta giorni e
65 1,36 (p. r6r) = Touraille r6 (p. rq); PR 34 (p. 222), 66 l,64 (p. 315) = Touraille 34 (p. 215); PR 65 (pp. 459-460). 67 Cf. Il,JI,I.
102
quaranta notti (cf. Mt 4,1-12). Allo stesso modo, tutti coloro che muovono sulle sue tracce fondano [sul digiuno] l'inizio della loro battaglia 68
.
Il digiuno, accompagnato da altre sofferenze corporali, deve procedere di pari passo con l'attività spirituale. Secondo !sacco la sofferenza corporale precede quella dell'anima, la quale a sua volta precede ogni attività della mente:
Le opere compiute con il corpo precedono quelle compiute con l'anima ... Chi non ha compiuto opere corporali non può possedere quelle dell'anima, poiché queste nascono da quelle, come la spiga nasce da un semplice granello di frumento. E colui che non possiede le opere dell'anima è privato dei doni spirituali 69 .
La mortificazione del corpo porta a un rinnovamento spmtuale dell'anima: "Nella misura in cui il corpo appassisce e si,indebolisce ... l'anima si ravviva di giorno in giorno e fiorisce progredendo verso Dio" 70
. Tuttavia le sofferenze corporee non sono di alcuna utilità se non si accompagnano al "governo interiore della mente" e se il monaco limita a esse il suo impegno spirituale. Tale impegno infatti riposerebbe unicamente su sforzi ascetici esteriori, facendo assomigliare il monaco in tal modo a quei farisei condannati da Cristo:
Limitare continuamente la propria speranza, come è tipico di un servizio unicamente esteriore, appartiene alla visione immatura e giudaica di coloro che menano vanto dei loro digiuni, delJe offerte e della durata delle loro preghiere, come ha detto nostro Signore (cf. Mt 6,16), ossia di coloro che non
66 l,37 (pp. I7I-r72) = Touraille 85 (pp. 424-425); PR 35 (pp. 238-240). 69 lA (p. 29) = Touraille 23 (p. r5r); PR 4 (pp. 40-41). 70 Il,24,3·
103

intimo la minima percezione né su Dio con le quali possano ornare la pro
un incremento di speranza 71 •
Seguendo uno classico che risale ad autori più quali Evagrio e il Solitario, il cammino del monaco verso Dio si divide tre tappe di progresso spirituale. Sì tratta dello stesso schema adottato da Isacco, quando scrive:
Le tappe attraverso le quali si progredisce sono tre: dei principianti, la tappa intermedia e quella di coloro che hanno raggiunto la pienezza. Nella prima, anche se la mente è orientata verso il tutto il pensiero e tutto il sono circoscritti dalle passioni. La seconda è una sorta di via mediana tra le passioni e la tappa spirituale: vi si agitano in egual misura pensieri della mano destra e della mano sinistra, mentre luce e tenebre vi si alternano senza posa. Quanto alla terza tappa, essa è caratterizzata dalle rivelazioni dei misteri divini, quando Dio dischiude la sua porta al monaco che ha perseverato nelle fatiche 72 .
Ne risultano tre tipi differenti di fatiche spirituali, ciascuno dei quali corrisponde a una tappa ben precisa dell'avanzamento spirituale:
I04
La fatica spirituale e il suo fine non sono identici nella tappa dei principianti, in quella intermedia e in quella finale. La
comporta una parte considerevole di recita-te" e la sola sottomissione del corpo a un difficile di-
Al culmine della tappa tutto dò diminuirà, la perseveranza del monaco cambierà oggetto e si estenuerà nella lettura spirituale e più particolarmente nelle genufles-
79-80) = Touraille II (p. ro5); PR 12 (pp. I2I·I22).
sioni. All'apice della terza tappa le pratiche precedenti scemeranno ulteriormente, per concentrarsi ormai sulla della e della preghiera del cuore 73 .
Questo non che solo i principianti dovranno digiu-nare, solo si trovano nella tappa intermedia leggere le solo i più avanzati dovranno pregare. Questi tipi di attività appartengono agli asceti in tutte le tap-pe e lungo corso della loro vita. Tuttavia se tappa dei principianti l'accento è posto sulle sofferenze corporee, l'attività interiore della mente si addice meglio a coloro che hanno la pienezza:
Ciò non che a ciascun culmine le caratteri-della tappa precedente siano completamente abbando
nate, ma piuttosto che qualcosa cambia nel loro orientamento e nel modo in cui sono adempiute ... La recita dei salmi e la sofferenza del digiuno appartengono alla tappa intermedia, ma ormai non sono più eseguite senza discernimento né con l'impeto che le contraddistingueva nella tappa dei principianti. Allo stesso modo, in cima alla tappa di coloro che hanno "'"-~;flJ.l.tul.v la pienezza ci sarà pur sempre la lettura e la fatica
genuflessioni e della salmodia, ma non ne sarà più necessaria una grande quantità, basterà consacrarvisi un attimo e subito si rimarrà catturati e dallo stupore, mentre la meditazione continua sull'economia divina (mdabbranu.ta) 74 e la preghiera nascosta avranno ormai maggiore importanza 75 •
termine siriaco mdabbranuta è ·,...,.,;,,,J,.nrP oil;onomfa, che significa il Si applica anche all'attività
sua morte per la salvezza degli nomini. di Dio, il suo piano di salvezza e redentrice del Figlio di Dio e
75 II,22,4·6.
IO)

rgr)m,,ntn delle pagine seguenti saranno gli svariati aspetti dell'attività interiore della mente, e avremo l'occasione di tornare più particolareggiatamente sui diversi tipi di preghiera, come pure su certi fenomeni mistici, quali lo "stupore" e la con-
possiamo trarre qualche rapida conclusione sul '-'"·'u'a".v verso Dio, così come Isacco ce lo presenta.
Questo cammino è un'ascesa a partire dall'attività esteriore del corpo fino dell'attività contemplativa interiore, che saranno quando si verrà giudicati degni dello "stupo-re" e dell'unione con Dio. Il primo requisito per giungervi è rinunciare al mondo ed essere lasciati soli con Dio. È parimenti necessario la quiete interiore della mente e del cuore, quella nasce dal silenzio esteriore della bocca e dalla solitudine. La rinuncia al mondo e la vita in solitudine non significano rifiuto dell'amore verso il prossimo: al contrario, grazie a questa rinuncia e a questo ritiro il monaco partecipa dell'amore di Dio, che finirà per destare nel suo cuore "l'amore luminoso" del prossimo.
In altre parole: dall'ascesi esteriore per andare verso la contemplazione di Dio, dal silenzio della bocca alla quiete dell'intelletto, dalla solitudine all'unione con Dio, dall' attività degli uomini all'" amore luminoso dell'umanità" tutta intera: ecco il cammino del solitario, quale Isacco l'ha descritto.
ro6
III PROVE SULLA VIA CHE CONDUCE A DIO
Dio non concede grandi doni senza grandi prove.
Ho fatto spesso esperienza di queste cose, e ciò che ho scoperto corrisponde a quanto ho appena scritto per amore fraterno, a guisa di pro memoria, giacché penso che molti possano trarre profitto da queste esperienze e progredire.
II,3J ,J
il Siro è celebre soprattutto per la descrizione degli stati superiori, propri degli asceti che hanno raggiunto una certa pienezza spirituale. Al tempo stesso, però, egli non ignora
negativi della vita cristiana e dell'ascesi, cioè le prove l'asceta deve attraversare.
capitolo analizzeremo l'insegnamento di Isacco sulinerenti alla vita cristiana e cercheremo di riassume
negative così come sono descritte nella sua ape-questo, ci occuperemo in primo luogo delle diverse
agguato sul cammino verso Dio dell'asceta, prima di parlare dell'abbandono da parte di Dio, forma suprema di ogni or>J·h•·e<>M
107

Le tentazioni
Il termine siriaco nesyana, corrispondente al greco peirasm6s, si può tradurre "tentazione", "prova", "esame", "saggio". Un altro termine affine, nesyuna, significa "esperienza"; entrambi derivano dalla radice ebraica nsh, che significa "mettere alla prova", "saggiare".
La Bibbia conosce vari tipi di tentazione, ai quali prendono parte tre personaggi: Dio, l'uomo e il demonio. Dio e il demonio hanno il ruolo di tentatori dell'uomo. Dio "tenta" Abramo al fine di mettere alla prova la sua fede (cf. Gen 22, r); mette alla prova il popolo eletto nel "crogiolo dell'afflizione" (Is 48,ro); prova "il cuore e le reni" (Sal 7 ,9) dell'uomo, "scruta tutti i segreti recessi del cuore" (Pr 20,27). Da parte sua, il demonio tenta Adamo ed Eva inducendoli a mangiare dell'albero della conoscenza (cf. Gen 3,r-6), e tenta Gesù nel deserto (cf. Mt 4,r-r r). Esiste un terzo tipo di tentazione, in cui è l'uomo a tentare Dio: Israele ha tentato Dio a causa della sua mancanza di fede (cf. Es I7, 7); i farisei e gli erodiani hanno tentato Gesù (cf. M t 2 2, r 5), mentre Anania e Saffira hanno tentato lo Spirito santo (cf. At 5,9). Esiste infine un quarto tipo di tentazione, quando l'uomo "è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce" (Gc r,r4).
I sacco tratta di solito le prime due tentazioni, da Dio e dal demonio. La prima è un'esperienza necessaria per giungere alla conoscenza di Dio; la seconda è un'esperienza spaventosa, che il cristiano cerca con tutte le sue forze di evitare. Un giorno, a chi gli chiedeva come le parole di Cristo "pregate, per non cadere in tentazione" (Mt 26,4r) si conciliassero con le frequenti esortazioni del medesimo a sopportare le tentazioni e i dolori (cf. Mt ro,28 e passim), !sacco così rispose:
ro8
Cristo ha detto: Prega per non cadere in tentazione contro la tua fede. Prega per non entrare nella tentazione di blasfemia
e di orgoglio a opera del demonio, a causa del fatto che la tua mente è contenta di sé. Prega perché Dio non permetta che tu cada nelle ovvie tentazioni dei sensi, che il demonio sa benissimo come proporti se Dio glielo consente per via dei tuoi sciocchi pensieri. Prega affinché la testimonianza della purezza non ti sia tolta e si trasformi nella fiamma seduttrice del peccato. Prega per non entrare in tentazione avendo causato sofferenza a qualcuno. Prega per non cadere nelle tentazioni dell'anima attraverso dubbi e provocazioni che la trascinano violentemente in una grande lotta. Nondimeno preparati con tutta l'anima a ricevere l'assalto delle tentazioni corporali; contrastale con tutte le tue membra e riempi gli occhi di lacrime, affinché l'angelo che ti protegge non ti abbandoni. Senza sostenere le prove, infatti, è impossibile contemplare la provvidenza di Dio o acquistare sicurezza davanti a lui. o imparare la sapienza dello Spirito, o vedere il desiderio di Dio stabilirsi dentro di te. Prima delle tentazioni, l'uomo prega Dio come un estraneo; ma dopo che, per suo amore, si è addentrato nelle tentazioni senza lasciarsi sviare, è come se Dio avesse contratto un debito con lui. Dio allora lo considera un amico sincero, poiché ha combattuto contro il nemico e ha trionfato per la forza della sua volontà. Ecco cosa vuol dire "pregate, per non cadere in tentazione". E ancora, prega di non entrare nella terribile tentazione del demonio a causa della tua arroganza, bensì a causa dell'amore di Dio, poiché ti auguri che la sua forza ti venga in aiuto e si serva di te per sgominare i suoi nemici. Prega di non entrare in simili prove a causa della stupidità dei tuoi pensieri e delle tue opere, ma piuttosto affinché il tuo amore per Dio venga messo alla prova e la sua forza sia glorificata attraverso la tua pazienza 1.
Fra le tentazioni provenienti da Dio, !sacco ne annovera alcune che le fonti monastiche attribuiscono generalmente al dia-
1 I.3 (pp. 25-26) = Tournille 44 (p. 254); PR 3 (pp. 36-37).
I09

volo, come "i pensieri di blasfemia e vanagloria"; Vl mserisce tuttavia una nota particolare per far capire che sta esprimendo solo un suo punto di vista:
Fratelli, credetemi: l' acedia, il torpore, la pesantezza delle membra, la confusione e il turbamento del pensiero e tutte le cose opprimenti che costituiscono il fardello dei monaci quando siedono nella quiete, sono opera di Dio. Non dovete pensare che opera sua siano solo le illuminazioni durante l'ufficio, la purezza del pensiero, l'allegrezza e l'esultanza del cuore, la consolazione delle dolci lacrime e la piacevole compagnia di Dio. In verità - e qui esprimo una mia opinione -anche i pensieri di blasfemia e vanagloria, come pure i detestabili impulsi della lussuria che vengono abitualmente ad assalire i solitari nella quiete, fino alla passione che si ritorce contro di loro, possono essere considerati, eccettuato l'orgoglio, come un sacrificio puro e come opera santa di Dio; e questo anche se il solitario si rivela ancora debole di fronte ad essi, purché ne affronti l'assalto e non scappi dalla propria cella 2 .
Le prove mandate da Dio hanno lo scopo di guarire le malattie dell'anima: sopportando le tentazioni l'uomo si avv1e1na a Dio e la sua fede si fortifica:
Chi fa l'esperienza dei ripetuti interventi dell'aiuto divino nel pieno delle tentazioni, raggiunge una fede solida. Un tale uomo non ha più paura e, grazie all'addestramento fatto, acquista maggiore audacia di fronte alle tentazioni. La tentazione è utile a tutti ... I lottatori dell'ascesi sono tentati affinché possano incrementare le loro ricchezze; gli indolenti affinché si guardino da ciò che potrebbe recare loro danno; i torpidi perché si armino di vigilanza; i lontani perché si riavvicinino
2 Centurie di conoscenza IV,23.
IIO
a Dio; quelli che gli appartengono perché abbiano l'audacia di riporre ogni loro gioia in lui ... Non c'è chi non si senta a disagio nell'ora della prova, chi non ne trovi amara, quando dovrà berla, l'aspra pozione. Ma senza le tentazioni non si può edificare una costituzione solida3 .
Dio manda le tentazioni affinché, tra i loro assalti, l'uomo diventi consapevole della vicinanza e della provvidenza divine.
··'"'"·••.'!········~---~-·············~- uno ha consolidato la propria speranza in Dio, questi
gli manda le tentazioni per avvicinarlo ancor di più a sé:
Dopo aver rafforzato il suo pensiero ... in modo che egli riponga tutta la sua fiducia in Dio, la grazia di Dio lo introduce a poco a poco alla tentazione, e consente che gli siano mandate tentazioni proporzionate, cosicché possa sopportarne la violenza. Ma nel pieno delle tentazioni l'aiuto di Dio si fa presente e palpabile, affinché l'uomo possa prendere coraggio e accrescere gradatamente la propria esperienza, acquistare sapienza e, grazie alla fiducia in Dio, disprezzare i nemici. In effetti, senza tentazioni l'uomo non cresce in sapienza nella lotta spirituale, né riconosce la presenza e la provvidenza del suo Dio, né si rafforza nella fede, se non attraverso l'esperienza in tal modo acquisita ... giacché l'amore meraviglioso di Dio gli si rivela in una situazione disperata, salvandolo dalla quale Dio gli mostra la propria potenza 4
•
È proprio nell'infuriare delle tentazioni, al colmo dello sconforto e della lotta, che si trova Dio, non nella rilassatezza e negli agi. Isacco paragona colui che affronta le tentazioni a un marinaio nella tempesta il quale, concluso il viaggio ed entrato in porto, rende grazie a Dio per le tribolazioni patite5
. Lo parago-
3 I,3 (pp. 25-26) = Touraille 48 (p. z68); PR 3 (pp. 36-37). 4 I,72 (p. 355) = Touraille r9 (pp. I32-133); PR 77 (p. 53r). 5 Cf. I,6 (p. 6r) = Touraille 56 (p. 305); PR 6 (p. 96).
III

na al tuffatore che cerca le perle in fondo al mare (mestiere i cui pericoli dovevano essere familiari a !sacco, cresciuto nel Qatar sulle rive del mar Rosso) 6 :
Se il tuffatore trovasse una perla in ogni ostrica, chiunque sarebbe subito ricco! E se appena tuffato ne riportasse una alla superficie, senza venire sbattuto qua e là dalle onde, senza incontrare squali, senza dover trattenere il respiro fin quasi a soffocare, senza privarsi dell'aria fresca di cui tutti godono, senza dover scendere negli abissi del mare, se così fosse, le perle sarebbero numerose e frequenti come il lampeggiare di un temporale lontano 7•
Una delle leggi della vita spirituale è che, quanto più ci si avvicina a Dio, tanto più le tentazioni aumentano di intensità. Isacco la formula così:
Mentre sei in cammino verso la città del regno e ti avvicini alla città di Dio, la violenza delle tentazioni che incontri ti serva da segnale: quanto più progredisci e ti avvicini, tanto più frequenti saranno i loro assalti. Pertanto, quando ti accorgi di incontrare tentazioni più varie e forti, sappi che proprio allora la tua anima è segretamente penetrata a un livello più alto e che una nuova grazia si è appena aggiunta alla condizione precedente. Dio infatti guida l'anima attraverso il tormento delle prove in misura direttamente proporzionale alla generosità delle grazie che le elargisce 8
.
!sacco ribadisce che Dio non manda a nessuno tentazioni superiori alla sua capacità di sopportazione, ma ne adatta sempre
6 Cf. S. Brode, n. 2 a II,34A, in esco 555, p. I48. 7 II,34A· Secondo i dotti del tempo di Isacco la perla nasce nell'ostrica quando vi
penetra un raggio di luce attraverso uno spiraglio tra le valve socchiuse. 3 1,42 (p. 208) = Touraille 46 (p. 26o); PR 39 (p. 298).
II2
forza e numero alla resistenza dell'uomo. Ma chi non è in grado di sostenere grandi tentazioni non sarà nemmeno all'altezza di ricevere doni importanti; e questa è un'altra legge della vita spirituale:
Se un uomo ha un'anima debole e priva della forza sufficiente a sopportare grandi tentazioni, preghi che gli siano risparmiate e che Dio lo esaudisca. Tuttavia puoi essere certo che la sua anima, nella misura in cui è troppo debole per le grandi prove, lo è anche per i doni importanti; e se alle grandi tentazioni non è concesso di entrare in essa, non lo sarà neanche ai doni importanti. Dio infatti non concede un dono importante senza una grande prova. Nella sua sapienza, che trascende la capacità di comprensione delle sue creature, Dio ha stabilito che i doni siano concessi in proporzione alle tentazioni ... Pertanto, in base alla durata delle prove, la tua anima può rendersi conto dell'onore che riceve dalla maestà di Dio, giacché la consolazione sarà commisurata alla sofferenza 9 •
Al tempo stesso, però, !sacco precisa che Dio non manda grandi tentazioni a nessuno senza averlo prima preparato a sostenerle per mezzo della grazia. Esiste quindi una specie di dinamica preposta a combinare le tentazioni e i doni della grazia:
Domanda: Viene forse prima la prova e poi il dono? Oppure c'è prima il dono e poi la grazia? Risposta: La prova non arriva finché l'anima non ha segretamente ricevuto, insieme allo Spirito di grazia, una parte maggiore di quanto ha avuto in precedenza. Lo testimoniano la tentazione del Signore e le prove degli apostoli, i quali non furono infatti ammessi alla tentazione prima di aver ricevuto il Paraclito. Bisogna dunque che coloro che ricevono in sorte il bene abbiano anche a sostenere le prove che toccano loro,
9 1,42 (p. 209) = Touraille 46 (p. 26r); PR 39 (p. 298).
II}

o-iacché la loro afflizione è mischiata con il bene ... Di conse:uenza se è vero che il dono precede la prova, è altrettanto ~erto che la percezione della tentazione precede quella del dono, e questo al fine di dimostrare la libertà d:ll'u~mo; p~rché la grazia non entra mai in lui prima che egh abbia saggiato la tentazione. Dunque nella realtà è la grazia che precede, ma nella percezione dei sensi essa si manifesta dopo 10
-
Qual è la differenza tra le prove che vengono da Dio e quel~ le dovute all'azione del demonio? Le prime sono mandate agh "amici di Dio, cioè agli umili". Gli amici di Dio vengono messi alla prova non già per punizione, ma in vista del loro progresso spirituale. In questo senso, tali prove fanno parte della pedagogia divina:
Le prove inflitte dalla verga di un padre per l_o sviluppo. e la crescita dell'anima da lui educata sono: apatia, oppressiOne del corpo, fiacchezza delle reni, prostrazione, confusione mentale sofferenze corporee, temporaneo sconforto, tenebre dei pen~ieri, abbandono da parte ~egli uomini, s~ar~it,à ~i mezzi materiali e così via. A causa di queste tentaziOni l anima si sente sconsolata e indifesa, il cuore mortificato e pieno di umiltà: così l'uomo si abitua a languire nel desiderio del suo Creatore. Tuttavia la provvidenza di Dio commisura le prove alle forze e ai bisogni di coloro che le patiscono. C?n~ solazione e sconforto, luce e oscurità, lotta e soccorso v1 si trovano mescolati insieme ... Questo è il segno che l'aiuto di Dio sta diventando più intenso 11 .
Le tentazioni provenienti dal demonio, invece, sono mandate ai "nemici di Dio cioè aa-li orgogliosi": esse "assalgono coloro che sono sfrontati;, e che,bnelloro orgoglio, abusano della bontà
1o 1,42 (p. 209) = Touraille 46 (p. 26r); PR 39 (p. 299). 11 l,4 2 (pp. 2o9·2ro) = Touraille 46 (p. 262); PR 39 (pp. 299-300).
1J4
di Dio. Queste tentazioni possono superare i limiti delle forze umane e condurre alla caduta spirituale. !sacco ne distingue due categorie: quelle dell'anima e quelle del corpo. Tra le prime annovera
il ritiro delle forze della sapienza, le trafitture della fornicazione ... un temperamento collerico, il voler seguire una propria strada, l'amore delle dispute, la tendenza a imprecare e offendere, un cuore sdegnoso, una ragione completamente sconvolta, la bestemmia contro il nome di Dio ... il desiderio di avere contatti con il mondo o di tornarvi, il parlare senza freno dicendo cose vane e insensate, l'essere continuamente in cerca di novità e persino di false profezie.
Tra le tentazioni del corpo egli enumera
gli inconvenienti penosi, prolungati, complicati e difficili da risolvere, gli incontri frequenti con uomini malvagi e senza Dio; gli assalti improvvisi di irragionevoli terrori; il cadere nelle mani di chi ci tormenta, l'inciampare spesso e malamente nelle rocce, il precipitare pericolosamente da luoghi elevati e simili disavventure che arrecano grave danno al corpo; infine, avere un cuore completamente privo del sostegno di Dio e ormai incapace di fare affidamento sulla fede ... un cuore -in una parola - che immagina cose impossibili e si spinge oltre le proprie forze e quelle di chi gli sta accanto 12 .
I cristiani che amano sinceramente Dio dimostrano il loro amore sopportando le tentazioni e ne vengono fortificati: sono messi alla prova come oro al fuoco, e attraverso tale prova diventano amici di Dio. Al contrario, coloro che non amano Dio "si dissolvono come schiuma ... perché, cedendo al nemico, abban-
12 l,42 (p. 2IO) = Touraille 46 (p. 263); PR 39 (pp. JOO·Jor).
115

donano il campo di battaglia, o a causa di un senso di colpa, o per negligenza o per orgoglio. Essi non sono stati degni di ricevere la forza che opera nei santi" 13 . Le tentazioni rivelano così chi è amico di Dio e chi gli è nemico, chi è fedele e chi no. Per questo motivo esse sono una sorta di krfsis, un giudizio che precede il giudizio finale in cui le pecore saranno separate" dai capri (cf. Mt 25,32-JJ).
Qualcuno potrebbe anche essere consegnato nelle mani del diavolo per esser messo alla prova o tentato, se è lui stesso a tentare Dio con il suo orgoglio o la sua dissolutezza. In tal caso è la collera di Dio che si infiamma contro di lui:
Tu non hai ancora sperimentato la severità del Signore, quando lascia la destra colma di bontà e passa alla sinistra reclamando il dovuto da quelli che approfittano di lui - quanto arde di collera e com'è pieno di sdegno in quei momenti! -. Una volta irritato a tal segno non torna più indietro, nemmeno se lo supplichi insistentemente; al contrario, la sua collera è ardente come fuoco di fornace (cf. MlJ,I9)14•
Questo è uno dei passi, estremamente rari negli scritti di Isacco, in cui si accenna alla collera di Dio, la quale tuttavia non significa affatto punizione o sanzione per i peccati e meno ancora "regolamento di conti". Come abbiamo già detto15, l'idea di una sanzione da parte di Dio è totalmente estranea a Isacco. Dio non va in collera perché si sente insultato o per desiderio di vendetta. Egli piuttosto manifesta un segno visibile della sua collera "lasciando la mano destra per la sinistra" - e questo vuol dire abbandonare un uomo per qualche tempo nelle mani del demonio- affinché quest'uomo possa sperimentare il sentimento dell'abbandono di Dio per poi convertirsi a lui con tutto il cuore.
1} r.39 (p. I95) = Tourai!Je 54 (p. 290); PR 36 (p. 279). '4 II,}I,IO.
15 Cf. supra, "Dio, l'universo e gli uomini", pp. 3 7-72.
rr6
È proprio per questo motivo che uno può essere "dato in balìa di Satana per la rovina della sua carne" (rCor 5,5). Il demonio non può assolutamente tentare nessuno senza il beneplacito di Dio. Esiste quindi un certo "accordo" tra Dio e il demonio circa i termini entro i quali quest'ultimo può agire. Il demonio "richiede" certe persone a Dio, proprio come ha dovuto "chiedere" di poter mettere alla prova Giobbe il giusto (cf. Gb r,6-rr;
2 ,r-j), ma liberare qualcuno dalla prova o non liberarlo dipende interamente da Dio. Ecco perché i due tipi di tentazione, quella proveniente da Dio e quella proveniente dal demonio, devono essere entrambe permesse da Dio, e possono così servire alla salvezza e al progresso spirituale dell'uomo.
Secondo Isacco, sono quattro i metodi che il demonio usa per combattere gli asceti. Il primo si manifesta all'inizio della conversione, quando il demonio infligge tentazioni opprimenti e violente, onde spingere il nuovo venuto in un abisso di scoraggiamento e distoglierlo dalla via appena intrapresa. Quando usa il secondo metodo il demonio lascia passare un certo tempo prima di accostarsi all'asceta, nell'attesa che il primo fervore si sia raffreddato. Con il terzo metodo il demonio, preso atto dei progressi fatti dall'asceta nella vita spirituale, cerca di instillare nella sua mente il pensiero di attribuire il successo a se stessi e non a Dio. Per applicare il quarto metodo il demonio fa leva su tutte le inclinazioni naturali dell'asceta, per esempio stimolando in lui pensieri di fornicazione, oppure ogni genere di illusioni. "Il demonio tentatore ottiene il permesso di combattere i santi con tutti questi mezzi, affinché il loro amore per Dio sia così messo alla prova" 16 .
Tutte le tentazioni, provengano da Dio o dal demonio, possono quindi giovare all'asceta, offrendogli l'occasione di dar prova del suo amore per Dio. Isacco invita tutti i cristiani apre-
16 I,39 (pp. r89-194) = Tourai!Je 51-54 (pp. 280-29r); PR 36 (pp. 369-378).
II7

pararsi a sostenere le tentazioni, senza le quali non si avanza nelle virtù;
Quando vuoi intraprendere un'opera buona, preparati innanzitutto ,all'assalto delle tentazioni e non dubitare della loro realtà. E infatti abitudine del nemico, quando vede qualcuno avviarsi con fede ardente verso un giusto modo di scagliargli contro tentazioni varie e terribili ... Non l'avversario abbia un tale potere- se così fosse, nessuno potrebbe agire bene-, ma perché Dio glielo concede, come abbiamo appreso a proposito di Giobbe il giustolì. Preparati dunque ad affrontare coraggiosamente le tentazionil8 •
Il tempo delle tentazioni e delle lotte, durasse anche tutta una vit~, non è una intermedia o meglio una tappa prepara-tona durante la quale le dell'asceta sono messe alla prova. Isacco ci tiene a sottolineare una volta superate le tentazio-ni, l'asceta penetra nel campo della e lì un "cambiamento sorprendente" si produce in lui:
Finché l'uomo si trova nella lotta e aggiunge battaglia a battaglia non può arrivare alla luce del pensiero né provare la pace delle ispirazioni. "Non ci sono buone notizie nei giorni del combattimento" (Qo 8,8), ha detto Qohelet, perché nelle cose di Dio tutto viene compiuto con grande fatica e tormento e senza la minima consolazione, si trattasse puranco di una sola pratica ascetica. Se si accosta alla preghiera, all'ufficio 0 a qualche osservanza, non può staccarsene se non facendo for-za su se tutta la sua opera è ancora inficiata dall' acedia. in parte consolato dalla lettura [della Scrittu-ra], ma anche qui tutto per lui è tenebra poiché nel suo operare per Dio attraversa ancora una plaga oscura. Il suo tempo è
17 Nella versione siro-orientale guesta allusione a Giobbe è assente.
'" I,5 (p. 42) = Touraille 5 (p. 77); PR 5 (pp. 6r-62).
II8
quello della messa alla prova dell'anima, nel quale il desiderio umano in tutto ciò che ha rapporto con Dio è saggiato dalla tristezza. Se sopporta di buon grado le tribolazioni che prostrano corpo e a causa della verità, una volta terminato, per grazia di Dio, il tempo della lotta, egli entrerà con la sua anima nelle piaghe della gioia e scoprirà in se stesso a ogni giorno che passa, come hanno detto i un cambiamento sorprendente 19
.
L'esperienza della derelizione {abbandono di Dio)
Isacco parla spesso di una condizione che la lingua siriaca designa con due locuzioni: meshtabqanuta (abbandono) o meshtabqanuta d-men alaha (abbandono da parte di Dio)2°. Altri due term1m s1 avv1cmano a nel significato: 'amfana (oscuramento) e qu!fa'a (prostrazione, scoraggiamento), ai quali corrisponde il termine greco akedfa (prostrazione, scoraggiamento, disperazione).
Isacco descrive la vita ascetica come un'avventura nella quale periodi che si possono chiamare di "assistenza'' da parte di Dio e altri di "debolezza" senza Dio si alternano senza sosta: presenza di Dio e derelizione, in una successione continua di alti e bassi nell'esperienza spirituale:
In tal modo, l'alternanza di assistenza e debolezza si riproduce in tutti i momenti e a tutte le tappe della vita ascetica, sia negli assalti contro la castità sia nei diversi stati di gioia
19 Centurie di conojcem.:a IV,57· 20 Più particolarmente: II,r,4 e II,r4,3; nella versione guesti due termini cor-
rispondono a enkatcileipsis (abbandono) e enkatdleipsis toti (abbandono da Dio). Cf. Evagrio Pontico, Sulla preghiera 3g; Lo gnostico 28; Scolii
II9

o abbattimento. A volte, infatti, a trasporti luminosi e gioiosi seguono bruscamente nuvole e tenebre, non diversamente da quanto avviene nella rivelazione di intuizioni mistiche e divine circa la verità. Chi serve Dio fa esperienza di simili variazioni: o sente l'aiuto della forza divina venire immediatamente in soccorso al suo intelletto, o sperimenta il contrario, e cosl prende coscienza della debolezza della natura umana e scopre quanto la propria natura sia fragile, debole, sciocca e puerile 21.
Da qui la necessità di periodi di derelizione e, per così dire, di deperimento spirituale, affinché l'uomo senta la sua impotenza e la sua dipendenza da Dio. La derelizione (meshtabqanuta) non significa che Dio si allontani da lui: essa consiste invece nel sentimento soggettivo dell'assenza di Dio, che non è dovuto al fatto di essere stati realmente da lui dimenticati; semplicemente, Dio vuol~ che l'uomo resti solo di fronte alle realtà che lo circondano. E così che per lungo tempo Antonio il Grande fu lasciato solo a combattere i demoni. Quando fu completamente sfinito Dio gli apparve in un raggio di luce. "Dov'eri?", gli chiese allora Antonio, "Perché non sei venuto a porre fine ai miei tormenti fin dall'inizio?". E la voce di Dio gli rispose: "Io c'ero, Antonio, ma ho aspettato, perché volevo vederti combattere" 22 • Dio vuole che attraverso l'esperienza della derelizione l'uomo riporti da solo la vittoria e si renda degno di lui.
La derelizione è un'esperienza attraverso la quale passa tutta l'umanità, credenti e non credenti, dalla caduta di Adamo in poi. Per un credente, tuttavia, si tratta dell'esperienza di un'assenza temporanea di Dio, alla quale seguirà un sentimento intenso della sua presenza; per l'ateo, invece, l'assenza è irreparabile e senza fine. Quest'ultimo considera l'assenza di Dio norma generale, mentre il credente ne sopporta il sentimento come
llll,9,II. 22 Atanasio di Alessandria, Vita di Antonio IO.
I20
una sofferenza acuta e particolarmente dolorosa. Non vi si può rassegnare: benché la sua ragione sappia benissimo che Dio non l'ha dimenticato, l'anima e il cuore hanno sete dell'esperienza consapevole della sua presenza. La vita in Dio si accompagna normalmente al sentimento della sua presenza; quando esso si smarrisce, il credente non può più ritrovare la pace finché non ritorna.
In questo senso la derelizione costituisce lo stadio più elevato della krisis o giudizio che separa i credenti dai non credenti. Per un cristiano l'esperienza della derelizione ha due soli sbocchi possibili: o l'accrescimento della sua fede e il riavvicinamento a Dio, oppure il "naufragio" della fede (cf. rTm r, 19) e la perdita di Dio. Per questo motivo Isacco mette in guardia contro la bestemmia di Dio durante i periodi di derelizione e tentazione, perché porterebbe alla perdita della fede. Secondo lui, quando un uomo è privato della grazia la fiducia in Dio e la giusta concezione della sua provvidenza vengono abbandonate 23
, ed egli può arrivare a "concludere che Dio per lui non esiste" 24
. Ma invece di prendersela con Dio farebbe meglio a placarsi con il ricordo della sua buona provvidenza:
Avvicinati un po' più a Dio durante le tue prove, amico mio, con questa disposizione d'animo: sai veramente contro chi stai imprecando? Se solo tu fossi abbastanza saggio da ricordarti della provvidenza che si cela in Dio, otterresti un sollievo immediato 2~.
Il sentimento di derelizione può avere diverse cagionP6, tra le quali il disprezzo delle tradizionali forme esteriori della preghie-
"'Cf. l,I (p. 4) = Touraille r (p. 6o); PR I (p. 3). "II,z6.6. 2
' Il,26,7. 26 Cf. Evagrio Pontico, Lo gnostico 28, che ne elenca cinque.
I2I

ra e la mancanza di rispetto. !sacco parla di "coloro che disprezzano i riti venerabili, come pure il timore di Dio e il rispetto che si deve mostrare durante la preghiera: a quale infelicità si espon-o-ono nell'ora in cm 10 1 a an onera. . . D' 1· bb d ' 1" 27
"' Qualche volta la ragione va cercata nella negligenza della pe~sona, nella sua impazienza e nell'orgoglio. In tal caso la derehzione prende la forma del disincanto e dello scoramento, due sentimenti che sono come un inferno sulla terra:
Quando piace a Dio di sottoporre qualcun~ ~ sofferenze ancor più grandi, egli lo lascia in balla del dlSlncanto. Questo sentimento fa nascere nell'uomo un forte scoramento che sembra soffocarali l'anima. È un primo assaggio della geen-
o . . . na. A partire da questo, svariati sent1ment1.s1 scatena~o con-tro di lui· si tratta di uno spirito di aberraziOne da cm scaturiscono cÙecimila specie di prove: la confusione, la ~oliera, l~ blasfemia, le proteste e le lamentazioni s~lla propna, s~rte, l pensieri perversi, il vagare da un luogo ali altro e ~0:1 ~la. s~ tu mi chiedessi dove sta la causa di tutto questo, ti drre1 che e in te, perché non ti sei dato la pena di trovarvi rimedio. Questo rimedio è ... l'umiltà del cuore 28 •
Il sentimento della derelizione può anche sopraggiung:re ~er ragioni indipendenti dalla persona di .c?i ne .è afflit:o. Tah r::enodi di derelizione, prostrazione, oscunta e d1sperazwne cap1t:no soprattutto aali asceti che vivono nella quiete. Nel loro caso e la provvidenza Ineffabile di Dio che ne è all'origine:
Non turbiamoci quando piombiamo nell'oscuri;à, spe~ialmente se non è per causa nostra. Considerala un operaziOne della provvidenza di Dio per motivi che lui solo conosce. In
27 II,I4,3· ( l
2s r, 42 (p. 2 r r) ~ Touraille 46 (pp. 263-264); PR 39 p. 302 ·
I22
certi momenti l'anima, come in balìa delle onde, è quasi sul punto di annegare. Un uomo in questo stato, che legga le Scritture, celebri la liturgia o qualsiasi altra cosa faccia, riceve tenebre su tenebre. Non riesce neppure ad avvicinarsi alla preghiera e la abbandona, totalmente incapace di credere in un cambiamento o di immaginare che ritroverà la pace. È un momento pieno di disperazione e paura; la speranza in Dio e la consolazione della fede sono totalmente bandite dalla sua anima al colmo del dubbio e dell'angoscia 29 •
Tuttavia, continua I sacco, Dio non lascerà a lungo l'anima in questa condizione. Dopo un periodo di disperazione ci sarà un cambiamento in meglio:
Chi è flagellato dai marosi di questo momento terribile conosce per esperienza il cambiamento che avrà luogo alla fine della tempesta. Dio non abbandona l'anima in tale stato nemmeno un giorno, altrimenti essa, divenuta straniera a ogni speranza cristiana, finirebbe con il perdersi; ma subito Dio le offre una via d'uscìta 30 •
Che deve fare l'asceta per sfuggire a questi periodi di derelizione, o almeno !imitarne i danni? Lo strumento principale è l'umiltà: "Finché l'uomo conserva l'umiltà, non ci sarà derelizione da parte di Dio in nessuna delle tentazioni che mettono alla prova il corpo o la coscienza, e in nessuna delle contrarietà corporali e psichiche" 31
. Ecco perché !sacco avverte il suo lettore: "Finché non avrai trovato l'umiltà sarai tentato dall'acedia più che da qualsiasi altra cosa" 32 . Altro mezzo importante è
29 I,5o (p. 24r) ~ Touraille 57 (p. 308); PR 48 (p. 339).
JO Ibid. 31 Centurie di conoscenza II,23. Jz Centurie di conoscenza IV,97.
I23

chiedere incessantemente a Dio di non precipitare nelle tenebre spirituali:
Notte e giorno non smetta mai di salire dal tuo cuore questa preghiera: "Signore, liberami dalle tenebre dell'anima!". Perché è questo il fine di ogni preghiera della conoscenza. Un'anima avvolta nelle tenebre è un secondo inferno, ma la mente illuminata è compagno dei serafini33•
Come deve comportarsi l'asceta durante questi periodi di derelizione e oscurità? Il consiglio più ovvio è di pregare e aspettare che passino: "Durante i periodi di tentazione, quando cadiamo nell'oscurità, bisogna prostrarsi faccia a terra e pregare, e non rialzarsi prima che una forza e una luce vengano dal cielo per sorreggere il nostro cuore con una fede che non dubiterà più" 34 . "Quando viene il tempo della lotta e dell'oscurità, prolunghiamo le preghiere e le genuflessioni anche se ci sentiamo distratti" 35.
Un'altra raccomandazione è di dedicarsi alla lettura degli scritti dei padri:
Quando avviene ... che la tua anima nel suo intimo sia immersa in fitte tenebre, come quando i raggi del sole si celano alla terra tra le nuvole, e sia per breve tempo priva di conforto spirituale e di luce della grazia a causa delle nubi delle passioni che la ricoprono, e quando la forza gioiosa è per un certo tempo indebolita e la tua mente avvolta da una nebbia insolita, allora non devi confonderti né abbandonarti allo sconforto. Sii paziente, immergiti nella lettura degli scritti dei dotto-
33 Centurie di co11oscenza I,34. 34 II,9,5· 35 Centurie di conoscenza I,}O.
ri della chiesa, sforzati di pregare e aspetta aiuto. L'aiuto non tarderà a venire, senza che tu te ne accorga 36 •
La "lettura della Scrittura" (qeryana, parola siriaca che si riferisce sia alla Bibbia che ai padri della chiesa)37 libera l'anima dallo sconforto e dalle tenebre:
Personalmente ne ho fatto spesso l'esperienza, e ciò che ho scoperto corrisponde a quanto ho appena scritto per amore fraterno, a guisa di pro memoria, giacché penso che molti possano trarre profitto da queste esperienze e progredire, accorgendosi che nella metà dei casi in cui, nella quiete, si soffre di un sentimento di pesantezza, esso svanisce con la lettura delle Scritture. A volte ciò dipende dal discernimento che se ne ricava e che proviene dalla luce della sapienza soggiacente a quelle parole 38 .
In certi casi, se preghiera o lettura da sole non bastano, può essere utile combinarle insieme: "Facciamo un misto di entrambe: cerchiamo rimedio dalla Scrittura e accostiamoci alla preghiera"39.
Un altro consiglio è di ricordarsi del fervore degli esordi e dei primi anni della vita ascetica:
Nell'ora della sconfitta, quando, oppresso dal nemico, ti senti debole, fiacco, invischiato in una dolorosa inerzia, richiama al tuo cuore i tempi passati pieni di fervore, ripensa come allora curavi anche i minimi particolari, con che vigore ti gettavi nella lotta e come ardevi di zelo contro chi poneva ostacoli al tuo progresso ... Così, grazie a queste e altre simili
36 I,30 (p. Sr) = Touraille r4 (p. rr4); PR I} (p. r24). 37 Cf. D. Miller, "Translator's Introduction", pp. CXI·CXII.
"II,J3,3· 39 Centurie di conoscenza I,}O.
125

rimembranze, la tua anima è come risvegliata da un abisso e rivestita della fiamma della passione ... Essa si risolleva dal suo sfinimento come da una morte, si volge in alto e ritorna allo stato di un tempo 40 .
Può darsi tuttavia che il sentimento di derelizione e scoraggiamento diventi così intenso da non lasciare a chi ne è vittima nemmeno più la forza di leggere la Scrittura o di pregare. In tal caso, ecco le raccomandazioni di Isacco:
Se non hai la forza di dominarti e di prostrarti faccia a terra per pregare, allora avvolgi la testa nel tuo mantello e dormi finché quest'ora di tenebre non è passata, ma non lasciare la tua dimora. Una tale prova capita specialmente a quelli che vogliono passare la vita nella disciplina della mente e cercano la consolazione della fede durante tutto il loro viaggio. È per questo che la loro sofferenza e il loro travaglio più grande consistono in simili momenti di oscurità, nei quali la mente vacilla e comincia a dubitare. La blasfemia è allora in agguato. Qualche volta si è assaliti da dubbi circa la resurrezione, o altro di cui non è necessario parlare. Noi ne abbiamo fatto spesso l'esperienza e abbiamo scritto di questa lotta, per la consolazione di molti ... Felice chi riesce a sopportare tutto ciò nel chiuso della sua cella! Come hanno detto i padri, lo aspetterà, dopo, una dimora grande e magnifica 41 .
Nel contempo, però, Isacco osserva che è tanto impossibile liberarsi del tutto di questi periodi di oscurità e derelizione, quanto lo è raggiungere quaggiù sulla terra la pace perfetta. L'alternarsi di momenti di oscurità e di luce contrassegnerà la vita del solitario fino all'ultimo respiro:
40 I,z (pp. IO-I I)= Touraille 30 (pp. I88-I89); PR 2 (pp. I I-Il). 41 I,so (pp. 24I-242) = Touraille 57 (p. 309); PR 48 (pp. 339-340).
rz6
Un giorno la prova, un altro giorno la consolazione. Egli continua così fino alla sua dipartita dal mondo. Non dobbiamo aspettarci di essere completamente liberati dalla lotta in questa vita, né di ricevere una consolazione perfetta 42 .
Isacco paragona questi periodi di tenebra e derelizione all'inverno, quando la vita della natura sembra fermarsi, mentre nelle profondità della terra il seme aspetta la primavera per schiudere i suoi germogli. Non bisogna dunque cedere allo sconforto, ma attendere pazientemente che le afflizioni, lo scoramento e il senso di derelizione sopportati diano i loro frutti:
Beato colui che, sperando nella grazia di Dio, ha sopportato il rifiuto e l'abbandono. Questo è un segreto cimento della virtù e della crescita dello spirito, simile alla desolazione dell'inverno che dà origine alla crescita del seme nascosto, destinato a disgregarsi nel terreno a causa delle aspre e molteplici burrasche del clima. In una medesima attesa dei frutti che verranno, attesa che può prolungarsi nel tempo, quest'uomo scaccerà da se stesso il sentimento dell'abbandono ... Che sappia attendere, mantenendosi a una certa distanza, senza credere che i frutti siano a portata di mano. Infatti, se non riceverà presto una consolazione in cambio delle sue sofferenze, egli rischierà di disperare, come un salariato che si sente truffato riguardo alla paga pattuita43 .
Al freddo dell'inverno, cessato inaspettatamente e improvvisamente come era cominciato, fa seguito la primavera dell'anima che si schiude:
Dio permette che freddo e pesantezza mettano l'uomo alla prova, ma se egli arde di zelo e si sforza di scacciare quei sen-
42 !,50 (p. 242) = Touraille 57 (pp. 309-3 ro); PR 48 (p. 34I). 43 II,34,3·
127

timenti la orazia non tarderà a soccorrerlo nuovamente e un' altr; forz: scenderà su di lui, una forza che racchiude in sé tutti i beni e ogni genere di conforti. Egli si meraviglierà e proverà grande stupore confrontando il ricordo della pesantezza di prima con l'attuale trionfo della leggerezza e della forza. Vedrà quant'è diverso il suo stato presente, vedrà che cambiamento importante si è prodotto inaspettatamente in lui. Da quel momento in poi sarà diventato sapiente e, dovesse di nuovo prodursi una simile pesantezza, saprà riconoscerla in base all'esperienza fatta 44
•
Isacco descrive poi in stile colorito l'illuminazione spirituale e l'esultanza che seguono a un tal periodo di tenebre:
Ci sono momenti in cui ci si adagia nella quiete ... senza sapere da dove entrare o uscire. Ma dopo aver frequentato a lungo le Scritture, dopo aver continuamente supplicato e ringraziato per il proprio stato di debolezza e aver appuntato incessantemente lo sguardo sulla grazia di Dio, succede che, a partire dal grande sconforto vissuto nella quiete, il cuore a poco a poco si allarghi, qualcosa cominci a nascere e faccia germogliare dentro una grande gioia, benché tale gioia non provenga dalla persona in questione attraverso un principio di attività del pensiero. Essa è consapevole della gioia del suo cuore, ma non sa perché. Infatti una certa esultanza occupa ora la sua anima, la cui letizia le permette di disprezzare tutto ciò che esiste ed è visibile. Attraverso la forza di questa letizia la mente scorge l'origine del rapimento del suo pensiero, ma non comprende perché ciò avvenga. L'uomo vede la propria mente innalzarsi al di sopra di ogni contatto con le cose, librarsi in quell'esaltazione al di là del mondo ... ma non discerne alcuna estensione dell'intelletto quando il suo cuore
~4 I,zo (p. ro3) = Touraille 29 (pp. r86·r87); PR I7 (p. qS).
128
danza in quel modo, o quando la mente è così trascinata e attirata fuori di sé 45 •
In questo modo, a partire dalle tentazioni cui è sottoposto, un asceta acquista esperienza e si inerpica, un gradino dopo l'altro, sulla scala che porta a Dio. Secondo Isacco le prove e le tentazioni lungo la strada verso Dio sono indispensabili a tutti. La prova più dolorosa è quella della derelizione, che "ha un sapore di geenna", quando si è gettati nelle tenebre e nello scoramento, e si perde così ogni speranza e ogni consolazione proveniente dalla fede. Non è però il caso di disperare; ciò che conta è ricordarsi della provvidenza di Dio che insieme con la tentazione, offrirà una via per uscirne (cf. rCor ro,r3), e anche conservarsi umili e pregare con tutto l'ardore possibile. Alla fine, il tempo della vicinanza di Dio seguirà a quello della tentazione, e il sentimento dell'abbandono di Dio lascerà il posto a quello della sua presenza.
129

IV L'UMILTÀ
L'umiltà è la veste della divinità. I.n
Beato colui che si umilia in tutto, perché in tutto sarà esaltato. Giacché colui che si umilia a causa di Dio e ha una piccola idea di se stesso, è glorificato da Dio. Colui che ha fame e sete di Dio, Dio lo inebrierà con un vino la cui ebbrezza non abbandona mai quanti l'hanno bevuto. Colui che va nudo a causa di Dio, Dio lo vestirà di una veste di incorruttibilità e di gloria. E colui che si fa povero a causa sua, sarà consolato dalle sue vere ricchezze.
1,5
Uno dei temi prediletti di Isacco, sul quale ritorna continuamente, è quello dell'umiltà. A esso sono dedicati molti discorsi, sia della prima sia della seconda parte della sua opera. Questo capitolo studierà l'insegnamento di Isacco in primo luogo sull'umiltà come mezzo per assomigliare a Dio, quindi sui riori ed esteriori di una vera umiltà.
IJ I

L'umiltà, mezzo per assomigliare a Dio
Per Isacco il Siro parlare di umiltà (mukkaka o makkikuta) 1 è parlare di Dio, perché ai suoi occhi Dio è prima di tutto "mite e umile di cuore" (Mt r r,29). Tale umiltà si è manifestata al mondo all'atto dell'incarnazione del Verbo. Nell'Antico Testamento Dio era rimasto invisibile e inaccessibile a chiunque. Ma dopo essersi rivestito di umiltà celando la sua gloria sotto una carne umana, Dio diventò visibile e avvicinabile:
Giacché l'umiltà è la veste della divinità. Se ne rivestì il Verbo che si fece uomo e con essa ci rivolse la parola nel nostro corpo. Tutti coloro che sono stati rivestiti di umiltà sono stati resi veramente somiglianti a colui che discese dalla sua altezza, nascose lo splendore della sua maestà e dissimulò la sua gloria dietro l'umiltà (cf. Eb ro,zo), per timore che la creazione nel contemplarlo ne fosse totalmente annientata2.
Ogni cristiano è invitato a imitare Cristo nella sua umiltà. Praticandola, diventa simile al Signore che se ne era rivestito:
È per questo che tutti gli uomini, che sono coperti dalla veste nella quale è apparso il Creatore attraverso il corpo che aveva assunto, indossano il Cristo. Giacché la somiglianza con cui è stato visto dalla sua creatura e nella quale ha voluto accompagnarla, egli ha anche voluto prenderla su di sé nel suo uomo interiore e con essa farsi vedere da amici e servitorP.
1 Isacco usa i due termini nella stessa accezione. In siriaco mukkaka significa il percorso attraverso il quale si acquisisce l'umiltà (l'uomo si abbassa), mentre makkikuta indica piuttosto il risultato (l'uomo che ha acquisito l'umiltà).
2 I,77 (pp. 38r-382) = Touraille zo (p. r37); PR 82 (p. 575). 3 I,77 (p. 382) = Touraille 20 (p. r38); PR 82 (pp. 575-576).
I}2
L'umiltà unita a fatiche correttamente praticate "fa dell'uomo un Dio in terra" 4
•
Inizialmente non è attraverso ogni sorta di fatiche ascetiche che l'uomo riesce a farsi adottare da Dio e a diventare simile a lui; per Isacco, la prima condizione è essere umili. L'ascesi senza l'umiltà non porta da nessuna parte, mentre l'umiltà senza ascesi è sufficiente per essere adottati da Dio:
L'umiltà, anche senza ascesi, fa perdonare molte offese, mentre le opere, senza umiltà, non danno alcun profitto; anzi, procurano grandi mali. Per questo, come ho appena detto, con l'umiltà devi guadagnarti il perdono delle tue azioni malvagie. Ciò che il sale è per il cibo, l'umiltà lo è per la virtù, potente com'è nel cancellare molti peccati ... Se la possediamo, essa farà di noi dei figli di Dio e, anche in assenza di opere buone, ci indirizzerà a lui. Senza l'umiltà, infatti, tutte le nostre opere sono inutili, così come ogni virtù e ogni pur onesta fatica 5.
Ne consegue che nessuno deve aspettarsi frutti dal suo travaglio spirituale prima di aver conquistato l'umiltà, quali che siano gli sforzi ascetici messi in atto per perseguire il suo scopo:
Non devi meravigliarti se, praticando una virtù eccellente, non riesci a gustarne i conforti: finché non si è diventati umili, infatti, non si riceve alcuna ricompensa per le proprie fatiche. La ricompensa non premia lo sforzo bensì l'umiltà, e chi fa torto a quest'ultima, non vi ha diritto 6.
Chi è rivestito di umiltà assomiglia a tal punto a Dio da suscitare attorno a sé l'amore che tutti portano a Dio, perché ormai è
4 I,6 (p. 6o) = Touraille 56 (p. 305); PR 6 (p. 95).
5 I,69 (p. 338) = Touraille 49 (p. 273); PR 72 (p. 499).
6 I,57 (pp. 382-383) = Touraille 37 (p. 224); PR 8z (pp. 576-577).
I}}

considerato un dio in terra. Così l'umiltà aiuta a ripristinare fra le persone relazioni fondate sull'amore:
Nessuno mai odia chi è umile, né lo ferisce con parole, né lo disprezza, perché il suo Signore lo ama ed egli è amato da tutti. Ama tutti e tutti lo amano. È caro a tutti, dovunque si presenti è visto come un angelo di luce ed è circondato di onori. Ridotti al silenzio, il saggio e il maestro avvezzi a discorrere cedono la parola all'umile. Tutti gli occhi sono rivolti alla sua bocca e a ogni parola che ne esce. E il mondo attende le sue parole quasi fossero le parole di Dio ... Tutti lo annunciano come un Dio, anche se non è esperto di parole, anche se il suo aspetto suscita ribrezzo ed è insignificante 7 •
Quando l'uomo è reso simile a Dio grazie all'umiltà, è ticondotto alla condizione priva di peccato della sua origine e ritrova l'armonia che allora regnava tra l'uomo e l'universo e che è stata spezzata per effetto della caduta. Non solo le persone, ma anche gli animali e gli elementi obbediscono all'umile, come obbedivano ad Adamo nel paradiso. Persino i demoni gli sono sottomessi:
Chi è umile può avvicinarsi alle fiere affamate e queste al solo vederlo, deposta ogni ferocia, gli si avvicinano come al padrone !ambendogli mani e piedi, giacché fiutano in lui l'odore che Adamo emanava intorno a sé prima della caduta, quando a ciascuna di esse, riunite in paradiso davanti a lui, egli diede un nome 8 ... Anche i demoni, nonostante la loro feroce ostilità e la loro arroganza, diventano polvere al suo cospetto. Di-
7 I,77 (pp. 382·383) = Touraille 20 (pp. 138-r39); PR 82 (pp. 576-577). 8 Cf. Gen 2,r9. La letteratura agiografica è ricca di racconti di animali selvatici
sottomessi all'uomo umile. Si veda ad esempio la Vita di san Gerasimo del Giordano, che si narra tenesse un leone al suo servizio. Più tardi, san Francesco ammansirà un lupo e san Serafim di Sarov si farà servire da un orso.
I34
menticano tutta la loro malvagità, le loro trappole sono sventate, i trucchi e le astuzie perniciose perdono ogni potere9.
S:cond? Isac_co l'umiltà consiste in una misteriosa potenza che 1 santi acqmstano quando raggiungono lo stato di pienezza. T~e P?tenz~ fu conferi~a agli apostoli il giorno della pentecoste, polche Gesu aveva ordmato loro di non lasciare Gerusalemme
~,~--~------ prima di aver ricevuto una forza dall'alto (cf. At r,4-8).
Gli_umili_so~o giudicati degni di ricevere in sé lo Spirito delle nvelaz10m che palesa i misteri. Per questo motivo alcuni santi hanno sostenuto che l'umiltà rende l'anima perfetta att;ave_rs~ le ~isi~ni divi?~ ... Beato colui che ha conquistato l umilta, p01che a ogm Istante bacia e abbraccia il petto di Gesù 10 !
Se l'umiltà è dono sovrannaturale concesso da Dio ne consegue che quanti sono per natura gentili, calmi, pacati ~ dolci non possono essere tutti considerati veramente umili 11. La differenza tra umiltà naturale e sovrannaturale è trattata nel capitolo 1 8 ~ella seconda parte dell'opera di Isacco. Egli insegna che l'umilta natur~le non ~uò mai sostituirsi a quella che, nel cristiano, è frutto d1 un pentimento profondo o del pensiero della crrandezza di Dio e dell'umiltà di Cristo: b
L'~miltà del cuore può sussistere nell'uomo per due ragioni: o ln conseguenza di un'esatta nozione dei suoi peccati 0 co~e frutto del ricor~o dell'abbassamento di nostro Sig~ore o, plUttosto, del pensiero della grandezza di Dio e del punto fino al quale la grandezza del Signore di tutto l'universo si è abbassata per rivolgersi agli uomini e impartire loro i suoi in-
:0I,77 (p. 383) = Touraille 20 (p. r39); PR 82 (pp. 577_578).
11 I,77 (pp. 384-385) = Touraille 20 (p. r4r); PR 82 (p. 580). Cf. I, 77 (p. 383) = Toumille 20 (p. r4o); PR 82 (pp. 579_580).
I35

segnamenti - abbassamento che si è spinto fino ad assumere un corpo come il nostro - e di tutto ciò che il corpo del Signore ha dovuto sopportare. Com'è parso disprezzabile al mondo, mentre in cielo rivestiva una gloria ineffabile presso Dio Padre e gli angeli tremavano alla sua vista quando, fiammeggiante, risplendeva alto sopra le loro schiere! A noi invece si è mostrato sotto un aspetto e in uno stato di abbassamento tali che gli uomini hanno potuto catturarlo, mentre rivolgeva loro la sua parola, e rnetterlo in croce a causa della sua così modesta apparenza 12 .
L'umiltà cosiddetta naturale, invece, non ha niente a che vedere con quella appena descritta da !sacco:
Non portatemi a esempio quelli che sono spontaneamente umili, sostenendo che molte persone lo sono per natura o perché provano sentimenti soffocati e deboli, e ogni ardore, ogni fuoco in loro è spento. Tali persone non possiedono quell'abbassamento accompagnato da discernimento che implica pensieri umili, riflessioni laboriose e penetranti, il fatto di considerare se stessi insignificanti, la frantumazione del cuore e i fiumi di lacrime che sgorgano dalla sofferenza della mente e dal discernimento della volontà. Se tu interrogassi quelle persone ti accorgeresti che in loro non c'è niente di tutto ciò: nessuna meditazione capace di suscitare dolore vero, nessun interesse che si affacci alla loro coscienza. Esse non meditano sull'abbassamento di nostro Signore e non ne custodiscono il ricordo, non le punge il dolore che nasce dalla consapevolezza dei propri peccati, nessuna passione ardente infiamma il loro cuore al presagio dei beni futuri, non concepiscono nessuno dei profittevoli pensieri che, in seguito alla debolezza della mente, vengono normalmente suscitati nel cuore 13 .
12 II, r8,6. u II,r8,8-9.
Se tutte le persone gentili e miti per natura venissero incluse nel numero degli umili, bisognerebbe allora annoverare gli eunuchi tra le vergini e le persone "santificate" 1\ benché la natura soltanto, non la volontà, impedisca loro di maritarsi:
Chi è bonario e umile per natura rientra esattamente nello stesso caso: la natura, non la forza della volontà, ha temperato le sue pulsioni. Tali persone non hanno assolutamente sentito il gusto né hanno la minima idea della dolcezza dei carismi e delle consolazioni provate da coloro che sono umili a causa del Signore 15 .
L'umiltà interiore
L'umiltà è prima di tutto una qualità interiore che consiste nella fiducia in Dio, nella diffidenza verso se stessi e nel sentimento di essere indegni e indifesi, unito a quello della presenza dello Spirito santo celato nelle profondità del proprio cuore. Nel contempo l'umiltà si manifesta esteriormente sotto forma di apparenza dimessa, abbigliamento povero, ritegno nel parlare, rifiuto dei privilegi, abitudine a non reagire, a onorare gli altri, a sopportare insulti e tormenti. Gli aspetti interiori ed esteriori dell'umiltà sono intimamente legati e non possono essere separati: l'umiltà esteriore sarebbe falsa se l'uomo non si umiliasse davanti a Dio nel proprio cuore, l'umiltà interiore non sarebbe vera se non si manifestasse in alcun modo all'esterno.
14 Nella letteratura siriaca primitiva (Afraat) il termine qaddisbe (santificati, messi a parte) designava le persone sposate che di loro spontanea volontà si astenevano da rapporti sessuali; solo in un secondo momento sarà usato per designare i "santi" in genere.
15 II,r8,ro-r r.
I3J

In conclusione, ci sono segni interiori e segni esteriori dell'umiltà, e non è facile tracciare una linea di demarcazione tra gli uni e gli altri, come testimonia questo passo:
L'umiltà si accompagna alla modestia e al raccoglimento, vale a dire alla castità dei sensi, a una voce moderata, parole rade, scarsa stima di sé, abbigliamento povero, atteggiamento modesto, sguardo rivolto a terra, misericordia sovrabbondante, facilità alle lacrime, animo solitario, cuore contrito, incapacità a farsi turbare dalla collera e distrarre dai sensi, scarsità di possessi, moderazione nei bisogni, sopportazione, pazienza, assenza di paura, cuore coraggioso a causa del disprezzo della vita presente, sopportazione paziente dei cimenti, riflessioni meditate e non fatue, assenza di cattivi pensieri, custodia dei misteri, castità, modestia, rispetto e soprattutto quiete assidua e proclamazione continua della propria ignoranza16 •
Un tale elenco contiene insieme le qualità interiori ed esteriori dell'umiltà, senza distinzione.
Se vogliamo distinguerle meglio a partire dai segni interiori, il primo sembra essere quello di un sentimento profondo della presenza di Dio, dal quale ha origine l'umiltà. Nessuno può conquistare l'umiltà da solo, come risultato dei suoi sforzi e delle sue attività esteriori, ma si umilia veramente quando incontra Dio e ne percepisce la grandezza nel proprio nulla: dopo tale incontro si avvicina a Dio in un silenzio profondo del cuore, e non si reputa degno nemmeno di pronunciare le parole della preghiera al cospetto di colui che è al di là di ogni parola. Questa preghiera silenziosa e umile conduce alle profondità mistiche della contemplazione di Dio:
Sarei assai sorpreso di vedere un uomo veramente umile azzardarsi a supplicare Dio quando si accosta alla preghiera, o
16 I,7r (p. 349) = Touraille Sr (p. 402); PR 74 (pp. sr6-5q).
chiedergli di essere giudicato degno di pregare o di implorarlo a qualsiasi altro fine, o semplicemente di sapere come pregare. Giacché l'umile custodisce, al di sopra di tutte le proprie riflessioni, un regno di silenzio, e non fa altro che aspettare la misericordia, o qualsiasi altra decisione su di lui da parte dell' adorabile maestà ... Quando china il capo a terra e nel suo cuore la contemplazione si innalza fino alla porta che conduce al Santo dei Santi di colui la cui dimora è tenebra (cf. rRe 8,12)- colui che fa abbassare lo sguardo ai serafini e ne intimidisce le legioni e i cori con il suo fulgore imponendo il silenzio a tutte le loro schiere mentre queste attendono che i misteri lascino l'Invisibile dal suo regno etereo attraverso movimenti muti, sentimenti incorporei e una percezione priva di immagini dell'Essenza senza forma che va al di là di quanto possa essere loro rivelato, poiché la virtù dei loro pensieri è troppo debole per sostenere l'onda dei suoi misteri -, allora soltanto l'umile osa parlare e pregare così: "Signore, fa' di me ciò che tu vuoi!" 17 .
Un altro segno interiore di umiltà consiste nell'essere morti al mondo: "Colui che ha conquistato l'umiltà nel proprio cuore è morto a questo mondo" 18 . Una certa ripugnanza nei confronti del mondo è un segno di umiltà che nasce dalla sapienza spirituale:
Domanda: In che modo ci si accorge di aver ricevuto la sapienza dello Spirito? Risposta: A partire dalla conoscenza, che insegna le vie dell'umiltà nelle profondità nascoste e nei sensi e rivela all'intelletto come si deve ricevere l'umiltà. Domanda: Come si può sapere che si è raggiunta l'umiltà? Risposta: Quando piacere al mondo, frequentarlo o rivolgergli
17 !,71 (p. 350) = Touraille Sr (p. 402); PR 74 (pp. 5I7-5r8). "!,51 (p. 244) = Touraille 58 (p. 3I 3); PR 50 (p. 346).
139

la parola è diventato odioso, e la gloria del mondo appare ai nostri occhi un abominio19
•
Un altro segno interiore di umiltà è il risveglio aella voce della coscienza che impara a non accusare mai Dio o il prossimo, a non incolpare le circostanze della vita, a non giustificare se stessi. Colui che ascolta la voce della coscienza raggiungerà la quiete spirituale e si riconcilierà con Dio:
I rimproveri continui della coscienza sono un segno di umiltà. La loro assenza in tutte le cose che si fanno dimostra durezza di cuore, indica l'abitudine a giustificare se stessi e incolpare altri o, peggio ancora, la sapiente provvidenza di Dio. Al contrario, ci si mantiene nell'umiltà quando non ci si reputa irreprensibili e non si attribuisce ogni colpa alle circostanze e alle occasioni che Dio ha previsto per noi. Quando infatti, sulla base dì un'esatta presa di coscienza, ci si considera sottomessi agli eventi, allora si realizza una condizione di profonda umiltà, riconoscibile dal fatto che, qualunque cosa accada, si resta in pace e tranquillità e ci si mostra imperturbati. È lo stato di calma che appartiene all'umiltà, frutto di maturità. Chi vi accede potrà constatare che in tutte le tentazioni il senso di riposo è più forte del tormento 20
•
La quiete interiore è uno dei segni caratteristici dell'umiltà: ''Senza la quiete il cuore non si umilia" 21, afferma I sacco. Essa si manifesta nell'assenza di ogni paura di fronte agli eventi, e nella fiducia nella provvidenza divina che protegge da ogni male:
L'umile non è mai precipitoso, non ha fretta, non si inquieta, non si accalora né si lascia andare a pensieri incontrollati,
19 I,62 (p. 298) Tow:aille 38 (pp. 228-229); PR 62 (pp. 431-432). 20 Ila7,r-z. 21 Centurie di conoscenza II,94.
I40
mantiene sempre la calma. Dovesse precipitare il cielo sulla terra, l'umile non ne sarebbe scosso. Non tutte le persone calme sono umili, ma tutte le persone umili sono calme ... giacché l'umile è sempre rilassato e nulla può turbare o aoitare il suo animo. Come nessuno può far paura a una monta;na così nessuno può intimorire la mente dell'umile22. '
Chi è umile non teme le cose che accadono accidentalmente perché teme so~o Dio: il timore di Dio scaccia ogni altra paur~ dal suo cuore. E nn timore che implica nn atteooiamento di religioso terrore davanti a Dio e lo sforzo di no;~ffenderlo con azioni o pensieri peccaminosi. Per Isacco l'umiltà trae oriuine pr_opri.o ~a questo timore di Dio. L'umiltà implica un cuore ~ontnto, il timore e la gioia spirituale:
C'è un'umiltà che deriva dal timore di Dio, e una che deriva dall'amore ardente di Dio. C'è chi si umilia a causa del timore e chi si umilia a causa della gioia. Quello la cui umiltà deriva dal timore possiede in tutte le sue membra la modestia sensi temperati e un cuore contrito. Ma quello la cui umiltà ha origine dalla gioia possiede una grande esuberanza e un cuore grande e incontenibile 23 •
Isacco paragona l'umiltà all'infanzia: coloro che sono umili a causa di Dio assomigliano ai bambini nella loro semplicità e innocenza. Il tema del recupero dell'infanzia appariva già nella predicazione di Gesù: "Se non vi convertirete e non diventerete com: i bam~ini, non entrerete nel regno dei cieli" (Mt r8,3). I padr1 esegeti della scuola di Antiochia vi hanno letto un invito ~i cristiani a coltivare un cuore umile e semplice24 . Sviluppando 1l tema, Isacco osserva che la vulnerabilità del bambino obbliga
:: I,71 (p. 349) Toura~lle 8r (pp. 401-40ZÌ; PR 74 (p. 515).
24 I,5I (~. 245)~ Touraille 58 (p. 313); PR ;;o (p. 346). Cf. Gwvanru Cnsostomo, Omelie su Matteo 58, 2 -3.

Dio a prendersi particolare cura di lui. L'umile dev'essere egualmente vulnerabile e indifeso:
Sta scritto: "Il Signore protegge i bambini" (Sal r r6,6). Un fanciullo si avvicina a un serpente e lo afferra per la testa, ma il serpente non gli fa alcun male. Va nudo d'inverno, quando tutti sono ben coperti, e non sente il gelo che gli sferza le membra. Siede nudo in una fredda giornata di ghiaccio e gelo senza soffrirne, perché il suo corpo innocente è avvol~ to da un'altra veste, invisibile, tessuta da quella provvidenza nascosta che protegge le sue tenere membra affinché nulla possa nuocergli ... "Il Signore protegge i bambini". E non solo quelli dal corpo piccolo e fragile, ma anche quelli che nel mondo erano sapienti, ma hanno abbandonato la loro scienza per consacrarsi unicamente a quell'altra sapienza che basta a tutto, ridiventando bambini per libera scelta25 •
È per questo che l'umile si trova sotto la protezione particolare della provvidenza divina: essa lo avvolge come una veste e lo protegge contro ogni pericolo esterno. In altri termini, l'umile ha instaurato un tipo particolare di rapporto con Dio: rinunciando ai mezzi naturali di difesa, ha posto tutta la sua fiducia in Dio, colui che "protegge i bambini".
San Paolo d insegna che proprio nella debolezza dell'uomo la forza di Dio si dispiega pienamente (d. 2Cor r2,9). Quando prende coscienza della sua fragilità e invoca l'aiuto di Dio, l'uomo è senz' altro esaudito. Da qui deriva lo stretto legame tra umiltà e preghiera:
Beato chi conosce la propria debolezza, giacché tale conoscenza diventa per lui fondamento, radice e principio di ogni bene ... Quando l'uomo sa di aver bisogno dell'aiuto di Dio,
25 I,7r (pp. 35r-352) = Touraille I9 (pp. rz8-r29); PR 77 (p. 525).
moltiplica le preghiere, e quanto più le moltiplica, tanto più il suo cuore si umilia: infatti è impossibile non umiliarsi quando si intercede e si supplica. "Un cuore affranto e umiliato Dio tu non disprezzi" (Salsr,r9)26• ' '
Cosl si spiega perché sia indispensabile pregare per raggiungere l'umiltà, che non si può ottenere con mezzi unicamente umani. Osserva Isacco:
Ciò che all'uomo è impossibile, con Dio può davvero accadere (cf. Mt r9,z6). Invece di pregare per uno scopo qualsiasi, invece di chiedere questo o quello, lascia perdere tutto e punta su una sola preghiera, dicendo: "Dio, concedimi l'umiltà affinché io sia liberato dalla sferza e possa accostarmi, quale che sia il mio desiderio, alle delizie della mente, anche quelle di cui non ho coscienza prima di aver acquisito tale umiltà". Dio allora ti concederà il dono del suo Spirito, dono del quale tu non sai né esprimere né concepire la grandezza, giacché ti renderà umile in un modo nascosto, se solo vedrà che non ti ritrai, non cessi di chiedere senza posa e non ti stanchi mai di rivolgergli questa preghiera. Fratello, bisogna convincersi che l'umiltà è una forza che nessuna lingua può descrivere, nessuna fatica umana conquistare. Essa è data a tutti coloro ai quali può essere data, e viene ricevuta in mezzo alle veglie, tra suppliche e ferventi intercessioni27 .
261,8 (pp. 67-68) = Touraille 2r (p. r43); PR 8 (pp. ro4-I05).
27 II,27,I-}.
I43

I segni esteriori dell'umiltà
Volgiamo ora la nostra attenzione ai segni esteriori dell'umiltà, a partire dalla mancanza di interesse per le distrazioni e i piaceri del mondo e dal rifiuto degli affanni e degli agi del secolo. Chi possiede molto denaro, chi si occupa di grandi opere, chi partecipa alle attività della società, si trova legato mani e piedi a questo mondo. Chi al contrario riesce a fuggire tutto ciò, conserva una libertà che lo rende simile a Dio:
L'umile non trae alcuna gioia dalle riunioni, dal tramestio delle folle, dal tumulto, da clamori e grida, dall'opulenza, dal lusso e da tutto ciò che è privo di sobrietà. Il suo piacere non sta nelle conversazioni, nelle assemblee, nel frastuono e nella dissipazione dei sensi, giacché a ogni altra cosa egli preferisce il raccoglimento nell'intimo e nella quiete, staccato da tutte le cose create, custodendo se stesso in un luogo silenzioso. L'essere insignificanti, la mancanza di beni, la miseria e la povertà gli sono sempre cose care. Egli non si impegna in faccende svariate e complesse, ma desidera essere libero da incombenze e preoccupazioni e dalla confusione delle cose mondane, per impedire che i suoi pensieri fuoriescano da lui ... Per tutte queste ragioni l'umile si protegge incessantemente dalla molteplicità degli affari e si fa cosl trovare sempre tranquillo,
buono, calmo, modesto e rispettoso28
•
Un simile atteggiamento verso la vita, che spinge a evitare ogni coinvolgimento nelle attività secolari e dà la sensazione di essere quasi ospiti in mezzo alla società degli uomini, è chiamato dagli autori ascetici greci xeniteia, termine che vuoi dire "esilio" o, più letteralmente, "stranierità", il fatto di "vivere come uno
28 I,7r (pp. 348-349) = Touraille 8r (pp. 400-40r); PR 74 (pp. 5r5·5r6).
I44
straniero" (da xénos, straniero). In siriaco il termine è stato tradotto con aksnayuta (da aksnaya, straniero)29 . Per !sacco "vivere da straniero" è l'atteggiamento che un asceta deve mantenere sempre e ovunque: "Considerati uno straniero ogni giorno della tua vita, ovunque tu sia" 30
. Un asceta deve "rendersi straniero a tutte le sue relazioni, al suo paese, alla famialia alla stirpe"· d " b' b ' ' eve a Itar: una terra straniera" e scegliersi "un luogo di quie-te dove ogm rumore cessi, per abitarvi poveramente nell'indigenza materiale 3I, e per viverci solo, in disparte da' ogni commercio con gli uomini e da ogni frequentazione e consolazione visibile" 32 •
Nella tradizione ascetica la xeniteia non comporta una vita noma~e ~una migrazione continua di luogo in luogo, ma piuttosto un esistenza appartata dal mondo e dalle sue distrazioni il sentimento della brevità e fragilità di questa vita e la rinunci~ a t~tto ciò che è terreno in favore delle cose del cielo. Tale atteggiamento conduce all'umiltà:
Come conquistare l'umiltà? . . . Rammentandosi continuamente delle proprie trasgressioni nella previsione della morte che incombe, vestendo poveramente, accontentandosi sempre dell'ultimo posto, assumendo i compiti più modesti e dis~rez:ati, non disobbedendo mai, osservando sempre il silenZIO, nfuggendo dalle riunioni, desiderando di essere sconosciuti e tenuti in nessun conto, evitando di affezionarsi a un sol~ tipo di opera [ascetica], evitando le conversazioni a più voci, avendo orrore del guadagno materiale e, in aggiunta a tutto questo, elevando la propria mente fino a non accusare o
, 29
, Su xeniteia/aksnayuta si veda A. Guillaumont, "Le dépaysement comme forme · d ascese dans le monachisme ancien", in Id., Aux origines du monachisme cbrétien Ab-bay~0 de Bellefontaine, ~égrolles-en-Mauges r979, pp. 89-r r6. '
I,4 (p. 33) = Touraille 23 (p. I 55); PR 4 (p. 47). '
1 Letteralmente: "corporale". '
2 Centurie di conoscenza I,85.
I45

biasimare nessuno, evitando di atteggiarsi a chi si oppone a tutto il mondo e ha tutto il mondo contro (cf. Gen r6,12), ma piuttosto comportandosi come chi sta solo, attende alle proprie faccende e d'altro non si cura. Riassumendo, dall'esilio, dalla povertà e dalla vita solitaria scaturiscono l'umiltà e la purezza del cuore 33 .
Un'altra manifestazione esteriore dell'umiltà è la sopportazione senza un lamento di ogni sorta di umiliazioni:
Soffri volentieri umiliazioni e disprezzo, per essere audace davanti a Dio. Colui che sopporta consapevolmente ogni sorta di parole aspre senza aver fatto torto al suo avversario, gli pone in testa una corona di spine; quanto a lui, invece, è benedetto e riceverà una corona imperitura in un tempo che ancora non sa 34 .
!sacco ritiene che sopportare accuse e ingiurie senza protestare sia la virtù più alta:
Colui che, pur potendo respingerla, riesce a sopportare con gioia la malvagità, riceve da Dio la consolazione consapevole della propria fede. Chi tollera con umiltà le accuse che gli sono rivolte ha raggiunto la pienezza, e gli angeli santi guardano a lui ammirati, giacché non c'è virtù altrettanto grande e difficile da mettere in pratica 35 .
L'umiltà si manifesta altresì negli sforzi fatti per essere umiliati dagli altri. Come la grazia è accompagnata dall'umiltà, così l'orgoglio è seguito da incidenti dolorosi. Gli occhi del Signore si posano sull'umile per rallegrarlo; ma il suo viso si
33 1,7r (p. 345) = Touraille 8r (p. 396); PR 74 (p. 508). 34 1,4 (p. 29) = Touraille 23 (p. rsr); PR 4 (p. 41). 35 1,5 (p. 43) = Touraille 5 (p. 78); PR 5 (pp. 63-64).
rivolta contro gli orgogliosi per render li umili. L'umiltà riceve sempre la misericordia del Signore; ma la durezza del cuore e la mancanza di fede devono sostenere scontri terribili ... Se ti abbassi in ogni modo davanti a tutti sarai innalzato al di sopra dei signori di questo mondo. Fa' conoscere a tutti la tua salvezza e la tua passione e ne sarai lodato più di chi porta in dote l'oro di Ofir (cf. I Re r o, I I). Sii spregevole ai tuoi stessi occhi e vedrai dentro di te la gloria di Dio, giacché dove ti spinge l'umiltà, là zampilla anche la gloria di Dio. Se ti sforzi di essere pubblicamente umiliato da tutti Dio farà in modo di colmarti di gloria. Se nutri l'umiltà neÌ cuore, Dio ti mostrerà la sua gloria. Sii disprezzabile nella tua grandezza, non voler essere grande nella tua insignificanza. Sopporta il disprezzo e sarai colmato dell'onore di Dio. Non cercare gli onori quando dentro di te sei tutto una piaga. Fuggi gli onori, per poterli ricevere; non amarli, per non essere disonorato 36 .
Per Isacco la vera umiltà si manifesta nell'onorare il prossimo al di sopra dei suoi meriti, perché l'umile tratta tutti quelli che incontra con rispetto, onore e amore:
Quando incontri il tuo prossimo, sforzati di fargli più onore di quanto gli è dovuto. Baciagli le mani e i piedi, prendigli spesso la mano con grande rispetto e posala sui tuoi occhi, congratulati con lui per cose che non possiede. Dopo che ti avrà lasciato, racconta di lui tutto il bene possibile e tutto ciò che induce rispetto. In questo modo e con atteggiamenti simili lo attiri verso il bene ... e poni in lui semi di virtù37•
Benché !sacco parli di "sforzarsi" di onorare il prossimo non si tratta di assumere ad arte un atteggiamento insincero, q~anto
36 1,5 (p. so)= Touraille 5 (p. 87); PR 5 (pp. 76-77). 37 1,5 (pp. 51-52)= Touraille 5 (p. 89); PR 5 (p. 79).
1 47

piuttosto della naturale conseguenza di un vero amore del prossimo: provare per lui un rispetto profondo e sentirsene personalmente indegni.
C'è ancora una manifestazione dell'umiltà interiore che si potrebbe definire estrema, cioè la "santa follia", fenomeno assai diffuso nell'oriente ortodosso ai tempi di Isacco. Scegliere di essere un "folle in Dio" significa assumere volontariamente un comportamento da folle o commettere azioni riprovevoli al fine di suscitare condanna e disprezzo. La follia in Dio era praticata da asceti divenuti celebri per la santità della loro vita virtuosa: non avendo più occasione di sopportare offese e umiliazioni, per riceverne ancora si imponevano la maschera della follia. Scrive I sacco:
Chi non disprezza onori e disonori e non sopporta pazientemente per via della quiete rimproveri, scherni, ingiurie e percosse e il fatto di essere diventato lo zimbello di tutti ed essere ritenuto un pazzo o un debole di mente, costui non può perseverare nei benefici della quiete38 .
Isacco cita ad esempio certi santi di un tempo che si erano imposti la maschera della follia per evitare la gloria umana, e si accusavano di peccati che non avevano commesso:
Chi è veramente umile non si turba quando gli viene fatto del male e non dice niente per giustificarsi di fronte all'ingiustizia, ma accetta le calunnie come verità, senza cercare di provare agli altri la sua innocenza ma chiedendo perdono. Certi si sono volontariamente addossati una reputazione di dissoluti pur non essendolo affatto; altri si sono lasciati accusare di un adulterio inesistente e con le loro lacrime ammettevano di portare il frutto di peccati non commessi; piangevano e chie-
38 I,44 (p. 217) = Touraille, Lettere r (p. 45r); PR 4I (pp. 307-308).
devano perdono a coloro che li offendevano per un male dì cui non avevano colpa, e al tempo stesso le loro anime venivano incoronate di purezza e castità; altri ancora, per non ricavare gloria dalle virtù che avevano ben nascoste in se stessi, fingevano di essere squilibrati mentre in realtà erano ripieni di sale divino e così saldamente installati nella serenità che gli angeli si facevano araldi delle loro prodezze, a causa della loro estrema perfezione 39 •
Isacco rievoca anche ricordi personali di quando era un giovane monaco, e conversazioni con asceti celebri sul tema della "santa follia". Racconta per esempio che un giorno andò a far visita a "un vegliardo, uomo eccellente e virtuoso" per confidargli: "Padre, mi è venuto in mente di andarmi a sedere la domenica mattina presto accanto alla porta della chiesa e mettermi a mangiare lì, cosicché tutti quelli che entrano ed escono mi disprezzino" . .i'vla ecco la risposta dell'anziano:
Sta scritto che colui che scandalizza ì cristiani che vivono nel mondo non vedrà la luce. Nessuno ti conosce in questa regione40, né sa qual è la tua fama. Diranno: "I monaci mangiano fin dalle prime ore del mattino ... ". Un tempo i padri si comportavano così a causa dei molti miracoli che avevano compiuto e dell'onore e della reputazione di cui godevano presso gli uomini. Facevano queste cose per disonorarsi, per offuscare la gloria della loro condotta ed eliminare ogni motivo d'orgoglio. Ma tu, che cosa ti obbliga a fare altrettanto? Non lo sai che ogni pratica ascetica ha le sue regole e un tempo opportuno? La tua condotta di vita non è straordinaria e il tuo nome non è celebre, dato che vivi come gli altri fratelli. Comportarti in quel modo a te non arrecherebbe vantaggio alcuno
39 I,6 (p. 55) Touraille 56 (pp. 298-299); PR 6 (pp. 85-86). Isacco si riferisce in particolare alla vita di san Simeone di Emesa, un folle in Cristo del vr secolo.
40 Questa osservazione fa supporre che Isacco, al tempo della sua giovinezza, abbia abitato o viaggiato in paesi stranieri.
149

mentre farebbe torto ad altri. Inoltre, queste cose sono eccezionali e non tutti possono trame profitto, ma solo i più grandi e quelli che hanno raggiunto la pienezza 41
.
Così l'anziano riuscì a smorzare lo zelo del giovane asceta e gli impedì di adottare un comportamento contrario all'etica monastica, anche se al fine di progredire nell'umiltà.
41 I,zr (pp. ro6-ro7) = Touraille 76 (pp. 382-383); PR r8 (pp. I42-r43).
v LE LACRIME
Sei tu che concedi il pentimento e un cuore afflitto al peccatore che si pente. Così tu rendi leggero il suo cuore, togliendogli il peso del peccato che lo prostra, grazie al sollievo dato dall'afflizione e dal dono delle lacrime.
n pentimento
II,s,J
Sulle orme di Afraat e di Giovanni il Solitario\ Isacco considera il pentimento un rimedio inventato da Dio per il nostro continuo rinnovamento e per la nostra guarigione:
Con la conoscenza piena di compassione che gli è propria Dio sapeva che, a esigere dagli uomini una giustizia rigorosa, solo uno su diecimila riuscirebbe a entrare nel regno dei cieli. Pertanto egli ha previsto un rimedio adatto a tutti: il pentimento. Così, ogni giorno e a ogni istante, grazie alla forza di questo
1 Cf. Afraat, Dimostrazioni 7,3-4; Giovanni di Apamea, Lettere 45· Cf. S. Brock, n. 2 a II,40,8, in esco 555. p. I76.

rimedio, Dio offre agli uomini l'opportunità di rimettersi facilmente sulla retta via: attraverso la compunzione (twata) essi saranno in grado di purificarsi da tutte le brutture di cui possano essersi macchiati. Davvero potente è il mezzo che il Creatore misericordioso ha preparato per noi nella sua divina sapienza, in vista della nostra vita eterna (~ayye)2, giacché egli desidera che noi ci rinnoviamo ogni giorno, ricominciando da capo attraverso un cambiamento in meglio della nostra volontà e della nostra mente 3
•
Il pentimento è un sentimento spirituale costa~te in .ogni asceta, che si protrae giorno e notte nel suo cuore: Dobbtamo sapere in ogni momento che abbiamo bisogno di pentirei duran-
, l . d 11 " 4 N ' te tutte le ventiquattr ore de gtorno e e a notte . on e un sentimento limitato a un periodo della vita o a una specifica categoria di persone, ma universale:
Se tutti siamo peccatori e nessuno è grande davanti alle tentazioni del peccato, è chiaro che non c'è virtù più eccelsa del pentimento (nessuno infatti potrà mai portarne a term~n~ l'o~ pera. Esso si addice sempre ai peccatori ma an~he al gms:l che aspirano alla salvezza. Non c'è limite alla ptenezza, pmché anche la pienezza dei perfetti non è mai veramente compiuta. È per questo che il pentimento non è legato a opere o momenti dati e dura fino alla morte)5.
!sacco definisce il pentimento come "l'abbandono delle opere passate e il dolore provato per esse" 6
. Secondo un'altra defini-
zione:
> Il termine siriaco hayye significa tanto "vita" quanto "salvezza". 3 Il,4o,8-9. 4 I,7o (p. 340) = Touraille 50 (p. 276); PR 73 (p. 502). . 5 r,32 (p. r 53) = Touraille 55 (p. 294); PR 30 (p. 2q). Il passo tra parentesi nella
redazione siro-orientale manca. 6 I,7r (p. 344) = Touraille Sr (p. 395); PR 74 (p. 507).
Il significato del termine pentimento (tyabuta) ... è il seguente: una continua supplica piena di tristezza che, grazie alla preghiera di compunzione, riavvicina l'anima a Dio, per cercare il perdono delle offese passate e chiedere di esserne preservati per l'avvenire 7•
In questa definizione si possono distinguere tre elementi. In primo luogo il pentimento è una preghiera rivolta a Dio da parte di chi sta al suo cospetto e non si accontenta di riflettere nel proprio intimo sui suoi peccati passati. In secondo luogo, esso comporta la rinuncia ai peccati passati e il rammarico per averli commessi. Da ultimo, il pentimento mira al futuro e ormai non ha altro desiderio che guardarsi dal peccato.
!sacco paragona il pentimento a una nave presa a nolo per attraversare il mare che ci separa dal paradiso spirituale. Timoniere è il timore di Dio, meta del viaggio il porto dell'amore divino. Chiunque sia "afflitto e pesantemente oppresso" 8 dal pentimento può entrare in porto. "Carica tutti i miei impulsi sulla navicella del pentimento, affinché io possa solcare esultando il mare del mondo, per entrare infine nel porto della tua speranza"9: ecco la preghiera di !sacco.
Il tema del pentimento come secondo battesimo fa parte della tradizione patristica, e anche !sacco lo sviluppa in tal senso. Egli non pensa che Dio volesse privare l'uomo, per avere questi abusato della sua libertà, della condizione di felicità a lui destinata. Ecco quindi che "Dio concepì nella sua misericordia un secondo dono, quello del pentimento, affinché la vita dell'anima potesse·ogni giorno rinnovarsi e rimettersi sulla retta
7 I, 70 (p. 340) = Touraille 50 (p. 2 76); PR 73 (p. 502). 8 I,46 (pp. 224-225) = Touraille 72 (p. 367); PR 43 (p. 3f7). Cf. Mt rr,28. 9 II,5,I4. Le immagini marine sono tradizionali negli autori siro-orientali dell'età
anteriore a Isacco; l'espressione "il mare del mondo" (yammeh d-'alma) è un luogo comune presso gli autori greci e siriaci; cf. S. Brock, nn. 2-3 a II,5,r4 (CSCO 555, p. I2) e n. 4 a II,7,3 (CSCO 555, p. 25).
1 53

via" 10• Il pentimento è appunto questo rinnovamento della gra
zia battesimale perduta a causa del peccato:
Il pentimento è donato come grazia dopo la grazia, giacché esso costituisce una seconda rigenerazione operata da Dio. Ciò che abbiamo ricevuto come promessa solenne nel battesimo ora lo otteniamo come dono attraverso il pentimento. Il pentimento è la porta della misericordia che si apre per coloro che la cercano. Per questa porta si accede alla misericordia e fuori da questa porta non si trova nessuna misericordia ... Il pentimento è la grazia seconda 11 .
Attraverso il pentimento l'uomo riceve di nuovo la conoscenza (ida'ta) che gli era stata donata al battesimo come promessa12.
Parlando del pentimento !sacco, seguendo la tradizione, paragona le lacrime del pentimento al sangue dei martiri:
Chi possiede il vero pentimento è un martire vivente. Le lacrime prevalgono sul sangue attraverso l'attività loro propria, e il pentimento prevale sul martirio. Il martirio delle lacrime precederà quello del sangue, quando riceveremo la corona. I martiri saranno incoronati insieme agli altri; coloro che vivono nel pentimento, prima degli altri. Chi possiede il vero pentimento sembra dunque ricevere una doppia corona 13 .
Il pentimento appare perciò come un frutto dell'azione della grazia divina sull'anima, alla quale Dio inizialmente concede di prendere coscienza dei suoi peccati. Questa presa di coscienza penetra nell'anima quando Dio ci vede soffrire ogni sorta di
10 II,IO,I9. 11 1,46 (p. 223) = Touraille 72 (p. 365); PR 43 (p. }I)). 12 1,47 (p. 227) = Touraille r8 (p. !25); PR 44 (p. 319). Cf. 1,46 (p. 223) = Touraille
72 (p. 365); PR 43 (p. 3I5); 1,64 (p. 305) = Touraille 34 (p. 2Io); PR 65 (p. 443). 13 Centurie di conoscenza 1,5 3.
154
prove14 . !sacco considera più importante essere consapevoli dei propri peccati che compiere miracoli o avere visioni soprannaturali o mistiche, giacché proprio attraverso una tale consapevolezza si intraprende la via del pentimento, che è virtù più grande di tante altre:
Chi conosce i propri peccati è più grande di chi fa del bene al mondo intero con la sua sola presenza. Chi geme sulla propria anima, anche per un'ora soltanto, è più grande di chi risuscita un morto con la preghiera e abita in mezzo agli uomini. Chi è giudicato degno di vedere se stesso è più grande di chi è giudicato degno di vedere gli angeli, giacché quest'ultimo vede con gli occhi del corpo mentre il primo scruta dentro di sé con gli occhi dell'anima. Colui che segue Cristo pentendosi nella solitudine è più grande di chi loda Dio nel mezzo di un'assemblea 15 .
Il pentimento unisce cuore e intelletto. !sacco riconosce nel "dolore del cuore" e nella "tristezza della mente" due attributi del pentimento 16 . Il "cuore affranto e umiliato" del salmista (cf. Sals r, 19) si ottiene attraverso il processo del pentimento, quando la presa di coscienza del peccato coincide con la liberazione dal suo peso; in una sua preghiera !sacco dice: "Sei tu che concedi il pentimento e un cuore afflitto al peccatore che si pente; così tu rendi leggero il suo cuore togliendogli il peso del peccato che lo prostra, grazie al sollievo dato dall'afflizione e dal dono delle lacrime".
Il perdono dei peccati è risultato e frutto del pentimento al quale fa immediatamente seguito, per quell'amore smisurato di Dio per gli uomini che ha spinto il Figlio di Dio non solo
14 Cf. 1,74 (p. 362) = Touraille 7I (p. 362); PR 79 (p. 542). "1,64 (p. 317) = Touraille 34 (p. 2!6); PR 65 (pp. 463-464). 16 1,51 (pp. 243-244) = Touraille 58 (p. }Ir); PR 50 (p. 344).
1 55

a perdonare i peccatori ma anche a farsi uomo per salvarli dal peccato:
Poiché il suo volto inclina sempre verso il perdono ... egli effonde su di noi la sua grazia immensa e senza limiti come l'oceano. A qualsiasi uomo che dia segno anche solo di un minimo sentimento di dolore per quanto ha fatto e di un desiderio di compunzione, Dio accorda immediatamente, lì e subito, il perdono dei peccati17
.
Dunque il cristiano, purché si penta, non ha il diritto di dubitare del perdono di Dio per i suoi pur gravi peccati. Tale fiducia nel perdono deriva dalla concezione di !sacco della misericordia di Dio, più grande della sua giustizia, e anche dalla sua concezione della provvidenza divina e più particolarmente dell'incarnazione di Dio il Verbo, che già conteneva la promessa di una riconciliazione tra Dio e il genere umano:
Vedendo e ascoltando tali cose, chi potrebbe essere così turbato dal ricordo dei propri peccati da nutrire questo dubbio nell'animo: "Dio è davvero pronto a perdonar mi le cose che mi fanno soffrire e il cui ricordo mi tormenta? Cose di cui ho orrore ma verso le quali continuo a inclinare e la cui sofferenza, dopo averle commesse, è più dolorosa di una puntura di scorpione? Le aborro, nondimeno mi ci trovo continuamente invischiato, e se da una parte me ne pento con dolore, dall'altra vi faccio sempre tristemente ritorno". Ecco cosa pensano molti tra coloro che hanno timore di Dio e si applicano alla virtù, trafitti dal dolore della compunzione. Piangono i loro peccati, ma la prosperità del mondo li costringe a far fronte alle cadute da essa stessa provocate, e così vivono tutto il tempo tra peccato e pentimento. Cara umanità, non dubitiamo dunque della speranza della nostra salvezza, vedendo
pieno di sollecitudine per essa colui che ha patito per causa nostra. La sua misericordia è ben più grande di quanto noi possiamo concepire, la sua grazia maggiore di quanto noi possiamo chiedere. La destra del Signore si stende infatti giorno e notte spiando l'occasione per sostenerci, confortarci e incoraggiarci insieme a quanti si rammaricano della loro poca rettitudine; soprattutto per vedere se c'è qualcuno che soffre anche un minimo di dolore e tristezza, per potergli accordare il perdono dei peccati 18 .
Così, attraverso un atto di pentimento, avviene la riconciliazione tra Dio e il peccatore. Da quest'ultimo ci si aspetta che si penta dei peccati commessi, si risolva, con un atto di volontà, a guardarsene per il futuro, e perseveri nella preghiera davanti a Dio per chiedergli perdono. Tale perdono viene da Dio, che riconcilia l'uomo con la propria persona e lo rende partecipe del suo amore.
Lacrime amare e lacrime dolci
Il tema delle lacrime si incontra di frequente nella letteratura ascetica di lingua siriaca, a partire da Efrem, chiamato il "padre del pentimento". Un suo contemporaneo bizantino lo descriveva con queste parole: "Per Efrem piangere era come per gli altri respirare. Leggendo i suoi scritti ci si accorge che lui non piange solo quando parla di pentimento, ma anche nelle occasioni in cui gli altri esprimono la loro gioia" 19 . Questo autore bizantino
18 II,4o,r5·I7· Nel manoscritto il testo dell'ultima frase è rovinato; cf. S. Brock, n. 2 a II,4o,q, in CSCO 555, p. !79·
19 Pseudo-Gregorio di N issa, Elogio di E/rem il Siro.
1 57

ha saputo ben rilevare un tratto carattensttco dell'esperienza delle lacrime nella tradizione siriaca: esse non esprimono solo il pentimento ma anche la gioia. Tale tema occupa quindi un posto importante nella spiritualità monastica di Isacco 20 e mostra come l'esperienza delle lacrime poggi su una doppia tradizione, scritturistica e patristica:
Accanto alla visione spirituale, anche le lacrime erano tenute in grande onore dai padri. Del beato Arsenio si dice che le lacrime facessero una guardia attenta e costante alle sue pupille. Ma perché parlare di questo se gli occhi del beato Paolo, questo gigante, questo vaso ripieno dello Spirito, piansero incessantemente per ben tre anni, come riferisce il beato Luca nel libro degli Atti (cf. A t 20,3 r)21?
Per !sacco le lacrime sono inseparabili dall'esperienza monastica. Si può osservare in proposito che il termine abila, che in siriaco significa in primo luogo "piangente", era usato anche per designare il monaco. Secondo la tradizione siriaca il monaco è soprattutto colui che piange su se stesso, sugli altri e sul mondo intero. Scrive Isacco:
Il piangente (abila) è colui che passa tutti i giorni della propria vita nella fame e nella sete delle cose che spera e dei beni a venire. Il monaco (i{Jidaya) è colui che, avendo stabilito la propria dimora lontano dagli spettacoli del mondo, non conosce che una domanda nella sua preghiera: il desiderio del mondo a venire. La ricchezza del monaco è la consolazione che gli viene dal pianto22
•
20 Cf. D. A. Licher, "Tears an d Contemplation in Isaac of Nineveh", in Diakonia I I (I976), pp. 239-258; P. T. Mascia, "The Gift of Tears in Isaac of Nineveh", ibid. I4 (I979), pp. 255-265.
21 CentUiie di conoscenza I, 82. '' I,6 (p. 54)= Touraille 56 (p. 298); PR 6 (pp. 83-84).
Conformemente a questa immagine del monaco come colui la cui principale attività consiste nel piangere i propri peccati, !sacco scrive:
Quale può essere la meditazione di un monaco nella sua cella, se non le lacrime? Potrebbe mai conoscere momenti senza lacrime per volgersi ad altri pensieri? E quale occupazione è migliore di questa? La cella stessa e la solitudine del monaco, simili a una vita di tomba lontana da gioie umane, gli insegnano che il suo compito è piangere. E anche il nome che gli viene dato lo induce e lo esorta a questo: egli infatti è chiamato "piangente" (abila), cioè colui che ha un cuore amareggiato. Tutti i santi hanno abbandonato la vita piangendo. Se tutti i santi hanno pianto e i loro occhi erano pieni di lacrime fino al momento di lasciare questa vita, chi mai potrebbe fare a meno delle lacrime? La consolazione del monaco nasce dalle lacrime. Se quaggiù hanno pianto i perfetti e i conquistatori, come potrebbe astenersi dal piangere chi è coperto di ferite? Chi vede la persona amata esanime ai suoi piedi e se stesso morto nel peccato ha forse bisogno di un insegnamento particolare per imparare a piangere? L'anima giace ai tuoi piedi uccisa dai peccati, quell'anima per te più preziosa dell'universo intero; è possibile che tu non senta il bisogno di piangerla? Ecco perché, se entriamo nella quiete e vi perseveriamo con pazienza, saremo certamente in grado di piangere senza sosta. Chiediamo dunque insistentemente al Signore di concederci le lacrime 23 •
Per !sacco le lacrime devono essere continue. Più ci si avvicina al frutto della vita spirituale, più frequenti esse diventano, fino a quando sgorgheranno ogni giorno e a ogni istante:
Domanda: Qual è il segno preciso e certo che il frutto celato nell'anima comincia ad apparire in seguito alle nostre sofferenze?
"!.37 (pp. rn-q8) = Touraille 85 (p. 432); PR 35 (pp. 25I-252).
159

Risposta: Quando uno è giudicato di ricevere il dono di lacrime copiose che sgorgano senza Giacché le lacri-me sono state istituite a beneficio della mente come una sorta di frontiera tra ciò che appartiene al corpo e ciò che appartiene alla mente, tra lo stato passionale e la purezza. Finché uno non ha ricevuto quel dono, la sua attività unicamente l'uomo esteriore; egli non ha ancora provato l'attività delle cose nascoste che ha luogo nell'uomo spirituale. Ma quando comincia ad abbandonare le cose corporali all'e-tà presente e varca il confine che lo fa accedere a ciò e m-terno alla natura visibile, egli ottiene immediatamente la grazia delle lacrime. Fin dalla prima tappa del cammino interiore le lacrime cominciano a scorrere e lo conducono alla ,.,,,.,.,,,,"'_ ne dell'amore di Dio. Più egli progredisce in tale u•~'-•~->•uu.u, più viene arricchito dall'amore; finché lacrime continue non finiscono per inzuppargli il cibo e diluirgli le bevande24 .
Tuttavia, le lacrime che scorrono incessantemente non costituiscono ancora il punto culminante del cammino spirituale, il cui apice secondo Isacco sarà il momento in cui, per effetto delle continue lacrime, si raggiunge la "pace del pensiero" ,e il riposo spirituale. Le lacrime diventano allora "moderate". E nel capitolo 16 della prima parte che Isacco sviluppa la dinamica sottesa ai diversi passaggi, dapprima dalle lacrime occasionali alle lacrime continue, poi dalle lacrime continue a quelle "moderate" che sono proprie di coloro che hanno raggiunto la pienezza. Isacco suggerisce che la comparsa delle lacrime del pentimento significhi che uno ha intrapreso il cammino verso Dio. Dapprima le lacrime sono temporanee e ritornano di tanto in tanto; in un secondo momento esse sgorgano incessantemente; al culmine del percorso trovano una loro "misura". Isacco considera questo insegnamento parte integrante della fede della chiesa universale:
160
Una volta giunto alla regione delle lacrime, sappi che la tua mente ha lasciato la prigione di questo mondo e ha già messo piede sull'ampio argine di un mondo nuovo, dove un'aria diversa e meravigliosa. Contemporaneamente cominciano a scorrere le lacrime, giacché stanno per iniziare i dolori del parto del pargolo spirituale. Effettivamente la madre comune di tutti noi, è ansiosa di partorire misticamente nell'anima l'immagine divina destinata alla luce dell'età futura.
Fino alla nascita del bimbo le lacrime sgorgheranno di quando in quando dagli occhi del solitario; ma dopo che sarà nato e comincerà a crescere aumenteranno fino a diventare inarrestabili: "Gli occhi di quest'uomo si trasformano in fontane per un anno o due o anche più, cioè per tutto il tempo del passaggio". Dopo questi due o più anni il solitario penetra nella "pace del pensiero" e nel "riposo" di cui parla la Lettera agli Ebrei (cf. Eb 4.3):
Man mano che ti addentri nella regione della pace dei pensiela grande ondata di lacrime ti è risparmiata ed esse ormai
arrivano solo in misura moderata e al momento opportuno. precisamente e concisamente, la verità del fenomeno
cosi come è inteso da tutta la chiesa, dai suoi uomini più illustri e dai combattenti di prima linea25 •
lacrime del pentimento che nascono dalla coscienza dei peccati sono accompagnate dall"'amarezza di cuore" e dalla contrizione. Ma il dinamismo della crescita spirituale implica un passaggio progressivo da questo primo tipo di lacrime a un altro in cui dominano le lacrime dolci della compunzione. Il discorso 3 7 della prima parte espone questa dottrina:
25 I,r4 (pp. 82-83) Touraille 15 (pp. 1I5·II6); PR 14 (pp. 125-127).
161

Ci sono lacrime che bruciano e lacrime che ungono come olio. Quelle che sgorgano dalla frantumazione e dalla pena del cuore per i peccati commessi bruciano e disseccano il corpo, e spesso capita che anche le facoltà che governano l'uomo ne siano danneggiate. Ma all'inizio si deve necessariamente passare per quelle lacrime, attraverso le quali viene aperta una porta che conduce a un secondo ordine superiore, segno
l'uomo ha ricevuto misericordia. Si tratta delle lacrime sparse a causa di un'intuizione. Esse abbelliscono il corpo ed è come se lo ungessero d'olio. Scorrono da sole, senza sforzo. Non solo ungono il corpo, ma cambiano l'aspetto dell'uomo. È detto: "Un cuore lieto rende ilare il volto, ma quando il cuore è triste la mente è depressa" (Pr I 5, I 3). Quando il pensiero tace, queste lacrime si spandono su tutto il viso. Il corpo ne riceve una sorta di nutrimento e gli si dipinge sul viso la gioia. Chi ha fatto esperienza di questo duplice cambiamento mi capirà26 .
Queste lacrime di compunzione, accompagnate da un mento di gioia spirituale, sono concesse a chi ha raggiunto la condizione di purezza di cuore e di assenza delle passioni. Esse sono conseguenza del fatto che la persona è stata giudicata degna delle rivelazioni celesti e della visione di Dio, come già annunciato dalle Beatitudini:
Ecco perché sono "beati i puri di cuore" (Mt 5,8), giacché per loro non ci sono più momenti in cui non godano della dolcezza delle lacrime, nelle quali vedono continuamente il Signore. I loro occhi sono ancora umidi di lacrime, ed ecco che già, al culmine della preghiera, sono giudicati degni di afferrarne le rivelazioni, e ormai non pregano più senza lacrime. Da qui si comprende che cosa voleva dire il Signore con le parole "beati quelli che piangono, perché saranno consolati"
26 I,37 {pp. 174-n5l Touraille 85 (p. 428); PR .35 (pp. 245-246).
(Mt 5,4). Infatti proprio a partire dalle lacrime si perviene al cuore puro. Ma il Signore, parlando di consolazioni, non ha spiegato in che cosa esse consistano. Quando un monaco, · grazie alle lacrime, è giudicato degno di attraversare i territori accidentati delle passioni per giungere alle pianure della purezza del cuore, vi ritrova una consolazione che non sarà mai provata in questo mondo. Egli allora comprende che là è la consolazione che si riceve grazie alla purezza del cuore quando cessano le lacrime, e che Dio ha voluto concederla a coloro che piangono. Infatti è impossibile che chi piange e si duole incessantemente sia tormentato dalle passioni, ché il dono delle lacrime e del pianto appartiene a coloro che non hanno più passioni. E se le lacrime di chi piange e si lamenta a lungo non solo lo portano all'assenza delle passioni, ma anche purificano completamente la sua mente e la liberano dal ricordo delle passioni, che dire allora di quelli che si sono votati giorno e notte a questa pratica? Ecco perché nessuno conosce esattamente il soccorso prestato dalle lacrime, tranne coloro che sono dediti a tale fatica. Tutti i santi si sforzano di trovare questa via d'accesso perché, grazie alle lacrime, viene loro aperta la porta che introduce nelle plaghe della consolazione, dove le tracce dell'amore di Dio sono impresse dalle rivelazioni 27 •
Così le lacrime della compunzione nascono dall'aver conquistato la purezza del cuore e l'assenza delle passioni, che portano poi alla perfezione dell'amore di Dio. Il segno che si è raggiunto l'amore di Dio sta nella facilità con cui si versano lacrime quando si pensa a lui:
Domanda: Da che cosa si può capire di aver raggiunto l'amore perfetto per Dio? Risposta: Dal fatto che il ricordo di Dio si agita nella mente, il cuore si infiamma immediatamente d'amore e gli occhi versa-
27 I,37 (pp. !78-r79l = Touraille 85 (pp. 432-433); PR 35 (p. 253).

no copiose lacrime. Giacché l'amore è avvezzo alle calde lacrime quando gli tornano alla mente le persone amate. Chi si trova in questo stato non sarà mai privo di lacrime, perché non gli mancherà mai ciò che gli riconduce alla mente il pensiero di Dio; persino nel sonno egli parla con Dio. Poichè l'amore è avvezzo a produrre tali cose, che costituiranno la pienezza degli uomini nella vita futura 28 .
Isacco rammenta spesso che le lacrime della compunzione dovrebbero accompagnare la preghiera, specialmente durante la lettura dei salmi:
Le lacrime che scorrono durante la preghiera, la dolcezza dei versetti [dei salmi] che si riversa sul cuore e lo intenerisce, la lingua che si impegna a ripeterli uno dopo l'altro, insaziabilmente e con amore, e che non può risolversi a !asciarli a causa delle delizie che vi trova, o ancora la modesta 29 gioia che di tanto in tanto sopraggiunge nel tempo della lettura o della meditazione: tutto questo, e ciò che vi assomiglia, è il sapore del soccorso della grazia di Dio, inconsapevolmente30 gustato da quanti si prodigano nella loro opera allo scopo di fortificare e far progredire l'anima verso una condizione di eccellenza, affinché essa accresca ulteriormente il loro vigore 31 •
Secondo lui le lacrime che cominciano a sgorgare durante la preghiera sono il segno che il nostro pentimento è stato accolto da Dio 32 • Quando il dono delle lacrime è concesso durante la preghiera, il diletto che ne deriva non deve essere preso per infingardaggine 33 . Le lacrime sono frequenti per chi vive nella
28 I,37 (p. r83) = Touraille 85 (p. 439); PR 35 (pp. z6r-z6z). 29 Letteralmente: "parziale". 30 Letteralmente: "senza conoscenza". 31 Centurie di conoscenza III,37· 32 Cf. I,54 (p. 269) = Touraille 33 (p. zo8); PR 53 (p. 384). " Cf. I,64 (p. 307) = PR 65 (p. 446).
quiete, "talora accompagnate dalla sofferenza, talaltra dalla meraviglia; giacché il cuore si umilia e diventa come un fragile poppante e, quando prega, le lacrime si mettono a scorrere prima ancora che abbia cominciato" 34. Secondo la testimonianza di Isacco la maggior parte dei bravi monaci del suo tempo facevano l'esperienza di queste lacrime durante la preghiera:
Dimmi, fratello mio, se esiste un uomo che sia rimasto quasi tre giorni e tre notti prostrato davanti alla croce, come alcuni nostri padri, o abbia ricevuto il dono delle lacrime durante la celebrazione dell'ufficio - quel dono di cui la maggior parte dei fratelli dallo spirito buono hanno esperienza - in quantità cosl irresistibile da renderlo incapace di portare a termine l'ufficio: pur lottando per riuscirei, sarà costretto a interrompere l'ufficio per l'abbondanza delle lacrime, e farà come chi si risveglia da un sonno profondo con tutto il corpo trasformato per cosl dire in una sorgente di lacrime che sgorgano dal s~o cu?re, provenienti dalla grazia che è in lui. Egli è irrorato d1la~n~e e la sua lingua tace per la gioia; intuizioni sorprendenti gli fanno scorrere le lacrime e rigare il viso, mentre la sua anima è rapita e ricolma di un'esperienza ineffabile35.
Possiamo dunque constatare che Isacco non considera il dono delle lacrime una cosa straordinaria, un carisma speciale di cui solo un piccolo numero sarebbe giudicato degno. Al contrario ritiene che questa esperienza sia necessaria a tutti i cristiani non solo ai monaci. '
. Ma che debbono fare quelli che per natura sono incapaci di piangere o poco inclini a farlo? Isacco risponde a questa domanda nel capitolo r8 della seconda parte. Le lacrime continue so-stiene, possono scorrere per tre ragioni: '
:; I,64 (p. )ro) = Touraille 34 (p. zr3); PR 65 (p. 45r). II,r4,46.

Prima di tutto può succedere che abbondanti lacrime comincino a scorrere senza che uno lo voglia e senza che provi alcun dolore, in conseguenza dello stupore davanti a intuizioni piene di mistero, quando esse sono rivelate all'intelletto ... Oppure le lacrime nascono da un ardente amore di Dio che infiamma l'anima, che non può sostenerne più a lungo la dolcezza e le delizie senza piangere continuamente. Ancora, le lacrime possono sgorgare da un cuore profondamente prostrato 36 •
Tuttavia, se uno non conosce queste lacrime abbondanti non vuol dire che sia privo di lacrime, quanto piuttosto dell'origine stessa delle lacrime: il suo cuore non possiede le radici che le producono. In altri termini, egli non ha mai sentito il gusto dell' amore di Dio; la presenza continua a Dio non ha fatto scattare in lui la meditazione sui misteri divini ed egli non ha neppure un cuore umile (mukkaka), benché si illuda di possedere l'umiltà (makkikuta)37
•
Ecco perché, quando ci mancano le lacrime, non dobbiamo cercare scuse nella costituzione particolare della nostra natura. Poiché la vera umiltà non è una qualità naturale e si acquisisce solo attraverso la presa di coscienza della propria indegnità e il ricordo dell'umiltà del Signore, parimenti le lacrime non dipendono dalla natura ma sono conseguenza di una delle tre cause sopra menzionate:
Se non hai un cuore umile né il dolore dolce e ardente che proviene dall'amore di Dio, cioè le radici delle lacrime che diffondono una così piacevole consolazione nel cuore, non cercare scusanti in qualche paralisi dovuta alla natura o in una presunta inerzia congenita del cuore.
36 II,r8,4-6. 37 Cf. II,r8, 7·
r66
Infatti, quando vi sono umiltà di cuore e coscienza della propria indegnità
è impossibile trattenere le lacrime anche volendo, poiché zampilla spontaneamente dal cuore una fonte inesauribile grazie al sentimento di ardente e incontenibile dolore che lo pervade e alla ferita che lo strazia 38 •
Isacco distingue tuttavia le lacrime esteriori, che scorrono visibilmente, da quelle interiori, celate nel profondo del cuore:
"Entra nella tua stanza, veglia e prega Dio in segreto" (cf. Mt 6,6) si accorda con "Beati coloro che piangono" (Mt 5,4), perché proprio grazie alle lacrime e alla quiete la preuhiera diventa limpida, ed è grazie alla preghiera che coloro ~he piangono sono consolati; consolazione che le lacrime non bastano a conquistare, se non si resta soli con se stessi ... Anche senza lacrime esteriori, esistono lacrime nascoste versate nel pensiero. Colui che porta in cuore una sofferenza continua per i propri peccati, o sul cui cuore si effonde la tristezza al pensiero dell'umiliazione di nostro Signore o dei peccati degli uornini, o che fors'anche si affligge e soffre a causa delle realtà del cielo che non cessa di attendere ... un uomo del genere, che non può essere consolato da alcuna cosa terrena, che non ottiene ciò è causa della sua sofferenza, non può essere altro che un continuo "piangente" 39 , giacché anche in assenza di lacrime materiali egli piange nel segreto [del suo cuore]. A colui che possiede uno di questi [motivi per piangere] si applica il detto "Beati quelli che piangono, perché saranno consolati" (Mt 5A)4o.
38 II,r8,I4-I5. 39
Gioco di parole su abi!a che significa sia "piangente" che "monaco". 4° Centurie di conoscenza IV, 74·

Non è dunque sempre necessario piangere fisicamente, poiché l'asceta può piangere di continuo nel suo cuore; l'importante è che resti un "piangente", quali che siano le sue lacrime: fisiche o interiori, lacrime amare del pentimento o lacrime dolci della compunzione. Ecco perché non sempre !sacco le distingue; esse sono piuttosto due facce di una stessa medaglia, due aspetti di un'unica e identica esperienza. Le lacrime della compunzione, che nascono da un'intuizione mistica dell'amore di Dio e da un profondo sentimento di umiltà, sono lacrime gioiose. Esse tuttavia al tempo stesso si accompagnano al pentimento, alla coscienza di essere peccatori, al "dolore ardente" e a un cuore frantumato.
VI UNA SCUOLA DI PREGHIERA
Come nulla può essere paragonato a Dio, così non c'è né servizio né opera che possano essere paragonati alla conversazione con Dio nella quiete.
Il,JO, I
Il tema della preghiera è quello più spesso evocato da !sacco e più approfonditamente sviluppato. Chi legge le sue opere non solo è in grado di farsi un'idea precisa del modo in cui pregavano !sacco e i fedeli della chiesa d'oriente di quel tempo, ma dispone per giunta di una descrizione dettagliata riguardo alla teoria e alla prassi della preghiera secondo la tradizione cristiano-orientale nel suo insieme. Per questi motivi gli scritti di !sacco sono stati una scuola di preghiera per i suoi contemporanei e lo sono rimasti per molti cristiani nelle diverse regioni del mondo in cui si continua a leggerli e a metterne in pratica i consigli.
Per facilitare la presentazione del suo insegnamento sulla preghiera occorre enuclearne i temi più specifici. Dopo aver dato uno sguardo d'insieme alla sua teoria della preghiera ne studieremo alcuni aspetti esteriori. Parleremo quindi della preghiera di fronte alla croce, e questo ci darà l'opportunità di evidenziarne l'importanza per i cristiani siriaci. La lectio quotidiana e le veglie notturne saranno analizzate in quanto elementi importan-

Non è dunque sempre necess~rio piangere fisican;:nte, poiché l'asceta può piangere di contmuo nel suo cuore; l1~port~~te è che resti un "piangente", quali che siano le sue lac~1me: flSl~ che 0 interiori, lacrime amare del pentimento o lacnme :fo!Cl della compunzione. Ecco perché non sempre Isacco le _d1stmgue; esse sono piuttosto due facce :fi una stessa _medaglia, due aspetti di un'unica e identica espenenza. Le lacnme della com~ punzione, che nascono da un'intui~ion: ~istica dell:amo~e .d1 Dio e da un profondo sentimento d1 umilta, sono lacnme ~1o1ose. Esse tuttavia al tempo stesso si accompagnano al pentimento alla coscienza di essere peccatori, al "dolore ardente" e a un
' cuore frantumato.
r68
VI UNA SCUOLA DI PREGHIERA
Come nulla può essere paragonato a Dio, così non c'è né servizio né opera che possano essere paragonati alla conversazione con Dio nella quiete.
II,30,I
Il tema della preghiera è quello più spesso evocato da Isacco e più approfonditamente sviluppato. Chi legge le sue opere non solo è in grado di farsi un'idea precisa del modo in cui pregavano Isacco e i fedeli della chiesa d'oriente di quel tempo, ma dispone per giunta di una descrizione dettagliata riguardo alla teoria e alla prassi della preghiera secondo la tradizione cristiano-orientale nel suo insieme. Per questi motivi gli scritti di Isacco sono stati una scuola di preghiera per i suoi contemporanei e lo sono rimasti per molti cristiani nelle diverse regioni del mondo in cui si continua a leggerli e a metterne in pratica i consigli.
Per facilitare la presentazione del suo insegnamento sulla preghiera occorre enuclearne i temi più specifici. Dopo aver dato uno sguardo d'insieme alla sua teoria della preghiera ne studieremo alcuni aspetti esteriori. Parleremo quindi della preghiera di fronte alla croce, e questo ci darà l'opportunità di evidenziarne l'importanza per i cristiani siriaci. La lectio quotidiana e le veglie notturne saranno analizzate in quanto elementi importan-

ti della preghiera di tutti i giorni. Dovremo inoltre sottolineare il carattere universale della preghiera secondo !sacco, come pure il suo insegnamento sulla preghiera per il prossimo, per la chiesa e per il mondo. Bisognerà poi ancora accennare alle regole concrete della preghiera. La conclusione verterà sulla meditazione e sugli stadi più elevati della preghiera, dove essa non esiste più in quanto tale ma si trasforma in contemplazione.
La preghiera
Secondo Evagrio "la preghiera è la conversazione della mente con Dio" 1 . Per I sacco la conversazione ('enyana) della mente con Dio costituisce l'attività spirituale più elevata e più importante per ogni cristiano, e non può essere paragonata a nessun' altra attività: "Proprio come nulla può essere paragonato a Dio cosl non c'è né servizio né opera che possano essere paraaon~ti alla conversazione con Dio ('enyana d- 'am alaha) nella ~uiete" 2 • Per preghiera I sacco intende l'insieme d_egli atti che accompagnano la conversazione della mente con D10:
Ogni applicazione dell'intelletto a Dio e ogni meditazione sulle cose spirituali che sia circondata di preghiera si chiama preghiera ed è compresa sotto questo nome, che si tratt~ di letture diverse, delle grida di una bocca che rende grazte a Dio, di pensieri dolorosi riguardo al Signore, di inclinazioni del corpo, di alleluia della salmodia e di tutto ciò che è alla base di un insegnamento sulla vera preghiera 3 •
1 Evagrio Pontico, Sulla preghiera 3. 2 II,JO,I. 3 I,63 (p. 303) = Touraille 35 (p. 219); PR 63 (pp. 439-440).
170
Secondo il pensiero ascetico tradizionale dei cristiani d' oriente la preghiera è la base della vita spirituale cristiana, fonte e origine di ogni bene. !sacco la definisce così:
La preghiera è rifugio ausiliatore, fonte di salvezza, tesoro di certezza, porto che salva dalla tempesta, luce per chi è nella tenebra, bastone per gli infermi, riparo contro le tentazioni, rimedio nel punto critico della malattia, scudo che protegge in guerra, freccia aguzza scoccata verso il volto del Nemico· in breve: la preghiera è ciò che permette di accedere a tutti questi beni4
•
Altrove !sacco definisce la preghiera come "la libertà della mente, la sospensione di tutto ciò che appartiene alla terra e un cuore il cui sguardo è interamente rivolto al desiderio ardente che accompagna la speranza delle cose a venire" 5 . Un altro passo presenta la preghiera come un'attività che rende lo spirito dell'uomo simile a Dio:
Nulla è tanto amato da Dio e onorato dagli angeli, nulla umilia tanto Satana e incute terrore ai demoni, fa tremare il peccato, fa scaturire la conoscenza, attira la misericordia, cancella i peccati, conquista l'umiltà, rende sapiente il cuore, procura consolazioni e unifica l'intelletto, nulla produce tutti questi effetti così pienamente come un solita_rio inginocchiato per terra e dedito alla preghiera continua. E quello il porto della conversione che tanti pensieri di pentimento mescolati alle lacrime ardentemente desiderano. Essa è il tesoro della forza, il lavacro del cuore, il sentiero della purezza, la via delle rivelazioni e la scala dell'intelletto. Essa rende la mente simile a Dio e attraverso i suoi slanci gli fa il dono di riceverlo, come se fosse già nelle realtà futuré.
4 I,8 (p. 68) = Touraille 21 (p. 144); PR 8 (p. 105). 5 I, 71 (p. 345) = Touraille 81 (pp. 395-396); PR 74 (p. 508). 6 Centurie di conoscenza IV .3 r.
171

Nell'ora della preghiera, quando la mente è raccolta e tutti i sensi sono stati ricondotti all'armonia, si produce un incontro tra Dio e l'arante. "Perché tutte le rivelazioni di Dio ai santi giungono nel momento della preghiera?", si chiede I sacco, e risponde: "Perché nessun tempo come quello della preghiera è fatto per la santità" 7 • Ecco perché tutti i doni spirituali e tutte le visioni mistiche furono accordate ai santi durante le loro preghiere. Fu allora che un angelo apparve a Zaccaria per annunciargli il concepimento di Giovanni il Battista (cf. Le r,rr ss.); fu durante la preghiera dell'ora sesta che Pietro ricevette una visione da parte di Dio (cf. At ro,9 ss.), e l'angelo apparve a Cornelio mentre era raccolto in preghiera (cf. At ro,3 ss.).
Quando una volta all'anno il sommo sacerdote nell'ora tremenda della preghiera penetrava nel Santo dei Santi e si prostrava faccia a terra ... sentiva gli oracoli di Dio attraverso una rivelazione impressionante e ineffabile. Che mistero terribile si celebrava in quella cerimonia! È sempre al tempo della preghiera che tutte le visioni e le rivelazioni si sono manifestate ai santi. In verità, quale tempo è altrettanto santo, quale per la sua santità cosl adatto a ricevere doni, quanto quello in cui l'uomo conversa con Dio? In quel momento, mentre formula le sue domande e le sue suppliche al cospetto di Dio e gli rivolge la parola, l'uomo si sforza di riunire tutti i moti e tutti i pensieri dell'anima per conversare solo con Dio, e allora il suo cuore è cosl abbondantemente ripieno di Dio da comprendere ciò che è impenetrabile 8.
Vediamo ora le principali condizioni poste da !sacco perché la preghiera sia vera.
La prima condizione è di pregare attentamente e senza distrazioni: le attività esteriori non dovrebbero mai distoglierci
7 Centurie di conoscenza III,84. 8 I,23 (pp. I20-I2I) = Touraille 32 (p. 202); PR 22 (pp. I7J-I74l-
172
dalla preghiera. !sacco cita l'esempio di un asceta che avrebbe detto:
Sono stupefatto quando sento parlare di monaci che eseguono un lavoro manuale nella loro cella, riescono a portare a termine le preghiere previste dalla regola senza trascurare nulla e conservano imperturbata la mente. Quanto a me, in verità ti dico che se esco a portare dell'acqua mi trovo estromesso dall'ordine naturale della mia mente e non sono più in grado di compiere le mie opere di virtù 9 .
Bisogna poi combattere i pensieri estranei alla preghiera, che provengono dal demonio e turbano la mente: "Non dipende da noi che pensieri estranei si introducano o meno nella nostra mente quando preghiamo; ma fermarsi o non fermarsi a meditare su di essi, questo sì che dipende da noi" 10 . Così dicendo !sacco si rifà all'insegnamento monastico corrente sulla vigilanza (in greco népsis), che implica un atteggiamento di attenzione tale da vigilare sull'intelletto e scacciarne ogni pensiero estraneo non appena si presenta; insegnamento già impartito con straordinaria chiarezza da Evagrio nei suoi testi sul discernimento delle passioni e dei pensieri e sulla vigilanza.
In terzo luogo, è importante evitare durante la preghiera tutto ciò che è frutto di immaginazione: ogni immagine o rappresentazione che prendesse forma nella mente costituirebbe una barriera tra l'uomo e Dio e rischierebbe di distruggere l'opera della preghiera:
Non approvare quelli che, al momento della preghiera, si fingono nella mente un'immagine sensibile e invece che nel pensiero unico, semplice e solitario che contiene l'intuizione
'I,2r (p. ro8) = PR rS (p. 146). 1° Centurie di conorcenza III,r4.
173

dell'incomprensibilità del nostro Salvatore, trovano soddisfazione nei fantasmi del loro pensiero. Al contrario, noialtri evitiamo costoro e i loro simili, ingannati come sono dalle loro stesse allucinazioni e, quando la preghiera acquista vigore, ci prepariamo attraverso un raccoglimento totale, affidando i sensi della nostra anima allo Spirito di Dio nella semplicità del cuore 11 •
In quarto luogo, bisogna pregare con umiltà. La preghiera dell'umile passa direttamente dalla sua bocca all'orecchio di Dio 12
:
Quando ti prostri davanti a Dio in preghiera, il tuo pensiero diventi come una formica, un animale che striscia, una sanguisuga, un fragile lattante che farfuglia. A Dio non dire niente che sappia di erudizione, ma avvicinati a lui con il pensiero di un bambino, e diventerai degno di quella protezione di cui i padri circondano i loro figli più piccoli 13 .
In quinto luogo, è importante pregare con sentimenti profondi e lacrime. L'afflizione del cuore unitamente alle sofferenze corporali così come le prostrazioni devono diventare parte integrante della preghiera: "Considera fallita quella preghiera in cui il corpo non soffre e il cuore non è afflitto, giacché una tale preghiera è senz' anima" 14 . E al tempo stesso !sacco cita Evagrio, per il quale "la preghiera è una gioia che rende grazie" 15
. La combinazione di cuore afflitto e gioia spirituale che nasce dal rendimento di grazie diventa una fonte di lacrime che accompagna la preghiera, particolarmente ai livelli più alti. Per !sacco, "la pienezza della preghiera è il dono delle lacrime" 16 . "Durante
11 Centurie di conoscenza II,59. 12 Cf. I,6 (p. 59)= Touraille 56 (p. 303); PR 6 (p. 93). 13 !,72 (p. 351) = Touraille 19 (p. 128); PR 77 (p. 524). 14 I,n (p. 107) = Touraille 76 (p. 383); PR 65 (p. 446). . . 15 I,8 (p. 68) = Touraille 21 (p. 144); PR 8 (p. w6). Cf. Evagno Pontlco, Sulla pre
ghiera I 5: "La preghiera è il frutto della gioia e del rendimento di grazie". 16 I,64 (p. 307) = PR 65 (p. 446).
174
la preghiera le lacrime segnalano che il pentimento dell'anima è stato giudicato degno della misericordia di Dio, che è stato accettato e che l'anima, attraverso le lacrime, ha appena fatto il suo ingresso sulle plaghe della limpida purezza" n.
In sesto luogo, è importante pregare con pazienza e ardore, due qualità che hanno a che fare con l'amore di Dio:
L'amore è il frutto della preghiera che, attraverso la sua contemplazione, attira un intelletto insaziabile verso l'oggetto dei suoi desideri, quando persevera pazientemente nella preghiera senza lasciarsi abbattere, sia che la preghiera appaia visibilmente e impegni il corpo, sia che essa si svolga con impegno e fervore attraverso le riflessioni silenziose della mente. La preghiera è la mortificazione degli impulsi del desiderio che appartengono alla vita carnale, giacché colui che prega come si deve assomiglia a chi è morto al mondo. Questo è il significato dell'espressione "rinunciare a se stessi" (cf. Mc 8,34): perseverare coraggiosamente nella preghiera1s.
In settimo luogo, ogni parola della preghiera deve sgorgare dalle profondità del cuore. Anche se sono tratte dai salmi, le parole della preghiera devono essere pronunciate come se fossero di colui che prega:
Recitando i versetti dei salmi, non fare come chi ripete le parole di un altro, per non restare completamente estraneo alla compunzione e alla gioia racchiuse nei salmi. Al contrario, recita le parole della salmodia come se fossero veramente tue in modo da formulare la tua supplica con comprensione e co~ una compunzione dotata di discernimento 19•
17 I,54 (p. 269) = Touraille 33 (p. 208); PR 53 (p. 384).
18 I,66 (p. 325) = Touraille 69 (pp. 353-354); PR 68 (p. 476).
19 !,54 (p. z69) = Touraille 33 (p. 207); PR 53 (p. 384).

!sacco tiene in grande considerazione la salmodia e sottolinea l'importanza di meditare le parole dei salmi:
Le parole sorprendenti depositate nei cantici affidati alla santa chiesa, insieme alle molte altre parole elevate che lo Spirito ha sparso in questi canti armoniosi, possono secondo alcuni prendere il posto della preghiera perfetta. A meditarle, esse fanno nascere in noi preghiere pure e intuizioni elevate e ci avvicinano alla limpidezza (shapyuta) della mente e allo stupore di fronte a Dio, e a tutto ciò che Dio userà per illuminarci con la sua sapienza al momento opportuno, quando sceglieremo versetti appropriati per offrirli al Signore con l'intento di farne una supplica, e li ripeteremo a lungo e con calma20
•
In ottavo luogo, non bisogna "preoccuparsi della quantità della preghiera, bensì mirare alla qualità" 21
• Può succedere che un solo versetto di un salmo basti ad alimentare un lungo momento di preghiera; ma in altri casi il monaco deve cambiare spesso
salmo:
Infatti, a partire da una sola parola si può prolungare una preghiera per tre notti e tre giorni. Nulla impedisce a un solitario di utilizzare per tutta la vita un solo versetto di preghiera, per l'orazione e per l'ufficio, senza sentirsi minimamente in colpa. Ma poiché, cambiando spesso salmo, disponiamo di numerosi sensi diversi grazie ai quali l'intelletto si dispone a essere colto da stupore davanti a Dio, passare frequentemente da un salmo all'altro non ci disturba affatto 22
•
Forse dicendo che un solo versetto basterebbe a nutrire la preghiera cli un'intera vita, !sacco ha in mente Paolo il Semplice, da
"II,2I,7· 21 Centurie di conoscenza II,55· 22 Ibid.
lui spesso citato 23 e che, secondo fonti monastiche 24, poté ap
prendere solo l'inizio del Salmo r, ma gli bastò a raggiungere la pienezza spirituale. Non è poi escluso che il nostro autore alluda alla pratica, diffusa tra i monaci, della preghiera continua sulla base di una breve formula come la "preghiera di Gesù", che proprio all'epoca di !sacco (vii-VIII secolo) aveva avuto un certo successo nei circoli monastici di Bisanzio. Non sappiamo se la formula bizantina della "preghiera di Gesù" fosse in uso nell'oriente siriaco, ma è certo che doveva esserci un tipo analogo di preghiera, trattandosi di una pratica universale presso i monaci.
In nono luogo, al momento della preghiera bisogna essere certi della propria assoluta fiducia in Dio 25 . Per questo non si devono chiedere a Dio i beni materiali che egli ci darebbe comunque, anche senza esserne pregato:
Presenta le tue richieste a Dio in modo confacente alla sua gloria, sicché il tuo onore sia magnificato davanti a lui ed egli si compiaccia di te ... Non chiedergli ciò che ha già deciso di darti spontaneamente ... Un figlio al padre non chiede pane, ma le cose importanti e preziose della sua casa. Ordinandoci di pregare per il pane quotidiano (cf. M t 6, r r) il Signore ha tenuto conto della debolezza di spirito dell'uomo comune, giacché a coloro che avevano una conoscenza piena e un'anima sana ha detto: "Perché vi affannate per il vestito? ... Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta" (Mt 6,28.33)26•
Coloro che hanno veramente fede in Dio non gli chiedono "donaci questo" oppure "liberaci da quest'altro", né si curano
23 Cf. per esempio I,75 (pp. 372·373) =PR So (p. s6o); II,q,20-22 (i due passi so-no citati più avanti in questo stesso capitolo).
24 Rufina, Storia dei monaci IX,2,7. "I,54 (p. 266) = Touraille 33 (p. 204); PR 53 (p. 379). 26 I,3 (pp. 23-24) = Touraille 44 (pp. 251-252); PR 3 (pp. 32-33).
I77
;
i

minimamente di se stessi, perché sentono la provvidenza paterna di Dio nella loro vita 27• Invece di chiedere a Dio: "Che cosa mi donerai?", l'anima nata libera gli chiede di il tesoro della fede nel suo cuore, "benché Dio bisogno neanche di questa preghiera" 28 •
Infine, la preghiera non è priva di con la vita con-creta di ciascuno di noi. Essa deve corrispondere al dubbara (condotta) di un monaco: "Una non si accompa-gna a una bella condotta è come un'aquila perde le pen-ne" 29 , ammonisce Isacco. Se l'arante trascura gli altri elementi dell'ascesi, la sua preghiera ne
Secondo Isacco, dunque, le caratteristiche della preghiera sono l'attenzione e la vigilanza, l'assenza di distrazioni, di pensieri estranei e immaginazioni, l'umiltà, il pentimento e le lacrime, la pazienza e il fervore, le parole affiorano dal profondo del cuore, la cura della qualità e non della quantità, la fede, l'abbandono fiducioso a Dio e uno di vita che le sia consono. Una preghiera dotata di queste qualità arriverà presto e facilmente alle orecchie di Dio.
Ma perché sembra a volte Dio tardi a rispondere alle no-stre domande o che addirittura non le esaudisca? Isacco ipotizza due ragioni. La prima è la provvidenza di Dio, grazie alla quale egli dona a ciascuno secondo la sua misura e la sua capacità di ricevere:
Non rattristarti se, quando lo supplichi, Dio indugia a rispondere: non sei più sapiente dì Dio. Questo avviene o perché non sei di ricevere ciò che chiedi, o perché le vie del tuo cuore non sono in sintonia con le tue richieste e anzi
27 Cf. !,52 (pp. 253-154) Touraille 62 (p. 329); PR 51 (pp. J6o-J6r). 28 II,8,24. 29 Centurie di conoscema III,5o.
178
contrastano con esse, o anche perché la tua misura interiore non è abbastanza matura per l'eccellenza che tu sollecitPo.
Se la nostra preghiera non viene esaudita ciò dipende anche dai nostri peccati, che d allontanano da Dio:
Se Dio è veramente pieno dì misericordia, com'è ""u''~";u<:: che non ci ascolti e non presti attenzione alla nostra ra quando, assaliti dalle tentazioni, bussiamo alla sua porta e preghiamo incessantemente? Il profeta l'ha con chia-rezza quando ha detto: "La mano del non è troppo piccola per salvarci, il suo orecchio non è così sordo da non sentirei, ma i nostri peccati ci hanno allontanato da lui, le nostre iniquità gli hanno fatto voltare il capo dall'altra parte per non sentirei" (cf. Is 59, Ricordati sempre di Dio, ed egli si ricorderà di te ogni volta che nel male 31 •
Gli aspetti esteriori della preghiera
Generalmente si pensa autori mistici mostrino scarso interesse per gli aspetti esteriori dell'ascesi e della prassi della preghiera, supponendo si concentrino sui frutti interiori di tali pratiche. Isacco il Siro fa parte della schiera relativamente nutrita di autori smentiscono questa erronea opinione. In lui troviamo molte descrizioni delle forme esteriori della preghiera in base sua prassi personale e a quella degli eremiti del suo tempo. una di queste descrizioni:
30
J1 (p. 24) Touraille 44 (p. 252); PR 3 (p. 33). (p. 46) Touraille 5 (p. 82); PR 5 (p. 70).
179

C'è chi passa la giornata intera a pregare e re, dedicandone solo una piccola parte alla lc~:lla.t.l~>Hcc terio, e così accresce in sé nel migliore dei il continuo raccoglimento in Dio. C'è poi si occupa tutta la i'\1'-'lll«L"
dei salmi, senza nemmeno rendersi conto di pregare. cora si limitano a ripetere giorno e notte molte ~;<=JllUILH .. ,,~.,Jal (sbìsut syam burke), recitando contempo le diverse parti delle ore e dell'ufficio ... Di tanto in tanto si alzano, con il cuore rasserenato, e si volgono per un attimo meditazione della Scrittura. Un altro riempirà la intera con la lettura delle Scritture, allo scopo di dimenticare questo mondo che passa e chiudere la mente a riguardante le questioni temporali e a ogni con le passioni; trovando la sua gioia nelle intuizioni ai misteri divini, meravi-gliandosi a ogni istante davanti all'economia divina, dedicherà poco tempo alla recitazione in della preghiera e della salmodia: il tempo consacrato alla lettura sarà più importante di quello consacrato alla 1-'"•n'"''"·'u
Il passo d fornisce un elenco di aspetti esteriori della preghiera: la salmodia, la lettura, le genuflessioni. Isacco tiene in grande considerazione i salmi e sostiene che proprio o:razie alla recitazione continua del salterio molti hanno raggi un-o to la gioia ineffabile "che riduce la lingua al silenzio dello stupo-re" quando li colpisce in modo sovrannaturale:
I8o
Dove sono quelli che sostengono che i salmi non sono necessari all'ufficio? Dico la verità come se parlassi davanti a Dio: conosco un uomo che è degno di tutto ciò nella sua personale tutti questi beni li ha ricevuti a partire dalla attraverso la misericordia della
e non solo una volta o due ... beni che consirivelazioni e misteri ìneffabili, nella sensazio-
ne meravigliosa delle cose del mondo a venire e di una conoscenza che trascende la natura33 .
Isacco attribuisce grande valore alle genuflessioni e alle prostrazioni, che considera tra gli esercizi spirituali più importanti, al di sopra della salmodia e delle altre pratiche
Non pensare che la prostrazione in ~,.;,..,,....,,.,,,_.,..,
davanti a Dio sia una forma di ozio, perché anzi neppure la salmodia la eguaglia in grandezza35 . Fra tutte le azioni eccel-lenti compiute dagli uomini non c'è ... Es-sa è il segno della morte al mondo e, a dell'Interprete, la via precisa del pentimento. Essa è umiltà corpo e del pensiero, fine delle suggestioni dissolvimento desideri, preparazione simbolica do [la morte] dal corpo, Dio: tutti i beni di e mondo futuro vi si trovano riuniti. Quest'opera non sembri dunque ai tuoi occhi. Se puoi, portala a senza sosta perseverando in essa e in essa sola, rinunciando a tutto il resto e a te stesso. Se le consacri la tua anima, non parlare della tua felicità in una lingua di questa terra: ti assicuro che quello che ti succederà da questo momento in sarà stupefacente e inef-fabile. Quest'opera è veramente perfetto dal mondo, o piuttosto dai comportamenti corrotti. È la fine di tutti i travagli, il debito pagato a tutti i comandamenti, e il compimento di ogni eccellenza 36 •
Isacco raccomanda di prostrarsi spesso durante la preghiera:
che la recitazione dei salmi, ama le pro-strazìoni .
CetJturie di conoscenza I,2o.

Quale che sia il momento nel quale Dio apre il tuo pensiero dall'interno, devi dedicarti a piegamenti e prostrazioni incessanti ... Nelle lotte dell'ascesi niente è più grande e più arduo e niente suscita in misura maggiore l'invidia dei demoni delle prostrazioni dinanzi alla croce di Cristo, pregando giorno e notte, le mani legate dietro la schiena come dei colpevoli37•
!sacco cita la preghiera notturna di un monaco era andato a far visita come esempio del modo in cui le prostrazioni si devono moltiplicare durante la preghiera: "Non riuscivo a contare il numero delle sue prostrazioni. E chi mai avrebbe potuto contare le prostrazioni eseguite da quel fratello ogni notte?" 38•
Accanto alle prostrazioni, un altro atteggiamento esteriore che può accompagnare la preghiera è quello di percuotere la testa al suolo. Questa pratica e altre simili sembra siano state molto diffuse non solo nella tradizione siriaca, ma nel rnonachesirno orientale in genere39 . "Piangere, percuotersi il capo durante la preghiera40, gettarsi a terra con fervore", tutto questo, secondo Isacco, "risveglia il calore ... della dolcezza all'interno del cuore che, in ammirevole rapimento, si slancia verso Dio" 41 . I sacco parla di battere il suolo con la testa "cento volte o più" 42 e sottolinea che alcune di queste pratiche possono essere appropriate per ciascun asceta al momento della preghiera, ma non c'è una regola generale che valga per tutti. Tuttavia stupisce che, secondo lui, la celebrazione giornaliera dell'ufficio nel suo insieme possa essere sostituita dal percuotere la testa:
38) = Touraille 2 3 (p. r6r); PR 4 (pp. 57-58). ro5} Touraille 75 (p. 38o); PR r8 (p. 140).
Climaco (Scala del paradiso 5,ro) menziona l'uso di battersi il petJJn:glll•c«>, mentre Simeone il Nuovo Teologo parla di percuotersi il viso e
strapparsi! (Catechesi 3o,r68-r69l-40 O anche: "battere il suolo con la testa". 41 I,r9 (p. 99) = Touraille r3 (p. rii); PR r6 (p. I}I). 42 I, n (p. ro5) = Touraille 75 (p. 38o); PR r8 (p. r4o).
r82
Le diverse opere di coloro che vivono secondo Dio sono le seguenti: c'è chi, al posto delle ore del suo ufficio, si batte tutto il giorno la testa. Altri raggruppa le preghiere fisse tutte insieme e le prolunga attraverso prostrazioni continue. Altri ancora sostituisce gli uffici con abbondanti lacrime, e tanto gli basta ... Ma un altro, che aveva poca esperienza di queste cose, si gonfiò d'orgoglio e cadde in errore43 •
Quest'ultimo cenno a coloro che si "gonfiano d'orgoglio" è un'allusione ai rnessalianì. In generale !sacco non è interessato alla polemica: egli evita, ad esempio, qualsiasi discussione su terni cristologici che possano suscitare controversie. Fanno eccezione i messali ani 4\ contro i quali troviamo nei suoi scritti diverse affermazioni polemiche. Il movimento dei rnessaliani (dal siriaco m.salyane, "quelli che pregano"), apparso nelrv secolo, si era diffuso in tutto l'oriente cristiano. rifiutavano i sacramenti della chiesa e l'ascesi perché ritenevano che l'attività rituale principale fosse la preghiera, attraverso la quale l'arante poteva raggiungere diversi stadi di estasi45 • !sacco, in quanto lui stesso autore mistico che si era dovuto spesso occupare di terni legati alle pratiche della preghiera e della vita spirituale, era sensibile a tutte le manifestazioni di falso rnisticisrno e a tutte le forme non autentiche della preghiera. Egli dunque reagl vivamente contro gli "errori dei rnessaliani".
Tra i passi antirnessaliani di suo pugno a noi pervenuti, il capitolo 14 della seconda parte occupa il primo posto. Si intitola "Sulla preghiera e le sue forme esteriori" e merita di essere studiato partitarnente, giacché contiene molte preziose indicazioni sul modo di pregare dei monaci siriaci del tempo.
u 1,6 (p. 62) Touraille 44 Cf. PR 72 (p. 495); e 47; Centurie conoscenza IV,3r.34 e passìm. 45 C. Srewart, ìVorking o/ the Heal't. Tbe Messa[ian Conti'Oversy in Hist01y,
Texts and Languages to AD 4JI, Clarendon Press, Oxford 1991, ha dato un contributo imporrante alla nostra conoscenza del messa!ianesimo.

I sacco comincia con l'affermare che nessuno ha il diritto di trascurare le forme esteriori della preghiera, anche se è evidente che la perfezione consiste nell'ottenere da Dio dei doni spirituali e la preghiera pura. In realtà, gli atteggiamenti esteriori che esprimono rispetto verso Dio aiutano a progredire interiormente verso la preghiera pura:
Chi decide di abbandonare le fasi iniziali prima di aver trovato il seguito è evidentemente preda del demonio ... Secondo l'onore che, con corpo e anima, rendiamo a Dio nella preghiera, si aprirà davanti a noi la porta dell'aiuto che ci condurrà alla purificazione dagli impulsi e all'illuminazione. Colui che durante la preghiera assume un atteggiamento rispettoso, tendendo le mani al cielo quando sta modestamente in piedi o prostrandosi faccia a terra, sarà giudicato degno di ricevere cospicue grazie dall'alto. Tutti coloro che abbelliscono continuamente la loro preghiera con tali atteggiamenti esteriori saranno giudicati degni, presto o subito, dell'attività dello Spirito santo, poiché mostrano di considerare grande il Signore ai loro occhi grazie all'onore che gli fanno con i sacrifici offerti, nei momenti stabiliti dalla legge della loro libera volontà 46
.
Isacco sottolinea che Dio non ha bisogno di segni esteriori di rispetto, ma da parte nostra ci vuole un atteggiamento rispettoso per abituarci a stare degnamente davanti a lui:
Bisogna che vi rendiate conto, fratelli miei, che Dio desidera vivamente certi atteggiamenti esteriori durante l'ufficio - gesti specifici di rispetto e forme visibili della preghiera - non già per sé ma per il nostro bene. Egli infatti non ricava alcun vantaggio da queste cose, né ci rimette nulla se le trascuriamo; esse sono però un sostegno alla debolezza della nostra
<6 II,r4,8.rr-r2.
natura. Se tali atteggiamenti esteriori non erli fossero o-raditi l. bb o o ' non l avre e egli stesso adottati al tempo della sua incarna-
zione e non ne avrebbe parlato nelle sacre Scritture. Niente pu? disonorarlo, poiché l'onore gli appartiene per natura. Ma no1, a causa delle nostre abitudini trasandate e di ocrni sorta di azioni irriguardose, assumiamo attecrcriamenti inte~iori che d' 00
lmostrano disprezzo nei suoi confronti. Così ci escludiamo dalla grazia per nostra precisa volontà, visto che siamo inclini a cadere: è allora che i demoni ci assalgono e ci ingannano senza posa; è allora che si sviluppa in noi una natura amante degli agi e pro n a alle azioni malvagie 47 •
Dopo aver così argomentato la necessità delle forme esteriori della preghiera, Isacco si scaglia direttamente contro le pratiche dei messaliani:
Molti hanno disprezzato gli aspetti esteriori della preghiera e hanno presunto che a Dio bastasse la preghiera del cuore. Supini o seduti in modo irrispettoso pretendono che conti solo il raccoglimento interiore su Dio, e non sono minimamente interessati ad abbellire lo stile visibile della loro preghiera attraverso prolungate stazioni in piedi secondo il vigore dei loro corpi, né a fare il venerando segno della croce sulle loro membra. Non gli interessa adottare, stando inginocchiati un atteggiamento interiormente ed esteriormente rispettos~, come di chi si avvicina al fuoco, né mostrare una riverenza particolare per il Signore onorandolo con tutto il corpo e mostrando un volto umile. In fatto è che non si sono resi conto del potere del loro Avversario, quindi si lasciano andare a opere false perché non hanno ancora capito che sono mortali e socrcretti a ricevere impulsi da parte della loro anima sempre incll~e alle cadute. Non si accorgono che non hanno racrcriunto lo stato d l
. 00
eg l esseri spirituali, che la resurrezione non ha avuto luocro o
47 II,I4,I3.

e non sono ancora immutabili. Essendo ancora nel corpo, in una condizione in cui la natura umana deve sforzarsi per adattarsi alle novità, hanno voluto condurre la loro vita secondo uno stato puramente spirituale, senza essere coinvolti da ciò che appariva inevitabilmente come la costrizione della vita di tutti i giorni in un mondo ancora soggetto alle passioni. "Immaginando di essere saggi, si sono comportati con disprezzo" (Rm I ,zz), nel senso che si sono manifestati in loro i segni dell'orgoglio e del disprezzo di Dio. In tal modo hanno conseguito una doppia perdita, proprio a causa della preghiera che invece è fonte di vita. Tutto ciò perché hanno creduto di poter offrire disprezzo a colui che solo è venerabile, che nessuno può disprezzare e che deve essere onorato da tutti gli
esseri creati 48.
Trascurando così le forme esteriori della preghiera i messaliani afferma !sacco si sono messi in contrasto con la tradizione , , della chiesa. Gli antichi padri non pregavano solo nel cuore, ma osservavano molte regole esteriori, prestando particolare cura all'atteggiamento del corpo durante la preghiera: "Non è esatto, come pretendono i loro detrattori, che questo numero fisso di preghiere fosse eseguito soltanto nel cuore, come vorrebbero i seguaci dei messaliani, che negano la necessità delle forme esteriori della liturgia" 49 • I santi padri, continua !sacco, pregavano con rispetto, si gettavano a terra davanti alla croce, si prostravano, abbracciavano la croce e a volte passavano ore intere in
ginocchio:
Le loro prostrazioni, grazie alle quali l'anima si manteneva umile, erano assolutamente reali. Essi le eseguivano tutte, avendo cura di alzarsi dal luogo in cui erano seduti - a meno che ne fossero impediti dalla debolezza fisica- con grande ri-
48 II,I4,I4. 49 II,r4,22.
spetto e umiltà di mente e di corpo, poggiando la faccia a terra davanti alla croce. Questi atti di adorazione erano del tutto diversi da quelli che si svolgevano nel cuore. Nondimeno, ogni volta che si alzavano eseguivano con il corpo secondo le circostanze i vari gesti di adorazione, baciando la croce cinque o dieci volte e contando ogni gesto e ogni bacio come una preghiera. Nel compiere tali gesti capitava talora di scoprire improvvisamente, all'interno di una sola preghiera, una perla che conteneva tutte le altre. Succedeva ad alcuni di essere rapiti in spirito dallo stupore della preghiera mentre stavano in piedi o in ginocchio: uno stato che non è controllato dalla volontà della carne e del sangue (cf. Gv 1,13) o dagli impulsi dell'anima. Oppure si ritrovavano in uno degli stati della preghiera pura che spiegheremo più avanti5°.
In seguito Isacco mostra più particolareggiatamente come i padri calcolassero il numero delle preghiere eseguite ogni giorno, e ci fa intendere che essi recitavano molte preghiere e facevano molte prostrazioni, ma non si alzavano dopo ognuna di esse. Si alzavano una sola volta, ripetevano le prostrazioni e, dopo averle terminate, leggevano la Scrittura, recitavano l'ufficio o pregavano con lacrime:
È così, nel modo che ho appena descritto, che i padri usavano compiere un gran numero di preghiere. Non dedicavano un tempo preciso alla stazione in piedi per ogni preghiera, come molti suppongono e alcuni pretendono, giacché il nostro fragile corpo non reggerebbe ad alzarsi ogni volta a ogni nuova preghiera. Il conto delle preghiere non avrebbe mai fine se davvero ci si dovesse alzare dalla sedia un centinaio di volte al giorno, o cinquanta o sessanta- per non dire trecento, com'era costume di certi santi -, cosa che non lascerebbe spazio alla lettura o alle altre osservanze richieste. Inoltre non ci sa-
50 II,I4,24.

rebbe stata neppure la possibilità di prolungare la preghiera se nel corso di essa, poniamo, la grazia avesse accordato il dono
lacrime, né dì permettere agli impulsi limpidi di farla durare, come nel caso di quelli che sono giudicati degni di tale In luogo di tutto ciò, l'ufficio di una tale persona sa
stato tormentato, ed essa stessa sarebbe stata piena di turbamento durante tutto il suo servizio51
.
!sacco al lettore di provare lui stesso questi diversi modi pregare, per constatare di persona l'impossibilità di eseguire cento o più preghiere alzandosi in piedi a ciascuna di esse:
faccia egli stesso la prova e veda se è catranquillamente dalla propria sedia cinquanta
per non dire cento o duecento -, evitando interiore e mantenendo tranquilla la sua pre-
nello stesso tempo al suo ufficio e alla delle Scritture che da sola costituisce una
della preghiera - e di mantenersi tutto il alcuna. Provi a mettere in pratica tut
per non dire tutta la vita52•
La ragione di Isacco su questi consigli pratici è che, al contrario dei messaliani, egli vuole lasciare ai suoi discepoli un manuale dettagliato di preghiera. I messaliani infatti, dice Isacco, rifiutano non solo le forme esteriori della preghiera, ma anche i sacramenti della chiesa e la lettura delle Scritture. Questa rottura con la li ha condotti all'errore spirituale, all'orgoglio e
All'origine deviazioni non c'è la preghiera continua, né l'omissione di certi se convenientemente motivata.
n Il,I4,25. 52 II, I4,26.
r88
Non bisogna fare della preghiera, fonte di vita, e delle fatiche che essa comporta, una causa di errore. Questo tuttavia succede quando si abbandonano le sue venerabili forme esteriori, dedicandosi invece a regole e costumi particolari stabiliti a capriccio, e ci si priva completamente dei santi misteri, sprezzandoli e facendosene gioco, per arrivare a rifiutare la luce delle sacre Scritture trascurando i precetti e le parole dei padri che ci hanno insegnato le trappole dei demoni. Cosi alcuni abbandonarono i gestì di umiltà, le genuflessioni, le continue prostrazioni, il cuore in pena, gli atteggiamenti sottomessi che si addicono alla preghiera, la stazione in piedi segno di modestia, le mani umilmente oiunte o tese al cielo i
b '
sensi pieni di rispetto. A tutto ciò sostituirono atteggiamenti fino a mescolare alle loro preghiere insulti contro
Dio insieme a espressioni e gesti arroganti, dimenticando così quanto è alta la natura di Dio, mentre la loro non è che polvere. Ma in tutto ciò, le parole della loro preghiera non erano diverse da dei salmi53 .
Continuando sua descrizione delle forme esteriori della preghiera, Isacco alla preghiera a braccia tese. Secondo lui questa postura il raccoglimento del pensiero e un sentimento di profonda compunzione. Egli sottolinea anche la necessità di pregare con parole proprie, convinto che questo porti a intuizioni spirituali:
Di fatti la parte delle preghiere sono composte di pa-role prese dai salmi, a idee e sentimenti dì dolore e di supplica, di e di lode, e via dicendo. Cosi talvolta, quando si sta inginocchiati con il capo reclinato o con le dita e lo rivolti al cielo, scandendo lentamente le parole si potranno sentimenti personali. A tratti il dolore e la scaturire parole

profondamente sentite; altre volte, in risposta a qualche avvenimento, esploderà una gioia che trasformerà la preghiera in lode per effetto della delizia provata dalla mente. Lo stesso si può dire dell'impulso dato dallo Spirito alla preghiera dei santi, la cui espressione comprende misteri e intuizioni ineffabili. Quando la forma esteriore della preghiera rivela qualche seono delle intuizioni che essa contiene, questo dà un'i-
" dea dei misteri e della pienezza di conoscenza che i santi ri-cevono mescolati alla loro preghiera grazie alla sapienza dello Spirito santo54 •
A pregare con parole proprie c'è il vantaggio di non dover imparare a memoria o recitare testi presi dai libri. Isacco osserva che certi santi del passato ignoravano completamente i salmi, eppure grazie alla loro umiltà le loro preghiere, contrariamente a quelle dei messaliani, giungevano a Dio:
O ci si avvicina a Dio, o si cade lontani dalla verità. Questo dipende dall'orientamento della mente e non dalle forme esteriori di ciò che è stato compiuto o trascurato. Un gran numero di antichi padri - mi riferisco a certi grandi solitari -non conoscevano nemmeno i salmi. Le loro preghiere tuttavia salivano come fuoco fino a Dio, a causa della loro condotta eccellente e dell'umiltà di spirito che avevano acquisito. Le loro parole mettevano i demoni in fuga come mosche che volavano via ronzando alloro arrivo. Molti, tuttavia, usano la preghiera come scusa per la loro pigrizia e il loro orgoglio: non riuscendo ad afferrare la parte migliore (cf. Le 10,42),
perdono anche quella che tenevano in mano. Non hanno niente, e si immaginano di aver raggiunto la pienezza. Altri, facendo assegnamento sulla formazione intellettuale ricevuta, hanno presunto che essa bastasse a scoprire la vera conoscenza: appoggiandosi sulla loro cultura secolare e sulla let-
54 II,14>43·
tura ordinaria sono caduti lontano dalla verità e non hanno saputo umiliarsi per potersi rialzare55 .
Questa è l'opinione di Isacco circa le forme esteriori della preghiera 56. Egli è convinto che la preghiera, con tutti gli atteggiamenti esteriori che comporta, sia la "pienezza di ogni virtù"57. Nel contempo sa che queste forme esteriori, indipendentemente dalla loro importanza, non sono altro che sussidi per l'acquisizione della preghiera pura; quando non polemizza con i messaliani si esprime assai più cautamente sulla loro indispensabilità: ammette, per esempio, che si possa pregare seduti58 . Soprattutto a favore degli anziani e dei malati ci vogliono regole che escludano la sofferenza fisica:
Non è nostra intenzione costringere i malati e gli infermi all'osservanza della regola, non vogliamo sottoporre nessuno all'impossibile. Tutto ciò che viene compiuto con rispetto e timore, secondo quanto richiedono le circostanze, è considerato da Dio un'offerta di qualità anche se fuori dalle regole. Non solo Dio non biasima queste persone, ma accoglie le cose irrisorie e insignificanti, se fatte con buona volontà e per causa sua, allo stesso modo delle azioni vigorose e complete ... giacché Dio è buono e misericordioso e non ha l'abitudine di giudicare le debolezze di natura o le cose fatte per necessità, benché riprovevoli. Ci giudica solo quando trascuriamo ciò che siamo in grado di fare 59 .
Se le forme esteriori sono necessarie alla preghiera, la loro misura deve però essere proporzionata alle forze di ciascuno. Non
55 II,14A4· 56 Circa le forme esteriori della preghiera, si veda anche Afraat, Dimostrazioni 4;
Origene, Sulla preghiera. 57 II,14>45· 58 I,2o (p. 103) = Touraille 29 (p. 186); PR I7 (pp. 137-138). Cf. II,21,6. 59 II,14,15.

solo i fratelli anziani e infermi sono dispensati dal ripetere le prostrazioni o altri gesti esteriori, ma tutti quelli che sono affaticati dalla preghiera possono commutare le forme tradizionali in preghiere personali prolungate:
Quando sei indebolito ed esausto per lo sforzo di una salmodia recitata assiduamente secondo l'uso, e per età avanzata o debolezza di corpo non sei più in grado di sostenere ciò che prima sopportavi, allora al suo posto affaticati con le suppliche, le intercessioni e cose simili. Presenta le tue suppliche con perseveranza e serietà, formula con cura le tue domande e soffri supplicando con cuore afflitto. Renditi importuno, prolunga la tua preghiera e insisti finché la porta non ti sarà aperta, perché nostro Signore è misericordioso e ti accoglierà non a causa del tuo sforzo ma secondo l'orientamento della tua mente. Nel momento stesso in cui prolunghi la supplica, la tua anima sarà illuminata e i tuoi pensieri si infiammeranno d'amore per lui. È così che riceverai il suo soccorso nel mezzo degli sforzi stentati che il tuo corpo infiacchito può sostenere, senza avere del tutto abbandonato, nella misura del possibile, gli uffici ormai abbreviati. In questo modo non sembrerai appartenere al novero di quanti rifiutano di sottoporsi alla regola monastica- atteggiamento che sarebbe conseguenza degli attacchi del demone dell'orgoglio, come succede a quanti si illudono di non aver più bisogno di queste cose - e non finirai con il cadere a poco a poco in uno stato di fatica presunta. Non voglio qui porre dei limiti fissi di tempo; parlo solo di quello che può succedere e che di fatto succedé0 •
Si può pregare in piedi, seduti o in ginocchio, ma più importante ancora è che la preghiera sia fatta con timore di Dio:
Non ci sarebbe nulla di riprovevole se, per un tempo corrispondente alle nostre forze - e non è nemmeno necessario
60 II,2I,I·J.
che vi corrisponda - durante il quale siamo in piedi o seduti, noi vedessimo il grande stupore e la vigilanza che ci accompagnano. Essi impedirebbero al disprezzo di Dio di insinuarsi in noi all'ora in cui celebriamo il suo ufficio, o quando offriamo il sacrificio della preghiera davanti a lui. Si tratta di una questione di giudizio e di discernimento piuttosto che di limiti prefissati e di confusione, senza che tu sia troppo preoccupato della quantità delle preghiere, giacché sovente è proprio questa preoccupazione a causare turbamento interiore. Al contrario, nostro scopo è di trovare la via seguendo la quale il cuore può avvicinarsi a Dio durante l'ufficio e la preghiera; per questo infatti sei ancora soggetto alla legge dei bambini. E ancora, alla salmodia aggiungi altre cose per farne un uso particolare, e cerca di stare a volte in piedi, a volte in ginocchio, poi siediti nuovamente 61 .
Isacco giunge alla conclusione che non ci sono atteggiamenti esteriori irrinunciabili nel corso della preghiera. Chi rifiutasse intenzionalmente ogni forma esteriore rischierebbe di cadere "nell'errore dei messaliani", ma ciò non significa che non sia del tutto impossibile pregare al di fuori di queste forme. Al contrario, siamo invitati a pregare ogni momento e indipendentemente dall'atteggiamento del nostro corpo:
Ci si può dedicare a ciò restando in piedi o seduti, lavorando o passeggiando nella cella, da quando si va a dormire fino a quando si sprofonda nel sonno, in casa o in viaggio. In tal modo- ma anche quando si sta sempre in ginocchio e dovunque è possibile farlo, anche senza porsi davanti a una croce -ci si tiene segretamente occupati nel proprio cuoré2 •
6! II,2I ,4·6. 62
II,5, titolo: Cf. II,r,75: "[Prega] quando mangi, quando bevi, in piedi e seduto, andando a dormrre o lavorando, e anche in viaggio e in mezzo a una folla".
193

La preghiera di fronte alla croce
Alcuni dei passi appena citati accennano al fatto di pregare e prostrarsi davanti alla croce o di baciarla o ad altri segni del rispetto particolare le è dovuto da parte di un cristiano. Le frequenti allusioni di Isacco alla croce e al crocifisso si spiegano con il ruolo eccezionale rivestito dalla santa croce nella cristianità di lingua siriaca. All'epoca di Isacco la chiesa d'oriente non aveva una tradizione significativa in fatto di pittura di icone: benché ve ne fossero esistiti vari tipi fin dalla remota antichità63, il culto della croce era molto più diffuso. La chiesa d'oriente aveva per la croce, in quanto simbolo della redenzione del genere umano e della presenza invisibile di Dio, una grande devozione e venerazione liturgica. In questo campo l'insegnamento di Isacco è del massimo interesse, giacché ci permette di entrare in contatto con l'antica tradizione dell'oriente siriaco e di constatare direttamente l'importanza della croce nella vita spirituale dei suoi contemporanei.
Il suo insegnamento sulla croce come simbolo dell'economia divina e oggetto di venerazione religiosa si trova nel capitolo I I
della seconda parte, cosl intitolato: "Sulla contemplazione del mistero della croce e sulla forza che essa procura invisibilmente sotto forma visibile; e intorno ai grandi misteri del governo di Dio tra gli antichi e al modo in cui tali misteri sono stati ricapitolati in Cristo nostro Signore, e come la croce onnipotente con-
63 Sul tema della venerazione delle icone nelle chiese di tradizione siriaca, si veda S. Brock, "lconoclasm and the Monophysites", in Ico11oclasm. Papers Givetl at the Ni11th Spri11g Symposium o/ Byza11ti11e Studies, University of Birmingham, Birmingham 1977, pp. 53·58; M. Mundell, "Monophysite Church Decoration", ibid., pp. 59-74; J. Dauvillier, "Quelques témoignages li~téraires et archéologiques sur la présence et sur le culte cles images dans l'ancienne Eglise chaldéenne", in.L'Orie11t syriett r,3 (1956), pp. 297-304; E. Delly, "Le culte cles saintes images dans l'Eglise syrienne-orientale", i bi d. r,r (1956), pp. 29r-296.
I94
teng~ tu:te _que~te. cose contemporaneamente". Già l'incipit contlene 1nd1caz10n1 abbastanza esplicite sul carattere universale della venerazione della croce nella tradizione siriaca:
Qual è_ il senso : il tip? di immagine che la croce rappresenta per nm, questa Immagme che, tenuta da noi in grande onore è venerata gioiosamente con amore e desiderio insaziabile l~ cui storia è conosciuta e ripetuta, per cosl dire, dall'unive~so intero?
Nel paragrafo introduttivo Isacco spiega la sua intenzione di trat~are dell'attività della potenza di Dio in diverse epoche della st?na _umana, _e del modo in cui Dio "a ogni generazione pone muab1lmen:e il_su? Nome venerabile negli oggetti corporei e, at~rav:rso d1 ess1, nvela al mondo cose stupende e degne di amm~r~~lOn~, ~large_ndo per il loro tramite grandi benefici agli uomml , e mfme d1 affrontare il tema della potenza eterna che risiede in una crocé4•
All'inizio della sua trattazione Isacco ci tiene a sottolineare che la particolare potenza contenuta nella croce non differisce da quella che operava al momento della creazione del mondo e che regge ancora l'universo conformemente alla volontà di Dio. In una croce vive precisamente la stessa potenza che già si trovava nell'arca dell'alleanza, circondata di venerazione e terrore dal popolo d'Israele:
La potenza illimitata di Dio risiede nella croce cosl come essa risiedeva, in un modo che sfugge alla nostra' comprensione, nell'arca venerata con grande onore e timore dal popolo ebraico. Essa vi co~piva miracoli e segni terribili in mezzo a persone che non SI vergognavano di invocarla con il nome di Dio65
'
64 Il,II,I-2. 65
Cf. N m ro,35·36, dove Mosè si rivolge all'arca chiamandola "Signore".
I95

cioè la trattavano con quel timore che avrebbero avuto alla vista di Dio, a causa del nome venerato di Dio che riposava su di essa. L'arca era venerata con il nome di Dio non solo dagli ebrei ma anche dai popoli stranieri loro nemici: "Guai a noi, poiché il Dio di quel popolo è oggi arrivato nel loro campo" ( r Sa m 4, 7). N o i crediamo che la forza che era insi ta nell'arca risieda oggi nella figura venerata della croce che noi teniamo in grande onore, pienamente consapevoli come siamo di percepire Dio attraverso di essa66
•
Che cosa c'era nell'arca, si chiede Isacco, per renderla così terribile e riempirla di forza e di segni? E risponde che la venerazione dell'arca era dovuta alla Shekinah (presenza) invisibile di Dio che in essa risiedeva:
Mosè e il suo popolo non si prostravano forse davanti all'arca con grande timore e tremore? E Giosuè, figlio di Nun, non è rimasto steso faccia a terra davanti a essa dal mattino fino alla sera (cf. Gs 7,6)? Non è forse in essa che si erano manifestate le rivelazioni tremende di Dio, come a voler onorare quell'oggetto nel quale la Sh~kinah di Dio risiedeva 67?
Ora, è proprio questa Shekinah che oggi risiede nella santa croce: essa ha lasciato l'arca dell'Antico Testamento ed è entrata nella croce del Nuovo Testamento 68
.
Così, l'arca dell'alleanza prefigurava la c~oce proprio come l'Antico Testamento prefigurava il Nuovo. E per questo che i miracoli degli apostoli descritti nel N uovo Testamento erano più potenti di quelli compiuti all'epoca dell'Antico:
Attraverso la forza della croce molti hanno domato animali selvatici, hanno affrontato il fuoco, camminato su distese
66 II,II,4. 67 II,II,5· 68 Cf. II,r r,s.
d'acqua, resuscitato i morti, respinto i flagelli, fatto scaturire fonti in terreni aridi e desertici, hanno dato un confine al mare, hanno ordinato a fiumi impetuosi di seguirli, hanno invertito il corso delle acque. Ma perché parlare di queste cose? Persino Satana con tutta la sua potenza è terrorizzato dall'immagine della croce, quando noi la raffiguriamo per usarla contro di lui69 .
Il culto dell'Antico Testamento con i suoi segni e i suoi miracoli non era in grado di estirpare completamente il peccato, mentre la croce ne ha annientato la forza. Essa ha annientato anche la potenza della morte:
Quanto alla morte, un tempo temuta dal genere mnano, ormai anche donne e bambini le tengono testa. Un tempo essa regnava su tutto, ma ora è diventata più arrendevole non solo ai credenti ma anche ai pagani, poiché il terrore che prima incuteva si è molto attenuato 70
•
In altri termini, la religione della croce introduce nel mondo un atteggiamento diverso di fronte alla morte, non più temuta come prima dell'era cristiana. Forse I sacco allude qui all'epoca dei martiri, quando donne e bambini affrontavano la morte? Secondo lui, la serenità ostentata dai cristiani avrebbe influenzato la visione della morte della società pagana stessa, sdrammatizzandola.
Ritornando poi all'Antico Testamento Isacco si chiede come mai a un oggetto di legno come l'arca, fabbricato da un falegname, "sia stata costantemente tributata un'adorazione piena di sacro terrore", e ciò ad onta della legge che proibiva il culto di opere fatte da mano d'uomo o di statue e immagini (cf. Es
69 II, II, 7-8. 70 II,II,8.
197

20,4-5; Lv z6,r; Dt 5,8). La ragione- risponde !sacco- è che diversamente dagli idoli pagani, la forza di Dio si era apertamente manifestata in essa e le era stato imposto il nome di Dio 71 . Parlando della venerazione della croce egli respinge l' accusa di idolatria, la stessa che a Bisanzio, nell'viii secolo, sarà mossa a quanti veneravano le icone. Diverso era il contesto della lotta iconoclastica a Bisanzio, nella quale l'argomento principale a favore dell'adorazione delle icone era l'incarnazione di Dio il Verbo che aveva reso possibile la sua rappresentazione dipinta in colori materiali, tema mai toccato da !sacco. In un senso più generale, tuttavia, la concezione di !sacco della presenza di Dio negli oggetti materiali ha molto in comune con quanto scrivevano a Bisanzio i difensori delle icone circa la presenza di Dio in esse. !sacco insiste in particolare sul fatto che, se la croce non fosse costruita "nel Nome di quell'uomo nel quale abita la divinità" 72, cioè il Verbo incarnato di Dio, allora l'accusa di idolatria sarebbe giustificata. Egli cita anche l'interpretazione dei "padri ortodossi" secondo cui la foglia di metallo posta sopra l'arca (cf. Es 25,17) sarebbe stata emblema della natura umana di Cristo 73 .
!sacco sottolinea il fatto che la presenza-Shekinah divina accompagna sempre la croce, dal momento in cui essa viene dipinta o fabbricata:
Non appena la sua immagine è dipinta su muro o tavola, o è plasmata con oro, argento o altro metallo, o è scolpita nel legno, immediatamente essa assume la forza divina che a suo tempo risiedeva nell'arca e ne è ripiena, diventando così il
71 Cf. II,rr,ro-rr. 72 II,rr,r3. 73 Cf. II,rr,r3. Isacco pensa a Narsai, Omelia sull'arca r83-r84: "Con la parola
'foglia' (.tassa, la foglia d'oro che copriva l'arca dell'alleanza), la Scrittura ci parla dell'umanità di nostro Signore".
luogo della Shekinah di Dio, in misura anche maggiore di quando essa avvolgeva l'arca 74 •
Questo passo contiene informazioni importanti circa i diversi tipi di croci in uso nella tradizione siriaca e rivela anche la fede della chiesa antica nel fatto che una croce, non appena veniva fabbricata o dipinta, diventasse fonte di santità per il popolo e luogo della presenza divina. Per questo motivo
ogniqualvolta fissiamo quest'immagine al momento della preghiera o la veneriamo a causa dell'uomo che vi fu crocifisso riceviamo la forza divina attraverso l'immagine e diventiam~ degni di aiuto, di salvezza e di beni ineffabili, in questo mondo e in quello a venire; e tutto questo ci viene attraverso la croce 75 .
Per !sacco i simboli dell'Antico Testamento erano solo figure e ombre delle realtà del Nuovo. Ecco come insiste sulla preminenza della croce rispetto ai simboli dell'Antico Testamento:
Come il ministero della nuova alleanza è più degno di onore davanti a Dio di quello dell'antica, come c'è differenza tra Mosè e il Cristo, come il compito ricevuto da Gesù è tanto più eccellente di quello assegnato a Mosè e così pure la sua gloria, allo stesso modo la figura della croce è molto più gloriosa a causa dell'onore dell'uomo che la divinità ha assunto fra noi per risiedervi, e perché la compiacenza divina per lui - divenuto realmente tempio di Dio 76 - è diversa da quella, metaforica, che Dio aveva per oggetti muti, semplici ombre di quelli che sarebbero venuti con il Cristo 77 •
74 Il,rr,r2. 75 II,rr,r3. 76 Formula cristologica tipica dei siro-orientali. 77 II,rr,rz.
1 99

Il culto dell'Antico Testamento esigeva un atteggiamento religioso e improntato al timore degli oggetti sacri. Ogni volta che il sacerdote entrava nell'arca "non osava alzare gli occhi per ispezionarla, perché vi aleggiava la tremenda Shekinah della divinità". Ma se già la figura è così venerabile e temibile, "ben di più dovrà esserlo l'archetipo al quale tutti i simboli e tutte le figure appartengono". Inoltre la venerazione tributata agli oggetti sacri dell'Antico Testamento era ispirata dalla paura della punizione che colpiva tutti quelli che mancavano loro di rispetto. Nel Nuovo Testamento, al contrario
la grazia è stata riversata senza misura, la severità è stata inghiottita dalla bontà ed è nata la libertà di parola (pan·besfa) ... Ora, la libertà di parola di solito scaccia la paura, grazie all'immensa bontà di Dio che ci è toccata in questo tempo78
•
Per questo, se oggi veneriamo la croce non è per paura di un castigo ma per l'amore misto a timore che portiamo a Cristo che ci ha riscattato attraverso la croce. Contemplando quella croce, i cristiani vedono Cristo in persona:
Per i veri credenti il segno della croce non è poca cosa, poiché credono che essa comprenda tutti gli altri simboli. Ogni volta che alzano gli occhi su di lei è come se contemplassero il volto di Cristo. Per questo motivo sono pieni di rispetto per la croce: vederla è per loro cosa preziosa e terribile, ma al tempo stesso teneramente amata ... Ogni volta che ci accostiamo alla croce è come se ci accostassimo al corpo di Cristo, giacché le cose per noi credenti stanno proprio così. Avvicinandoci a lui e fissando lo sguardo su di lui, immediatamente il nostro intelletto si leva misticamente in volo verso il cielo. Benché si tratti di uno sguardo che non può essere né visto né provato,
78 II,ri,I4-r6.
200
la nostra visione segreta, a partire dall'onore reso all'umanità del Signore, è come inghiottita attraverso una certa contemplazione del mistero della fede 79 •
La croce è venerata nel nome di Cristo e a causa di Cristo 80 .
In generale, tutto ciò che appartiene all'umanità di Cristo dev'essere venerato in quanto innalzato allivello di Dio, che ha voluto che l'uomo Gesù Cristo partecipasse della gloria della sua divinità. Tutto ciò è stato reso a noi manifesto a partire dalla croce, grazie alla quale abbiamo acquisito una conoscenza esatta del Creatore81 .
La croce materiale, di cui l'arca dell'alleanza era figura, diviene a sua volta figura del regno escatologico di Cristo alla fine dei tempi. In questo modo la croce è per così dire illeo-ame tra Anti-
- b
co e Nuovo Testamento, come pure fra quest'ultimo e il secolo a venire in cui simboli e figure materiali saranno tutti aboliti. Tutta l'economia di Cristo, che è cominciata all'inizio dell'Antico Testamento e si protrarrà sino alla fine del mondo, viene così a trovarsi compendiata nel simbolo della croce:
La croce infatti è la veste di Cristo, come l'umanità di Cristo è la veste della sua divinità. Ogo-i la croce serve come fio-ura
b b '
in attesa del momento in cui il vero prototipo sarà svelato e queste cose non saranno più necessarie. Giacché la divinità abita nell'umanità senza separazione, senza fine e per sempre; in altre parole, illimitatamente. Per questo motivo guardiamo alla croce come al luogo proprio della Sbekinah dell'Altissimo, al Santo dei Santi del Signore e all'oceano dei simboli dell'economia divina. Grazie all'occhio della fede la fio-ura della croce ci manifesta il simbolo appartenente ai clue T;stamenti ... Essa è inoltre il suggello finale dell'economia del
79 II,rr,r7-19. 8° Cf. II, II ,2 I. 81 Cf. II,rr,21-22. Cf. supra, p. 66, n. Sr.
20!

nostro Salvatore. Ogni volta che guardiamo la croce con animo pacificato, i ricordi dell'insieme dell'economia del Salvatore si raccolgono e si dispongono davanti ai nostri occhi interiori 82
.
11 capitolo termina con un inno di ringraziamento a Dio, che da sempre aveva l'intenzione di elargire agli uomini la vera conoscenza per mezzo della croce, simbolo materiale della sua economia:
Benedetto sia Dio, che si serve continuamente di oggetti materiali per attirarci in modo simbolico alla conoscenza della sua natura invisibile; egli semina e imprime nel nostro intelletto la reminiscenza della pena che si è dato per noi attraverso tutte le generazioni, seducendole con il suo amore e le sue ricchezze per mezzo di segni visibili. Gioiscano i nostri cuori nei misteri della fede in cui crediamo: esultiamo in Dio che tanta cura si prende di noi. Entriamo, attraverso lo sguardo della nostra mente, nell'opera mirabile che egli ha intrapreso a nostro beneficio. Rallegriamoci nella speranza di quanto ci è stato rivelato nei misteri del Nuovo Testamento e che noi, gregge di Cristo, per sua intercessione abbiamo ricevuto. Quanto dunque non dovrà essere adorato colui che, per salvarci, ha disposto ogni cosa del mondo al fine di riavvicinarci a lui? E questo ancor prima che ciò che aveva preparato per noi fosse rivelato, e che noi avessimo ricevuto benefici degni dei figli di Dio! Quanto non dovrà essere adorato il simbolo della croce, grazie al quale - grazie cioè alla potenza dalla quale tutte le cose visibili e invisibili sono state create- tutto questo ci è stato accordato e siamo stati giudicati degni della conoscenza che è propria degli angeli 83?
Questa è la "teologia della croce" sviluppata da Isacco nel capitolo I I della seconda parte della sua opera, e che si può co-
82 II, II ,24·26. 8} II,II,JI-34·
202
sì riassumere: I) la Shekinah-presenza di Dio ha sede nella croce, in cui si è installata dopo aver lasciato l'arca dell'alleanza; 2 ) l'arca dell'alleanza era una figura della croce; 3) la venerazione della croce non è idolatria a causa della presenza in essa di Cristo, e in quanto a lui rivolta e non a un oggetto materiale; 4) la croce è il simbolo del progetto di Dio sugli uomini; 5) la croce è figura delle realtà del secolo a venire, nel quale i simboli materiali saranno aboliti.
Così vediamo come, nella tradizione siriaca in generale e più particolarmente presso Isacco, la croce fosse di fatto la più importante e addirittura l'unica immagine sacra, divenuta oggetto di culto liturgico. Se nella tradizione bizantina le diverse tappe dell'economia del Cristo, come pure i grandi personaggi della storia biblica ed ecclesiastica (profeti, apostoli, santi), si sono potuti incarnare in diversi soggetti iconografici, per il cristiano siriaco questa varietà di immagini era sostituita dalla sola immagine della croce. Si tratta di una concezione ascetica che si concentra in modo esclusivo sulla croce e non ha bisogno di tante immagini dipinte. Nella tradizione siriaca tutte le preghiere convergono, per così dire, verso un unico punto che è la croce di Cristo.
Che Isacco si senta in dovere di dire che la preghiera "anche non davanti alla croce" 84 è comunque possibile, dimostra come tale procedura fosse considerata parte integrante e obbligatoria della pratica della preghiera: pregare davanti alla croce era un rito così diffuso che il fatto di non osservarlo richiedeva una giustificazione particolare.
Isacco descrive diversi modi di atteggiarsi davanti alla croce durante la preghiera, tra i quali la già menzionata prostrazione prolungata, silenziosa, talora a braccia tese. Isacco ricorda un asceta che "restò prostrato davanti alla croce, faccia a terra, tre
84 II,5, titolo.
203

giorni e tre notti" 85. Aggiunge poi che tutti gli obbli~hi della
preghiera possono essere sostituiti da questa prostraztone davanti alla croce, nei momenti di grazia abbondante:
n fatto che tu stia prostrato davanti alla croce per la maggior parte della giornata - modo di pregare che compendia in sé tutte le preghiere parziali dell'ufficio stesso - non dimostra forse che quella preghiera ha posto tutte le regole della preghiera in tuo potere? ... Chi si tiene incessantemente in contatto con Dio profondendosi in preghiere, supplicandolo continuamente prostrato a terra, con l'anima immersa nel desiderio di lui, mentre giace così faccia a terra non è sottoposto a nessun genere di legge né alle imposizioni di una regola, e tempi o momenti prefissati non hanno alcun potere su di lui, giacché semmai a questo punto egli è al di là della legge, perché si trova con Dio, senza limiti nel tempo 86
•
Secondo Isacco, dunque, starsene prostrati davanti alla croce è una forma di preghiera superiore a ogni altra poiché l.e contie~ ne tutte. Essa consiste in un'esperienza di concentraziOne e dt raccoglimento estremi che accompagnano·un sentimento intenso della presenza di Dio.
Un altro tipo di preghiera davanti alla croce consiste nell'alzare gli occhi e fissarla continuamente, e può essere eseguit~ in piedi o seduti, o anche in ginocchio a braccia tese. Isacco Cl ha lasciato la descrizione di uno che "si inginocchia quando prega e tende le mani al cielo, fissando con gli occhi la croce di Cristo e concentrando tutti i suoi pensieri in Dio" 87
• Altrove egli parla di una "intellezione di colui che è crocifisso" 88 concessa durante la preghiera davanti alla croce. Si tratta di un Cristo crocifisso
85 II,I4,46. 86 II.4.4·9· 87 I.4 (p. 39) = Touraille 23 (p. r6r); PR 4 (p. 58). 88 II,5, r6.
204
- la croce con sopra Cristo - oppure di una semplice croce senza l'immagine di Cristo, simbolo della presenza invisibile del Crocifisso? Noi propendiamo per quest'ultima interpretazione: si tratterebbe allora dello sguardo portato su Cristo presente in modo invisibile nella croce. Le immagini di Cristo in croce, cosi popolari a Bisanzio come nell'occidente latino, non sono diffuse nella tradizione siriaca. Non a caso Isacco sostiene, in un passo appena citato, che ogni volta che i credenti posano lo sguardo sulla croce è "come se vedessero" il Cristo in persona 89 ,
e questo vuol dire che essi vedono la rappresentazione di Cristo non già con gli occhi del corpo, ma con quelli dell'intelletto e del cuore.
!sacco ci segnala anche le prostrazioni davanti alla croce, vuoi in serie, vuoi una prostrazione unica ma prolungata:
Durante i periodi nei quali Dio ti guida interiormente al pentimento, moltiplica gli inchini e le genuflessioni ... Nessuna fatica è più penosa e difficile e suscita in maggior misura l'invidia dei demoni che quella di gettarsi davanti alla croce di Cristo pregando giorno e notte, a volte con le mani giunte dietro la schiena 90 •
In particolare egli accenna a serie di trenta o più prostrazioni eseguite di fila, e anche al fatto di restare prostrati davanti alla croce per tre intere giornate:
La fame, la lettura, la sobria veglia di tutta una notte, secondo le forze di ciascuno, e le numerose prostrazioni che dobbiamo eseguire di giorno e, altrettanto spesso, di notte. C'è chi si prostra trenta volte di seguito, quindi prima di ritirarsi bacia la preziosissima croce. Altri ne incrementano ulterior-
'9 II,rr,q.
90 I,56 (p. 289).
205

mente il numero, secondo la loro capacità. Altri ancora permangono tre ore nella stessa preghiera e il loro intelletto si mantiene vigile senza sforzo e, mentre giacciono prostrati faccia a terra, i loro pensieri non si sviano 91
.
Baciare ripetutamente la croce è un altro modo di venerarla. Gli antichi padri si prostravano e poi baciavano la croce cinque o dieci volte 92 . !sacco ci descrive la preghiera di un eremita presso il quale aveva passato la notte una volta che era ammalato:
Vedevo qual era l'abitudine di questo fratello, che si alzava di notte prima di tutti gli altri per dare inizio alla sua regola di preghiera. Cominciava con il recitare i salmi fino a quando improvvisamente abbandonava la regola e, prostrato sul proprio volto, batteva la testa per terra cento volte o più, con l'ardore che la grazia gli aveva acceso nel cuore. Quindi si alzava, baciava la croce del Signore, si prostrava nuovamente, baciava ancora una volta la croce, si prostrava di nuovo faccia a terra ... A volte gli capitava perfino di baciare la croce venti volte con timore e fervore e con un amore misto a rispetto, prim~ di riprendere la recitazione dei salmi93
•
Non c'è dubbio che la pratica di venerare la croce o di pregare davanti a essa fosse uno degli elementi più importanti dell'inse
gnamento di !sacco sulla preghiera.
91 I,I8 (p. 97) = Touraille 9 (p. Ioz); PR I) (p. I29). 92 Cf. II, I4,24-" I,2I (p. IO))= Touraille 75 (p. 38o); PR I8 (p. qo).
zo6
La lectio divina
Un altro elemento importante era costituito dalla recitazione di testi in spirito di preghiera, che noi chiamiamo lettura o lectio divina (qeryana). !sacco ne parla sovente e ce ne dà una descrizione. Il termine indica soprattutto, ma non esclusivamente, la lettura della Scrittura. Per !sacco, come per tutta la tradizione monastica antica, tale lettura consisteva non tanto in uno studio intellettuale del testo biblico, quanto piuttosto in un dialogo, un incontro, una rivelazione da esso ricevuta: il testo della Bibbia è un mezzo per fare esperienza diretta del dialogo con Dio, per incontrarlo misticamente e raccogliere intuizioni sulla sua realtà profonda.
!sacco parla della lettura della Scrittura come del mezzo più importante per la trasformazione spirituale che accompagna l'abbandono di una vita di peccato:
L'inizio di un cammino di vita consiste nell'occupare incessantemente l'intelletto con le parole di Dio e nel vivere in povertà ... Per bandire dalla nostra anima le tendenze alla dissolutezza che vi si sono incrostate e cacciarne i ricordi attivi che si ribellano nella carne e vi producono una fiamma inquieta, niente è più efficace che immergersi nell'amore ardente per esserne istruiti e scrutare da vicino le intuizioni profonde contenute nelle divine Scritture. Quando i pensieri di un uomo sono totalmente e deliziosamente immersi nei tesori di sapienza celati nella Scrittura, con l'aiuto delle facoltà da essa illuminate egli si getta dietro le spalle il mondo con tutto ciò che gli appartiene ... Spesso non sa neppure più come servirsi dei pensieri che visitano abitualmente la natura umana e la sua anima è rapita a causa dei nuovi incontri che affi~rano dall'oceano dei misteri della Scrittura 94.
94 I, I (pp. 3-5) = Touraille I (pp. 59-6I); PR I (pp. 2-5).
207

Nella cella, la lettura riguarda non solo la Scrittura ma anche gli scritti dogmatici e ascetici dei padri della chiesa. !sacco raccomanda entrambi:
Dobbiamo considerare lo sforzo della lettura una cosa estremamente nobile, la cui importanza non sarà mai abbastanza sottolineata. Essa è una porta attraverso la quale l'intelletto accede ai misteri divini e riceve la forza per giungere alla preghiera luminosa e immergervisi con gioia, passando in rassegna tutte le azioni compiute dall'economia divina per il bene dell'umanità. A causa di queste azioni siamo continuamente colti da stupore e riceviamo una forza che è precisamente frutto della condotta ascetica di cui stiamo parlando. La preghiera ne viene illuminata e rafforzata, sia che le letture siano tratte dalle Scritture dello Spirito santo, sia che riguardino oli scritti dei orandi dottori della chiesa che hanno per tema P economia di~ina o che insegnano i misteri della vita ascetica. Entrambi i generi sono utili all'uomo spirituale ... Senza lettura la mente non dispone di alcun mezzo per avvicinarsi a Dio: la Scrittura fa innalzare la mente e a ogni istante la orienta a Dio, la libera dal mondo corporeo e dalle sue intuizioni e la fa librare incessantemente oltre il corpo. Nessun' altra fatica consente progressi maggiori. Ecco le cose che si possono scoprire nella Scrittura, a patto di leggerla per coglierne la verità 95
•
Leggere la Scrittura, i padri e le vite dei santi, così come pregare, significa frequentare Dio. !sacco consiglia di alternare lettura e preghiera, in modo che i pensieri provenienti dalla Scrittura riempiano la mente durante la preghiera. Passando da una frequentazione all'altra, la mente si rammenta sempre di Dio:
95 II,2I,I3-I5.
zo8
Leggi spesso e avidamente gli scritti dei dottori della chiesa che trattano della provvidenza di Dio . . . Leggi anche i due Testamenti che Dio ci ha consegnato perché potessimo conoscere l'universo intero ... Per passare da una frequentazione all'altra cerca dunque di leggere libri che ti spianino le vie sottili della disciplina ascetica, della contemplazione e della vita dei santi ... E quando ti alzerai per recitare la preghiera della tua regola, invece di pensare a quello che hai visto e sentito nel mondo rifletterai nella tua mente sulle divine Scritture che hai appena letto ... Per mezzo della lettura ogni volta l'anima è di nuovo illuminata, rinnovata e aiutata a pregare senza posa e senza inquietudine 96 .
!sacco chiama la lettura "fonte della preghiera pura" 97, ma sottolinea altresì che essa deve limitarsi alla Scrittura e alla letteratura ascetica. Se il monaco è assorbito dalla lettura di numerosi libri su argomenti d'ogni sorta, la sua mente ne sarà distratta e impedita dal raggiungere lo stato della preghiera pura:
Dopo che Dio ti avrà reso degno del dono della quiete per restare seduto nella solitudine, non dovrai più dissiparti in un gran numero di libri. La limpidezza non si incontra nella molteplicità degli insegnamenti e neppure nella varietà dei libri, ma nella cura dedicata alla preghiera. Come potrebbe giovare al raccoglimento e alla purezza della preghiera la conoscenza di numerosi libri e dei loro commenti? In verità, poiché ogni solitario ha abbandonato gli usi del mondo, chi leggesse anche un solo libro, scolastico o secolare, all'infuori di quelli che trattano della vita solitaria, avrebbe mancato in anticipo lo scopo del suo cammino, perché il suo pensiero è scivolato verso la ricerca del piacere. Quand'anche questi libri ti innalzassero al cielo, non ti sarebbero d'aiuto, a meno che non in-
961,4 (pp. 33-36) = Touraille 23 (pp. I56-I59); PR 4 (pp. 48, 52-53).
97 1,64 (p. 307) = PR 65 (p. 447).
209

segnassero la condotta di vita degli stranieri 98 . Ti bastino gli scritti del Nuovo Testamento e quelli che trattano della condotta dei solitari in vista della conoscenza piena e di un pensiero limpido 99
.
!sacco ripete più volte che "non tutti i libri sono utili al raccoglimento della mente" 100, ma solo quelli che favoriscono il progresso spirituale e giovano alla preghiera. Egli raccomanda ai monaci di astenersi dalla lettura di scritti polemici, legati a determinate posizioni teologiche o religiose. In primo luogo, un asceta dovrà evitare la letteratura eterodossa: "Guardati dai libri che riassumono dottrine e credenze allo scopo di spiegarle, giacché essi più di ogni altra cosa possono fornire allo spirito di blasfemia delle armi contro di te" 101 . Forse qui !sacco allude alla letteratura polemica contro gli ebrei, molto diffusa in Siria; può anche darsi che metta in guardia contro gli scritti di "teologia comparata" che a quel tempo trattavano temi cristologici. Da asceta esperto, Isacco ritiene che tutta la letteratura di "contestazione" rischi di compromettere la mente pacata e dedita alla preghiera del solitario, suscitando in essa una foga polemica difficile da conciliare con la vocazione monastica (ed è questo che egli chiama "spirito di blasfemia").
Secondo Isacco tutta la letteratura che non appartiene al novero dei testi scritturistici o patristici dev'essere esclusa dalla lettura giornaliera dell'asceta:
98 Altro nome per i monaci, poiché vivono come stranieri sulla terra; per l'insegnamento di Isacco su aksnayutafxeniteia si veda il capitolo "La via del solitario" (supra, pp. 73-ro6).
., Centurie di conoscenza IV,72. 100 !,64 (p. 307) ~ PR 65 (p. 446). . . . lol l,4 (p. 33) ~ Touraille 23 (p. r56); PR 4 (p. 48). A.]. Wensmck, Mystzc 1ì·eatrs~s,
p. 34, traduce così quest? passo: "Sii prudente nell~gge_re ~bri c?e a~centu_ano le differenze tra le confessiom allo scopo d1 provocare sc1sm1, g1acche ess1 forruscono allo spirito della calunnia armi potenti contro di te". Può darsi che sia un'allusi?n.e a?~ letteratura polemica contro gli ebrei o, più probabilmente, alla letteratura anttdioflSlta (o antimonofisita).
210
Gli altri libri, quali che siano, lo danneggeranno, gettando tenebre nella sua mente e offuscando il suo proposito che si trova presso Dio; sono letture atte a generare in lui oscurità e indolenza al momento dell'ufficio e della preghiera 102 •
Né le opere didascaliche sulla retorica e la filosofia (''ciò che ti introduce alle discussioni sulle parole o all'apprendistato della saggezza di questo mondo"), né i libri di storia della chiesa (''che ti informano su avvenimenti e conflitti all'interno della chiesa"), né le cronache di storia profana (''sulle leggi e le gesta degli imperatori, le loro vittorie e le loro imprese"), né, ancora una volta, la letteratura polemica ("le parole polemiche aventi lo scopo di dimostrare questa o quella opinione"), nulla di tutto ciò è utile ai solitari; dice I sacco, non senza ironia:
Questo genere di letture, !asciamole a coloro che godono di buona salute; ma quanto a noi sofferenti, noi abbiamo bisogno di medicine, vale a dire di testi redatti per la guarigione dalle nostre passioni, e di vite di santi vissuti prima di noi - giacché hanno vissuto la vita solitaria che è più elevata di quella nel mondo- come pure di resoconti delle rivelazioni di cui sono stati giudicati degni e degli insegnamenti che hanno ricevuto da Dio circa il loro genere di vita solitaria, delle passioni e delle battaglie combattute per l'istruzione loro personale e di quanti camminano sllile loro tracce, e dei racconti di vittorie e sconfitte, cadute e resurrezioni che hanno dovuto subire. In una parola, occupiamoci solo dei libri che hanno a che fare con la vita monastica e ce ne descrivono l'organizzazione e le forme esteriori 103 •
Ma oltre alla letteratura secolare, ci sono anche le opere patristiche sul dogma che non sempre giovano a chi non ha una men-
102 II,2 I,I4.
103 II,IA5·
2II

te purificata dalle passioni. Ad alcuni si devono consigliare solo opere ascetiche:
Ci sono persone alle quali neppure la lettura delle azioni dell'economia divina sarà giovevole, perché non ne trarrebbero alcun beneficio: la maggior parte di loro ne avrebbe la mente ancor più oscurata, giacché ha molto più bisogno di letture che insegnino a raddrizzare le passioni. Ciascuno riceve vantaggio e progredisce nella misura in cui le sue letture sono appropriate allo stadio in cui si trova 104 .
Quest'ultima frase riflette una concezione comune presso gli antichi monaci, e cioè che la sola ragion d'essere della lettura consista nel miglioramento che se ne può ricavare. Da un monaco non ci si aspetta una grande cultura ma una mente pura; ne deriva il consiglio:
Il corso delle tue letture corrisponda al fine del tuo tipo di vita ... La maggior parte dei libri che contengono insegnamenti non sono utili alla purificazione, e la lettura di molti e svariati libri causerà distrazioni alla mente. Sappi che non tutti i libri che istruiscono nella religione sono utili alla purificazione della coscienza e al raccoglimento dei pensieril05 .
Il consiglio di astenersi non solo dai libri secolari ma anche dalla letteratura dogmatica può sembrare una forma di oscurantismo da parte di Isacco. Noi però non pensiamo che Isacco voglia dire che un monaco non ha bisogno di conoscere con chiarezza e precisione la dottrina cristiana. Nel passo appena citato egli intende soprattutto ricordare allettare una massima monastica affatto tradizionale, cioè che le letture devono corrispon-
104 II,2r,r6. 10
' !,64 (p. 307) = PR 6:; (pp. 446-447).
2I2
dere alla vita. È probabile inoltre che Isacco pensasse ai conflitti cristologici quali lui e i suoi contemporanei erano continuamente invischiati, ed è in tale contesto che va intesa la sua messa in guardia contro le letture di argomento dogmatico. Egli non voleva che i monaci fossero coinvolti in dispute teologiche, an-
se riguardanti la verità o la vera fede. "Chi ha gustato la verità non si mette a disputare sulla verità ... e non s'infiamma nemmeno quando si tratta della fede" 106• Per Isacco la vera fede non viene dai libri ma dall'esperienza; essa nasce dalla purificazione più che dalle letture 107
•
Vediamo ora qualche consiglio di Isacco sul modo di leggere la Scrittura. La prima condizione per ogni lettura fatta in cella sarà il silenzio, la quiete: "Persevera nella lettura mentre ti trovi nella quiete, affinché il tuo intelletto sia attratto a ogni istante verso la meraviglia e lo stupore" 108
• "Che la tua lettura si svolga in una quiete che nulla venga a turbare" 109 • La seconda condizione è il raccoglimento della mente e l'assenza di pensieri provenienti dall'esterno:
Liberati da ogni preoccupazione riguardante il corpo e i grattacapi degli affari, affinché, attraverso la dolce comprensione del senso delle Scritture che sorpassa ogni altra sensazione, tu possa gustarne nell'anima il dolcissimo sapore110 .
La terza condizione è di pregare prima di cominciare a leggere:
Non accostarti alle parole dei misteri contenuti nelle divine Scritture senza pregare e supplicare Dio di aiutarti, ma di':
106 Centurie di corwscem:a IV,77. 107 Per la sua concezione della fede si veda il paragrafo "Fede e sapere" (ìnfra, pp.
305'319). w• 1,4 (p. 31) = Touraille 23 (p. 153); PR 4 (p. 43). 109 !,4 (p. 34) = Touraille 23 (p. 156); PR 4 {p. 48). 110 1,4 (p. 34) = Touraille 23 (p. r56l; PR 4 (pp. 48-49).
213

"Signore, concedimi di sentire la forza che esse contengono!". Considera la preghiera come la chiave di una vera comprensione della divina Scrittura 111
.
La comprensione del senso interiore e nascosto della Scrittura è il fine principale della lettura. Qui non si tratta dell'esegesi allegorica del testo, che godeva di scarso favore nella tradizione siro-orientale anche se !sacco talvolta la pratica, ma piuttosto di intuizioni (sukkala) mistiche relative al senso spirituale di parole o frasi della Scrittura, che si producono nella mente dell'asceta quando legge in raccoglimento e con grande attenzione. Queste intuizioni sono un raggio di sole che illumina improvvisamente
la mente del lettore:
Non scrutinare cÒn pedanteria parole che, scritte sulla base dell'esperienza, hanno l'intento di sostenere il tuo genere di vita e aiutarti con le loro elevate intuizioni a elevare te stesso. Scopri l'intenzione soggiacente a ogni passo delle Scritture che incontri, per immergerti più profondamente in esso e sondare le intuizioni profonde negli scritti di uomini che ricevettero l'illuminazione. Coloro che nel loro genere di vita sono condotti dalla grazia divina a ricevere l'illuminazione si accorgono sempre di qualcosa di simile a un raggio spirituale che passa attraverso le righe e le rende capaci di distinguere le parole dette in modo ordinario da quelle importanti per l'illuminazione dell'anima. Chi legge in modo ordinario righe che contengono un significato importante rende ordinario anche il suo cuore e lo priva di quella potenza santa che può procurargli un sapore dolcissimo, attraverso intuizioni che immobilizzano l'anima nello stupore. Ogni cosa abitualmente segue ciò che è proprio della sua specie; così l'anima che ha ricevuto una partecipazione dello Spirito e sente una frase in cui si nasconde una potenza spirituale, la tiene ardentemente per sé.
111 I,48 (p. 233) = Touraille 73 (p. 372); PR 45 (p. 329).
214
Il mondo intero non è abbastanza sveglio per stupirsi di ciò che è detto spiritualmente e cela una grande potenza 112.
Questo passo si può considerare il credo di !sacco circa il modo di comprendere la Scrittura. Egli distingue da una parte "le parole dette in modo ordinario", che non parlano né al cuore né alla mente, dall'altra "ciò che è detto spiritualmente" e si rivolge direttamente all'anima del lettore. Questa distinzione non significa che la Scrittura contenga contemporaneamente parole significative e parole insignificanti, ma piuttosto che non tutte le parole della Scrittura sono ugualmente importanti per tutti i lettori. I sacco pone qui l'accento sull'atteggiamento soggettivo del lettore: ci sono parole e frasi che lo lasciano freddo e indifferente, altre che lo infiammano al fuoco dell'amore divino. È importante non lasciar passare inosservati quei versetti della Scrittura che sono "pieni di senso", per non restare privati delle intuizioni spirituali che essi contengono.
Quando un monaco legge la Scrittura cercando di afferrarne il contenuto nascosto, la sua comprensione aumenta in proporzione alla lettura e lo conduce per gradi a uno stato di stupore spirituale, raggiunto il quale egli si trova completamente immerso in Dio:
[L'asceta] che si dedica allo studio delle divine Scritture ricercandone il senso avrà certamente tregua dalle passioni. I pensieri vani, infatti, si affrettano ad abbandonarlo a causa della comprensione delle Scritture divine che in lui risiede e diventa sempre maggiore, giacché la sua mente non può più staccarsi dal grande desiderio delle Scritture e dal raccoali-
" mento su di esse. Allo stesso modo l'asceta diventa incapace di prestare attenzione alle cose di questa vita a causa della grande dolcezza della continua riflessione sulle Scritture che
112 I,r (pp. 6-7) = Touraille r (pp. 62-63); PR r (pp. 6-7).
215

lo esalta nella quiete profonda del deserto. Così egli arriva a dimenticare se stesso e la propria natura umana, diventando come un invasato che non conserva più alcuna memoria del tempo presente. Si sofferma a riflettere con impegno particolare su ciò che riguarda la maestà di Dio, dicendo: "Gloria alla sua divinità!", o anche: "Gloria alle sue opere meravigliose!". Così, assorto in queste meraviglie e incessantemente colto da stupore, l'asceta è sempre in stato di ebbrezza, quasi vivesse la vita successiva alla resurrezione113 .
L'insegnamento di Isacco sulla lettura delle Scritture è contenuto specialmente nel capitolo 29 della seconda parte, così intitolato: "Circa i grandi benefici che nascono dalla frequentazione delle Scritture, e sul ministero nascosto, la meditazione e la continua ricerca che essa implica, come pure sulla ricerca della materia da essa insegnata; e contro le persone che accusano quanti si applicano con zelo a questa ammirabile e divina fatica" 114 • Si tratta di un testo a carattere polemico, benché non esprima una reazione a un'eresia specifica come quella dei messaliani. Qui Isacco combatte un'opinione allora molto diffusa negli ambienti monastici, secondo la quale la lettura dei libri è inutile e solo
li d 11 . h ' . h' 115 que a e e opere ascet1c e e ne lesta a un monaco . Contro costoro Isacco afferma che considerare l'ascesi e la fa
tica corporea più elevate della lettura è sbagliato e fuorviante. La fatica corporea costituisce "la via e la regola per la gente che è nel mondo", ma per i monaci è molto più importante avere la mente sempre colma del pensiero dell'economia divina, il che costituisce "l'attività perfetta e la summa dei comandamenti di nostro Signore". Colui il cui raccoglimento è continuamente prigioniero del Signore grazie alla lettura e alla preghiera "ha
113 I,37 (p. 179) = Touraille 85 (p. 434); PR 35 (p. 254). 114 II,29, titolo. 115 Cf. II,29,r.
zr6
piantato in sé tutte le opere eccellenti" e "le ha condotte a pieno compimento, senza che niente facesse loro difetto" 116 .
La lettura è la fonte della preghiera, continua Isacco. Grazie alla lettura e alla preghiera "siamo trasportati verso l'amore di Dio la cui dolcezza si espande incessantemente nei nostri cuori come il miele nel favo, e le nostre anime esultano al sapore che il servizio nascosto della preghiera e della lettura delle Scritture riversa nel nostro cuore". In seguito alla lettura e alla preghiera e all'amore di Dio che da esse promana, il cuore dei lettori si infiamma e rimane in conversazione costante con Dio, e il loro intelletto "fa schiudere un simbolo particolare della verità, risultato delle delizie continue che provengono da queste parole importanti con le quali essi si danno pena notte e giorno". La ricerca dei sensi spirituali nelle parole della Scrittura li conduce a uno stato di profonda gioia interiore:
Cosa c'è di più di. grande che gioire continuamente in Dio lodandolo a ogni istante con un nuovo canto di lode (cf. Sal 33,3; 40,4; 96,r ... ) scaturito dallo stupore dell'anima in letizia, contemporaneamente a molte altre cose che nascono dalla stessa fonte, come la preghiera che zampilla improvvisamente, perennemente e spontaneamente dalle profondità di un cuore in cerca della contemplazione117?
Isacco denuncia poi quelli che leggono la Scrittura unicamente allo scopo "di ricavarne materia di gloria umana, o per rendere la mente più acuta". La Scrittura dev'essere letta solo "a causa della verità": allora soltanto la mente del lettore
abita continuamente in cielo, conversando a ogni istante con Dio, e i suoi pensieri navigano verso il mondo a venire cui
u• II,29,2·3· 117 II,29,5·9. In tale contesto il termine "contemplazione" (te'o1ya) può riguardare il
"significato spirituale" di certi passi della Scrittura.
2!7

anelano ... La sua mente medita sulla speranza futura e, nel corso della sua vita, non sceglie altro compito né fatica né servizio che sia più grande di questa sola occupazione 118
•
Giunto a questo stadio l'uomo è come un angelo che non pensa più ad altro che a Dio e alle cose di Dio.
Queste citazioni bastano a mostrare l'estrema importanza agli occhi di Isacco della lettura delle Scritture e dei padri, e a stabilire che la lectio faceva parte della sua concezione della preghiera. Bisogna ricordare che nell'antichità cristiana, e più in particolare nella pratica dei monaci, la lettura, anche solitaria, non si faceva solo con gli occhi bensì ad alta voce. La Scrittura veniva letta lentamente, con molte pause, e ogni frase o parola era oggetto di meditazione. Questo modo particolare di "coltivare" la lettura è oggi praticamente scomparso, poiché è spesso necessario assorbire un numero imponente di parole senza grande interesse, e leggere di tr~verso e affrettatamente dozzine e perfino centinaia di pagine. E ovvio però che la "lettura pregata" consigliata da Isacco, cioè una lettura che investe il massimo possibile di attenzione su ogni singola parola, resta la forma ideale per chi vuol penetrare il significato spirituale delle sante Scritture. L'esperienza e le raccomandazioni di !sacco mantengono qui tutto il loro valore.
Ad onta del suo grande amore per la lettura, specialmente della Bibbia, !sacco tuttavia ammette che possa esistere uno stato spirituale nel quale nessuna lettura è più necessaria:
Chi non ha ancora ricevuto il Paraclito ha bisogno di opera d'inchiostro per imprimere il ricordo del bene nel suo cuore, applicarsi senza sosta al bene attraverso la lettura continua e proteggere l'anima dalle vie insidiose del peccato. Egli infatti non ha ancora acquisito la potenza dello Spirito che scaccia
118 II,29,I0-I2.
218
l'illusione capace di far prigionieri i pensieri che giovano all'anima e di raffreddare gli animi con le distrazioni dell'intelletto. Quando la potenza dello Spirito penetra le potenze spirituali di un'anima attiva, sono i suoi comandamenti non le leggi scritte con l 'inchiostro, a mettere radici nel suo ;uore. A questo punto l 'uomo è ormai segretamente istruito dallo Spirito e può fare a meno dell'aiuto delle cose sensibili119 •
!sacco non è stato l 'unico a mettere in luce la priorità dell'esperienza spirituale interiore rispetto a tutte le sue espressioni formali ed esteriori, compresa la lettura della Scrittura e dei testi ascetici: si tratta infatti di un tema fra i più caratteristici della letteratura monastica e agiografica 120 . Agli occhi di I sacco importa non tanto il testo che viene letto quanto le intuizioni spirituali e mistiche che se ne possono trarre. Quando la lettura è un mezzo per frequentare Dio, essa conduce là dove la mente, cessata ogni attività umana, entra in contatto diretto con Dio.
La preghiera notturna
La preghiera notturna appartiene alla grande tradizione cristiana, sia nella prassi liturgica generale 121 sia, più specificamente, in quella della preghiera monastica. Quando gli autori spirituali raccomandano ai monaci le veglie, insistono sul fatto che l'intera creazione si trova in quel momento immersa nel sonno e
119 I,6 (p. 58)= Touraille 56 (p. 302); PR 6 (p. 9r). 120 La Vita di Maria Egiziaca narra di una donna che si ritirò nel deserto senza aver let
to neanche ~n~ parola de~a Scrittura ma che, dopo molti anni di rigorosa vita ascetica, e:a capace d1 c1tare la Scnttura a memoria, essendo stata istruita direttamente dallo Spinto santo. Cf. anche la storia di Paolo il Semplice, in Rufina Storia dei monaci IX 2 7.
121 Si pensi ad esempio alle veglie notturne ancor oogi (enute in gran conto ~;lla chiesa ortodossa. "
219

quindi nulla potrà distrarre l'asceta. La notte diventa cosl il periodo più propizio alla preghiera. Ascoltiamo !sacco in proposito: "Che ogni preghiera offerta durante la notte sia più preziosa ai tuoi occhi di tutte le pratiche del giorno" 122
. La veglia notturna rappresenta quell' "opera deliziosa" durante la quale "l'anima fa esperienza della vita immortale e grazie ad essa si spoglia degli abiti delle tenebre e riceve i doni dello Spirito" 123
.
!sacco sviluppa questo tema nei capitoli zo e 75 della prima parte dei suoi scritti. Il primo discorso illustra i fondamenti teorici della veglia, mentre il secondo propone soprattutto consigli pratici che fanno riferimento alla vita dei santi, ed è solo parzialmente contenuto nella recensione siro-occidentale delle opere, il che spiega perché esso sia in parte assente nella traduzione greca. Prima di tentare, sulla base del capitolo 75, una ricostruzione del modo in cui la preghiera era praticata dal monachesimo d'oriente, vediamo che cosa ci insegna !sacco nel capitolo 20
sulla preghiera notturna. Questo discorso comincia con una "lode della veglia" consi
derata come un'attività degli angeli che porta l'uomo a Dio:
O uomo, devi considerare che nessuna opera monastica è più grande della pratica della preghiera notturna . . . Il monaco che persevera nella veglia con discernimento non sembra rivestito di carne, perché questa è veramente un'opera che appartiene alla condizione angelica ... L'anima che soffre ed eccelle nella pratica della veglia avrà occhi di cherubino, per poter guardare e scrutare in ogni momento le visioni celesti 124
.
!sacco si affretta però ad aggiungere che lo sforzo delle veglie giova all'asceta solo a condizione che egli si guardi, durante il
122 1,64 (p. 308) = Touraille 34 (p. 2rr); PR 65 (p. 447). 123 1,65 (pp. 320-32r) = Touraille, Lettere 3 (pp. 46o-46r); PR 66 (p. 469). 124 1,20 (p. ror) = Touraille 29 (p. r84); PR I7 (p. r34).
220
giorno, dalla dissipazione e dalle cure secolari. In caso contrario, quando starà in piedi durante la veglia non riuscirà a raccogliere la sua mente, e la fatica rimarrà senza frutto:
O uomo, com'è possibile che tu conduca la tua vita con così poco discernimento? Stai in piedi a pregare tutta la notte e sopporti le fatiche della salmodia, degli inni e delle litanie, e poi ti sembra compito gravoso e difficile stare un po' più attento durante il giorno, soprattutto se Dio ti ha reso degno della sua grazia in virtù dello zelo che dimostri per altre fatiche! A che scopo aumenti il tuo impegno nel seminare di notte se poi quello che hai seminato lo dissipi di giorno, in modo che non possa dare frutto? ... Se tu di giorno avessi coltivato il tuo cuore con occupazioni ferventi per renderlo conforme alla meditazione della notte, senza erigere tra le due cose un muro di separazione, in breve avresti abbracciato il petto di Gesù125
•
Chi veglia su di sé durante il giorno conosce la forza delle veglie notturne. Esse da sole possono sostituire tutte le virtù: "Se uno ha un corpo così estenuato dalla malattia da non poter digiunare, la veglia da sola può dare stabilità al suo intelletto in preghiera e riversargli nel cuore l'intuizione spirituale necessaria per comprendere la natura della potenza spirituale". A chi poi non ha la forza di prostrarsi e recitare i salmi a causa di un offuscamento e un rilassamento spirituali, la veglia da sola potrà bastare, anche se resta seduto:
Se devi abbandonare queste opere [prostrazione e salmodia] perché non sei in grado di compierle, resta almeno sveglio da seduto, prega con il cuore, fa ogni sforzo possibile per trascorrere la notte senza dormire, seduto e meditando pensieri
125 1,20 (p. ro2) = Touraille 29 (p. r85); PR I7 (p. r34).
22!

buoni. Se non lasci indurire il tuo cuore, se non lo lasci offuscare dal sonno, la grazia ti restituirà quel tuo fervore originario, quella leggerezza e quella forza, e finirai con il danzare di gioia rendendo grazie a Dio 126
.
Diamo ora uno sguardo al capitolo 75 di Isacco e alle sue raccomandazioni pratiche circa le veglie. Egli comincia con il richiamare la nostra attenzione sull'inizio della preghiera notturna, che richiede secondo lui una preparazione appropriata. Bisogna dapprima prostrarsi, fare il segno della croce, restare un certo tempo in piedi e in silenzio, poi formulare una preghiera composta di parole personali:
Quando vuoi stare in piedi durante la liturgia della veglia, se Dio ti aiuta fa' come ti dico. Inginocchiati secondo l'uso, ma non dare immediatamente inizio alla liturgia. Dopo aver finito una preghiera, segna cuore e fianchi con il segno vivificante della croce resta un momento in piedi e in silenzio e aspetta che i tuoi ;ensi siano placati e i pensieri in riposo. Alza poi lo sguardo interiore sul Signore e supplicalo, con il cuore dolente, di fortificare la tua debolezza e concederti che la salmadia della tua lingua e i pensieri del tuo cuore siano graditi alla sua volontà, affidando tranquillamente alla preghiera del cuore le parole seguenti: "Signore Gesù, mio Dio, tu che contempli l'insieme della tua creazione, al quale le mie passioni, la debolezza della nostra natura e la potenza dell'Avversario appaiono evidenti, sii tu stesso il rifugio contro la malvagità del nostro comune nemico ... Proteggimi dal tumulto dei pensieri e dal traboccare delle passioni e rendimi degno di portare a compimento questa santa liturgia affinché non mi accada di auastarne la dolcezza con le mie passioni, apparendo sfron-
"' tato e temerario di fronte a te" 127
.
126 1,2o (p. 103) = Touraille 29 (p. 1S6); PR 17 (pp. 137-13S). 1211,75 (pp. 365-366) = Touraille zS (p. 1S1); PR So (pp. 546-547).
222
Isacco non ha tratto questa preghiera da qualche celebrazione liturgica: essa è composta da lui, come un gran numero di preghiere che si trovano sparse qua e là nei suoi scritti. Egli attribuiva grande importanza alla preghiera composta dalle parole dell'arante stesso e raccomandava ai cristiani di non limitarsi a recitare le preghiere prescritte dalla regola, bensì di trovare parole personali con cui rivolgersi a Dio.
Al tempo stesso, però, la veglia notturna degli asceti comportava una specie di "regola", vale a dire una successione di preghiere, inni, letture e prostrazioni obbligate ogni volta che si celebravano le vigilie. Tuttavia per Isacco questa regola non doveva comportare per forza un numero fisso di preghiere: dimorare in Dio con l'intelletto è più importante che attenersi rigidamente a un regolamento. "Dobbiamo celebrare la liturgia completamente liberi da ogni pensiero e inquietudine infantili". Isacco poi suggerisce:
Se vediamo che il tempo è poco e ci accorgiamo che l'aurora ci coglierà prima che abbiamo portato a termine la nostra liturgia, allora saltiamo volontariamente e saggiamente una marmita 128 o due di quelle abitualmente previste dalla regola, per non causare turbamento e non guastare il dolce sapore della nostra liturgia 129
.
Proprio per questo, per non perdere il gusto della veglia, non bisogna recitare i salmi affrettatamente nella speranza di far prima a completare il numero regolamentare:
Mentre celebri la liturgia, se mai un pensiero si insinuasse nella tua mente e ti suggerisse: "Accelera un po', hai molte
128 Parte del salterio. Nella tradizione siro-orientale il salterio era diviso in venti bulla/e e cinquantasette mannyata.
129 1,75 (p. 366) = Touraille 2S (p. 1S1); PR So (p. 547).
22}

cose da fare e sarai libero prima", tu ignoralo. E se questo pensiero continuasse a tormentarti, ritorna alla marmita precedente o dove vorrai, e ricanta ogni versetto per comprenderlo ... E se proprio non la smettesse di importunarti, interrompi la salmodia, inginocchiati e prega: "Io non voglio fare il conto delle parole ma raggiungere le dimore del cielo" 130 •
Un primo modo di lottare contro i pensieri consiste dunque nel recitare lentamente i salmi ripetendo ogni versetto più volte; un secondo modo nell'ignorare il numero prescritto di salmi e pregare con parole personali. Isacco continua:
Se ti senti mancare le forze per la fatica di quella lunga posizione in piedi e se il pensiero ti sussurra in un orecchio: "Ora smettila, non ce la fai più", rispondi: "No, ma vado a sedermi, che è sempre meglio che dormire. Anche se la lingua tace e non recita più salmi, la mia mente rimarrà in rapporto con Dio nella preghiera e nella presenza al suo fianco; è sempre più giovevole vegliare che dormire" 131 .
La cosa che di primo acchito d colpisce è che Isacco preveda l'eventualità di pregare seduti; ci colpisce poi anche il permesso da lui accordato di sostituire la recitazione ad alta voce con la preghiera silenziosa all'interno del proprio animo. È probabile che pregare ad alta voce fosse la pratica corrente tra gli asceti dell'epoca, mentre la preghiera mentale era ammessa solo in caso di affaticamento o durante le attività comuni che non consentivano di essere soli o infine quando si stava prostrati faccia a terra.
Isacco insegna poi che la successione dei diversi elementi all'interno della veglia notturna non è identica per tutti gli asceti.
130 I, 75 (p. 366) Touraille 2.B (p. rBz); PR Bo (p. 54 B). 131 I,75 (p. 366) Touraille 2B (p. r8z); PR So (p. 548).
224
Ci sono vari tipi di veglie e serie diverse di preghiere, come pure molti modi di favorire l'attenzione e l'umiltà. Merita poi di essere rilevato il cenno alla preghiera costituita da una breve formula132 e alla possibilità di pregare senza inginocchiarsi:
Né la preghiera né la semplice salmodia esauriscono completamente la veglia del monaco. C 'è chi passa tutta la notte salmodiando, chi a pentirsi ripetendo le preghiere di compunzione e le prostrazioni, altri ancora è impegnato in pianti, lacrime e lamentazioni sui propri peccati. Di uno dei nostri padri hanno scritto che per quarant'anni ripeté un'unica preghiera: "Ho peccato come uomo, ma tu, come Dio, perdonami"133. I padri lo sentivano meditare queste parole con compunzione e lo vedevano piangere senza mai tacere; questa preghiera faceva per lui le veci dell'ufficio, di notte come di giorno. Un altro fratello consacra una parte della sera alla salmodia e il resto della notte ai cantici134 • Un altro ancora loda Dio e legge delle marmyata, mentre tra una marmita e l'altra si illumina e si ristora leggendo la Bibbia, finché non ha ripreso lena. Altri infine si impone come regola di non piegare le ginocchia nemmeno per la preghiera conclusiva di una marmita, benché questo sia l'uso durante le vigilie, ma passa la notte intera nel continuo silenzio 135 •
Con questa allusione a Mosè l'Etiope, che pregava senza mai piegare le ginocchia, si conclude il capitolo 75 nella recensione siro-occidentale e quindi nella traduzione greca. Ma la versione originale prosegue con una descrizione della gioia spirituale che si riversa sul monaco durante le veglie:
132 La "preghiera di Gesù", largamente diffusa in tutto l'oriente bizantino, è una delle numerose forme di questa "preghiera a formula breve".
133 Abba Apollo. Cf. Palladio, Sto,ùrlausiaca 2.. 1" I "tropari" greci.
135 I,75 (pp. 366-367) = Touraille zB (pp. rB:H83); PR Bo (pp. 54B-549).

Quando i forti provano godimento e piacere durante le veglie, passano senza scoraggiarsi le lunghe ore della notte. La loro anima fiorisce, gioisce e dimentica la sua veste carnale ... La gioia e la danza del cuore non permettono loro di pensare al sonno, perché hanno l'impressione di essersi spogliati del corpo e di aver aià raaaiunto quello che sarà il loro stato dopo la resurrezione~ Per ~ia dell'immensità della loro gioia capita loro di interrompere la salmodia e prostrarsi faccia a terra, a causa dello zampillo di gioia che scaturisce nelle loro anime. La notte sembra loro lunga come il giorno e l'avvicinarsi dell' oscurità è come il sorgere del sole, a causa della speranza che innalza e inebria il loro cuore quando meditano su questo ... Mentre le loro lingue suonano l'arpa spirituale, l'intelletto va dietro a ciò che gli è proprio. Ora ritorna sul significato dei versetti, ora respinge un pensiero estraneo non appena si affaccia alla mente, ora infine, quando l'anima incomincia a essere stanca, ritorna alle letture del giorno
136.
!sacco allora riprende i suoi consigli sulla preghiera in stato di stanchezza. Se uno vuole dare un po' di riposo al corpo, si sieda con il viso rivolto a oriente. Finché resta seduto così, bisogna che la mente non sia vuota ma rifletta sull'utilità delle veglie notturne ricordandosi come un tempo i padri perseveravano in questa fatica. Questo richiamo lo riempie di stupore, pensando alla grande tradizione di cui ha ricevuto l'eredità. L'esempio di padri celebri che si sono dati gran pena nelle veglie (qui !sacco cita vari nomi) porta a uno stato di ebbrezza spirituale, giacché sembra al monaco di trovarsi in mezzo a loro e di vederli con i
propri occhi 137:
A causa del ricordo delle vite dei santi, di cui la mente si rammenta e medita le vicende, il suo scoraggiamento ormai è sva-
136 I,75 (pp. 367-36S) = PR So (p. 550). 137 Cf. I,75 (pp. 36S-37o) = PR So (pp. 551-555).
226
nito, l'indifferenza scacciata, le reni rinvigoriscono, il sonno è stanato dalle pupille ... e una gioia ineffabile affiora alla sua ~nim~. ~?lei lacrime gli rigano il volto, un giubilo spirituale mebna l mtelletto, l'anima riceve consolazioni indicibili la speranza sostiene il cuore e gli infonde coraggio. A quest'~omo sembra ora di dimorare in cielo per tutta la durata di una veglia piena di tante cose eccellenti 138.
Il te.ma dell'eb~rez~a spirituale è il più caratteristico tra quelli trattatl da !sacco 11 Suo. Nel capitolo seguente avremo occasione di analizzarlo in maggior dettaglio. Per il momento accontentiamoci di s?ttolineare il carattere estatico della preghiera nott~r.na, c?e d~venta"per Isa~co u~a fonte di gioia soprannaturale e d~ 1.llum1naz~one: Nulla mfattl rende la mente così raggiante e g1010sa, la nempie tanto di luce, scaccia i cattivi pensieri e fa esultare l'anima, quanto l'applicazione a veo-lie continue" 139 E continua: "Crist~ stesso si appartava contin~amente per and~re a pregare e scegheva, non senza discernimento, come tempo la notte e come luo~o il deserto (cf. Mt 14,23; Mc r,35)". Analogamente, la magg10r parte delle rivelazioni fatte ai santi avvennero durante la preghiera notturna 140:
La preg~iera of!erta durante la notte è molto potente, più di quella dmrna. E questa la ragione per cui i aiusti hanno tutti pregato di notte, lottando contro la pesan;ezza del corpo e la dolcezza del sonno. Per questo Satana teme la fatica della veglia e cerca con ogni mezzo di ostacolare ali asceti come n~l caso di Antonio il Grande, del beato Paolo, di Ar~enio e d1 ~ltri padri d'Egitto. Tuttavia i santi hanno perseverato con ost~na~10ne nella veglia e hanno trionfato sul diavolo. Quale sohtano, pur dotato di ogni altra virtù, non sarebbe stato
138 I,75 (p. 370) = PR So (p. 555). 139 I,75 (p. 370) = PR So (pp. 555-556). 14° Cf. I,75 (p. 37r) = PR So (p. 556).
227

considerato un inetto se avesse trascurato questa fatica? Giacché la veglia è la luce della coscienza (tar'ita), essa esalta la mente (mad'a) e concentra il pensiero (re'yana); attraverso di essa l'intelletto (hawna) spicca il volo e fissa lo sguardo sulle realtà spirituali mentre, ringiovanito grazie alla preghiera, rifulge di splendore 141_
Come ha notato Dana Miller, questo è l'unico passo nell'opera di Isacco in cui i quattro vocaboli che designano in siriaco le facoltà mentali dell'uomo sono usati tutti insieme 142. È probabile che !sacco abbia voluto così sottolineare fino a che punto la preghiera di notte possa interessare l'intera persona e sia capace di trasfigurare la totalità delle sue capacità mentali. Per !sacco la preghiera notturna possiede un carattere globale: egli la considera il mezzo universale per antonomasia che consente di giungere all'illuminazione della mente. Di Arsenio, l'eroe preferito di !sacco, si dice che alla veglia del giorno del Signore (domenica) si lasciasse il sole alle spalle e tendesse le mani al cielo finché il sole, sorgendo dalla parte opposta, non giungesse a illuminargli il viso 143 . A causa delle suo assiduo vegliare Arsenio pervenne a un tale grado di illuminazione che nel corso della preghiera il suo intero corpo diventava come di fuoco 144. San Pacomio, in questo campo rivale di Arsenio, vegliava nello stesso modo e finì con l'acquistare una tale purezza di spirito che "vedeva Dio, che è invisibile, come in uno specchio". "Ecco i frutti della veglia, le benedizioni che ricevono coloro che la praticano e il coronamento delle loro lotte" 145 .
Come si vede, i frutti principali della veglia sono la trasfigurazione della mente, la purificazione del cuore e la visione mistica
141 I,75 (pp. 372-373) = PR So (p. s6o). 142 Cf. D. Miller, n. z6 a I,75, in Tbe Ascetica! Homi!ies, p. 373· 143 Cf. Apoftegmi dei padri, Arsenio 30. 144 Cf. ibid., Arsenio 27. 14
' I,75 (p. 374) = PR So (pp. 563-564).
228
di Dio. !sacco conclude con un appello al lettore affinché imiti i santi del passato e diventi "loro sociale ed erede del loro stile di vita" 146 .
La "legge della schiavitù" e la "legge della libertà"
Abbiamo visto come Isacco, parlando della preghiera durante le veglie, osservi che tale preghiera dev'essere eseguita in "totale libertà", affrancata dal desiderio infantile di aderire ad ogni costo alle prescrizioni di una regola 147 . Egli torna spesso su questo consiglio, sottolineando come un "attegaiamento da schiavo" rispetto alla regola, consistente nel riten~re che la cosa più importante sia l'esecuzione di una quantità prescritta, non possa liberarci dalla confusione e dai pensieri materiali, ma che solo la "libertà" possa condurre a uno stato di calma dello spirito e dell'anima:
Vuoi_ trarre le tue delizie dai salmi della liturgia e comprendere gh oracoli dello Spirito? Non dare allora importanza alla quantità dei versetti, dimentica la tua abilità a imprimere loro un ri:mo, per riuscire invece a recitarli come una preghiera. Lasc1a perdere l'abitudine di recitarli a memoria e cerca di capirmi ... Quando la tua mente avrà raagiunto la 'stabilità • b
1n questa meditazione, la confusione sgombrerà il campo e ti lascerà. La pace dei pensieri non potrà essere trovata con un lavoro da schiavi, mentre nella libertà dei figli di Dio non c'è né confusione né irrequietudine14s.
146 I,75 (p. 375) = PR So (p. 564). •
147 9uand_o parla della "regola" della preghiera Isacco usa come sinonimi due t ermim greci: kanon (regola) e n6mos (leaae).
148 - . 00
I,J4 (p. z6S) = Touraille 33 (pp. 206-207); PR 53 (pp. 3S2-3S3).
229

Nel capitolo 4 della seconda parte Isacco studia la funzione di una regola per la preghiera. L'idea di fondo è che fissare per norma un numero definito di preghiere vada bene per coloro la cui mente non ha raggiunto l'illuminazione, mentre chi l'ha ricevuta non ne ha bisogno. Affine alla precedente è l'idea che la regola sia utile in un periodo di rilassamento spirituale, ma diventi superflua quando domina la grazia:
La mente che ha ricevuto l'illuminazione non ha più bisogno di molte formule di preghiera per unirsi a Dio. La varietà delle preghiere è di grande aiuto a chi subisce l'assalto delle distrazioni, poiché la forza che gliene deriva lo induce al pentimento e gli fa acquistare la dolce preghiera, le genuflessioni prolungate, l'intercessione in favore della creazione e le lunghe suppliche che prendono le mosse dall'interno del suo animo. Ciò accade perché a ogni parola incontrata in queste preghiere si sente come scosso dal torpore e si imbatte continuamente in sorprendenti intuizioni e capisce che tali parole, dotate di una forza nascosta, sono di per sé un dono della grazia. In ogni momento, quando le legge o vi medita sopra, egli riceve un soccorso. Nei periodi in cui domina la grazia, quando gioisci in questa preghiera deliziosa e nelle genuflessioni prolungate, non è necessario che tu ti attenga alle ore della regola o ti preoccupi del numero di preghiere da recitare, perché quella preghiera deliziosa contiene in sé tutte le preghiere che devono essere recitate in numero fisso e fa sì che le regole siano sottomesse a te [e non viceversa]l49
.
Isacco continua affermando che nella preghiera pura la fatica della preghiera trova il proprio culmine: chi è arrivato fin lì non ha più bisogno di regole o canoni. Se però non ci sei arrivato non devi abbandonare le regole: anche se la preghiera pura la
possiedi in parte, "continua a osservare la regola e i canoni per la parte che non possiedi" 150
. Osservare le regole è necessario finché si rimane bambini spiritualmente, ma una volta raggiunta la maturità esse diventano inutili 151 • Esiste una "legge dei bambini che illumina ed educa in vista della libertà", ed esiste una "legge degli schiavi che non permette alcun progresso ed educa in modo adatto ai bambini piccoli" 152
. La prima corrisponde alla "legge della libertà", rispecchia l'atteggiamento di un figlio verso il padre e non richiede regole particolari; la seconda corrisponde alla "legge della schiavitù" e ha bisogno di limiti canonici e di regole. Finché uno prega in momenti precisi della giornata, deve osservare gli uffici della regola; ma quando è capace di pregare ininterrottamente, prostrato davanti alla croce, "non è sottoposto a regola o legge canonica di sorta, e i tempi o i momenti espressamente previsti non hanno alcuna autorità su di lui. Al contrario, egli è ormai al di là delle regole perché è con Dio, senza limiti né confini" 153 .
Isacco sviluppa lo stesso tema, ma in un contesto diverso e antimessaliano, nel già citato capitolo 14 della seconda parte. L'accento qui è posto su vantaggi e necessità di una regola per la preghiera, contro i messaliani che ne rifiutavano ogni forma esteriore. Anche qui però Isacco accenna a situazioni in cui la regola può essere trascurata, a causa della gioia che deriva dall'amore di Dio:
Ecco un cattivo segno: trascurare l'obbligo delle ore dell'ufficio senza una ragione urgente. Ma se è la preghiera stessa che ci induce a trascurare le ore, se sono la pressione e il peso di una lunga esperienza della preghiera prolungata che ci spingo-
231

no a farne a meno, o i tempi aggiuntivi causati dal predominio delle delizie che ci reca la preghiera, allora abbiamo avuto la fortuna di concludere un ottimo affare per via dell' oggetto invidiabile di cui ci siamo impadroniti. Come sta scritto: "La sorte che gli tocca è deliziosa" (Sal 16,6). Tutto va bene se trascuriamo l'ora dell'ufficio non per idee vane ispirate da un atteggiamento di disprezzo, ma piuttosto perché la dolce gioia trovata nella preghiera e dovuta alla pressione esercitata dall'amore di Dio ci ha trattenuto. Infatti, dopo tutto, proprio in ciò consiste l'adempimento del nostro servizio, che non è imposto da una legge né a essa è sottomesso 154
.
Sembra che !sacco passi dalla critica di un "atteggiamento di disprezzo" verso la regola, proprio dei messaliani, alla sua personale concezione secondo la quale l'osservanza di una regola non è sempre necessaria né sempre possibile all'asceta ortodosso. È chiaro che vuole evitare che il suo amore per la libertà sia scambiato per un atteggiamento messaliano, dal quale egli tiene a dissociarsi sottolineando come l'abbandono delle regole, nella tradizione ortodossa, non sia dovuto a disprezzo o arroganza ma al contrario all'abbondanza dell'amore di Dio che costrin-
' ' ge talvolta a dimenticare ogni regola.
Se a qualcuno queste cose accadono continuamente - e sono un segno dei carismi divini e costituiscono una potente introduzione alla purezza della preghiera -, ma soprattutto se, durante la preghiera, egli mostra un atteggiamento esteriore pieno di venerazione e di profondo rispetto, è perché è stato rapidamente innalzato al rango di coloro che hanno raggiunto la pienezza, particolarmente se continua a osservare atteggiamenti esteriori pii e a mostrare un profondo timore di Dio nella preghiera 155
.
154 II,I4,7· 155 II,r4,7-8.
232
Per !sacco le regola è utile perché insegna l'umiltà; privarcene può indurre all'orgoglio:
Il cuore acquista maggior libertà di parola nei confronti di Dio durante la preghiera che nel corso dell'ufficio. Ma trascurare completamente quest'ultimo porta all'orgoglio, e a causa dell'orgoglio l'uomo cade lontano da Dio. Vedi come attraverso il semplice sforzo di sottomissione a una regola una persona relativamente libera nel suo modo di vivere mantenga l'anima umile, senza offrire al demone dell'orgoglio l'occasione di agitare pensieri malvagi davanti ai suoi occhi. Ritenendosi insignificante e incapace di libertà, essa umilia e abbassa ogni orgoglio del pensiero. Non c'è, per la bocca, freno più efficace di una mente che si innalza 156 .
Per questa ragione gli antichi padri, pur possedendo la preghiera ininterrotta, non abbandonavano la regola 157
:
Non senza ragione questi padri si imponevano a volte un centinaio di preghiere 158
, a volte cinquanta o sessanta, benché la loro persona tutta intera fosse ormai diventata un altare di preghiera. Che bisogno c'era di un numero fisso se non smettevano mai di pregare? Di Evagrio si dice che ne recitasse un centinaio, il beato Macario sessanta, Mosè l'Etiope cinquanta, Paolo il grande solitario trecento, e così via. Il motivo per cui questi beati padri si costringevano, come dei servi, al rispetto delle regole, era la paura dell'orgoglio 159 .
La regola sottomette l'anima all'umiltà, che è propria della condizione servile. Tuttavia, all'interno della regola stessa per-
156 II,q,rS. 157 Cf. II,q,I9. 158 Si tratta ancora una volta di una regola contenente brevi preghiere, che può com
prendere un salmo, un'invocazione e una serie di prostrazioni. 159 Il,I4,20-22,
2 33

mane la libertà, come all'interno della libertà permane la regola. Alcuni progrediscono grazie alla regola, altri grazie alla libertà
che viene loro dalla regola 160:
Alcuni fanno maggiori progressi nella libertà che quando sono sottoposti a una regola. Nondimeno, dalla libertà possono diramarsi strade che portano all'errore. Nella libertà si nascondono molte possibilità di caduta, ma con la regola nessuno mai si discosta dalla retta via. Coloro che si sottopongono con perseveranza al giogo di una regola saranno indotti alla caduta solo dopo averla abbandonata e disprezzata. Per questo motivo i santi d'un tempo, che hanno portato a termine il loro cammino senza deviare dalla retta via, si facevano guidare da qualche regola 161
.
Per Isacco "c'è una regola che implica la libertà e una regola destinata agli schiavi". Quest'ultima consiste nell'obbligo di recitare un numero fisso di preghiere e di salmi a ogni ufficio:
Si ha la legge degli schiavi quando uno dice a se stesso: Ecco la quantità di salmi che reciterò a ogni liturgia e a ogni preghiera. Chi dice così è invariabilmente obbligato tutti i giorni agli stessi salmi senza poter cambiare, perché nella preghiera e nell'ufficio è costretto a uniformarsi ai criteri di numero, lunghezza e quantità che egli stesso ha fissato. Questo è del tutto estraneo al cammino della vera conoscenza, giacché non tiene conto né dell'azione di Dio né della debolezza della natura umana o della possibilità di lotte frequenti: quanto alla prima, potrebbe essergli concessa una grazia che gli faccia prolungare la preghiera oltre i limiti fissati dalla sua volontà; negli altri casi, la natura umana potrebbe rivelarsi troppo debole per adempiere la regola 162
.
16° Cf. II,I4,3I-31. 161 II,I4,33. 162 II,I4,34·
2 34
In altre parole, chi si impone una quantità fissa di preahiere alle diverse ore del giorno non tiene conto del fatto che pot~ebbe non riuscire a rispettarla, o perché una grazia sovrabbondante gli fa dimenticare le parole, o perché la debolezza fisica non gli permette di portare a termine le preghiere prescritte.
La "legge della libertà", per contro, non fissa in anticipo né la successione né il numero delle preghiere. Ogni monaco deve mantenere i sette uffici tradizionali della giornata, ma contenuto e lunghezza delle preghiere sono lasciati alla sua discrezione:
La legge della libertà consiste nell'osservanza fedele dei sette uffici, stabiliti dai santi padri riuniti in concilio ecumenico dallo Spirito santo al fine della purezza del nostro stile di vita 163 . Lungi da noi solitari l'idea di non sottometterei alla chiesa, ai suoi capi e alle sue leggi. È precisamente questo il motivo per il quale osserviamo le sette ore dell'ufficio in conformità con quanto la chiesa ha prescritto ai suoi figli. Questo tuttavia non significa che a ogni ufficio siamo obbligati a recitare lo stesso numero di salmi, né che un numero fisso di preghiere debba essere recitato ogni giorno durante gli uffici diurni e notturni. Neppure è necessario precisare la durata di ogni preghiera o specificarne le parole. Al contrario, si consacri pure a ogni preghiera il tempo per il quale la grazia ce ne dà la forza, domandando tutto quello che l'urgenza del momento può esigere e servendoci della preghiera alla quale ci sentiamo portati. Pregando così saremo più raccolti e liberi da distrazioni, in vista della gioia che ne deriva. Pregando così, adatteremo le nostre richieste alla forza della natura umana e alla sapienza che il Signore ci concede 164 .
1 ~ 3 Qui .Isacco allude al ~anone 54 del concilio di Nicea (325), che prescrive la celebra.zwne dlSe.tte ~fflc.1 al g;?rno. Cf. Centurie di conoscenza IV,24, in cui l'autore mette m guard1a 1 sohtarl dal trascurare senza un motivo impellente i sette uffici fissati dalle regole per la salvezza di coloro che lottano contro il demonio".
164 II,I4>35·
235

Questo passo sottolinea come dai monaci ci si aspetti obbedienza alla chiesa, e ciò costituisce una nuova critica ai messaliani che alle tradizioni della chiesa, da loro rifiutate, preferiscono la preghiera spontanea. Tuttavia !sacco presenta le sette ore come una specie di "legge quadro" al servizio della preghiera dei monaci senza annullare il carattere spontaneo di quest'ultima: né la successione delle preghiere né la loro lunghezza devono essere precisate. Tra i fattori che ne determinano la lunghezza e l'ordine di successione !sacco cita "la necessità urgente del momento" o "la forza della natura". In altri termini, la preghiera non dev'essere astratta o ignorare i bisogni reali di chi prega, così come la sua lunghezza non deve eccedere le capacità naturali di quest'ultimo.
Quanto alle parole, secondo !sacco nessuna preghiera scritta è obbligatoria, nemmeno il Padre nostro. Il peso di questa preghiera non sta nelle parole; ciò che più importa è che l'arante sia impregnato del suo spirito:
Se uno pretende che in tutte le nostre orazioni si debba recitare la preghiera pronunciata dal Salvatore usando le medesime parole e rispettandone l'ordine preciso più che il significato, costui non ha capito niente dell'intenzione di nostro Signore nel formulare la sua preghiera e resta ben lontano dal pensiero del beato lnterprete 165 . Nostro Signore non ha voluto insegnarci una successione particolare di parole, ma ha voluto indicarci quale debba essere lungo tutta la nostra vita la meta della nostra mente. Egli ci ha dato un senso, non una serie di parole da recitare con le labbra. Ogniqualvolta dunque noi poniamo questa preghiera davanti alla mente come meta da raggiungere, noi preghiamo secondo il suo senso e dirigiamo i movimenti della nostra preghiera in accordo con esso: per
165 Isacco allude all'Omelia catechetica II di Teodoro di Mopsuestia, dedicata al Padre nostro.
esempio, quando chiediamo il regno [di Dio] e la sua giustizia (cf. Mt 6,33), o quando preghiamo di essere liberati dalle tentazioni, come a volte ci capita. In altri momenti possiamo pregare per i bisogni della nostra natura umana, o per avere di che nutrirei durante il giorno, o per tutte le altre cose che il Signore ci ha insegnato a chiedere. La nostra preghiera dev'essere ispirata al significato delle parole e noi dobbiamo indirizzare la nostra vita in conformità a esse 166 .
Quando nostro Signore ha consegnato questa preghiera ai suoi discepoli non si è limitato alla sequenza delle parole ma ha insegnato loro "a non mescolare alla preghiera, come fanno i pagani, ogni sorta di cose contrarie ai suoi comandamenti" 167• Pensare diversamente è indice di una mentalità puerile che osserva e studia l'ordine preciso delle parole invece di fare attenzione al loro significato, dal quale promanano preghiere, domande e riflessioni in perfetta sintonia con la condotta del mondo nuovo. Modificare la forma esterna della preghiera insegnata dal Signore non cambia nulla, a patto di rispettarne il senso e seguirla nello spirito 168 .
Come risulta dai testi citati, !sacco è favorevole a un atteggiamento libero verso le regole di preghiera e i testi da usare: né il tempo dedicato alla preghiera né le parole hanno un valore assoluto. L'importante è che la preghiera corrisponda ai bisogni interiori dell'arante e al modo in cui Gesù Cristo ha insegnato ai cristiani a pregare. Si può pregare con parole personali oppure con i salmi o con preghiere scritte da altri: in quest'ultimo caso, le parole altrui debbono essere fatte proprie da chi le recita, devono cioè passare attraverso il profondo del suo cuore. La fedeltà a Cristo non consiste nella ripetizione pedissequa della pre-
166 II,q,36·37· 167 II,I4,}8. 168 Cf. II,I4.39·
237

ghiera che egli ci ha insegnato, bensì nell'essere imbevuti del suo spirito. Parimenti la fedeltà alla chiesa e alla tradizione monastica non esige che si recitino tutti gli uffici e i salmi stabiliti dagli antichi padri, ma che ci si lasci permeare dal loro spirito mirando a eguagliarne la santità.
La preghiera per il mondo intero
!sacco il Siro fa parte di quegli autori della chiesa antica che avevano una visione universale e non perdevano mai di vista il mondo intero, tutta la creazione e tutti gli uomini con le loro sofferenze. In ciò consiste il paradosso della vita solitaria: l'eremita che si ritira dal commercio con gli uomini non li dimentica affatto, e pur rinunciando al mondo non smette mai di pregare per esso. !sacco era amante della solitudine e del silenzio, ma ogni tentazione di chiudersi in se stesso o di occuparsi della propria salvezza senza darsi pensiero per i suoi fratelli gli era totalmente estranea. Egli possedeva quel "cuore misericordioso" la cui caratteristica è di avere compassione per tutte le creature: non solo per i cristiani ma anche per gli apostati, gli animali e i demoni. Come la preghiera liturgica, la sua preghiera personale si estendeva su scala cosmica, abbracciando non solo i vicini e gli estranei, ma la totalità degli uomini e dell'universo.
Per conoscere un po' meglio questa straordinaria esperienza di preghiera universale prendiamo in esame il capitolo 5 della seconda parte dell'opera di !sacco. Esso contiene una lunga preghiera per il mondo intero, ed esordisce con un ringraziamento a Dio per l'incarnazione:
La mia anima si inchina fino a terra e io ti offro con tutte le mie ossa e tutto il mio cuore il sacrificio che ti si confà, o Dio
di gloria che dimori entro un silenzio ineffabile. In vista del mio rinnovamento tu hai innalzato per me sulla terra un tabernacolo d'amore in cui ti compiaci di riposarti, un tempio di carne 169 che è stato unto con l'olio più santo tra quelli del Santo dei Santi. Tu l'hai colmato della tua santa presenza, cosicché tutta la liturgia vi possa essere celebrata, facendola conoscere in onore delle Persone eterne della Trinità e rivelando al mondo, creato da te nella tua grazia, un mistero indicibile, una potenza che non può essere né sentita né afferrata da nessun elemento venuto alla luce nella tua creazione. Gli esseri angelici, immersi nel silenzio, sostano stupiti davanti alla nube impenetrabile (cf. Es 2o,2I) di questo eterno mistero e davanti al fiume glorioso che sgorga da quella meravigliosa sorgente che è celebrata nelle placrhe del silenzio da ocrni pensiero santificato e reso degno di t~liD. o
La nostra attenzione è attirata dalle domande con cui la preghiera si apre, formulate secondo il linguaggio dei salmi: una frase come "con tutte le mie ossa e tutto il mio cuore" è evidentemente ispirata a immagini del salterio (cf. Sal 9,2; 35,Io; I I9, Io e passim). Proseguendo nella sua preghiera I sacco rivolge l'attenzione alla creazione e alla caduta dell'uomo, e riferendo quest'ultima a se stesso parla di sé come di un bambino che implora Dio di trattarlo con la sollecitudine di un padre:
Signore, mi prostro davanti allo sgabello dei tuoi piedi (cf. Sal 99,5; I 3 2, 7) e davanti alla tua santa destra che mi ha modellato e ha fatto di me un essere umano, capace di sentire la tua presenza. Ma ho peccato e agito male, sia dentro di me che davanti a te, giacché ho abbandonato la santa conversazione con te per trascorrere i miei giorni in conversazione con le concupiscenze. Te ne supplico, Signore: non contare contro
169 Si tratta della natura umana del Verbo incarnato [N.d.T. francese]. 170 Il,), I.
239

di me i peccati della mia giovinezza (cf. Sal 2 5, 7), l'ignoranza della mia vecchiaia e la fragilità della natura che mi hanno vinto e sommerso in pensieri rivolti a oggetti spregevoli. Volgi il mio cuore verso di te, lontano dalle torbide distrazioni dei piaceri; fa' abitare in me una luce nascosta. L'azione della tua bontà previene sempre ogni velleità del mio cuore a bene agire e oani disponibilità alla virtù. La tua sollecitudine a sottoporre la mia libera volontà alla prova tu non l'hai mai trattenuta, anzi, essa mi ha seguito come un padre segue il proprio figlio ... giacché da sempre tu sai che io, come e più di un bambino, ignoro la meta del mio viaggio 171
•
Seguono richieste di essere liberato da ogni intenzione malvaaia dai desideri carnali e dalla potenza del demonio 172 . Isacco do~anda poi a Dio di concedergli un vero pentimento, affinché egli possa vedere i propri peccati:
Busso alla porta della tua misericordia, Signore: vieni in soccorso dei miei impulsi di dissipazione, avvelenati da tante passioni e dalla potenza delle tenebre. Tu vedi le piaghe nascoste nel mio intimo: avvia dentro di me la contrizione, anche se non è pari alla gravità dei miei peccati, giacché se io avrò piena conoscenza della loro entità, la mia anima sarà consumata di dolore e di amarezza a causa loro ... O Nome di Gesù173, chiave di tutti i doni, disserra per me la grande porta del tuo tesoro, affinché io possa entrarvi e lodarti di una lode che viene dal cuore per gli atti di misericordia che ho sperimentato da parte tua, poiché tu sei venuto e mi hai rinnovato attraverso la percezione del mondo nuovo 174
.
Seguono domande di carattere più personale, che mescolano sentimenti diversi con espressioni di pentimento, ringraziamen-
171 II,5,z. 172 Cf. II - 3. m Sul N;;'~e di Gesù, cf. Efrem il Siro, Inni sulla fede 6,r7; Inni sulla Natività 27. 174 II,5A·5·
ti e azioni di lode. Isacco si rivolge quindi alla natura umana di Cristo per lodarla, poi passa a una preghiera di pentimento:
Signore, sto davanti al trono della tua maestà, io polvere, cenere, rifiuto dell'umanità. Migliaia e migliaia di angeli e legioni innumerevoli di serafini ti offrono una liturgia spirituale nel segreto del loro essere, con lodi infuocate e sante ispirazioni rivolte a te, santo Essere, celato ai sensi e alla conoscenza di ogni creatura. Con il tuo soccorso, Signore, stai accanto a ognuno nei momenti di sventura; a tempo opportuno e anche inopportuno, la tua porta rimane sempre aperta alle preghiere di ciascuno. Non hai ribrezzo dei peccatori, non volgi le spalle alle anime macchiate d'ogni sorta di peccati, tu che da mali infiniti fai scaturire ogni bene. Quanto a me, così interamente ricoperto di bruttura, tu, Signore, mi hai reso degno di prostrarmi davanti a te, faccia a terra, e di osare pronunciare con le mie labbra il tuo santissimo Nome, benché io sia un vaso di lordura, indegno d'essere annoverato fra i discendenti di Adamo. Concedimi, o Signore, di essere santificato attraverso le tue lodi e di essere purificato dal ricordo di te; rinnova la mia vita con il cambiamento del mio intelletto e con i pensieri benefici che tu sai avviare in me ... Fortifica in me l'unico desiderio di contemplarti a ogni istante, e il pensiero che non smette mai di riporre in te ogni sua speranza grazie alla mortificazione continua imposta per causa tua. Concedimi, Signore, una bocca che non ti preghi con parole insincere, concedimi di perseverare su questa terra nel tesoro nascosto dell'umiltà del cuore e del pentimento della mente 175 •
Quindi Isacco si rivolge a Dio con una domanda sulla sua morte a beneficio del mondo e un ringraziamento per la misericordia con la quale ha creato l'uomo 176; poi chiede di poter asso-
175 II,5,8. 176 Cf. II,5,IO-II.

migliare ai padri e agli asceti d'un tempo, ripercorrendo il loro cammino sulla via che conduce a Cristo:
O forza grazie alla quale gli antichi padri hanno trionfato sugli attacchi potenti e terribili dell'Avversario - erano uomini immersi nella natura umana con tutti i suoi bisogni, ma sembravano persone libere da ogni costrizione, apparse sulla terra come emissari della realtà futura-, tu hai reso le tombe degli uomini, le [loro] grotte e le [loro] campagne il luogo della tua Shekinah, rivelandoti a essi. Riversa nel mio cuore l'ardore dei loro pensieri ... poni in me il seme della conoscenza dell'umiltà ... O soccorso dei deboli, via retta per chi è smarrito, rifugio per quanti vengono sorpresi dalle tempeste, abbassa tu stesso davanti a me l'orgoglio del mio Avversario, spezza la forza crudele che egli dispiega contro di me, umilia lo strapotere del suo orgoglio, spiana davanti ai miei pensieri le tue vie nascoste, sii mia consolazione nell'ora dello sconforto e mia guida nei passi perigliosi. O sole di giustizia, grazie al quale i giusti possono vedersi e diventano specchi per la loro generazione, schiudi in me la porta della tua conoscenza, dammi un pensiero penetrante che non vada a urtare gli scogli della colpa, nell'attesa ch'io possa giungere al porto luminoso nel quale sono già entrati i padri d'un tempo, a te così graditi per tutte le loro fatiche 177
•
Tornando poi all'incarnazione del Verbo, !sacco chiede a Dio di essere reso degno di comprendere il mistero del sacrificio del suo Figlio amato 178 • Il richiamo alla morte di Cristo in croce gli suggerisce un inno di ringraziamento, in cui la preghiera assume accenti di drammatica intensità:
Tu hai donato al mondo tutto ciò che avevi come tesoro ... Veramente questo mistero è grande ... La fiumana dei misteri di
177 II,5,1 2·1}. 178 Cf. II,5,15-
Cristo travolge la mia mente come le onde del mare. Avrei voluto restare in silenzio davanti a essi e non dire nulla, ma si sono rivelati fuoco ardente nelle mie ossa (cf. Ger zo,9). La mia mente mi rivela i miei peccati e mi rimprovera. Il tuo mistero da una parte mi getta nello stupore, dall'altra mi spinge a continuare a contemplarlo ... O mia speranza, infondimi nel cuore quell'ebbrezza che consiste nella speranza che io ripongo in te. O Gesù Cristo, resurrezione e luce di tutti i mondi, incorona il capo della mia anima con il diadema della conoscenza di te, spalanca tutt'a un tratto davanti a me la porta delle tue misericordie, fa' rifulgere nel mio cuore i raggi della tua grazia 179 •
Dopo una lunga e commovente preghiera rivolta a Cristo, nella quaJe ne ripercorre la vita e le sofferenze patite per il bene dell'umanità, !sacco giunge a una preghiera per i monaci e i solitari, vivi e morti, che ora acquista quella risonanza universale così tipica delle anafore eucaristiche della chiesa d'oriente. D'altronde, non è un caso che la preghiera citi a questo punto l'offerta del corpo e del sangue di Cristo:
Siano ricordati sul tuo santo altare, Signore, nel momento terribile in cui il tuo corpo e il tuo sangue sono offerti in sacrificio per la salvezza del mondo, tutti i padri e tutti i fratelli che vivono nella montagna, nelle grotte, nei valloni, sulle scogliere, in luoghi aspri e solitari, uomini celati al mondo, dei quali tu solo conosci la dimora; quelli che sono già morti e quelli che, vivi, celebrano in corpo e anima davanti a te, che solo sei santo e risiedi nei santF80 nei quali la tua divinità riposa; quelli che hanno abbandonato il mondo temporale e so-
179 II,5,18.19.2I. 180 Secondo S. Brock (n. 3 a II,5,z6, in CSCO 555, p. 17), l'espressione si basa su Is
57,15 LXX, passo spesso citato dagli autori greci, da uno dei quali !sacco potrebbe averlo ripreso. Da parte nostra vorremmo suggerire un parallelo tra questa espressione di !sacco ed espressioni analoghe nelle anafore cristiane primitive: "Le cose sante per i santi".

no già morti a questa vita perché sono usciti incontro a te, cercandoti e anelando a te tra le afflizioni di una vita di tormenti. O re di tutti i mondi e di tutti i padri ortodossi che per la vera fede hanno patito esilio e sofferenze da parte dei loro persecutori, e che nei monasteri, nei conventi, nei deserti e nelle dimore del mondo, dappertutto e in ogni luogo, hanno avuto cura di piacerti attraverso le fatiche sopportate al fine della virtù: accompagnali con il tuo soccorso, Signore, sii per loro un baluardo perpetuo, manda loro di nascosto il tuo continuo conforto, lega a te le loro menti nell'infuriare delle battaglie; che la forza della tua Trinità abiti in loro e che possano celebrare alla tua destra sino alla fine della vita, con una buona coscienza e una condotta eccellente. Rendili degni, mentre sono ancora nel corpo, del porto del riposo 181 .
A questa preghiera per i monaci e i solitari segue una preghiera in favore dei malati e dei prigionieri:
Siano ricordati davanti a te anche quanti soffrono malattie gravi che ne mettono a dura prova i corpi. Manda loro un angelo di compassione a placarne le anime crudelmente afflitte dalle gravi sofferenze dei corpi. Abbi anche compassione, Signore, di quanti sono in balla di gente malvagia ed empia; affrettati a inviare loro un angelo di misericordia che li liberi dalla situazione critica in cui versano. Mio Signore e mio Dio, riconforta tutti quelli che soffrono di una qualche brutalità, qualsiasi essa sia 182•
In tale richiesta, e ancor più in quella seguente, è facile riconoscere analogie letterarie con le preghiere eucaristiche tradizionali della chiesa d'oriente. Per esempio, la preghiera che la chiesa sia liberata dalla persecuzione e dai conflitti intestini, o
181 II,5,z6. "' II,5,z 7.
244
che tra re e sacerdoti - vale a dire tra stato e chiesa - siano preservate la carità e la concordia, è formulata nel modo seguente:
Signore, accogli la tua santa chiesa- che è stata riscattata con il tuo sangue- sotto la tua ombra; fa' abitare in essa la tua vera pace, quella che hai donato ai tuoi santi apostoli; congiungi i suoi figli tra di loro con i legami santi e indissolubili dell'amore; fa' che gli avversari non possano soggiogarla; allontana da lei persecuzione, tumulto e guerra, sia che provengano dal suo interno sia dall'esterno; fa' che re e sacerdoti siano strettamente congiunti in pace profonda e nella carità, con lo sguardo tutto fisso in te; e che la santa fede sia baluardo al tuo gregge 183 •
A titolo di confronto, ricordiamo l'intercessione dell'anafora siro-orientale attribuita a Teodoro di Mopsuestia:
Signore Dio potente, accogli questa offerta (q urbana) ... per tutti i sacerdoti, i re e le autorità ... per tutta la chiesa santa e cattolica, perché abiti in essa la tua quiete e la tua pace, per tutti i giorni del mondo; e siano allontanate da essa le persecuzioni, i tumulti, le liti, gli scismi e le divisioni; e noi tutti siamo uniti, nella concordia l'uno con l'altro, con cuore puro e amore perfetto 184 .
Nelle sue ultime intercessioni Isacco menziona quelli che, smarriti, hanno lasciato la vita senza pentirsi e lontani dalla vera fede:
Ti supplico e scongiuro, Signore: concedi a tutti coloro che hanno deviato da te di conoscerti veramente, in modo che
"' II,5,28. 1
" Anafora di mar Teodoro di Mopsuestia, in Segno di unità. Le più antiche eucaristie delle chiese, a cura dei monaci e delle monache di Bose, sotto la direzione di E. Mazza, Qiqajon, Bose r996, pp. 3I3-3I5·
2 45

tutti e ciascuno possano venire a conoscenza della tua gloria 185• Quanto a coloro che hanno lasciato questa vita senza virtù e senza fede, sii il loro avvocato, Signore, a causa del corpo che hai assunto tra di loro, affinché a partire dal corpo unico e unificato di questo mondo noi offriamo le nostre lodi al Padre, al Figlio e allo Spirito santo nel regno dei cieli, sorgente infinita di gioie eterne 186 .
Quest'ultima richiesta in favore di quanti muoiono fuori della vera fede mostra come fosse totalmente estranea al pensiero di Isacco l'idea che non si potesse pregare per i morti non cristiani. Egli non immaginava un regno dei cieli accessibile solo agli eletti, mentre il resto degli uomini ne sarebbe stato escluso. Abbiamo appena visto che Isacco considera il mondo intero come un "corpo unico e unificato", di cui ogni uomo è membro. Nel secolo a venire l'universo intero sarà trasformato nel corpo di Cristo, che è la chiesa riscattata per opera sua. Quando, nell'ultimo capitolo di questo libro, discuteremo l'escatologia di Isacco, vedremo come in lui questa visione universale si svilupperà nella sua concezione della salvezza universale.
!sacco è dunque convinto che i cristiani debbano pregare per tutti, indipendentemente dalle loro virtù o religioni:
Bisogna che preghiamo attivamente e intercediamo dolorosamente per tutti questi scopi. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo tenere verso tutti gli uomini: pregare dolorosamente per loro come per noi stessi, giacché proprio allora la divinità verrà a riposare in noi, e in noi collocherà la sua volontà, "come in cielo così in terra" (Mt 6,ro) 187 .
165 Cf. l'anafora di Teodoro di Mopsuestia: "E [presentiamo questa offerta] per l'intera progenie degli uomini, quelli che sono nel peccato e nell'errore, perché nella tua grazia, mio Signore, tu li renda degni della conoscenza della verità" (Segno di unità, p. 315).
''6 II,s,29·3o. 167 Il,5,32.
La meditazione su Dio e la "preghiera pura"
Tra le categorie di preghiera citate da !sacco riveste un ruolo eccezionale la meditazione, designata da molti vocaboli, e specialmente dai tre termini caratteristici di tutta la tradizione siro-orientale: herga, meditazione; renya, riflessione; 'uhdana, ricordo. Ciascuno di questi termini, al di là delle loro sfumature specifiche, può essere riferito alla meditazione su Dio e sulle cose spirituali. In questo paragrafo ci occuperemo soprattutto di quella che Isacco chiama herga db-alaha, meditazione su Dio. Essa è intimamente legata alla preghiera, dalla quale è difficilmente separabile: talvolta la preghiera fa nascere la meditazione, in altri momenti invece è la meditazione che fa nascere la preghiera188.
In un capitolo delle sue Centurie di conoscenza Isacco descrive con dovizia di particolari il contenuto di tale "meditazione su Dio":
Quando siedi tra due uffici per applicare l'intelletto alla meditazione su Dio, aggiungi queste riflessioni: considera che sei venuto all'esistenza dalla totale non-esistenza; considera chi era colui che ti ha modellato affinché tu, una volta uscito dal tuo nulla, potessi esistere nello stato presente, e come tu - per usare le parole della Scrittura -, benché inizialmente creato nella bellezza, abbia preso di tua volontà una cattiva strada, mangiando dell'albero proibito, e continui a mangiarne ogni giorno; ti sei rivolto al male a causa di ciò che l'Onnipotente ti aveva promesso, benché il suo intento non mirasse a tale esito. E ancora, rifletti su ciò che sei volontariamente diventato e sulla tua condizione attuale, senza aspettarti nulla, ma senza neppure ignorare la speranza alla quale sei stato
lBB Cf. Il,IO,J.

improvvisamente chiamato per la compassione sovrabbondante di colui che, cercandoti nel nome di Cristo Gesù nostro Signore, ti riconduce alla relazione luminosa che avevi originariamente con Dio. Guarda come sei rimasto nella disobbedienza persistendo nella condizione della caduta, mentre Dio non si è affatto disinteressato di te ma, di sua iniziativa, ha escogitato per te cose al punto di venirti a trarre in salvo quando tu stesso non eri nemmeno più capace di chie-derlo. Considera inoltre ciò che sei in questa vita presen-te e quello che presto sarai, e in corruzione finirà il tuo stato attuale: diventerai come se non fossi mai esistito, senza che nessuno si ricordi di te, senza nome né monumento in memoria per tutte le generazioni future di questo mondo. Ma come descrivere una simile meraviglia, cioè che proprio a partire da questa corruzione si preparano un'esistenza e una condizione del tutto nuove, e tu questo tugurio per una sfarzo sa dimora? Metti poi a confronto quello che c'è ora con quello che vi sarà dopo, e il balzo dalla nostra condotta presente a quella della vita futura, quando dalle semplici ipotesi passeremo a una conoscenza e a una visione piene di certezza 189
•
Così, la meditazione su Dio presuppone il richiamo all'intera economia di salvezza dispiegata da Dio in degli uomini, a partire dalla creazione, passando attraverso l'incarnazione per giungere infine alla vita del secolo a venire. Al tempo stesso, tale meditazione su Dio include considerazioni sulla vita ascetica e le virtù cristiane, come Isacco precisa nel capitolo ro della seconda parte. Secondo lui, tale meditazione all'illuminazione spirituale:
Ciascuno troverà l'illuminazione nella in cui si inoltra e nelle idee che la sua mente indaga: vi troverà la sapienza, e tanto si concentrerà su di esse che potrà
189 Centurie di conoscenza II,84.
"'""""~"· le azioni della giustizia riflettendo su questo ministero ... e meditando sull'esercizio della virtù, su come può cere a Dio con la purezza del corpo, con lo sforzo della pre
con il digiuno che rende il corpo diafano, con la recie la lotta contro tutto ciò che la intralcia ... e
tiPttPnrlrt poi sui diversi ordini in cui si dispongono le virtù fra di esse che gli procurano luce e progresso - e in
queste dovrà dunque più particolarmente perseverare e infine su tutto ciò che a ogni singola virtù si oppone ... allora sl che riuscirà ad approfondire enormemente la propria conoscenza 190 •
La riflessione diverse specie di virtù che Isacco suggeri-sce in questo passo costituisce una forma astratta di meditazione su argomenti ordine morale. Essa è tuttavia necessaria all'asceta nella misura in cui gli fornisce il fondamento teorico di una vita virtuosa. Ma è importante non limitare la meditazione agli aspetti negativi della vita ascetica, cioè alla lotta contro le passioni e i pensieri. Questo tipo di meditazione non è privo di utilità, ma quella che gli aspetti positivi della vita cristiana è di gran lunga più proficua:
Colui che medita passioni, sui pensieri e le lotte da essi suscitate, e su come i pensieri e le passioni si susseguono gli uni alle altre, e qual è l'inizio e la fine della prima passione, qual è la forza di come si possono tenere a bada e donde ricevono la loro ... un uomo del genere si concen-tra ed esercita il proprio intelletto unicamente sulle passioni. Ma se egli medita su Dio e lascia spaziare la mente su ciò che gli appartiene, cercando Dio con animo semplice, egli nericeverà l'illuminazione: una tale meditazione ingloberà tutti i temi precedenti, che sono interessanti ma portano a conflitti. La riflessione e la conoscenza dell'anima e del corpo non de-
2 49

vano assolutamente finire, giacché in esse c'è ben di più della resistenza alle passioni: ... non è questa l'oggetto della speranza che ci è stata predicata né quello che ci ha detto l' Apostolo, cioè che dobbiamo "comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità" (Ef 3 ,8), oppure eccellere "con ogni sapienza e intelligenza" (Ef I, I 8). Come eccellere in sapienza ed esserne consapevoli, se si è notte e giorno impegnati a discutere e a preoccuparsi di pensieri passionali? Eppure sono in molti a concentrarsi su questo, e benché il loro impegno sia difficile e degno di rispetto, essi per nulla al mondo si interesserebbero all'altro aspetto di cui abbiamo parlato 191 •
Chi si preoccupa dei pensieri e delle passioni è continuamente coinvolto nelle battaglie della vita spirituale: talora vince ma spesso è sconfitto 192, mentre colui che nella sua meditazione mira a Dio si trova al di là della lotta contro le passioni:
Questo non vuol dire che il suo intelletto abbia trionfato su pensieri, impulsi e passioni, ma che regna su di loro ed essi scompaiono; non sono sconfitti perché non c'è stata vittoria: semmai passioni, ricordi e tutto ciò che si insinua insieme a loro spariscono, perché ora quest'uomo è stato innalzato al di sopra del mondo, lasciando dietro di sé, in basso, nel loro luogo naturale, tutte le riflessioni che riguardano il mondo, le sue varie faccende e la loro conoscenza, mentre l'intelletto è stato rapito fuori di esse ... Un uomo, quando medita su Dio e sulle onde imponenti di tutto ciò che gli appartiene, quando si dedica a Dio, ha abbandonato il mondo, e la porta che dà su tutti i ricordi è tenuta chiusa, mentre le passioni restano alloro posto inoperose, perché quest'uomo per ora è trascinato via dal luogo in cui esse risiedono 193 .
191 II, IO, 7-IO. 192 Cf. II,ro,rr. 193 II,ro,rz-r3.
La meditazione su Dio, accompagnata da un oblio totale del mondo presente, conduce allo stato di contemplazione spirituale in cui l'uomo penetra nella "nube oscura" della gloria di Dio (cf. Es zo,zr) e si rende simile agli angeli:
Una volta che queste cose sono state spiegate, la meditazione su Dio comincia a smuovere l'intelletto e a poco a poco, per gradi, se ne impadronisce completamente, lo guida nella nube oscura della sua gloria e gli concede di restarvi e di avvicinarsi alla fonte dalla quale sgorga incessantemente la vita per il bene di tutti gli intelletti superiori e inferiori: quelli i cui sforzi si spingono verso l'alto, al di là del corpo, e quelli il cui impegno si dispiega sulla terra e muore; quelli i cui slanci sono "fuoco ardente" (cf. Sal I04,4) e quelli i cui moti sono limitati dalla loro spessa natura194.
La "meditazione luminosa" su Dio è uno degli stadi più elevati della preghiera, a un solo passo dallo "stupore" mistico in cui l'intelletto, completamente liberato da questo mondo, viene catturato da Dio:
Se desideri gustare l'amore di Dio, fratello mio, considera e medita con intelligenza su ciò che appartiene a lui e sulla sua santa natura: medita e rifletti mentalmente, lascia ogni momento vagare il tuo intelletto tra queste cose. Proprio a partire da qui ti accorgerai di come tutte le parti della tua anima avvampino d'amore, quando una fiamma ardente comincerà a bruciare nel tuo cuore e il desiderio di Dio si impadronirà di te ... La meditazione luminosa su Dio è lo scopo ultimo della preghiera o piuttosto la fonte principale di tutte le preghiere, dal momento che la preghiera stessa ha come approdo la riflessione su Dio. Ci sono momenti nei quali la preghiera ci trasporta verso una meditazione piena di meraviglia, ce ne
194 II,ro,r7.

sono altri in cui è la preghiera a nascere dalla meditazione su Dio. Ci sono tappe differenti nel percorso che l'intelletto porta divinamente a compimento nello stadio di questo mondo, senza distogliere mai lo sguardo dalla corona (cf. rCor 9,24-25). La corona del solitario è la gioia spirituale in Cristo nostro Signore. Chi l'ha trovata ha ricevuto la caparra del mondo e delle cose a venire195.
La relazione tra preghiera e meditazione è sviluppata nel capitolo rs della seconda parte dell'opera di !sacco, tema principale del quale è la "preghiera pura" (~lata dkita), che consiste per lui nella "meditazione sulla virtù". Non bisogna credere, sostiene Isacco, che la preghiera pura presupponga l'assenza totale di pensiero; essa consiste piuttosto in una "divagazione" (pehya) della mente nelle cose di Dio:
La preghiera pura, o discepolo della verità, e il raccoglimento della mente nel quale essa consiste, è una riflessione esatta sulla virtù nella quale noi ci impegniamo diligentemente all'atto della preghiera. Proprio come la purezza del cuore, tanto raccomandata dai padri, non consiste nell'essere totalmente privi di pensieri, riflessioni o impulsi, ma piuttosto in un cuore purificato da ogni male, che guarda a tutte le cose con benevolenza e le considera dal punto di vista di Dio, cosl avviene della preghiera pura e priva di distrazioni. Ciò non significa che la mente sia completamente svuotata di pensieri o di qualsivoglia divagazione, ma che essa, nel tempo della preghiera, non si addentra in argomenti futili; non già che la mente resti fuori della preghiera pura finché non divaga su qualcosa di specificamente buono, giacché può anche considerare argomenti appropriati e sviluppare durante la preghiera pensieri graditi a Dio. Non è nemmeno obbligatorio che nessun pensiero insignificante si affacci alla mente
durante la preghiera: basta non occuparsene e non lasciarsi distrarre da esso 196 .
Due sono i modi nei quali la mente può divagare, uno buono e uno cattivo. Anche la preghiera pura implica una divagazione, ma allora si tratta di "divagazione eccellente", poiché la mente si concentra su cose buone e divine 197 :
La divagazione è cattiva quando si è distratti da pensieri insignificanti o malvagi, perché si è presi da essi mentre si prega davanti Dio; è buona quando per tutto il tempo della preghiera la mente divaga su Dio e sulla sua maestà e gloria, a partire da una riflessione sulle Scritture o su intuizioni relative alle espressioni di Dio e alle sante parole dello Spirito ... Non consideriamo estranee alla preghiera pura o nocive al raccoglimento del pensiero tutte le memorie utili che affiorano alla coscienza a partire dalle Scritture dello Spirito e che generano, durante la preghiera, delle intuizioni e una comprensione spirituale del mondo di Dio. Per alcuni, esaminare l'oggetto della propria richiesta e riflettere su di essa in raccoglimento costituisce un modo eccellente di pregare, purché sia in accordo con il fine dei comandamenti di nostro Signore. Questo è uno splendido modo di raccogliere la mente198 .
Così, meditazione sulle cose di Dio e preghiera pura sono sinonimi, e Isacco arriva ad affermare che la divagazione della mente può essere migliore della preghiera, quando si accompagna a intuizioni sulle realtà spirituali:
Se la mente, lasciando da parte questa preghiera, s1 nversa nelle cose di Dio, o se qualche riflessione eccellente gli viene
196 II,I5,2. 197 Cf. Il,I5,}· 198 Il,I5A-5·
253

suggerita dalle intuizioni della Scrittura su Dio - che si tratti di intuizioni particolari alla persona in questione o appartenenti all'intera comunità, riguardanti l'economia di Dio o l'azione della sua provvidenza, quotidiane o universali - attraverso tutte queste cose le profondità del cuore si avviano alla lode di Dio, al rendimento di grazie e alla gioia, a causa dell'immensità e dell'elevatezza della sua compassione e del suo amore verso di noi; e un tal genere di divagazione, quando si verifica, è migliore della stessa preghiera! Indipendentemente dall'elevatezza e dalla purezza della preghiera, è quello il culmine di ogni raccoglimento della mente e di ogni preghiera eccellente199 .
"Intuizioni" (sukkale) è uno dei termini preferiti di !sacco, sul quale ritorneremo nel capitolo seguente. Limitiamoci per ora a osservare come esso riguardi una certa vicinanza e degli incontri mistici che hanno avuto luogo durante la preghiera: vicinanza e incontri con una realtà diversa, trascendente la comprensione e le parole dell'uomo. Rileviamo per inciso un particolare degno di nota: queste intuizioni possono essere un fatto individuale, ma anche "appartenere alla comunità". Che cosa vuol dire? Probabilmente non si tratta dell'esperienza di un gruppo i cui membri ricevano tutti contemporaneamente una medesima intuizione, bensì di intuizioni personali di un singolo membro della comunità riguardanti l'esperienza della chiesa nel suo complesso, che diventa così per lui, proprio attraverso quelle intuizioni, un'esperienza personale. In altri termini, una cosa già in precedenza rivelata agli altri membri della comunità ecclesiale, è rivelata a un singolo durante la preghiera. Per via di questa rivelazione personale l'esperienza della comunità è integrata con quella di un credente particolare. Così la preghiera pura è un luogo d'incontro tra individuo, comunità ecclesiale e tradizione della chiesa.
199 II,I5,6.
2 54
Nelle Centurie di conoscenza !sacco usa un'altra espressione: la "preghiera sapiente" (~lata hakimta), che è sinonimo di "preghiera pura" e sottolinea il fatto che essa non si fonda sulla sapienza umana ma su quella che viene direttamente da Dio erischiara l'uomo a partire dalla sua interiorità:
Quando parlo di una preghiera sapiente non penso alla saggezza del mondo o all'erudizione verbosa e sciocca, che dovrebbe far arrossire l'anima in preghiera davanti a Dio a causa della vana gloria che suscita, e che allontana il soccorso di Dio. Penso invece alle parole di sapienza che, nella preghiera, promanano dalla sapienza di Dio e dalla luce dell'anima, e che i fervidi impulsi fanno affiorare nel cuore a causa dell'amore per la vera vita che precede la preghiera e che, riscaldando il cuore, suscita parole involontarie e che tuttavia il ricordo [di Dio] fa scaturire. Quante volte, su questa strada, non sono sgorgate lacrime a partire dal calore del cuore e dal soccorso di Dio! È questo che [i padri] chiamano preghiera pura2oo_
Nello stesso scritto !sacco enumera molti livelli di preghiera pura, corrispondenti a diverse tappe della crescita interiore e dovuti ai vari influssi dello Spirito santo sull'anima:
La preghiera pura consiste nel fatto che il pensiero non sguazza negli impulsi risvegliati in noi dai demoni o dalla natura o dai ricordi, oppure dai moti del nostro carattere. Anche nella preghiera pura ci sono varie misure, secondo i gradi del pensiero di coloro che la offrono. Più un pensiero si innalza al di sopra dell'amore per le realtà di questa terra, più esso è risparmiato dalle immàgini che, ad opera delle distrazioni, si affacciano al momento della preghiera. Quando è completamente elevato al di sopra dell'amore per le cose di quaggiù, il
zoo Ce11turie di conoscenza III, 13.
2 55

suggerita dalle intuizioni della Scrittura su Dio che si tratti di intuizioni particolari alla persona in o appartenenti all'intera comunità, riguardanti l'economia di Dio o l'azione della sua provvidenza, quotidiane o attraverso tutte queste cose le profondità del cuore si avviano alla lode di Dio, al rendimento di grazie e alla a causa del-l'immensità e dell'elevatezza della sua e del suo amore verso di noi; e un tal genere di divagazione, quando si verifica, è migliore della stessa preghiera! Indipendentemente dall'elevatezza e dalla purezza della preghiera, è il culmine di ogni raccoglimento della mente e di ogni tm::>tl'lìe:ra eccellente199 .
"Intuizioni" (sukkale) è uno dei termini preferiti di sul quale ritorneremo nel capitolo seguente. Limitiamoci per ora a osservare come esso riguardi una certa vicinanza e degli incontri mistici che hanno avuto luogo durante la preghiera: vicinanza e incontri con una realtà diversa, trascendente la comprensione e le parole dell'uomo. Rileviamo per inciso un particolare degno di nota: queste intuizioni possono essere un fatto individuale, ma anche "appartenere alla comunità". Che cosa vuo1 dire? Probabilmente non si tratta dell'esperienza di un gruppo i cui membri ricevano tutti contemporaneamente una medesima intuizione, bensì di intuizioni personali di un singolo 111c:llllJJ.V della comunità riguardanti l'esperienza della chiesa nel suo complesso, che diventa così per lui, proprio attraverso quelle intuizioni, un'esperienza personale. In altri termini, una cosa
precedenza rivelata agli altri membri della comunità eccleè rivelata a un singolo durante la preghiera. Per via di que
sta rivelazione personale l'esperienza della comunità è integrata con quella di un credente particolare. Coslla preghiera pura è un luogo d'incontro tra individuo, comunità ecclesiale e tradì-
della chiesa.
199 II,I5,6.
254
Nelle Centurie di conoscenza !sacco usa un'altra espressione: la "preghiera sapiente" (~lota hakimta), che è sinonimo di "pre-ghiera pura" e sottolinea il essa non si fonda sulla sa-pienza umana ma su quella che direttamente da Dio e ri-schiara l'uomo a partire dalla sua interiorità:
Quando parlo di una sapiente non penso alla saggezza del mondo o all'erudizione verbosa e sciocca, che dovrebbe far arrossire l'anima in davanti a Dio a causa della vana gloria che suscita, e che allontana il soccorso di Dio. Penso invece alle parole di sapienza che, nella preghiera, promanano dalla sapienza di Dio e dalla luce dell'anima, e che i fervidi impulsi fanno affiorare nel cuore a causa dell'amore per la vera vita che precede la e che, riscaldando il cuore, suscita parole involontarie e che tuttavia il ricordo [di Dio] fa scaturire. Quante volte, su questa strada, non sono sgorgate lacrime a partire dal calore del cuore e dal soccorso di Dio! È questo che [i padri] chiamano ,.,.,_,., •• "W··~ pura2oo.
Nello stesso scritto Isacco enumera molti livelli di pura, corrispondenti a diverse tappe della crescita interiore e dovuti ai vari influssi dello Spirito santo sull'anima:
La preghiera pura consiste nel fatto che il pensiero non sguazza negli impulsi risvegliati in noi dai demoni o dalla natura o dai ricordi, oppure dai moti del nostro carattere. Anche nella preghiera pura ci sono varie misure, secondo i gradi del pensiero di coloro che la offrono. Più un pensiero si innalza al di sopra dell'amore per le realtà di questa terra, più esso è risparmiato dalle immàgini che, ad opera delle distrazioni, si affacciano al momento della preghiera. Quando è completamente elevato al di sopra dell'amore per le cose di quaggiù, il
20° Centurie di co>toscem:a III, I3.
255

pensiero non dimora più presso la preghiera ma si libra in alto al di là della preghiera pura, perché l'alba della sorge di continuo nella sua preghiera, ed esso è di quando in quando attirato fuori di sé da qualche azione santa. L'amore per le realtà temporali e la riflessione su di esse u"''"'"'"'-'-Hlv
porzione, e i pensieri scemano con il ridursi della nr1ess1o,ne e quanto più scemano tanto più l'anima si "u''"Li'-"• sura in cui l'anima si purifica, l'azione [dello ~,., ...... VJ
offerta al pensiero al momento della prt!gtueJta
Nel pensiero di Isacco la preghiera pura è estremo di ogni preghiera; oltre questo
ultimo e limite non c'è più pre-
ghiera:
Come la forza delle e dei comandamenti dati da Dio tro-vano il loro fine nella purezza cuore, secondo la parola dei padri, così anche tutti i modi e le della preghiera di cui ci si serve per pregare Dio trovano in essa il loro fine. I gemiti, le prostrazioni, le suppliche che partono dal più profondo del cuore, le dolci grida di lamento e tutte le altre forme di preghiera hanno infatti il loro come ho già detto, nella preghiera pura e si estendono fino ad essa. Una volta che la mente supera questo limite ... non possiede più né preghiera, né moti, né pianti, né dominio di né libero arbitrio, né supplica, né desiderio, né aspirazione fervente verso le realtà sperate in questa vita o nella vita futura. Ecco perché al dì là della preghiera pura non c'è più preghiera202 •
Quelli che raggiungono lo stadio della preghiera pura, aggiunge Isacco, sono molto
Se ne troverà uno su mille che ... sia stato giudicato degno di «1';!~1U111';1:1<: la pura ... Quanto al mistero che viene
201 Centurie dì conoscenza 202 1,23 (p. n6) Touraille 32 rn); PR 22 (p. I65).
dopo e si trova al di là di essa, a mala pena in ogni generazione se ne troverà uno che, per grazia di Dio, abbia potuto attingere a questa conoscenza203 .
Ecco perché la preghiera pura consiste nella divagazione la mente in mezzo alle cose di Dio, quando più niente di terreno o di futile si trova mischiato ai suoi slanci. Questa nrP·on1P
ra è prossima alla meditazione, e l'una e l'altra sono le tappe più elevate dello sforzo della preghiera. Ciò che si colloca al di là della preghiera pura e viene chiamato spirituale", stupore, contemplazione, beatitudine, non è più È già pienezza di vita in Dio e appartiene alla vita secolo a ve-nire: proviene dall'esperienza della preghiera, ma ne LJ."'"'-''u'-1"-'
confini.
20' 1,23 (p. I r7l Touraille 32 (p. r98); PR 22 (pp. r66-r67).
2 57

VII VITA IN DIO
Breve, fratello mio, è il tempo della nostra vita, l'apprendistato del nostro mestiere lungo e difficile, ma inenarrabili i beni ci sono stati promessi!
Cer~turie di cor~oscer~za III,62
O uomo, attento a ciò che senza fatica, non troverai, e se non bussi con ardore alla porta e non vegli incessantemente, non sarai esaudito.
Con il tema della "preghiera spirituale", vista come lo stato in cui la mente dell'uomo è ridotta al silenzio, cominceremo questo capitolo dedicato alla mistica di !sacco. Passeremo poi a discutere della contemplazione-theorfa, dell"' accoglimento sotto l' ombra" (obumbratio) e dell'illuminazione. considerare alcuni temi caratteristici di !sacco quali lo "stupore" (estasi) e l"'ebbrezza" causati dall'amore di Dio. concludere, ci soffermeremo sulla sua gnoseologia, cioè il suo msef!:J1amento sulla conoscenza che nasce dalla fede in Dio.
Prima di procedere è opportuno osservare che sono tutti strettamente collegati fra loro ed è difficile ~"'r'"'"''""" per sottopor li a un'analisi puntuale. Pertanto, al fine di dare alla
2 59

teologia mistica di !sacco una parvenza di sistematicità, è necessaria un'analisi semantica preliminare dei termini da lui usati per designare i diversi aspetti dell'esperienza mistica. Ci soffermeremo sui principali, illustrando il ventaglio semantico di ciascuno. Sulla base di questa analisi saremo meglio attrezzati per esprimere un giudizio sul carattere peculiare della mistica del nostro autore.
La "preghiera spirituale" e la "quiete della mente"
Secondo !sacco, la differenza tra la preghiera pura e ciò che sta oltre consiste in questo: durante la preghiera pura la mente è piena di svariati impulsi (zaw'e) di preghiera (per la liberazione dalle tentazioni, ad esempio); al di là della preghiera pura, invece, la mente è libera da ogni impulso. C'è una preghiera pura e c'è una "preghiera spirituale (~lata ru~anayta)" 1 : quest'ultima, ripresa da Giovanni di Apamea e da altri autori ascetici antichi, denota per !sacco uno stato posto oltre i confini della preghiera pura. Per lui, purezza della preghiera significa che niente di esteriore viene a intorbidarne gli impulsi, "nessun pensiero estraneo e nessuna inquietudine riguardo a qualsivoglia argomento". Per quanto riguarda la "preghiera spirituale", essa non comporta più alcun moto della mente,
perché i santi nel secolo a venire, quando il loro intelletto sarà stato inghiottito dallo Spirito, non pregheranno più per mezzo di preghiere ma risiederanno con stupore nella gloria che
1 Cf. É. Khalifé-Hachem, "La prière pure et la prière spirituelle selon Isaac de Ninive", in Mémorial Mgr Gabriel Kbouri-Sarkis, Impr. Orientaliste, Louvain r969, pp. 157-173·
z6o
sarà la loro gioia. Lo stesso succederà anche a noi. Da quando è giudicato degno di presentire la beatitudine futura, l'intelletto dimentica se stesso e tutte le cose di quaggiù, e non sente più alcun impulso verso alcunché 2 .
La "preghiera spirituale" che comincia al di là dei confini della preghiera pura è la discesa della mente in uno stato di riposo e di quiete, in cui ogni genere di preghiera viene meno:
Nella vita della mente ... non c'è più nessuna preghiera. Tutte le preghiere sono fatte di squisiti pensieri e slanci spirituali. Ma a livello "psichico" e nella vita dell'anima non ci sono più né pensieri né impulsi, e nemmeno il minimo sentimento del più piccolo moto dell'anima in rapporto a chicchessia; anzi, la natura umana si trova molto lontana da questo e da tutto ciò che le è proprio. L'uomo è allora immerso in un silenzio ineffabile e inesplicabile, giacché l'azione dello Spirito santo è avviata in lui ed egli è innalzato al di là di quanto l'a1ùma possa comprendere 3•
Per !sacco i concetti di riposo o silenzio (shetqa) e di preghiera spirituale sono sinonimi. Lo stato di silenzio o la quiete della mente non si acquistano con sforzi umani, ma sono un dono di Dio:
Quando la mente è totalmente sciolta da ogni pensiero o riflessione, allora abbiamo il silenzio della mente\ non la preghiera pura. La preghiera pura è una cosa, ma la mente silenziosa, lontana da ogni divagazione o riflessione sulle parole
2 I,23 (p. rr9) = Touraille 32 (p. 200); PR 22 (p. qo). 3 II,32,4. 4 O "silenzio del pensiero (sbetqa d-re'yana)". Nella nostra traduzione della secon
da parte degli scritti di I sacco il termine sbelya è reso con "quiete", sbetqa con "calma'' o "silenzio", re<yana con "pensiero" e hawntl con "intelletto". Nei passi ripresi dalla prima parte dei suoi scritti, la logica di queste traduzioni non è sempre rispettata nella misura in cui esse non sono state condotte sull'originale siriaco.
z6r

della preghiera e quindi priva di moti, è un'altra cosa, completamente diversa. Nessuno è cosl sciocco da volerla conquistare a forza di braccia e della propria volontà, poiché si tratta eli un dono di rivelazione all'intelletto, che oltrepassa la misura della preghiera pura e trascende le capacità della volontà5 .
Secondo Isacco il termine "preghiera spirituale" è usato dagli autori ascetici in senso convenzionale ed è sottinteso che esso designi uno stato non corrispondente alla preghiera nel senso abituale della parola:
z6z
Talvolta ciò che è detto "preghiera spirituale" si chiama "via" o "conoscenza" o ancora "visione spirituale". Vedi come i padri cambiano continuamente i nomi delle cose spirituali? La loro precisione, infatti, vale per le cose presenti, ma non esistono vocaboli precisi e puntuali per quelle del secolo futuro. Noi possiamo solo sapere che esistono, ma sono al di là di
denotazione, di ogni principio o immagine, configurazione o colore, e al eli là di qualsiasi vocabolo inventato da noi. Per questo motivo, quando la conoscenza dell'anima si innalza al di là del mondo visibile, i padri per alludervisi servono di qualsiasi denominazione piaccia loro, giacché non c'è nessuno sia in grado di nominarla con precisione ... Tuttavia, come scrisse Dionigi, per dare una certa coerenza alle loro riflessioni ricorrono a termini e parabole: "Noi usiamo parabole, sillabe, nomi plausibili e termini derivati dai sensi, ma quando la nostra anima è muta a causa dell'azione dello Spirito verso le cose di Dio, i sensi e la loro attività diventano
come superflue sono ormai le potenze dell'anima essa diventa simile a Dio attraverso un'ue quando, nei suoi moti, è risclùarata da
di luce sublime" 6•
199); PR n (pp. r68-r69). La citazione finale è rue:oD2ll!lta I nomi divini 4, r r.
che questo arresto totale dell'attività intellettuale - che chiama calma o "silenzio della mente" e che, da lontano,
può simile al nilvana dei buddisti - è una via d'uscita oltre i confini dell'esistenza personale, paragonabile a una totale perdita della coscienza di sé? La risposta non può che essere negativa. il "silenzio della mente" non è sinonimo di perdita di conoscenza o annullamento delle percezioni. In que-sto silenzio, come lo intende, un elemento positivo: la mente diventa di Dio. A differenza del nirvana, ìl "silenzio della presuppone un'attività estremamente in-tensa mente si trova sotto l'influsso di Dio ed è attratta verso le profondità ancora insospettate dello Spirito:
Appena entrata regno del silenzio la mente cessa di pregare ... A dal momento in cui la direzione e la guida dello Spirito incominciano a governare l'intelletto ... la natura è privata della libertà e l'intelletto, guidato da altri, non si governa più solo. Dove sarebbe allora la preghiera se la natura non avesse più nessun su se stessa ma fosse diretta da un'altra forza? Essa non sa dov'è condotta ed è incapace di orientare i movimenti della sua mente nella dire-zione voluta, ma, e fatta prigioniera da quella for-za, non capisce dove sarà In questa condizione l'uo-mo non ha più desideri e come testimonia la Scrittu-ra, non sa nemmeno più se è o del suo corpo (cf. zCor Iz,z)7.
Si tratta qui di assenza dei movimenti e desideri caratteristici dell'intelletto, non della perdita o dell'annientamen-to della persona. Nel "silenzio della , al contrario, si pro-duce un'intensa comunione dell'uomo personale con il Dio personale. Per !sacco il "silenzio della è allo "stupo-
7 I,23 (pp. rr8-rr9l = Touraille 32 (p. 2oo); PR 22 (pp. r69-qo).

re" e alla "contemplazione", che stanno oltre i confini della prepura:
Ci sarà allora stupore e non più preghiera, giacché tutto ciò che appartiene alla preghiera è ormai cessato e si fa strada una certa contemplazione (te'orya}, mentre la mente non prega più nessuna preghiera ... La preghiera è la semina, la contemplazione la messe, dopo la quale il contemplativo è condotto verso lo stupore davanti a una visione ineffabile: come hanno potuto, dai granelli piccoli e nudi che aveva seminato, sptmtare all'improvviso davanti a suoi occhi spighe così belle? La sua attività personale rimane allora priva di ogni movimento8
•
Non è difficile individuare l'influsso di Evagrio in questo insegnamento sul "silenzio della mente". In particolare, Isacco si basa sulle parole di Evagrio circa la purezza dell'intelletto quando descrive lo stato dì quiete come "ebbrezza" della mente per opera dello Spirito santo, in seguito alla visione della luce divina:
Lo Spirito santo, infatti, agisce in tutti gli uomini, secondo le forze di ciascuno ... in modo tale che la preghiera è privata di movimento e l'intelletto è colpito e inghiottito dallo stupore ... i suoi movimenti sono immersi in un'ebbrezza profonda ed esso non fa più parte di questo mondo. Allora non ci sarà più distinzione tra anima e corpo né rimembranza di alcunché, come ha detto Evagrio: "La preghiera è la purezza dell'intelletto, concessa solo dalla luce della santa Trinità, nello stupore dell'uomo". Inoltre, aggiunge Evagrio: "La purezza dell'intelletto fa spiccare il volo alle facoltà intellettuali e assomiglia alla luce del cielo, nella quale irradia la luce della santa Trinità durante la preghiera" 9
.
8 l,23 (pp. rr6-rr7) Touraille 32 (pp. I,28 (p. I2I) PR 2.2 (p. I74l. Le
Skemmata 2 7 e 4-
PR 22 (pp. r65- r66). sono tratte da Evagrio Pontico,
Isacco segue l'insegnamento dì Evagrio sull'intelletto e la sua natura luminosa, e anche quello di Dionigi l'Areopagita sulla "beata ignoranza" che supera ogni conoscenza umana:
Quando l'intelletto si spoglia dell'uomo vecchio e riveste il nuovo, quello della grazia, vede la propria purezza simile a un colore celeste10
, che gli antichi figli d'Israele chiamarono ''luogo di Dio", quando Dio apparve loro sulla montagna (cf. Es 24,9 Ecco perché, come ho già detto, questo dono e questa non devono essere chiamati preghiera spiritua-le, ma sono i germogli preghiera pura, ormai inghiottita dallo Spirito santo. In tale momento l'intelletto si trova al di là della preghiera, che è stata abbandonata perché qualcosa di meglio è apparso. L'intelletto allora non prega con la preghiera, ma si sente rapire e contempla cose inafferrabili che travalicano i confini del mondo mortale, ed è ridotto al silenzio dall'ignoranza di tutto ciò che vi si trova. Ecco l'ignoranza che è detta essere più sublime della conoscenza 11 •
Agli occhi di Isacco la preghiera spirituale è una partecipazione al secolo futuro, esperienza del paradiso in terra. Proprio gra
alla preghiera spirituale l'esperienza della contemplazione, di cui i santi sono giudicati degni nel secolo futuro, è concessa all'uomo nel corso della sua vita terrena:
L'anima non prega con la preghiera ma esperimenta le realtà spirituali del secolo a venire, realtà che trascendono il sapere dell'uomo e la cui comprensione è possibile solo grazie alla potenza dello Spirito santo. Ma qui si tratta della contemplazione dell'intelletto e non di un movimento o di un'espressione della preghiera, benché nella preghiera tale contemplazio-
1° CL Evagrio Pontico, Skemmata 4· u !,23 (pp. I2I-I22) PR 22 (pp. 174·I75l. CL Pseudo-Dionigi l'Areopagita, Teo
mistica r,2-3.

ne abbia avuto inizio ... È a partire da questa preghiera che lo Spirito santo innalza alla contemplazione chiamata "visione spirituale" 12
•
L'insegnamento di !sacco sulla preghiera spirituale e sul silenzio della mente già delinea i temi principali della sua teologia mistica, in particolare quelli della contemplazione, della visione spirituale, dello stupore, dell'ebbrezza e dell'ignoranza, che ora esammeremo uno per uno.
La contemplazione
Nel vocabolario mistico di !sacco si è subito colpiti dal termine contemplazione (te'orya), ripreso pari pari dal greco theoria. !sacco lo attinge dal linguaggio di Evagrio e di Dionigi l'Areopagita. Presso gli autori siriaci che lo hanno preceduto - Afraat, Efrem, Narsai e Giacomo di Sarug- tale termine non si trova. Filosseno di Mabbug fu probabilmente il primo autore di lingua siriaca a usarlo (in particolare nella sua Lettera a Simeone, successivamente attribuita a !sacco). Nei secoli vr e vrr il termine entra nell'uso degli autori ascetici siro-orientali grazie alla loro conoscenza delle opere di Evagrio 13 . In un contesto di teologia mistica viene tradotto con "contemplazione" o "visione divina". !sacco lo rende con "visione spirituale" 14.
12 I,37 (pp. r82-r83) ~ Touraille 85 (p. 438); PR 35 (p. z6o). 13 Cf. S. Brock, "Some Uses of the Term 'Theoria' in the Writings of Isaac of Ni
neveh", in Parole de l'Orient zo {r995 [r996]), pp. 407-4r9. "I,37 (p. r83) ~ Touraille 85 (p. 438); PR 35 (p. z6o). Nella sua traduzione ingle
se della prima parte, Miller traduce "visione divina", mentre Brock, nella seconda parte, preferisce "contemplazione". Noi usiamo normalmente "contemplazione" per rendere te '01ya.
Il termine "contemplazione" in !sacco ricorre associato a svariati aggettivi: essenziale, divina, nascosta, esatta, noetica, naturale, angelica, elevata, spirituale, verace, celeste, e altri ancora. !sacco parla della contemplazione dei misteri, di quella dell'essere divino, della provvidenza, dell'attività creatrice di Dio, delle cose create, delle proprietà di Cristo, del giudizio, delle cose immateriali, della sapienza, della passione di Cristo, delle realtà spirituali, della Scrittura, degli angeli, dello Spirito, della verità, del secolo a venire. Come ha dimostrato Sebastian Brock, la maggior parte di queste espressioni sono tratte dal vocabolario di Evagrio 15 . Quello che soprattutto ci interessa è la contemplazione in quanto fenomeno mistico; pertanto ci limiteremo allo studio dei testi che trattano della contemplazione di Dio e del mondo immateriale.
!sacco usa sovente il vocabolo "contemplazione" come sinonimo di "visione di Dio". Egli parla di uno stato sovrannaturale dell'anima come del suo "movimento verso la contemplazione della divinità transustanziale" 16 . In esso l'anima "si slancia ... ed è innalzata sulle ali della fede al di là della creazione visibile e diventa quasi ebbra di stupore nella sua frequentazione di Dio, grazie a una visione semplice e a intuizioni invisibili della natura divina" 17
• I sacco sottolinea allo stesso tempo che i giusti non possono vedere l'essenza di Dio: "Quando si è innalzati alla contemplazione di Dio, ciò che si vede non è la natura di Dio bensì la 'nube oscura della sua gloria"' 18
. L'uomo non è capace di vedere nient'altro che un riflesso dell'essenza di Dio, anche se questa visione sarà più completa nel secolo a venire:
Più l'uomo diventa perfetto in rapporto a Dio, più lo segue dappresso. Nel secolo di verità Dio gli mostrerà il volto ma
"Cf. S. Brock, "Some Uses of the Term 'Theoria'". 16 I,3 (p. r8) ~ Touraille 83 (p. 405); PR 3 (p. 23). 17 I,52 (p. 263) ~ Touraille 65 (p. 343); PR 5r (p. 377). 18 II,ro,q.

non l'essenza, giacché, per profonda che sia la loro contemplazione, i giusti non vedono Dio se non in enigma, come riflesso in uno specchio (cf. rCor I},rz), nel quale però appare loro la rivelazione della verità 19 .
Isacco distingue vari tipi di contemplazione. Una cosa è contemplare l'azione di Dio nel mondo creato, altra cosa è contemplare l'essenza stessa dell'essere divino. La prima, nella sua forma naturale, la traiamo dalle impressioni che riceviamo dal mondo sensibile. La seconda non proviene né dall'intelletto né da un oggetto esteriore. Amala pena un giusto su mille è giudicato degno di questo stato sublime. Dalla contemplazione della divinità nasce quella dell'incarnazione e dell'apparizione di Dio nella carne.
Accanto alla contemplazione di Dio nella sua essenza e nelle sue azioni c'è anche la contemplazione delle potenze angeliche "nella loro vera natura e nella sfera loro propria". La contemplazione degli angeli dev'essere distinta dalle visioni nelle quali essi appaiono agli uomini sotto forma visibile. Queste ultime non sono vere visioni ma solo manifestazioni degli angeli per incoraggiare i semplici. Solo la prima specie di visione, la contemplazione degli angeli nella sfera invisibile che è loro propria, merita davvero il nome di contemplazione: "Essa appartiene agli uomini che hanno ricevuto illuminazione e sapienza e sono stati innalzati al rango della purezza grazie alla condotta gloriosa della quiete" 20
.
!sacco usa il termine theoria in rapporto alla Trinità e a Cristo. Egli distingue tra la "contemplazione dell'essenza divina" e la "contemplazione del mistero delle distinzioni tra le persone21
dell'essenza [divina]" 22 • Quando adotta il vocabolario di Eva-
19 1,48 (pp. 230-231) = Touraille 73 (p. 369); PR 45 (p. 324). 20 1,22 (pp. r r 3-r r 4) = PR 20 (pp. r6r-r62). 21 Qnome è qui applicato alle persone in Dio. 22 Centurie di conoscenza II,4.
z68
grio distingue anche tra la "contemplazione naturale seconda" 23
e la "contemplazione che nei suoi diversi elementi è anteriore a quella precedente l'esistenza" degli angeli; la prima appartiene agli esseri corruttibili composti di anima e corpo, la seconda agli spiriti incorporei24
•
!sacco distingue inoltre la "contemplazione naturale" (kyanayta), che è in rapporto con la natura dell'anima, dalla "contemplazione spirituale" (ru~anayta), dono soprannaturale di Dio. La prima era propria dell'uomo nel suo stato naturale anteriore alla caduta; la seconda fa parte della beatitudine del secolo futuro. Egli scrive:
La contemplazione avvicina l'anima alla nudità dell'intelletto che è chiamata theorfa immateriale. Si tratta di una disciplina spirituale, giacché innalza il pensiero al di là della sfera terrestre, lo avvicina alla contemplazione originaria dello Spirito e lo concentra in Dio e nella contemplazione della gloria ineffabile ... Quando l'intelletto dei santi riceve tale contemplazione, quella naturale viene loro tolta insieme al carattere grossolano dei corpi, e la loro contemplazione diventa spirituale. Chiamo contemplazione naturale quella propria allo stato primitivo della natura creata. A partire dalla contemplazione naturale l'uomo è portato facilmente alla conoscenza della vita unitiva che è, in parole semplici, lo stupore davanti a Dio. Si tratta di una condizione elevata, a causa del godimento dei beni futuri, che sarà accordato nella libertà della vita immortale, nella vita dopo la resurrezione 25
.
Così la contemplazione di Dio è l'esperienza dell'uscita da questo mondo per comunicare con il secolo a venire. Isacco sot-
23 La contemplazione di cui, secondo Evagrio, godette Cristo (Capitoli gnostici II,2 ss.).
24 Cf. Centurie di conoscenza II,ro5. 2 ' 1.43 (pp. 213-214) = Touraille I7 (p. r2r); PR 40 (pp. 303-304).

tolinea questo carattere escatologico della contemplazione di Dio affermando che il regno dei cieli è la "contemplazione spirituale (te'orya rupanayta)" 26 • L'esperienza di tale regno comincia nella vita presente e prosegue in quella futura. Tuttavia pochi diventano degni di questo dono al tempo della loro vita e la maggior parte di loro sono asceti e solitari che hanno rinunciato al mondo:
La contemplazione spirituale ... si dispiega in intuizioni luminose. Chi la non ha più interesse a questo mondo né attaccamento al corpo ... Se Dio avesse accordato uom1ru anche solo un istante questa vera contemplazione, non si sa-rebbero più generazioni sulla terra. È una contem-plazione che l'uomo con legami ai quali la natura non può resistere . . . una grazia divina ... ed è concessa larmente a chi Dio sappia essere veramente degno di abbandonare questo mondo per una vita migliore ... È una che cresce e dimora in coloro che abitano luoghi solitari e appartati ... Dobbiamo chiedere questa contemplazione nelle nostre preghiere; per essa dobbiamo votarci a lunghe e stare in lacrime davanti a Dio per chiedergli la concessione di una tale grazia impareggiabile27 •
Agli occhi di Isacco la contemplazione è essenzialmente ta alla quiete (shelya) della mente:
La luce della contemplazione va di pari passo con la quiete {shelyuta) ininterrotta e con il recedere delle impressioni che provengono dall'esterno. Dopo aver fatto il vuoto dentro di sé, l'intelletto sta continuamente all'erta nell'attesa che sorga in lui la contemplazione28 .
26 1,72 (p. 353) = Touraille 19 (p. 131); PR 27 1,49 (p. 2 39) = Touraille 39 (pp.
528). 47 (pp. 336·337).
2' Centurie di conoscenza 1,29.
270
contemplazione di Dio si accompagna alla visita degli
Quando siamo immersi nello stupore a causa delle intuizioni legate alla contemplazione dell'Essenza elevata, quando, come ha detto Evagrio29 , gli angeli si avvicinano a noi e ci colmano di contemplazione, allora si allontana da noi ogni avversità e, finché restiamo in questo stato, una pace e una tranquillità indicibili si diffondono in noi}0 •
Isacco parla di "contemplazioni celesti (te'oryas shmayyanyata)" quando "l'intelletto, esclusi i sensi, è messo in movimento dalle potenze spirituali del mondo superiore che dispongono di innumerevoli meraviglie" 3
\ e di "contemplazioni angeliche" 32.
Queste due formule, che non troviamo né Evagrio né presso i predecessori siriaci di Isacco, indicano una partecipazione degli angeli alla contemplazione.
Si può notare qui come l'insegnamento di Isacco sulla contemplazione tradisca un qualche influsso sistema gerarchico ereditato da Dionigi l'Areopagita, secondo il quale per gli esseri umani è impossibile la contemplazione diretta di Dio, mentre può darsi una contemplazione parziale per il tramite degli angeli. Le rivelazioni su Dio sono prima, attraverso la mediazione di Gesù, trasmesse da Dio stesso agli angeli, poi da questi agli uomini. Facendo eco a questa dottrina dell'Areopagita, Isacco descrive un ordine gerarchico che assicura la trasmissione delle rivelazioni a partire da Dio fino agli uomini:
Gli ci istruiscono, cosi come si istruiscono gli uni con gli altri. Gli angeli inferiori sono istruiti da che li sovra-
2' Il testo greco reca "san Marco".
30 1,69 {p. 337) Touraille 49 (p. 272); PR Tl (p. 497). 31 !,43 (pp. 215·n6) Touraille I7 (pp. 122-113); PR 40 {p. 307). ,, Centurie di conoscenza III,9o.

stano con l'abbondanza della loro luce. In questo modo ocrni ordine è istruito da un altro, risalendo tutti i gradi fino a q~el-l'ordine unico è istruito dalla santa Trinità. Quest'ordine d1e è il primo, chiaramente di non essere istruito da s; stesso ma dal mediatore Gesù, dal quale riceve tutto ciò che trasmette agli ordini inferiori. Secondo me, il nostro intelletto non ha il potere naturale di avviarsi alla contemplazione di Dio ... Anche se fossimo diventati puri e senza macchia, senza l'intermediazione delle essenze angeliche non riusciremmo ad avvicinarci alla rivelazione e alla conoscenza che conducono alla contemplazione eterna, vera rivelazione del mistero. Il nostro intelletto non possiede questa capacità, che è propria esseri elevati che ricevono le rivelazioni e le contemplazioni direttamente dall'Eterno, senza intermediari 33 •
Nel secolo a venire i santi contempleranno Dio faccia a faccia . ' ma vlta presente la contemplazione non è possibile se non attraverso la mediazione angeli:
272
Quando nell'intelletto dei santi si produce la sensazione della rivelazione di un qualche essa viene angeli. Quando Dio lo permette, la rivelazione si trasmette da un ordine superiore a uno inferiore, e così via fino al più basso. Se dunque, a un cenno di Dio, è concesso a un ogcretto di arrivare fino alla natura umana, questo è trasmesso ;traverso coloro che ne sono degni al più alto grado. Infatti è aali ordini [angelici] più elevati i santi ricevono la luce"' della contemplazione e della contemplazione fino al glorioso Essere eterno-, mistero che non può essere insegnato ... Nel secolo futuro, tuttavia, quest'ordine di cose sarà abolito, per-
la rivelazione della gloria di Dio non sarà ricevuta da altri ... ma ognuno riceverà senza intermediari quello che ha meritato in proporzione alle sue fatiche 34
•
(p. 139) = Touraille 84 (pp. 413-414); PR 27 (pp. ,a-;.TCm>
(p. qo) = Tourai!le 84 (pp. 414-415); PR 27 (pp.
Visioni, rivelazioni, intuizioni
I termini "visione" (/;zata) e "rivelazione" (gelyana) sono strettamente associati a di "contemplazione". Tuttavia, mentre quest'ultima è caratterizzata dall'indispensabile mediazione degli angeli, le visioni e le rivelazioni suggeriscono spesso un contatto diretto con il mondo superiore. Al tempo stesso, come abbiamo visto, angeli non sono assenti dalle visioni, ma la loro funzione non si limita alla mediazione tra Dio e l'uomo. Al contrario essi svolgono visioni un ruolo indipendente co-me dei misteri dì Dio.
!sacco definisce la "visione divina" (/;zata alahaya) una "rivelazione fatta all'intelletto al di là dei sensi" 35
• i termini "visione" e "rivelazione" sembrano sinonimi, ma intercorre fra di essi una differenza semantica sulla quale il nostro autore ri-chiama l'attenzione testo seguente:
Domanda: Visione e rivelazione sono la stessa cosa? Risposta: No, tra i due termini c'è una differenza. Spesso entrambi i concetti sono designati con il termine di rivelazione: poiché in un caso come nell'altro viene rivelato qualcosa di nascosto, visione è chiamata rivelazione. Ma non ogni rivelazione è una visione. Il termine "rivelazione" è usato il più delle volte per cose che saranno conosciute, che sono sperimentate e afferrate dall'intelletto. Ma le visioni hanno luogo in molteplici modi, per esempio sotto forma di somiglianze e di immagini, come nell'Antico Testamento, in un sonno profondo o in stato di veglia, talora con tutta altre volte in modo più oscuro attraverso parvenze. Per questo motivo chi riceve una visione spesso non sa se sogna o è Può darsi che senta una voce che gli porta soccorso, o intrave-
"I,22 (p. II3) PR 20 (p. I62).
2 73

da una certa forma, mentre a volte vede in modo più chiaro, faccia a faccia ... Visioni del genere si producono in luoghi deserti e abbandonati dagli uomini, dove l'uomo ne ha maggiore bisogno, privo com'è di ogni aiuto o consolazione che gli provenga dal luogo stesso. Ma le rivelazioni, che sono percepite nell'intelletto e vengono facilmente accolte se questo è puro, si presentano solo ai perfetti e a quanti sono in grado di comprendere36.
Una "rivelazione" è quindi superiore a una "visione". Inoltre, il concetto di "rivelazione" è più generale di quello di "visione". La rivelazione è indice di un'esperienza interiore, mentre la visione si riferisce ad apparizioni visibili e concrete provenienti dal mondo immateriale. Le apparizioni degli angeli ai martiri e agli asceti appartengono più specificamente al campo delle visioni:
Che i santi martiri ti siano di esempio e di incoraggiamento. Essi hanno spesso combattuto in molti insieme per Cristo, o talvolta da soli, in luoghi diversi ... Gli angeli sono loro apparsi sotto forma visibile ... C'è forse bisogno di ricordare gli asceti e gli eremiti divenuti stranieri a questo mondo? Del deserto essi fecero una città37
, una dimora e un luogo d'accoglienza per gli angeli, i quali li frequentavano assiduamente a causa della loro eccellente condotta di vita ... E poiché costoro, avendo abbandonato ciò che appartiene alla terra e amando le cose del cielo, erano diventati imitatori degli angeli, era giusto che questi ultimi non si celassero ai loro occhP8 •
Ma non apparvero loro solo gli angeli; dopo la morte, anche i santi si manifestarono nel sonno a quegli asceti:
36 1,37 (pp. q6·rn) = Touraille 85 (pp. 430-43r); PR 35 (pp. 249-250). 37 Cf. Atanasio di Alessandria, Vita di Antonio r4. 38 1,5 (p. 44) = Touraille 5 (pp. 79-8o); PR 5 (p. 65).
274
Molti che avevano raggiunto lo stato di purezza sono stati giudicati degni di contemplare nelle loro visioni notturne il volto dei santi ... Si dice che gli angeli rivestano le sembianze di certi santi beati e degni e le mostrino in sogno all'anima nel tempo dell'assenza dei pensieri, per la sua gioia, il suo arricchimento e la sua letizia39 •
Il termine "rivelazione" suggerisce una vicinanza interiore a una realtà che non è di questa terra, ma non comporta necessariamente la visione di immagini. Esso è generalmente usato al plurale:
L'inizio della contemplazione spirituale è quello di tutte le rivelazioni nell'intelletto, attraverso le quali esso cresce e si fortifica nelle cose nascoste, e in tal modo progredisce verso altre rivelazioni che sorpassano la natura umana. È così che sono trasmesse tutte le contemplazioni divine e tutte le rivelazioni dello Spirito che i santi ricevono in questo mondo40•
Qui Isacco considera le rivelazioni alla stregua di fenomeni che accompagnano l'intelletto nelle diverse tappe della sua evoluzione: il percorso dell'intelletto è considerato un cammino che porta da una rivelazione all'altra.
Per Isacco le "rivelazioni" sono, fin da questa vita, un'esperienza di comunione con il regno di Dio:
La rivelazione del bene che è in noi consiste nel fatto di sperimentare la conoscenza della verità: "Il regno di Dio è misticamente dentro di voi" (cf. Le q,2r) ... Lo stupore di fronte alla natura divina è la rivelazione del secolo nuovo. Le rivelazioni del secolo nuovo sono impulsi che, grazie a Dio, ci rapiscono. Tutte le nature dotate di ragione sono avviate verso
39 1,54 (p. 267) = Touraille 33 (p. 205); PR 53 (p. 38r). 40 1,49 (p. 240) = Touraille 40 (pp. 234-235); PR 47 (p. 338).
275

l'esistenza futura, verso la dimora del cielo. Poiché le sante potenze esistono adesso per opera di questi impulsi, tale è la forma della loro vita. A ogni istante esse sono rapite da questo mistero grazie alle rivelazioni che ricevono sotto varie forme, attraverso il loro orientamento all'essenza divina. Ecco lo stato in cui noi tutti ci troveremo dopo la resurrezione 41
•
!sacco distingue tra le rivelazioni del "secolo futuro" e quelle del "secolo nuovo". Le prime sono incontri con la realtà divina; le altre, intuizioni spirituali circa lo stato escatologico futuro del mondo creato:
Le rivelazioni del secolo futuro sono differenti da quelle del mondo nuovo. Le prime riguardano il carattere glorioso della natura divina, le seconde si riferiscono alle svariate forme delle sorprendenti trasformazioni che subirà la creazione, come pure ai diversi aspetti della loro condizione futura, che l'intelletto apprende per rivelazione intuitiva, grazie alla meditazione continua su di esse e in virtù di un'illuminazione42.
In una delle omelie della prima parte, che non figura nella traduzione greca, !sacco parla delle sei specie di rivelazioni menzionate nella Scrittura: attraverso i sensi; tramite una visione fisica; per effetto del rapimento dell'intelletto; mediante la profezia; attraverso "una qualche forma intellettuale", "come in sogno". Le rivelazioni "attraverso i sensi" si producono o "con l'intermediazione degli elementi", come il roveto ardente, o attraverso la nube della gloria di Dio, e via dicendo; oppure "senza l'aiuto della materia" ma pur sempre "attraverso i sensi corporei", come l'apparizione dei tre uomini ad Abramo, la scala di
41 II,S,I-4-6. 42 II,8,7.
Giacobbe e altre ancora. Tra le rivelazioni che si producono con l'ausilio di una visione fisica si può citare, fra le altre, quella del profeta Isaia che contempla il Signore seduto su di un trono alto ed elevato, circondato dai serafini (cf. Is 6,r ss.). Il "rapimento dell'intelletto" è quello che provò l'apostolo Paolo quando fu rapito al terzo cielo e udì parole divine ineffabili (cf. 2Cor 12,2-4). Le rivelazioni "mediante la profezia" sono giunte ai profeti "che predissero avvenimenti che si sarebbero verificati molti secoli più tardi". La rivelazione "attraverso forme intellettuali" è quella che consente di gettare uno sguardo sulla natura di Dio, sulla resurrezione dei morti, sulla vita del secolo a venire o su altre verità dogmatiche centrali per la fede cristiana. Infine, le rivelazioni possono essere mandate durante il sonno 43 .
!sacco sottolinea il fatto che le rivelazioni possono prodursi sia "per mezzo di immagini" che "senza immagini". Dio concede il primo tipo di rivelazioni al fine di istruire più persone grazie a una "piccola intuizione" della verità. Il secondo tipo, al contrario, è di solito concesso a una sola persona per suo orientamento e consolazione44 . !sacco insiste però sul fatto che le rivelazioni non si debbano intendere come piena verità o conoscenza piena, poiché esse non sono altro che intuizioni della verità, disvelate solo nella misura in cui l'uomo può accoglierle 45 .
Il vocabolo "intuizioni" (sukkale) è semanticamente vicino a "rivelazioni": come questo è usato quasi sempre al plurale e serve a descrivere improvvisi ed eccezionali incontri con realtà dell'altro mondo. Le intuizioni si distinguono dalle rivelazioni per il loro carattere puntuale; esse sono istantanee ma lasciano nell' anima un segno profondo, e si possono produrre a di versi stadi della vita spirituale del cristiano:
. ~ 3 ~~·~R. 20 (pp. ;rs6-r59l = Mystic Tì·eatises, pp. ro6-ro8. Si vedano anche gli svanatl tlpl dt nvelaz10m nportati in Centurie di co11oscenza III,s6.59-6o.
44 Cf. PR 20 (pp. I59-r6o) = Afystic Tì·eatises, p. ro8. 45 Ibid.
277

Può succedere che uno, avendo acquisito il massimo grado di perfezione allo stadio dell'anima, non sia ancora penetrato in quello dello spirito, solo alcuni moti del quale hanno cominciato a farsi sentire in lui. Mentre in tutta la sua condotta si trova ancora allo stadio dell'anima, può succedere a volte che alcuni impulsi spirituali, di quando in quando e confusamente, si facciano strada in lui, e che egli cominci a sentire in sé stesso una gioia e una consolazione nascoste, come lampi di luce ... Intuizioni mistiche sorgono nel suo animo e lo scuotono, e di colpo il cuore esplode di gioia ... Conosco uno della mia cerchia46 che ha esperienza del gusto di tali lampi di luce. Benché l'intuizione mistica attraversi il suo intelletto in un attimo per allontanarsi subito dopo, nondimeno l'esplosione di gioia da essa prodotta e il suo sapore durano a lungo, e la pace da essa diffusa nei suoi pensieri rimane per un bel po' dopo la sua partenza. In questo modo il suo corpo e le sue membra, pacificati, provano un grande ristoro, e la gioia e la dolcezza di questa meraviglia, gustate nel momento supremo, restano a lungo impresse nel suo palato spirituale 47
•
Le "intuizioni" sono per così dire delle risorgi ve spirituali che sgorgano all'improvviso durante la preghiera o la lettura delle Scritture. In quei momenti l'intelletto penetra nel Santo dei Santi dei misteri della Scrittura, nei sensi spirituali più reconditi di quest'ultima, e stabilisce un contatto immediato con Dio. Ecco perché, come al momento della quiete dell'intelletto, la preghiera cessa:
Quando parlo di preghiera penso allo stare in piedi o a un servizio liturgico preciso, giacché quando egli [l'asceta] si dedica alla lettura, non è mai privato, nemmeno un istante, di queste risorgive della preghiera. Non c'è infatti lettura [delle Scrit-
46 Sembra evidente che qui Isacco parli di se stesso in terza persona. 47 II,zo,r9-20.
ture] -purché intrapresa a fine spirituale- che sia priva ditale fonte di preghiera, poiché l'uomo che la compie è letteralmente inebriato dai misteri che incontra. Preghiere profonde si sommuovono dentro di lui, in modo sorprendente e inatteso, senza preparazione né sforzo di volontà da parte sua. Ma perché chiamare preghiera questa frequente ebbrezza occasionata da un'intuizione, quando in essa non c'è più posto per alcun impulso di preghiera né per un ricordo che la riguardi? In effetti, si tratta di qualcosa di più eccellente - se mi è lecito esprimermi così - dello stadio della preghiera. La preghiera si colloca a un livello inferiore rispetto a quello degli impulsi spirituali, giacché è innegabile che la preghiera sia inferiore a quel tipo di mistero. Sovente, quando l'intelletto è commosso da qualche intuizione relativa a un avvenimento proveniente dalla natura o dalle Scritture, quando l'asceta scandaglia il loro senso spirituale e, con l'aiuto della grazia, scruta il Santo dei Santi dei loro misteri, non gli resta più un briciolo di forza per pregare o pensare, perché a questo punto è ridotto al silenzio nel corpo e nell'anima. Ogni avvenimento, natura o parola di questa creazione presente ha il suo tempio e il suo Santo dei Santi. E quando l'intelletto è autorizzato a entrarvi e riceve la forza per farlo, allora nei suoi sensi non resta nessun'altra forza, impulso o attività. Tra coloro che sono qui riuniti c'è qualcuno 48 che ne ha fatto continuamente esperienza: so che il suo cuore batte più forte quando incontra un momento simile nelle sue letture; e questo gli viene dalla sua esperienza 49 .
Ecco perché si può parlare di visioni, rivelazioni e intuizioni come di aspetti diversi del medesimo fenomeno dell'incontro con Dio e con le realtà del mondo immateriale. Così le "visioni" stanno a significare gli incontri con esseri dell'aldilà (anaeli
b ' santi) che appaiono sotto una forma visibile; le "rivelazioni" so-
" Senza dubbio Isacco parla nuovamente di se stesso. 49 II,Jo,S-r r.
2 79

no una sorta di accesso all'essenza di Dio o al rinnovamento escatologico del mondo creato; le "intuizioni" sono sfolgoranti lampi mistici che si producono nell'intelletto dell'uomo quando i misteri del secolo futuro gli vengono subitamente rivelati, nel tempo della preghiera e della lettura delle Scritture.
L"'accoglimento sotto l'ombra" e l'illuminazione
Dobbiamo ora esaminare due termini della mistica di Isacco che esprimono l'azione della grazia di Dio sull'uomo: "il fatto di essere accolto sotto l'ombra di Dio", che in latino sarà detto obumbratio, e l"'illuminazione". In collegamento con quest'ultimo termine bisognerà anche trattare della concezione della "luce mistica".
Il termine siria co maggnanuta50 significa "discesa", "accoglimento sotto l'ombra", "protezione". Esso indica un'azione particolare di un superiore verso un sottoposto. Per Isacco, che vi ha consacrato un'intera omelia51, l'"accoglimento sotto l'ombra" significa un'influenza positiva dello Spirito santo sull'uomo. Il nostro autore comincia con il definire il significato del termine e l'uso che ne viene fatto nella Bibbia:
L'espressione "accoglimento sotto l'ombra" evoca aiuto e protezione, ma anche la ricezione di un dono dal cielo. Per esempio: "Lo Spirito santo scenderà su di te, su di te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo" (Le r,35). Un'altra forma di "accoglimento sotto l'ombra" si trova nel passo: "La tua
5° Cf. S. Brode, '"Maggnanqta'. A Technical Terrn in East Syrian Spirituality", in Mélanges Antoine Guillaumont, Ed. P. Crarner, Genève r988, pp. rzr-r29.
51 II,r6; manca nella traduzione greca.
destra, Signore, mi prende sotto la sua ombra" (Sal r38,7-8), che è una richiesta di soccorso, proprio come "prenderò questa città sotto la mia ombra e la salverò" (zRe r9,34; Is 38,6). Possiamo così distinguere due generi di "accoglimento sotto l'ombra" degli uomini da parte di Dio: l'uno è misterioso e spirituale, l'altro ha luogo nel corso degli avvenimenti52 •
Il primo "accoglimento sotto l'ombra" è la
santificazione ricevuta attraverso la grazia di Dio; cioè il fatto di essere santificati nel corpo e nell'anima dall'azione dello Spirito santo, come accadde a Elisabetta, a Giovanni Battista e alla beata Maria, la benedetta tra le donne; benché quest'ultimo caso non possa essere messo sullo stesso piano degli altri, perché }"'accoglimento sotto l'ombra" di Maria è superiore a tutto ciò che sia mai stato concesso alle nature create.
Un simile "accoglimento sotto l'ombra" accade a ogni santo quando diventa degno di una rivelazione di Dio e di un intervento dello Spirito santo:
La forma mistica dell"'accoglimento sotto l'ombra" che capita ad alcuni santi rappresenta l'attività di chi prende l'intelletto [dell'uomo] sotto la propria ombra. Quando uno è giudicato degno di un simile "accoglimento sotto l'ombra", l'intelletto è rapito dallo stupore e si allarga per una qualche divina rivelazione. Finché questa attività prende l'intelletto sotto la propria ombra, l'uomo è innalzato al dì là del movimento dei pensieri dell'anima grazie alla partecipazione allo Spirito santo ... Quando questa forza accoglie qualcuno sotto la sua ombra, questi è giudicato degno della gloria del secolo futuro mediante le rivelazioni. Tale partecipazione parziale era quel-
52 II,r6,z-3 = PR 54 (p. 390).

la dei "santi nella luce" (Col I, I z) di cui ha parlato il beato Paolo, partecipazione di cui sono degni coloro che hanno ricevuto dallo Spirito la santificazione del loro intelletto grazie a una condotta santa e piena di opere buone 53
.
La seconda specie di "accoglimento sotto l'ombra" si esplica nella prassi quotidiana. Essa è
una forza spirituale che protegge l'uomo e aleggia continuamente sopra di lui'\ allontanando tutto ciò che potrebbe arrecargli danno al corpo e all'anima, ed è percepita invisibilmente da un intelletto illuminato che possiede la conoscenza grazie all'occhio della fede 55.
Così, il secondo "accoglimento sotto l'ombra" ha un carattere mistico come il primo, ma è accompagnato da una "visione invisibile", cioè da un'esperienza contemplativa di una realtà invisibile e accessibile solo "all'intelletto illuminato". Si vede da tali affermazioni che l'espressione "accoglimento sotto l'ombra" è semanticamente vicina a "visione" e "contemplazione".
Il termine "illuminazione" (nahhiruta) indica a sua volta un'attività diretta di Dio e non dell'uomo. Esso deriva da nuhra, "luce", e si applica a un'azione di Dio che implica una presenza luminosa. Isacco ne parla nelle Centurie di conoscenza:
Si riceve l'illuminazione (nahhiruta) secondo la qualità del proprio comportamento nei riguardi di Dio. Nella misura in cui si è attratti verso la conoscenza, l'anima è sempre più libera e si passa da una conoscenza a un'altra sempre più elevata. La luce (nuhra) che non viene dalla conoscenza è una luce che
"II,I6,s-6 = PR 54 (p. 39I). " I sacco usa qui la stessa parola di Gen I ,2: "Lo spÌiito di Dio aleggiava sulle
acque". "II,I6,7 = PR 54 (p. 39I).
z8z
viene dagli elementi [materiali], ma nel mondo nuovo sorgerà una luce nuova. Non ci sarà più alcun bisogno di usare di ciò che è corporale o che viene dagli elementi. La luce della conoscenza è l'intelletto illuminato dalla conoscenza divina che, senza impedimento alcuno, si riversa nella natura [umana] 56 .
Nel capitolo 6 della seconda parte Isacco indica due segni che permettono all'uomo di accorgersi che l'illuminazione comincia a prodursi in lui:
Fratello mio, ti indicherò due indizi affidabili grazie ai quali, quando Dio ti giudicherà degno di un'illuminazione interiore, potrai percepire la luce della tua anima. Essi saranno sufficienti a farti riconoscere il momento in cui la verità sfolgorerà nella tua anima. Quando per grazia e misericordia di nostro Signore Gesù Cristo l'illuminazione dell'intelletto, di cui parlano i padri, comincia a irradiare in te, questi due segni ti daranno una conferma in proposito ... Uno è il seguente: quando la luce nascosta comincia a risplendere nella tua anima, il segno sarà che, ogniqualvolta interrompi la lettura della Scrittura o la preghiera, il tuo intelletto verrà catturato da qualche versetto o dal senso in esso contenuto, e tu vi applicherai la tua meditazione, lo esaminerai e, immediatamente commosso, ne scruterai il significato spirituale. n tuo intelletto ne sarà avvinto al punto da non poter essere distratto da nessun altro oggetto proveniente dal mondo creato. Anche se tu non te ne curi in modo particolare come di un oggetto presente, è così che accadrà all'intelletto, non pienamente ma almeno in parte. Il secondo segno, preciso come il primo, è il seguente: quando l'anima abbandona le tenebre e diventa luce dentro di sé, al solitario sono concesse delle genuflessioni prolungate che sono per lui talmente dolci da starsene tre giorni inginocchiato a terra senza sentire fatica alcuna a causa
56 Centurie di conoscenza I, I 2- I 3.

di questo godimento e senza neppure desiderare di alzarsi. Ogni volta che solleva la testa per tirarsi su ricade faccia a terra, a causa della dolcezza prolungata che ha invaso il suo cuore. Allora la preghiera non è più tanto importante per lui57
,
giacché da quando essa è entrata nel suo cuore sente così intensamente l'aiuto di Dio e il piacere di questa preghiera aumenta a tal punto, che la lingua gli si blocca e il cuore tace. Allora una quiete58 così dolce gli pervade il cuore e le membra che egli pensa che nemmeno le delizie del regno dei cieli siano paragonabili - se è lecito esprimersi così - a quel silenzio59 nella preghiera. Giorno e notte giace così, disteso a terra, senza proferire parola. In tal modo, nella misura in cui un uomo accede a tale illuminazione dell'intelletto, è degno delle delizie delle genuflessioni 60 •
Questo passo verte su un'illuminazione che si produce in modo discreto e invisibile e che può essere riconosciuta più da segni esteriori che da una sensazione interiore. !sacco ne precisa chiaramente la natura: si tratta della luce dell'anima o piuttosto dell'"anima che diventa luce". L'illuminazione consiste nel fatto che l'anima lascia le tenebre e comincia a percepire la propria luce naturale.
Bisogna osservare che il termine "luce" (nuhra) si incontra di frequente negli scritti di !sacco, ma di solito non designa una luce visibile e concreta, e neppure la luce divina nel senso in cui la intendono gli autori mistici siriaci e bizantini (Giovanni di Dalyata, Simeone il Nuovo Teologo, Gregorio Palamas e molti altri). Pur avendo fatto l'esperienza della contemplazione della luce divina, !sacco non l'ha mai descritta nei particolari. Non è dunque possibile fare di Isacco un precursore dell'esicasmo bi-
57 Si tratta delia preghiera orale ad alta voce. 58 In siriaco sbelya. 59 In siriaco sbelvufl.z. 60 II,6,I-4. .
zantino. Questa affermazione sarà senza dubbio sorprendente per quanti hanno familiarità con il testo greco di !sacco o con le traduzioni in lingue moderne basate su di esso: si ricorderanno immediatamente di espressioni come "la luce della santa Trinità", "la luce di Dio" e altre simili. Tuttavia questi termini non si trovano nei testi autentici di Isacco: risalgono piuttosto o agli scritti di Giovanni di Dalyata e di Filosseno di Mabbug che furono a lui attribuiti, oppure a citazioni tratte da Evagrio. !sacco parla soprattutto dell'anima dell'asceta che diventa luce, e non dell'asceta che contempla la luce divina 61
. Quanto ai testi autentici di !sacco che parlano della "luce divina", l'espressione non vi riveste mai il senso specifico e concreto che ha nella letteratura esicasta. La stessa cosa vale per formule come "luce della theorfa" 62 , "luce santa" 63 e altre analoghe, che si riferiscono tutte unicamente a una certa esperienza interiore di visione spirituale: l'asceta vede la luce della propria anima in conseguenza dell'illuminazione che ha ricevuto nel proprio intelletto.
Le fonti di tale illuminazione spirituale e dello "sfavillio della luce" all'interno dell'anima sono la preghiera e le altre pratiche ascetiche64, fra le quali citiamo il ricordo di Dio e le veglie notturne:
Se l'anima sfavilla per il ricordo di Dio e per le continue veglie, di notte e di giorno, il Signore dispone al di sopra di
61 È chiaro che !sacco conosceva l'insegnamento di Evagrio sull'esistenza di una duplice luce: la luce trinitaria dell'essenza divina e la luce naturale dell'anima umana che, pur apparentata con la precedente, non è identica a essa. Evagrio descrive lo stato nel quale "l'uomo interiore", divenuto un vero "gnostico", contempla la "luce della bellezza della propria anima (nulmz d-sbupm d-tuzpsbeb)", o la "luce della propria bellezza" (Pseudo-supplementi ai Gzpitoli gnostici 50). In !sacco non ritroviamo tale confronto tra le due luci. Quando parla di luce, egli considera per lo più la luce nascosta nell'intimo dell'anima umana. E in questo senso che bisogna intendere l'espressione "luce divina" (nulmz alabaya) che si incontra nei suoi scritti (cf. II,II,29).
62 I, 77 (p. 382) = Touraille 20 (p. q8); PR 75 (p. 550). 6J II,9,7· 64 Cf. II,I0,4.

questa regolarità una nube che di giorno la prende sotto la sua ombra e di notte la illumina con una luce di fuoco. Nelle sue tenebre risplende la lucé5.
Infine, le genuflessioni eseguite con spirito di pentimento favoriscono anch'esse lo sfavillio della luce nell'uomo:
Nel tempo in cui Dio guida interiormente il tuo cuore verso il pentimento, esegui incessantemente piegamenti e genuflessioni ... È a questo punto che la luce brillerà dentro di te e che la tua giustizia non tarderà a risplendere, e tu sarai ... come un giardino in fiore e una sorgente d'acqua inestinguibile (cf. Is 58,rr) 66 •
Lo sfolgorare della luce nel cuore dell'uomo diventa allora fonte inesauribile di gioia:
Finché l'uomo mantiene la fede del proprio cuore - vale a dire la conoscenza esatta della provvidenza di Dio - non potrà cadere nelle tenebre dell'intelletto donde nascono inquietudine e angoscia, ma la sua anima sarà incessantemente colmata di luce e di gioia e di esultanza continua. Un tale uomo è come se vivesse in cielo, nell'illuminazione dei pensieri che la fede gli offre: egli è ormai degno di ricevere la rivelazione delle intuizioni67 .
L'allusione alla gioia spirituale ci introduce allo studio dello "stupore" mistico, altro termine cruciale nella dottrina di Isacco.
"I,6 (p. 54)= Touraille 56 (p. 297); PR 6 (82-83). 66 I,4 (pp. 38-39) = Touraille 23 (p. I6I); PR 4 (p. 58). 67 II,8,25.
z86
Lo stupore
Uno degli stati spirituali più caratteristici descritti dagli autori mistici è da loro chiamato "estasi", ed è spesso accompagnato da un senso di rapimento e compunzione dell'anima, da lacrime, talora da perdita di conoscenza, indebolimento delle membra e uscita della mente fuori del corpo. La parola greca ékstasis, che significa letteralmente "uscita all'esterno, fuoriuscita", non ha un esatto equivalente in siriaco. I termini che più le si avvicinano sono temha e tehra, traducibili entrambi con "stupore", "meraviglia". Nelle opere di Isacco li incontriamo sovente, e indicano appunto lo stato mistico che gli autori greci descrivono come estasi. Nella versione greca di Isacco, infatti, i due termini sono abitualmente tradotti con ékstasis.
!sacco è consapevole delle particolarità del vocabolario greco dell' ékstasis. Commentando i due passi in cui i LXX usano questa parola - il sonno di Adamo e quello di Abramo - !sacco ne riporta, come ha ben dimostrato Paolo Bettiolo68 , l'interpretazione corrente presso i padri siriaci:
Se uno domanda: "Dove si trova il pensiero in questi momenti di elevato raccoglimento?", ecco cosa dice la Scrittura: "La quiete cadde su Abramo" (Gen r5,rz). E altrove, a proposito di Adamo: "Il Signore Dio gettò la quiete su Adamo" (Gen z,zr). Invece di quiete, il greco parla di stupore (temha). Ecco come il beato Interprete commenta il mistero dello stupore: "Da' il nome di stupore a ciò che è al di fuori dell'ordine abituale e al di fuori di quello che l'uomo può sperimentare" 69 .
Per designare lo stupore !sacco usa anche un'altra espressione biblica, la "nube oscura" ('arpe/la), che nella pshitta, la versione
68 Cf. !sacco di Ninive, Disco1!i spirituali, p. 197, n. q. 69 Centurie di conoscenza IV,95.

siriaca della Bibbia, è applicata alla tenebra nella quale Mosè incontra Dio:
La nube oscura, caratteristica dello stadio spirituale, [si manifesta] quando l'intelletto è inghiottito dallo stupore e riceve un'intuizione dello Spirito. Essa piomba all'improvviso sull' anima e tiene l'intelletto in stato di immobilità, mentre tutto ciò che è visibile si sottrae al suo sguardo, in un non sapere e un non sentire riguardo all'oggetto che esso cerca di fissare. Questa nube fa sì che l'intelletto indugi nella quiete, come quando una nube oscura avvolge un oggetto e lo sottrae agli occhi del corpo 70 •
Per Isacco lo stato di stupore è strettamente legato a quelli appena descritti come "quiete dell'intelletto" o "contemplazione spirituale":
Quando uno riceve continuamente la percezione di questi misteri grazie all'occhio interiore che si chiama contemplazione spirituale (te'mya d-ru{J) e consiste in una visione proveniente dalla grazia, appena percepisce l'uno o l'altro di questi misteri il suo cuore si placa in una sorta di stupore. Non solo le labbra smettono di pronunciare preghiere e tacciono, ma anche i pensieri languono nel suo cuore per la meraviglia 71
che lo coglie. Al tempo stesso, egli riceve dalla grazia la dolcezza dei misteri della sapienza e dell'amore di Dio, in virtù della visione che conosce gli avvenimenti e le nature 72 •
Lo stupore può avere molteplici cause. Può essere frutto dell' allontanamento dal mondo e di una vita nella quiete: "Per il fatto di vivere in disparte dal mondo e nella quiete, l'anima è
7° Centurie di conoscenza !,52. 71 In siriaco dummara, che significa anche "stupore". 72 II,35.4·
z88
naturalmente spinta alla conoscenza delle creature di Dio, a partire dalla quale si innalza a Dio e, nella meraviglia, è colta da stupore e dimora presso di lui" 73
• Lo stupore può anche nascere da una preghiera meditati va, "giacché la quiete ... e la meditazione suscitano nel cuore una dolcezza immensa e infinita, e portano l'intelletto allo stupore ineffabile" 74
. Esso può inoltre essere causato dalla lettura della Scrittura: "Medita con delizia le Scritture che ti fanno conoscere il fine della creazione divina e che, nel tempo della preghiera, attirano il tuo intelletto verso lo stupore" 75
. Può poi scaturire dal ricordo continuo di Dio: "Conservando a lungo il ricordo di Dio, l'anima può essere a tratti condotta allo stupore e alla meraviglia" 76
• Infine Isacco indica come possibile causa dello stupore l'azione dello Spirito santo:
La sapienza dello Spirito umilia l'anima e la induce a scrutare Dio nello stupore 77
•
Proprio come in certe specie di alberi la linfa zuccherina viene prodotta dall'azione del sole, così, quando lo Spirito sfavilla nel nostro cuore, gli impulsi della meditazione chiamati "condotta spirituale" (dubbara ru{Jana) si avvicinano alla limpidezza e il nostro intelletto, colto da stupore e senza che la volontà intervenga, in virtù di qualche riflessione è attratto verso Dio 78
.
Gli scritti di Isacco contemplano diversi tipi di stupore, distinti secondo il grado di intensità dell'esperienza che rappresentano. n primo è una sorta di rapimento che si verifica all'atto
73 I,3 (p. r6) ~ Tournille 82 (p. 403); PR 3 (p. 20). 74 !,37 (p. r82) = Tournille 85 (p. 437); PR 35 (p. 259). 75 Centurie di conoscema !,67; cf. anche !,37 (p. r79l = Touraille 85 (p. 434); PR 35
(p. 254). 76 I,5 (p. 48) = Touraille 5 (p. 84); PR 5 (p. 73). 77 Centurie di conoscenza III,zo. 78 II,ro,2.

della preghiera o della lettura delle Scritture, nel corso del quale l'interessato non perde il controllo di sé, ma il suo intelletto può essere interamente "catturato" da Dio:
Egli si spinge fino a dimenticare sé stesso e la sua natura e, colto dallo stupore, si dimentica completamente del secolo presente ... Assorbito dalle meraviglie di Dio, in uno stato continuo di stupore dinanzi a esse, egli è sempre ebbro, quasi assaporasse già la vita dopo la resurrezione ... Inebriato da queste cose, viene poi ricondotto alla contemplazione del secolo presente nel quale ha continuato a vivere, per esclamare con stupore: "O profondità della ricchezza, della sapienza, della conoscenza, dei pensieri e dei giudizi dell'inenarrabile provvidenza di Dio!" (cf. Rm II,33). Da questo momento in poi egli viene di nuovo innalzato alle realtà precedenti la formazione del mondo ... e, come rapifo, riflette e dice: "Quanto durerà ancora questo secolo, e quando farà posto all'inizio del secolo futuro? Come sarà la vita di laggiù? In che forma risusciterà e sarà ricostituita la natura umana? In che modo sarà sottoposta a una nuova creazione?". Mentre riflette su queste e simili cose, passa attraverso il rapimento, lo stupore e un silenzio senza parole. Allora si alza, si inginocchia e, versando lacrime copiose, ringrazia e glorifica Dio, unico sapiente79.
La seconda specie di stupore ha come segno esteriore un affievolimento delle membra:
Se uno, inginocchiato con le mani tese al cielo, lo sguardo fisso alla croce di Cristo, i pensieri tutti raccolti in un'unica preghiera rivolta a Dio, prega con lacrime di pentimento, spesso tutt'a un tratto gli capita di sentir zampillare nel cuore una sorgente dalla quale si riversa dentro di lui una grande dolcez-
79 I,37 (pp. 179-r8r) = Touraille 85 (pp. 434-436); PR 35 (pp. 254-257).
za. Le membra gli si affievoliscono, lo sguardo si appanna, la testa pende giù e si alterano i pensieri, cosicché, per la gioia che pervade tutto il suo corpo, non può più compiere prostrazioni 80
•
La terza specie di stupore è caratterizzata dalla totale perdita di coscienza e dall'uscita dell'intelletto dal corpo. Questo stupore ci è noto dai santi che sono rimasti in uno stato simile per ore o giorni:
Vediamo sant'Antonio stare in preghiera per nove ore di seguito e accorgersi che il suo intelletto era asceso fino ai cieli 81
•
Uno dei padri stava in preghiera con le mani tese per giungere al rapimento dopo quattro giorni. E molti altri furono sedotti durante la preghiera da un potente ricordo di Dio e dal suo amore, e così ottennero il rapimento 82 .
!sacco cita un suo contemporaneo che un giorno gli confidò:
Quando voglio rimanere in piedi per celebrare la liturgia, Dio mi lascia recitare una sola marmita ma poi, se continuo a stare in piedi per tre giorni, mi ritrovo nello stupore accanto a Dio senza provare un briciolo di stanchezza 83 .
In uno dei discorsi della prima parte !sacco descrive un caso particolare di stupore che non è stato incluso nella versione siro-occidentale, quindi neanche in quella greca. In esso lo stupore comincia a farsi sentire durarte il sonno, provoca il risveglio e prosegue nello stato di veglia. E probabile che !sacco vi descriva la propria esperienza personale anche se, come suole fare in questi casi, usa la terza persona singolare:
80 I,4 (p. 39) = Touraille 23 (p. r62); PR 4 (p. 58). 81 Cf. Atanasio di Alessandria, Vita di Antonio 62. 82 I,37 (p. r83) = Touraille 85 (p. 439); PR 35 (pp. 26o-26r). "I,54 (p. 272) = PR 35 (p. 388).

Conosco un uomo (cf. zCor rz,z) che anche durante il sonno fu colto da stupore divino mentre contemplava ciò che aveva letto la sera prima di coricarsi, e che, quando il suo intelletto fu affascinato dalla meditazione di ciò che contemplava, fu come se avesse compreso di essere rimasto a lungo nei pensieri del sonno seguendo le tracce della sua sorprendente contemplazione. Tutto ciò avveniva a notte fonda: si svegliò all'improvviso, con le lacrime che a fiotti gli bagnavano le guance. Le sue labbra erano piene di dossologie e il cuore meditò a lungo e con dolcezza insaziabile su quella visione. A causa delle lacrime che gli scendevano copiose dagli occhi e a causa dello stupore della sua anima, tutte le sue membra erano come paralizzate e una grande gioia gli palpitava in cuore, al punto di non essere più in grado di celebrare la liturgia abituale della preghiera notturna. Solo con grande sforzo poté recitare un salmo sul far del giorno: a tal punto traboccava di lacrime, che sgorgavano a fiotti dagli occhi, e di altre esperienze spirituali 84 •
Per Isacco lo stato di stupore non è limitato nel tempo, ma può a volte prolungarsi ininterrottamente per molti giorni. Egli lo chiama allora "stupore totale" (temha kulonoya), caratterizzato dall'assenza di ogni percezione della realtà terrestre:
Quando l'intelletto è mosso dalla grazia alle realtà spirituali, per effetto della dolcezza della conoscenza esso mette fine per lungo tempo alla riflessione e al ricordo e giace tranquillo nello stupore. Non parlo qui del raccoglimento totale che ha luogo al momento della contemplazione di Dio, quando gli slanci dell'intelletto sono trasformati in stupore o piuttosto quando l'intelletto resta privo di moti per un giorno o più. Ciò che nasce improvvisamente da certe contemplazioni e da altre rivelazioni non implica ancora la cessazione di ogni pen-
84 I, App. A III (pp. 392-393) = PR 71 (pp. 492-493).
siero, né che la natura [umana] passi dalla conoscenza alla non conoscenza - secondo i padri superiore alla precedente-; ma qui sono la pace e la gioia ad accompagnare l' ebbrezza e il fervore del cuore. Quanto allo "stupore totale" nella preghiera e all'assenza di ogni percezione delle cose di quaggiù, non lo si incontra tra le conoscenze e le dolcezze della mente, eccetto in questa, che è unica 85 .
!sacco menziona spesso la gioia che si manifesta in chi è colto a tal segno dallo stupore. Questa gioia soprannaturale e divina, nella quale si rivela un sentimento di libertà e di amore per Dio, si accompagna alla liberazione da ogni paura:
Così, nel momento in cui uno, nella meditazione e nella conoscenza, viene innalzato oltre il livello dell'anima che comprende le opere buone della vita attiva, quando la sua coscienza è elevata all'altezza della vita dello spirito per quanto è possibile alla natura umana quaggiù, immediatamente lo stupore dinanzi a Dio (telml db-alaha) lo pervade, diventa tranquillo e calmo rispetto ai pensieri di prima e tutto il suo intelletto è mosso da slanci spirituali d'amore. Contemporaneamente a questa conoscenza, ogni paura scompare e la sua mente si muove in piena libertà in rapporto ai pensieri e supera ogni timore e dolore spirituale, a immagine di quanto avverrà nel secolo futuro. E questo perché, attraverso la grazia di Cristo, è stato giudicato degno della forma che appartiene alla vita dell'uomo nuovo, al regno dei cieli, per effetto dei moti che si manifestano nella sua natura. Ogni volta che si libera in tal modo della paura e delle sofferenze, egli prova una grande gioia spirituale e in tutte le sue meditazioni non assomiglia più ai figli di questo secolo, giacché si trova ormai affrancato dai pensieri, in una libertà piena di moti di conoscenza e di stupore davanti a Dio. Nella misura in cui vive nello stato di conoscenza, che è superiore a quello dell'anima,
" Centurie di conoscenza IV,48.
2 93

ed è innalzato al di sopra della paura, gli slanci dei suoi pensieri risiedono a ogni istante nella gioia in Dio, come è proprio dei bambini86 •
Questa gioia in Dio e questo stupore possono diventare un'esperienza continua:
Beato l'intelletto che è diventato degno del frutto della riflessione continua su Dio, della meditazione e del pensiero sui suoi misteri. In esso si adempie a ogni istante ciò che è stato detto: "Signore, hai messo gioia nel mio cuore" (Sal4,8) 87
.
Tuttavia I sacco sottolinea che nell'esperienza spirituale la gioia si accompagna alla sofferenza. Se la gioia deriva da un sentimento d'amore fervido per Dio e dall'esperienza della sua ineffabile vicinanza, d'altra parte la sofferenza si spiega con l'impossibilità di permanere sempre in questo stato. Ecco perché !sacco può esclamare: "Signore, rendirni degno di abbeverarmi a questa fonte!"88. Più l'uomo si avvicina a Dio, più cresce la sua sete inestinguibile di comunione con lui. È così che gioia e sofferenza procedono di conserva, come due facce di un'unica esperienza:
In virtù di questo dolce patire che affligge la mente a causa di Dio, e attraverso la tristezza vivificante di cui ha parlato l'Apostolo (cf. 2Cor 7,ro), sorgono nell'intelletto, in conformità alle diverse specie di meditazioni, il pentimento o la gioia a causa di Dio, come pure un cuore intriso di inestinguibile speranza. Sofferenza e gioia che, per l'ardore e la forza che le contraddistinguono, bruciano e consumano il corpo fino a disseccarlo, mentre il sangue affluisce copioso alle vene e dona calore, giacché la fiamma dei moti dell'intelletto riscalda
86 II,zo,ro-rr. " II,z9,9· 88 II,r8,r6.
294
tutto il corpo con il fuoco della liturgia nascosta. Essa provoca a ogni istante una sorprendente trasformazione che procura o gioia o forte dolore all'anima e al corpo; e fa sì che notte e giorno l'uomo vegli in ansia per la propria salvezza, preghi di tutto cuore e porga, con il cuore in fiamme e il pensiero immoto, fervide suppliche a Dio 89
.
Lo stato di stupore che alcuni asceti attraversano nel corso della loro vita sulla terra è il simbolo della meraviglia nella quale vivranno i santi nel secolo a venire: essa è un pregusto del regno dei cieli 90
. Per avvalorare il suo pensiero !sacco fa appello a Evagrio:
Evagrio, vaso traboccante di rivelazioni spirituali, lo chiamava "il centuplo che il Signore ha promesso nell'evangelo" 9\ e di fronte alla grandezza di questo stupore legato alla dolcezza, a ragione lo definiva "la chiave del regno dei cieli" 92 . Te lo dico come se fossi davanti a Dio in persona: le membra corporee non possono sostenere una simile dolcezza e il cuore è incapace di contenerla, tanto è intensa. Cosa possiamo dire di più se i santi la chiamano "percezione del regno dei cieli"? Giacché essa è il mistero del futuro stupore davanti a Dio. I giusti troveranno la loro gioia nel regno dei cieli non attraverso uno sguardo sul mondo materiale e la sua attività, magrazie alle realtà verso le quali l'intelletto, quasi percorrendo una scala, risale di quaggiù, cioè il regno dei santi dove essi resteranno colti dallo stupore. A buon diritto tale percezione viene detta il "mistero del regno dei cieli"; attraverso questi misteri, infatti, conosciamo colui che è il vero regno di tutto ciò che esiste, ogniqualvolta l'intelletto è da essi sospinto grazie al dono della forza divina 93 .
89 II,z4,2. 90 Cf. II,8,I·4· 91 Evagrio Pontico, Capitoli gnostici IV,42. 92 Ibid. IV,4o. 93 II,35,I2·13·
2 95

L'"ebbrezza" d'amore per Dio
Il termine "ebbrezza" (rawwayuta) è semanticamente affine a "stupore". Esprime efficacemente l'eccezionale vigore dei sentimenti d'amore per Dio, di gioia e di rapimento spirituale, e suggerisce una sorta di estasi mistica. Il tema della "sobria ebbrezza" è centrale nella tradizione mistica cristiana, e si incontra già in Origene e Gregorio di Nissa 94 . Nella tradizione siriaca fa la sua apparizione in Efrem e Giovanni di Apamea. Tra gli autori del VII secolo è presente in Dadisho' e Simeone di Taibuteh95. Per Isacco, il concetto di ebbrezza spirituale rappresenta per così dire la sintesi di tutta la sua teologia mistica: lo studio di questo concetto ci permetterà di sviluppare i tratti salienti della mistica del nostro autore.
Nel corpus degli scritti di Isacco il tema dell'ebbrezza è presente sia nella prima che nella seconda parte. Nelle sue Centurie di conoscenza egli ne parla a più riprese. Ecco un esempio:
Finché non si è resi degni della rivelazione dei misteri divini, conosciuti dall'intelletto in perfetta purezza grazie all'azione dello Spirito santo, è a questo fine che la consolazione spirituale è gustata da coloro che camminano sulla via della conoscenza. Che si tratti di meditare i salmi o di partecipare assiduamente alla lettura e alla preghiera, o alla riflessione sul loro senso, lo scopo è sempre quello: diventare degni dell'azione dello Spirito nel proprio intelletto. Nello stupore parziale e nell'ebbrezza del cuore, costoro prendono piacere nella gioia che è in Dio e nelle intuizioni che, di quando in quando, oscuramente ricevono. Sono quelli che per conoscere Dio
9'1 Per un'analisi sistematica di questo tema si veda H. Lewy, Sobria ebrietas. Untersuchungen zur Geschichte der antiJ?en Mystik, Topelmann, Giessen I929.
95 Cf. S. Brock, n. 3 a Il,roa5, in CSCO 555, p. 49·
affrontano ogni giorno grandi tentazioni e si preparano lietamente alla morte, e la loro mente non si rattrista e la loro quiete non si incrina 96
.
In uno dei capitoli della seconda parte, dedicato allo stato di stupore che comincia al di là dei confini della preghiera, Isacco ricorre alla metafora del vino per descrivere il rapimento spirituale che si impadronisce di chi prega:
Talvolta, quando la preghiera è ancora solo in parte presente, l'intelletto, come uno schiavo, è strappato a se stesso verso il cielo e le lacrime, scorrendo spontaneamente come fontane d'acqua, rigano il viso. In questi momenti l'uomo è tranquillo, silenzioso, e il suo intimo è pieno di una visione sorprendente. Spesso non riesce più assolutamente a pregare. Si tratta, in verità, di quella cessazione della preghiera che è al di là della preghiera. Essa consiste nell'essere continuamente colti da stupore davanti a tutta la creazione divina, come quelli che hanno perso la testa per aver bevuto troppo vino: è questo "il vino che allieta il cuore dell'uomo" (Sal ro4,15) ... Beato chi è entrato da questa porta e ne ha fatto lui stesso esperienza, giacché tutta la potenza dell'inchiostro, delle lettere e delle frasi è troppo poca cosa per esprimere la dolcezza di un tale mistero 97
•
Isacco ricorre più spesso alla metafora dell'ebbrezza quando parla dell'amore di Dio che afferra e rapisce. L'amore, per lui, è un dono che l'uomo non può ottenere con i suoi soli sforzi. L'ascesi, lettura della Scrittura inclusa, favorisce l'acquisizione dell'amore ma senza un dono dall'alto, il vero amore non può manifestarsi n~ll'uomo. È impossibile conoscere l'amore a partire dai libri: lo si può solamente gustare o bere. Scrive !sacco:
Centurie di conoscenza II,r4. 97 IIa5,r.6.
297

L'amore di Dio non si mette in movimento senza uno ne sia consapevole, giacché non può scaturire dalla sola conoscenza delle Scritture, così come nessuno può amare Dio solo perd1é si sforza di farlo ... E nemmeno si può amare Dio a partire dalla legge o dai comandamenti, che è stato lui a darci e non senza rapporto con l'amore, la incute timore, non amore. E finché uno non avrà ricevuto Spirito della rivelazione e i moti dell'anima non si saranno accompagnati a quella sapienza che sta più in alto del mondo, finché uno non avrà conosciuto la di Dio attraverso un'esperienza personale, non potrà accostarsi al gusto glorioso dell'amore. Chi non ha bevuto (eshti) vino non diventa ebbro a forza dì disquisire sul vino, e chi non è stato giudicato degno (esbtwi) di ricevere in sé la conoscenza di Dio non può inebriarsi del suo amore 98
Il simbolismo del vino e dell'ebbrezza a Isacco l'oppor-tunità di rappresentare diversi della vita mistica che sarebbe stato difficile descrivere affidandosi solo alle parole. La sete dell'unione con Dio, per esempio, così caratteristica dei momenti di derelizione, viene espressa attraverso la sete di bevande forti provata dal bevitore quando l'astinenza fa sentire i suoi effetti:
Con un lodevole impulso il cuore si slancia verso Dio e grida: "Il mio cuore ha sete del Dio vivente! Quando verrò e potrò comparire dinanzi al volto di Dio?" (cf. Sal42,3). Solo chi ha bevuto di questo vino e ne è stato privato sa in che miserancio stato di abbandono si trova, e di che cosa è stato privato a causa della sua u~5u,5~, ... ~u
Parlando dell'indebolimento che accompagna lo stupore, Isacco lo paragona all'abbattimento prodotto dall'ubriachezza:
in siriaco. III·II2); PR r6 (p. r3r).
Grazie a questo potente e divino desiderio ... l'uomo comincia a essere avviato all'amore di Dio e, tutt'a un tratto, entra in uno stato di ebbrezza, come se avesse bevuto vino. Le sua membra diventano fiacche, n pensiero è colto da stupore, il cuore, come uno schiavo, è condotto a Dio. Così come ho detto, assomiglia a un ubriaco 100.
Il fatto che l'ebbrezza derivante menticare i pensieri e i dolori del mondo è all'identi-co fenomeno che accompagna l'intossicazione alcolica:
Come chi beve del vino in un giorno dolore dimentica i propri affanni, così l'ebbro d'amore di Dio in questo mondo, d1e è una casa di lacrime, dimentica tutte le sue pene e il suo dolore, reso alle passioni peccaminose dall'ebbrezza101.
Nella vita mistica lo stato spirituale dell'uomo cambia ed egli diventa disponibile a fino a poco prima inaccessibili. Invece di una dolorosa egli prova la gioia in Dio, grazie alla quale acquista un altro sguardo sul mondo e una diversa percezione della realtà. Tale cambiamento del suo stato spirituale è anch'esso simboleggiato dalla percezione alterata della realtà nell'ubriaco:
Le buone azioni e l'umiltà fanno dell'uomo un Dio in terra. La e la misericordia lo avvicinano rapidamente alla pu-rezza. impossibile che nella stessa persona convivano fer-vore e contnzwne cuore, proprio come un ubriaco è incapace di controllare i suoi pensieri. Infatti, dal momento in cui questo è donato all'anima, la contrizione e le lacrime le sono Il vino è donato per l'allegrezza e il fervore per
too I.49 (p. 101 I,74 (p.
Tour:illle 40 (p. 234); PR 47 (pp. 337-338). PR 78 (p. 543).
299

la gioia spirituale. Il vino riscalda il cuore e la parola di Dio riscalda l'intelletto. Coloro che ardono di sono trascinati dalla meditazione di quello che sperano, e preparano il loro pensiero al secolo a venire. Infatti, come ubriachi di vino sono soggetti a ogni sorta di allucinazioni, così quanti sono inebriati e riscaldati da questa speranza ignorano ormai
dolore e tutto ciò che riguarda questo mondo 102•
Trattando dell'impassibilità o assenza di passioni, Isacco ricorre di nuovo all'immagine dell'ebbrezza: "Impassibilità non vuoi dire non provare le passioni, ma piuttosto non accoglierle, grazie all'ebbrezza dell'intelletto prodotta dalla gloria dell'ani-ma"103. stesso vocabolario è adottato per lo stato in cui la si arresta perché una gioia non terrena ha preso possesso del cuore: "Vuoi dunque ornare il tuo corpo ... Sta scritto: 'Di' cinque parole con la tua intelligenza' 1Cor 14,19), ma quando sei in preda all'ebbrezza" 104 • L'espe-rienza della spirituale che accompagna lo stato di stupore è descritta passo seguente:
Quando dunque nel pensiero di un uomo comincia a svilupparsi la speranza, e senza motivo apparente e senza sosta la gioia improvvisa di cui parliamo germoglia nel suo cuore, egli non conosce più né la fatica, né il peso dell' acedia, né la paura della morte. Ti assicuro, fratello mio, che quest'uomo è arrivato dov'è arrivato perché era completamente ebbro, al punto che volendo glorificare Dio e confessare la propria gli si la lingua e non riusciva a benedire Dio, ma balbettava come un bimbo e parlava con Dio come un bambino parla a suo Questa è una gioia che inebria completamente; di una gioia tale noi diciamo che rende il cuore
102 I,6 (p. 6o) = Touraille (p. 305); PR 6 (p. 95). 10
' Centurie di conoscenza 10
' Centurie di conoscenza
)00
do e che è la porta d'ingresso rivelazioni spirituali del-l'intelletto, quelle che si vedono nella preghieralo5.
L'immagine del vino offre a !sacco l'opportunità di precisare cosa intende quando parla della dolcezza e delle delizie del cielo proprie dell'esperienza mistica:
Una gioia si infiamma improvvisa nel tuo cuore, cosl intensa da costringere la tua lingua a tacere, e una dolcezza ne scaturisce incessantemente e ti travolge, senza che tu nemmeno te ne accorga? A tratti una dolcezza e una gioia che nessuna lingua mortale potrebbe esprimere impercettibil-mente in tutte le tue membra? .. . una simile dolcez-za si diffonde in tutto il corpo e l'uomo, allora egli pensa che il regno dei cieli non sia diverso da questo106 .
Il senso di spirituale che si produce esperien-ze mistiche e quello della vicinanza del fuoco divino che invade l'uomo sua totalità sono ancora una volta descritti attraverso la similitudine dell'ebbrezza:
Domanda: Perché la speranza è così dolce, la sua condotta e le fatiche che comporta così leggere, la sua azione sull'anima così rapida? Risposta: essa avvia nell'anima un desiderio naturale,
da bere quel calice e lo inebria attraverso bel-lezza. Perché le persone che fanno questa esperienza non sentono la difficoltà, diventano insensibili ai tormenti e per tutto il resto del loro viaggio pensano di camminare sull'aria, e che il loro non sia un incedere umano ... La speranza le fa ardere come fuoco, ed esse non sanno co:t1ce:aen tregua alcuna nella corsa impetuosa e incessante
105 Centurie di conoscet/Za I,8o. WG 1,68 (p. 333) = Touraille 8 (p. 98); PR 70 (p. 486).
)OI

con gioia. Si realizza in esse ciò che è stato detto dal profeta Geremia: "Mi dicevo: non penserò più a lui, non parlerò più in suo nome! Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa" (Ger 20,9). È così che il ricordo di Dio opera nel cuore inebriandolo con la speranza delle sue promesse107.
Il tema della "follia in Dio" è strettamente legato a quello dell'ebbrezza ed è anch'esso caratteristico di molti spirituali cri::
in san Paolo che contrappone la "sapienza del mondo" alla "follia dell'evangelo" (cf. rCor r,r8-23), e la follia di una vita alla gloria del mondo. I mistici parlano più tre•mJ:f'ntf'tnente di follia quando vogliono sottolineare il carattere paradossale, inesplicabile e irrazionale dell'esperienza della comunione con Dio.
È così che assimila lo stato di ebbrezza alla follia, a causa dell'amore di Dio è tipico dello stupore:
L'amore è per natura e quando infiamma qualcuno ol-tre rende folle la sua anima. Il cuore che prova un tale amore non può né contenerlo né sostenerlo ... Già gli apostoli e i martiri ne furono inebriati. I primi poterono così sparpagliarsi per tutto il mondo, soffrendo e patendo umiliazioni; i secondi versarono sangue membra amputate come se fosse acqua, ma tra i più atroci tormenti non si persero d'animo, li sopportarono coraggiosamente e, divenuti sapienti, furono folli (cf. ICor 3,r8). Altri vagarono "per i deserti, sui monti, tra le caverne e le spelonche della terra" (Eb rr,38), e in mezzo al disordine furono assai ordi-nati. Possa Dio a noi una follia del generei08 !
Questa "follia" mistica è stata vissuta da numerosi santi:
107 I,7I (pp. 346•347) 108 1,35 (pp. 158·159)
302
Dopo averne fatto esperienza i santi si dimenticarono di se stessi e, resi folli, si precipitarono al tuo inseguimento; nella loro erano continuamente mescolati a te ... Coloro che hanno a questa dolce fonte perché avevano sete del tuo amore, tu li hai resi ebbri e li hai colpiti con lo stupore davanti ai tuoi misteri109.
Ma non furono solo i santi del passato a diventare "folli" a forza di ubriacarsi spiritualmente, giacché Isacco ne parla come di un'esperienza follia è quell'amore di Dio e del prossimo che non conosce frontiere e supera tutti i limiti del ragionevole. Il gusto dell'amore è paragonabile a quello del miele che è, come il vino, simbolo di dolcezza:
Chi ha raggiunto l'amore divino non desidera più restare in questo mondo, perché l'amore scaccia la paura (cf. rGv 4,r8). Anche a me, miei amati, è volta di cadere nella follia. Non posso tacere diventato folle per il bene dei miei giacché l'amore vero non può perseverare mistero senza quelli che ama. Sovente, mentre scrivevo queste cose, le dita mi si inceppavano sulla carta e non riuscivo a sostenere la dolcezza che si rinnovava in cuore e riduceva i miei sensi al silenzio ... La gioia in Dio è più grande di questa vita presente e chi l'ha trovata non solo non bada più alla ma non getta più neanche uno sguardo alla propria vita e non conserva nessun altro sentimento, se questa gioia è veramente reale. L'amore è più dolce della vita, e la conoscenza di Dio da cui nasce l'amore è più dolce del miele e del favo. Come descrivere questa dolcezza dell'amore, più dolce della vita stessa? L'amore non ha paura di attraversare mille morti per i suoi amici 110 .
109 Centurie di conoscenza 1,88. 110 1,62 (pp. 297-298) = Touraille 38 (pp. 227-228); PR 62 (pp. 430-432).

notare come in Isacco il simbolismo del vino e ebbn~zz;a rivestano a volte persino un carattere eucaristico.
L'amore vi appare allora come nutrimento e bevanda, come pane e vino con i gli amanti di Dio comunicano a ogni istante. Il simbolismo eucaristico è tipico degli autori della tradizione siriaca, a cominciare da Efrem, e Isacco lo sviluppa ampiamente:
ha trovato l'amore si comunica con il pane del cielo e viene fortificato senza fatica né dolore. Il pane del cielo è Cristo disceso dal cielo che ha dato la vita per il mondo (cf. Gv 6,5r), è il nutrimento degli angelì. Chi ha trovato l'amore assapora ogni giorno e ogni ora Crìsto e diventa immortale. "Chi mangia questo pane vivrà in eterno" (Gv 6,58). Beato colui che assaggia il pane dell'amore che è Gesù! Chi l'amore mangia Cristo che è Dio al di sopra di tutto, come attesta Giovanni dicendo che "Dio è amore" (rGv 4,8) ... L'amore è il regno nel quale il Signore ha misticamente promesso ai suoi discepoli che lo mangeranno. Giacché cosa ~1~HH1'-" "mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno" se non che noi mangeremo l'amore? L'amore basta a nutrire al posto del cibo e delle bevande. È questo "il vino che allieta il cuore dell'uomo" (Sal ro4,15). Beato colui che beve di questo vino! Ne hanno bevuto i dissoluti e sono stati peccatori, e hanno abbandonato la strada sulla si erano impantanati 111 ; gli ubriaconi ne hanno bevuto e sono diventati amanti del digiuno; i ricchi ne hanno bevuto e hanno desiderato la povertà; i poveri ne hanno bevuto e sono diventatì ricchi di speranza; i malati ne hanno bevuto e sono stati guariti; gli ignoranti ne hanno bevuto e sono diventati
m Variante: "sono diventati casti". m I,46 (p. 224) = Touraille 72 (pp. 366-317); PR 5r (pp.
Fede e sapere
Resta da esaminare la gnoseologia di Isacco, il suo inse-gnamento sui diversi gradi del sapere e sul rapporto tra conoscenza e fede 113
. Questo insegnamento il fondamento teorico della sua teologia mistica e pertanto richiede di essere studiato nell'ambito complessivo della sua dottrina mistica.
Per Isacco, fede e sapere sono due strade in direzioni op-poste. L'acquisizione della fede presuppone un silenzio del sapere, e l'aumento del sapere contribuisce della fede:
L'anima in cammino sui sentieri della fede compie sovente ge di nuovo alle tecniche
vita ascetica e sulla via Ma se essa sì vol-
ta nella sua fede e privata sua forza spirituale ... Perché l'anima che si è affidata a Dio nella fede una volta per tutte e che, per lunga sa riconoscere il suo agire, non pensa più a se stessa, in preda allo stupore e al si-lenzio non è piì1 capace di rivolgersi alle tecniche del sapere ... Il sapere si alla In tutto ciò che la riguarda, la fede distrugge del sapere, ma certamente non quelle della conoscenza La legge del sapere consiste nel rifiutarsi di agire senza un'indagine e un esame volto ad accertare se quello che si pensa o si vuole è possibile ... La fede, al contrario, un solo modo di pensare, puro e sempli-ce e lontano artificio o ricerca tecnica. Osserva fino a che punto i si contrappongono! La fede risiede in un pen-siero a quello dei bambini e in un cuore semplice ... Il
trappole ai cuori e ai pensieri semplici e vi sì o psì colloca all'interno dei confini della natura
muove i propri passi al di là della natura 114 .
113 Sulla teoria della conoscenza di l sacco si veda anche J, Popovié, "H e gnoseolo-ghla tou haghlou Isaàk tou in Theologhia 38 (I967), pp. 206-225, 386-407.
114 1,52 (pp. 2)}-254) 62 (pp. 329-330); PR )I (pp. 360-362).
305

Per Isacco la fede è dotata di una potenza creatrice illimitata, libera com'è dall'impaccio di dover sottostare alle leggi della natura, contrariamente al sapere che non può agire al di fuori di esse. Ecco perché il sapere serve la natura con timore, mentre la fede travalica audacemente le sue leggi:
Il sapere è accompagnato dal timore, la fede dalla speranza. Quanto più si seguono le tecniche del sapere, tanto più si cade in preda al timore ... ma chi cammina secondo la fede diventa ben presto libero e indipendente e, come figlio di Dio, si serve di tutto a suo da padrone. L'amante della fede, come Dio stesso, ha tutta la natura creata a disposizione, giacché la fede gli dà il potere di creare nuove creature, come può fare Dio ... Sovente può anche far uscire le cose dal nulla, mentre il sapere non produce niente se non ha materia a disposizione 115 •
È in questo senso che la fede ammette la possibilità del miracolo, mentre il sapere lo esclude in quanto estraneo alle leggi della natura. Il carattere sovrannaturale e "miracoloso" della fede è confermato dall'esperienza dei martiri e degli asceti cristiani:
È in virtù della fede che molti si sono gettati nelle fiamme e hanno potuto farsi schermo all'ustione del fuoco, attraversandolo indenni, oppure hanno passeggiato sulla superficie del mare come sulla terra ferma. Tutto ciò va al di là della natura e contraddice le tecniche sapere ... Queste ultime hanno dominato il mondo più o meno per cinquemila anni 116 e nessuno è mai riuscito ad alzare il capo da terra per accorgersi della potenza del suo creatore, prima che la nostra fede ci illumi-
115 I,52 (p. 254) = Touraille 62 (pp. 330-33r); PR 51 116 Isacco calcola il tempo a partire "dalla creazione
tudine della chiesa antica. , secondo la consue-
nasse liberandoci dalle tenebre dell'attività terrestre ... Non c'è sapere che non si riveli insufficiente, per vasto che sia, mentre le ricchezze della né cielo né terra possono contenerle 117 .
Se la fede è "più elevata del sapere" 118, I sacco tuttavia concede che non si escludano a vicenda. Al contrario, la conoscenza e il sapere conducono alla fede, e la fede è il perfezionamento della conoscenza:
La conoscenza riceve la sua dalla fede e acquista la forza di salire più in alto, di provare ciò che sta al di là di ogni sentimento, di contemplare uno splendore che l'intelligenza e la conoscenza di una creatura non possono raggiungere. La conoscenza è un cammino attraverso il quale l'uomo sale alle altezze della fede e una volta che le ha raggiunte non ha più bisogno del sapere119
•
Ad onta dell'accento posto sulla qualità superiore della fede in rapporto al sapere, Isacco non può essere tacciato di anti-intellettualismo: egli non è un nemico della conoscenza razionale, né propugna una fede e meramente istintiva. Egli considera l'ascesa a Dio come un cammino che va non solo dal sapere al-la fede, ma dalla fede alla conoscenza. I concetti di (haymanuta) e di conoscenza (ida'ta) hanno molte connotazioni a un primo e a un secondo livello semantico.
Quando parla della superiorità della rispetto alla cono-scenza, !sacco sottolinea che la fede non solo comprende la professione esteriore di certi dogmi, ma implica l'esperienza misteriosa dell'incontro con la realtà divina:
117
1!8
119
(p. 255) Touraille62 (p. 33r); PR r (p. 363). (p. 256) = Touraille 62 (p. 333); PR r (p. 366). (p. 257) = Touraille 62 (p. 334); PR I (p. 367).

Quando diciamo "fede" non intendiamo solo quella per cui l'uomo crede alle diverse persone adorabili dell'Essenza divina, alle sue proprietà e alla sua meravigliosa economia di salvezza per l'umanità grazie alla natura umana da essa assunta, anche se questa forma della fede è già molto elevata. Ma noi chiamiamo fede quella che risplende nell'anima per mezzo della grazia e fortifica il cuore attraverso la testimonianza dell'intelletto. Questa fede è disvelata non già da un maggiore ascolto delle orecchie, ma grazie agli occhi spirituali che contemplano nell'anima i misteri nascosti e la ricchezza invisibile di Dio che, dissimulata agli occhi dei figli della carne, è rivelata dallo Spirito a coloro che si nutrono alla mensa di Cristo ... L'anima si slancia in avanti, sprezzante di ogni pericolo in virtù della speranza che ripone in Dio e, sulle ali della fede, si innalza al di sopra della creazione visibile. Essa diventa come ebbra per lo stupore generato dall'assidua meditazione su Dio e, grazie a una visione semplice e non composita e a intuizioni invisibili sulla natura divina, l'intelletto si abitua a una meditazione attenta di questa natura nascosta 120.
In questo modo la fede è una conoscenza sperimentale, un contatto mistico con la realtà divina espresso in termini di "ebbrezza", "stupore", "visione", "intuizione" e "rivelazione". Una simile fede, "piena di sicurezza di sé" perché "viene dalla grazia di Dio" 12
\ è più alta di qualsiasi presa di coscienza razionale e, in quanto tale, conduce l'uomo oltre i suoi limiti. In questo contesto i termini di "conoscenza" o "sapere" significano la "saggezza del secolo presente" che è "stoltezza davanti a Dio" (rCor 3,19), "conoscenza terrestre" contrapposta alla fede.
La "conoscenza terrestre" rappresenta il primo dei tre tipi di conoscenza descritti da !sacco. Al servizio del progresso della civiltà, della scienza e delle arti, essa è una conoscenza senza
120 I,52 (pp. 262-263) = Touraille 65 (pp. 342-343); PR 5; (pp. 376·377). 121 Centurie di conoscenza !,64.
Dio, al centro della quale sta un uomo pieno d'orgoglio che si figura signore dell'universo:
Quando la conoscenza si accompagna alla cupidigia della carne, essa verte sui temi seguenti: ricchezza, vanagloria, onore, rilassamento corporeo, attenzione a tutto ciò che permette di governare il mondo o produce invenzioni nuove nel campo delle arti e delle scienze ... È qui che si annida la conoscenza contraria alla fede. Viene anche chiamata "conoscenza nuda" perché esclude qualsiasi interesse per Dio e sta sotto l'impero del corpo. Essa introduce nell'intelletto una debolezza irrazionale e tutti i suoi interessi si appuntano unicamente su questo mondo presente ... Essa non tiene alcun conto della provvidenza divina che governa il mondo ... ma attribuisce alle proprie abilità quanto di buono c'è nell'uomo ... È all'interno di questa conoscenza che è piantato l'albero della conoscenza del bene e del male, che sradica l'amore ... Essa produce la presunzione e l'orgoglio, perché attribuisce a se stessa tutto quello che c'è di buono e non tiene alcun conto di Dio122
.
Accanto a questa "conoscenza nuda" c'è la gnosi o conoscenza cristiana. Essa ha poco a che vedere con l'erudizione secolare, perché non proviene dai libri ma dalla pratica e dall' espenenza:
Una cosa è l'erudizione attinta dai libri e acquisita con lo studio, altra cosa la conoscenza della verità di ciò che i libri contengono. La prima è consolidata da studi prolungati e dalla fatica di seguire un insegnamento; la seconda si innalza [nell' anima] attraverso la pratica dei comandamenti di Dio e per mezzo di una coscienza limpida a lui rivolta 123 .
122 I,52 (pp. 258-259) =Touraille 63 (pp. 336·337); PR 51 (pp. 369-371). 123 Centurie di conoscenza III,99·

Contrariamente alla conoscenza profana che è frutto di erudizione, la conoscenza spirituale ha la sua fonte primaria in Dio:
Molti altri si sono fatti istruire da brevi sentenze messe per iscritto nei libri di santi uomini che hanno [un po'] gonfiato le parole e approfondito i loro discorsi su questo tema, pensando così di possedere realmente la condotta spirituale. Non hanno pensato né compreso che non è per mezzo di abili parole né dell'esercizio di un insegnamento qualsiasi che quest'attività può essere conosciuta e appresa dall'uomo. I misteri di Dio non si insegnano con opera d'inchiostro e con parole, ma sono da lui instillati nei cuori grazie a sorprendenti intuizioni sulla sua maestà, scaturite dal profondo di un'intelligenza purificata ... E se anche si trattasse di uomini dottissimi, sottili e svelti nel comprendere, non potrebbero conoscere niente senza aver ricevuto una rivelazione dallo Spirito 124
.
La vera conoscenza spirituale è caratterizzata dal desiderio di conoscere Dio e di avvicinarsi a lui obbedendo ai comandamenti e percorrendo le varie vie dell'ascesi. Questo è il secondo grado della conoscenza, caratteristico dell'uomo di fede che tuttavia non ha ancora raggiunto il culmine della sua scalata verso Dio. Chi vi si trova pratica "il digiuno, la preghiera, la misericordia, la lettura delle divine Scritture e svariate buone azioni", e combatte le passioni. La conoscenza spirituale fortifica la fede pur non essendo ancora il grado più elevato di conoscenza: "Essa mostra le vie del cuore che ci conducono alla fede, lungo le quali facciamo provviste per il nostro cammino verso il secolo futuro. Tuttavia, si tratta ancora di una conoscenza corporea e composita" 125 .
Il grado più elevato della conoscenza è quello che porta al di là sia della conoscenza razionale, sia dei limiti dell'ascesi esteriore.
124 Centurie di co11osce11za IV, I 6- I 7. 125 I,52 (p. z6o) ~ Touraille 64 (p. 339); PR 5I (pp. 372-373).
JIO
Si tratta di una conoscenza che sarà per così dire inghiottita dall'esperienza mistica della fede, per poter risorgere in un secondo tempo dotata di una qualità nuova:
Quando la conoscenza viene elevata al di sopra delle cose terrene, quando i suoi pensieri cominciano a sperimentare le realtà interiori celate agli occhi ed essa si protende verso l'alto e segue la fede nel suo interesse per il secolo nuovo, nel suo desiderio della beatitudine promessa e nell'esplorazione dei misteri nascosti, allora la fede inghiottisce questa conoscenza, la riconverte e la rigenera per farla diventare interamente spirito. Essa può allora, quasi alata, prendere il volo nel regno degli esseri incorporei, toccare le profondità di un mare ineffabile ponendo di fronte alla mente l'azione meravigliosa di Dio che governa le creature spirituali e corporee, ed esplorare i misteri spirituali che essa penetra con intelligenza semplice e sottile. I sensi interiori sono poi avviati a un'attività spirituale conforme a quella che sarà la condizione della vita immortale e incorruttibile. Giacché fin d'ora una simile fede riceve, nel mistero, la resurrezione spirituale, testimonianza verace del generale rinnovamento 126
•
Il terzo grado della conoscenza è dunque costituito dallo stato spirituale superiore che nasce dalla fede, la quale è la via che porta a tale grado di conoscenza. La vera conoscenza acquisita con l'aiuto della fede è l'opposto della "conoscenza terrena": questa allontana da Dio, quella rende più vicini a Dio; l'una è razionale, l'altra mistica; l'una intrisa d'orgoglio, l'altra inseparabile dall'umiltà:
La vera conoscenza rende perfetta nell'umiltà l'anima di coloro che l'hanno acquisita, come avvenne a Mosè, David, Isaia,
126 I,52 (p. z6I) ~ Touraille 65 (p. 340); PR 5I (pp. 373-374).
JII

Pietro, Paolo e gli altri santi sono stati resi degni della conoscenza per quanto a natura umana è consentito. E analogamente al caso di tali santi, anche la vera conoscenza di costoro è sempre sommersa da contemplazioni straordinarie, rivelazioni divine, visioni spirituali elevate e misteri ineffabìli, nonostante essi si considerino cenere e polvere127 .
Da notare come i termini "contemplazione", "rivelazione" e "visione" si applichino qui alla conoscenza, proprio come venivano applicati alla un passo che abbiamo citato all'inizio del capitolo.
Nella patristica la ripartizione della conoscenza è tra-dizionale: Isacco si all'insegnamento dei padri circa le co-noscenze naturali, e sovrannaturalil28 . Secondo ta-le classificazione, è la conoscenza degli atei, che allontana da Dio; la conoscenza naturale è quella religiosa che conduce a Dio e la conoscenza sovrannaturale è la conoscenza mistica che unisce a Dio:
della conoscenza raffredda l'anima nei confronti opere che portano a Dio; la seconda la infiamma e la incita verso dò che appartiene alla fede; la teF;;:a consiste nel dalla fatica ed è l'immagine di ciò che verfà, attra
applicazione dell'intelletto che trova la pronei misteri futuri 129
.
Isacco non segue sempre rigorosamente la classifica-zione tradizionale. chiama talvolta conoscenza naturale tutta la conoscenza del mondo materiale, conoscenza spirituale la conoscenza di Dio e conoscenza sovrannaturale l'unione con lui.
Touraille 63 (pp. 337-338); PR 5r (p. 37r). 26r) Touraille65 (p. 34rl; PR 5r (p. 374), Cf. inoltre, ad esempio, A di quelli cbe credono di w ere giustificati per !e opere 90.
65 (p. 34I); PR 5I (p. 375).
3I2
Quest'ultima, in definitiva, oltrepassa il concetto di "conoscene si potrebbe anche chiamare "ignoranza" apofatica o
vra-conoscenza":
La conoscenza che si occupa delle cose visibili e il cui oggetto è ricevuto attraverso i sensi è detta naturale. La conoscenza che risiede nel campo spirituale e raggiunge con le sue gli oggetti incorporei è detta spirituale ... Ma la conoscenza che si spinge fino alle cose di Dio sì chiama sovrannaturale o piuttosto ignoranza o anche conoscenza al di là della conoscenza130.
Questi ultimi due termini sono senza dubbio alla teo-logia di Dionigi l'Areopagita, che chiama la conoscenza mistica "n es d enza" o ignoranza 131 .
!sacco talvolta classifica la conoscenza in due categorie, distinguendo tra "conoscenza naturale" e "conoscenza spiritua-
: ~"Esiste una conoscenza che precede la e un'altra che nasce dalla fede. Quella che precede la è la conoscenza naturale, quella che nasce dalla fede è spirituale" 132 • conoscenza naturale è razionale, una "conoscenza dal basso"; la conoscenza spirituale è "sovra-razionale", una "conoscenza dall'alto". Non bisogna credere, sottolinea Isacco, che l'unione con Dio - che è la vera conoscenza - sia accessibile ai ragionamenti discorsivi dei filosofi:
Molte persone semplici pensano il fine dei ragionamenti dei filosofi sia un certo pregusto di comunione che contiene in sé tutti gli splendori dei misteri divini. Il beato vescovo Basilio, in una lettera al [Gregorio dì Nissa],
Ho I,;n (p. 264) = Touraille 66 (p. m Cf. Pseudo-Dionigi l'Areopagita, 132 !,47 (p. 226) = Touraille r8 (p. r24);
r e passim.

distingue tra la percezione dei filosofi e quella che ricevono i santi circa le essenze create, quest'ultima essendo la scala razionale di cui parla il beato Evagrio 133
, e che è al di là di qualsiasi visione ordinaria: "C'è una comunione -egli dice- che apre la porta che ci permette di contemplare la conoscenza delle essenze create ma non i misteri spirituali" 134
. Questa conoscenza dei filosofi egli la chiama una "conoscenza dal basso", accessibile anche a coloro che giacciono sotto il dominio delle passioni. Per contro, la percezione che ricevono i santi nel loro intelletto, per mezzo della grazia, è da lui chiamata "conoscenza dall'alto dei misteri spirituali". Chi ne è stato reso degno rimane giorno e notte in questo stato come chi, abbandonato il corpo, si trovasse già nel mondo dei giusti. Si tratta di quella dolcezza divina che il meraviglioso Ammonas, uomo dal cuore puro, ha sostenuto essere "più dolce del favo o del miele" 135 , ma ben pochi fra i solitari e gli asceti l'hanno conosciuta. È l'ingresso nella divina quiete di cui hanno parlato i padri 136 , e il passaggio dal campo delle passioni all'illuminazione e agli slanci della libertà 137
.
In quest'ultimo passo non si può fare a meno di notare le molte citazioni di testi patristici cui !sacco attinge per avvalorare le sue affermazioni. In un altro testo, a proposito dei due tipi di conoscenza, egli ricorre a Marco l'Eremita presso il quale il tema della conoscenza è studiato nel contesto delle pratiche ascetiche:
Esiste una conoscenza la cui forza dipende dalle opere buone ma ce n'è un'altra costituita dalla meditazione dell'intellet~o su Dio, come ha detto il beato Marco l'Asceta: "C'è una
133 Evagrio Pontico, Capitoli gnostici IV,43. . . . . . 134 Basilio Lettera 2 (che Isacco sostiene essere indmzzata a Gregono d1 N1ssa). m Ammo;1as, Lettere 2 (sul tema della forza divina che conduce l'uomo alla quiete). 136 Ibid. U7 II,35·7-II.
conoscenza il cui oggetto è l'attività, un'altra che ha per oggetto la verità. Come il sole è superiore alla luna, così la seconda è più importante della prima" 138 . Egli chiama "conoscenza attiva" quella che nasce dal servizio e dalla lotta contro le passioni, conformemente all'insegnamento dei comandamenti: l'uomo diventa sapiente attraverso il rapporto con i comandamenti, traendo profitto dalla meditazione su di essi. Ma la conoscenza della verità è quella che innalza l'intelletto al di là di tutto ed è illuminata dall'assidua meditazione su Dio, giacché solo in virtù della speranza l'intelletto è innalzato fino a Dio 139
.
La prima specie di conoscenza corrisponde a quella che la tradizione ascetica di lingua greca e soprattutto Evagrio chiama "vita attiva" (praktiké), mentre la seconda è chiamata "vita contemplativa" (theoria). !sacco adotta questa classica distinzione in un passo delle Centurie di conoscenza 140 . La seconda specie di conoscenza, identificata con la "contemplazione", non è altro che l'ascesa mistica dell'intelletto verso Dio.
Per !sacco la vera conoscenza consiste nel fare esperienza di Dio, nell'incontrarlo personalmente. È un'esperienza che permette di toccare con mano la realtà divina. Essa genera l'amore di Dio ed è fonte di estrema dolcezza:
L'amore nasce dalla conoscenza, e la conoscenza nasce dalla salute spirituale ... Domanda: Che cos'è la conoscenza? Risposta: La percezione della vita immortale. Domanda: Che cos'è questa vita immortale? Risposta: L'esperienza di Dio. Giacché l'amore viene dalla conoscenza e la conoscenza di Dio è la regina di tutti i desi-
138 Cf. Marco l'Eremita, A proposito di quelli cbe credono di essere giustificati per le opere I44·
"'II,ro,r4-r6. 14° Cf. Centurie di conoscenza I,56.

cleri; al cuore di colui che l'ha ricevuta ogni altra dolcezza della terra sembra insignificante. Nulla infatti è paragonabile alla dolcezza della conoscenza di Dio 141 .
L'uomo non può ricevere la vera conoscenza prima di aver raggiunto la purezza dell'intelletto, la semplicità di un bambino e la santità. È indispensabile rinunciare alla conoscenza naturale per acquisire quella spirituale:
Non solo è impossibile per una conoscenza puramente umana ricevere la conoscenza spirituale, ma non può nemmeno provaria attraverso i sensi, né rendersene degna in virtù di qualche sia pur generoso sforzo. Chi desidera accostarsi a questa conoscenza dello Spirito non potrà avvicinarvisi nemmeno di un passo finché non avrà rinunciato alla conoscenza puramente umana e finché i suoi pensieri non saranno diventati come quelli di un bambino. La conoscenza dello Spirito è semplice e non illumina le concezioni umane. Finché l'intelletto non si è liberato da un gran numero di pensieri e non è entrato nella semplicità unificata della purezza, non può provare la conoscenza spirituale il cui oggetto è percepire la dolcezza della vita del secolo a venire ... Nessuno può accogliere questa conoscenza spirituale a meno di convertirsi e diventare come un bambino (cf. Mt r8,3). Infatti fin da questa vita egli già sperimenta il regno dei cieli. Quando dicono "regno", le Scritture intendono la contemplazione spirituale 142.
I vari gradi della conoscenza spirituale corrispondono alle diverse tappe dello sviluppo mistico. !sacco elenca cinque tappe nella crescita spirituale, ciascuna delle quali possiede un particolare accento mistico e che, tutte insieme, costituiscono "il vertice unico della conoscenza spirituale":
141 I,62 (p. 298) = Touraille 38 (p. 228); PR 62 (p. 43r). 142 I,72 (pp. 352-353) = Touraille r9 (pp. r3o-r3r); PR 77 (pp. 526-528).
Le prime delizie trovate nella rivelazione spirituale fatta all'intelletto si incontrano nella contemplazione della sollecitudine di Dio, della quale l'intelletto sente la potenza e l'efficacia negli avvenimenti sensibili. Vengono poi le delizie che si trovano nella contemplazione di quella stessa sollecitudine in favore degli esseri [viventi]. In terzo luogo, quelle derivanti dalla contemplazione della sapienza di Dio negli esseri. L'incomprensibilità della sua economia di salvezza è tanto maggiore quanto più i suoi giudizi sono diseguali. A un primo sguardo, queste delizie si producono soprattutto a partire da mezzi umani: è la prima fede dell'intelletto. A un secondo sguardo, si basano sulla fiducia nel creatore e sono da essa rafforzate. Al terzo, le delizie sono per così dire soggiogate dal suo amore, come un bimbo quando vede il padre. Nel quarto caso, sono nascoste nella nube oscura della sua "multiforme sapienza" (Ef 3,ro). Al quinto impulso, le delizie sono accompagnate dalla stupefazione, in una coscienza che non comprende, sorda a ogni spiegazione ... Questi cinque cambiamenti, che si producono quando la comprensione aumenta, sono contenuti sotto il vertice unico della conoscenza spirituale143.
La conoscenza spirituale non si può acquisire con sforzi umani: è un dono dall'alto. Non è conseguenza immediata di una vita religiosa e non deriva dalle opere buone, ma è una ricompensa accordata all'eccellenza della vita. Questa conoscenza conduce alcuni fino al grado più elevato della fede che ormai non è più "fede per sentito dire" (cf. Rm Io,q) bensl "fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono" (Eb I I, I):
Questa conoscenza spirituale è concessa in dono all'esercizio del timore di Dio. Se lo esaminerai attentamente ti accorgerai
"' Centurie di conoscenza II, 73.75.

che esso è pentimento. E la conoscenza spirituale che lo segue è identica a quanto abbiamo detto a proposito del battesimo, cioè che "quello che abbiamo assaggiato come primizia lo riceviamo in dono nel pentimento" 144 • La conoscenza spirituale è disvelamento di ciò che è nascosto. Quando uno fa esperienza di queste cose invisibili che oltrepassano di gran lunga tutto il resto e dalle quali deriva il nome di conoscenza spirituale, allora nasce in lui un'altra fede che non si contrappone alla precedente ma la conferma. Si chiama "fede della contemplazione (theorfa) divina". Prima c'era l'ascolto, ora c'è la contemplazione (cf. Gb 42,5). Ma la contemplazione è più certa dell' ascolto145 •
Possiamo constatare che, per vie diverse, Isacco perviene a un'unica conclusione: il culmine dell'ascesa spirituale è l'esperienza mistica, indipendentemente dal termine con il quale essa è designata: preghiera spirituale, contemplazione, rivelazione, visione, illuminazione, intuizione, fede contemplativa, conoscenza spirituale. La via che conduce a questo culmine può essere descritta come un percorso che va dalla vita attiva nelle opere, la praktiké, alla theoria, la contemplazione; dall'ascolto alla visione, dalle tenebre all'illuminazione, dalla conoscenza razionale a quella sovra-razionale, dalla fede istintiva alla conoscenza spirituale, dal sapere umano all' "ignoranza" divina o alla sovra-conoscenza. La via verso la conoscenza di Dio, che è quella dell'ignoranza o nescienza, è una via che non conosce fine. Non avrà termine che nel secolo futuro, quando l'uomo sarà divenuto capace della pienezza della contemplazione e della conoscenza:
144 1,46 (p. 223) = Touraille 72 (p. 365); PR 43 (p. 3r5). '"' 1,47 (p. 227) = Touraille r8 (pp. I25·I26); PR 44 (p. vo).
Prima di potersi avvicinare alla conoscenza, l'uomo dovrà salire e scendere nella sua condotta. Avvicinandovisi, sarà completamente sollevato; ma, quale che sia l'elevazione, la sua ascesa verso la conoscenza sarà portata a termine solo quando avrà raggiunto il secolo glorioso nel quale potrà ricevere la piena misura delle sue ricchezze146
.
146 1,48 (p. 230) = Touraille 73 (p. 369); PR 45 (p. 324).

VIII LA VITA DEL SECOLO A VENIRE
Dio non vendica il male ma lo risana.
La maggior parte degli uomini entreranno nel regno dei cieli senza aver fatto l'esperienza della geenna.
Il,40,12
Ed eccoci giunti all'ultimo argomento della nostra dissertazione: l'escatologia di Isacco. La sua visione escatologica è parte integrante del suo sistema teologico: essa deriva dall'insegnamento sul Dio-amore e si basa su presentimenti connessi alla sua personale esperienza di mistico, avvalorati dall'autorità dei padri della chiesa che l'hanno preceduto.
La prima sezione di questo capitolo tratterà il tema ascetico tradizionale del memento mori. N ella seconda sezione raccoglieremo le concezioni escatologiche di !sacco così come si trovano, disseminate un po' dappertutto, nel corpus dei suoi scritti, ad eccezione dei discorsi dal39 al 41 della seconda parte della sua opera. Dal momento che questi tre ultimi discorsi presentano un'esposizione sistematica, ci è parso utile studiarli in dettaglio nella terza sezione del capitolo, che fungerà da conclusione a tutta la nostra ricerca.
321

Meditazione sul mondo a venire
La tradizione monastica d'oriente attribuisce una grande importanza al "ricordo della morte", considerandolo una delle pratiche capitali. Dobbiamo a Evagrio il consiglio: "Ricordati sempre della tua morte e non dimenticare mai il giudizio finale" 1. Gli eco abba Isaia: "Abbi tutti i giorni la morte davanti agli occhi ... preparati a rispondere nel giorno tremendo del giudizio di Dio" 2 • N ella tradizione siria ca i temi del ricordo della morte e del giudizio finale sono stati particolarmente sviluppati da il Siro\ e proprio a lui si richiama !sacco nel testo seguente:
Finché d troviamo in questo mondo Dio non appone il suo suggello o sul male, fino all'ora della nostra morte quando l'attività in patria avrà termine e usciremo in una regione straniera. Come ha detto sant'Efrem: "Dobbiamo pensare alla nostra anima come a un vascello pronto a salpare che ancora non sa quando spirerà il vento, o come un soldato che non sa quando suonerà la tromba di guerra. Se questo avviene
minore importanza, come ci dovremo prepa-rare ed in vista di quel giorno tremendo, di fron-te al ponte e alla porta conducono al secolo nuovo?" 4
•
Secondo !sacco il del carattere effimero della natu-ra umana non ci dovrebbe abbandonare maP. Ogni volta che ci prepariamo al sonno dobbiamo rammentarci della morte e dire a
1 Apoftegmi dei padri, Evagria 4· 2 Abba Isaia, Discorri r. 3 La sua opera più importante in siriaca è la Lettera a Publio sulla geenna. I nume
rosi testi di Efrem sull'argomenta, oggi conosciuti nelle principali lingue europee, ri-salgano a versioni greche e non la totalità dei suoi scritti.
4 I,6r (p. 301) = Thuraille 38 (p. PR 62 5 Cf. I,49 (p. 238) Touraille 39 232); 335-336).
322
noi stessi che quella notte potrebbe essere l'ultima: "Quando ti avvicini alletto, digli: 'Questa notte essere la mia tomba, e io non so se invece di un sonno temporaneo non scenderà su di me il sonno eterno"' 6 . Bisogna ricordarsi a ogni istante del giudizio finale e prepararsi all'incontro con Dio:
Come dice l'Interprete 7: "Il tempio della è sempre congiunto con Dio e il suo pensiero si preoccupa continuamente del suo giudizio"; e cosa vuol dire "preoccuparsi continuamente del suo giudizio" se non averlo sempre in cima ai propri pensieri, cercare incessantemente il riposo in Dio, rammaricarsi di non poter raggiungere la a causa della fragilità della nostra natura? Rammaricarsi incessantemente significa portare incessantemente nel cuore il ricordo di Dio, come ha detto il beato Basilio8
... Ecco in che cosa consistono la preoccupazione e il cuore frantumato con i quali ci prepariamo al nostro riposo9!
Il pensiero della morte e del secolo a venire aiutano a dominare la paura della morte:
uno persiste nella povertà il pensiero della partenza dalla vita non lo abbandona, ma orienta continuamente la sua meditazione verso la vita dopo la resurrezione; egli vi si prepara sempre e in tutti i modi ... per non temere la morte,
a ogni istante fissa gli occhi su di lei, come se fosse lì aspettarlo10•
Il pensiero del giudizio finale, che sorge nell'uomo grazie all'illuminazione spirituale, favorisce la sua crescita nel bene.
va te
(p. 215); PR 65 (p. 459). tvlopsuestra. Nella versione greca e nelle traduzioni da essa deri
anr:lotma a Gregorio il Teologo (di Nazianza).
3I8); PR 50 (pp. 352•353l-36o); PR 79 (p. 538).

Rammentandosi della sua ultima ora, l'uomo si fa più riflessivo e più attento alla propria condotta:
Quando la forza spirituale che è in noi si illumina, disprezziamo profondamente la paura della morte e veniamo continuamente ispirati dalla speranza della resurrezione ... l' attenzione al giudizio di Dio si rafforza e l'uomo comincia a sorvegliare giorno e notte il proprio comportamento, le parole e i pensieri; anche se si congeda da una splendida e pia ascesi, tale attenzione e tale ricordo non lo abbandonano più 11 •
"La meditazione sui beni futuri" 12 dovrebbe diventare una delle occupazioni più assidue del cristiano. Isacco porta l'esempio di un asceta che prega così:
Come ha fatto Dio a portare alla luce il mondo creato? ... E come lo distruggerà, annientando l'ammirevole costruzione, la bellezza degli esseri, il corso armonioso delle creature, delle ore e dei momenti, la sequenza dei giorni e delle notti, gli anni che si succedono agli anni, le varietà dei fiori che sbocciano dalla terra, le imponenti costruzioni cittadine con lo splendore dei loro palazzi, i rapidi movimenti di popoli, la loro operosità, la loro dura fatica dalla nascita fino alla morte? Come arrestare tutt'a un tratto questo mirabile ordine per dare inizio a un secolo nuovo, nel quale nessun ricordo della prima creazione resterà più impresso in nessuno, nel quale sopravverranno altri cambiamenti, altre meditazioni, altre preoccupazioni? La natura umana non ricorderà più nulla di questo mondo né della precedente forma di vita, perché l'intelletto dell'uomo aderirà totalmente alla contemplazione del suo nuovo stato, né più gli sarà concesso di tornare alla guerra
11 11,20,2. 12 Letteralmente: "meditazione sulle [realtà] a venire". La versione greca, e le ver
sioni moderne che da essa derivano, rendono "meditazione sulla restaurazione futura".
contro la carne e il sangue: con la distruzione del presente secolo, infatti, comincerà immantinente il secolo futuro 13 .
Questa meditazione arante porta l'uomo allo stupore davanti alla grandezza di Dio:
Oltre a essere colto da stupore davanti a ciò che Dio ha fatto e ad avere la mente ricolma della sua maestà, l'uomo è per giunta rapito fuori di sé dalla misericordia divina: e pensare che, dopo tutto questo, Dio ha preparato agli uomini un altro mondo che non avrà fine, la cui gloria non è stata rivelata nemmeno agli angeli! ... L'uomo è colto da stupore di fronte alla gloria che trascende ogni cosa, di fronte all'immagine di una restaurazione così elevata e all'insignificanza della vita presente in confronto alla creazione che è stata preparata per il secolo futuro 14 .
La meditazione escatologica sul secolo futuro è l'inizio di una rinascita spirituale e di un rinnovamento dell'uomo. Essa a poco a poco spegne il lui il pensiero della carne e cambia le sue idee mettendogli davanti agli occhi l'immagine del secolo a venire:
È quindi nella meditazione continua sui beni futuri che sta l'inizio del rinnovamento interiore dell'uomo. Egli in tal modo è progressivamente purificato dalla dissipazione abituale dovuta a cause terrene: assomiglia al serpente che si spoglia della vecchia pelle per rinnovarsi e ringiovanire. Allo stesso modo, nella misura in cui i pensieri materiali e le preoccupazioni che li accompagnano vanno scemando nell'intelletto, il pensiero dei beni del cielo e lo sguardo appuntato al futuro crescono nell'anima e si rafforzano. La dolcezza derivante dal pensiero dei beni futuri supera quella che viene dai pensieri materiali e li domina 15 .
13 I,37 (p. r8r) = Touraille 85 (p. 436); PR 35 (pp. 256-257). 14 II,ro,r9. 15 II,8,r6.

La vita dopo la morte
Consideriamo ora lo sguardo che !sacco rivolge alle realtà fondamentali dell'escatologia cristiana studiando i testi in cui parla della morte, della resurrezione dei morti, della separazione tra giusti e peccatori, delle pene dell'inferno e delle gioie del paradiso.
Isacco considera l'esistenza dell'uomo sulla terra come uno stato d'infanzia, un tempo da dedicare alla crescita spirituale. L'età futma, al contrario, implica ciascuno abbia raggiunto la sua taglia spirituale definitiva. I rapporti tra Dio e il suo popolo sono così chiamati a matmare: non più quelli di un padre con dei bambini che richiedono cure assidue e a volte debbono essere castigati. In altre parole, se la vita sulla terra corrisponde a un tempo di preparazione, e crescita, quella nel secolo a venire corrisponderà al pieno adempimento di tutte le potenzialità dell'uomo:
Se Dio è veramente lui che tutto ha generato attraverso la grazia, se gli esseri dotati di ragione sono suoi figli, se questo mondo è come una scuola in cui Dio educa i bambini alla conoscenza e li corregge quando fanno una sciocchezza, e se il mondo a venire è un retaggio per quando la "piena matu-rità [dì Cristo]" 4, sarà stata raggiunta, allora verrà un tempo in cui bambini diventeranno uomini e il padre senza dubbio muterà in gioia, in un mondo adulto, ciò che oggi ha l'apparenza del castigo, e i bambini saranno a loro volta elevati al di là bisogno di essere corretti 16 .
La frontiera tra la vita sulla terra e quella del mondo a venire è costituita dalla morte. Isacco la morte è lo shabta (sabato)
16 Centurie di conoscenza III, 7 r.
la natura umana troverà riposo alla vigilia della
Sei giorni passano nell'attività, nell'adempimento dei comandamenti; il settimo giorno viene trascorso interamente presso la tomba; l'ottavo è quello dell'uscita dalla tomba ... La tomba è il vero e incomparabile shabta che ci addita e ci fa conoscere il sollievo completo dal fardello delle passioni e il ristoro che deriva dalla cessazione dell'attività: la natura umana, anima e corpo, vi celebra il suo shabta 17 .
L'idea dello shabta come simbolo della morte è affatto tradi-zionale: la si ritrova sia nei testi patristici in quelli liturgici. Parimenti tradizionale è l'idea dell'ottavo come simbolo della resurrezione. Per !sacco la lo futuro è altresì prefigurata dal corpo to durante la vita presente:
dei morti nel secosi risolleva dal pecca-
La vera resurrezione del corpo avrà luogo quando esso sarà trasformato in modo ineffabile nel suo stato futuro, attraverso la spoliazione da ogni carnale e da tutto ciò che appartiene a quest'ultima. La sua resurrezione mistica avrà luogo quando sarà risuscitato da ogni peccato cui era legato nella sua vita terrena, e sarà consacrato al servizio insuperabile di Dio 18•
Riguardo alla resurrezione, uno dei testi più impressionanti si trova nelle Centurie di conoscenza, in cui !sacco ne parla come di una fonte di speranza per tutti uomini:
Non rattristarti, o di dover entrare un giorno nel silenzio della tomba, tu il più bello fra tutti, ma corrotto
11 1,29 (p. I4:2) = Touraille 74 (p. 3 n); PR 28 (pp. 202-204). 18 11,8,ro.
327

dall'oltraggio della morte! Dio ha posto un limite al silenzio della tua umiliazione e alla totale spoliazione, senza che resti ricordo di te. Com'è bella la tua struttura corporea' Ma anche: com'è impressionante la sua corruzione! Non !asciarti però abbattere dalla tristezza, giacché tu la rivestirai di nuovo quella struttura che, ardente di fuoco e di Spirito, porterà in sé l'immagine esatta del Creatore. Non ti tormenti alcun dubbio sulla solidità di questa speranza: Paolo stesso ti conforta: "Egli trasformerà - dice - il corpo della nostra umiliazione e lo renderà conforme al corpo della sua gloria" (Fil 3,2 r). Non rattristarti se dovremo restare lunghi anni nella corruzione della morte, sotto la polvere, fino a che sopravvenga la fine del mondo presente, giacché tutto ciò non peserà su di noi. La morte e tutto il tempo che dormiremo in una tomba passeranno come il sogno di una notte. Infatti il Creatore sapiente ha reso così leggera la nostra morte che non ne sentiremo minimamente dolore. Essa ci pesa finché non l'avremo accolta, ma poi non ci accorgeremo né della corruzione né della dissoluzione della nostra struttura, ma tutto ciò, quando ci sveglieremo e ci alzeremo per un nuovo giorno come se ci fossimo addormentati la sera prima, non sarà stato altro che il sogno di una notte. Così, leggero sarà per noi il sonno prolungato della tomba e lieve la durata degli anni che vi passeremo 19 .
Il giudizio finale è presentato da Isacco come il momento dell'incontro non solo con Dio ma con tutti coloro ai quali la nostra vita quaggiù è stata legata. La sentenza decreterà o l'entrata dell' anima nel regno di Cristo insieme ai giusti, o la sua separazione da loro. Tuttavia essa non sarà altro che una semplice ratifica dello stato raggiunto dall'uomo nella sua vita sulla terra. Chi è stato separato quaggiù dai suoi amici da una vita di peccato, lo sarà anche là:
19 Centurie di conoscenza III,74-75·
Guai al monaco che infrange il suo voto e, calpestando la propria coscienza, dà la mano al diavolo ... Con che faccia si presenterà al giudizio quando i suoi amici - gli stessi dai quali si era separato durante il cammino comune per avviarsi alla via della perdizione-, raggiunta la purezza, si ritroveranno al suo fianco? E, cosa ancora più tremenda: come egli se n'era staccato lungo il cammino di quaggiù, così Cristo lo separerà da loro nel giorno in cui una nube luminosa ne innalzerà i corpi fulgidi di purezza per deporli dinanzi alle porte del cielo 20
•
Agli occhi di Isacco la vita del secolo futuro appare come un "riposo ininterrotto e ineffabile in Dio" 21 . Essa non conosce né cambiamento né fine: "La nostra dimora sarà in cielo e noi saremo esseri celesti in una vita che non conoscerà mai né fine né mutamento" 22
• All'attività corporea se ne sostituirà una spirituale che consisterà in "uno sguardo di estrema dolcezza e una visione senza distrazioni" 23 . La mente umana sarà tutta presa dalla contemplazione della bellezza di Dio in uno stato di ininterrotto stupore:
La natura umana non cesserà mai di stupirsi di Dio e non conserverà nessun pensiero riguardo alle creature ... Dal momento che, nella rinascita futura, ogni bellezza creata sarà inferiore a quella di Dio, come potrebbe la mente, assorta nella sua contemplazione, distrarsi da essa 24?
Nel secolo futuro cesserà anche di esistere la struttura gerarchica del mondo, secondo la quale le rivelazioni divine vengono trasmesse da Dio agli ordini superiori degli angeli, quindi, per il loro tramite, agli ordini inferiori e all'uomo:
20 I,9 (p. n)~ Touraille ·+r (p. 239); PR 9 (p. I I4). 21 II, I8,3. 22 Centurie di conoscenza I, I 9. "II,8,2. 24 I,43 (p. 214) ~ Touraille I7 (p. I2I); PR 40 (p. 304).

dall'oltraggio della morte! Dio ha posto un limite al silenzio della tua umiliazione e alla totale spoliazione, senza che resti ricordo di te. Com'è bella la tua struttura corporea! Ma anche: com'è impressionante la sua corruzione! Non lasciarti però abbattere dalla tristezza, giacché tu la rivestirai di nuovo quella struttura che, ardente di fuoco e di Spirito, porterà in sé l'immagine esatta del Creatore. Non ti tormenti alcun dubbio sulla solidità di questa speranza: Paolo stesso ti conforta: "Egli trasformerà - dice - il corpo della nostra umiliazione e lo renderà conforme al corpo della sua gloria" (Fil 3,2r). Non rattristarti se dovremo restare lunghi anni nella corruzione della morte, sotto la polvere, fino a che sopravvenga la fine del mondo presente, giacché tutto ciò non peserà su di noi. La morte e tutto il tempo che dormiremo in una tomba passeranno come il sogno di una notte. Infatti il Creatore sapiente ha reso così leggera la nostra morte che non ne sentiremo minimamente dolore. Essa ci pesa finché non l'avremo accolta, ma poi non ci accorgeremo né della corruzione né della dissoluzione della nostra struttura, ma tutto ciò, quando ci sveglieremo e ci alzeremo per un nuovo giorno come se ci fossimo addormentati la sera prima, non sarà stato altro che il sogno di una notte. Così, leggero sarà per noi il sonno prolungato della tomba e lieve la durata degli anni che vi passeremo 19 .
Il giudizio finale è presentato da !sacco come il momento dell'incontro non solo con Dio ma con tutti coloro ai quali la nostra vita quaggiù è stata legata. La sentenza decreterà o l'entrata dell' anima nel regno di Cristo insieme ai giusti, o la sua separazione da loro. Tuttavia essa non sarà altro che una semplice ratifica dello stato raggiunto dall'uomo nella sua vita sulla terra. Chi è stato separato quaggiù dai suoi amici da una vita di peccato, lo sarà anche là:
19 Centurie di conoscenza III,74-75·
Guai al monaco che infrange il suo voto e, calpestando la propria coscienza, dà la mano al diavolo ... Con che faccia si presenterà al giudizio quando i suoi amici - gli stessi dai quali si era separato durante il cammino comune per avviarsi alla via della perdizione -, raggiunta la purezza, si ritroveranno al suo fianco? E, cosa ancora più tremenda: come egli se n'era staccato lungo il cammino di quaggiù, così Cristo lo separerà da loro nel giorno in cui una nube luminosa ne innalzerà i corpi fulgidi di purezza per deporli dinanzi alle porte del cielo 20
•
Agli occhi di !sacco la vita del secolo futuro appare come un "riposo ininterrotto e ineffabile in Dio" 21 . Essa non conosce né cambiamento né fine: "La nostra dimora sarà in cielo e noi saremo esseri celesti in una vita che non conoscerà mai né fine né mutamento" 22 . All'attività corporea se ne sostituirà una spirituale che consisterà in "uno sguardo dì estrema dolcezza e una visione senza distrazioni" 23 . La mente umana sarà tutta presa dalla contemplazione della bellezza di Dio in uno stato di ininterrotto stupore:
La natura umana non cesserà mai di stupirsi di Dio e non conserverà nessun pensiero riguardo alle creature ... Dal momento che, nella rinascita futura, ogni bellezza creata sarà inferiore a quella di Dio, come potrebbe la mente, assorta nella sua contemplazione, distrarsi da essa 24?
Nel secolo futuro cesserà anche di esistere la struttura gerarchica del mondo, secondo la quale le rivelazioni divine vengono trasmesse da Dio agli ordini superiori degli angeli, quindi, per il loro tramite, agli ordini inferiori e all'uomo:
20 I,9 (p. 73) = Touraille 4r (p. 239); PR 9 (p. rr4). 21 II,r8,3. 22 Centurie di conoscenza I,r9. "II,S,z. 24 I,43 (p. 2r4) = Touraille r7 (p. rzr); PR 40 (p. 304).

Nel secolo a venire quest'ordine di cose sarà soppresso, giacché nessuno riceverà da altri la rivelazione della gloria di Dio per la gloria e la gioia della sua anima, ma essa sarà elargita a tutti, senza intermediari, dal Signore in persona, a ciascuno secondo le sue forze in rapporto alla misura della sua ascesi e a ciò di cui è degno. Nessun dono verrà da altri, come accade oggi; nessuno insegnerà e nessuno dovrà essere istruito, nessuno avrà bisogno di altri per colmare le proprie carenze. Ci sarà un solo Donatore che donerà senza intermediari a quanti saranno in grado di ricevere, e questi ne otterranno la gioia del cielo. Abolite le categorie di maestro e di discepolo, il desiderio di tutti sarà di incontrare al più presto l'Unico 25 .
Nel secolo a venire le attività spirituali di questo mondo saranno annullate. In particolare, la preghiera nella sua forma presente verrà sostituita da uno stato sovrannaturale di cui solo i santi per ora hanno avuto saltuariamente esperienza:
Fra tutti i modi di essere dello stato psichico nulla è più elevato e più grande della preghiera. Nel mondo a venire, tuttavia, persino la preghiera sparirà, poiché gli uomini resteranno muti davanti a un ordine più elevato di quello della preghiera. Ordine che, fin da questo mondo, è già di tanto in tanto concesso ai santi quando pregano e a coloro che hanno raggiunto la pienezza 26 •
Anche la contemplazione e le visioni cesseranno alla fine dei tempi:
Se tutto ciò che ha attinenza con l'oggetto della contemplazione naturale, con tutte le sue forme, sarà abolito nel mondo futuro - giacché sta scritto che la forma di questo mondo pas-
"I,z8 (p. I4o) = Touraille 84 (pp. 4I4-4I5); PR 27 (p. zoi). 26 Centurie di conoscenza III,46.
330
serà con tutti i suoi gradi (cf. 1Cor 7,31)- è evidente che la sua contemplazione sarà anch'essa abolita e, con essa, la sua visione 27
.
Nella futura felicità nessuno subirà costrizioni. Ognuno dovrà fare una scelta personale per trovare la propria gioia in Dio. Per gli uomini tale scelta ha luogo durante la vita sulla terra e si esp:t:ime nella rinuncia alle passioni e nella conversione: "Non che gli uomini siano costretti a ereditare la gloria futura contro la loro volontà e senza conversione, giacché è piaciuto alla sapienza di Dio che ciascuno scelga i1 bene spontaneamente e possa così essere introdotto presso di lui" 28 . La felicità futura sarà appannaggio di coloro che fin dalla vita presente avranno raggiunto la "terra della promessa" e si saranno congiunti a Dio. I sacco però non esclude dal regno dei cieli quanti, pur non avendo visto quella terra da vicino, sono morti nella speranza di raggiungerla. Costoro, che hanno aspirato alla pienezza senza raggiungerla, saranno inclusi nella schiera dei giusti dell'Antico Testamento, che non hanno visto il Cristo in vita ma hanno sperato in lui 29 .
Chi entrerà nel regno dei cieli si troverà più o meno vicino a Dio secondo la propria capacità di accogliere la luce divina. Questa differenza di grado non implica tuttavia una diseguaglianza gerarchica tra gli eletti: per ciascuno, la misura personale della comunione con Dio sarà la più grande possibi1e e nessuno si troverà in posizione tale da prevalere sugli altri:
Parlando d eli' esistenza di molte dimore presso il Padre (cf. Gv 14,2) il Salvatore allude alle diverse misure di conoscenza di quanti abiteranno in quel luogo, cioè all'ineguaglianza e al-
27 Centurie di conoscenza III,9. 28 II,I0,20. 29 Cf. I,I2 (p. So)= Touraille II (p. Io6); PR I2 (p. I23).
33 1

la differenza dei doni spirituali che faranno la nostra gioia secondo la misura della conoscenza. In effetti, parlando di "dimore differenti" egli non intende luoghi diversi. Come ognuno gode del sole materiale in proporzione della purezza e della virtù ricettiva del suo sguardo ... così nel secolo futuro i giusti risiederanno tutti nella stessa regione senza essere separati gli uni dagli altri, ma ognuno contemplerà il medesimo sole spirituale secondo la sua misura personale, e attirerà gioia e allegrezza secondo la propria degnità ... Nessuno considererà la parte toccata all'amico più o meno importante della propria, cosicché, anche se dovesse constatare che la grazia dell'amico supera)a propria, non proverà per questo rammarico o tristezza. E impossibile che sia diversamente là dove non ci saranno più né rimpianti né lamenti (cf. Ap 2r,4)! Al contrario, ciascuno gioirà interiormente della misura che gli è stata concessa 30
.
Benché ci siano molte dimore nel regno dei cieli, tutte sono comprese entro i suoi confini, oltre i quali c'è la geenna di fuoco. Isacco non conosce nessuno stato intermedio tra il regno e la geenna:
Nel regno dei cieli l'oggetto della contemplazione è lo stesso per tutti, come pure il luogo. Tra questi due stati non c'è via di mezzo. Ho visto il livello più alto e il più basso: la differenza tra i due sta nella diversità delle ricompense. Se questo è giusto - e certamente lo è - si possono allora dire parole più insensate e sciocche di queste: "Mi basta evitare la oeenna· perché dovrei preoccuparmi di entrare nel regno?". Infatti: evitare la geenna è la stessa cosa che entrare nel reano e mancare il regno è lo stesso che precipitare nella geen;a. La Scrittura non parla di tre regioni, ma dice: "Quando verrà il Figlio dell'uomo ... porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sini-
30 I,6 (pp. 55-56)= Touraille 56 (pp. 299-3oo); PR 6 (pp. 86-87).
332
stra" (M t 25,3 r.33). Non capisci da queste parole che lo stato opposto a quello più eccelso è la geenna dei tormentP1?
Cosa rappresentano il paradiso e la geenna nel pensiero di Isacco? La felicità del cielo consiste per lui nella comunione dell'uomo con l'amore di Dio che è "l'albero della vita" o "il pane del cielo", cioè Dio stesso:
Il paradiso è l'amore di Dio nel quale si trovano le delizie di tutti i beati. Il beato Paolo vi ricevette un cibo sovrannaturale e dopo aver assaggiato dell'albero della vita esclamò: "Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono nel cuore di un uomo, queste Dio le ha preparate per coloro che lo amano" (rCor 2,9). Adamo divenne estraneo a quest' albero per suggerimento del diavolo. L'albero della vita è l'amore di Dio dal quale Adamo è stato strappato al momento della caduta ... Finché non abbiamo trovato l'amore, tutto ciò che riusciamo a produrre sulla terra sono soltanto rovi ... Ma quando l'abbiamo trovato veniamo nutriti dal pane del cielo ... Il pane del cielo è Cristo, disceso dal cielo per dare la vita al mondo (cf. Gv 6,33) ... in modo tale che chi vive secondo l'amore coglie la vita accanto a Dio e, fin da questo mondo, respira l'aria della resurrezione, quell'aria che farà la letizia dei giustP2
.
I tormenti dell'inferno, al contrario, si compendiano nell'impossibilità di unirsi all'amore di Dio. Ciò non significa che all'inferno i peccatori ne siano privati: anzi, l'amore è egualmente offerto tanto ai peccatori quanto ai giusti. Ma per i primi esso diventa fonte di gioia e felicità in paradiso, per gli altri, fonte di tormento nella geenna:
"I,6 (pp. 56-57)= Touraille 56 (p. 3oo); PR 6 (p. 88). 32 I,46 (p. 224) = Touraille 72 (pp. 366-367); PR 43 (pp. 3 r6-3 q).
333

Sostengo che coloro che sono tormentati geenna sono flagellati dalla sferza dell'amore! E quanto è cocente e le tale tormento! Coloro infatti che si rendono conto di aver peccato contro l'amore subiscono un tormento della paura del castigo; la tristezza che pervade i loro cuori a causa dei peceatì contro l'amore è più terribile di -.-·~--·--Sarebbe fuori luogo pensare che i nella geenna siano privati dell'amore di Dio. L'amore ... è concesso a tutti in generale. Ma la forza dell'amore ha un effetto: tormenta i peccatori - proprio come quaggiù essa a volte fa sl che un amico soffra a causa dell'amico quelli che hanno pagato il loro debito. a mio avviso, i tormenti della geenna sono una forma di Ma me-bria delle sue gioie i figli del cielo".
Benché Isacco sia persuaso che finale le pecore saranno separate dai capri e questi precipiteranno nella geenna, questa convinzione non gli di sperare nella misericordia di Dio la quale, a suo giudizio, trascende qualsiasi idea di giusta ricompensa, come abbiamo potuto rilevare nel primo capitolo di questo libro. La fiducia nella misericordia di Dio lo induce a pensare che le dei peccatori nella geenna non siano eterne. Se il male, il la morte e la geenna non hanno origine in Dio, è concepibile possano durare eterna-mente? Se i demoni, come pure uomini malvagi, sono stati creati da Dio buoni e senza ma si sono staccati da lui per loro libera scelta, è pensabile Dio possa accettare in eter-no una situazione simile? del genere sono state poste, molto prima di Isacco, da alcuni padri e dottori della chiesa an-tica, in particolare da Nissa.
Un discorso della non tradotto in greco, ha come titolo: "Contro dicono: Se Dio è buono, perché ha
33 !,28 (p. r4rl Touraille 84 (p. 4r5); PR 27 (pp. 2or-202).
334
creato cose simili?". Isacco confuta la concezione dualistica secondo la quale il bene e il male, Dio e il demonio sono te eterni. Nella sua argomentazione Isacco abbandona mento consueto della tradizione cristiana secondo cui Dio non sarebbe il creatore del male perché il male non ha sostanza:
Il peccato, la geenna e la morte non esistono nel più assoluto in Dio, perché sono azioni e non sostanze. Il peccato è frutto della libera volontà. Ci fu un tempo in cui il peccato non esisteva e ci sarà un tempo in cui non esisterà La geenna è frutto del peccato. Essa ha cominciato a esistere a partire da un dato momento, ma il tempo sua fine ci è ignoto. La morte tuttavia è la misericor-dia del Creatore. Essa dominerà solo per poco sulla natura e sarà in seguito completamente abolita. Il nome di Satana indica la sua caduta volontaria al di fuori ma non vuoi dire che sia stato malvagio fin dall'inizio 34 •
Per Isacco, il peccato e la morte saranno aboliti da Dio, mentre la "fine della geenna" rimane e la sua conoscenza travalica i limiti della ragione umana: non per nulla essa non fa nemmeno parte dell'insegnamento dogmatico della chiesa. Isac-co non sviluppa qui il suo insegnamento carattere non eterno della geenna, come avrà occasione di discorsi dal 39 al 41 della seconda parte. La sua attenzione inizialmente non si appunta sulla geenna in sé e per sé, ma piuttosto sulla futura trasfigurazione dell'universo dopo l'abolizione della geenna.
La visione escatologica di Isacco è pervasa di ottimismo. In questo senso egli è vicino all'escatologia di san Paolo, presso il quale troviamo la dottrina della trasfigurazione della creazione, quando "la morte sarà stata ingoiata per la vittoria" (rCor 15,55), e Dio sarà "tutto in (rCor 15,28). Isacco è con-
34 PR 26 (p. r89).
335

vinto che questo stato, che ci è promesso, arriverà senza fallo, anche se potrà essere preceduto da un periodo intermedio durante il quale i peccatori si troveranno nella geenna. La speranza della trasfigurazione del creato alla fine della storia umana gli fa sgorgare dal cuore un rendimento di grazie a un Dio la cui misericordia non conosce limiti:
Che bontà infinita è quella con cui Dio porta la natura peccatrice al suo rinnovamento! Chi ha forze sufficienti a glorificarlo? Egli risolleva chi ha trasgredito i suoi ordini e bestemmiato il suo Nome! Il peccatore non sa immaginarsi la grazia della sua resurrezione. Dov'è la geenna che avrebbe potuto abbatterci? Dov'è il tormento capace di impaurirci in mille modi e di soverchiare la gioia del suo amore? E che cosa significa la geenna in confronto alla grazia della sua resurrezione, quando ci solleverà dagli inferi e farà sì che "questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità" (1Cor 15,53), e innalzerà nella gloria ciò che prima era all'inferno? Venite, uomini dotati di ragione, e riempitevi di meraviglia! Quale uomo dotato di spirito saggio e ammirevole sarebbe degno di stupirsi della misericordia del nostro creatore? C'è forse un premio per i peccatori se, invece di un equo compenso, egli dona loro la resurrezione e, al posto della corruzione dei loro corpi, li riveste della gloria perfetta dell'incorruttibilità? Una misericordia simile - farci risuscitare dopo tutti i peccati che abbiamo commesso! -è più grande di quella che ci ha portato dal nulla alla luce. Gloria, o Signore, alla tua grazia infinita! Ecco, le onde della tua grazia mi riducono al silenzio e non mi lasciano più alcun pensiero per ringraziartP5!
"I,5r (pp. 251-252) = Touraille 6o (p. 325); PR 50 (pp. 358-359)
<é~ij$f i
Punizione eterna o salvezza universale?
Gli avvenimenti successivi alla morte sono oggetto di uno studio particolare nei tre capitoli conclusivi della seconda parte dell'opera di Isacco. Il capitolo 39 è intitolato: "Contemplazione sul tema della geenna, per quanto sia concessa a natura umana la grazia di farsi un'opinione su tali misteri". Esso contiene un'ampia trattazione teorica della sua dottrina sulla natura, il fine e la durata dei tormenti della geenna. Il discorso 40 si riallaccia al precedente e il suo tema è così definito: "Il carattere permanente e immutabile della natura divina e il suo amore, all'inizio e alla fine della creazione". Il discorso 4 r trae le conclusioni etiche degli altri due.
Nel discorso 39 la riflessione di Isacco comincia con il chiedersi perché Dio abbia istituito la geenna. L'autore sottolinea che tutta l'attività di Dio per l'umanità discende dalla sua "immutata ed eterna bontà", dall'amore e dalla compassione. Pertanto, gli sembra blasfemo pensare che Dio possa agire per vendetta o rivalsa 36 . Tale opinione è tanto più inaccettabile in quanto Dio, pur conoscendo prima ancora di crearlo i peccati e le future cadute dell'uomo, nondimeno lo creò:
Che vergogna pensare che in Dio possa albergare il desiderio di vendicarsi del male commesso dall'uomo: sarebbe come attribuire a questo essere [perfetto] la debolezza di servirsi di una cosa tanto importante e dolorosa per prendersi una rivincita! Se già è inverosimile trovare un desiderio del genere in persone dalla vita pia e onesta in pieno accordo con la volontà di Dio, a maggior ragione non è credibile che Dio abbia potuto fare alcunché a scopo di vendetta per il male compiuto, mentre sapeva già da prima come si sarebbero comporta-
36 Si vedano le citazioni del capitolo "Dio, l'universo e gli uomini" (supra, pp. 37-72).
337

ti quelli ai quali con stima e amore aveva dato la vita. Sapeva tutto quello che avrebbero fatto, eppure non ha chiuso la fonte della sua grazia. Dirò di più: anche dopo che essi si furono impegolati in azioni malvagie la sua sollecitudine per loro non venne meno un solo istante37
.
Ancora più fuorviante è l'opinione secondo la quale Dio avrebbe permesso agli uomini di peccare durante la loro vita sulla terra per poterli punire eternamente dopo la morte. Questa affermazione blasfema e perversa equivale a una calunnia:
Se qualcuno sostiene che unicamente per manifestare la sua pazienza Dio tollera quaggiù quelli che poi castigherà senza misericordia nell'aldilà, attribuisce a Dio - mostrando una coscienza puerile - una bestemmia mostruosa: toglie a Dio la bontà, l'i~dulgenza e la misericordia, cioè precisamente le qualità grazie alle quali egli sopporta i peccatori e i malvagi. Chi pensa questo attribuisce a Dio uno stato d'animo passionale, come se egli evitasse di infliggere castighi quaggiù solo per paterne preparare in cambio di ben più gravi, dopo questa pazienza di corta durata. Un uomo del genere non solo non attribuisce a Dio niente di giusto o lodevole, ma addirittura lo calunnia 38
•
In questa presentazione della bontà e della misericordia divine !sacco ha in mente il racconto della maledizione scagliata da Dio contro Adamo ed Eva dopo il loro peccato e la cacciata dal paradiso terrestre. L'introduzione della morte e la cacciata dal paradiso hanno avuto luogo sotto forma di maledizione, al cuore della quale, tuttavia, si celava una benedizione:
Avendo introdotto la morte per Adamo sotto forma di una sentenza che castiga il peccato, e avendo rivelato la presenza
37 II,39,2. "Ibid.
del peccato per mezzo di un castigo - benché il castigo non fosse il suo scopo -, Dio ha dato l'impressione che la morte fosse stata istituita come punizione per la colpa di Adamo. Ma così egli ha celato il vero mistero della morte e, sotto un'apparenza paurosa, ha congiunto il suo fine eterno riguardo alla morte con un piano sapiente basato su di essa: mentre la morte di primo acchito può far paura e sembrare vergognosa e crudele, nondimeno è per mezzo di essa che noi siamo innalzati verso un mondo elevato e pieno di gloria. Senza la morte non sarebbe stato possibile passare da quaggiù a lassù. Quando la istituì, il Creatore non disse: "Questo vi capita a causa dei beni che sono stati preparati per voi e a causa di una vita più gloriosa della presente". Al contrario, l'ha presentata come un male e una cosa funesta. Parimenti, quando cacciò Adamo ed Eva dal paradiso lo fece come se fosse in collera: "Poiché avete trasgredito il mio ordine, sarete fuori del paradiso", come se la permanenza nel paradiso fosse stata lor; tolta a causa della loro indegnità. Ma in tutto questo c'era un piano [divino] per realizzare quello che era l'obiettivo del Creatore fin dall'inizio. Non è stata la disobbedienza a procurare la morte alla discendenza di Adamo, né è stata la trasgressione al comando di Dio a cacciarlo con Eva dal paradiso: questo infatti rappresentava solo una piccola parte della terra mentre essi erano destinati a dominarla tutta quanta. Perciò non dobbiamo dire che Dio li ha cacciati a causa della trasgressione al suo ordine: anche se non avessero trasgredito non sarebbero comunque rimasti per sempre in paradiso 39 •
In tal modo !sacco rafforza la tesi che la morte sia stata una benedizione in quanto fin dall'inizio conteneva in potenza la resurrezione futura, e che la cacciata dal paradiso sia stata un bene per l'uomo perché, in cambio di un "cantuccio di terra", egli ricevette il dominio di tutto il pianeta. Questo approccio al rac-
,. II,J9.4·
339

conto della Genesi è senz'altro basato sull'esegesi di Teodoro di Mopsuestia, secondo il quale la morte fu una fortuna per l'uomo perché gli aprì la strada verso la conversione e il successivo rinnovamento 40
.
Per !sacco la morte fu il risultato di un"'astuzia" di Dio, che avrebbe celato il suo vero scopo - la salvezza dell'umanità - sotto le sembianze di un castigo per il peccato. Con un'astuzia analoga si spiega la geenna, istituita da Dio come apparente forma di castigo, mentre il suo vero scopo è il bene dell'uomo. È indispensabile, afferma !sacco, che la storia dell'umanità appaia dall'esterno un castigo e una pena, mentre il suo vero fine è la realizzazione del nostro bene con tutti i mezzi possibili. Conoscendo in anticipo la nostra inclinazione per tutte le forme del male, Dio ci ha preparato un'astuzia, cosicché ciò che appariva un danno si rivelasse invece strumento del nostro riscatto. Solo attraversando quello che sembra un castigo inflitto da Dio ci accorgiamo che esso è al servizio del nostro bene. Da parte di Dio non c'è castigo, giacché la sua unica preoccupazione è il bene che potrà derivare da tutta la sua attività in favore degli uomini. Ora, i castighi della geenna, istituiti da Dio, fanno appunto parte di questa attività 41 .
Così, passo dopo passo, !sacco si avvicina alla sua idea centrale, cioè che la conclusione della storia umana debba corrispondere alla grandezza della Trinità, e che la sorte ultima dell'uomo debba essere degna della misericordia di Dio:
Per quanto mi riguarda - dichiara Isacco - io penso che il glorioso Creatore si proponga di mostrare l'azione mirabile e il punto d'arrivo della sua grande e inesplicabile misericordia per quanto concerne gli aspri tormenti da lui istituiti, affinché grazie a essi la ricchezza del suo amore, la sua potenza
4° Cf. Teodoro di Mopsuestia, Frammenti sullibm della Genesi. 41 Cf. II,)9,5·
e la sua sapienza siano ancor più evidenti, come pure la virtù sfolgorante degli effluvi della sua bontà. Il Signore misericordioso non ha creato esseri dotati di ragione per sottoporli spietatamente a sofferenze infinite se, pur sapendo già da prima di crearli in che modo si sarebbero corrotti, li creò ugualmente. Tanto più che progettare il male o la vendetta è caratteristico delle passioni delle creature, non del Creatore; è un atteggiamento tipico degli uomini, che non sanno quello che fanno o pensano e non sono consapevoli di ciò che capita loro. Quando qualcosa di imprevisto li colpisce, si infiammano di collera e provano un impulso di vendetta. Questo non ha assolutamente niente a che vedere con il Creatore che, disegnando l'immagine della creazione, sapeva tutto quello che era successo prima e tutto quello che sarebbe successo dopo come conseguenza della sua azione, fino alle intenzioni degli esseri razionali 42 .
Per avvalorare il suo punto di vista !sacco fa appello sia a Teodoro di Mopsuestia, il quale aveva insegnato che le sofferenze del secolo futuro non sarebbero state eterne 43 , sia a Diodoro di Tarso, che aveva teorizzato la breve durata dei tormenti dei peccatori, mentre la loro felicità dopo la liberazione sarebbe stata eterna 44
. E Isacco commenta:
Tali illuminazioni e opinioni mirabili, che ci portano ad amare il Creatore e a stupirei dinanzi a lui, ci vengono offerte da queste grandi colonne della chiesa 45 quando trattano dell'economia divina, del giudizio futuro e della grande misericordia di Dio, la cui fiumana è più potente delle cattive azioni delle creature e trionfa su di esse. Il loro punto di vista fa giustizia di tutte le opinioni puerili che vorrebbero introdurre le
42 II,39,6. 43 Contro quelli che sostengono che il peccato sia intrinseco alla natura umana. 44 Cf. Diodoro di Tarso, Sulla provvidenza 5-6. 45 Teodoro e Diodoro.
34I

passioni nella natura divina, sostenendo che Dio cambia secondo le circostanze temporali. Ci insegnano altresì il senso dei castighi e dei tormenti, quelli di quaggiù e quelli dell' aldilà, e l'obiettivo misericordioso di Dio nel permettere che questi tormenti ci colpiscano e le conseguenze principali che ne discendono. Il senso non è che Dio voglia lasciarci soccombere a tali tormenti, né che voglia farceli sopportare in eterno; al contrario, ce li manda come un padre e non come un vendicatore, cosa che sarebbe segno di odio da parte sua. Il loro scopo è di farci pensare a lui, di farcelo conoscere, di condurci
colti dallo stupore al suo amore, di coprirci di confusione e farci raddrizzare la nostra condotta in questa vita 46 .
!sacco ritiene l'idea della non eternità del castigo non debba attenuare né annullare il timore di Dio. Al contrario, a partire da una presa di coscienza dell'infinita misericordia del Creatore, essa dovrebbe infiammare l'uomo d'amore per lui e condurlo al pentimento. L'idea di un Dio che è come un padre pieno di sollecitudine per noi, genera nell'uomo un sentimento d'amore filiale e il desiderio di abbandonarsi a lui, mentre l'idea di un vendicatore spietato suscita timore servile e angoscia al suo cospetto.
Ogni sventura e ogni sofferenza che colpisca l'uomo è mandata da Dio per indurlo a un cambiamento interiore. Dio non si vendica mai del passato, non quaggiù e neppure nell'aldilà, ma si preoccupa unicamente del nostro avvenire:
I castighi e i tormenti di ogni sorta che da lui ci vengono non ce li manda per farci pagare il fio azioni passate, ma se ne serve per un vantaggio futuro ... Ecco quello che ci dicono e ci rammentano le Scritture ... in particolare, che Dio non si vendica male, ma lo punisce per correggerlo. La vendetta
è propria dei malvagi, la correzione è propria di un padre. La Scrittura mostra che se egli permette il bene o il male come castigo, non è questo il suo fine ma, al contrario, egli vuole suscitare in noi l'amore e il timore. Attraverso il timore purifichiamo il nostro modo di vivere; attraverso l'amore cresciamo con discernimento nelle opere buone. Se non fosse così, che relazione ci sarebbe tra la venuta di Cristo e le azioni delle generazioni precedenti? Questa immensa compassione ti sembra davvero essere un castigo per quelle azioni malvagie? O uomo, se Dio è un vendicatore e se tutto ciò che fa lo fa per vendetta, mostrami le prove di tale vendetta47 !
L'idea dell'amore è in antitesi con quella della vendetta: Isacco non si stanca mai di ripeterlo. Inoltre, supporre che Dio faccia soffrire i peccatori in eterno sarebbe quasi come ammettere che la creazione del mondo stata uno scacco e un errore, poiché Dio non sarebbe stato capace di opporsi a un male che non era nei suoi piani:
In questo modo noi non attribuiamo più l'idea di vendetta all' azione di Dio verso di noi ma, al contrario, parliamo della sua provvidenza paterna, del suo sapiente governo del mondo, della sua volontà perfetta tutta orientata al nostro bene, del suo amore. Dove c'è amore non c'è castigo, ve c'è castigo non c'è amore. Quando l'amore compie azioni buone o corregge i passi falsi, non esige che si paghi per le colpe commesse in passato ma si prende cura di ciò che è più vantaggioso per l'avvenire, ed esplora quello che ancora succedere, non ciò è già avvenuto. Pensare il contrario - che modo puerile di vedere le cose! - vorrebbe dire considerare il Creatore un inetto perché, essendosi le sue creature corrotte contro la sua volontà, egli avrebbe escogitato una soluzione qualsiasi e, per punirle della loro corruzione, avrebbe
47 II,39,I5-I6.
.34.3

provocato un male impressionante. Questo modo di vedere fa del Creatore un incapace 48 !
La ragione umana non può comprendere i giudizi segreti di Dio. Uno di tali misteri è appunto la geenna, creata solo per condurre alla perfezione morale chi non è riuscito a raggiungerla durante la vita terrena:
C'è un mistero nei tormenti e nella condanna della geenna, giacché il sapiente Creatore si è servito delle nostre azioni e delle nostre volontà malvagie come di un punto d'appoggio per realizzare il risultato futuro, secondo un'economia che contiene un sapiente insegnamento e un'utilità ineffabile celati tanto agli angeli quanto agli uomini, nonché a coloro che soffrono il castigo - demoni o uomini che siano - e che resteranno nascosti per tutta la durata dell'attesa stabilita49 •
La geenna, dunque, più che un inferno è una sorta di purgatorio, il cui fine è di salvare sia gli angeli che gli uomini. Esso tuttavia è nascosto agli occhi di coloro che vi sono tormentati e sarà svelato solo nel momento della sua abolizione.
A questo punto !sacco riprende la discussione sull'incompatibilità tra l'idea di ricompensa e quella della bontà di Dio, adducendo, a fil di logica, i seguenti argomenti:
344
Si parla di ricompensa quando chi ne è il dispensatore tiene più o meno conto del risultato delle buone o cattive azioni compiute e, in rapporto a quelle azioni, la sua conoscenza cambia al loro variare e i suoi disegni si modificano secondo le circostanze. Ora, se il regno e la geenna non fossero stati previsti dalla coscienza del nostro Dio sommamente buono contemporaneamente all'apparizione del bene e del male,
non ci sarebbe più un'economia eterna di Dio riguardo a essi e la giustizia o il peccato sareb~ero stati a lui sconosciuti prima di essere messi in opera. E per questo che il regno e la geenna sono conseguenze della misericordia di Dio, da lui inventate secondo la sua bontà eterna e non come frutto di una ricompensa, anche se è stato dato loro questo nome. Ancora una volta, dire o sostenere che questo modo di fare non è intriso d'amore e di misericordia è una bestemmia contro il Signore Dio nostro. Se poi sosteniamo che è per farci soffrire e infliggerei tormenti e pene che egli ci sottopone al fuoco, allora attribuiamo all'essenza divina sentimenti di inimicizia contro gli esseri dotati di ragione che essa stessa ha plasmato per pura bontà; analogamente, se affermiamo che agisce o pensa per cattiveria, spirito di rivalsa o desiderio di punire, è come se dicessimo che si vendica di se stesso50 .
Possiamo così constatare come !sacco si avvalga di tutte le risorse disponibili per provare la sua tesi dell'incompatibilità tra castigo eterno e bontà del Creatore: egli si appoggia dapprima sulle Scritture e sui testi dei dottori della chiesa, per concludere poi con argomentazioni di ordine logico. Abbiamo già mostrato nel primo capitolo di questo libro come la dottrina di un Dio che è amore sia la forza motrice della sua teologia. Vediamo ora come essa si ripercuote nella sua escatologia.
L'amore di Dio si rivela nel destino ultimo del mondo
La dissertazione sull'amore infinito di Dio, iniziata nel discorso 39, prosegue nel successivo. !sacco vi afferma che l'amo-
'0 II,39,2I-22.
345

re di Dio per le creature non subisce mutamento alcuno se esse cambiano. Abbiamo già accennato a questa concezione nel primo capitolo. Dio, per essenza è necessariamente lo stesso da sempre, "riversa su tutta la creazione lo stesso amore e la stessa misericordia, immutabili, eterni e fuori del tempo" 51 •
Per !sacco è contro natura trovarsi lontani da Dio, e Dio non permette a chi si è allontanato da lui di rimanere per sempre in questa condizione. porta alla salvezza tutti coloro che sono caduti e si sono da lui. Ma questa salvezza non sarà lo-ro imposta per forza: dovranno rivolgersi spontaneamente a lui quando avranno raggiunto la maturità spirituale. Il per il quale la creazione è stata portata all'esistenza è indipendente dal cammino che essa ha intrapreso: prima o poi sarà ricondotta al suo fine. Ne discende la necessità della salvezza finale dei peccatori e dei demoni:
È certo che Dio non li ha abbandonati al momento della loro caduta; pertanto, né i demoni rimarranno nella loro condizione di demoni, né i peccatori persevereranno nel loro peccato: al contrario, egli ha intenzione di portarli tutti verso una stessa e identica perfezione in rapporto al suo essere personale, verso lo stato in cui si trovano fin d'ora angeli santi, nella ple:nezza dell'amore e in una coscienza impassibile. Egli ha voluto condurli a quell'eccellenza della volontà in cui non saranno più né prigionieri, né liberi, né dagli impulsi dell'Avversario, ma si troveranno in una conoscenza eccellente, nella quale i pensieri matureranno ai moti ricevuti da-gli divini, preparati dal nostro Creatore secondo la sua grazia. Saranno resi perfetti nel loro amore verso di lui e realizzati nella conoscenza che li porrà al di là di ogni inclinazione malvagia dei loro impulsi52 .
, II,40,L 5> II,4o,4.
Secondo il pensiero di Isacco tutti quelli che si sono allontanati da Dio si volgeranno di nuovo a lui dopo un breve castigo nella geenna, predisposta al fine di purificarli nel fuoco del dolore e del pentimento. Dopo aver attraversato questo fuoco purificatore, aspetteranno di raggiungere uno stato simile a quello degli angeli:
Forse raggiungeranno la più perfezione e saranno ancor più in alto dello stato in cui ora si trovano gli angeli, giacché saranno tutti abbracciati in uno stesso amore, una stessa coscienza, una stessa volontà, una stessa conoscenza perfetta; contempleranno Dio con desiderio insaziabile pieno d'amore, anche se quel disegno 53 si può provvisoriamente realizzare per una ragione nota solo a Dio e per un tempo da lui stabilito, secondo il volere della sua sapienza54 •
Dio non dimentica nessuna delle sue creature e ciascuna ha un posto che la attende regno dei cieli. Per quelli che non so-no subito preparati a entrarvi ha previsto un periodo torio di tormenti nella geenna:
Dio non lascia nessun gruppo di creature dotate di ragione, quando si tratta di prepararle per quel regno sublime che è destinato a tutti gli uomini. In virtù della bontà della sua essenza alla quale dopo aver portato l'universo al-l'esistenza lo lo guida e se ne prende cura, tanto de-gli uomini quanto di tutte le altre creature - sua compassione ha progettato di costruire il regno dei cieli per l'insieme degli esseri dotati di ragione, anche se ha dovuto stabilire un periodo transitorio affinché arrivare tutti allo stesso livello. Il nostro modo di vedere concorda con l'insegnamento delle Scritture. Tuttavia, anche se
'" Quello della geenna. 54 !1,40,5.
347

limitata nel tempo, non per questo la geenna è meno tremen-da. Chi la può sopportare? Per questa "c'è gioia da-
per un solo peccatore si converte" (Le
Se dagli esseri dotati di ragione si dovesse una giusti-zia rigorosa, solo uno su diecimila- osserva Isacco- entrerebbe nel regno dei Per questo Dio ha donato all'uomo il rimedio del pentimento, capace di guarire in breve dal peccato. Dio "non vuole la morte del peccatore", e così ci ha donato il pentimento per poterei rinnovare ogni giorno. Dio è buono in essenza e "vuole salvare tutto con qualsiasi mezzo" 56 •
L'opinione che la maggior parte degli uomini sarebbe condannata al fuoco dell'inferno e solo una piccola schiera di eletti potrebbe nel regno dei cieli è totalmente estranea a Isacco. Al contrario, egli è convinto che la maggior parte degli uomini si ritroverà nel regno dei cieli e solo pochi malvagi e qualche peccatore saranno mandati alla geenna, e comunque so-lo il tempo necessario alla remissione loro peccati:
Secondo questa concezione della la maggior parte degli uomini entreranno nel regno dei senza aver fatto l' espe-rienza della geenna; tranne a causa della durezza di cuore e della sua totale inclinazione verso il male e la concupiscenza, non ha il cuore frantumato per le sue colpe e i suoi peccati, nella misura in cui non è stato ancora corretto. Giacché la santa Essenza è così buona e misericordiosa da essere continuamente alla ricerca della minima occasione per rimetterei sulla retta via, allo scopo di poter perdonare i peccati degli uomini, come è successo al pubblicano giustificato dalla sua preghiera di contrizione (cf. Le 18,9-14), o alla vedova con le sue due monetine (cf. Mc I o alladrone che ricever-
I.
croce (cf. Le z 3 ,40-43). Dio infatti cerca la nostra non un pretesto per farci
La vita sulla terra è data all'uomo in vista della conversione. Basta che eglì si rivolga a Dio chiedendo perdono, perché i suoi peccati siano immediatamente perdonati58 . Ne abbiamo un pegno nell'incarnazione del Verbo di Dio il quale, giacendo tutta la creazione in mezzo a mali d'ogni sorta, discese sulla terra per riscattare l'umanità e l'universo intero con la sua morte in croce.
Lo studio dell'escatologia di I sacco è stato particolarmente ar-duo per l'autore di queste pagine. consapevoli che il suo insegnamento sulla salvezza di tutti gli uomini avrebbe lasciato perplesso più di un lettore. Dato il contesto, abbiamo preferito non schierard a favore punto dì vista di Isacco né dissociarci da esso. Ci riteniamo troppo lontani dalla sua pienezza spirituale e dalla sua visione mistica per osare proporre una valutazione equilibrata e definitiva delle sue concezioni escatologiche. Vorremmo solo rispondere ad alcune domande - non per giustificare Isacco, cosa di cui un padre della chiesa non ha bisogno, ma per chiarire le ai lettori-, domande che noi ci siamo posti durante la lettura e la traduzione degli ultimi capitoli della seconda parte della sua opera.
Innanzitutto, in una tale concezione del dramma della storia umana, il bene e il male non stanno in definitiva sullo stesso piano fronte alla misericordia di Dio? Quale può essere il senso della sofferenza, della vita ascetica, della preghiera, se i giusti
57
58
349

si trovano prima o poi nella stessa condizione dei peccatori? E ancora, in che misura l'opinione di Isacco corrisponde all'insegnamento dell'evangelo, in particolare al racconto del giudizio finale nel quale si parla di separazione delle "pecore" dai "capri"? La sua dottrina non assomiglia forse a quella di Origene sull'apocatastasi, condannata a Costantinopoli nel vr secolo?
Bisogna prima di tutto ricordare che Isacco non rifiuta affatto l'idea della separazione delle pecore dai capri, anzi ricorre proprio a essa per affermare che non c'è via di mezzo fra la geenna e il regno dei cieli. Ma il suo pensiero si spinge più in là, in quanto egli ritiene che la separazione tra pecore e capri non sia né definitiva né immodificabile. Come abbiamo potuto constatare, Isacco non nega mai la realtà del giudizio finale, anzi, raccomanda di ricordarsene ogni giorno. Quando ne parla, descrive concretamente la separazione tra i peccatori e i giusti. Tuttavia, secondo lui, questa separazione ha già avuto luogo nella vita presente, nella quale c'è chi visita i malati, riveste gli ignudi, nutre gli affamati, e chi non lo fa. Questo è il senso della parabola: il giudizio finale non farà altro che rivelare lo stato che l'uomo ha raggiunto sulla terra. Isacco pertanto intende la parabola del giudizio non come affermazione dell'eternità dei castighi, bensì come ammonimento profetico rivolto a quanti, nella vita presente, non si curano del loro prossimo.
In secondo luogo, Isacco ci avverte che l'esperienza della geenna e della separazione da Dio è terribile e dura da sopportare anche se limitata nel tempo:
Stiamo attenti, miei amati, e cerchiamo di comprendere che un soggiorno nella geenna, anche limitato nel tempo, resta qualcosa di assolutamente terribile, e che il livello delle sofferenze ivi patite va al di là della nostra capacità di comprensione59.
"II,4I,I.
350
Il castigo dell'amore di Dio che punisce i peccatori nella geenna sembra a Isacco così orribile, che la sola possibilità di trovarsi all'inferno, anche per poco, lo obbliga a ricordarsene incessantemente e a pregare di esserne liberato, lui e tutti quanti gli UOmllll.
In terzo luogo - probabilmente è il dato più importante - tutta la teologia di Isacco è direttamente basata su un'esperienza di unione mistica con l'amore di Dio. Un'esperienza simile esclude ogni possibilità di odio verso gli altri, al punto che colui che si trova sul gradino più elevato della pienezza spirituale ha conseguentemente più possibilità di trovare posto nel regno dei cieli. In sé e per sé, l'esperienza dell'unione con il Dio-amore è fonte di una felicità così grande che colui che prega, che consacra se stesso a una vita ascetica o sopporta la sofferenza e la sventura, non pensa minimamente a una ricompensa futura. Nel mezzo della sofferenza, della preghiera o di una difficile ascesi egli riceve la facoltà di unirsi senza intermediari a Dio. Il fine della preghiera, dell'ascesi e dei comandamenti non è di superare gli altri per ottenere un posto migliore nel regno futuro. Loro unico scopo è l'unione con Dio che si realizza fin da questa vita. L'incontro con Dio e l'esperienza mistica diretta dell'unione con l'amore di Dio sono l'unica giustificazione di tutto lo sforzo ascetico, delle sofferenze e della lotta spirituale. In definitiva, l'incontro con Dio è lo scopo ultimo di tutta la storia umana.
Quanto alla dottrina origenista dell'apocatastasi, si deve escludere un parallelo diretto con Isacco. Per Origene l'apocatastasi non è ancora la fine del mondo, ma solo una tappa transitoria prima dell'apparizione del mondo nuovo. Sotto l'influsso platonico, Origene insegnava che era esistito un altro mondo prima della creazione di quello attuale e che dopo la restaurazione dell'universo, quando questo mondo avrà termine, un nuovo mondo verrà creato da Dio, e dopo questo un altro ancora e così di seguito senza fine. La caduta dell'uomo lontano da Dio e la sua conversione a Dio si ripeterebbero continuamente, e Dio si in-
351

carnerebbe più di una, volta per prendere su di sé i peccati del mondo e riscattarli60 . E precisamente questo insegnamento, contrario al messaggio evangelico sul carattere unico del sacrificio redentore di Cristo, che fu condannato dal sinodo di Costantinopoli del 543, insieme ad altre opinioni erronee di Origene, come quella riguardante la preesistenza delle anime61 .
Le radici dell'insegnamento di Isacco sulla salvezza universale non sono riconducibili a Origene - anche se può darsi che una volta o l'altra egli ne abbia avuto tra le mani le opere - giacché I sacco non deve nulla a influenze platoniche o d'altro genere, estranee alla fede cristiana. Su questo punto il suo insegnamento sì fonda unicamente su quanto è dichiarato dal Nuovo Testamento circa un Dio "che vuole che tutti gli uomini siano salvati" (ITm 2,4). Essenzialmente non è altro che uno sviluppo del pensiero di san Paolo secondo il quale, dopo l'avvento finale di Dio Padre e l'abolizione di tutti i principati e le potenze, dopo la sconfitta dì tutti i nemici e l'annientamento della morte da parte del Cristo Salvatore, Dio sarà "tutto in tutti" (ICor 15,28). Per Isacco la salvezza universale è una diretta conseguenza dell'amore infinito di Dio per l'uomo, un amore che lo ha spinto a creare il mondo, a incarnarsi e a prendere su di sé i peccati degli uomini, al fine di salvarli e condurli nel suo regno che non avrà fine.
Può darsi che nel suo insegnamento teologico Isacco si sia spinto un po' oltre quanto è consentito dalla dottrina dogmatica tradizionale e abbia voluto spingere lo sguardo su territori ancora ignoti alla ragione umana. È anche possibile che fosse proprio l'insegnamento sui fini ultimi a far parte dei "tre punti" contro i quali Daniele Bar Tubanita rivolse i suoi scritti. Tuttavia Isacco non fu il solo a professare l'universalità della salvezza. Tra i suoi
6° Cf. Trattato sui principii III,5,3. 61 Ecco il passo-chiave in tal senso dell'editto di Giustiniano che sarà fatto proprio
dal sinodo di Costantinopoli: "Chi afferma la preesistenza delle anime e concorda con lui a proposito dell'apocatastasi ... ".
35 2
predecessori, oltre ai dottori della chiesa siriaca che abbiamo già menzionato, bisogna annoverare Gregorio di Nissa, che predicò la salvezza per tutti gli uomini e tutti i demoni, insegnamento mai condannato da nessun concilio, né ecumenico né locale62. La possibilità di una salvezza universale fu ammessa anche da Gregorio il Teologo (di Nazianzo), Massimo il Confessore e Giovanni Climaco63 , i quali partirono tutti dalla constatazione che nulla è impossibile a Dio e che, di conseguenza, egli può salvare il mondo intero. Peraltro, come sottolinea Massimo il Confessore, ogni uomo ha la facoltà di rifiutare la salvezza portata a compimento da Cristo. La salvezza non è obbligatoria per nessuno: non saranno salvati se non quelli che "desiderano seguire" Cristo64 • Parole, queste, che contengono una precisazione importante rispetto alle affermazioni di Isacco circa la salvezza di tutti gli uomini.
L'ottimismo escatologico di un Isacco, di un Gregorio di Nissa e dei padri della chiesa che abbiamo appena citato non dev' essere accolto come espressione dell'insegnamento dogmatico della chiesa. Esso tuttavia dà voce a una speranza condivisa da molti cristiani, cioè che ogni uomo, ad onta di ciò che sembra equo e giusto, riceverà, in virtù della misericordia del nostro Dio infinitamente buono, la possibilità di essere salvato.
62 Al contrario, il sesto concilio ecumenico lo cita tra i "padri santi e beati", e il settimo lo saluta come il "padre dei padri". Quanto al sinodo di Costantinopoli del 543 e al quinto concilio ecumenico (553), nei quali le dottrine di Origine furono condannate, è significativo che l'insegnamento di Gregorio sulla salvezza di tutti- per altro ben noto - non sia stato identificato con l' origenismo. I padri di quei concili conoscevano un modo eretico di concepire tale salvezza (l'apocatastasi di Origene em legata alla sua dottrina sulla preesistenza delle anime), ma anche un modo ortodosso, basato su rCor 15,24-28.
63 Cf. Gregorio di Nazianzo, Discm!i 30,6, dove egli ammette, per quanto riguarda il castigo dei peccatori, una "interpretazione più conforme all'amore di Dio per gli uomini" alludendo all'insegnamento di Gregorio di N issa circa la salvezza universale. Cf. anche Massimo il Confessore, Esegesi del Salmo 59; Mistagogia 7; Qaes6ones et dubia r3; Giovanni Climaco, Scala del pamdiso 26: "Benché non tutti possano essere esenti da passioni, non è tuttavia impossibile che tutti siano salvati e si riconcilino con Dio".
6' Massimo il Confessore, Quaestiones ad Thalassium 63.
353

CONCLUSIONE
Nel 1987 un giovane che aveva appena finito il servizio militare si presentò in un piccolo monastero ubicato nel centro di una città baltica, oggi capitale di uno stato indipendente. Ogni giorno vi si celebravano lunghi offici, si leggevano a tavola le vite dei santi, in una parola vi si poteva trovare tutto ciò che occorreva alla vita monastica, tranne una cosa: mancava un accompagnatore spirituale incaricato della formazione dei monaci e dei novizi. Egli allora cercò aiuto negli scritti dei santi padri e degli asceti della chiesa antica. Il novizio amava molto leggere gli scritti di !sacco il Siro e prendeva appunti durante la lettura. Decise di trascrivere sul muro della sua cella alcune sentenze che l'avevano particolarmente colpito, per averle sempre davanti agli occhi. Un po' per volta ne aggiunse delle altre. In capo a un anno i muri della sua cella erano coperti di citazioni di !sacco: erano diventate per lui come il pane quotidiano, senza il quale non avrebbe potuto sopravvivere nemmeno un giorno.
Questo non è che un esempio dell'attualità di !sacco il Siro per il monachesimo odierno. Senza esagerare, si può dire che il suo nome è noto a tutti i monaci della chiesa russa. Negli ambienti ortodossi i suoi scritti godono della stessa popolarità dalla Grecia ai Balcani, dall'America alla Gran Bretagna. È uno degli autori più letti sul Monte Athos, e i suoi scritti hanno avuto un ruolo importante nella rinascita del monachesimo copto.
Ma l'influenza di !sacco non si limita all'ambiente monastico. Chi scrive ha potuto incontrare molti laici ferventi che lo amano
355

profondamente e lo rileggono in continuazione. Gli è anche capitato di sentire dei cristiani (né monaci, né preti, né teologi) citarne passi a memoria. Evidentemente non solo quelli che hanno voltato le spalle al mondo ma anche quelli che vivono nel mondo trovano consolazione nelle sue parole, benché non siano tenuti a metterne in pratica i consigli.
Le parole di Isacco non hanno attraversato solo le frontiere del tempo: hanno anche varcato le barriere confessionali. A partire dal IX secolo egli era letto tanto dai bizantini e dai siro-ortodossi quanto dalla chiesa d'oriente, e ogni gruppo aveva una propria recensione dei suoi scritti. Nel xv secolo Isacco penetrò nell'universo cattolico, pur continuando a essere uno degli autori spirituali più popolari dell'ortodossia. Nella nostra epoca i suoi scritti suscitano l'interesse di cristiani appartenenti a chiese e tradizioni diverse che hanno tuttavia in comune la stessa fede in Gesù e la stessa ricerca spirituale. Mi ricordo di tre persone che vennero a trovarmi dopo una conferenza che avevo appena tenuto sulla preghiera in Isacco. Erano, uno dopo l'altro, un monaco cistercense, un laico protestante e un monaco buddista. Tutti e tre furono stupefatti dai punti di contatto tra la dottrina di Isacco e la loro tradizione di preghiera. Dopo di loro un francescano venne ad annunciarmi l'esistenza di una casa di riposo "Sant'Isacco di Ninive" in Nuova Zelanda, gestita insieme da cattolici e anglicani. ..
Il seo-reto del successo di Isacco nel mondo moderno è dovu-o to in primo luogo al fatto che egli non smette mai di parlare del-l' amore di Dio per gli uomini, un amore che non conosce limiti e ignora la vendetta per i peccati, un amore spinto fino al sacrificio che ha portato Gesù alla croce, che trionfa di tutto e davanti al quale né la morte né l'inferno resistono. Ricordarsi di un simile amore è necessario in ogni epoca della storia cristiana, giacché l'immagine di un Dio-amore appare spesso offuscata agli sguardi dei credenti, per fare spazio a quella di un Dio-giudice o carnefice, un Dio reputato "giusto" che ripaga ciascuno secondo
quello che ha meritato. E benché tutto l'evangelo affermi con chiarezza che la salvezza viene da un Dio misericordioso e non dagli sforzi degli uomini, che Dio salva i peccatori insieme ai o-iusti che vuole che tutti gli uomini siano salvati, nondimeno b '
c'è stata e persiste ancor oggi la tentazione di sostituire a una re-ligione d'amore una religione di schiavitù, ogni volta che l'osservanza dei comandamenti è considerata non come conseguenza diretta dell'amore dell'uomo per Dio, ma come inevitabile corollario della sua paura del castigo e della sua speranza in una ricompensa.
La parola di Isacco si rivolge a coloro che hanno paura di incontrare faccia a faccia l'amore di Dio. Questo incontro potrebbe essere doloroso per quanti non possiedono un "cuore misericordioso" per il loro prossimo, non sono liberi da gelosie e rivalità, si ritengono migliori degli altri. Chi è sinceramente persuaso di salvarsi mentre gli altri saranno perduti non può accogliere come si dovrebbe il discorso di Isacco sulla salvezza di tutti per l'universale misericordia di Dio. Chi spera di essere aiustificato nel giudizio finale mentre gli altri saranno condan~ati non può concepire l'idea che ha Isacco di un Dio "ingiusto", davanti al quale tutti i peccati dell'umanità, come una manciata di sabbia, saranno gettati nell'oceano del suo amore per esservi dissolti. Chi si preoccupa della quantità delle preahiere da dire invece che della loro qualità, è incapace di ap-o prezzare il suo insegnamento sulla "legge della libertà", che pre-ferisce il pensiero continuo di Dio e la stazione davanti alla croce alle interminabili preghiere vocali. Chi vive alla superficie della vita cristiana e non desidera spingersi fino alle profondità dove si realizza il misterioso incontro dell'uomo con Dio, non può accettare il pensiero di Isacco sul necessario distacco da assumere rispetto al mondo per acquisire l'amore di Dio e del pross1mo.
Abbiamo già detto che Isacco, pur conducendo una vita da eremita aveva una visione universale, capace di abbracciare le
'
357

sofferenze e i dolori del intero. È soprattutto a causa di questa visione che la sua opera, prodotta per una cerchia ristretta di solitari siriaci, è sopravvissuta alla sua epoca e si è diffusa ben oltre i confini della d'oriente, riuscendo a conquistarsi un uditorio universale.
Vorremmo concludere questo libro con le parole che chiudono il discorso di I sacco sull'escatologia, alla fine della seconda parte dei suoi scritti, e sono un invito alla conversione e alle opere buone. Benché le pene della geenna siano destinate a finire, scrive Isacco, esse sono spaventose e conviene prodigare tutte le proprie energie per sfuggirvi e avvicinarsi, fin da questa vita, alle porte del regno di Dio. vita non è stata donata all'uomo perché la sprecasse in occupazioni vane, ma perché diventasse degno di Dio. Allora i misteri di Dio si rivelano all'uomo ed egli ha il diritto di dire:
Sforziamoci di gustare di Dio pensando incessante-mente a lui, e di della geenna che deri-va dalla negligenza. Evitiamo di disperderci in ogni sorta di cose trascurando la nostra vita di raccoglimento, evitiamo le chiacchiere vane e segrete come pure le negligenze evidenti, per poter provare quella misericordia dentro di noi. Nessuno meglio del ricco può parlare della ricchezza, mentre nes-suno può parlare della libertà di chi la possiede ... La bellezza della verità si confà a labbra; dò che è santo si confà a un santo ... Il fuoco il fuoco, e un cuore fer-vente deve conservare la bellezza di Dio nella santità 1.
Ogni uomo è chiamato a diventare teologo nel senso più elevato della parola, cioè uno al quale sono rivelati i misteri di Dio e che ha ricevuto il diritto di parlare liberamente con lui. Ogni uomo è anche chiamato a diventare per offrire a
ogni istante un sacrificio a Dio sull'altare del suo cuore, per sé stesso, per il suo prossimo e per il mondo intero:
Adorna te stesso di buone azioni, o uomo debole! Affinché ti sia concesso di celebrare come sacerdote 2 davanti a Dio, nella casa dei misteri, per ricevere l'unzione della santità da te dello Spirito, grazie a un'abbondante purezza ti lisce per la liturgia delle tue membra esteriori e per quella nascosta nel segreto del tuo cuore. Disegna in te, esteriormente e interiormente, l'immagine della tenda che era stata in precedenza mostrata [a Mosè]. Riunisci nei tuoi sensi l' assemblea delle virtù e offri a Dio nel tuo cuore, come un sacerdote, un sacrificio puro. Offri un sacrificio di riconciliazione per i peccati di coloro che sono lontanP. E al posto del coperchio d'oro che stava sopra l'arca (cf. Es nel tuo cuore la contemplazione dei misteri del Salvatore: è così
Dio ti inizierà a mirabili rivelazioni4•
Oxford, Pasqua 1996
2 CL rPt 2,5-9. Secondo il Liber graduum 12,2, "il cuore celebra come un sacerdote interiore".
>Cioè "fuori del tempio": i non cristiani che stanno al di fuori della chiesa. 4 Il,41,2.
359

ABBREVIAZIONI E BIBLIOGRAFIA
Testi originali siriaci
Prima parte
PR = MAR IsAACUS NrNIVITA, De pe1/ectione religiosa, ed. P. Bedjan, Harrassowitz, Parisiis-Lipsiae r909.
Seconda parte
II= IsAAC OF NrNEVEH (IsAAC THE SYIUAN), "The Second Part", Chapters IV-XLI, ed. by S. Brock, Peeters, Lovanii I995 (CSCO 554).
Centurie di conoscenza= Ms. Teheran, Issayi 4 ( = II,3).
Versioni antiche delle opere di !sacco citate nel libro
Versione greca
Tou hosiou patròs hem6n Isaàk episk6pou Nineuì tou Syrou tà heurethénta asketikd, ed. N. Theotokes, Breitkopf, Lipsiae rno.
Versione araba
Traités religieux, philosophiques et moraux. Extraits des oeuvres d'Isaac de Ninive (VIF siècle) par Ibn as-Salt (IX" siècle), éd. par P. Sbath, Impr. Al-Chark, Le Caire I934·

Traduzioni in lingue moderne delle opere di !sacco citate nel libro
Prima parte
I The Ascetica! Homilies o/ Saint Isaac the Syrian, tr. by D. Miller, Holy Transfiguration Monastery, Boston 1984.
lsAcco DI NrNIVE, Discorsi ascetici, I. L'ebbrezza della fede, a cura di M. Gallo e P. Bettiolo, Città Nuova, Roma
Afystic Treatises by Isaac o/Nineveh, ed. by A. J. ''\1'-'lJ.blw .. ,,., Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam 1923.
PREPODOBNYJ lsAAK Sm.rN, O bozestvennich tajnach i o duchovnof Zizni, ed. Ilarion Alfeev, Zacat'evskij Monastyr', Moskva 1998.
Touraille = lsAAC LE SYRIEN, Oeuvres spirituelles. Les 86 discours ascé-tiques - Les lettres, tr. par]. Touraille, de Brouwer, Paris 1981.
Seconda parte
lsAAC OF NrNEVEH (lsAAC THE SYRIAN), Second Part", Chapters N-XLI, tr. by S. Brock, Peeters, Lovanii 1995 (CSCO 555).
lsAcco m NrNIVE, Discorsi spirituali. Capitoli sulla conoscenza. Preghiere. Contemplazione sull'argomento della gehenna. Altri opuscoli, a cura di P. Bettiolo, Qiqajon, Bose 1990.
"St. Isaac the Syrian: Two Unpublished Texts", ed. by S. Brock, in Sobomost I9,I (1997), pp. 7-33.
Antologie
The Heart of Compassion. Dai~y Readings with St. Isaac of Syria, ed. by A. M. Allchin and S. Brock, London 1989.
lsAcco DI NrNIVE, Un 'umile speranza, antologia a cura di S. Chi alà, Qiqajon, Bose I999·
St Isaac of Nineveh an Ascetica! Li/e, tr. by M. Hansbury, St Vladi-mir's Seminary Crestwood-New York 1989.
The \visdom o/ Saint Isaac the Syrian, tr. by S. Brock, SLG Press, Oxford I999·
Fonti di !sacco citate nel libro
ABBA Discorsi Les cinq recensions de l'Ascéticon syriaque d'Ab-ba Isai'e, éd. par R. Draguet, Secrétariat du esco, Louvain I968 (CSCO 293-294).
Aphraatis sapientis persae demonstrationes, Paris 1894-1907 (Patrologia syriaca
AMMONAS, Lettere Ammonii eremitae epistulae, ed. M. Kmosko, Firmin-Didot, Paris 1914 (Patrologia orientalis ro,6). Tr. fr. in Lettres des pères du désert. Ammonas, Macaire, Arsène, Sémpion de Thmuis, éd. par B. Outtier, A. L:mf, M. Van Parys et C. A Zirnheld, Abbaye de Bellefontaine, Bégrolles-en-Mauges 1985, pp. r-6o.
Apoftegmi padri= Apophthegmata patrum. Collectio alphabetica, PG 65,71-440. Tr. i t. Vita e detti dei padri del deserto, a cura di L. Mortari, Città Nuova, Roma 1996.
ATANASIO DI ALESSANDRIA, Vita di Antonio= Athanase d'Alexandrie, La vie de saim Antoine, éd. par G.]. M. Bartelink, SC 400, Cerf, Paris I994- Tr. it. Atanasio di Alessandria, Vita di Antonio. Antonio abate, Detti Lettere, a cura di L. Cremaschi, Paoline, Milano I995·
Lettera 2 (a Gregorio di N issa)= Ms. Londra, British 17192 (versione siriaca). Tr. it. in Basilio di Cesarea, Le lettere I, a cura di M. Forlin Patrucco, SEI, Torino 1983, pp.

CIRILLO DI ALESSANDRIA, Lettera 3 a Nestorio = Sancti Cyrilli epistolae tres oecumenicae, ed. P. E. Pusey, Oxford 1875, pp. 2-11. Tr. it. in Decisioni dei concili ecumenici, a cura di G. Alberigo, UTET, Torino 19]8, pp. 133-140.
Decisioni dei concili ecumenici, a cura di G. Alberigo, UTET, Torino 1978.
DIODORO DI T ARSO, Sulla provvidenza (opera perduta).
EFREM IL ?I~o,_Jnni sul digiuno= Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de zezunzo, hrsg. von E. Bee~, Secrétariat du CSCO, Louvain 1964 (CSCO 246-247). Tr. fr. Ephrem le Syrien, Hymnes sur le jeune, éd. par D. Cerbelaud, Abbaye de Bellefontaine, Bégrollesen-Mauges 1997.
-,Inni sull'Epifania= Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Nativitate (Epiphania), hrsg. von E. Beck, Secrétariat du CSCO Louvatn 1959 (CSCO 186-187). Tr. fr. Éphrem le Syrien Hym~es sur l:Epiphanie. Hymnes baptismales de l'Orient syrien, éd: par F. Cassmgena, Abbaye de Bellefontaine, Bégrolles-en-Mauges 1997.
- Inni sulla fede = Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de fide, hrsg. von E. Beck, Impr. Orientaliste L. Durbeck, Louvain 1955 (CSCO 154-155).
- Inni sulla Natività = Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Nativi~ate (Epiphania), hrsg. von E. Beç:k, Secrétariat du CSCO, Louvam 1959 (CSCO 186-187). Tr. fr. Ephrem de Nisibe, Hymnes sur la Nativité, éd. par F. Griffin et F. Cassinaena SC 459 Cerf Paris 2001. " ' ' '
-, Lettera a Publio sulla geenna= S. Brock, "Ephrem's Letter to Publius", in Le Muséon 89 (1976), pp. 261-305.
EvAGRIO PoNT!CO, Capitoli gnostici= Les six centuries des "Kephalaia gnostica" d'Evagre le Pontique, éd. parA. Guillaumont, Firmin-Didot, Paris 1958 (Patrologia orientalis 28,1).
- Lo .gnostico= Évagre le Pontique, Le gnostique, éd. par A. et C. Guillaumont, SC 356, Cerf, Paris 1989. Tr. it. in Evagrio Pontico,
Per conoscere Lui, a cura di P. Bertiolo, Qiqajon, Base 1996, pp. 241·263.
-, Pseudo-supplementi ai Capitoli gnostici= W. Frankenberg, Euag1izts Ponticus, \X!eidmannsche Buchhancllung, Berlin 1912, pp. 422-471.
-, Scolii sull'Ecclesiaste= Évagre le Pontique, Scholies à l'Ecclésiaste, éd. par P. Géhin, SC 397, Cerf, Paris 1993.
-, Skemmata =J. Muyldermans, Evagriana, P. Geuthner, Paris 19_31, pp. 38·44·
-, Sulla preghiera= S. Nili abbatis de oratione tractatus, PG 79, 1165-1200. Tr. it. Evagrio Pontico, La preghiera, a cura di V. Messana, Città Nuova, Roma 1994.
Everghetin6s = Everghetin6s, étoi synagoghè tòn thcophth6ngon rhemdton kaì didaskaliòn tòn theoph6ron kaì hagbion patéron ... , ed. M. Langhen, Mone Metamorphoseos tou Soteros (Kouvara, Attikes), Athenai 1976-1978 6.
GIOVANNI CuMAco, Scala del paradiso= Iohannis Climaci scala paradisi, PG 88,632-II64. Tr. it. Giovanni Climaco, La scala del paradiso, a cura di C. Riggi, Città Nuova, Roma 1989.
GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelie su Matteo = Sancti Ioannis Chrysostomi archiepiscopi constantinopolitani homiliae in Matthaeum, ed. F. Field, Cantabrigiae 1839. Tr. it. San Giovanni Crisostomo, Commento al Vangelo di san Matteo, a cura di R. Minuti e F. Monti, Città Nuova, Roma 1966-1967.
GIOVANNI DI APAMEA, Lettere= Brie/e von Johannes dem Einsiedler, hrsg. von L. G. Rignell, Hakan Ohlssons, Lund 1941.
GREGORIO DI NAZIANZO, Discorsi= Grégoire de Nazianze, Discours, éd. par J. Bernardi, SC 247, 250, 270, 284, 309, 318, 358, 384, 405, Cerf, Paris 1978-. Tr. it. Gregorio di Nazianzo, Tutte le orazioni, a cura di C. Moreschini, Bompiani, Milano 2000.
GREGORIO DI NISSA, Inte1pretazione delle Beatitudini= Gregorii Nysseni orationes VIII de beatitudinibus, PG 44,1193-1302.

GREGORIO IL SINAITA, La quiete e i due modi della preghiera= Gregorii Sinaitae de quietudine et duobus orationis modis, PG 150,1313-1330. Tr. i t. in La filocalia III, a cura di Nicodimo Aghiorita e Macario di Corinto, tr. a cura di M. B. Artioli e M. F. Lovato, Gribaudi, Torino 1985, pp. 584-596.
IsHo'DENAH DI BAsRA, Liber castitatis =Le livre de la chasteté composé par Jésusdenah, éveque de Baçrah, éd. par J.-B. Chabot, s.l. 1896.
LEONE MAGNO, Tomo a Flaviano= Sancti Leonis Magni tomus ad Flavianum episcopum constantinopolitanum, ed. C. Silva-Tarouca, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1932. Tr. it. in Decisioni dei concili ecumenici, pp. 151-161.
Li ber graduum = Liber graduum e codicibus syriacis Parisiis, Londini, Romae, Hiemsolymis alibique asservatis, ed. M. Kmosko, Firmin-Didot, Paris 1926 (Patrologia syriaca 3).
MARCO L'EREMITA, A pmposito di quelli che credono di essere giustificati per le opere= Mare le Moine, Traités I, éd. par G.-M. de Durand, se 445, Cerf, Paris 1999, pp. 130-20!. Tr. it. in La/ilocalia I, a cura di Nicodimo Aghiorita e Macario di Corinto, tr. a cura di M. B. Artioli e M. F. Lovato, Gribaudi, Torino 1982, pp. 188-211.
MASSIMO IL CONFESSORE, Esegesi del Salmo 59= Expositio in Psalmum LIX, PG 90,856-872. Tr. it. in S. Massimo Confessore, La mistagogia ed altri scritti, a cura di R. Cantarella, Ediz. "Testi cristiani", Firenze 1931, pp. 1-25.
-, Mistagogia = Mystagogia, PG 91,657-717. Tr. i t. in S. Massimo Confessore, La mistagogia ed altri scritti, pp. 119-215.
-, Quaestiones ad Thalassium, PG 90,244-785. Tr. fr. Saint Maxime le Confe~seur, Questions à Thalassios, éd. par J.-C. Larchet et E. Ponsoye, Ed. de l'Ancre, Suresnes 1992.
- Quaestiones et dubia, PG 90,785-856. Tr. fr. Maxime le Confesseur, Questions et difficultés (Quaestiones et dubia), éd. par J.-C. Larchet et E. Ponsoye, Cerf, Paris 1999·
NESTORIO, Libro di Eraclide= Nestorius, Le livre d'Héraclide de Damas, éd. par F. Nau, P. Bedjan et M. Brière, Letouzey et Ané, Paris 1910.
0RIGENE, Sulla preghiera= Origenes Werke, II. Buch V- VIII gegen Celsos. Die Schri/t vom Gebet, hrsg. von P. Koetschau, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig 1899. Tr. it. Origene, La preghiera, a cura di N. Antoniano, Città Nuova, Roma 1997.
-, Trattato sui principii = Origène, Traité des principes, éd. par H. Crouzel et M. Simonetti, SC 252-253, 268-269, 312, Cerf, Paris 1978-1984.
PALLADIO, Storia fausiaca = Palladio, La storia lausiaca, testo critico di G. J. M. Bartelink, tr. di M. Barchiesi, Fondazione Lorenzo Valla-Mondadori, Milano 1974.
PsEUDO-DIONIGI L'AREOPAGITA, I nomi divini= Pseudo-Dionysius, Corpus Dionysiacum, I. De divinis nominibus, hrsg. von B. R. Suchla, De Gruyter, Berlin 1990. Tr. it. in Dionigi Areopagita, Tutte le opere, a cura di E. Bellini e P. Scazzoso, Rusconi, Milano 1981, pp. 243-397·
-, Sulla gerarchia celeste= Pseudo-Dionysius, Corpus Dionysiacum, II. De coelesti hierarchia, De ecclesiastica hierarchia, De mystica theologia, Epistufae, hrsg. von G. Heil und A. M. Ritter, De Gruyter, Berlin 1991. Tr. it. in Dionigi Areopagita, Tutte le opere, pp. 69-135.
-, Teologia mistica= Pseudo-Dionysius, Corpus Dionysiacum II. Tr. it. in Dionigi Areopagita, Tutte le opere, pp. 399-414.
PsEuno-GREGORIO DI NISSA, Elogio di E/rem il Siro= Sancti Gregorii Nysseni vita atque encomium sancti patris nostri Ephraem Syri, PG 46,819-850.
PsEUDO-MACARIO, Omelie= Die 50 geistlichen Homilien des Makarios, hrsg. von H. Déirries, E. Klostermann und M. Kroeger, De Gruyter, Berlin 1964. Tr. it. Pseudo-Macario, Spirito e fuoco. Omelie spirituali (Collezione Il), a cura di L. Cremaschi, Qiqajon, Bo se 1995·

RuFINO, Storia dei monaci= Rufinus, Historia monachorum, ed. E. Schulz-Fliigel, De Gruyter, Berlin-New York 1990. Tr. it. Rufina di Concordia, Storia di monaci, a cura di G. Trettel, Città Nuova, Roma 1991.
Segno di unità. Le più antiche eucaristie delle chiese, a cura dei monaci e delle monache di Base, sotto la direzione di E. Mazza, Qiqajon, Base 1996.
SrMEONE IL Nuovo TEOLOGO, Catechesi= Syméon le Nouveau Théologien, Catéchèses, éd. par B. Krivocheine et ]. Paramelle, SC 96, ro4, 113, Cerf, Paris 1963-1965. Tr. it. Simeone il Nuovo Teologo, Catechesi, a cura di U. Neri, Città Nuova, Roma 1995.
SIMONE DI TAIBUTEI-I, Libro della grazia= Ms. Vaticano sir. 562, ff. r6U-2IOV.
TEODORO DI MoPSUESTIA, Framrnenti sul libro della Genesi= Theodori Mopsuestenifragmenta in Genesim, PG 66,633-646.
-, Ornelie catechetiche = Les Homélies catéchétiques de Théodore de Mopsueste, éd. R. Tonneau et R. Devreesse, Città del Vaticano 1949 (Studi e testi 145).
Vita di Maria Egiziaca = Vi~a Mariae Aegyptiae, PG 87,3697-3726. Tr. fr. Vie de sainte Marie l'Egyptiemze, éd. par N. Molinier, Monastère Saint-Antoine-le-Grand, Saint-Laurent-en-Royans 1995.
Vita di san Gerasimo del Giordano= K. M. Koikylides, Hai parà tòn Iorddnen Laurai Koldmonos kaì hagbiou Gherasfmou ... , Typ. tou Hierou Koinou tou Panaghiou Taphou, Hierosolymoi 1902. Tr. it. Nel deserto accanto ai fratelli. Vite di Gerasimo e di Giorgio di Choziba, a cura di L. Campagnano Di Segni, Qiqajon, Base 1991.
Studi generali sulla spiritualità orientale e siriaca
ABouZAYD, S., Ihidayutha. A Study o/ the Li/e o/ Singleness in the Syrian Orient /rom Ignatius o/ Antioch to Chalcedon, 45 r AD, ARAM Society far Syro-Mesopotamian Studies, Oxford 1993.
AssEMANI, G. S., Bibliotheca orientalis, III, I. De scriptoribus syris nestorianis, Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, Romae 1]28.
ATIYA, A. S., A History o/ Eastem Christianity, Methuen, London 1968.
ATTWATER, D., The Christian Churches o/ the East, The Bruce Publishing Co., Milwaukee 1961.
BAUMSTARK, A., Geschichte der syrischen Literatur, A. Marcus & E. Webers, Bonn 1922.
BEGGIANI, S. ]., Early Syriac Theology with Special References to the Maronite Tradition, University Press of America, Lanham 1983.
-, Introduction to Eastem Christian Spirituality. The Syriac Tradition, University of Scranton Press-Associated University Presses, Londonr991.
BEULAY, R., L'enseignement spirituel de Jean de Dalyatha, mystique syro-oriental du vrre siècle, Beauchesne, Paris 1990.
-, La lumière sans /o~me. Introduction à l'étude de la mystique chrétienne syro-orientale, Editions de Chevetogne, Chevetogne 1987.
BROCK, S., "Clothing Metaphors as a Means of Theological Expression in Syriac Tradition", in Typus, Symbol, Allegorie bei den ostlichen Vatem und ihren Parallelen im Mittelalter, hrsg. von M. Schmidt, Pustet, Regensburg 1982, pp. u-38.
-, "Iconoclasm and the Monophysites", in Iconoclasm. Papers Given at the Ninth Spring Symposium o/ Byzantine Studies, University of Birmingham, Birmingham 1977, pp. 53-58.
-, Tbe Luminous Eye. The Spiritual World Vision o/ St. Ephrem, Cistercian Publications, Kalamazoo r 992.
-, "'Maggnanuta'. A Technical Ter!Jl in East Syrian Spirituality", in M.élanges Antoine Guillaumont, Ed. P. Cramer, Genève 1988, pp. 121-129.

-, "The 'Nestorian' Church. A Lamentable Misnomer", in Bulletin o/ the fohn Ryland's Library 78 (I996 [I997]), pp. 53-66.
-, "The Prayer of the Heart in Syriac Tradition", in Sobomost 4,2 (I982), pp. I3 I-142.
-, Spirituality in the Syriac Tradition, SEERI, Kottayam I989.
-, "The Spirituality of the Heart in Syrian Tradition", in The Hmp I,2-3 (I988), pp. 93-I I5.
-, Studies in Syriac Christianity. History, Literature and Theology, Variorum, London I992.
-, "The Syriac Background", in Archbishop Theodore. Commemorative Studies an His Li/e and In/luence, ed. by M. Lapidge, Cambridge University Press, New York-Cambridge I995, pp. 30-53.
-, The Syriac Fathers an Prayer and the Spiritual Li/e, Cistercian Publications, Kalamazoo I987.
-, Syriac Perspectives an Late Antiquity, Variorum, London I984.
-, "The Syriac Tradition", in The Study of Spirituality, ed. by C. Jones, G. Wainwright and E. Yarnold, SPCK, London I986, pp. I99-2I5.
CANIVET, P., "Théodoret et le monachisme syrien avaqt le concile de Chalcédoine", in Théologie de la vie monastique. Etudes sur la tradition patristique, Aubier, Paris I96I, pp. 24I-282.
CHABOT, J-B., La littérature syriaque, Librairie Blouf et Gay, Paris
I934·
CHEDIATH, G., The Christology of Mar Babai the Great, Pontificia Università Lateranense, Roma I982.
DAUVILLIER, J., "Quelques témoignages littéraires et archéolog,iques sur la présence et sur le culte des images dans l' ancienne Eglise chaldéenne", in L'Orient syrien I ,3 (I956), pp. 297-304.
370
DELLY, E., "Le culte des saintes images dans l'Église syrienne-orientale", in L'Orient syrien I,3 (I956), pp. 29I-296.
DuvAL, R., Ancienneslittératures chrétiennes, II. La littérature syriaque, Librairie Vietar Lecoffre, Paris I907.
FILARETE m MoscA, Zizneopisanija oteeestvennych podvii.nikov blagocestija xvm-XIXVV., Sentjabr', Moskva I909.
FLOROVSKIJ, G., '"Cur Deus Homo?'. The Motive of the Incarnadon", in The Collected Works of Georges Florovsky III, Nordland, Belmont I976, pp. I63-qo; 3Io-3I4.
-, Vizantijskie otcy v-vmvekov, YMCA Press, Paris I933·
GRIFFITH, S. H., "Asceticism in the Church of Syria. The Hermeneutics of Early Syrian Monasticism", in Asceticism, ed. by V. L. Wimbush and R. Valantasis, Oxford University Press, Oxford-New York I995, pp. 220-245.
-, "Monks, 'Singles' and the 'Sons of the Covenant'. Reflections on Syriac Ascetic Terminology", in Eulogema. Studies in Honor of Robert Taft s.j., Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, Roma I993, pp. I4I-I6o.
GUILLAUMONT, A., "Le dépaysement camme forme d'ascèse dans le monachisme ancien", in Id., Aux origines du monachisme chrétien, Abbaye de Bellefontaine, Bégrolles-en-Mauges I979·
-, Études sur la spiritualité de l'Orient chrétien, Abbaye de Bellefontaine, Bégrolles-en-Mauges I966.
HALLEUX, A. DE, "Nestorius. Histoire et doctrine", in Irénikon 66 (I993), pp. 38-5I; I63-q8.
KIREEVSKIJ, I., Polnoe sobranie soCinenij II, Tip. imp. Mosk. Univers., Moskva I9I I.
LEWY, H., Sobria ebrietas. Untersuchungen zur Geschichte der antiken Mystik, Topelmann, Giessen I929.
37I

LossKY, V., Essai sur la théologie mystique de l'église d'Orient, Aubier, Paris 1944.
MEYENDORFF, ]., Christ in Eastern Christian Thought, St Vladimir's Seminary Press, Crestwood 1975 2
• Tr. it. Cristologia ortodossa, AvE, Roma 1974.
-, Imperia! Unity and Christian Divìsiom. The Church, 45o-68o AD, St Vladimir's Seminary Crestwood 1989.
MINGANA, A., Woodbroke Studies, VII. Eady Christian Mystics, W. Effer and Sons, Cambridge 1934.
MuNDELL, M., "Monophysite Decoration", iniconoclasm. Pa-pers Given at the Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies, University of Birmingham, Birmingham 1977, pp. 59-74.
MuRRAY, R., Symbols of Church and Kingdom. A Study on Early Syriac Tradition, Cambridge University Press, London 1975.
NEDUNGATT, G., Covenanters of the Early Syrian-speaking Church", in Orientalìa christiana periodica 39 (1973), pp. 191-215; 419-444·
0RTIZ DE URBINA, I., Patrologia syriaca, Pro, Roma 1965.
STEWART, C., Working of the Heart. The Messalian Contro-versy in History, Texts and Languages to AD 4JI, Clarendon Press, Oxford 1991.
Studia syriaca I, ed. I. Rahmani, Seminarium Scharfense, Monte no 1904.
VèioBus, A., History of Asceticism in the Syrian Orient, Peeters, Lovanii 1959-1988 (CSCO r84, 197, 500).
-, Hist01y of the Scbool of Nisibis, Peeters, Lovanii 1965 (CSCO 266).
WRIGHT, W., A Short History of Sy1iac Literature, C. Black, London r894.
372
Studi su !sacco
BETTIOLO, P., "Avec la charité camme but. Dieu et création dans la méditation d'Isaac de Ninive", in Irénikon 63 (1990), pp. 323-345.
BROCK, S., "Isaac of Nineveh. Some Newly Discovered Works", in Sobornost 8,1 (1986), pp.
-, "Lost and Found. Part II of Works of St Isaac of Nineveh", in Studia patristica r8,4 (1990), pp. 230-233.
-, "Some Uses of the Term in the Writings of Isaac of Nine-veh", in Parole de l'Orient 20 (1995), pp. 407-419.
-, "St lsaac of Nineveh", in
-, "St Isaac of Nineveh", in
Assyrian 3,6 (1986), pp. 8-9.
Ulay (January r98r), pp. 68-74.
BuNGE, G., "Mar Isaac of Nineveh and His Relevance Nowadays", in Christian Orient 7,4 (1986), pp. 193-195.
-, "Mar Isaak von Ninive sein 'Buch der Gnade"', in Ostkirchli-che Studien 34 (r985), pp. 3-22.
CHABOT, ].-B., De S. Isaaci Nìnivitae vita, scriptis et doctrina, ex. Lefever F. et S., Parisiis-Lovanii r 89 2.
CHIAL.:l.., S., Dall'ascesi eremitica alla miseric01dia infinita. Ricerche su !sacco di Ninive e la sua fortuna, Leo S. Olschki, Firenze 2002.
HAUSHERR, I., "Un précurseur de la théologie scotiste sur la fin de l'Incarnation", in Recherc)Jes de scieuces religieuses 22 (1932), pp. 316-320, ripreso in Id., Etudes de spiritualité orie1ztale, Pro, Roma !969, pp. 1·5·
KHALIFÉ-HACHEM, "L'àme et les passions cles hommes d'après un texte d'Isaac de Ninive", in Parole de l'Orie11t r 2 (1984-1985), pp. 201-2!8.
-, s. v. "Isaac Ninive", in Dictionnaire de spiritualité VII, u~;;"u'.ll"~-ne, Paris 1971, 2041-2054·
373

-, "La prière pure et la prière spiri tue ile selon Isaac de Ninive", in Mémorial Mgr Gabriel Khouri-Sarkis, Impr. Orientaliste, Louvain I969, pp. I57-IJ3.
LrcHER, D. A., "Tears and Contemplation in Isaac of Nineveh", in Diakonia II (I976), pp. 239-258.
MAserA, P. T., "The Gift of Tears in Isaac of Nineveh", in Diakonia I4 (I979), pp. 255-265.
PoPoVIé, J., "He gnoseologhia toù haghiou Isaàk toù Syrou", in Theologhia 38 (I967), pp. 206-225; 386-407.
TsiRPANLIS, C. N., "Praxis and Theoria. The Heart, Lave and Light Mysticism in Saint Isaac the Syrian", in The Patristic and Byzantine Review 6 (I987), pp. 93-I20.
V66Bus, A., "Eine neue Schrift von Ishaq von Ninive", in Ostkirchliche Studien 2I (I9J2), pp. 309-3I2.
WARE, K., "The Meaning of 'Pathos' in Abba Isaias and Theodoret of Cyrus", inStudiapatristica 20 (I989), pp. 3I5-322.
374
INDICE
5 PREFAZIONE
I I Introduzione. I SACCO DI NINIVE, AUTORE SPIRITUALE DELLA CHIESA D'ORIENTE
I 2 La chiesa d'oriente al tempo di Isacco I7 La cristologia della chiesa d'oriente 23 Vita di !sacco di Ninive 28 Gli scritti di !sacco 33 Le fonti della teologia di !sacco
37 I. DIO, L'UNIVERSO E GLI UOMINI 3 7 L'amore di Dio si rivela attraverso il mondo creato 48 Struttura del mondo creato 56 L'incarnazione
I07 I08 II9
I3I
I32 I37 I44
I5I
I5I
I 57
II. LA VIA DEL SOLITARIO Solitudine e rinuncia al mondo Amore di Dio e amore del prossimo Quiete e silenzio Un cammino monastico verso Dio
III. LE PROVE SULLA VIA CHE CONDUCE A DIO Le tentazioni L'esperienza della derelizione (abbandono di Dio)
IV. L'UMILTÀ L'umiltà, mezzo per assomigliare a Dio L'umiltà interiore I segni esteriori dell'umiltà
V. LE LACRIME Il pentimento Lacrime amare e lacrime dolci
375

r69 VI. UNA SCUOLA DI PREGHIERA qo La preghiera Iì9 Gli aspetti esteriori della ~-'"'-/'\""""" I94 La preghiera di fronte alla croce 207 La lectio divina 2r9 La preghiera notturna 229 La "legge della schiavitù" e la della libertà" 238 La preghiera per il mondo intero 247 La meditazione su Dio e la preghJera
259 VII. LA VITA IN DIO 260 La "preghiera spirituale" e la della mente" 266 La contemplazione 2 7 3 Visioni, rivelazioni, intuizioni 280 L"' accoglimento sotto l'ombra" e l'illuminazione 287 Lo stupore 296 L'"ebbrezza" d'amore per Dio 305 Fede e sapere
32 r VIII. LA VITA DEL SECOLO A VENIRE 322 Meditazione sul mondo a venire 326 La vita dopo la morte 33 7 Punizione eterna o salvezza universale? 345 L'amore di Dio si rivela nel destino ultimo del mondo
355 CONCLUSIONE
36r ABBREVIAZIONI E BIBLIOGRAFIA

Finito di stampare nel mese di maggio 2003
M.S./Litografia, Torino
EDIZIONI QIQAJON- COMUNITÀ DI BOSE 13887 MAGNANO (BI)
TEL. 015.679.264 - FA..'C 015.679.290 e-mail: [email protected]
VOLUMI PUBBLICATI (2003)
COMMENTI BIBLICI
E. BIANCHI, L'Apocalisse di Giovanni
E. BIANCHI, L. MANICARDI, La carità nella chiesa
E. BIANCHI, Magnificat, Benedictus, Nunc dimittis
A. MELLO, Geremia
INDICE CONCETTUALE DEL MEDIO GIUDAISMO
r. Famiglia z. Sessualità
SPIRITUALITÀ BIBLICA
G. ALBERIGO, E. BIANCHI, C. M. CARD.
MARTINI E AA.Vv., La pace: dono e pmfezia
E. BIANCHI, Adamo, dove sei? Commento esegetico-spirituale a GenI-II
E. BIANCHI, B. CALATI, F. CoccHINI,
L lLLICH E AA.Vv., La lectio divina nella vita religiosa
E. BIANCHI, V. Fusco, B. STANDAERT E
AA.Vv., La Parola edifica la comunità
G. BRUNI, Mi chiameranno beata
J. CoRBoN, La gioia del Padre. Omelie per l'anno liturgico dal vangelo secondo Luca
V. Fusco, La casa sulla roccia. Temi spirituali di Matteo
GRUPPO m DoMBES, Maria, nel disegno di Dio e nella comunione dei santi
A. MELLO, L'arpa a dieci corde. Introduzione al Salterio
A. MELLo, Evangelo secondo Matteo. Commento midrashico e nan-ativo
A. MELLO, La passione dei profeti
M. M. MoRFINO, Leggere la Bibbia con la vita
F. Rossi DE GASPERIS, Maria di Nazaret. Icona di Israele e della Chiesa
SPIRITUALITÀ EBRAICA
A.-C. AVRIL, P. LENHARDT, La lettura ebrai-ca della Scrittura
M. BusER, Il cammino dell'uomo
A. CHOURAQUI, Gesù e Paolo. Figli d'Israele
Commenti rabbinici allo Shema' Jisra'el
P. DE BENEDETTI, Ciò che tarda avven·à
Detti di rabbini. Pirqè Avot
J. ELICHAJ, Ebrei e cristiani. Dal pregiudizio al dialogo
R. F ABRIS, Uno nella mia mano. Israele e Chiesa in cammino verso l'unità
R. GIRARD, La pietra scartata. Antigiudaismo cristiano e antropologia evangelica
J. HEINEMANN, La pregbiera ebraica
A.]. HESCHEL, Il canto della libertà
A.J. HESCHEL, La discesa della Shekinah
A.J. HESCHEL, L'uomo alla ricerca di Dio A. KACYZNE, Le perle malate
RABBI]ISHMA'EL, Il cantico presso il mare
RASHI DI TROYES, Commento al Cantico dei cantici
Un mondo di grazia. Midrash Tehillim. Letture dal midrash sui Salmi
PADRI ORIENTALI
ANTONIO IL GRANDE, Secondo il vangelo. Le venti lettere tradotte dall'arabo
Parole dal deserto. Detti inediti di Iperechio, Stefano di Tebe e Zosima

Detti inediti dei padri del deserto
Paconlio e i suoi discepoli: regole e sCiitti
BASILIO DI CESAREA, Le regole
Umiltà e misericordia. Virtù di san Macmio
EvAGRIO PoNTICO, Per conoscere Lui
PsEUDO-MACARIO, Spirito e fuoco. Omelie spirituali
Nelfa tradizione basiliana. Costituzioni ascetiche. Ammonizione a 1111 figlio spirituale
B. WARD, Donne del deserto
Cercare Dio nel deserto. Vita di Caritone
Nel deserto accanto ai fratelli. Vite di Gerasi m o e di Giorgio di Choziba
IsAcco DI NrNIVE, Discorsi spirituali e altri opuscoli
NICOLA DELLA SANTA MONTAGNA, Alle Oligini dell'Athos. Vita di Pietm l'Athonita
NERSES DI LAMBRON, If primato della carità. Discorso sinodale
GREGORIO PALAMAS, "AbbassÒ i cieli e discese". Omelie
I PADRI ESICASTI, L'amore della quiete. L'esicasnlo bizantino tm il XIII e il xv secolo
PADRI OCCIDENTALI
GIOVANNI CASSIANO, Abba, cos'è la pre-ghiera? Conferenze sulla preghiera
CESARIO D'ARLES, Predicare la Parola
GREGORIO MAGNO, Crescere nella fede
ATTONE DI VERCELLI, Omelie
BRUNO DI QuERFURT, Storia di cinque compagni
STEFANO DI MuH.ET, L'evangelo e nient'altro
I PADRI CISTERCENSI, Una medesima carità. Gli inizi cistercensi
I pADRI CERTOSINI, Una parola dalsilwzio. Fonti certosine, L Le lettere
PADRI CERTOSINI, Fratelli nel deserto. Fonti certosine, IL Testi nonnativi, testimonianze documentarie e lettermie
PADRI MONASTICI DEL XII SECOLO, [a sapienza del cuore
PADRI OLIVETANI, Per una rinnovata fedeltà. Fonti olivetane: i pizì importanti documenti, le più antiche cronache e le più rilevanti testimonianze letterarie
GuGLIELMO DI SAINT- THIERRY, Contemplazione
GUGLIELMO DI SAINT-THIERRY, Natura e grandezza dell'amore
GUGLIELMO DI SAINT-THIERRY, Dalla meditazione alla preghiera
GUGLIEUvlO DI SAINT-THIERRY, Commento al Cantica dei cantici
GUGLIELMO DI SAINT-THIERRY, Lettera d'ara
GUERRrco D'IGNY, Sermoni
BALDOVINO DI FORD, Perfetti nell'amare
GurGO II CERTOSINO, Tomerò al mio cuore
Regale monastiche d'accidente. Da Agosti-na a Francesca d'Assisi
SPIRITUALITÀ ORIENTALE
P. DESEILLE, Il vangelo 11el deserta. Un itinerario di spiritualità
N. DEVILLIERS, Alrtania e la latta spirituale
P. DESEILLE, E. BrANCHI, Pacamia e la vita comunitaria
L. REGNAULT, Ascoltare oggi i padri del deserta
E. BrANCHI, TH. MERTON E AA.Vv., Abba, dimmi u11a parola!
D. BuRTON-CHRISTIE, La parola nel deserta. Scrittura e ricerca della santità
G. GouLD, La comunità. I rapporti /ratemi nel deserta
Fuoco ardente. Guida spirituale
P. MrQUEL, Lessico del deserta. Le parole della spùitualità
S. BROCK, M. CORTESI, A. DE VOGUÉ,
].-R. PoucHET E AA.Vv., Basilia tra oriente e accidente
G. BUNGE, Akedia. Il male oscuro
G. BUNGE, La paternità spirituale. Nel pensiero di Evagria
G. BuNGE, Vasi di argilla. La prassi della preghiera personale
G. BUNGE, Vi11o dei draghi e pane degli angeli. Dall'ira alla mitezza
I. fuFEEV, La forza dell'amare. L'universo spirituale di [sacco il Siro
I. HAUSHERR, Philautfa. Dall'amore di sé alla carità
IGNAZIO E TEODOSIO DI MANJAVA, Sottomessi all'euangelo. Vita di Iou di Man;aua, Testamento di Teodosio. Regola dello skytyk
PAISIJ VELrCKOVSK!J, Autobiografia di ur1o starec
S. SALVESTRONI, Dostoeuskii e la Bibbia
P. EvDOKIMOV, Serafim di Sarot•, uomo dello Spirito
N. ARSENIEV, V. LossKY, Padri nello Spirito. La paternità spirituale in Russia
]. B. DUNLOP, Amt•rosii di Optirw
P. A. FLORENSKIJ, Il sale della ten·a. Vita dello starec Isidom
L fuFEEV, La gloria del Nome. L'opera dello schimonaco I!arion e la controuersia athonita sul Nome di Dio all'inizio del xx secolo
SILVANO DELL'ATHOS, Non disperare! Scritti inediti e vita
N. KAUCHTSCHISCHWILI, Mat' Mariia. If cammino di una monaca. Vita e scritti
L BALAN, Volti e parole dei padri del deserto romeno
A. ScRIMA, Il padre spirituale
MATTA EL MESKIN, L'esperienza di Dio nella preghiera
MATTA EL MESKIN, Comunione nell'amore
MATTA EL MESKIN, Il cristiano: nuova creatura
V. LosSKY, Conoscere Dio
G. FLOROVSKIJ, Cristo, lo Spirito, la chiesa
M. LOT-BORODINE, Perché l'uomo diuenti Dio
S. S. AvERINCEV, S. S. CHORUZIJ, O. A. SEDAKOVA E AA.Vv., L'accidente visto dall'arimte
I. ZrZIOULAS, Il creata come eucaristia
L ZrziOULAS, Eucaristia e regna di Dia
O. CLÉl\·lENT, Occhio di fuoco. Ems e kosmas
K. \'7ARE, Dire Dio oggi. Il cammina del cristiano
K. W ARE, Riconoscete Cristo in vai?
G. KHOD!è', Nella nudità di C1isto
AA.Vv., Lo Spirito e la chiesa
AA.Vv., Giovarmi Climaca e il Sin ai
AA.Vv., Amare del bella. Studi sulla Fila-calia
AA.Vv., Nicodema l'Aghiorita e la Filacalia
AA.Vv., San Sergio e il sua tempo
AA.Vv., N il Sarskii e l'esicasmo
AA.Vv., Paisii, la starec
AA.Vv., San Serafim: da Sarov a Diveeva
AA.Vv., Siluano dell'Athos
AA.Vv., La grande vigilia
AA.Vv., L'autunno della Santa Russia
AA.Vv., La notte della chiesa russa
AA.Vv., Fanne della santità russa
AA.Vv., Vie del monachesima russa
SPIRITUALITÀ OCCIDENTALE
E. BrANCHI, Il mantello di Elia. Itinerario spirituale per la vita religiosa
E. BrANCHI, Non siamo migliori. La vita religiosa uelfa cbiesa, tra gli uomini
PrccOLA SORELLA ANNIE DI GEsÙ, Charles de Faucauld
A. CHATELARD, Cbarles de Foucauld. Verso Tamanrasset
H. TEISSIER, c. DAGENS, P. s. RAYMONDE
ANDRÉE, A. CHATELARD, P. SEQUERI
E AA.Vv., Charles de Faucauld. L'eloquenza di una vita secar1do l'evangelo
B. CHENU, Tracce del volto. Dalfa parafa alla sguanla
C. FALCHINI, Monachesiwa: un cammina di urtificaziolle
C. GENNARO, Chiara d'Assisi
D. GoNNET, A11che Dio conosce la so/fere11za
L.-A. LAssus, Elogio delnascondimenta
]. LEcLERCQ, San Bemarda e la spirito cistercense
A. LouF, Generati dallo Spirito. L'accom-pagnamento spirituale oggi
A. LouF, Sotto la guida dello Spirito
A. LouF, La Spirito prega in noi
A. LouF, La t•ita spirituale
TH. MATURA, Celibato e comunità
TH. MATURA, E lasciato tutta lo seguirono. Fo11damenti biblici della vita religiosa

TH. MATURA, Fmncesco, maestro nello Spirito TH. MATURA, Incontri con Francesco d'Assisi G. Mrccou, Seguire Gesù povero. Nel Te
stamento di Francesco d'Assisi
TH. MERTON, Un vivere alternativo L. MIRRI, La dolcezza nella lotta. Donne e
ascesi secondo Girolamo F. VARILLON, L'umiltà di Dio
LITURGIA E VITA
L. BouYER, Architettura e liturgia
O. CLÉMENT, Le feste cristiane
A. CoNTESSA, Gerusalemme, promessa e profezia
F.-X. DURRWELL, Eucaristia ed evangelizzazione
C. GIRAUDO, Conosci davvero l'eucaristia?
A. NocENT, Liturgia semper refonnanda. Rilettura della rijo1ma liturgica
Segno di unità. Le più antiche eucaristie delle chiese
C. V ALENZIANO, L'anello della sposa. La celebrazione dell' Eucm-istia
AA.Vv., Vincolo di carità. La celebrazione eucaristica 1-innovata dal Vaticano II
PREGHIERA E VITA
E. BrANCHI, Via Crucis. Meditazioni e testi poetici sulla Passione
A. BwoM, La preghiem giorno dopo giorno
A. BLOOM, Ritornare a Dio. Pentimento, confessione e co1nunione
C. MASSA, Il tempo del vivere
MATTA EL MESKIN, Consigli per la preghiera
Preghiere della tavola. Benedizioni per i pasti B. STANDAERT, O. CLÉJ\1ENT, Pregare il
Padre nostro Un raggio della tua luce. Preghiere allo Spi
rito santo J.-P. VAN ScHOOTE, J.-C. SAGNE, Miseria e
misericordia. Perché e come confessarsi oggi
SEQUELA OGGI
J. BASTAIRE, Eros redento. Amore e ascesi
P. BEAUCHAMP, A. LouF E AA.Vv., La so-littldine: grazia o maledizione?
A. BLOOM, Vivere nella chiesa
D. BoNHOEFFER, Memoria e fedeltà
G. BRUNI, Servizio di comunione. L'ecumenismo nel magistero di Giovanni Paolo II
M. DE CERTEAU, Mai senza l'altro. Viaggio nella differenza
D. F. FoRD, Dare fanna alla vita. Suggerimenti spirituali per la vita quotidiana
D. HAMMARSKJOLD, Tracce di cammino
X. LACROIX, Il co1po e lo spirito. Sessualità e vita cristiana
F. LovsKY, Verso l'unità delle chiese
R. MANCINI, Il silenzio, via verso la vita J.-P. MENSIOR, Percorsi di crescita umana e
cristiana B. STANDAERT, Le tre colonne del mondo.
ìfldemecum per il pellegrino del }(XI secolo H. TEISSIER, Accanto a un amico. Lettere e
scritti dall'Algeria X. THÉVENOT, Le ali e la brezza. Etica e vi
ta spirituale X. THÉVENOT, Avanza su acque profonde! J.-M. R. TILLARD, La morte: enigma o mi
stero? C. VALENZIANO, Vegliando sul gregge. "Sen
so del pastore" e piani pastorali R. WILLIAMS, Il giudizio di Cristo. Il pm
cesso di Gesù e la nostra conversione
TIVEU!-liXTlXOl - SPIRITUALI
BARTHOLOMEOS I, Gloria a Dio per ogni cosa
A. BwoM, Alla sera della vita
A. LoUF, Cantare la vita TH. MERTON, La contemplazione cristiana M. VAN PARYS, Incontrare il fratello
R. CARD. ETCHEGARAY, Che ne hai fatto di Cristo?
ARcHIMANDRITA SoFRONIO, La preghiera: un'opera infinita
SYMPATHETIKA
G. ALBERIGO, Chiesa santa e peccatrice G. ANGELINI, Le ragioni della scelta M. AssENZA, Ricollocarci nel vangelo E. BrANCHI, Aids. Vivere e morire in comu-
nione E. BrANCHI, Come evangelizzare oggi E. BIANCHI, Come vivere il giubileo del 2000
E. BIANCHI, L. MANICARDI, Accanto al malato. Riflessioni sul senso della malattia e sull'accompagnamento dei malati
E. BIANCHI, C. M. CARD. MARTim, Parola e politica
CH. BoBIN, L'uomo che cammina
S. CHIALÀ, "Discese agli inferi"
O. CLÉMENT, Il potere croci/isso
P. DE BENEDETTI, E l'asina disse ...
F.-X. DURRWELL, L'eucarestia presenza di Cristo
A. LoUF, L'umiltà
S. NATOLI, Il cristianesimo di un non credente
Povertà e condivisione nella chiesa
PADRI DELLA CHIESA: VOLTI E VOCI
l PADRI DEL DESERTO, Detti editi e inediti !sACCO DI NrNIVE, Un'umile speranza
PATERIKA
Misericordia sempre. Casta meretrix, in alcuni testi dei padri della chiesa
Uomini e animali. Visti d4i padri della chiesa
POESIE
D. BoNHOEFFER, Poesie D. CIARDI, Non basta la ten·a. Poesie Brucia, invisibile fiamma. Poesie pa ogni
tempo liturgico R. M. R!LKE, Vita di Maria
R. A. AL VES, Parole da mangiare L. GoBBI, Lessico della gioia E. DE LucA, Ora prima A.JoLLIEN, Elogio della debolezza






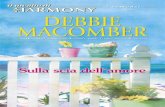
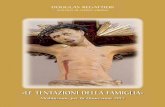



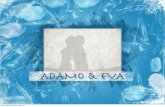


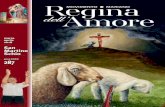




![Matthieu ARNOLD...Bonhoeffer e la preghiera, Magnano, Qiqajon, 2007, 120 pages. 7b. [Traduction anglaise, pour les États-Unis, du n 7 par Jack McDonald.] Fifteen days of prayer with](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5fefd8ae7b77337aaa70e2eb/matthieu-arnold-bonhoeffer-e-la-preghiera-magnano-qiqajon-2007-120-pages.jpg)