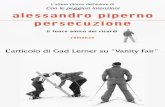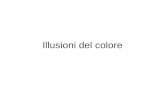Al Piperno Su Le Illusioni Perdute 04-12-2012
description
Transcript of Al Piperno Su Le Illusioni Perdute 04-12-2012

P assy, oggi, è unquartiere residen-ziale di Parigi ada-giato sulla riva de-
stra della Senna. Uno spa-zio urbano a dir poco esclu-sivo (quindicimila euro ametro quadro) che gode di
totale autosufficienza. Chi vive lì trova tuttoquello di cui ha bisogno: e chi vive lì ha biso-gno di molte cose. L’atmosfera che vi si respi-ra quasi tutto l’anno (soprattutto quando il cie-lo grigio del mattino viene scaldato dai coloriesotici della frutta, dei crostacei, delle tartelet-tes geometricamente esposti dietro le vetri-ne) è quella di un Natale perpetuo. Glishowroom di biancheria e di arredo per la ca-sa meritano una menzione speciale: non cen’è uno che non esibisca un soggiorno e unacucina in cui chiunque amerebbe trasferirsi.
Nonostante (o forse in virtù?) di tanta di-stinzione, Passy non è un quartiere turistico. Ibistrot sono affollati di benestanti famiglie au-toctone e di studentesse americane della NewYork University, la cui sede parigina è una del-le glorie del quartiere. Quando siedi tra loro,come uno sfiancato flâneur baudelairiano,quasi non ti ricordi di essere così vicino al fiu-me. Passy sembra costruita per suggerire inchi vi abita l’illusione di aver raggiunto final-mente un porto sicuro. Forse non è un casoche con tutta Parigi a disposizione BernardoBertolucci abbia rinchiuso Paul e Jeanne —gli immortali sporcaccioni di Ultimo tango —proprio in un appartamento di Passy.
I condomini più eleganti sono quelli di rueRaynouard, spettacolarmente affacciati sul fiu-me. Percorrendo questa via silenziosa hai l’im-pressione di essere nel classico waterfront diuna metropoli internazionale. Almeno finchénon ti imbatti in una modesta casupola al nu-mero 47, stretta fra due palazzi di lusso.
È in quel rudere sul fiume che, quasi duesecoli fa, Honoré de Balzac, braccato dai credi-tori, si trasferì, sotto false generalità, per po-ter lavorare in pace al suo mostruoso progettoromanzesco. Rimase in quella catapecchiaper sette anni e morì poco tempo dopo averlaabbandonata. La piccolezza della scrivania dilegno (unico pezzo originale della modestissi-ma collezione) è inversamente proporzionaleall’energia circostante: è su questo pezzo di le-gno che lavorò il più grande stacanovista del-
la storia della letteratura. È qui dentro che,nella primavera del 1843, eccitato dall’idea dipoter finalmente raggiungere l’amata mada-me Hanska a San Pietroburgo, Balzac scrissein pochi mesi la terza parte di Illusioni perdu-te: il romanzo cui lavorava da quasi dieci annie le cui prime due parti erano uscite da un belpezzo. A quel tempo Passy era ancora un pae-se autonomo rispetto a Parigi. Solo nel 1860,dieci anni dopo la morte di Balzac, sarebbe di-ventato il XVI arrondissement.
Non è suggestivo che Balzac scriva della fu-ga da Parigi di Lucien de Rubempré in un luo-go che non è ancora Parigi ma che sta per di-ventarlo? In fondo, se non da un punto di vi-sta topografico almeno da un punto di vistaemotivo si può dire che Passy si trovi a metàstrada tra Angoulême — la cittadina di provin-cia in cui Lucien è nato — e Parigi, la metropo-li in cui non è riuscito a fare fortuna, dalla qua-le sta fuggendo, alla quale ben presto verrà
convinto a tornare, e nella quale, da bravoeroe ottocentesco, troverà la morte.
Che dire di tutto questo se non che è splen-didamente balzachiano?
***
«Balzac aveva tre sogni: una grande edizio-ne ben curata delle sue opere, il saldo dei suoidebiti e un matrimonio coccolato e accarezza-to da lungo tempo nel fondo dell’animo; gra-zie a fatiche la cui mole atterrisce l’immagina-zione dei più ambiziosi e laboriosi, l’edizionesi fa, i debiti si pagano, il matrimonio va inporto. Balzac senza dubbio è felice. Ma la sortemaliziosa che gli aveva permesso di mettereun piede nella sua terra promessa, subito ve lostrappò violentemente. Balzac ebbe un’agoniaterribile e degna delle sue forze».
Parole di Baudelaire, ovvero di uno dei piùferventi ammiratori che Balzac abbia mai avu-to. Colgono perfettamente la natura fatale deldestino di un uomo di stupefacente esuberan-za che commise l’errore di scommettere sullafelicità e di credere nella possibilità che i desi-
deri umani, prima o poi, si esaudissero.Illusioni perdute racconta questa ingenuità
e questa follia: un meraviglioso itinerario diautodistruzione. Non sorprende che Balzac laconsiderasse «l’opera capitale nell’opera». To-gliete alla Commedia umana Illusioni perdute(e il suo sequel Splendori e miserie delle corti-giane), fate sparire dall’universo balzachianoLucien de Rubempré e David Séchard, e nullasarà più come prima. Se La pelle di zigrino è ilromanzo della svolta, quello in cui Balzac tro-va se stesso definitivamente, se in Papà Goriotfanno la loro comparsa sulla scena due dei per-sonaggi più rappresentativi dell’immenso ci-clo balzachiano, il dittico formato da Illusioniperdute e Splendori rappresenta, nell’ecosiste-ma della Commedia umana, lo zenit sfavillan-te: il luogo privilegiato in cui tutti i motivi ri-tornano, amalgamandosi con una gravità euna grazia che tolgono il fiato. In cui i perso-naggi più celebri danno il peggio e il meglio disé. In cui Rastignac incontra de Rubempré, ein cui Vautrin riappare sotto mentite spogliema sempre più determinato. In cui Balzac, co-me solo i sommi romanzieri sanno fare, parladi sé senza mai nominarsi.
Come dicevo, Illusioni perdute fu elaboratonel corso di molti anni, e portato a terminenell’età giusta per un romanziere. Quella incui il vigore della giovinezza e il disincanto del-la maturità trovano un radioso equilibrio.Qualcosa di simile sarebbe capitato a Stendhalnei cinquantatré giorni in cui scrisse La certo-
sa di Parma, e nei lustri in cui Flaubert avreb-be elaborato L’educazione sentimentale. Ciòche unisce questi tre capolavori della narrativadi ogni tempo è il fatto che furono vergati dauomini che iniziavano a sentirsi vecchi, e for-se per questo desideravano raccontare, con ilsenno di poi, il fallimento delle aspirazioni del-la giovinezza. Romanzi generazionali destinatia divenire romanzi universali.
Del resto, non c’è niente in Illusioni perdu-te con cui Balzac non si senta intimamente im-plicato. Balzac conosce la monotonia della vi-ta di campagna e i lussuosi miraggi della me-tropoli; conosce l’odore di chiuso delle stam-perie di provincia, così come l’aria insalubredelle tipografie cittadine; il pane secco dellamiseria, e quello fresco e profumato di unatavola ben imbandita; per non dire degli usicapricciosi dell’aristocrazia, della corruzionedei giornalisti, dell’orgoglio monastico degliincorruttibili, della dissoluta frivolezza dellecortigiane... Ma soprattutto Balzac conoscequello stato d’animo peculiare in cui illusionee disillusione si danno costantemente il cam-
bio: la dialettica interiore che rende la vita dicerti uomini troppo ingenui e troppo ambizio-si un calvario senza fine. Dire che Illusioni per-dute è l’opera più autobiografica di Balzacnon significa dire che lui somigli al suo bion-do eroe, Lucien de Rubempré. Ciò che Balzaccondivide con Lucien è il senso di inadegua-tezza, il revanscismo, la voglia di essere rico-nosciuto, il terrore di non farcela. Non stupi-sce che la genealogia di Lucien sia così contro-versa. È figlio di un’aristocratica di provinciae di un borghese: i suoi natali fanno quindi dilui un potenziale impostore e uno snob. An-che in questo Lucien è gemello del suo creato-re. D’altro canto, la facilità con cui Lucien si faabbindolare dalle proprie stesse illusioni nonè meno balzachiana dei suoi improvvisi acces-si di virtù. Basta mettere il naso nell’epistola-rio di Balzac per rendersi conto che la vita diquel grand’uomo fu scandita da una serie infi-nita di previsioni sulla propria sorte a dir po-co ottimistiche. Occorre dire che le sue sma-nie erano talmente impetuose da non cono-scere alcuna scaramanzia. La vita lo punì,
L’arte come vita: «Illusioni perdute» di Balzac
L’opera Ritorna il capolavoro dell’800al culmine della «Commedia umana»
Cultura
I sogni dell’autore
Il trionfo della volgaritàUno specchio del mondodi ALESSANDRO PIPERNO
Un’edizione ben curata dei suoiromanzi; il saldo dei suoi debiti; unmatrimonio accarezzato da tempo
Il senso Teatro, editoria, giornalismo:sono mondi dove la gloria non esiste
Da oggi in libreriacon Oscar Mondadori
IdentificazioneIl protagonistaCiò che lo scrittore condivide conLucien è senso d’inadeguatezza,voglia di riconoscimento,revanscismo, terrore di non farcela
Pubblichiamo lo scritto introduttivodi Alessandro Piperno al volume«Illusioni perdute» di Honoré deBalzac, che esce oggi per gli OscarClassici Mondadori (pp. 800, e 13,50)nella traduzione di Dianella SelvaticoEstense e Gabriella Mezzanotte. Lanarrazione si colloca tra «Scene dellavita di provincia» e «Scene della vitaparigina» e insieme a «Splendori emiserie delle cortigiane» compone undittico imperniato sulla figura diLucien de Rubempré.
Il libro
Commette l’errore irrimediabiledi scommettere tutto sulla felicità,di credere nella possibilità chei desideri umani si esaudiscano
42 Martedì 4 Dicembre 2012 Corriere della Sera

l’opera se ne giovò. Illusioni perdute è la subli-me presa d’atto di tanta dissennatezza.
***
Il più grande dolore della mia vita è stata lafine di Doctor House, la famosa serie tv ameri-cana.
Sto parafrasando, o per meglio dire paro-diando, Oscar Wilde, quando disse che la mor-te di Lucien de Rubempré era «one of the gre-atest tragedies of my life».
La boutade estetizzante di un dandy? Un’af-fettazione di disprezzo decadente nei confron-ti dell’esperienza umana a vantaggio dell’espe-rienza artistica? La sagace celia di un aforistairresistibile? Forse tutte queste cose assiemema anche parecchio di più.
E lo capisco oggi: grazie al senso di luttoprodotto in me dall’abbandono delle scene te-levisive di Gregory House — il diagnosta ge-niale, il moralista classico, il misantropo, ildrogato, l’assiduo frequentatore di prostitu-te...
Esiste Doctor House?Certo che esiste. Esiste molto più dell’anti-
patico edicolante da cui compro il giornaleogni mattina, della cui vita non so niente eniente voglio sapere. Mi manca più delle don-ne che ho amato e degli amici che ho perso,più di mia nonna morta tanti anni fa. L’ideache il caro Greg non possa più entrare in casamia, che non possa più sorprendermi con uno
dei suoi motti cinici, con le sue stravaganze,con il nichilismo esibito e il dissimulato senti-mentalismo, rende i miei giorni più noiosi etristi. Certo, è sconcertante che io intrattengauna così affettuosa relazione con un personag-gio di fantasia, per il quale, peraltro, io nonesisto. Devo tale miracolo alla forza di unagrande messa in scena, diluita negli anni. È co-me se la potenza dell’immaginazione si fosseunita alla potenza dell’assiduità. C’è qualcosadi folle e di magnifico nella promiscuità chetalvolta si stabilisce tra la nostra vita e le operedi fantasia. Una psicoanalista una volta mi rac-contò che una sua giovane paziente aveva ten-tato il suicidio per amore di Mr Darcy, il prota-gonista di Orgoglio e pregiudizio. E ho sentitodire che un giorno i barcaioli della Senna scio-perarono perché Dumas, a causa d’un’influen-za, non era riuscito a consegnare la puntatasettimanale del Conte di Montecristo...
Ecco, diciamo che nessuno ha saputo con-cepire un’opera così compromessa con la vitacome Honoré de Balzac.
Dopo un po’ che leggi i suoi romanzi nonriesci più a distinguere la differenza tra il datoreale e quello fittizio (e per i suoi contempora-nei la sensazione doveva essere ancor più im-barazzante). E l’idea di far tracimare i perso-naggi da un romanzo all’altro, affidando loroogni volta un ruolo diverso (che so, Rastignacè protagonista in Papà Goriot e semplice com-parsa in Illusioni perdute), è un geniale tradi-mento del patto romanzesco tra autore e letto-re. Balzac viola un vincolo oltre il quale c’è lafollia. Tale violazione fa di lui il più grande evisionario romanziere del diciannovesimo se-colo. A tal proposito Proust ha scritto: «Se, co-m’è stato mille volte osservato, i personaggidei suoi romanzi erano per lui esseri reali, tan-to ch’egli discuteva seriamente quale fosse ilmiglior partito per Clotilde de Grandlieu oper Eugénie Grandet, si può egualmente direche la sua vita era un romanzo, ch’egli costrui-
va assolutamente nella stessa guisa. Non c’erain lui nessuna distinzione tra la vita reale(quella che, a mio giudizio, non è tale) e lavita dei suoi romanzi (la sola vera per lo scrit-tore)». Non è superfluo osservare che Proustscriveva queste parole alla vigilia dell’immer-sione nella Recherche, ovvero nel momentoin cui si stava preparando a vivere lo spicchiodi vita che gli restava in preda a una follia nonmeno totalizzante di quella di Balzac.
In Illusioni perdute l’osmosi tra vita e arte ètalmente radicale che ne risentono persino lostile e la tecnica narrativa. La prima parte dellibro, intitolata I due poeti, si svolge nella cit-tadina di provincia di Angoulême e raccontal’amicizia tra Lucien de Rubempré, poeta alleprime armi, e David Séchard, lo stampatoredal cuore buono e dall’ingegno fertile. Balzacdescrive da par suo la vita di provincia: diffe-renze di classe, maldicenze, questioni eredita-rie, poderi contesi e vita di società. Il lettorefatica ad appassionarsi. Lo stile è lento, trop-po puntiglioso. Balzac sembra indugiare sudettagli insignificanti.
Solo dopo aver letto d’un fiato la secondaparte, Un grand’uomo di provincia a Parigi,che racconta in modo a dir poco funambolicol’esperienza in città di Lucien, alla ricerca difama e fortuna, il lettore capisce perché la pri-ma parte del libro fosse così noiosa. È attraver-so tale shock stilistico che Balzac rende plasti-camente la differenza tra la vita di campagnae la vita di città. La vertigine, l’eccitazione, lo
stupore barocco che soverchiano Lucien appe-na arrivato a Parigi somigliano molto a quelliche afferrano il lettore, uscito con le ossa rot-te da un centinaio di pagine molli e tediose.Ecco che d’un tratto anche il lettore (oltre aLucien) inizia a spassarsela.
***
Ha scritto Francesco Fiorentino: «Illusioniperdute costituisce la prima e più terribile re-quisitoria romanzesca contro il potere dellastampa. Ha emesso una condanna che nonavrà appello: il romanzo europeo non sarà maibenevolo con i giornali».
È interessante notare come tale contagio ab-bia varcato l’Oceano. Basti pensare ai libri diTom Wolfe (autore sommamente balzachia-no), o riflettere sulle vite ascetiche di Pynchono di Salinger, per rendersi conto che anche gliscrittori americani hanno un conto aperto conla carta stampata. D’altro canto, dai tempi diBalzac, i poteri dell’informazione hanno sapu-to differenziarsi. Al Quarto Potere della stam-pa si sono aggiunti il Quinto della tv e il Sestodel Web. Chi fa lo scrittore oggi sa che moltadella sua reputazione passa attraverso queimezzi non sempre equanimi, e spesso desola-tamente faziosi. E sa anche che il suo atteggia-mento nei confronti di tali poteri non può per-mettersi alcuna ambiguità: c’è solo l’acquie-scenza o il rifiuto.
E in fondo, a ben pensarci, lo scontro trascrittori e giornalisti descritto da Balzac in Illu-sioni perdute, ancora in auge nella nostra epo-ca, non è altro che il conflitto inevitabile trachi impiega qualche anno per scrivere un li-bro e chi ne deve leggere (si fa per dire!) e re-censire una dozzina alla setti-mana. Non è detto che lo scrit-tore sia più profondo e talen-tuoso del giornalista, e il giorna-lista per forza più superficialedello scrittore. Spesso capitache un recensore brillante si oc-cupi di uno scrittore mediocre.E tuttavia, converrete con me,la prospettiva tra uno scrittoree un giornalista è tutt’affatto di-versa.
Chi scrive un libro è animatodall’illusione che il suo manu-fatto possa essere letto anche tra qualche tem-po, se non per sempre. Chi scrive un articolosa che esso è, per sua stessa natura, effimero.Un buon libro può concedersi qualche lentez-za meditabonda. Un articolo deve essereesplosivo, a costo di risultare tranchant...
Balzac era di casa in questo tipo di scontro.E non solo perché nella sua avventurosa esi-stenza aveva fatto molti mestieri: editore, gior-nalista, drammaturgo, scrittore... ma ancheperché, come tutti gli artisti controversi — al-le spalle un bel numero di successi e di fia-schi —, era oggetto privilegiato di attacchigiornalistici, di sarcasmi e di pettegolezzi. Laseconda parte di Illusioni perdute, Un gran-d’uomo di provincia a Parigi, è interamenteconsacrata alla dialettica implacabile tra l’in-transigenza del «cenacolo» artistico che acco-glie fraternamente Lucien appena giunto a Pa-rigi, riconoscendo in lui un talento in nuce, ela combriccola dei giornalisti votati all’impre-cisione, al gossip e alla maldicenza. Niente distrano. Illusioni perdute, come tutti i grandiromanzi ottocenteschi, è un’opera manichea,edificata su esasperanti dicotomie: campa-gna-città, povertà-lusso, prodigalità-avarizia,ingenuità-scaltrezza, virtù-vizio, lavoro-pigri-zia e naturalmente la purezza giansenista delcenacolo contrapposta alla corruzione moraledel giornalismo.
La cosa grandiosa è che Lucien, stretto tratutti questi fuochi, si distingue sempre per in-dolenza, malleabilità, mimetismo. È senti-
mentalmente attratto dalla via aspra ma fini-sce sempre con l’imboccare quella più facile.E ancora una volta il lettore è con lui. Perquanto i discorsi di d’Arthez, lo scrittore delcenacolo, siano pieni di onestà, virtù, rigore,il lettore è decisamente più attratto dalle cini-che prolusioni del bieco Lousteau, e dal suomilieu popolato di laidi commercianti, attri-cette minorenni, editori senza scrupoli, gior-nalisti prezzolati... La filippica nella quale Lou-steau spiega a Lucien perché occorre stronca-re duramente un buon libro è seconda, perbellezza e verità, solo a quella con cui, nellaterza parte del libro, Vautrin (travestito daHerrera) convince Lucien a ritornare a Parigi.
Balzac ha una naturale attrazione per l’abie-zione. Come aveva ben inteso Proust, per capireBalzac fino in fondo occorre innamorarsi dellasua volgarità. Illusioni perdute, essendo «l’ope-ra capitale nell’opera», trasuda degli impulsi pri-mari da cui Balzac è ossessionato non meno diquanto lo sia il suo inesperto eroe. Balzac si pre-occupa dell’età, dell’avvenenza e dell’eleganzadei suoi personaggi in modo a dir poco compul-sivo. Il barone Sixte du Châtelet viene semprepresentato come un ex bel giovane che patetica-mente non si arrende all’idea di essere invec-chiato. D’altronde, Balzac non si dimentica maidi ricordarci quanto Lucien sia bello e giovane.E quanto sia malvestito. Il mirabile splendore dimadame de Bargeton sbiadisce, agli occhi di Lu-cien almeno, non appena viene paragonato aquello emanato dalle dame parigine...
A confronto, la tragica superficialità di Bal-zac fa scolorire il nichilismo edonista del suoepigono Bret Easton Ellis. Nel mondo balzachia-no la giovinezza, la ricchezza e la bellezza sonovalori assoluti e insindacabili. Una sorta di fero-ce darwinismo ante litteram.
Per non dire dei soldi, naturalmente. Chemeritano un capitolo a parte. Balzac ci informapedissequamente delle rendite e dellasolvibilità di ciascun personaggio. Le pagine diIllusioni perdute sono zeppe di cifre come la di-chiarazione dei redditi stilata da un coscienzio-so commercialista. Quando c’è di mezzo il de-naro la prosa di Balzac diventa di una sensuali-tà erotica.
Così Lucien reagisce al primo luculliano ban-chetto cui partecipa: «Assaporava le prime deli-zie della ricchezza, soggiaceva al fascino del lus-so, al potere della buona tavola; i suoi istinti ca-pricciosi si risvegliavano, beveva per la primavolta vini sceltissimi, faceva conoscenza con ipiatti squisiti dell’alta cucina; vedeva un mini-stro, un duca e la sua ballerina che, mischiati aigiornalisti, ne ammiravano l’atroce potere». Eancora: «Quel lusso agiva sulla sua anima co-me una ragazza di strada agisce su un licealecon le sue carni nude e le sue calze bianche bentirate».
E ancora: «Alle orecchie di Lucien, ogni cosasi risolveva con il denaro. Nel Teatro come nel-l’Editoria, nell’Editoria come nel Giornalismo, diarte e di gloria non si parlava neanche». (Anchein questo il mondo non è cambiato così tantorispetto ai tempi di Balzac: ancora oggi l’argo-mento preferito da uno scrittore è il modesto an-ticipo ricevuto, non all’altezza del suo talento, equello assai più sostanzioso elargito dall’editoreal collega meno dotato).
Le ragioni dell’arte e quelle sociali nel mon-do balzachiano sembrano coincidere. Luciennon sogna mai la gloria disgiunta dal denaro edal riscatto sociale. Non conosce la forza mora-le (o non ha l’ipocrisia?) dell’artista romanticoche lavora solo per sé, e per la posterità. E anco-ra una volta si rivela parente stretto del suo cre-atore. Il quale in certe cose non poneva alcunadistinzione.
E il paradosso è servito: questa mancanza didistinzione, questa grettezza, questa tetragginefangosa e levantina fanno di Balzac l’insuperatocantore del destino umano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
I l ripetuto ascolto, in questi giorni,di uno dei capolavori di Verdi, il Si-mon Boccanegra, mi ha indotto
una riflessione che desidero esprime-re nella speranza che non risulti sgradi-ta ai lettori.
Nel Prologo il giovane Boccanegraaffronta a faccia a faccia il giovane Fie-sco. È costui il padre della Maria ama-ta da Simone e da lui resa gravida. Ma-ria è rinchiusa nell’«atra magion» deiFieschi; è sola, terribilmente sola. Lasua finestra s’illumina solo quando Fie-sco va a visitarla. Poi muore; ma Simo-ne non lo sa; penetra nel palazzo men-tre il rappresentante della nobiltà guel-fa, Simone essendo popolano e ghibel-lino, dice a se stesso alludendo a Simo-ne: «T’inoltra e stringi gelida salma!».Ma prima che ciò avvenga i due uomi-ni hanno un dialogo.
Simone chiede «perdono» a Fiesco;e costui risponde che tra loro pace po-trà esser solo a patto che il «corsaro»gli dia la bimba nata dall’unione con lafiglia del guelfo. Ma essa è sparita, di-chiara desolato Simone: affidata a unavecchia, presso Pisa, a un certo punto,morta questa, «tre giorni pianse, tregiorni errò»; poi scomparve.
Simone dice tutto questo in un bra-no in forma di Ballata; in Fa minore, inmisura di 3/8, in tempo «andantino».La melodia è carezzevole. «Del mar sullido, tra gente ostile, crescea nell’om-bra quella gentile». Verdi adopera so-vente il modello della Ballata per rac-contare un fatto storico, effettivamen-te avvenuto: per lui questo modelloserve a comunicare una verità.
Veniamo adesso al Siegfried di Ri-chard Wagner. Siamo, durante il I at-to, nella spelonca del nano Mime, chelì ha allevato Siegfried con l’intenzione
che il giovane dagli occhi di drago, co-me tutti quelli della stirpe dei Welsidi,sia per procurargli la ricchezza e l’Oro.Siegfried prova per Mime odio e schi-fo. Il nano allora piagnucola e tenta dibuttarla sul patetico: e canta una Balla-ta in Fa minore nel tempo di 3/4, ter-nario dunque come quello di Verdiperché la Ballata ternaria ha da essere,e secondo me viene affrontata dai di-rettori in un movimento troppo mos-so. «Als zullendes Kind zog ich dichauf, wärmte mit Kleiden den oleineWurm»; «Infante ancor, ti trassi su;scaldai coi panni il vermicciuol», tra-duce Angelo Zanardini. Su pedale, lamelodia è del pari carezzevole: manon riesce a ingannar nessuno.
Per Wagner la Ballata è modo peresprimer menzogna; vale a dire l’esat-to opposto che per Verdi in un brano aquello di Verdi simile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Opera lirica Mentre nel «Simon Boccanegra» questo genere musicale è utilizzato per rivelare una verità, nel «Siegfried» è utilizzato per mentire
I disegni
Quarto Potere
Verdi e Wagner: i due modi opposti di usare la Ballata
Sopra in grande,un’illustrazione per ilromanzo «Illusioniperdute» di AdrienMoreau (1843-1906).In piccolo: un altrodisegno dello stessoautore ritrae una scenadifferente del libro
È la prima e più terribile requisitoriaromanzesca contro la stampa, unacondanna che non avrà appello
di PAOLO ISOTTA
L’Europa di Camus, senza muriMaestri
] Honoré deBalzac (fotogrande al centro,nato a Tours nel1799 e morto aParigi nel 1850)è stato unautore francesepoliedrico eprolifico:scrittore,drammaturgo,critico letterario,saggista,giornalista estampatore. Èconsiderato ilmaestro delromanzo realistaottocentesco. Lasua operamonumentale è
la «Commediaumana», unciclo che sicompone dinumerosiromanzi eracconti chehanno l’obiettivodi descrivere inmodo «totale»la società deltempo, e cheinfluenzòprofondamenteda Flaubert aZola, fino aProust e a Giono(foto piccole).Proprio perquesto è stataportataripetutamentesugli schermi
di ARTURO COLOMBO
Giuseppe VerdiRichard Wagner
Un discorso del ’55
A lbert Camus è il grande scrittore, autore de La peste (1947); ma è statoanche un intellettuale impegnato, capace di misurarsi con i maggiori
problemi politici del secondo ’900. Come dimostra il piccolo, ma eloquente,volume su Il futuro della civiltà europea (ed. Castelvecchi, pp. 60, e 7), cheraccoglie il testo di un incontro-dibattito tenuto da Camus a Atene il 28 apriledel 1955, e tradotto per la prima volta in italiano. La civiltà europea — ecco latesi di fondo — «è in primo luogo una civiltà pluralista», dove però, a causadella rottura fra Stati Uniti e Unione Sovietica, in quegli anni 50 esisteva (epersisteva) una rottura fra l’Europa occidentale individualista (e «borghese») e ipaesi dell’Europa dell’Est, costretti a subire il dominio di tipo sovietico. Da qui illucido imperativo di Camus, convinto che «bisogna lottare per riuscire asuperare gli ostacoli e fare l’Europa», perché solo un’Europa politicamenteunita, senza più gelosie fra Stati nazionali sovrani, potrà «svolgere il suo ruolonella storia di domani». Quel traguardo lo stiamo ancora aspettando.
La vita
43CulturaCorriere della Sera Martedì 4 Dicembre 2012