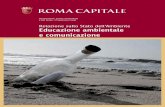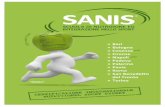Adattamenti
-
Upload
alberto-fatticcioni -
Category
Documents
-
view
609 -
download
0
description
Transcript of Adattamenti

ADATTAMENTI
M. Marella

GLI ADATTAMENTI Adattamento genotipicoAdattamento genotipico – rappresenta il processo di
un insieme di individui della stessa specie alle condizioni dell’ambiente in cui vivono, grazie ai cambiamenti genetici ed alla selezione naturale.
Adattamento fenotipicoAdattamento fenotipico – è quel processo che si sviluppa durante la vita di un singolo individuo in risposta dei vari fattori dell’ambiente esterno.
Normalmente si definisce il processo col quale l’organismo si adatta Normalmente si definisce il processo col quale l’organismo si adatta ai fattori dell’ambente esterno e interno, sia per descrivere il relativo ai fattori dell’ambente esterno e interno, sia per descrivere il relativo equilibrio tra organismo e ambiente, sia per indicare il risultato delequilibrio tra organismo e ambiente, sia per indicare il risultato del processo di adattamentoprocesso di adattamento

ADATTAMENTI

SINDROME DI SELYENormalmente viene utilizzato sia per definire il processo col quale l’organismo si adatta ai fattori dell’ambiente interno ed esterno, sia per descrivere il relativo equilibrio tra organismo e ambiente, sia per indicare il risultato del processo di adattamento.
Uno stress provocaUno stress provoca:
Attivazione dell’ipofisicheche
Aumenta la increzione dell’ormone adrenocorticotropocheche
stimola l’attività della corteccia surrenale i cui ormoni stimolanoi cui ormoni stimolanoi meccanismi adattativi.

Reazioni ad uno stressPrimo tipo di reazionePrimo tipo di reazione – è uno stimolo molto intenso e prolungato che si sviluppa quando vengono pianificati carichi eccessivi che non corrispondono alle possibilità dell’atleta ( ciclismo su strada, tornei eliminatori di pugilato, maratona, alpinismo ecc.)
Wade O., BischopJ.M., Cardiac, Outputand regional blood flow,Oxford, Blackwell Scientific Pubblications,1962. De Vries H.,A.,Housh T., Physiology of exercise, Madison, Brown and Benchmark, 1994

ADATTAMENTISecondo tipo di reazioneSecondo tipo di reazione – è uno stimolo che non supera l’entità delle
riserve dell’organismo ed è quello che stimola la formazione di adattamento
favorisce l’aumento della concentrazione ematica di glucosio, di acidi grassi, di aminoacidi.
• aumenta l’attività del sistema cardiocircolatorio e respiratorio trasportando substrati e ossigeno ai tessuti maggiormente sottoposti al carico. Esp. A riposo i muscoli consumano il 30%, il cervello il 20% i reni il 7% di ossigeno. Durante i carichi massimali i muscoli consumano l’87%, il cervello il 2% i reni 1%.

ADATTAMENTI
CONCEZIONE ANCORA PRESENTE
Nella fase anabolica l’organismo, non solo riportava l’equilibrio rotto, ma compensa in eccedenza (supercompensazione). Il superamento della fase iniziale (fase anabolica) permette, la volta successiva, di partire da un livello superiore.
l’allenamento ha l’obiettivo di somministrare all’organismo uno stress in modo tale che questo rispondesse, nella fase di recupero, con una risposta anabolica

ADATTAMENTIL’errore sulla programmazione poteva dipendere da:
non aver quantizzato gli stimoli giusti o in difetto o non aver quantizzato gli stimoli giusti o in difetto o in eccessoin eccesso
l’organismo non raggiungeva la soglia di eccitazione o la superava prepotentemente: in entrambi i casi non si aveva alcun beneficio.
non aver dato all’organismo un recupero adeguatonon aver dato all’organismo un recupero adeguato e sufficientee sufficiente
si poteva assistere ad un affaticamento dell’organismo che, non riuscendo a recuperare il carico rispondeva con un abbassamento delle difese immunitarie ed una diminuzione della prestazione (sovrallenamento).

ADATTAMENTINel 1986 Platonov introdusse, sul filone della supercompensazione, l’idea che andando a stimolare una capacità questa non migliorava da sola ma coinvolgeva i sistemi che gli permettono di agire.Ad esempio se il lavoro è incentrato sulla velocità, agisco indirettamente e in misura diversa anche sul sistema anaerobico e quello aerobico
[

ADATTAMENTIBernard (1898) e Cannon (1929-32) avevano messo in risalto la teoria dell’omeostasi, indicando il principale elemento delle risposte a stimoli esterni nella ricerca dell’organismo a ritrovare l’equilibrio quando elementi esterni (stimoli) lo alteravano.
Attualmente la supercompensazione va interpretata come variazione dovuta all’allenamento e che riguarda il
metabolismo energetico.
La supercompensazioni infatti, sia nella letteratura medica (Hollmann ed Hettinger 80), (De Marèes 79) che nel dizionario
della Oxford University esiste solo per ciò che riguarda i processi metabolici del glicogenoper ciò che riguarda i processi metabolici del glicogeno

ADATTAMENTI
• N.Jakovlev 1983-1986N.Jakovlev 1983-1986
Ha dimostrato che la supercompensazione avviene anche per il creatinfosfatocreatinfosfato, per le proteine enzimatiche e strutturaliproteine enzimatiche e strutturali, per i fosfolipidifosfolipidi, per la quantità di mitocondrimitocondri nelle fibre muscolari, per le sostanze che vengono utilizzate o alteratesostanze che vengono utilizzate o alterate durante un lavoro muscolare.
Quindi dopo una attività, nel periodo di riposo, il potenziale potenziale energetico non solo viene ripristinatoenergetico non solo viene ripristinato, ma, per un determinato per un determinato periodo, si creano le condizioni per una capacità più elevataperiodo, si creano le condizioni per una capacità più elevata.
L’entità e la rapiditàL’entità e la rapidità sono direttamente proporzionali all’intensità dell’utilizzazione delle sostanze usateall’intensità dell’utilizzazione delle sostanze usate durante la fase di lavoro.

ADATTAMENTI
• Verchoshanskij (1979-1983)Verchoshanskij (1979-1983)
ha dimostrato che, nell’alta prestazione, dopo lavori di grande volume concentrati in breve periodo (da 2-4 a 8-10 settimane) si è avuto un abbassamento della prestazione, poi un incremento anche del 30%
Questo fenomeno va sotto il nome di EARLT (effetto di allenamento ritardato a lungo termine).

ADATTAMENTI
Adattamenti generali:
1) mobilitazione delle riserve energetiche
2) Attivazione delle riserve proteiche
3)
3) Attivazione delle difese dell’organismo
IL S.N.C AVVIA LA RISPOSTA DI ADATTAMENTO ATTRAVERSOIL S.N.C AVVIA LA RISPOSTA DI ADATTAMENTO ATTRAVERSO
1) I meccanismi specifici omeostatici che attivano una risposta di attivazione della fase acuta
2) I meccanismi dell’adattamento rispondono con una mobilitazione delle riserve energetiche, proteiche, del sistema immunitario

ADATTAMENTI
Adattamenti
Impegni EsplosiviImpegni EsplosiviAumento della Velocità di liberazione della risintesi di ATP per via anaerobica (reazione mediata dall’enzima Creatinfosfochinasi) CKP.
Impegni Impegni Sub-massimali Sub-massimali di Media Duratadi Media Durata
Miglioramento dell’ossidazione anaerobica dei carboidrati (glicolisi).
Impegni di intensità Impegni di intensità moderata di lunga moderata di lunga duratadurata
Risintesi aerobica di ATP caratterizzato dalla capacità che prevede l’utilizzazione sia dei Carboidrati che dei Lipidi.
Hollmann W., T Hettinger

ADATTAMENTI
DURANTE L’ATTIVITA’ MUSCOLARE I COMPITI ORMONALISONO DI MENTENERE COSTANTE NEGLI SPAZI INTRA EDINTER CELLULARI:
A)A) Il livello degli ioniIl livello degli ioniB)B) Il livello dell’acquaIl livello dell’acquaC)C) Il livello del glucosio ematicoIl livello del glucosio ematico
Una funzione importante viene svolto dagli enzimi enzimi che sono responsabili della direzione e dell’ordine di grandezza dei processimetabolici; in un mitocondrio ci possono essere circa 10 miliardidi molecole ed enzimi, durante il lavoro fisico e in presenza di unenzima la velocità di reazione può aumentare da 10 5 a 10 20
De Marèes H: fisiologia dello sport – Colonia 1979

ADATTAMENTILe necessità energetiche dipendono oltre che alla qualità dello stimolo (intensità) anche dalla durata.Ogni stimolo temporalmente diverso richiede l’intervento di un determinato sistema e di apporto energetico e di una via d’accesso per ottenere la necessaria energia diversa.

ADATTAMENTI
La cellula può in ogni momento provvedere direttamente alle proprie necessità energetiche ricorrendo alla scissione dell’ATP: ma questa si può accumulare soltanto in piccola quantità nella cellula, pertanto va risintetizzato nella misura in cui viene scisso
Da un punto biochimico si può calcolare che ogni persona usa nel corso della giornata una quantità di ATP circa uguale al 75%
della sua massa corporea.
Per un atleta che corre la maratona (in poco più di 2 ore) con un livello energetico circa 20 volte superiore rispetto al normale, la quantità di ATP scissa ammonta a ben 80 Kg. (Newsholme 1987)
Uno sprinter se accelera dopo 1” ha già esaurito le scorte ma se Uno sprinter se accelera dopo 1” ha già esaurito le scorte ma se continua a accelerare lo fa perché riesce a risintetizzare ATPcontinua a accelerare lo fa perché riesce a risintetizzare ATP

ADATTAMENTI
In una gara di 100 m. uno sprinter dopo 6” ha In una gara di 100 m. uno sprinter dopo 6” ha consumato già l’88% delle sue riserve di consumato già l’88% delle sue riserve di fosfocreatina, e al 7” il 100%; per riuscire a fosfocreatina, e al 7” il 100%; per riuscire a continuare lo sprint l’atleta deve ricorrere al sistema continuare lo sprint l’atleta deve ricorrere al sistema glicolitico.glicolitico.

ADATTAMENTI
In linea teorica secondo Keul 1969la demolizione dei fosfageni (ATP-CP) avviene entro il 6-10 secondi per via anerobica alla massima velocità. La concentrazione di lattato avviene nella prima fase di in lavoro submassimale tra il 3° e 5° minuto, dopo di che viene assicurato dall’apporto di ossigeno e limitato dal massimo consumo di ossigeno.
[1]
Keul J. , E. Doll, D. Keppler: Muskelstoffwechsel – Mǜnchen 1969

ADATTAMENTI
di Prampero ’81 crede che, sia la successione lineare della sollecitazione dei meccanismi energetici, sia la stessa classificazione delle fonti energetiche del lavoro muscolare risultino “poco naturali”
Verchoshanskij (2002), i principali cambiamenti del meccanismo energetico sono legati alle trasformazioni morfofunzionali ed ai cambiamenti delle capacità contrattili e ossidative dei muscoli di messa a disposizione dell’energia
.

ADATTAMENTINeumann (1994) il processo di adattamento alla resistenza,
ha quattro stadi:
Primo stadio – il programma di controllo motorio si concretizza nell’aggiustamento del programma motorio attraverso aggiustamenti funzionali dei sistemi di regolazione centrale neuroendocrini e vegetativi; Secondo stadio – l’adattamento produce un aumento delle riserve energetiche e delle proteine strutturali e funzionali; Terzo stadio – l’adattamento è caratterizzato da un miglioramento funzionale ottenuto attraverso le modificazioni strutturali raggiunte;• Quarto stadio – inizia quando, nella muscolatura allenata, si sono oramai conclusi sia gli aggiustamenti funzionali che la trasformazione strutturale.

ADATTAMENTI1) la supercompensazione è un primo stadio dell’adattamento che permette all’atleta di affrontare quello successivo. (Verchoshanskij, Viru 1987) 2) se si continua con carichi crescenti le tracce dei lavori precedenti si sommano e portano ad un adattamento stabile (Verchoshanskij, Viru 1987; Chocacka, Pometo 1977; Viru 1980)3) la supercompensazione degli ormoni ed enzimi utilizzati svolgono un ruolo determinante nella sintesi delle proteine che costituiscono la base della specializzazione morfofunzionale ( Viru 1981, Verchoshanskij 1985, Bauer 1935)Come le medicine non curano il malato ma aiutano il suo Come le medicine non curano il malato ma aiutano il suo organismo a combattere la malattia, l’allenamento aiuta organismo a combattere la malattia, l’allenamento aiuta l’atleta ad adattarsi alle condizioni di una specifica attività l’atleta ad adattarsi alle condizioni di una specifica attività sportivasportiva.

ADATTAMENTIADATTAMENTIRimane però il problema di come allenare atleti di alta prestazioneRimane però il problema di come allenare atleti di alta prestazione
La soluzione trovata negli anni 70 indicava la strada nell’incremento del volumenell’incremento del volume con la conseguenza di portare l’organismo al superallenamento e all’incremento dei traumi. Per risolvere questo secondo problema si è cercata nel recupero recupero da svilupparsi sia in giornate di riposo durante il microciclo, sia nel cambio tra le varie esercitazioni, sia alla termine di ogni allenamento (Platanov 2000). Questa soluzione, vista dal Questa soluzione, vista dal versante dell’adattamento, ha poco senso se pensiamo che le versante dell’adattamento, ha poco senso se pensiamo che le esercitazioni hanno lo scopo di creare uno squilibrio che poi esercitazioni hanno lo scopo di creare uno squilibrio che poi l’organismo deve riequilibrare.l’organismo deve riequilibrare. Introducendo il recupero favoriamo l’eliminazione delle tracce biochimiche dell’effetto allenante riparando o eliminando l’azione dei metabolici che determinano la biosintesi post lavorativa (Jakovlev 1971, 1976, 1983; Viru 1994).

ADATTAMENTIADATTAMENTI
La strategia metodologica attuale ci indica che dopo la fase di lavoro concentrato di alto volume EARLT (effetto di allenamento ritardato a lungo termine), si devono ricercare mezzi e metodi più vicini al gesto sportivo specifico nei quali l’intensità, il carico esterno, l’ampiezza del gesto ecc. siano sovrapponibili alla gara.


Difensori

Centrocampisti

Attaccanti

QUANTITA’ e QUALITA’ della CORSA in PARTITA
(M. Marella 2001)
Totale Cammino
Corsa < 4Km/h
Corsa e sprint
Media 11539 8487,5 3051,5
Dev. St.
1139,3 611,1 752,4

Numero e Distanze nello sprint
M. Marella 2001
Totale Numero Metri
Media 630.25 48.9 13.24
Dev. St. 293.16 20.49 3.16

SPRINT: Metri Percorsi e Tempo Di Recupero
M. Marella 2001
Distanza Recupero
Media 13.24 99.6
Dev. St. 3.16 33.42

Nel calcio, + che di velocità si deve parlare di sprint o di “scatto”(effetto di spinta che la rapida estensione degli arti inferiori ha sul corpo del giocatore) C. VittoriVariazioni ritmiche:• spinta verso l’alto con estensione simultanea dei due arti inferiori• raddrizzamento di un arto, combinato alla flessione dell’altro arto
Il corpo può andareIl corpo può andare: : • in avantiin avanti• lateralmentelateralmenteIn uno sprint di pochi passi (a volte anche solo 1-2 In uno sprint di pochi passi (a volte anche solo 1-2 appoggi)appoggi)

30
20
10
706050403020100
40
distanza in metri
num
ero
di sp
rin
tNumero degli sprint in media prodotti in gara in funzione della distanza.(Dufour, 1990)

7.50 120105907560453015
55
35
40
45
50
15
20
25
30
10
5
0
tempi di pausa
tempi di gioco
tempi (s)
perc
en
tuale
Durata delle sequenze di gioco (Monbaerts, 1991)
- Il 93% delle pause di gioco è a 30”
- Il 73% dei tempi di gioco è a 30”
- Il 52% delle pause di gioco è di 15”
- Il 33% dei tempi di gioco è di 15”


sprint totali
22
32
27
43
3
71
51
36
73
4844
119
0
10
20
30
40
50
60
70
80
numero tempo
numero 22 32 27 43 3 71 51 36 73 48 44 11 9
tempo 4,21 2,58 2,39 2,12 9,44 1,18 1,37 2,39 1,17 1,59 1,26 2,09 1,23
Falcone Castellini Zaccardo Tarantino Olive Brighi Nervo Pecchia Cruz Zauli BrioschiDella Rocca
Bellucci

Profilo fisiologico e quadro prestativo del giocoProfilo fisiologico e quadro prestativo del gioco
“Malgrado l'alto numero di sprint il LA va raramente oltre i 6-7 mmol/L”
(Mombaerts, 1991)

Concentrazioni medie di LA (mM) nel calcio
Study Players First half
End
Second half
End
Agnevik, 1970 First division 10
Ekblom, 1986 First division 9,5 7,2
Second div. 8 6,6
Third div. 5,5 4,2
Fourth div. 4 3,9
Mombaerts, 1991 6 - 7
Bangsbo, 1993 League, Den. 2,6 2,7
Sassi – Candel, 1998 4,2
Nanni e coll., 2001 Serie A 6,2

ARKRAY
YSI Sport Lactate Analyzer

Lattato (mM) in partite ufficiali (2° tempo)Campionato 2001-02; 52 prelievi
Difensori (9) 6.1+1.9 (3.2-9.3)
Centrocampisti (6) 6.4+1.9 (3.3-9.2)
Attaccanti (5) 6.2+1.4 (4.5-7.5)

“…Una delle conclusioni è di evitare gli sforzi
prolungati atti a provocare un forte carico di LA.
Per questo si consiglia di evitare in allenamento i
lavori ad alta intensità e di tempo >30" tendenti a
stimolare la tolleranza ad alte concentrazioni di LA.“
Profilo fisiologico e quadro prestativo del giocoProfilo fisiologico e quadro prestativo del gioco
(Chatard, 1992)