Adaptive landscapes: A case study of metaphors, models, and synthesis in evolutionary biology
Click here to load reader
-
Upload
emanuele-serrelli -
Category
Education
-
view
565 -
download
3
description
Transcript of Adaptive landscapes: A case study of metaphors, models, and synthesis in evolutionary biology

Università degli Studi di Milano Bicocca
Scuola di Dottorato in Scienze Umane
Dottorato di Ricerca in Scienze della Formazione e della Comunicazione
XIII ciclo
Presentazione della tesi:
Adaptive landscapes: A case study of metaphors,
models, and synthesis in evolutionary biology
di
Emanuele Serrelli
Discussione finale
17 gennaio 2011
! 1

! 1. In questa presentazione del mio lavoro di tesi, come ho cercato di
fare nella Conclusione di esso, presenterò un sommario abbastanza
completo dei problemi, delle alternative, delle mie analisi e proposte attorno
al tema dei paesaggi adattativi in biologia evoluzionistica. Cercherò di
evidenziare come da questo caso di studio possano emergere se non
questioni, almeno stimoli di portata generale su termini come metafora,
modello, sintesi, che descrivono lʼattività scientifica nelle più diverse
discipline. Per facilitare la messa in relazione della mia esposizione con la
tesi, ho inserito in rosso nelle slides i riferimenti precisi ad essa.
! 2. Per cominciare, i paesaggi adattativi sono un esempio di metafora
scientifica, quale vengono spesso definiti in letteratura. Attraverso il caso ho
dunque indagato natura e ruolo della metafora nella scienza. Innanzitutto ho
enfatizzato i legami della metafora con il contesto storico-scientifico in cui
essa si è diffusa: la Sintesi Moderna.
! 3. Sulla SM adotto la visione dellʼillustre evoluzionista Ernst Mayr
sebbene nella tesi io abbia considerato anche visioni alternative. Per Mayr la
SM fu un processo - svoltosi dagli anni ʼ10 a tutti gli anni ʼ30 del Novecento -
di natura essenzialmente comunicativa. Consistette nella costruzione e
nellʼaffinamento di un linguaggio comune che consentì a campi prima
! 2

separati1 di iniziare un lavoro congiunto di riconoscimento e ricostruzione
della storia della vita sulla Terra.
! 4. Anzi, come ho scritto nella conclusione, «...di dare il senso di una
unità comprendente geni, fenotipi con i loro adattamenti a differenti ambienti,
speciazioni, micro e macroevoluzione, episodi singoli e il pattern più generale
dellʼevoluzione» (p. 208). Ho considerato con particolare interesse la visione
di Mayr per lʼimportanza che essa dà al linguaggio e al superamento di
barriere comunicative. Questa visione si differenzia ad esempio da altre che
vedono la SM come una estensione a tutte le discipline biologiche dei metodi
e dei modelli matematici della genetica delle popolazioni.
! 5. E ho ipotizzato che il paesaggio adattativo - che ho definito una
metafora migrante - possa aver svolto un ruolo in questo processo di
“costruzione di ponti”.
! 6. Lʼidea di metafora migrante è distinta da una parte dallʼidea di una
metafora che riassumerebbe in sé lʼevoluzione “in un sol colpo”, e dallʼaltra
dallʼidea di uno strumento che si applicherebbe in tutti i contesti allo stesso
modo indipendentemente da essi. La metafora migrante - con il relativo
vocabolario di termini come “picco” o “valle” che vedremo - si ritrova nei
diversi campi della biologia, ma in ciascuno viene declinata diversamente.
! 3
1 Come la paleontologia, la genetica teorica e sperimentale, la morfologia, la zoologia, la botanica e molti altri.

! 7. Ho analizzato con particolare attenzione i paesaggi adattativi proposti
da capostipiti come il genetista Theodosius Dobzhansky e il paleontologo
George Gaylord Simpson, rilevandone la portata,2 aspetti comuni e
specificità. Tornerò su questo tra poco.
! 8. Mi è stato necessario un certo sforzo di analisi per isolare tre idee
fondamentali, semplici e intuitive alla base della metafora in tutte le sue
istanze:
- “higher is better”: lʼaltitudine corrisponde in qualche modo al “meglio”: le
migliori combinazioni e soluzioni sono collocate su picchi, e le peggiori in
fondo a valli;
- “meglio” e “peggio” sono termini relativi a un particolare ambiente, che non
compare nel diagramma ma lo influenza, determinando lʼaltitudine dei punti
del paesaggio;
- il paesaggio è lʼintero insieme di possibilità per una data entità in evoluzione,
e lʼevoluzione viene concepita come la realizzazione di potenzialità nel
corso del tempo.
Un esempio. Se costruiamo il paesaggio adattativo di una popolazione
considerata dal punto di vista genetico, il paesaggio sarà lʼinsieme di tutte le
combinazioni genetiche individuali che sono virtualmente possibili nella
popolazione; il dato ambiente in cui la popolazione vive determinerà
! 4
2 Perché sono “big pictures”? Al di là dellʼautorevolezza dei loro proponenti, queste immagini (Dobzhansky, Dawkins) sono proposte come sufficienti a rappresentare lʼevoluzione (in coerenza con la preminenza della genetica), con enorme portata tassonomica comprendente anche le “specie possibili”. Oppure (Simpson) fondamentali nel raccordo tra micro e macro, e con la vocazione a individuare pattern evolutivi ripetuti.

lʼaltitudine delle combinazioni genetiche: le migliori si troveranno sui picchi, le
peggiori nelle valli. Gli individui effettivamente realizzati (una piccola
percentuale di quelli possibili) saranno visualizzati come punti sulla
superficie, e la popolazione sarà rappresentata come una nuvola di punti che
cambia nel tempo. Il processo di adattamento sarà visualizzato come la
“scalata” a uno o più picchi, cioè la produzione e la conservazione di individui
sempre più adatti allʼambiente di vita generazione dopo generazione.
! 9. Lʼidea di metafora migrante nella SM mette al centro lʼaccezione
linguistica della nozione di metafora, e il significato dinamico - insito nella sua
etimologia - di “trasferire”, “portare” da un campo allʼaltro.3 Introdotta negli
anni ʼ30, la sua forza si riscontra a tuttʼoggi, ad esempio la vediamo
comparire in libri divulgativi che diffondono e difendono lʼevoluzione, come
Alla conquista del monte improbabile di Richard Dawkins, del 1996.
! 10. In questa immagine si vede il paesaggio dellʼevoluzione dellʼocchio,
immaginato da un biologo su richiesta di Dawkins. Ma il linguaggio dei picchi
e delle valli è utilizzato come accennerò tra poco anche nella ricerca.
! 11. Recentemente, poi, si stanno diffondendo paesaggi adattativi di
forma differente: gli “holey landscapes”, che consistono in superfici più o
meno piatte e bucate, prive di picchi o valli.4 Cosa possono significare questi
! 5
3 La comunicazione attraverso la metafora - anche laddove non utilizzabile - rese noti e comprensibili gli avanzamenti nel campo della genetica di popolazioni, anche se in modo superficiale (“come se” i dettagli non importassero). La diffusione della metafora fu senzʼaltro supportata dallʼautorevolezza di tale campo, ma probabilmente contribuì a consolidare tale autorevolezza. Non ho preso in considerazione visioni più forti della metafora che la vedono come esplicativa in se stessa (p. 57).
4 Fino a questo momento la forma dei paesaggi era stata trattata come inerente ai paesaggi stessi.

paesaggi per lʼevoluzione e per la biologia evoluzionistica? Cosa accadrebbe
se migrassero anchʼessi in diversi campi? Si è sviluppato un notevole
dibattito, che però a detta di molti ha creato più confusione che
chiarificazione. Una delle proposte che ho fatto per arrivare precisare la
relazione tra paesaggi bucati e paesaggi collinosi è stata di andare ad
analizzare i paesaggi adattativi (metafora migrante) nel loro contesto nativo.
! 12. Il contesto teorico originario dei paesaggi adattativi è la genetica
matematica mendeliana delle popolazioni, e dal medesimo contesto teorico
provengono i paesaggi bucati, sebbene circa 65 anni dopo.
! 13. Lʼanalisi che ho svolto ha messo in evidenza che i paesaggi
adattativi nel loro contesto nativo sono già metafora, ma in un senso
particolare che è familiare in matematica: sono metafora di un modello. I due
termini vanno dunque visti in relazione gerarchica tra loro piuttosto che in
concorrenza, laddove in altre sedi la metafora viene vista come un modello
imperfetto, oppure come il preludio alle forme più avanzate e affidabili di
rappresentazione, i modelli. Ho anche suggerito brevemente di immaginare
che questa relazione gerarchica valga anche per la metafora migrante: forse
questa viene adottata in un campo per la sua capacità di rappresentare non i
fenomeni oggetto di studio, bensì i modelli che il quel campo sono già
familiari. Una riflessione sulla costitutiva ricorsività della conoscenza - dove si
danno rappresentazioni di rappresentazioni - farebbe forse sfumare la rigida
! 6

distinzione tra i due modi di vedere la metafora, e anche i modelli. Visto
comunque che i paesaggi nativi sono metafora di un modello, è comunque
fondamentale rispondere alla domanda “di quale modello questa metafora è
metafora?”, in modo molto più dettagliato di quanto sia stato fatto fino ad
oggi.
! 14. La genetica di popolazioni - spesso presentata come un corpo di
conoscenze compatto - ha una struttura teorica piuttosto articolata, e
contiene strumenti matematici e formali di diversi tipi. Di quali di questi
strumenti i paesaggi adattativi sono metafora? Seguendo alcune suggestioni
poco conosciute in letteratura ho approfondito la struttura teorica della
genetica di popolazioni e ho stabilito che il paesaggio adattativo è metafora di
un oggetto formale assolutamente fondamentale: la popolazione mendeliana,
ovvero uno spazio combinatorio genetico provvisto di fitness (cioè lo spazio
logico che rappresenta tutte le combinazioni tra geni che sono possibili in una
popolazione).
! 15. Avendo moltissime dimensioni, questo spazio non è trattabile
direttamente mediante equazioni matematiche. Dunque, da una parte ho
criticato molti commentatori che hanno dato per scontato che i paesaggi
siano metafore di “equazioni troppo complicate”; dallʼaltra ho analizzato come
Wright abbia potuto arrivare a conoscere qualcosa dello spazio combinatorio
avendo a disposizione soltanto equazioni. In altre parole, come egli abbia
! 7

potuto oltrepassare il “gap epistemologico” che separa spazio ed equazioni e
arrivare a informazioni poi visualizzate mediante la metafora del paesaggio.
! 16. Questa è una sintesi di quanto ho appena detto.
! 17. In questa storia sono comparsi diversi oggetti: lo spazio
combinatorio della popolazione mendeliana; la popolazione (senza prefisso)
che è la parziale realizzazione dello spazio, che cambia nel corso del tempo;
la superficie adattativa, cioè una metafora che mostra caratteristiche dello
spazio; le equazioni della genetica di popolazioni, che descrivono le
frequenze geniche nella popolazione; e altri.5 Questo insieme eterogeneo di
oggetti si incontra con una pluralità di significati del temine “modello” nella
filosofia della biologia contemporanea, portando a una variabilità
dellʼestensione semantica del termine: quali e quanti di questi oggetti (o
combinazioni di questi oggetti) possono essere definiti “modello”? Ho insistito
molto su un “approccio pragmatico” in filosofia della biologia: lʼuso
indiscriminato di parole come “modello” ha infatti, secondo la mia analisi,
alimentato confusione nella discussione.
! 18. Ho proposto un vocabolario per discutere lʼaffascinante tema dei
paesaggi adattativi. In particolare ho scelto una nozione di modello molto
! 85 Cf. tutto il ramo della genetica biometrica.

interessante e “atipica” per questo dibattito. Non entro qui nei dettagli ma tra
poco dirò di più su cosa ho voluto intendere per modello.6
! 19. Avendo approfondito la storia e lʼepistemologia della metafora
nativa, e avendo fissato un vocabolario che consente di parlare di paesaggi
in modo non ambiguo, mi sono occupato dei cosiddetti “landscape models”
che proliferano nella biologia evoluzionistica odierna, e che non sono legati
necessariamente né alla popolazione mendeliana, né alla superficie
adattativa.7 Il loro tratto comune è un spazio combinatorio provvisto di fitness,
ed essi variano in base a: natura dei fattori che vengono combinati,
dimensionalità, metodo con cui la fitness è assegnata, parametri dinamici.
Una nota importante: con la distinzione da me introdotta tra spazio
combinatorio e superficie di fitness, diviene evidente (come dʼaltra parte era
già chiaro a Wright) che la dinamica del movimento non si svolge sulla
superficie, bensì nello spazio combinatorio, dove si trovano i parametri e i
vincoli.8 La metafora - la superficie - consente una parziale visualizzazione,
descrizione, comprensione di quelle dinamiche.
! 9
6 Ho proposto di catturare lo spazio combinatorio mendeliano mediante la nozione di modello come «obiettivo stabile di spiegazione». Essa rende conto di tutto il lavoro fatto attorno al modello, su di esso, per comprenderne le caratteristiche e i comportamenti. Lascia aperte domande su quando e che cosa il modello rappresenti o spieghi, ma a mio parere questo è un ulteriore punto di forza di questa nozione. Essa obbliga a considerare la dimensione pragmatica dellʼattività di modellizzazione, in una visione che lascia agli scienziati la facoltà di decidere che cosa conta come rappresentazione o spiegazione, per che cosa, e fino a che punto.
7 Perché allora si chiamano “landscape models”? Per la già citata efficacia del linguaggio metaforico che consente di parlarne.
8 Nello spazio vi sono due “principi strutturanti” essenziali dei paesaggi adattativi, che non sono menzionati tra i primi tre criteri minimali esposti allʼinizio. Ora che la necessità dello spazio combinatorio è manifesta, bisogna aggiungerli: vicinanza (neighborhood) e meccanismo di movimento (II.2.2).

! 20. Sono anche ritornato sulle istanze della metafora migrante,
mostrando nel paesaggio di Dobzhansky le caratteristiche conservate e le
inconsistenze; in quelli di Simpson le novità e la coerenza; e nelle visioni di
Dawkins lʼimpulso retorico e astraente.
! 21. Alcuni spazi combinatori genetici, poi, affrontano un problema che
secondo Sergey Gavrilets è stato tradizionalmente lasciato fuori dalla
modellizzazione matematica: la speciazione.! Il libro di Gavrilets del 2004 -
nel quale egli colloca i paesaggi bucati - presenta lo stato dellʼarte di questo
campo, che ho descritto come un repertorio di diversi strumenti,9 un
“patchwork”, che ha iniziato a far sì che la popolazione mendeliana possa
essere modello anche della speciazione. Lʼidea di “spazi bucati” è prodotta
da un nuovo tipo di analisi statistica degli spazi ad alta dimensionalità:
lʼanalisi di percolamento. A loro volta, gli spazi bucati sono un presupposto
teorico che autorizza alcuni tipi di modelli a bassa dimensionalità della
speciazione; gli spazi bucati, poi, vengono visualizzati metaforicamente nel
modo ormai familiare. La mia analisi individua dunque un modello formale
fondamentale - la popolazione mendeliana - e un “patchwork” di strumenti
interconnessi che non soltanto migliorano la nostra conoscenza del modello,
ma lo rendono di volta in volta adatto ad essere rappresentazione anche di
nuovi fenomeni. Le domande di ricerca e gli interessi degli scienziati guidano
! 109 Analisi statistiche, spazi combinatori a bassa dimensionalità, equazioni di frequenze.

questo processo, e cambiano nel tempo - ad esempio Wright era interessato
allʼadattamento, non alla speciazione.
! 22. In generale, il progresso nella modellizzazione appare come un
processo non banale, in cui contano molto le dimensioni pragmatiche
(domande e decisioni degli scienziati), e bisogna valutare attentamente le
relazioni tra gli elementi del “patchwork”. Ho criticato il lavoro del filosofo e
biologo Massimo Pigliucci (2008) sui paesaggi adattativi principalmente
perché mi è parso poco in sintonia con questa complessità della dinamica
della scienza.
! 23. Mosso da preoccupazioni dellʼoggi, Pigliucci attacca i paesaggi
adattativi perché essi non sono in grado di rappresentare correttamente il
rapporto tra genotipi e fenotipi; e li utilizza, dipingendo Wright come
precursore, per avvalorare un filone di studio contemporaneo, quello
dellʼevolvibilità. Pigliucci è uno dei principali proponenti del progetto definito
“Sintesi Evoluzionistica Estesa” (ecco che torna il tema della sintesi), e
mosso forse da preoccupazioni e urgenze attuali opera alcune conflazioni
storiche ed epistemologiche, trascurando gli scopi originari dei paesaggi
adattativi e le caratteristiche inerenti lʼattività stessa di modellizzazione,10
enfatizzando ciò che mancherebbe in quei paesaggi, e confondendo diversi
! 11
10 Pigliucci non vede, ad esempio, la legittimità della compressione di fenotipi e ambienti che avviene nella genetica di popolazioni, e che consente a questa disciplina di concentrarsi su geni, genotipi e frequenze geniche con un ambito ben preciso e una definizione dei problemi. Né riconosce la necessità di differenti paesaggi per rispondere a domande diverse (pluralismo di Wright).

paesaggi e contesti teorici nello sforzo interpretativo di trovare ante litteram
domande di ricerca.
! 24. Per il progetto di una Sintesi Evoluzionistica Estesa ho individuato
due sfide: quella di arrivare a definire la struttura della teoria dellʼevoluzione e
della Sintesi Moderna, specificando il cambiamento strutturale ora in corso; e
quella di dare a modelli e strumenti - come i paesaggi adattativi - una
collocazione appropriata in questa struttura. Alla prima sfida ho indicato una
possibile via di risposta nellʼipotesi neo-Lakatosiana di Telmo Pievani basata
sul concetto di “programma di ricerca”. Si noti che dal punto di vista della
Sintesi Estesa, la Sintesi Moderna è un oggetto, un prodotto del processo
storico di cui dicevo con Ernst Mayr. In chiusura del mio lavoro ho parlato di
nuovo brevemente di “sintesi come processo” illustrando lʼapproccio sintetico
del National Evolutionary Synthesis Center. Secondo questo approccio, la
sintesi guiderebbe tuttora la biologia evoluzionistica, almeno nella risposta
alle grandi questioni e alle prospettive ampie. Essa consisterebbe nel
costante superamento situazioni di frammentazione e mancanza di
comunicazione attraverso, ad esempio, modalità innovative di gestione e
rappresentazione delle informazioni, e costruzione di linguaggi comuni.
Compiti nei quali, penso, possono assumere un ruolo importante sia la
filosofia della biologia, sia i paesaggi adattativi (a condizione, forse, che
analisi come quella che ho svolto ne diano una idea chiara e condivisa).
! 12



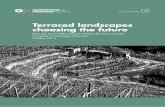







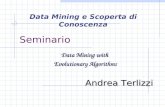





![[d.a.t.] Abstract[d.a.t.] Pag.97 [divulgazioneaudiotestuale] NUMERO 5 THE ICY FACE OF NAPLES: CONTEMPORARY LANDSCAPES OF PIANO MUSIC FIRST SECTION LORENZO PONE [ENGLISH TRANSLATION](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/6107870d7fac5755943820fa/dat-abstract-dat-pag97-divulgazioneaudiotestuale-numero-5-the-icy-face.jpg)

