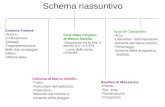1350728184 Schema Riassuntivo Pascoli
-
Upload
andrea-piras -
Category
Documents
-
view
467 -
download
8
description
Transcript of 1350728184 Schema Riassuntivo Pascoli

Giovanni Pascoli
DECADENTISMO � movimento culturale che si espresse soprattutto in campo artistico dall’inizio degli
anni ’80 fino alla prima guerra mondiale
� intuizione no razionalità
POSITIVISMO sta a ILLUMINISMO come
DECADENTISMO sta a ROMANTICISMO
VARIE TENDENZE NEL DECADENTISMO:
• Simbolismo (1857)
• Estetismo
• Superomismo
• Dandismo
Simbolismo � insieme delle opere che hanno un interesse per la capacità evocativa della poesia e per
l’elaborazione di un personale sistema simbolico.
Occorre un’arte ideista, simbolista, sintettica, decorativa e soggettiva.
Autori di riferimento francesi: Boudelaire, Rimbaud, Verlaine
Autori di riferimento italiani: D’Annunzio, Pascoli
Estetismo � in origine faceva riferimento ai sensi poi viene scelto come tendenza verso il bello; culto
dell’arte per l’arte.
Autori di riferimento: D’Annunzio, Oscar Wilde
Superomismo � un uomo che va oltre l’uomo presente e con la potenza vuole vincere la vita infinita sulla
limitazione della ragione e dell’etica.
Dandismo � ricerca del piacere sia nell’arte che nella vita non curandosi di alcun aspetto morale; la vita è
tesa tutta alla bellezza.
PASCOLI:
� 1855: nasce a San Mauro di romagna; è il quarto di dieci fratelli.
� 1867: gli viene ucciso il padre a colpi di fucile da due sicari.
� 1868: muoiono la sorella maggiore Margherita, e la madre.
� 1871-73: inizia a frequentare il liceo a Rimini.
� 1891: esce la prima edizione di Myricae con soli 22 componimenti.
� 1897: sulla rivista “Il Marzocco” vengono pubblicati i primi capitoli del Fanciullino, in una redazione
parzialmente diversa da quella completa pubblicata nel 1903.
� 1903: pubblica i Canti di Castelvecchio.
� 1905: riceve la nomina alla cattedra di letteratura italiana all’Università di Bologna.
� 1911: pubblica i Poemi Italici; Pascoli tiene un discorso in onore delle vittime italiane in Libia (La
grande proletaria si è mossa).
� 1912: muore a Bologna.

POETICA: Caratteri Principali;
- Nella poetica di Pascoli ha un ruolo centrale il saggio intitolato “Il fanciullino”
- L’infanzia è per Pascoli un momento intatto, non toccato dal male e immune dalla sofferenza a cui si
ritorna nella memoria come a un paradiso perduto
- Il poeta coincide con il fanciullo che è in ognuno di noi; poeta è chi sa ascoltare e si fa guidare da quel
fanciullino che è in lui
- Il compito del poeta è quello di scoprire nelle cose le somiglianze e le relazioni più ingegnose
- La poesia non si inventa ma la scopre il fanciullo tramite il “vedere” e l’”udire” potendo anche cogliere
quel particolare in cui egli vede racchiusa la poesia
- La poetica di Pascoli si allontana dal tradizionale uso della retorica perché il fanciullino ingenuo non
può essere un retore; nonostante ciò il poeta è in grado di dire la parola che tutti hanno nel cuore e in
cui tutti si riconoscono
SOGGETTI POETICI: la campagna con le sue fatiche, le figure dimesse, gli attrezzi da lavoro, ecc.
Il testo di riferimento: (“E’ dentro noi un fanciullino”)
• Caratteristica del fanciullo: “serena meraviglia”
• Pascoli si rifà a Celes Tebano (interlocutore di Socrate nel dialogo di Platone “il fedone”) il quale
ipotozza che ci sia in tutti un fanciullino che ha paura della morte
• Quando siamo piccoli il fanciullino che è in noi non si riconosce
• Pascoli associa il macrocosmo al microcosmo
TEMI DELLE POESIE - natura
- timore e paura nei confronti della natura
- il nido (la famiglia)
- il lutto
- la memoria
- il dolore
MYRICAE (1891) Myricae = tamerici � linguaggio delle umili cose della vita quotidiana
Uso del latino per 2 motivi:
- per la formazione classica di Pascoli
- per l’uso, all’interno del testo, di argomenti appartenenti alla botanica che
era in latino (esaltazione della scienza)
� poesia che tratta temi modesti e quotidiani, legati ai ritmi delle stagioni e dei lavori nei campi
IMPRESSIONISMO LIRICO � con la poesia non si vuole realizzare l’oggettività (verismo) ma ciò che
arriva all’occhio (impressione); uso dei 5 sensi
� Nella natura di Pascoli è sempre presente l’uomo
STRUTTURA:
- componimenti brevi
- poesia come impressione colta all’istante
- la narrazione non segue più un percorso logico ma procede per ellissi, analogie (pigolio di stelle – “Il
gelsomino notturno), sinestesie, onomatopee, assonanze, ecc.

LINGUAGGIO:
Pascoli utilizza 3 linguaggi:
• linguaggio grammaticale � la lingua che si usa normalmente per la comunicazione
• linguaggio agrammaticale � fuori dalla grammatica (onomatopee)
• linguaggio post-grammaticale � termini tecnici, lingue speciali e gerghi
IL LINGUAGGIO DI PASCOLI VISTO DA “GIANFRANCO CONTINI”
- translinguismo � il linguaggio di Pascoli oltre quello medio (latino, linguaggio
scientifico)
- cislinguismo � il linguaggio di Pascoli sotto la grammatica (onomatopee,
allitterazioni)
METRICA:
Pascoli rispetta la metrica tradizionale: cesure, enjambements, ecc; frantuma il verso tradizionale che
diviene spezzato e singhiozzante
I POEMETTI (1897) - componimenti più ampi con scopo narrativo
- temi centrali restano con in Myricae la campagna e la vita agreste ma al posto della Romagna subentra
la Garfagnana
- stesso stile, stesso ritmo e stessa sintassi di Myricae
- linguaggio: uso di dialetti garfagnanini
- Omero, Esiodo e Virgilio sono citati per descrivere semplici fanciulle o modesti oggetti di un mondo
rurale
I CANTI DI CASTELVECCHIO (1903) - elementi di continuità con Myricae come la dedica alla madre per esempio
- stessi temi
- secondo Contini Pascoli vuole mettere in risalto il legame che c’è tra la Romagna e la Garfagnana
- uccelli, fiori e campane sono oggetto della poesia e parlano all’animo del poeta e del poeta
- il mondo esterno minaccia il microcosmo campestre del poeta, mettendo a repentaglio il nido
ricostruito a Castelvecchio, il proprio mondo
Il testo di riferimento: “Il gelsomino notturno”
� Pascoli scrive questo canto in occasione del matrimonio di un suo amico utilizzando un simbolismo
sensuale
� Questa valenza erotica ha un stretto legame con la cultura classica pascoliana perché nell’antica Grecia
l’amore (eros) era collegato alla morte (zanatos).