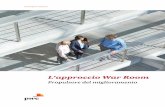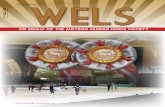12^ Rassegna Internazionale Cinema Scuola ORIZZONTI DI LUCE · Park, A.I. Intelligenza Arti˜ciale...
-
Upload
nguyenkien -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of 12^ Rassegna Internazionale Cinema Scuola ORIZZONTI DI LUCE · Park, A.I. Intelligenza Arti˜ciale...

L’INCONTRO TRA DUE GIGANTIPrima o poi sarebbe accaduto: il più grande regista vivente, che ha celebrato in molti suoi �lm l’incanto dell’infa-nzia, ha scelto di trasporre in immagini il romanzo più noto del più bizzarro scrittore per ragazzi che la letteratura abbia mai conosciuto. Stiamo ovviamente parlando di Steven Spielberg e Roald Dahl. Abbiamo ammirato negli anni passati la maniera in cui Spielberg ha raccontato l’infanzia in �lm come E.T., Ai con�ni della realtà, Jurassic Park, A.I. Intelligenza Arti�ciale ma anche in �lm storici come L’impero del sole, Schindler’s list e War Horse. Un’infan- zia segnata dalla necessità di fuggire dal mondo troppo piccolo creato dagli adulti, desiderosa di conoscere l’Altro, di ampliare lo sguardo e soprattutto desiderosa di scoprire il nuovo, il diverso che agli occhi dei bambini è meraviglia dell’universo. Non è un caso che i bambini di Spielberg non sono mai davvero arrabbiati, anche quando subiscono cattiverie da parte degli adulti. Semmai hanno lo sguardo aperto, gli occhi spalancati a volte spaventati ma non per paura quanto per aver colto l’inaspettato, per aver scoperto qualcosa che il mondo reale ha nascosto loro. I bambini di Spielberg insomma sono a loro modo ribelli e positivi, non distruttivi, sono attivi, si muovono nel mondo cercando, esplorando e così costruiscono speranze. D’altronde è l’infanzia stessa dell’auto-re che irrompe sullo schermo: «Non sono stato un bambino felice – racconta Spielberg – quando i miei genitori si sono separati ho so�erto tantissimo, mi sono sentito abbandonato. E questa sensazione dell’abbandono me la sono portata dentro per molto tempo, non solo, ma mi faceva sentire diverso dai miei compagni. A scuola poi, mi sentivo socialmente abbandonato. Non ero popolare. I ragazzi che ammiravo non mi permettevano di giocare con loro. Sono stato solo una comparsa nella mia vita, per molti anni. E questo sentimento ho provato a raccon-tarlo nei miei �lm». Anche Sophie è a suo modo una ribelle. Anzi è la prima cosa che ci viene raccontata di lei: mentre tutti gli altri nell’orfanotro�o dormono, lei legge romanzi e siccome è vietato, lo fa nascondendosi sotto la coperta facendosi luce con una torcia. E il libro che sta leggendo è la storia di altri bambini come lei, orfani, soli e ribelli come tutti i protagonisti dei libri di Dickens. Quando Sophie si avvicina alla �nestra per guardare in strada sa che sta facendo una cosa proibita: «Mai scendere dal letto, mai andare alla �nestra, mai vedere cosa c’è dietro la tenda» sono le regole dette e ripetute dell’orfanotro�o. Regole a cui lei verrà meno, senza ripensamenti. D’altr-onde se non avesse disubbidito non avrebbe mai conosciuto il Grande Gigante Gentile, cioè non avrebbe avuto un amico straordinario seppur immaginario. Sarebbe rimasta nel suo letto, schiacciata dalla solitudine.Anche i bambini raccontati da Roald Dahl sono ribelli, ma in modo diverso rispetto a quelli di Spielberg. Vivono storie decisamente più cattive, più buie, in cui la presenza degli adulti è davvero un peso insopportabile e a tratti
trova, delle regole che le sono state date, ma non si rassegna alla sua condizione. La curiosità, il bisogno di a�etto e di calore umano, il desiderio di scoprire mondi diversi da quello che già conosce la spingono a immaginare, immergendosi nella lettura di libri che divora in maniera segreta sotto le coperte, al buio, come se legge-re/fantasticare fosse l’attività più pericolosa di questo mondo. E che dire della possibilità di scorgere dalla �nestra le luci della strada che appaiono come fantasmi nel buio della notte e scoprire che di notte vive un mondo fantastico, a volte spaventoso, sicuramente strano e proibito? Sophie non vuole sottrarsi a questa possibilità. Come tutti i bambini e le bambine, Sophie si sente attirata e spaventata da ciò che non conosce e prova a fare piccoli passi in avanti per assaporare l’imprevisto. Ma questa volta lo sconosciuto è molto molto più grande di lei ed entra all’improvviso nella sua vita, prima che lei se ne accorgesse, in una scena bellissima in cui il nuovo, lo spaventoso, il meraviglioso l’accoglie nella sua mano gigantesca. È una delle scene simbolo del �lm perché racconta della delicatezza, della dolcezza con cui il magico, il fantastico accoglie la bam-bina e la trasporta in una terra in cui tutto è possibile anche creare sogni e regalarli ai più piccoli. Non è straordi-nario tutto questo? Sì, ma bisogna fare attenzione perché se lasciamo che i piccoli siano troppo liberi nella loro immaginazione, avremmo troppi ribelli nel mondo e questo non piace a chi decide quali debbano essere le regole da seguire. Per questo a un certo punto appaiono i giganti cattivi, i cui nomi ci dicono molto delle loro atroci abilità e abitudini: la loro missione non è tanto quella di mangiare Sophie (piccola com’è non basta a soddisfare l’appetito di nessuno di loro), ma quello di distruggere i sogni. Vomitoso, Strizza-teste, San-Guinario, Inghiotti-cicciaviva, Trita-bimbo, Spella-fanciulle, Scotta-dito sono avidi, violenti, rozzi, ignoranti, stupidi esatta-mente come chiunque usi la violenza per piegare l’altro alla propria volontà. È una lotta impari quella che si viene a creare tra loro e il fratello più piccolo (il nanerottolo lo chiamano) e Sophie. Ma a vincere saranno proprio loro due, i più piccoli, perché hanno armi più intelligenti, più profonde, più ra�nate che sono la gentilezza, l’ami-cizia necessarie per raggiungere obiettivi più alti (non già il riempirsi la pancia) come l’a�ermazione della giusti-zia, l’accettazione delle diversità, il potere dell’immaginazione, la difesa della libertà.
LA GENTILEZZA RENDE GRANDILa gentilezza non è solamente forma, se si riduce a questo diventa ipocrita. La gentilezza di cui ci parla Il GGG è sostanza e coerenza. Basti pensare alla maniera in cui il Gigante Gentile protegge Sophie dai suoi fratelli cattivi o alla maniera in cui difende la sua diversità (è il più basso dei Giganti e per questo deriso) o alla maniera in cui custo-disce il suo dolore più profondo. A un certo punto il GGG mostra a Sophie il vaso in cui ha racchiuso il suo incubo peggiore: dentro ci sono i rimorsi e il dolore per qualcosa da cui non può più tornare indietro ovvero la scomparsa del bambino che per primo era diventato amico del GGG, scoperto e divorato da altri giganti cattivi. Da allora lo scopo del GGG è proteggere tutti i bambini che decide di portare con sé perché nel mondo reale nessuna infan-zia deve essere o�esa, violata, nessun bambino deve diventare vittima delle disattenzioni, delle distrazioni. Sophie per lui diventa quindi il simbolo dell’infanzia, un’età in cui l’idea del mondo che ci si fa, dipende soprat-tutto dai buoni o dai cattivi esempi che si ricevono. Il GGG arriva in un momento particolare della vita della bam-bina: ha dieci anni, che rappresentano un po’ il con�ne tra l’infanzia e la preadolescenza, cioè è una fase in cui il fantastico e il reale assumono dei contorni più chiari e �nalmente ci si può prendere la responsabilità e la libertà di farli comunicare per creare qualcosa di diverso. Magari più giusto… e più divertente. Si, perché un concetto chiaro che Il GGG esprime con forza è che non è vero che se si è gentili si è deboli, s�gati, come dicono alcuni. Al contrario, se si è gentili e leali e amici veri, si fanno esperienze strabilianti come essere invitati dalla Regina e risultare interessanti, originali, divertenti. Di contro chi usa la forza, l’arroganza, la violenza non è per niente �go, anzi è davvero ributtante come i giganti del �lm, ma contro di loro il Gigante Gentile e Sophie non sentono desiderio di vendetta, solo giustizia. Per questo il �nale non vede l’eliminazione del nemico ma viene data loro una specie di punizione “educativa”, ripa-ratoria: vengono mandati su un’altra terra a imparare a coltivare e mangiare cetrionzoli. «La magia ci fa essere intraprendenti – ha detto Spielberg – la speranza viene da lì».
orizzonti di luceorizzonti di luce
NEI CINEMA E NELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADOE DI SECONDO GRADO DI BARI, BAT E ALTRE PROVINCE PUGLIESI
FILM, DIBATTITI, INCONTRI CON AUTORI, SUPPORTI DIDATTICI, LABORATORI, SEMINARI
DAL 21 NOVEMBRE 2016AL 15 MAGGIO 2017
12^ RASSEGNA INTERNAZIONALE CINEMA SCUOLA
info e prenotazioni:Cooperativa Sociale Il Nuovo Fantarca a r.l.Via Ospedale di Venere, 64 – 70131 Carbonara – BARItel./fax 080.4673486 mobile 338.7746218/347.6761637 e-mail [email protected]
CERCACI SU
con il patrocinio di
Comune di BariAssessorato alle Culture
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIATURISTICA E CULTURALE
con il contributo di
DIREZIONE GENERALE CINEMA
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA E COMUNICAZIONE CORSO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
con la collaborazione di
Istituto PenaleMinorile di Bari“Nicola Fornelli”
Multicinema Galleria - BariCinema Nuovo Splendor - BariMultisala Paolillo - BarlettaMulticinema Teatro Norba - ConversanoCinema Grande - Altamura
WWW.NUOVOFANTARCA.IT
di Steven Spielberg
terri�cante, come in un racconto horror. Anche se, a dire il vero, Il GGG rispetto agli altri libri di Dahl è più tenero, divertente, probabilmente perché l’autore l’ha scritto come una delle tante �abe della buona notte che doveva portare serenità alle sue �glie prima e alle sue nipotine dopo. Forse la più grande di�erenza tra Spielberg e Dahl sta nel fatto che il primo intravvede sempre la luce pur attraversando le tenebre, il secondo la luce non riesce neanche a scorgerla e i suoi racconti spesso lasciano una certa amarezza, una sensazione profondamente legata alla realtà, pur essendo la sua scrittura molto creativa e fantasiosa. Anche qui dobbiamo scomodare l’infanzia e ancor di più l’adolescenza dell’autore, segnate da morti importanti e da un’educazione sin troppo rigida. Dahl ad esempio perse sua madre all’età di soli quattro anni. Per un po’ visse con la nonna che adorava ma a un certo punto suo padre decise di risposarsi e Dahl bambino dovette vivere un’altra separazione dolorosa, quella dalla nonna appunto, per dare posto ad una donna giovane ma autoritaria. Inoltre la scuola che Dahl ragazzino frequentò era un college di buona fama ma in cui l’educazione e la disciplina si trasmettevano attraverso puni-zioni corporali e psicologiche e dominavano gli atti – diremmo oggi – di bullismo feroce, da parte dei ragazzi più grandi verso quelli più piccoli. E Dahl, pur essendo alto già a quindici anni 1 metro e 98 centimetri, non riuscì a sottrarsi alle violente pratiche dei college inglesi di quegli anni. Ma riuscì a resistere. Il suo modo per a�rontare e sopportare la brutalità del college consisteva nel reprimere le emozioni, nel non con�darsi mai con nessuno, chiudendosi anche lui come Spielberg nel silenzio e nella solitudine, più tardi riem-piti dalla loro fervida immaginazione. Anche la vita di Dahl adulto è stata costellata da lutti importanti: a 7 anni muore sua �glia Olivia che ispira la �gura proprio di Sophie per Il GGG. «Fumava sigarette Dunhill, odorava di sapone da barba e aria fresca, aveva la voce calda e famigliare come il rumore di passi su pavimento di legno» ha raccontato al Guardian sua nipote Sophie, �glia di Tessa, secondogenita di Dahl. Sono state le sorelle minori Olivia e Lucy, ad ascoltare per prime, in forma di racconto della buona notte quello che sarebbe stato Il GGG. Quando le bambine andavano a letto il “gigante” Dahl saliva su una scala, prendeva una lunga canna di bambù e giocava a so�are sogni per tutta la stanza. L’idea del gigante che raccoglie sogni chiudendoli in delle scatole per poi o�rirli ai bambini per farli felici durante il sonno, è un’idea che inseguiva da tempo lo scrittore anglo-nor-vegese. Ed è così che i bambini di Dahl sono creature che resistono alle crudeltà dei più grandi, che a�rontano le peggiori di�coltà senza mai abbattersi e senza mai mostrarsi sentimentali, che a�rontano la morte come qualcosa di terribile ma reale. Ad esempio in Matilda vediamo genitori che non capiscono la propria �glia, anzi la detestano perché chiede regole ed educazione, in Willy Wonka i bambini possono scomparire per sempre o tornare a casa dopo molto tempo, in Le streghe i bimbi vengono trasformati in topi e ci rimangono! A Dahl insomma non interessa il lieto �ne, il �nale consolatorio del “vissero tutti felici e contenti”! Ed è per questo che mentre i �lm di Spielberg sono stati sempre ben accolti dal pubblico in tutto il mondo, i libri di Dahl furono molto ostacolati perché considerati volgari, violenti, non adatti ai ragazzi. Nell’unica autobiogra�a autorizzata da Dahl e scritta da Donald Sturrock si racconta di un’editrice orgogliosa di aver ri�utato per due volte di pubbli-care i suoi libri. Ad esempio Eleanor Cameron, autrice per bambini canadese de�nì La fabbrica di cioccolato un libro scadente, di cattivo gusto, sadico e orribile e pericoloso per i bambini. Un’altra scrittrice di fantascienza, Ursula K. Le Guin, scrisse che sua �glia era diventata una villana dopo la lettura de La fabbrica di cioccolato.Oggi fortunatamente i libri di Roald Dahl sono ampiamente apprezzati per la sua scrittura libera, fuori da regole e schemi, ricca di parole inventate (basti pensare a come parla il Grande Gigante Gentile), pervasa da un umori-smo a volte feroce ma divertente, una scrittura così vicina all’immaginazione che ogni bambino ha dentro di sé e così carica di quella sana ribellione utile ad ogni bambino per crescere libero e indipendente.
UNA STRAORDINARIA STORIA DI AMICIZIA Possiamo considerare Il GGG la storia di due solitudini che un giorno si incontrano e, superate le prime di�den-ze, sentono che uno può essere utile all’altro, capiscono che stanno bene insieme perché ognuno ha qualcosa di buono da mettere a disposizione. Ma soprattutto ciò che li incoraggia a darsi una mano, a credere l’uno nell’altro e a farsi accettare per quello che sono, è la gentilezza! E che cos’è la gentilezza se non la via per stare insieme senza farsi male, la via per dialogare con l’altro senza costruire muri e senza sopra�azioni, la via per rispettare la dignità dell’altro, indipendentemente da come si è? La Sophie che conosciamo all’inizio del �lm è una bambina vispa, intelligente, consapevole del posto in cui si

orizzonti di luceorizzonti di luce
L’INCONTRO TRA DUE GIGANTIPrima o poi sarebbe accaduto: il più grande regista vivente, che ha celebrato in molti suoi �lm l’incanto dell’infa-nzia, ha scelto di trasporre in immagini il romanzo più noto del più bizzarro scrittore per ragazzi che la letteratura abbia mai conosciuto. Stiamo ovviamente parlando di Steven Spielberg e Roald Dahl. Abbiamo ammirato negli anni passati la maniera in cui Spielberg ha raccontato l’infanzia in �lm come E.T., Ai con�ni della realtà, Jurassic Park, A.I. Intelligenza Arti�ciale ma anche in �lm storici come L’impero del sole, Schindler’s list e War Horse. Un’infan- zia segnata dalla necessità di fuggire dal mondo troppo piccolo creato dagli adulti, desiderosa di conoscere l’Altro, di ampliare lo sguardo e soprattutto desiderosa di scoprire il nuovo, il diverso che agli occhi dei bambini è meraviglia dell’universo. Non è un caso che i bambini di Spielberg non sono mai davvero arrabbiati, anche quando subiscono cattiverie da parte degli adulti. Semmai hanno lo sguardo aperto, gli occhi spalancati a volte spaventati ma non per paura quanto per aver colto l’inaspettato, per aver scoperto qualcosa che il mondo reale ha nascosto loro. I bambini di Spielberg insomma sono a loro modo ribelli e positivi, non distruttivi, sono attivi, si muovono nel mondo cercando, esplorando e così costruiscono speranze. D’altronde è l’infanzia stessa dell’auto-re che irrompe sullo schermo: «Non sono stato un bambino felice – racconta Spielberg – quando i miei genitori si sono separati ho so�erto tantissimo, mi sono sentito abbandonato. E questa sensazione dell’abbandono me la sono portata dentro per molto tempo, non solo, ma mi faceva sentire diverso dai miei compagni. A scuola poi, mi sentivo socialmente abbandonato. Non ero popolare. I ragazzi che ammiravo non mi permettevano di giocare con loro. Sono stato solo una comparsa nella mia vita, per molti anni. E questo sentimento ho provato a raccon-tarlo nei miei �lm». Anche Sophie è a suo modo una ribelle. Anzi è la prima cosa che ci viene raccontata di lei: mentre tutti gli altri nell’orfanotro�o dormono, lei legge romanzi e siccome è vietato, lo fa nascondendosi sotto la coperta facendosi luce con una torcia. E il libro che sta leggendo è la storia di altri bambini come lei, orfani, soli e ribelli come tutti i protagonisti dei libri di Dickens. Quando Sophie si avvicina alla �nestra per guardare in strada sa che sta facendo una cosa proibita: «Mai scendere dal letto, mai andare alla �nestra, mai vedere cosa c’è dietro la tenda» sono le regole dette e ripetute dell’orfanotro�o. Regole a cui lei verrà meno, senza ripensamenti. D’altr-onde se non avesse disubbidito non avrebbe mai conosciuto il Grande Gigante Gentile, cioè non avrebbe avuto un amico straordinario seppur immaginario. Sarebbe rimasta nel suo letto, schiacciata dalla solitudine.Anche i bambini raccontati da Roald Dahl sono ribelli, ma in modo diverso rispetto a quelli di Spielberg. Vivono storie decisamente più cattive, più buie, in cui la presenza degli adulti è davvero un peso insopportabile e a tratti
Regia: Steven Spielberg; sceneggiatura: Melissa Mathi-son, tratto dal romanzo omonimo di Roald Dahl; inter-preti principali: Mark Rylance (Il grande gigante genti-le), Ruby Burnhill (Sophie), Penelope Wilton (la Regina), Jemaine Clement (Inghiotticicciaviva), Rebecca Hall (Mary), Rafe Spall (Mr Tibbs), Bill Hader (San Guinario), Adam Godley (Strizzateste), Paul Miniz de Sa (Vomito-so), Jonathan Holmes (Trita-bimbo), Olafur Olafsson (Spella-fanciulle), Daniel Bacon (Scotta-dito); montag-gio: Michael Kahn; fotogra�a: Janusz Kaminski; musi-che: John Williams; scenogra�a: Rick Carter, Robert Stromberg; costumi: Joanna Johnston; supervisore e�etti visivi: Joe Letteri; produttori esecutivi: Kathleen Kennedy, John Madden, Kristie Macosko Krieger, Micha-el Siegel; prodotto da: Steven Spielberg, Frank Mar-shall, Sam Mercer; origine: USA, 2016; durata: 115 min.
Abbiamo fame di tenerezza,in un mondo dove tutto abbonda
siamo poveri di questo sentimentoche è come una carezza
Alda Merini
La tramaLondra, Sophie dieci anni, vive in un orfanotro�o. Una notte mentre tenta di a�acciarsi alla �nestra della sua stanza, viene rapita da una creatura gigantesca che si aggira per le strade della città. Sophie viene portata in una terra lontana a lei sconosciuta: la terra dei giganti. All’inizio la bambina è terrorizzata perché è sicura che il gigante l’avrebbe mangiata. Ma il gigante che l’ha rapita è vegetariano, gentile e non mangia carne né bambini, solo cetrioli. Inoltre lui non è un mostro, la sua missione è catturare sogni da regalare ai bambini per renderli un po’ più felici. Stando con lui, Sophie scopre con sorpresa che in quella strana terra ci sono altri giganti, nove in tutto, molto più grandi del suo amico ma soprattutto sono cattivi, o�ensivi, pronti, loro sì, a mangiare carne fresca. Il gigante gentile farà di tutto per nascondere Sophie alla cattiveria dei suoi fratelli e a scappare con lei a Londra per incontrare la Regina Elisa-betta, l’unica, secondo Sophie, ad avere il potere di liberare la terra dai giganti cattivi. Ma la Regina crederà a questa strana storia? E riusciranno insieme davvero a liberarsi dei cattivi?
trova, delle regole che le sono state date, ma non si rassegna alla sua condizione. La curiosità, il bisogno di a�etto e di calore umano, il desiderio di scoprire mondi diversi da quello che già conosce la spingono a immaginare, immergendosi nella lettura di libri che divora in maniera segreta sotto le coperte, al buio, come se legge-re/fantasticare fosse l’attività più pericolosa di questo mondo. E che dire della possibilità di scorgere dalla �nestra le luci della strada che appaiono come fantasmi nel buio della notte e scoprire che di notte vive un mondo fantastico, a volte spaventoso, sicuramente strano e proibito? Sophie non vuole sottrarsi a questa possibilità. Come tutti i bambini e le bambine, Sophie si sente attirata e spaventata da ciò che non conosce e prova a fare piccoli passi in avanti per assaporare l’imprevisto. Ma questa volta lo sconosciuto è molto molto più grande di lei ed entra all’improvviso nella sua vita, prima che lei se ne accorgesse, in una scena bellissima in cui il nuovo, lo spaventoso, il meraviglioso l’accoglie nella sua mano gigantesca. È una delle scene simbolo del �lm perché racconta della delicatezza, della dolcezza con cui il magico, il fantastico accoglie la bam-bina e la trasporta in una terra in cui tutto è possibile anche creare sogni e regalarli ai più piccoli. Non è straordi-nario tutto questo? Sì, ma bisogna fare attenzione perché se lasciamo che i piccoli siano troppo liberi nella loro immaginazione, avremmo troppi ribelli nel mondo e questo non piace a chi decide quali debbano essere le regole da seguire. Per questo a un certo punto appaiono i giganti cattivi, i cui nomi ci dicono molto delle loro atroci abilità e abitudini: la loro missione non è tanto quella di mangiare Sophie (piccola com’è non basta a soddisfare l’appetito di nessuno di loro), ma quello di distruggere i sogni. Vomitoso, Strizza-teste, San-Guinario, Inghiotti-cicciaviva, Trita-bimbo, Spella-fanciulle, Scotta-dito sono avidi, violenti, rozzi, ignoranti, stupidi esatta-mente come chiunque usi la violenza per piegare l’altro alla propria volontà. È una lotta impari quella che si viene a creare tra loro e il fratello più piccolo (il nanerottolo lo chiamano) e Sophie. Ma a vincere saranno proprio loro due, i più piccoli, perché hanno armi più intelligenti, più profonde, più ra�nate che sono la gentilezza, l’ami-cizia necessarie per raggiungere obiettivi più alti (non già il riempirsi la pancia) come l’a�ermazione della giusti-zia, l’accettazione delle diversità, il potere dell’immaginazione, la difesa della libertà.
LA GENTILEZZA RENDE GRANDILa gentilezza non è solamente forma, se si riduce a questo diventa ipocrita. La gentilezza di cui ci parla Il GGG è sostanza e coerenza. Basti pensare alla maniera in cui il Gigante Gentile protegge Sophie dai suoi fratelli cattivi o alla maniera in cui difende la sua diversità (è il più basso dei Giganti e per questo deriso) o alla maniera in cui custo-disce il suo dolore più profondo. A un certo punto il GGG mostra a Sophie il vaso in cui ha racchiuso il suo incubo peggiore: dentro ci sono i rimorsi e il dolore per qualcosa da cui non può più tornare indietro ovvero la scomparsa del bambino che per primo era diventato amico del GGG, scoperto e divorato da altri giganti cattivi. Da allora lo scopo del GGG è proteggere tutti i bambini che decide di portare con sé perché nel mondo reale nessuna infan-zia deve essere o�esa, violata, nessun bambino deve diventare vittima delle disattenzioni, delle distrazioni. Sophie per lui diventa quindi il simbolo dell’infanzia, un’età in cui l’idea del mondo che ci si fa, dipende soprat-tutto dai buoni o dai cattivi esempi che si ricevono. Il GGG arriva in un momento particolare della vita della bam-bina: ha dieci anni, che rappresentano un po’ il con�ne tra l’infanzia e la preadolescenza, cioè è una fase in cui il fantastico e il reale assumono dei contorni più chiari e �nalmente ci si può prendere la responsabilità e la libertà di farli comunicare per creare qualcosa di diverso. Magari più giusto… e più divertente. Si, perché un concetto chiaro che Il GGG esprime con forza è che non è vero che se si è gentili si è deboli, s�gati, come dicono alcuni. Al contrario, se si è gentili e leali e amici veri, si fanno esperienze strabilianti come essere invitati dalla Regina e risultare interessanti, originali, divertenti. Di contro chi usa la forza, l’arroganza, la violenza non è per niente �go, anzi è davvero ributtante come i giganti del �lm, ma contro di loro il Gigante Gentile e Sophie non sentono desiderio di vendetta, solo giustizia. Per questo il �nale non vede l’eliminazione del nemico ma viene data loro una specie di punizione “educativa”, ripa-ratoria: vengono mandati su un’altra terra a imparare a coltivare e mangiare cetrionzoli. «La magia ci fa essere intraprendenti – ha detto Spielberg – la speranza viene da lì».
2
Non si arriva a nessuna salvezzasenza essere passati per le tenebre
Steven Spielberg
terri�cante, come in un racconto horror. Anche se, a dire il vero, Il GGG rispetto agli altri libri di Dahl è più tenero, divertente, probabilmente perché l’autore l’ha scritto come una delle tante �abe della buona notte che doveva portare serenità alle sue �glie prima e alle sue nipotine dopo. Forse la più grande di�erenza tra Spielberg e Dahl sta nel fatto che il primo intravvede sempre la luce pur attraversando le tenebre, il secondo la luce non riesce neanche a scorgerla e i suoi racconti spesso lasciano una certa amarezza, una sensazione profondamente legata alla realtà, pur essendo la sua scrittura molto creativa e fantasiosa. Anche qui dobbiamo scomodare l’infanzia e ancor di più l’adolescenza dell’autore, segnate da morti importanti e da un’educazione sin troppo rigida. Dahl ad esempio perse sua madre all’età di soli quattro anni. Per un po’ visse con la nonna che adorava ma a un certo punto suo padre decise di risposarsi e Dahl bambino dovette vivere un’altra separazione dolorosa, quella dalla nonna appunto, per dare posto ad una donna giovane ma autoritaria. Inoltre la scuola che Dahl ragazzino frequentò era un college di buona fama ma in cui l’educazione e la disciplina si trasmettevano attraverso puni-zioni corporali e psicologiche e dominavano gli atti – diremmo oggi – di bullismo feroce, da parte dei ragazzi più grandi verso quelli più piccoli. E Dahl, pur essendo alto già a quindici anni 1 metro e 98 centimetri, non riuscì a sottrarsi alle violente pratiche dei college inglesi di quegli anni. Ma riuscì a resistere. Il suo modo per a�rontare e sopportare la brutalità del college consisteva nel reprimere le emozioni, nel non con�darsi mai con nessuno, chiudendosi anche lui come Spielberg nel silenzio e nella solitudine, più tardi riem-piti dalla loro fervida immaginazione. Anche la vita di Dahl adulto è stata costellata da lutti importanti: a 7 anni muore sua �glia Olivia che ispira la �gura proprio di Sophie per Il GGG. «Fumava sigarette Dunhill, odorava di sapone da barba e aria fresca, aveva la voce calda e famigliare come il rumore di passi su pavimento di legno» ha raccontato al Guardian sua nipote Sophie, �glia di Tessa, secondogenita di Dahl. Sono state le sorelle minori Olivia e Lucy, ad ascoltare per prime, in forma di racconto della buona notte quello che sarebbe stato Il GGG. Quando le bambine andavano a letto il “gigante” Dahl saliva su una scala, prendeva una lunga canna di bambù e giocava a so�are sogni per tutta la stanza. L’idea del gigante che raccoglie sogni chiudendoli in delle scatole per poi o�rirli ai bambini per farli felici durante il sonno, è un’idea che inseguiva da tempo lo scrittore anglo-nor-vegese. Ed è così che i bambini di Dahl sono creature che resistono alle crudeltà dei più grandi, che a�rontano le peggiori di�coltà senza mai abbattersi e senza mai mostrarsi sentimentali, che a�rontano la morte come qualcosa di terribile ma reale. Ad esempio in Matilda vediamo genitori che non capiscono la propria �glia, anzi la detestano perché chiede regole ed educazione, in Willy Wonka i bambini possono scomparire per sempre o tornare a casa dopo molto tempo, in Le streghe i bimbi vengono trasformati in topi e ci rimangono! A Dahl insomma non interessa il lieto �ne, il �nale consolatorio del “vissero tutti felici e contenti”! Ed è per questo che mentre i �lm di Spielberg sono stati sempre ben accolti dal pubblico in tutto il mondo, i libri di Dahl furono molto ostacolati perché considerati volgari, violenti, non adatti ai ragazzi. Nell’unica autobiogra�a autorizzata da Dahl e scritta da Donald Sturrock si racconta di un’editrice orgogliosa di aver ri�utato per due volte di pubbli-care i suoi libri. Ad esempio Eleanor Cameron, autrice per bambini canadese de�nì La fabbrica di cioccolato un libro scadente, di cattivo gusto, sadico e orribile e pericoloso per i bambini. Un’altra scrittrice di fantascienza, Ursula K. Le Guin, scrisse che sua �glia era diventata una villana dopo la lettura de La fabbrica di cioccolato.Oggi fortunatamente i libri di Roald Dahl sono ampiamente apprezzati per la sua scrittura libera, fuori da regole e schemi, ricca di parole inventate (basti pensare a come parla il Grande Gigante Gentile), pervasa da un umori-smo a volte feroce ma divertente, una scrittura così vicina all’immaginazione che ogni bambino ha dentro di sé e così carica di quella sana ribellione utile ad ogni bambino per crescere libero e indipendente.
UNA STRAORDINARIA STORIA DI AMICIZIA Possiamo considerare Il GGG la storia di due solitudini che un giorno si incontrano e, superate le prime di�den-ze, sentono che uno può essere utile all’altro, capiscono che stanno bene insieme perché ognuno ha qualcosa di buono da mettere a disposizione. Ma soprattutto ciò che li incoraggia a darsi una mano, a credere l’uno nell’altro e a farsi accettare per quello che sono, è la gentilezza! E che cos’è la gentilezza se non la via per stare insieme senza farsi male, la via per dialogare con l’altro senza costruire muri e senza sopra�azioni, la via per rispettare la dignità dell’altro, indipendentemente da come si è? La Sophie che conosciamo all’inizio del �lm è una bambina vispa, intelligente, consapevole del posto in cui si

L’INCONTRO TRA DUE GIGANTIPrima o poi sarebbe accaduto: il più grande regista vivente, che ha celebrato in molti suoi �lm l’incanto dell’infa-nzia, ha scelto di trasporre in immagini il romanzo più noto del più bizzarro scrittore per ragazzi che la letteratura abbia mai conosciuto. Stiamo ovviamente parlando di Steven Spielberg e Roald Dahl. Abbiamo ammirato negli anni passati la maniera in cui Spielberg ha raccontato l’infanzia in �lm come E.T., Ai con�ni della realtà, Jurassic Park, A.I. Intelligenza Arti�ciale ma anche in �lm storici come L’impero del sole, Schindler’s list e War Horse. Un’infan- zia segnata dalla necessità di fuggire dal mondo troppo piccolo creato dagli adulti, desiderosa di conoscere l’Altro, di ampliare lo sguardo e soprattutto desiderosa di scoprire il nuovo, il diverso che agli occhi dei bambini è meraviglia dell’universo. Non è un caso che i bambini di Spielberg non sono mai davvero arrabbiati, anche quando subiscono cattiverie da parte degli adulti. Semmai hanno lo sguardo aperto, gli occhi spalancati a volte spaventati ma non per paura quanto per aver colto l’inaspettato, per aver scoperto qualcosa che il mondo reale ha nascosto loro. I bambini di Spielberg insomma sono a loro modo ribelli e positivi, non distruttivi, sono attivi, si muovono nel mondo cercando, esplorando e così costruiscono speranze. D’altronde è l’infanzia stessa dell’auto-re che irrompe sullo schermo: «Non sono stato un bambino felice – racconta Spielberg – quando i miei genitori si sono separati ho so�erto tantissimo, mi sono sentito abbandonato. E questa sensazione dell’abbandono me la sono portata dentro per molto tempo, non solo, ma mi faceva sentire diverso dai miei compagni. A scuola poi, mi sentivo socialmente abbandonato. Non ero popolare. I ragazzi che ammiravo non mi permettevano di giocare con loro. Sono stato solo una comparsa nella mia vita, per molti anni. E questo sentimento ho provato a raccon-tarlo nei miei �lm». Anche Sophie è a suo modo una ribelle. Anzi è la prima cosa che ci viene raccontata di lei: mentre tutti gli altri nell’orfanotro�o dormono, lei legge romanzi e siccome è vietato, lo fa nascondendosi sotto la coperta facendosi luce con una torcia. E il libro che sta leggendo è la storia di altri bambini come lei, orfani, soli e ribelli come tutti i protagonisti dei libri di Dickens. Quando Sophie si avvicina alla �nestra per guardare in strada sa che sta facendo una cosa proibita: «Mai scendere dal letto, mai andare alla �nestra, mai vedere cosa c’è dietro la tenda» sono le regole dette e ripetute dell’orfanotro�o. Regole a cui lei verrà meno, senza ripensamenti. D’altr-onde se non avesse disubbidito non avrebbe mai conosciuto il Grande Gigante Gentile, cioè non avrebbe avuto un amico straordinario seppur immaginario. Sarebbe rimasta nel suo letto, schiacciata dalla solitudine.Anche i bambini raccontati da Roald Dahl sono ribelli, ma in modo diverso rispetto a quelli di Spielberg. Vivono storie decisamente più cattive, più buie, in cui la presenza degli adulti è davvero un peso insopportabile e a tratti
trova, delle regole che le sono state date, ma non si rassegna alla sua condizione. La curiosità, il bisogno di a�etto e di calore umano, il desiderio di scoprire mondi diversi da quello che già conosce la spingono a immaginare, immergendosi nella lettura di libri che divora in maniera segreta sotto le coperte, al buio, come se legge-re/fantasticare fosse l’attività più pericolosa di questo mondo. E che dire della possibilità di scorgere dalla �nestra le luci della strada che appaiono come fantasmi nel buio della notte e scoprire che di notte vive un mondo fantastico, a volte spaventoso, sicuramente strano e proibito? Sophie non vuole sottrarsi a questa possibilità. Come tutti i bambini e le bambine, Sophie si sente attirata e spaventata da ciò che non conosce e prova a fare piccoli passi in avanti per assaporare l’imprevisto. Ma questa volta lo sconosciuto è molto molto più grande di lei ed entra all’improvviso nella sua vita, prima che lei se ne accorgesse, in una scena bellissima in cui il nuovo, lo spaventoso, il meraviglioso l’accoglie nella sua mano gigantesca. È una delle scene simbolo del �lm perché racconta della delicatezza, della dolcezza con cui il magico, il fantastico accoglie la bam-bina e la trasporta in una terra in cui tutto è possibile anche creare sogni e regalarli ai più piccoli. Non è straordi-nario tutto questo? Sì, ma bisogna fare attenzione perché se lasciamo che i piccoli siano troppo liberi nella loro immaginazione, avremmo troppi ribelli nel mondo e questo non piace a chi decide quali debbano essere le regole da seguire. Per questo a un certo punto appaiono i giganti cattivi, i cui nomi ci dicono molto delle loro atroci abilità e abitudini: la loro missione non è tanto quella di mangiare Sophie (piccola com’è non basta a soddisfare l’appetito di nessuno di loro), ma quello di distruggere i sogni. Vomitoso, Strizza-teste, San-Guinario, Inghiotti-cicciaviva, Trita-bimbo, Spella-fanciulle, Scotta-dito sono avidi, violenti, rozzi, ignoranti, stupidi esatta-mente come chiunque usi la violenza per piegare l’altro alla propria volontà. È una lotta impari quella che si viene a creare tra loro e il fratello più piccolo (il nanerottolo lo chiamano) e Sophie. Ma a vincere saranno proprio loro due, i più piccoli, perché hanno armi più intelligenti, più profonde, più ra�nate che sono la gentilezza, l’ami-cizia necessarie per raggiungere obiettivi più alti (non già il riempirsi la pancia) come l’a�ermazione della giusti-zia, l’accettazione delle diversità, il potere dell’immaginazione, la difesa della libertà.
LA GENTILEZZA RENDE GRANDILa gentilezza non è solamente forma, se si riduce a questo diventa ipocrita. La gentilezza di cui ci parla Il GGG è sostanza e coerenza. Basti pensare alla maniera in cui il Gigante Gentile protegge Sophie dai suoi fratelli cattivi o alla maniera in cui difende la sua diversità (è il più basso dei Giganti e per questo deriso) o alla maniera in cui custo-disce il suo dolore più profondo. A un certo punto il GGG mostra a Sophie il vaso in cui ha racchiuso il suo incubo peggiore: dentro ci sono i rimorsi e il dolore per qualcosa da cui non può più tornare indietro ovvero la scomparsa del bambino che per primo era diventato amico del GGG, scoperto e divorato da altri giganti cattivi. Da allora lo scopo del GGG è proteggere tutti i bambini che decide di portare con sé perché nel mondo reale nessuna infan-zia deve essere o�esa, violata, nessun bambino deve diventare vittima delle disattenzioni, delle distrazioni. Sophie per lui diventa quindi il simbolo dell’infanzia, un’età in cui l’idea del mondo che ci si fa, dipende soprat-tutto dai buoni o dai cattivi esempi che si ricevono. Il GGG arriva in un momento particolare della vita della bam-bina: ha dieci anni, che rappresentano un po’ il con�ne tra l’infanzia e la preadolescenza, cioè è una fase in cui il fantastico e il reale assumono dei contorni più chiari e �nalmente ci si può prendere la responsabilità e la libertà di farli comunicare per creare qualcosa di diverso. Magari più giusto… e più divertente. Si, perché un concetto chiaro che Il GGG esprime con forza è che non è vero che se si è gentili si è deboli, s�gati, come dicono alcuni. Al contrario, se si è gentili e leali e amici veri, si fanno esperienze strabilianti come essere invitati dalla Regina e risultare interessanti, originali, divertenti. Di contro chi usa la forza, l’arroganza, la violenza non è per niente �go, anzi è davvero ributtante come i giganti del �lm, ma contro di loro il Gigante Gentile e Sophie non sentono desiderio di vendetta, solo giustizia. Per questo il �nale non vede l’eliminazione del nemico ma viene data loro una specie di punizione “educativa”, ripa-ratoria: vengono mandati su un’altra terra a imparare a coltivare e mangiare cetrionzoli. «La magia ci fa essere intraprendenti – ha detto Spielberg – la speranza viene da lì».
RIFLETTIAMOCI UN PO’…
orizzonti di luceorizzonti di luce 3
terri�cante, come in un racconto horror. Anche se, a dire il vero, Il GGG rispetto agli altri libri di Dahl è più tenero, divertente, probabilmente perché l’autore l’ha scritto come una delle tante �abe della buona notte che doveva portare serenità alle sue �glie prima e alle sue nipotine dopo. Forse la più grande di�erenza tra Spielberg e Dahl sta nel fatto che il primo intravvede sempre la luce pur attraversando le tenebre, il secondo la luce non riesce neanche a scorgerla e i suoi racconti spesso lasciano una certa amarezza, una sensazione profondamente legata alla realtà, pur essendo la sua scrittura molto creativa e fantasiosa. Anche qui dobbiamo scomodare l’infanzia e ancor di più l’adolescenza dell’autore, segnate da morti importanti e da un’educazione sin troppo rigida. Dahl ad esempio perse sua madre all’età di soli quattro anni. Per un po’ visse con la nonna che adorava ma a un certo punto suo padre decise di risposarsi e Dahl bambino dovette vivere un’altra separazione dolorosa, quella dalla nonna appunto, per dare posto ad una donna giovane ma autoritaria. Inoltre la scuola che Dahl ragazzino frequentò era un college di buona fama ma in cui l’educazione e la disciplina si trasmettevano attraverso puni-zioni corporali e psicologiche e dominavano gli atti – diremmo oggi – di bullismo feroce, da parte dei ragazzi più grandi verso quelli più piccoli. E Dahl, pur essendo alto già a quindici anni 1 metro e 98 centimetri, non riuscì a sottrarsi alle violente pratiche dei college inglesi di quegli anni. Ma riuscì a resistere. Il suo modo per a�rontare e sopportare la brutalità del college consisteva nel reprimere le emozioni, nel non con�darsi mai con nessuno, chiudendosi anche lui come Spielberg nel silenzio e nella solitudine, più tardi riem-piti dalla loro fervida immaginazione. Anche la vita di Dahl adulto è stata costellata da lutti importanti: a 7 anni muore sua �glia Olivia che ispira la �gura proprio di Sophie per Il GGG. «Fumava sigarette Dunhill, odorava di sapone da barba e aria fresca, aveva la voce calda e famigliare come il rumore di passi su pavimento di legno» ha raccontato al Guardian sua nipote Sophie, �glia di Tessa, secondogenita di Dahl. Sono state le sorelle minori Olivia e Lucy, ad ascoltare per prime, in forma di racconto della buona notte quello che sarebbe stato Il GGG. Quando le bambine andavano a letto il “gigante” Dahl saliva su una scala, prendeva una lunga canna di bambù e giocava a so�are sogni per tutta la stanza. L’idea del gigante che raccoglie sogni chiudendoli in delle scatole per poi o�rirli ai bambini per farli felici durante il sonno, è un’idea che inseguiva da tempo lo scrittore anglo-nor-vegese. Ed è così che i bambini di Dahl sono creature che resistono alle crudeltà dei più grandi, che a�rontano le peggiori di�coltà senza mai abbattersi e senza mai mostrarsi sentimentali, che a�rontano la morte come qualcosa di terribile ma reale. Ad esempio in Matilda vediamo genitori che non capiscono la propria �glia, anzi la detestano perché chiede regole ed educazione, in Willy Wonka i bambini possono scomparire per sempre o tornare a casa dopo molto tempo, in Le streghe i bimbi vengono trasformati in topi e ci rimangono! A Dahl insomma non interessa il lieto �ne, il �nale consolatorio del “vissero tutti felici e contenti”! Ed è per questo che mentre i �lm di Spielberg sono stati sempre ben accolti dal pubblico in tutto il mondo, i libri di Dahl furono molto ostacolati perché considerati volgari, violenti, non adatti ai ragazzi. Nell’unica autobiogra�a autorizzata da Dahl e scritta da Donald Sturrock si racconta di un’editrice orgogliosa di aver ri�utato per due volte di pubbli-care i suoi libri. Ad esempio Eleanor Cameron, autrice per bambini canadese de�nì La fabbrica di cioccolato un libro scadente, di cattivo gusto, sadico e orribile e pericoloso per i bambini. Un’altra scrittrice di fantascienza, Ursula K. Le Guin, scrisse che sua �glia era diventata una villana dopo la lettura de La fabbrica di cioccolato.Oggi fortunatamente i libri di Roald Dahl sono ampiamente apprezzati per la sua scrittura libera, fuori da regole e schemi, ricca di parole inventate (basti pensare a come parla il Grande Gigante Gentile), pervasa da un umori-smo a volte feroce ma divertente, una scrittura così vicina all’immaginazione che ogni bambino ha dentro di sé e così carica di quella sana ribellione utile ad ogni bambino per crescere libero e indipendente.
UNA STRAORDINARIA STORIA DI AMICIZIA Possiamo considerare Il GGG la storia di due solitudini che un giorno si incontrano e, superate le prime di�den-ze, sentono che uno può essere utile all’altro, capiscono che stanno bene insieme perché ognuno ha qualcosa di buono da mettere a disposizione. Ma soprattutto ciò che li incoraggia a darsi una mano, a credere l’uno nell’altro e a farsi accettare per quello che sono, è la gentilezza! E che cos’è la gentilezza se non la via per stare insieme senza farsi male, la via per dialogare con l’altro senza costruire muri e senza sopra�azioni, la via per rispettare la dignità dell’altro, indipendentemente da come si è? La Sophie che conosciamo all’inizio del �lm è una bambina vispa, intelligente, consapevole del posto in cui si

L’INCONTRO TRA DUE GIGANTIPrima o poi sarebbe accaduto: il più grande regista vivente, che ha celebrato in molti suoi �lm l’incanto dell’infa-nzia, ha scelto di trasporre in immagini il romanzo più noto del più bizzarro scrittore per ragazzi che la letteratura abbia mai conosciuto. Stiamo ovviamente parlando di Steven Spielberg e Roald Dahl. Abbiamo ammirato negli anni passati la maniera in cui Spielberg ha raccontato l’infanzia in �lm come E.T., Ai con�ni della realtà, Jurassic Park, A.I. Intelligenza Arti�ciale ma anche in �lm storici come L’impero del sole, Schindler’s list e War Horse. Un’infan- zia segnata dalla necessità di fuggire dal mondo troppo piccolo creato dagli adulti, desiderosa di conoscere l’Altro, di ampliare lo sguardo e soprattutto desiderosa di scoprire il nuovo, il diverso che agli occhi dei bambini è meraviglia dell’universo. Non è un caso che i bambini di Spielberg non sono mai davvero arrabbiati, anche quando subiscono cattiverie da parte degli adulti. Semmai hanno lo sguardo aperto, gli occhi spalancati a volte spaventati ma non per paura quanto per aver colto l’inaspettato, per aver scoperto qualcosa che il mondo reale ha nascosto loro. I bambini di Spielberg insomma sono a loro modo ribelli e positivi, non distruttivi, sono attivi, si muovono nel mondo cercando, esplorando e così costruiscono speranze. D’altronde è l’infanzia stessa dell’auto-re che irrompe sullo schermo: «Non sono stato un bambino felice – racconta Spielberg – quando i miei genitori si sono separati ho so�erto tantissimo, mi sono sentito abbandonato. E questa sensazione dell’abbandono me la sono portata dentro per molto tempo, non solo, ma mi faceva sentire diverso dai miei compagni. A scuola poi, mi sentivo socialmente abbandonato. Non ero popolare. I ragazzi che ammiravo non mi permettevano di giocare con loro. Sono stato solo una comparsa nella mia vita, per molti anni. E questo sentimento ho provato a raccon-tarlo nei miei �lm». Anche Sophie è a suo modo una ribelle. Anzi è la prima cosa che ci viene raccontata di lei: mentre tutti gli altri nell’orfanotro�o dormono, lei legge romanzi e siccome è vietato, lo fa nascondendosi sotto la coperta facendosi luce con una torcia. E il libro che sta leggendo è la storia di altri bambini come lei, orfani, soli e ribelli come tutti i protagonisti dei libri di Dickens. Quando Sophie si avvicina alla �nestra per guardare in strada sa che sta facendo una cosa proibita: «Mai scendere dal letto, mai andare alla �nestra, mai vedere cosa c’è dietro la tenda» sono le regole dette e ripetute dell’orfanotro�o. Regole a cui lei verrà meno, senza ripensamenti. D’altr-onde se non avesse disubbidito non avrebbe mai conosciuto il Grande Gigante Gentile, cioè non avrebbe avuto un amico straordinario seppur immaginario. Sarebbe rimasta nel suo letto, schiacciata dalla solitudine.Anche i bambini raccontati da Roald Dahl sono ribelli, ma in modo diverso rispetto a quelli di Spielberg. Vivono storie decisamente più cattive, più buie, in cui la presenza degli adulti è davvero un peso insopportabile e a tratti
trova, delle regole che le sono state date, ma non si rassegna alla sua condizione. La curiosità, il bisogno di a�etto e di calore umano, il desiderio di scoprire mondi diversi da quello che già conosce la spingono a immaginare, immergendosi nella lettura di libri che divora in maniera segreta sotto le coperte, al buio, come se legge-re/fantasticare fosse l’attività più pericolosa di questo mondo. E che dire della possibilità di scorgere dalla �nestra le luci della strada che appaiono come fantasmi nel buio della notte e scoprire che di notte vive un mondo fantastico, a volte spaventoso, sicuramente strano e proibito? Sophie non vuole sottrarsi a questa possibilità. Come tutti i bambini e le bambine, Sophie si sente attirata e spaventata da ciò che non conosce e prova a fare piccoli passi in avanti per assaporare l’imprevisto. Ma questa volta lo sconosciuto è molto molto più grande di lei ed entra all’improvviso nella sua vita, prima che lei se ne accorgesse, in una scena bellissima in cui il nuovo, lo spaventoso, il meraviglioso l’accoglie nella sua mano gigantesca. È una delle scene simbolo del �lm perché racconta della delicatezza, della dolcezza con cui il magico, il fantastico accoglie la bam-bina e la trasporta in una terra in cui tutto è possibile anche creare sogni e regalarli ai più piccoli. Non è straordi-nario tutto questo? Sì, ma bisogna fare attenzione perché se lasciamo che i piccoli siano troppo liberi nella loro immaginazione, avremmo troppi ribelli nel mondo e questo non piace a chi decide quali debbano essere le regole da seguire. Per questo a un certo punto appaiono i giganti cattivi, i cui nomi ci dicono molto delle loro atroci abilità e abitudini: la loro missione non è tanto quella di mangiare Sophie (piccola com’è non basta a soddisfare l’appetito di nessuno di loro), ma quello di distruggere i sogni. Vomitoso, Strizza-teste, San-Guinario, Inghiotti-cicciaviva, Trita-bimbo, Spella-fanciulle, Scotta-dito sono avidi, violenti, rozzi, ignoranti, stupidi esatta-mente come chiunque usi la violenza per piegare l’altro alla propria volontà. È una lotta impari quella che si viene a creare tra loro e il fratello più piccolo (il nanerottolo lo chiamano) e Sophie. Ma a vincere saranno proprio loro due, i più piccoli, perché hanno armi più intelligenti, più profonde, più ra�nate che sono la gentilezza, l’ami-cizia necessarie per raggiungere obiettivi più alti (non già il riempirsi la pancia) come l’a�ermazione della giusti-zia, l’accettazione delle diversità, il potere dell’immaginazione, la difesa della libertà.
LA GENTILEZZA RENDE GRANDILa gentilezza non è solamente forma, se si riduce a questo diventa ipocrita. La gentilezza di cui ci parla Il GGG è sostanza e coerenza. Basti pensare alla maniera in cui il Gigante Gentile protegge Sophie dai suoi fratelli cattivi o alla maniera in cui difende la sua diversità (è il più basso dei Giganti e per questo deriso) o alla maniera in cui custo-disce il suo dolore più profondo. A un certo punto il GGG mostra a Sophie il vaso in cui ha racchiuso il suo incubo peggiore: dentro ci sono i rimorsi e il dolore per qualcosa da cui non può più tornare indietro ovvero la scomparsa del bambino che per primo era diventato amico del GGG, scoperto e divorato da altri giganti cattivi. Da allora lo scopo del GGG è proteggere tutti i bambini che decide di portare con sé perché nel mondo reale nessuna infan-zia deve essere o�esa, violata, nessun bambino deve diventare vittima delle disattenzioni, delle distrazioni. Sophie per lui diventa quindi il simbolo dell’infanzia, un’età in cui l’idea del mondo che ci si fa, dipende soprat-tutto dai buoni o dai cattivi esempi che si ricevono. Il GGG arriva in un momento particolare della vita della bam-bina: ha dieci anni, che rappresentano un po’ il con�ne tra l’infanzia e la preadolescenza, cioè è una fase in cui il fantastico e il reale assumono dei contorni più chiari e �nalmente ci si può prendere la responsabilità e la libertà di farli comunicare per creare qualcosa di diverso. Magari più giusto… e più divertente. Si, perché un concetto chiaro che Il GGG esprime con forza è che non è vero che se si è gentili si è deboli, s�gati, come dicono alcuni. Al contrario, se si è gentili e leali e amici veri, si fanno esperienze strabilianti come essere invitati dalla Regina e risultare interessanti, originali, divertenti. Di contro chi usa la forza, l’arroganza, la violenza non è per niente �go, anzi è davvero ributtante come i giganti del �lm, ma contro di loro il Gigante Gentile e Sophie non sentono desiderio di vendetta, solo giustizia. Per questo il �nale non vede l’eliminazione del nemico ma viene data loro una specie di punizione “educativa”, ripa-ratoria: vengono mandati su un’altra terra a imparare a coltivare e mangiare cetrionzoli. «La magia ci fa essere intraprendenti – ha detto Spielberg – la speranza viene da lì».
Seven Spileberg nasce il 18 dicembre del 1946 dall'ingegnere elettrico Arnold Spielberg e dalla pianista concertista Leah Adler. La sua famiglia, di origine ebraica, vive per qualche
tempo nel New Jersey, poi si trasferisce a Scottsdale, in Arizona, dove Steven cresce. Desti-nato a diventare uno dei più grandi registi del suo tempo, Spielberg rimane l'unico tra i maggiori cineasti della sua generazione – a cominciare da George Lucas, amico di una vita – a non avere alle spalle studi universitari di cinematogra�a. Sostituisce però la
scuola con una pratica da autodidatta cominciata �n da ragazzino quando i genitori gli a�dano l'uso di una cinepresa ad 8 mm per registrare le gite di famiglia. In realtà, oltre alle
gite, il giovane Steven prende l'abitudine di girare �lmetti a soggetto in cui dà già prova della sua propensione per il fantastico e del suo gusto per gli e�etti speciali. Uno di questi �lmetti, Escape to Nowhere, vince un concor-so cineamatoriale; un altro, il fantascienti�co Firelight viene proiettato in una sala e incassa 500 dollari. Da giova-ne comincia a frequentare gli studi della Universal e la leggenda vuole che vi si sia introdotto allestendo clande-stinamente un u�cio nei locali vuoti di una portineria, e che i custodi, ai quali si presenta sempre in giacca e cravatta, lo lasciassero passare credendolo di casa. In ogni modo, Spielberg non riesce a far vedere le sue prime prove a qualcuno che conti e solo quando Amblin', il suo primo �lm in 35 mm, un cortometraggio di 24 minuti, vince premi al Festival di Venice e di Atlanta, la Universal si accorge di lui e lo mette sotto contratto nella sua sezione televisiva. Per la TV, nel 1971, gira Duel che è considerato a tutti gli e�etti il primo �lm di Spielberg. In questo primo �lm si vedono già le caratteristiche della sua narrazione: la propensione agli e�etti speciali e il tema l'uomo comune che si trova a misurarsi con circostanze eccezionali e a tirare fuori l'eroismo che non pensa-va di avere. Il �lm diventerà un cult per l'eccezionalità dell'essere stato girato in soli tredici giorni. Nel 1974 gira The Sugarland Express: road movie ispirato a un fatto di cronaca, racconta la tragica fuga attraverso il Texas di un evaso e di sua moglie, i quali corrono a riprendersi il �glioletto dato in adozione; con questo lavoro il regista ottiene il premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes, ma non un grande successo di pubblico, probabilmente per i toni troppo cupi e drammatici della pellicola. Un anno più tardi, con Lo squalo, si fa conosce-re al grande pubblico; nonostante le di�coltà legate alla sua inesperienza, a un malfunzionante squalo mecca-nico, alle di�coltà climatiche che lasciano pochissime ore al giorno per le riprese in esterni (in mare aperto) il �lm è campione d'incassi (470 milioni di dollari), vince tre Oscar, e causa addirittura una sorta di psicosi colletti-va, tanto da far registrare un calo di turisti nelle località balneari. Nel '77 ottiene un altro clamoroso successo con Incontri ravvicinati del terzo tipo e di fatto riscrive le regole del genere fantascienti�co, che volevano gli alieni nei panni dei mostruosi conquistatori, dandone una visione assai più benevola, "umanizzante". Con questo �lm ottiene la prima nomination agli Oscar, per la miglior regia. Dopo lo scarso successo di 1941: allarme a Hollywood (1979), commedia sull'isteria collettiva antigiapponese che si di�use in America dopo Pearl Harbor, torna ad incassi da record nel 1980 con I predatori dell'arca perduta, scaturito da un'idea sviluppata insieme a George Lucas (reduce dall'enorme successo della saga di Guerre Stellari), con cui nasce il personaggio dell'avventuroso archeologo Indiana Jones, che Spielberg riprenderà nell'84 (Indiana Jones e il tempio maledetto) e nell'89 (India-na Jones e l'ultima crociata). Nel frattempo torna alla fantascienza con un �lm che meglio di altri rappresenta la sua idea di cinema come strumento per accendere sogni, stupori, fantasie: E.T. L'extraterrestre del 1982, storia del piccolo alieno dimenticato dalla sua astronave, solo e smarrito sulla Terra: è così che batte tutti i record d'incasso della storia del cinema. La pellicola vale al regista la terza nomination agli Oscar. A partire dal 1982 Spielberg comincia a occuparsi anche di produzione e fonda la Amblin Entertainment (in omaggio al titolo del suo primo cortometraggio) assieme ai colleghi Kathleen Kennedy e Frank Marshall: la casa produce �lm campioni di incassi come la trilogia di Ritorno al futuro di Robert Zemeckis. Nel 1985 gira Il colore viola, storia tratta da un romanzo di Alice Walzer che racconta di una donna di colore salvata dai maltrattamenti del marito grazie ad un'amica. Del 1987 è L'impero del Sole, in cui racconta le vicissitudini di un bambino inglese che, al momento dell'occupazione giapponese di Shangai nel '41, perde i genitori e si ritrova a trascorrere gli anni della guerra da solo, passando da un campo di prigionia all'altro. Dopo il romantico Always – Per sempre (1988), in cui recita anche Audrey Hepburn, gli anni 90 si aprono con il ritorno di Spielberg al genere fantasy: Hook – Capitan Uncino (1991), in cui immagina un Peter Pan sposato e con �gli, e tuttavia coinvolto in misteriose avventure: il �lm ha un chiaro riferi-mento alle dinamiche di relazione fra adulti e ragazzi, fra genitori e �gli, e quindi ad una componente autobio-
orizzonti di luceorizzonti di luce 4
RIFLETTIAMOCI UN PO’…
gra�ca. Ma è soprattutto con Jurassic Park (1993), che avviene la consacrazione a re del genere fantascienti�co e il raggiungimento di un nuovo record storico di incassi. Non ancora terminata la post produzione di quel �lm, Spielberg si lancia nell'avventura di Schindler's List (1994), in cui riesce a raccontare la tragedia dell'olocausto attraverso l'itinerario umano e morale di un imprenditore iscritto al partito nazista, che si ritrova a mettere in salvo migliaia di ebrei dapprima quasi per caso, poi con consapevolezza e dedizione sempre maggiori. Con Schindler's List, vince sia il premio per il miglior �lm sia quello per la miglior regia. Spielberg è particolarmente legato a questa sua opera, essendo lui stesso di origini ebraiche e avendo provato sulla propria pelle, soprattut-to in gioventù, gravi episodi di discriminazioni, come ricorda in numerose interviste. Dopo questo enorme successo dà un seguito a Jurassic Park con Il mondo perduto (1997) e realizza Amistad (1997) – storia della rivolta di un gruppo di neri contro l'equipaggio della nave che, nel 1839, li porta da Cuba agli Stati Uniti per venderli come schiavi. Nel 1998 è la volta di Salvate il soldato Ryan con quest'ultimo �lm, ottiene anche il suo secondo Oscar come miglior regista, ma la pellicola ne ottiene altri quattro per la fotogra�a, il montaggio, il sonoro e gli e�etti sonori. Nel 2002 esce Minority Report, tratto dall'omonimo romanzo di P. K. Dick, interpretato, fra gli altri, da Tom Cruise e arricchito da echi di Kubrick e Hitchcock. Sempre del 2002 è Prova a prendermi, con Leonardo Di Caprio. Nel 2004 dirige The Terminal con Tom Hanks, ispirato alla vera storia del rifugiato iraniano Mehran Nasseri bloccato all'aeroporto di Parigi. Del 2005 è, invece, La guerra dei mondi – girato in soli tre mesi sgomberando un intero quartiere di una cittadina del New Jersey – in cui il regista torna a collaborare con Tom Cruise: l'atmosfera cupa e drammatica del �lm è certamente ancora in�uenzata dai fatti dell'11 settembre. Sempre di un episodio terroristico racconta anche Munich, grande successo dello stesso anno, ispirato al terribile massacro di israeliani perpetrato durante i Giochi Olimpici di Monaco '72 e la cui ossatura è costituita dall'adattamento del libro-in-chiesta del giornalista canadese George Jonas. Nel 2008 Spielberg torna al passato girando il quarto episodio di "Indiana Jones”. Nel 2011 decide invece di misurarsi con la spettacolare animazione in 3D con Le avventure di Tintin: il segreto dell'unicorno. Nel 2012 è di nuovo un tema politico e storico a ispirarlo: la biogra�a del presiden-te degli Stati Uniti che abolì la schiavitù cambiando la storia per sempre Lincoln. Del 2015 è Il ponte delle spie. Il GGG è il suo ultimo �lm.
terri�cante, come in un racconto horror. Anche se, a dire il vero, Il GGG rispetto agli altri libri di Dahl è più tenero, divertente, probabilmente perché l’autore l’ha scritto come una delle tante �abe della buona notte che doveva portare serenità alle sue �glie prima e alle sue nipotine dopo. Forse la più grande di�erenza tra Spielberg e Dahl sta nel fatto che il primo intravvede sempre la luce pur attraversando le tenebre, il secondo la luce non riesce neanche a scorgerla e i suoi racconti spesso lasciano una certa amarezza, una sensazione profondamente legata alla realtà, pur essendo la sua scrittura molto creativa e fantasiosa. Anche qui dobbiamo scomodare l’infanzia e ancor di più l’adolescenza dell’autore, segnate da morti importanti e da un’educazione sin troppo rigida. Dahl ad esempio perse sua madre all’età di soli quattro anni. Per un po’ visse con la nonna che adorava ma a un certo punto suo padre decise di risposarsi e Dahl bambino dovette vivere un’altra separazione dolorosa, quella dalla nonna appunto, per dare posto ad una donna giovane ma autoritaria. Inoltre la scuola che Dahl ragazzino frequentò era un college di buona fama ma in cui l’educazione e la disciplina si trasmettevano attraverso puni-zioni corporali e psicologiche e dominavano gli atti – diremmo oggi – di bullismo feroce, da parte dei ragazzi più grandi verso quelli più piccoli. E Dahl, pur essendo alto già a quindici anni 1 metro e 98 centimetri, non riuscì a sottrarsi alle violente pratiche dei college inglesi di quegli anni. Ma riuscì a resistere. Il suo modo per a�rontare e sopportare la brutalità del college consisteva nel reprimere le emozioni, nel non con�darsi mai con nessuno, chiudendosi anche lui come Spielberg nel silenzio e nella solitudine, più tardi riem-piti dalla loro fervida immaginazione. Anche la vita di Dahl adulto è stata costellata da lutti importanti: a 7 anni muore sua �glia Olivia che ispira la �gura proprio di Sophie per Il GGG. «Fumava sigarette Dunhill, odorava di sapone da barba e aria fresca, aveva la voce calda e famigliare come il rumore di passi su pavimento di legno» ha raccontato al Guardian sua nipote Sophie, �glia di Tessa, secondogenita di Dahl. Sono state le sorelle minori Olivia e Lucy, ad ascoltare per prime, in forma di racconto della buona notte quello che sarebbe stato Il GGG. Quando le bambine andavano a letto il “gigante” Dahl saliva su una scala, prendeva una lunga canna di bambù e giocava a so�are sogni per tutta la stanza. L’idea del gigante che raccoglie sogni chiudendoli in delle scatole per poi o�rirli ai bambini per farli felici durante il sonno, è un’idea che inseguiva da tempo lo scrittore anglo-nor-vegese. Ed è così che i bambini di Dahl sono creature che resistono alle crudeltà dei più grandi, che a�rontano le peggiori di�coltà senza mai abbattersi e senza mai mostrarsi sentimentali, che a�rontano la morte come qualcosa di terribile ma reale. Ad esempio in Matilda vediamo genitori che non capiscono la propria �glia, anzi la detestano perché chiede regole ed educazione, in Willy Wonka i bambini possono scomparire per sempre o tornare a casa dopo molto tempo, in Le streghe i bimbi vengono trasformati in topi e ci rimangono! A Dahl insomma non interessa il lieto �ne, il �nale consolatorio del “vissero tutti felici e contenti”! Ed è per questo che mentre i �lm di Spielberg sono stati sempre ben accolti dal pubblico in tutto il mondo, i libri di Dahl furono molto ostacolati perché considerati volgari, violenti, non adatti ai ragazzi. Nell’unica autobiogra�a autorizzata da Dahl e scritta da Donald Sturrock si racconta di un’editrice orgogliosa di aver ri�utato per due volte di pubbli-care i suoi libri. Ad esempio Eleanor Cameron, autrice per bambini canadese de�nì La fabbrica di cioccolato un libro scadente, di cattivo gusto, sadico e orribile e pericoloso per i bambini. Un’altra scrittrice di fantascienza, Ursula K. Le Guin, scrisse che sua �glia era diventata una villana dopo la lettura de La fabbrica di cioccolato.Oggi fortunatamente i libri di Roald Dahl sono ampiamente apprezzati per la sua scrittura libera, fuori da regole e schemi, ricca di parole inventate (basti pensare a come parla il Grande Gigante Gentile), pervasa da un umori-smo a volte feroce ma divertente, una scrittura così vicina all’immaginazione che ogni bambino ha dentro di sé e così carica di quella sana ribellione utile ad ogni bambino per crescere libero e indipendente.
UNA STRAORDINARIA STORIA DI AMICIZIA Possiamo considerare Il GGG la storia di due solitudini che un giorno si incontrano e, superate le prime di�den-ze, sentono che uno può essere utile all’altro, capiscono che stanno bene insieme perché ognuno ha qualcosa di buono da mettere a disposizione. Ma soprattutto ciò che li incoraggia a darsi una mano, a credere l’uno nell’altro e a farsi accettare per quello che sono, è la gentilezza! E che cos’è la gentilezza se non la via per stare insieme senza farsi male, la via per dialogare con l’altro senza costruire muri e senza sopra�azioni, la via per rispettare la dignità dell’altro, indipendentemente da come si è? La Sophie che conosciamo all’inizio del �lm è una bambina vispa, intelligente, consapevole del posto in cui si

L’INCONTRO TRA DUE GIGANTIPrima o poi sarebbe accaduto: il più grande regista vivente, che ha celebrato in molti suoi �lm l’incanto dell’infa-nzia, ha scelto di trasporre in immagini il romanzo più noto del più bizzarro scrittore per ragazzi che la letteratura abbia mai conosciuto. Stiamo ovviamente parlando di Steven Spielberg e Roald Dahl. Abbiamo ammirato negli anni passati la maniera in cui Spielberg ha raccontato l’infanzia in �lm come E.T., Ai con�ni della realtà, Jurassic Park, A.I. Intelligenza Arti�ciale ma anche in �lm storici come L’impero del sole, Schindler’s list e War Horse. Un’infan- zia segnata dalla necessità di fuggire dal mondo troppo piccolo creato dagli adulti, desiderosa di conoscere l’Altro, di ampliare lo sguardo e soprattutto desiderosa di scoprire il nuovo, il diverso che agli occhi dei bambini è meraviglia dell’universo. Non è un caso che i bambini di Spielberg non sono mai davvero arrabbiati, anche quando subiscono cattiverie da parte degli adulti. Semmai hanno lo sguardo aperto, gli occhi spalancati a volte spaventati ma non per paura quanto per aver colto l’inaspettato, per aver scoperto qualcosa che il mondo reale ha nascosto loro. I bambini di Spielberg insomma sono a loro modo ribelli e positivi, non distruttivi, sono attivi, si muovono nel mondo cercando, esplorando e così costruiscono speranze. D’altronde è l’infanzia stessa dell’auto-re che irrompe sullo schermo: «Non sono stato un bambino felice – racconta Spielberg – quando i miei genitori si sono separati ho so�erto tantissimo, mi sono sentito abbandonato. E questa sensazione dell’abbandono me la sono portata dentro per molto tempo, non solo, ma mi faceva sentire diverso dai miei compagni. A scuola poi, mi sentivo socialmente abbandonato. Non ero popolare. I ragazzi che ammiravo non mi permettevano di giocare con loro. Sono stato solo una comparsa nella mia vita, per molti anni. E questo sentimento ho provato a raccon-tarlo nei miei �lm». Anche Sophie è a suo modo una ribelle. Anzi è la prima cosa che ci viene raccontata di lei: mentre tutti gli altri nell’orfanotro�o dormono, lei legge romanzi e siccome è vietato, lo fa nascondendosi sotto la coperta facendosi luce con una torcia. E il libro che sta leggendo è la storia di altri bambini come lei, orfani, soli e ribelli come tutti i protagonisti dei libri di Dickens. Quando Sophie si avvicina alla �nestra per guardare in strada sa che sta facendo una cosa proibita: «Mai scendere dal letto, mai andare alla �nestra, mai vedere cosa c’è dietro la tenda» sono le regole dette e ripetute dell’orfanotro�o. Regole a cui lei verrà meno, senza ripensamenti. D’altr-onde se non avesse disubbidito non avrebbe mai conosciuto il Grande Gigante Gentile, cioè non avrebbe avuto un amico straordinario seppur immaginario. Sarebbe rimasta nel suo letto, schiacciata dalla solitudine.Anche i bambini raccontati da Roald Dahl sono ribelli, ma in modo diverso rispetto a quelli di Spielberg. Vivono storie decisamente più cattive, più buie, in cui la presenza degli adulti è davvero un peso insopportabile e a tratti
trova, delle regole che le sono state date, ma non si rassegna alla sua condizione. La curiosità, il bisogno di a�etto e di calore umano, il desiderio di scoprire mondi diversi da quello che già conosce la spingono a immaginare, immergendosi nella lettura di libri che divora in maniera segreta sotto le coperte, al buio, come se legge-re/fantasticare fosse l’attività più pericolosa di questo mondo. E che dire della possibilità di scorgere dalla �nestra le luci della strada che appaiono come fantasmi nel buio della notte e scoprire che di notte vive un mondo fantastico, a volte spaventoso, sicuramente strano e proibito? Sophie non vuole sottrarsi a questa possibilità. Come tutti i bambini e le bambine, Sophie si sente attirata e spaventata da ciò che non conosce e prova a fare piccoli passi in avanti per assaporare l’imprevisto. Ma questa volta lo sconosciuto è molto molto più grande di lei ed entra all’improvviso nella sua vita, prima che lei se ne accorgesse, in una scena bellissima in cui il nuovo, lo spaventoso, il meraviglioso l’accoglie nella sua mano gigantesca. È una delle scene simbolo del �lm perché racconta della delicatezza, della dolcezza con cui il magico, il fantastico accoglie la bam-bina e la trasporta in una terra in cui tutto è possibile anche creare sogni e regalarli ai più piccoli. Non è straordi-nario tutto questo? Sì, ma bisogna fare attenzione perché se lasciamo che i piccoli siano troppo liberi nella loro immaginazione, avremmo troppi ribelli nel mondo e questo non piace a chi decide quali debbano essere le regole da seguire. Per questo a un certo punto appaiono i giganti cattivi, i cui nomi ci dicono molto delle loro atroci abilità e abitudini: la loro missione non è tanto quella di mangiare Sophie (piccola com’è non basta a soddisfare l’appetito di nessuno di loro), ma quello di distruggere i sogni. Vomitoso, Strizza-teste, San-Guinario, Inghiotti-cicciaviva, Trita-bimbo, Spella-fanciulle, Scotta-dito sono avidi, violenti, rozzi, ignoranti, stupidi esatta-mente come chiunque usi la violenza per piegare l’altro alla propria volontà. È una lotta impari quella che si viene a creare tra loro e il fratello più piccolo (il nanerottolo lo chiamano) e Sophie. Ma a vincere saranno proprio loro due, i più piccoli, perché hanno armi più intelligenti, più profonde, più ra�nate che sono la gentilezza, l’ami-cizia necessarie per raggiungere obiettivi più alti (non già il riempirsi la pancia) come l’a�ermazione della giusti-zia, l’accettazione delle diversità, il potere dell’immaginazione, la difesa della libertà.
LA GENTILEZZA RENDE GRANDILa gentilezza non è solamente forma, se si riduce a questo diventa ipocrita. La gentilezza di cui ci parla Il GGG è sostanza e coerenza. Basti pensare alla maniera in cui il Gigante Gentile protegge Sophie dai suoi fratelli cattivi o alla maniera in cui difende la sua diversità (è il più basso dei Giganti e per questo deriso) o alla maniera in cui custo-disce il suo dolore più profondo. A un certo punto il GGG mostra a Sophie il vaso in cui ha racchiuso il suo incubo peggiore: dentro ci sono i rimorsi e il dolore per qualcosa da cui non può più tornare indietro ovvero la scomparsa del bambino che per primo era diventato amico del GGG, scoperto e divorato da altri giganti cattivi. Da allora lo scopo del GGG è proteggere tutti i bambini che decide di portare con sé perché nel mondo reale nessuna infan-zia deve essere o�esa, violata, nessun bambino deve diventare vittima delle disattenzioni, delle distrazioni. Sophie per lui diventa quindi il simbolo dell’infanzia, un’età in cui l’idea del mondo che ci si fa, dipende soprat-tutto dai buoni o dai cattivi esempi che si ricevono. Il GGG arriva in un momento particolare della vita della bam-bina: ha dieci anni, che rappresentano un po’ il con�ne tra l’infanzia e la preadolescenza, cioè è una fase in cui il fantastico e il reale assumono dei contorni più chiari e �nalmente ci si può prendere la responsabilità e la libertà di farli comunicare per creare qualcosa di diverso. Magari più giusto… e più divertente. Si, perché un concetto chiaro che Il GGG esprime con forza è che non è vero che se si è gentili si è deboli, s�gati, come dicono alcuni. Al contrario, se si è gentili e leali e amici veri, si fanno esperienze strabilianti come essere invitati dalla Regina e risultare interessanti, originali, divertenti. Di contro chi usa la forza, l’arroganza, la violenza non è per niente �go, anzi è davvero ributtante come i giganti del �lm, ma contro di loro il Gigante Gentile e Sophie non sentono desiderio di vendetta, solo giustizia. Per questo il �nale non vede l’eliminazione del nemico ma viene data loro una specie di punizione “educativa”, ripa-ratoria: vengono mandati su un’altra terra a imparare a coltivare e mangiare cetrionzoli. «La magia ci fa essere intraprendenti – ha detto Spielberg – la speranza viene da lì».
Seven Spileberg nasce il 18 dicembre del 1946 dall'ingegnere elettrico Arnold Spielberg e dalla pianista concertista Leah Adler. La sua famiglia, di origine ebraica, vive per qualche
tempo nel New Jersey, poi si trasferisce a Scottsdale, in Arizona, dove Steven cresce. Desti-nato a diventare uno dei più grandi registi del suo tempo, Spielberg rimane l'unico tra i maggiori cineasti della sua generazione – a cominciare da George Lucas, amico di una vita – a non avere alle spalle studi universitari di cinematogra�a. Sostituisce però la
scuola con una pratica da autodidatta cominciata �n da ragazzino quando i genitori gli a�dano l'uso di una cinepresa ad 8 mm per registrare le gite di famiglia. In realtà, oltre alle
gite, il giovane Steven prende l'abitudine di girare �lmetti a soggetto in cui dà già prova della sua propensione per il fantastico e del suo gusto per gli e�etti speciali. Uno di questi �lmetti, Escape to Nowhere, vince un concor-so cineamatoriale; un altro, il fantascienti�co Firelight viene proiettato in una sala e incassa 500 dollari. Da giova-ne comincia a frequentare gli studi della Universal e la leggenda vuole che vi si sia introdotto allestendo clande-stinamente un u�cio nei locali vuoti di una portineria, e che i custodi, ai quali si presenta sempre in giacca e cravatta, lo lasciassero passare credendolo di casa. In ogni modo, Spielberg non riesce a far vedere le sue prime prove a qualcuno che conti e solo quando Amblin', il suo primo �lm in 35 mm, un cortometraggio di 24 minuti, vince premi al Festival di Venice e di Atlanta, la Universal si accorge di lui e lo mette sotto contratto nella sua sezione televisiva. Per la TV, nel 1971, gira Duel che è considerato a tutti gli e�etti il primo �lm di Spielberg. In questo primo �lm si vedono già le caratteristiche della sua narrazione: la propensione agli e�etti speciali e il tema l'uomo comune che si trova a misurarsi con circostanze eccezionali e a tirare fuori l'eroismo che non pensa-va di avere. Il �lm diventerà un cult per l'eccezionalità dell'essere stato girato in soli tredici giorni. Nel 1974 gira The Sugarland Express: road movie ispirato a un fatto di cronaca, racconta la tragica fuga attraverso il Texas di un evaso e di sua moglie, i quali corrono a riprendersi il �glioletto dato in adozione; con questo lavoro il regista ottiene il premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes, ma non un grande successo di pubblico, probabilmente per i toni troppo cupi e drammatici della pellicola. Un anno più tardi, con Lo squalo, si fa conosce-re al grande pubblico; nonostante le di�coltà legate alla sua inesperienza, a un malfunzionante squalo mecca-nico, alle di�coltà climatiche che lasciano pochissime ore al giorno per le riprese in esterni (in mare aperto) il �lm è campione d'incassi (470 milioni di dollari), vince tre Oscar, e causa addirittura una sorta di psicosi colletti-va, tanto da far registrare un calo di turisti nelle località balneari. Nel '77 ottiene un altro clamoroso successo con Incontri ravvicinati del terzo tipo e di fatto riscrive le regole del genere fantascienti�co, che volevano gli alieni nei panni dei mostruosi conquistatori, dandone una visione assai più benevola, "umanizzante". Con questo �lm ottiene la prima nomination agli Oscar, per la miglior regia. Dopo lo scarso successo di 1941: allarme a Hollywood (1979), commedia sull'isteria collettiva antigiapponese che si di�use in America dopo Pearl Harbor, torna ad incassi da record nel 1980 con I predatori dell'arca perduta, scaturito da un'idea sviluppata insieme a George Lucas (reduce dall'enorme successo della saga di Guerre Stellari), con cui nasce il personaggio dell'avventuroso archeologo Indiana Jones, che Spielberg riprenderà nell'84 (Indiana Jones e il tempio maledetto) e nell'89 (India-na Jones e l'ultima crociata). Nel frattempo torna alla fantascienza con un �lm che meglio di altri rappresenta la sua idea di cinema come strumento per accendere sogni, stupori, fantasie: E.T. L'extraterrestre del 1982, storia del piccolo alieno dimenticato dalla sua astronave, solo e smarrito sulla Terra: è così che batte tutti i record d'incasso della storia del cinema. La pellicola vale al regista la terza nomination agli Oscar. A partire dal 1982 Spielberg comincia a occuparsi anche di produzione e fonda la Amblin Entertainment (in omaggio al titolo del suo primo cortometraggio) assieme ai colleghi Kathleen Kennedy e Frank Marshall: la casa produce �lm campioni di incassi come la trilogia di Ritorno al futuro di Robert Zemeckis. Nel 1985 gira Il colore viola, storia tratta da un romanzo di Alice Walzer che racconta di una donna di colore salvata dai maltrattamenti del marito grazie ad un'amica. Del 1987 è L'impero del Sole, in cui racconta le vicissitudini di un bambino inglese che, al momento dell'occupazione giapponese di Shangai nel '41, perde i genitori e si ritrova a trascorrere gli anni della guerra da solo, passando da un campo di prigionia all'altro. Dopo il romantico Always – Per sempre (1988), in cui recita anche Audrey Hepburn, gli anni 90 si aprono con il ritorno di Spielberg al genere fantasy: Hook – Capitan Uncino (1991), in cui immagina un Peter Pan sposato e con �gli, e tuttavia coinvolto in misteriose avventure: il �lm ha un chiaro riferi-mento alle dinamiche di relazione fra adulti e ragazzi, fra genitori e �gli, e quindi ad una componente autobio-
orizzonti di luceorizzonti di luce 5
RIFLETTIAMOCI UN PO’…
gra�ca. Ma è soprattutto con Jurassic Park (1993), che avviene la consacrazione a re del genere fantascienti�co e il raggiungimento di un nuovo record storico di incassi. Non ancora terminata la post produzione di quel �lm, Spielberg si lancia nell'avventura di Schindler's List (1994), in cui riesce a raccontare la tragedia dell'olocausto attraverso l'itinerario umano e morale di un imprenditore iscritto al partito nazista, che si ritrova a mettere in salvo migliaia di ebrei dapprima quasi per caso, poi con consapevolezza e dedizione sempre maggiori. Con Schindler's List, vince sia il premio per il miglior �lm sia quello per la miglior regia. Spielberg è particolarmente legato a questa sua opera, essendo lui stesso di origini ebraiche e avendo provato sulla propria pelle, soprattut-to in gioventù, gravi episodi di discriminazioni, come ricorda in numerose interviste. Dopo questo enorme successo dà un seguito a Jurassic Park con Il mondo perduto (1997) e realizza Amistad (1997) – storia della rivolta di un gruppo di neri contro l'equipaggio della nave che, nel 1839, li porta da Cuba agli Stati Uniti per venderli come schiavi. Nel 1998 è la volta di Salvate il soldato Ryan con quest'ultimo �lm, ottiene anche il suo secondo Oscar come miglior regista, ma la pellicola ne ottiene altri quattro per la fotogra�a, il montaggio, il sonoro e gli e�etti sonori. Nel 2002 esce Minority Report, tratto dall'omonimo romanzo di P. K. Dick, interpretato, fra gli altri, da Tom Cruise e arricchito da echi di Kubrick e Hitchcock. Sempre del 2002 è Prova a prendermi, con Leonardo Di Caprio. Nel 2004 dirige The Terminal con Tom Hanks, ispirato alla vera storia del rifugiato iraniano Mehran Nasseri bloccato all'aeroporto di Parigi. Del 2005 è, invece, La guerra dei mondi – girato in soli tre mesi sgomberando un intero quartiere di una cittadina del New Jersey – in cui il regista torna a collaborare con Tom Cruise: l'atmosfera cupa e drammatica del �lm è certamente ancora in�uenzata dai fatti dell'11 settembre. Sempre di un episodio terroristico racconta anche Munich, grande successo dello stesso anno, ispirato al terribile massacro di israeliani perpetrato durante i Giochi Olimpici di Monaco '72 e la cui ossatura è costituita dall'adattamento del libro-in-chiesta del giornalista canadese George Jonas. Nel 2008 Spielberg torna al passato girando il quarto episodio di "Indiana Jones”. Nel 2011 decide invece di misurarsi con la spettacolare animazione in 3D con Le avventure di Tintin: il segreto dell'unicorno. Nel 2012 è di nuovo un tema politico e storico a ispirarlo: la biogra�a del presiden-te degli Stati Uniti che abolì la schiavitù cambiando la storia per sempre Lincoln. Del 2015 è Il ponte delle spie. Il GGG è il suo ultimo �lm.
terri�cante, come in un racconto horror. Anche se, a dire il vero, Il GGG rispetto agli altri libri di Dahl è più tenero, divertente, probabilmente perché l’autore l’ha scritto come una delle tante �abe della buona notte che doveva portare serenità alle sue �glie prima e alle sue nipotine dopo. Forse la più grande di�erenza tra Spielberg e Dahl sta nel fatto che il primo intravvede sempre la luce pur attraversando le tenebre, il secondo la luce non riesce neanche a scorgerla e i suoi racconti spesso lasciano una certa amarezza, una sensazione profondamente legata alla realtà, pur essendo la sua scrittura molto creativa e fantasiosa. Anche qui dobbiamo scomodare l’infanzia e ancor di più l’adolescenza dell’autore, segnate da morti importanti e da un’educazione sin troppo rigida. Dahl ad esempio perse sua madre all’età di soli quattro anni. Per un po’ visse con la nonna che adorava ma a un certo punto suo padre decise di risposarsi e Dahl bambino dovette vivere un’altra separazione dolorosa, quella dalla nonna appunto, per dare posto ad una donna giovane ma autoritaria. Inoltre la scuola che Dahl ragazzino frequentò era un college di buona fama ma in cui l’educazione e la disciplina si trasmettevano attraverso puni-zioni corporali e psicologiche e dominavano gli atti – diremmo oggi – di bullismo feroce, da parte dei ragazzi più grandi verso quelli più piccoli. E Dahl, pur essendo alto già a quindici anni 1 metro e 98 centimetri, non riuscì a sottrarsi alle violente pratiche dei college inglesi di quegli anni. Ma riuscì a resistere. Il suo modo per a�rontare e sopportare la brutalità del college consisteva nel reprimere le emozioni, nel non con�darsi mai con nessuno, chiudendosi anche lui come Spielberg nel silenzio e nella solitudine, più tardi riem-piti dalla loro fervida immaginazione. Anche la vita di Dahl adulto è stata costellata da lutti importanti: a 7 anni muore sua �glia Olivia che ispira la �gura proprio di Sophie per Il GGG. «Fumava sigarette Dunhill, odorava di sapone da barba e aria fresca, aveva la voce calda e famigliare come il rumore di passi su pavimento di legno» ha raccontato al Guardian sua nipote Sophie, �glia di Tessa, secondogenita di Dahl. Sono state le sorelle minori Olivia e Lucy, ad ascoltare per prime, in forma di racconto della buona notte quello che sarebbe stato Il GGG. Quando le bambine andavano a letto il “gigante” Dahl saliva su una scala, prendeva una lunga canna di bambù e giocava a so�are sogni per tutta la stanza. L’idea del gigante che raccoglie sogni chiudendoli in delle scatole per poi o�rirli ai bambini per farli felici durante il sonno, è un’idea che inseguiva da tempo lo scrittore anglo-nor-vegese. Ed è così che i bambini di Dahl sono creature che resistono alle crudeltà dei più grandi, che a�rontano le peggiori di�coltà senza mai abbattersi e senza mai mostrarsi sentimentali, che a�rontano la morte come qualcosa di terribile ma reale. Ad esempio in Matilda vediamo genitori che non capiscono la propria �glia, anzi la detestano perché chiede regole ed educazione, in Willy Wonka i bambini possono scomparire per sempre o tornare a casa dopo molto tempo, in Le streghe i bimbi vengono trasformati in topi e ci rimangono! A Dahl insomma non interessa il lieto �ne, il �nale consolatorio del “vissero tutti felici e contenti”! Ed è per questo che mentre i �lm di Spielberg sono stati sempre ben accolti dal pubblico in tutto il mondo, i libri di Dahl furono molto ostacolati perché considerati volgari, violenti, non adatti ai ragazzi. Nell’unica autobiogra�a autorizzata da Dahl e scritta da Donald Sturrock si racconta di un’editrice orgogliosa di aver ri�utato per due volte di pubbli-care i suoi libri. Ad esempio Eleanor Cameron, autrice per bambini canadese de�nì La fabbrica di cioccolato un libro scadente, di cattivo gusto, sadico e orribile e pericoloso per i bambini. Un’altra scrittrice di fantascienza, Ursula K. Le Guin, scrisse che sua �glia era diventata una villana dopo la lettura de La fabbrica di cioccolato.Oggi fortunatamente i libri di Roald Dahl sono ampiamente apprezzati per la sua scrittura libera, fuori da regole e schemi, ricca di parole inventate (basti pensare a come parla il Grande Gigante Gentile), pervasa da un umori-smo a volte feroce ma divertente, una scrittura così vicina all’immaginazione che ogni bambino ha dentro di sé e così carica di quella sana ribellione utile ad ogni bambino per crescere libero e indipendente.
UNA STRAORDINARIA STORIA DI AMICIZIA Possiamo considerare Il GGG la storia di due solitudini che un giorno si incontrano e, superate le prime di�den-ze, sentono che uno può essere utile all’altro, capiscono che stanno bene insieme perché ognuno ha qualcosa di buono da mettere a disposizione. Ma soprattutto ciò che li incoraggia a darsi una mano, a credere l’uno nell’altro e a farsi accettare per quello che sono, è la gentilezza! E che cos’è la gentilezza se non la via per stare insieme senza farsi male, la via per dialogare con l’altro senza costruire muri e senza sopra�azioni, la via per rispettare la dignità dell’altro, indipendentemente da come si è? La Sophie che conosciamo all’inizio del �lm è una bambina vispa, intelligente, consapevole del posto in cui si

L’INCONTRO TRA DUE GIGANTIPrima o poi sarebbe accaduto: il più grande regista vivente, che ha celebrato in molti suoi �lm l’incanto dell’infa-nzia, ha scelto di trasporre in immagini il romanzo più noto del più bizzarro scrittore per ragazzi che la letteratura abbia mai conosciuto. Stiamo ovviamente parlando di Steven Spielberg e Roald Dahl. Abbiamo ammirato negli anni passati la maniera in cui Spielberg ha raccontato l’infanzia in �lm come E.T., Ai con�ni della realtà, Jurassic Park, A.I. Intelligenza Arti�ciale ma anche in �lm storici come L’impero del sole, Schindler’s list e War Horse. Un’infan- zia segnata dalla necessità di fuggire dal mondo troppo piccolo creato dagli adulti, desiderosa di conoscere l’Altro, di ampliare lo sguardo e soprattutto desiderosa di scoprire il nuovo, il diverso che agli occhi dei bambini è meraviglia dell’universo. Non è un caso che i bambini di Spielberg non sono mai davvero arrabbiati, anche quando subiscono cattiverie da parte degli adulti. Semmai hanno lo sguardo aperto, gli occhi spalancati a volte spaventati ma non per paura quanto per aver colto l’inaspettato, per aver scoperto qualcosa che il mondo reale ha nascosto loro. I bambini di Spielberg insomma sono a loro modo ribelli e positivi, non distruttivi, sono attivi, si muovono nel mondo cercando, esplorando e così costruiscono speranze. D’altronde è l’infanzia stessa dell’auto-re che irrompe sullo schermo: «Non sono stato un bambino felice – racconta Spielberg – quando i miei genitori si sono separati ho so�erto tantissimo, mi sono sentito abbandonato. E questa sensazione dell’abbandono me la sono portata dentro per molto tempo, non solo, ma mi faceva sentire diverso dai miei compagni. A scuola poi, mi sentivo socialmente abbandonato. Non ero popolare. I ragazzi che ammiravo non mi permettevano di giocare con loro. Sono stato solo una comparsa nella mia vita, per molti anni. E questo sentimento ho provato a raccon-tarlo nei miei �lm». Anche Sophie è a suo modo una ribelle. Anzi è la prima cosa che ci viene raccontata di lei: mentre tutti gli altri nell’orfanotro�o dormono, lei legge romanzi e siccome è vietato, lo fa nascondendosi sotto la coperta facendosi luce con una torcia. E il libro che sta leggendo è la storia di altri bambini come lei, orfani, soli e ribelli come tutti i protagonisti dei libri di Dickens. Quando Sophie si avvicina alla �nestra per guardare in strada sa che sta facendo una cosa proibita: «Mai scendere dal letto, mai andare alla �nestra, mai vedere cosa c’è dietro la tenda» sono le regole dette e ripetute dell’orfanotro�o. Regole a cui lei verrà meno, senza ripensamenti. D’altr-onde se non avesse disubbidito non avrebbe mai conosciuto il Grande Gigante Gentile, cioè non avrebbe avuto un amico straordinario seppur immaginario. Sarebbe rimasta nel suo letto, schiacciata dalla solitudine.Anche i bambini raccontati da Roald Dahl sono ribelli, ma in modo diverso rispetto a quelli di Spielberg. Vivono storie decisamente più cattive, più buie, in cui la presenza degli adulti è davvero un peso insopportabile e a tratti
trova, delle regole che le sono state date, ma non si rassegna alla sua condizione. La curiosità, il bisogno di a�etto e di calore umano, il desiderio di scoprire mondi diversi da quello che già conosce la spingono a immaginare, immergendosi nella lettura di libri che divora in maniera segreta sotto le coperte, al buio, come se legge-re/fantasticare fosse l’attività più pericolosa di questo mondo. E che dire della possibilità di scorgere dalla �nestra le luci della strada che appaiono come fantasmi nel buio della notte e scoprire che di notte vive un mondo fantastico, a volte spaventoso, sicuramente strano e proibito? Sophie non vuole sottrarsi a questa possibilità. Come tutti i bambini e le bambine, Sophie si sente attirata e spaventata da ciò che non conosce e prova a fare piccoli passi in avanti per assaporare l’imprevisto. Ma questa volta lo sconosciuto è molto molto più grande di lei ed entra all’improvviso nella sua vita, prima che lei se ne accorgesse, in una scena bellissima in cui il nuovo, lo spaventoso, il meraviglioso l’accoglie nella sua mano gigantesca. È una delle scene simbolo del �lm perché racconta della delicatezza, della dolcezza con cui il magico, il fantastico accoglie la bam-bina e la trasporta in una terra in cui tutto è possibile anche creare sogni e regalarli ai più piccoli. Non è straordi-nario tutto questo? Sì, ma bisogna fare attenzione perché se lasciamo che i piccoli siano troppo liberi nella loro immaginazione, avremmo troppi ribelli nel mondo e questo non piace a chi decide quali debbano essere le regole da seguire. Per questo a un certo punto appaiono i giganti cattivi, i cui nomi ci dicono molto delle loro atroci abilità e abitudini: la loro missione non è tanto quella di mangiare Sophie (piccola com’è non basta a soddisfare l’appetito di nessuno di loro), ma quello di distruggere i sogni. Vomitoso, Strizza-teste, San-Guinario, Inghiotti-cicciaviva, Trita-bimbo, Spella-fanciulle, Scotta-dito sono avidi, violenti, rozzi, ignoranti, stupidi esatta-mente come chiunque usi la violenza per piegare l’altro alla propria volontà. È una lotta impari quella che si viene a creare tra loro e il fratello più piccolo (il nanerottolo lo chiamano) e Sophie. Ma a vincere saranno proprio loro due, i più piccoli, perché hanno armi più intelligenti, più profonde, più ra�nate che sono la gentilezza, l’ami-cizia necessarie per raggiungere obiettivi più alti (non già il riempirsi la pancia) come l’a�ermazione della giusti-zia, l’accettazione delle diversità, il potere dell’immaginazione, la difesa della libertà.
LA GENTILEZZA RENDE GRANDILa gentilezza non è solamente forma, se si riduce a questo diventa ipocrita. La gentilezza di cui ci parla Il GGG è sostanza e coerenza. Basti pensare alla maniera in cui il Gigante Gentile protegge Sophie dai suoi fratelli cattivi o alla maniera in cui difende la sua diversità (è il più basso dei Giganti e per questo deriso) o alla maniera in cui custo-disce il suo dolore più profondo. A un certo punto il GGG mostra a Sophie il vaso in cui ha racchiuso il suo incubo peggiore: dentro ci sono i rimorsi e il dolore per qualcosa da cui non può più tornare indietro ovvero la scomparsa del bambino che per primo era diventato amico del GGG, scoperto e divorato da altri giganti cattivi. Da allora lo scopo del GGG è proteggere tutti i bambini che decide di portare con sé perché nel mondo reale nessuna infan-zia deve essere o�esa, violata, nessun bambino deve diventare vittima delle disattenzioni, delle distrazioni. Sophie per lui diventa quindi il simbolo dell’infanzia, un’età in cui l’idea del mondo che ci si fa, dipende soprat-tutto dai buoni o dai cattivi esempi che si ricevono. Il GGG arriva in un momento particolare della vita della bam-bina: ha dieci anni, che rappresentano un po’ il con�ne tra l’infanzia e la preadolescenza, cioè è una fase in cui il fantastico e il reale assumono dei contorni più chiari e �nalmente ci si può prendere la responsabilità e la libertà di farli comunicare per creare qualcosa di diverso. Magari più giusto… e più divertente. Si, perché un concetto chiaro che Il GGG esprime con forza è che non è vero che se si è gentili si è deboli, s�gati, come dicono alcuni. Al contrario, se si è gentili e leali e amici veri, si fanno esperienze strabilianti come essere invitati dalla Regina e risultare interessanti, originali, divertenti. Di contro chi usa la forza, l’arroganza, la violenza non è per niente �go, anzi è davvero ributtante come i giganti del �lm, ma contro di loro il Gigante Gentile e Sophie non sentono desiderio di vendetta, solo giustizia. Per questo il �nale non vede l’eliminazione del nemico ma viene data loro una specie di punizione “educativa”, ripa-ratoria: vengono mandati su un’altra terra a imparare a coltivare e mangiare cetrionzoli. «La magia ci fa essere intraprendenti – ha detto Spielberg – la speranza viene da lì».
Seven Spileberg nasce il 18 dicembre del 1946 dall'ingegnere elettrico Arnold Spielberg e dalla pianista concertista Leah Adler. La sua famiglia, di origine ebraica, vive per qualche
tempo nel New Jersey, poi si trasferisce a Scottsdale, in Arizona, dove Steven cresce. Desti-nato a diventare uno dei più grandi registi del suo tempo, Spielberg rimane l'unico tra i maggiori cineasti della sua generazione – a cominciare da George Lucas, amico di una vita – a non avere alle spalle studi universitari di cinematogra�a. Sostituisce però la
scuola con una pratica da autodidatta cominciata �n da ragazzino quando i genitori gli a�dano l'uso di una cinepresa ad 8 mm per registrare le gite di famiglia. In realtà, oltre alle
gite, il giovane Steven prende l'abitudine di girare �lmetti a soggetto in cui dà già prova della sua propensione per il fantastico e del suo gusto per gli e�etti speciali. Uno di questi �lmetti, Escape to Nowhere, vince un concor-so cineamatoriale; un altro, il fantascienti�co Firelight viene proiettato in una sala e incassa 500 dollari. Da giova-ne comincia a frequentare gli studi della Universal e la leggenda vuole che vi si sia introdotto allestendo clande-stinamente un u�cio nei locali vuoti di una portineria, e che i custodi, ai quali si presenta sempre in giacca e cravatta, lo lasciassero passare credendolo di casa. In ogni modo, Spielberg non riesce a far vedere le sue prime prove a qualcuno che conti e solo quando Amblin', il suo primo �lm in 35 mm, un cortometraggio di 24 minuti, vince premi al Festival di Venice e di Atlanta, la Universal si accorge di lui e lo mette sotto contratto nella sua sezione televisiva. Per la TV, nel 1971, gira Duel che è considerato a tutti gli e�etti il primo �lm di Spielberg. In questo primo �lm si vedono già le caratteristiche della sua narrazione: la propensione agli e�etti speciali e il tema l'uomo comune che si trova a misurarsi con circostanze eccezionali e a tirare fuori l'eroismo che non pensa-va di avere. Il �lm diventerà un cult per l'eccezionalità dell'essere stato girato in soli tredici giorni. Nel 1974 gira The Sugarland Express: road movie ispirato a un fatto di cronaca, racconta la tragica fuga attraverso il Texas di un evaso e di sua moglie, i quali corrono a riprendersi il �glioletto dato in adozione; con questo lavoro il regista ottiene il premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes, ma non un grande successo di pubblico, probabilmente per i toni troppo cupi e drammatici della pellicola. Un anno più tardi, con Lo squalo, si fa conosce-re al grande pubblico; nonostante le di�coltà legate alla sua inesperienza, a un malfunzionante squalo mecca-nico, alle di�coltà climatiche che lasciano pochissime ore al giorno per le riprese in esterni (in mare aperto) il �lm è campione d'incassi (470 milioni di dollari), vince tre Oscar, e causa addirittura una sorta di psicosi colletti-va, tanto da far registrare un calo di turisti nelle località balneari. Nel '77 ottiene un altro clamoroso successo con Incontri ravvicinati del terzo tipo e di fatto riscrive le regole del genere fantascienti�co, che volevano gli alieni nei panni dei mostruosi conquistatori, dandone una visione assai più benevola, "umanizzante". Con questo �lm ottiene la prima nomination agli Oscar, per la miglior regia. Dopo lo scarso successo di 1941: allarme a Hollywood (1979), commedia sull'isteria collettiva antigiapponese che si di�use in America dopo Pearl Harbor, torna ad incassi da record nel 1980 con I predatori dell'arca perduta, scaturito da un'idea sviluppata insieme a George Lucas (reduce dall'enorme successo della saga di Guerre Stellari), con cui nasce il personaggio dell'avventuroso archeologo Indiana Jones, che Spielberg riprenderà nell'84 (Indiana Jones e il tempio maledetto) e nell'89 (India-na Jones e l'ultima crociata). Nel frattempo torna alla fantascienza con un �lm che meglio di altri rappresenta la sua idea di cinema come strumento per accendere sogni, stupori, fantasie: E.T. L'extraterrestre del 1982, storia del piccolo alieno dimenticato dalla sua astronave, solo e smarrito sulla Terra: è così che batte tutti i record d'incasso della storia del cinema. La pellicola vale al regista la terza nomination agli Oscar. A partire dal 1982 Spielberg comincia a occuparsi anche di produzione e fonda la Amblin Entertainment (in omaggio al titolo del suo primo cortometraggio) assieme ai colleghi Kathleen Kennedy e Frank Marshall: la casa produce �lm campioni di incassi come la trilogia di Ritorno al futuro di Robert Zemeckis. Nel 1985 gira Il colore viola, storia tratta da un romanzo di Alice Walzer che racconta di una donna di colore salvata dai maltrattamenti del marito grazie ad un'amica. Del 1987 è L'impero del Sole, in cui racconta le vicissitudini di un bambino inglese che, al momento dell'occupazione giapponese di Shangai nel '41, perde i genitori e si ritrova a trascorrere gli anni della guerra da solo, passando da un campo di prigionia all'altro. Dopo il romantico Always – Per sempre (1988), in cui recita anche Audrey Hepburn, gli anni 90 si aprono con il ritorno di Spielberg al genere fantasy: Hook – Capitan Uncino (1991), in cui immagina un Peter Pan sposato e con �gli, e tuttavia coinvolto in misteriose avventure: il �lm ha un chiaro riferi-mento alle dinamiche di relazione fra adulti e ragazzi, fra genitori e �gli, e quindi ad una componente autobio-
il Regista
SpielbergSteven
orizzonti di luceorizzonti di luce 6
StevenSpielberg
gra�ca. Ma è soprattutto con Jurassic Park (1993), che avviene la consacrazione a re del genere fantascienti�co e il raggiungimento di un nuovo record storico di incassi. Non ancora terminata la post produzione di quel �lm, Spielberg si lancia nell'avventura di Schindler's List (1994), in cui riesce a raccontare la tragedia dell'olocausto attraverso l'itinerario umano e morale di un imprenditore iscritto al partito nazista, che si ritrova a mettere in salvo migliaia di ebrei dapprima quasi per caso, poi con consapevolezza e dedizione sempre maggiori. Con Schindler's List, vince sia il premio per il miglior �lm sia quello per la miglior regia. Spielberg è particolarmente legato a questa sua opera, essendo lui stesso di origini ebraiche e avendo provato sulla propria pelle, soprattut-to in gioventù, gravi episodi di discriminazioni, come ricorda in numerose interviste. Dopo questo enorme successo dà un seguito a Jurassic Park con Il mondo perduto (1997) e realizza Amistad (1997) – storia della rivolta di un gruppo di neri contro l'equipaggio della nave che, nel 1839, li porta da Cuba agli Stati Uniti per venderli come schiavi. Nel 1998 è la volta di Salvate il soldato Ryan con quest'ultimo �lm, ottiene anche il suo secondo Oscar come miglior regista, ma la pellicola ne ottiene altri quattro per la fotogra�a, il montaggio, il sonoro e gli e�etti sonori. Nel 2002 esce Minority Report, tratto dall'omonimo romanzo di P. K. Dick, interpretato, fra gli altri, da Tom Cruise e arricchito da echi di Kubrick e Hitchcock. Sempre del 2002 è Prova a prendermi, con Leonardo Di Caprio. Nel 2004 dirige The Terminal con Tom Hanks, ispirato alla vera storia del rifugiato iraniano Mehran Nasseri bloccato all'aeroporto di Parigi. Del 2005 è, invece, La guerra dei mondi – girato in soli tre mesi sgomberando un intero quartiere di una cittadina del New Jersey – in cui il regista torna a collaborare con Tom Cruise: l'atmosfera cupa e drammatica del �lm è certamente ancora in�uenzata dai fatti dell'11 settembre. Sempre di un episodio terroristico racconta anche Munich, grande successo dello stesso anno, ispirato al terribile massacro di israeliani perpetrato durante i Giochi Olimpici di Monaco '72 e la cui ossatura è costituita dall'adattamento del libro-in-chiesta del giornalista canadese George Jonas. Nel 2008 Spielberg torna al passato girando il quarto episodio di "Indiana Jones”. Nel 2011 decide invece di misurarsi con la spettacolare animazione in 3D con Le avventure di Tintin: il segreto dell'unicorno. Nel 2012 è di nuovo un tema politico e storico a ispirarlo: la biogra�a del presiden-te degli Stati Uniti che abolì la schiavitù cambiando la storia per sempre Lincoln. Del 2015 è Il ponte delle spie. Il GGG è il suo ultimo �lm.
terri�cante, come in un racconto horror. Anche se, a dire il vero, Il GGG rispetto agli altri libri di Dahl è più tenero, divertente, probabilmente perché l’autore l’ha scritto come una delle tante �abe della buona notte che doveva portare serenità alle sue �glie prima e alle sue nipotine dopo. Forse la più grande di�erenza tra Spielberg e Dahl sta nel fatto che il primo intravvede sempre la luce pur attraversando le tenebre, il secondo la luce non riesce neanche a scorgerla e i suoi racconti spesso lasciano una certa amarezza, una sensazione profondamente legata alla realtà, pur essendo la sua scrittura molto creativa e fantasiosa. Anche qui dobbiamo scomodare l’infanzia e ancor di più l’adolescenza dell’autore, segnate da morti importanti e da un’educazione sin troppo rigida. Dahl ad esempio perse sua madre all’età di soli quattro anni. Per un po’ visse con la nonna che adorava ma a un certo punto suo padre decise di risposarsi e Dahl bambino dovette vivere un’altra separazione dolorosa, quella dalla nonna appunto, per dare posto ad una donna giovane ma autoritaria. Inoltre la scuola che Dahl ragazzino frequentò era un college di buona fama ma in cui l’educazione e la disciplina si trasmettevano attraverso puni-zioni corporali e psicologiche e dominavano gli atti – diremmo oggi – di bullismo feroce, da parte dei ragazzi più grandi verso quelli più piccoli. E Dahl, pur essendo alto già a quindici anni 1 metro e 98 centimetri, non riuscì a sottrarsi alle violente pratiche dei college inglesi di quegli anni. Ma riuscì a resistere. Il suo modo per a�rontare e sopportare la brutalità del college consisteva nel reprimere le emozioni, nel non con�darsi mai con nessuno, chiudendosi anche lui come Spielberg nel silenzio e nella solitudine, più tardi riem-piti dalla loro fervida immaginazione. Anche la vita di Dahl adulto è stata costellata da lutti importanti: a 7 anni muore sua �glia Olivia che ispira la �gura proprio di Sophie per Il GGG. «Fumava sigarette Dunhill, odorava di sapone da barba e aria fresca, aveva la voce calda e famigliare come il rumore di passi su pavimento di legno» ha raccontato al Guardian sua nipote Sophie, �glia di Tessa, secondogenita di Dahl. Sono state le sorelle minori Olivia e Lucy, ad ascoltare per prime, in forma di racconto della buona notte quello che sarebbe stato Il GGG. Quando le bambine andavano a letto il “gigante” Dahl saliva su una scala, prendeva una lunga canna di bambù e giocava a so�are sogni per tutta la stanza. L’idea del gigante che raccoglie sogni chiudendoli in delle scatole per poi o�rirli ai bambini per farli felici durante il sonno, è un’idea che inseguiva da tempo lo scrittore anglo-nor-vegese. Ed è così che i bambini di Dahl sono creature che resistono alle crudeltà dei più grandi, che a�rontano le peggiori di�coltà senza mai abbattersi e senza mai mostrarsi sentimentali, che a�rontano la morte come qualcosa di terribile ma reale. Ad esempio in Matilda vediamo genitori che non capiscono la propria �glia, anzi la detestano perché chiede regole ed educazione, in Willy Wonka i bambini possono scomparire per sempre o tornare a casa dopo molto tempo, in Le streghe i bimbi vengono trasformati in topi e ci rimangono! A Dahl insomma non interessa il lieto �ne, il �nale consolatorio del “vissero tutti felici e contenti”! Ed è per questo che mentre i �lm di Spielberg sono stati sempre ben accolti dal pubblico in tutto il mondo, i libri di Dahl furono molto ostacolati perché considerati volgari, violenti, non adatti ai ragazzi. Nell’unica autobiogra�a autorizzata da Dahl e scritta da Donald Sturrock si racconta di un’editrice orgogliosa di aver ri�utato per due volte di pubbli-care i suoi libri. Ad esempio Eleanor Cameron, autrice per bambini canadese de�nì La fabbrica di cioccolato un libro scadente, di cattivo gusto, sadico e orribile e pericoloso per i bambini. Un’altra scrittrice di fantascienza, Ursula K. Le Guin, scrisse che sua �glia era diventata una villana dopo la lettura de La fabbrica di cioccolato.Oggi fortunatamente i libri di Roald Dahl sono ampiamente apprezzati per la sua scrittura libera, fuori da regole e schemi, ricca di parole inventate (basti pensare a come parla il Grande Gigante Gentile), pervasa da un umori-smo a volte feroce ma divertente, una scrittura così vicina all’immaginazione che ogni bambino ha dentro di sé e così carica di quella sana ribellione utile ad ogni bambino per crescere libero e indipendente.
UNA STRAORDINARIA STORIA DI AMICIZIA Possiamo considerare Il GGG la storia di due solitudini che un giorno si incontrano e, superate le prime di�den-ze, sentono che uno può essere utile all’altro, capiscono che stanno bene insieme perché ognuno ha qualcosa di buono da mettere a disposizione. Ma soprattutto ciò che li incoraggia a darsi una mano, a credere l’uno nell’altro e a farsi accettare per quello che sono, è la gentilezza! E che cos’è la gentilezza se non la via per stare insieme senza farsi male, la via per dialogare con l’altro senza costruire muri e senza sopra�azioni, la via per rispettare la dignità dell’altro, indipendentemente da come si è? La Sophie che conosciamo all’inizio del �lm è una bambina vispa, intelligente, consapevole del posto in cui si

L’INCONTRO TRA DUE GIGANTIPrima o poi sarebbe accaduto: il più grande regista vivente, che ha celebrato in molti suoi �lm l’incanto dell’infa-nzia, ha scelto di trasporre in immagini il romanzo più noto del più bizzarro scrittore per ragazzi che la letteratura abbia mai conosciuto. Stiamo ovviamente parlando di Steven Spielberg e Roald Dahl. Abbiamo ammirato negli anni passati la maniera in cui Spielberg ha raccontato l’infanzia in �lm come E.T., Ai con�ni della realtà, Jurassic Park, A.I. Intelligenza Arti�ciale ma anche in �lm storici come L’impero del sole, Schindler’s list e War Horse. Un’infan- zia segnata dalla necessità di fuggire dal mondo troppo piccolo creato dagli adulti, desiderosa di conoscere l’Altro, di ampliare lo sguardo e soprattutto desiderosa di scoprire il nuovo, il diverso che agli occhi dei bambini è meraviglia dell’universo. Non è un caso che i bambini di Spielberg non sono mai davvero arrabbiati, anche quando subiscono cattiverie da parte degli adulti. Semmai hanno lo sguardo aperto, gli occhi spalancati a volte spaventati ma non per paura quanto per aver colto l’inaspettato, per aver scoperto qualcosa che il mondo reale ha nascosto loro. I bambini di Spielberg insomma sono a loro modo ribelli e positivi, non distruttivi, sono attivi, si muovono nel mondo cercando, esplorando e così costruiscono speranze. D’altronde è l’infanzia stessa dell’auto-re che irrompe sullo schermo: «Non sono stato un bambino felice – racconta Spielberg – quando i miei genitori si sono separati ho so�erto tantissimo, mi sono sentito abbandonato. E questa sensazione dell’abbandono me la sono portata dentro per molto tempo, non solo, ma mi faceva sentire diverso dai miei compagni. A scuola poi, mi sentivo socialmente abbandonato. Non ero popolare. I ragazzi che ammiravo non mi permettevano di giocare con loro. Sono stato solo una comparsa nella mia vita, per molti anni. E questo sentimento ho provato a raccon-tarlo nei miei �lm». Anche Sophie è a suo modo una ribelle. Anzi è la prima cosa che ci viene raccontata di lei: mentre tutti gli altri nell’orfanotro�o dormono, lei legge romanzi e siccome è vietato, lo fa nascondendosi sotto la coperta facendosi luce con una torcia. E il libro che sta leggendo è la storia di altri bambini come lei, orfani, soli e ribelli come tutti i protagonisti dei libri di Dickens. Quando Sophie si avvicina alla �nestra per guardare in strada sa che sta facendo una cosa proibita: «Mai scendere dal letto, mai andare alla �nestra, mai vedere cosa c’è dietro la tenda» sono le regole dette e ripetute dell’orfanotro�o. Regole a cui lei verrà meno, senza ripensamenti. D’altr-onde se non avesse disubbidito non avrebbe mai conosciuto il Grande Gigante Gentile, cioè non avrebbe avuto un amico straordinario seppur immaginario. Sarebbe rimasta nel suo letto, schiacciata dalla solitudine.Anche i bambini raccontati da Roald Dahl sono ribelli, ma in modo diverso rispetto a quelli di Spielberg. Vivono storie decisamente più cattive, più buie, in cui la presenza degli adulti è davvero un peso insopportabile e a tratti
trova, delle regole che le sono state date, ma non si rassegna alla sua condizione. La curiosità, il bisogno di a�etto e di calore umano, il desiderio di scoprire mondi diversi da quello che già conosce la spingono a immaginare, immergendosi nella lettura di libri che divora in maniera segreta sotto le coperte, al buio, come se legge-re/fantasticare fosse l’attività più pericolosa di questo mondo. E che dire della possibilità di scorgere dalla �nestra le luci della strada che appaiono come fantasmi nel buio della notte e scoprire che di notte vive un mondo fantastico, a volte spaventoso, sicuramente strano e proibito? Sophie non vuole sottrarsi a questa possibilità. Come tutti i bambini e le bambine, Sophie si sente attirata e spaventata da ciò che non conosce e prova a fare piccoli passi in avanti per assaporare l’imprevisto. Ma questa volta lo sconosciuto è molto molto più grande di lei ed entra all’improvviso nella sua vita, prima che lei se ne accorgesse, in una scena bellissima in cui il nuovo, lo spaventoso, il meraviglioso l’accoglie nella sua mano gigantesca. È una delle scene simbolo del �lm perché racconta della delicatezza, della dolcezza con cui il magico, il fantastico accoglie la bam-bina e la trasporta in una terra in cui tutto è possibile anche creare sogni e regalarli ai più piccoli. Non è straordi-nario tutto questo? Sì, ma bisogna fare attenzione perché se lasciamo che i piccoli siano troppo liberi nella loro immaginazione, avremmo troppi ribelli nel mondo e questo non piace a chi decide quali debbano essere le regole da seguire. Per questo a un certo punto appaiono i giganti cattivi, i cui nomi ci dicono molto delle loro atroci abilità e abitudini: la loro missione non è tanto quella di mangiare Sophie (piccola com’è non basta a soddisfare l’appetito di nessuno di loro), ma quello di distruggere i sogni. Vomitoso, Strizza-teste, San-Guinario, Inghiotti-cicciaviva, Trita-bimbo, Spella-fanciulle, Scotta-dito sono avidi, violenti, rozzi, ignoranti, stupidi esatta-mente come chiunque usi la violenza per piegare l’altro alla propria volontà. È una lotta impari quella che si viene a creare tra loro e il fratello più piccolo (il nanerottolo lo chiamano) e Sophie. Ma a vincere saranno proprio loro due, i più piccoli, perché hanno armi più intelligenti, più profonde, più ra�nate che sono la gentilezza, l’ami-cizia necessarie per raggiungere obiettivi più alti (non già il riempirsi la pancia) come l’a�ermazione della giusti-zia, l’accettazione delle diversità, il potere dell’immaginazione, la difesa della libertà.
LA GENTILEZZA RENDE GRANDILa gentilezza non è solamente forma, se si riduce a questo diventa ipocrita. La gentilezza di cui ci parla Il GGG è sostanza e coerenza. Basti pensare alla maniera in cui il Gigante Gentile protegge Sophie dai suoi fratelli cattivi o alla maniera in cui difende la sua diversità (è il più basso dei Giganti e per questo deriso) o alla maniera in cui custo-disce il suo dolore più profondo. A un certo punto il GGG mostra a Sophie il vaso in cui ha racchiuso il suo incubo peggiore: dentro ci sono i rimorsi e il dolore per qualcosa da cui non può più tornare indietro ovvero la scomparsa del bambino che per primo era diventato amico del GGG, scoperto e divorato da altri giganti cattivi. Da allora lo scopo del GGG è proteggere tutti i bambini che decide di portare con sé perché nel mondo reale nessuna infan-zia deve essere o�esa, violata, nessun bambino deve diventare vittima delle disattenzioni, delle distrazioni. Sophie per lui diventa quindi il simbolo dell’infanzia, un’età in cui l’idea del mondo che ci si fa, dipende soprat-tutto dai buoni o dai cattivi esempi che si ricevono. Il GGG arriva in un momento particolare della vita della bam-bina: ha dieci anni, che rappresentano un po’ il con�ne tra l’infanzia e la preadolescenza, cioè è una fase in cui il fantastico e il reale assumono dei contorni più chiari e �nalmente ci si può prendere la responsabilità e la libertà di farli comunicare per creare qualcosa di diverso. Magari più giusto… e più divertente. Si, perché un concetto chiaro che Il GGG esprime con forza è che non è vero che se si è gentili si è deboli, s�gati, come dicono alcuni. Al contrario, se si è gentili e leali e amici veri, si fanno esperienze strabilianti come essere invitati dalla Regina e risultare interessanti, originali, divertenti. Di contro chi usa la forza, l’arroganza, la violenza non è per niente �go, anzi è davvero ributtante come i giganti del �lm, ma contro di loro il Gigante Gentile e Sophie non sentono desiderio di vendetta, solo giustizia. Per questo il �nale non vede l’eliminazione del nemico ma viene data loro una specie di punizione “educativa”, ripa-ratoria: vengono mandati su un’altra terra a imparare a coltivare e mangiare cetrionzoli. «La magia ci fa essere intraprendenti – ha detto Spielberg – la speranza viene da lì».
Seven Spileberg nasce il 18 dicembre del 1946 dall'ingegnere elettrico Arnold Spielberg e dalla pianista concertista Leah Adler. La sua famiglia, di origine ebraica, vive per qualche
tempo nel New Jersey, poi si trasferisce a Scottsdale, in Arizona, dove Steven cresce. Desti-nato a diventare uno dei più grandi registi del suo tempo, Spielberg rimane l'unico tra i maggiori cineasti della sua generazione – a cominciare da George Lucas, amico di una vita – a non avere alle spalle studi universitari di cinematogra�a. Sostituisce però la
scuola con una pratica da autodidatta cominciata �n da ragazzino quando i genitori gli a�dano l'uso di una cinepresa ad 8 mm per registrare le gite di famiglia. In realtà, oltre alle
gite, il giovane Steven prende l'abitudine di girare �lmetti a soggetto in cui dà già prova della sua propensione per il fantastico e del suo gusto per gli e�etti speciali. Uno di questi �lmetti, Escape to Nowhere, vince un concor-so cineamatoriale; un altro, il fantascienti�co Firelight viene proiettato in una sala e incassa 500 dollari. Da giova-ne comincia a frequentare gli studi della Universal e la leggenda vuole che vi si sia introdotto allestendo clande-stinamente un u�cio nei locali vuoti di una portineria, e che i custodi, ai quali si presenta sempre in giacca e cravatta, lo lasciassero passare credendolo di casa. In ogni modo, Spielberg non riesce a far vedere le sue prime prove a qualcuno che conti e solo quando Amblin', il suo primo �lm in 35 mm, un cortometraggio di 24 minuti, vince premi al Festival di Venice e di Atlanta, la Universal si accorge di lui e lo mette sotto contratto nella sua sezione televisiva. Per la TV, nel 1971, gira Duel che è considerato a tutti gli e�etti il primo �lm di Spielberg. In questo primo �lm si vedono già le caratteristiche della sua narrazione: la propensione agli e�etti speciali e il tema l'uomo comune che si trova a misurarsi con circostanze eccezionali e a tirare fuori l'eroismo che non pensa-va di avere. Il �lm diventerà un cult per l'eccezionalità dell'essere stato girato in soli tredici giorni. Nel 1974 gira The Sugarland Express: road movie ispirato a un fatto di cronaca, racconta la tragica fuga attraverso il Texas di un evaso e di sua moglie, i quali corrono a riprendersi il �glioletto dato in adozione; con questo lavoro il regista ottiene il premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes, ma non un grande successo di pubblico, probabilmente per i toni troppo cupi e drammatici della pellicola. Un anno più tardi, con Lo squalo, si fa conosce-re al grande pubblico; nonostante le di�coltà legate alla sua inesperienza, a un malfunzionante squalo mecca-nico, alle di�coltà climatiche che lasciano pochissime ore al giorno per le riprese in esterni (in mare aperto) il �lm è campione d'incassi (470 milioni di dollari), vince tre Oscar, e causa addirittura una sorta di psicosi colletti-va, tanto da far registrare un calo di turisti nelle località balneari. Nel '77 ottiene un altro clamoroso successo con Incontri ravvicinati del terzo tipo e di fatto riscrive le regole del genere fantascienti�co, che volevano gli alieni nei panni dei mostruosi conquistatori, dandone una visione assai più benevola, "umanizzante". Con questo �lm ottiene la prima nomination agli Oscar, per la miglior regia. Dopo lo scarso successo di 1941: allarme a Hollywood (1979), commedia sull'isteria collettiva antigiapponese che si di�use in America dopo Pearl Harbor, torna ad incassi da record nel 1980 con I predatori dell'arca perduta, scaturito da un'idea sviluppata insieme a George Lucas (reduce dall'enorme successo della saga di Guerre Stellari), con cui nasce il personaggio dell'avventuroso archeologo Indiana Jones, che Spielberg riprenderà nell'84 (Indiana Jones e il tempio maledetto) e nell'89 (India-na Jones e l'ultima crociata). Nel frattempo torna alla fantascienza con un �lm che meglio di altri rappresenta la sua idea di cinema come strumento per accendere sogni, stupori, fantasie: E.T. L'extraterrestre del 1982, storia del piccolo alieno dimenticato dalla sua astronave, solo e smarrito sulla Terra: è così che batte tutti i record d'incasso della storia del cinema. La pellicola vale al regista la terza nomination agli Oscar. A partire dal 1982 Spielberg comincia a occuparsi anche di produzione e fonda la Amblin Entertainment (in omaggio al titolo del suo primo cortometraggio) assieme ai colleghi Kathleen Kennedy e Frank Marshall: la casa produce �lm campioni di incassi come la trilogia di Ritorno al futuro di Robert Zemeckis. Nel 1985 gira Il colore viola, storia tratta da un romanzo di Alice Walzer che racconta di una donna di colore salvata dai maltrattamenti del marito grazie ad un'amica. Del 1987 è L'impero del Sole, in cui racconta le vicissitudini di un bambino inglese che, al momento dell'occupazione giapponese di Shangai nel '41, perde i genitori e si ritrova a trascorrere gli anni della guerra da solo, passando da un campo di prigionia all'altro. Dopo il romantico Always – Per sempre (1988), in cui recita anche Audrey Hepburn, gli anni 90 si aprono con il ritorno di Spielberg al genere fantasy: Hook – Capitan Uncino (1991), in cui immagina un Peter Pan sposato e con �gli, e tuttavia coinvolto in misteriose avventure: il �lm ha un chiaro riferi-mento alle dinamiche di relazione fra adulti e ragazzi, fra genitori e �gli, e quindi ad una componente autobio-
gra�ca. Ma è soprattutto con Jurassic Park (1993), che avviene la consacrazione a re del genere fantascienti�co e il raggiungimento di un nuovo record storico di incassi. Non ancora terminata la post produzione di quel �lm, Spielberg si lancia nell'avventura di Schindler's List (1994), in cui riesce a raccontare la tragedia dell'olocausto attraverso l'itinerario umano e morale di un imprenditore iscritto al partito nazista, che si ritrova a mettere in salvo migliaia di ebrei dapprima quasi per caso, poi con consapevolezza e dedizione sempre maggiori. Con Schindler's List, vince sia il premio per il miglior �lm sia quello per la miglior regia. Spielberg è particolarmente legato a questa sua opera, essendo lui stesso di origini ebraiche e avendo provato sulla propria pelle, soprattut-to in gioventù, gravi episodi di discriminazioni, come ricorda in numerose interviste. Dopo questo enorme successo dà un seguito a Jurassic Park con Il mondo perduto (1997) e realizza Amistad (1997) – storia della rivolta di un gruppo di neri contro l'equipaggio della nave che, nel 1839, li porta da Cuba agli Stati Uniti per venderli come schiavi. Nel 1998 è la volta di Salvate il soldato Ryan con quest'ultimo �lm, ottiene anche il suo secondo Oscar come miglior regista, ma la pellicola ne ottiene altri quattro per la fotogra�a, il montaggio, il sonoro e gli e�etti sonori. Nel 2002 esce Minority Report, tratto dall'omonimo romanzo di P. K. Dick, interpretato, fra gli altri, da Tom Cruise e arricchito da echi di Kubrick e Hitchcock. Sempre del 2002 è Prova a prendermi, con Leonardo Di Caprio. Nel 2004 dirige The Terminal con Tom Hanks, ispirato alla vera storia del rifugiato iraniano Mehran Nasseri bloccato all'aeroporto di Parigi. Del 2005 è, invece, La guerra dei mondi – girato in soli tre mesi sgomberando un intero quartiere di una cittadina del New Jersey – in cui il regista torna a collaborare con Tom Cruise: l'atmosfera cupa e drammatica del �lm è certamente ancora in�uenzata dai fatti dell'11 settembre. Sempre di un episodio terroristico racconta anche Munich, grande successo dello stesso anno, ispirato al terribile massacro di israeliani perpetrato durante i Giochi Olimpici di Monaco '72 e la cui ossatura è costituita dall'adattamento del libro-in-chiesta del giornalista canadese George Jonas. Nel 2008 Spielberg torna al passato girando il quarto episodio di "Indiana Jones”. Nel 2011 decide invece di misurarsi con la spettacolare animazione in 3D con Le avventure di Tintin: il segreto dell'unicorno. Nel 2012 è di nuovo un tema politico e storico a ispirarlo: la biogra�a del presiden-te degli Stati Uniti che abolì la schiavitù cambiando la storia per sempre Lincoln. Del 2015 è Il ponte delle spie. Il GGG è il suo ultimo �lm.
Con quali libri per l’infanzia è cresciuto lei?Ai miei tempi c’era un numero pietosamente limitato di libri per ragazzi, rispetto alla massiccia o�erta di oggi, con libri illustrati meravigliosi. I miei genitori mi leggevano i Little Golden Books, libri pratici sui mestieri. Dopo Five little �remen volevo fare il pompiere. Poi al libro successivo volevo fare il poliziotto. Poi sono arrivati i romanzi come Black Beauty di Anna Sewell e le avventure degli Hardy Boys di Franklyn Dick-son. Poi mi compravano anche storie terri�canti. Stavano sullo sca�ale per ragazzi, ma erano horror. Racconti che mi facevano paura pur attraendomi. Credo che molto del mio mondo fantastico provenga da ciò che mi spaventa.Com’è cambiato il mondo dell’immaginazione tra rete e tablet?Noi eravamo abituati a qualche programma tv, una manciata di classici, un libro da colorare. Oggi, dalla libreria al tablet, si trova di tutto. Questo signi�ca che siamo noi genitori a mettere i �ltri, creare la biblioteca. Stabilire senza delegare agli altri, cosa è appropriato per l’età dei nostri �gli, quali sono i giusti valori.Ha avuto un amico immaginario a farle compagnia?Non un bambino. La mia fantasia non aveva corpo. Era l’abilità di immaginare e di spaventare me stesso con la stessa immaginazione. Se mi guardavo allo specchio per più di un minuto mi venivano in mente orribili immagini. Le nuvole in cielo, le guardavo sdraiato a cinque anni, mi sembravano cigni bellissimi che subito dopo si trasformavano in orribili mostri.
(dichiarazioni tratte dall’intervista di Maurizio Turroni per Famiglia Cristiana del 25.12.2016 e dall’intervista di Arianna Finos per la Repubblica del 14.12.2016)
Qual è l’elemento del romanzo che l’ha conquistata?Dahl racconta i valori in cui credo, a partire dall’accettazione del diverso. E poi è la storia d’amore che avevo sempre cercato: quella di un bambino per il genitore e di un genitore per un bambino. Adoro l’assoluta man-canza di cinismo dei protagonisti. Sono due anime solitarie che, pur appartenendo a mondi diversi, hanno lo stesso grande cuore.Lei ha mai letto il romanzo di Dahl ai suoi �gli?Certo che sì. A tutti e sette! Innumerevoli volte. Ognuno ha avuto reazioni diverse. C’è chi si è identi�cato nel gigante, chi in Sophie o in Peter, uno persino nel maggiordomo. Tutti poi ridevano alle bu�e parole di inventate da Dahl: i popolli, Inghiotticicciaviva, Ciucciabudella, San Guinario, Vomitoso.Sophie è un’orfana. Nei suoi �lm Lei spesso parla di famiglie assenti o disfunzionali…Conosco il senso di abbandono. Il personaggio che ha un trauma e trova il modo di superarlo è il vero eroe. Sono �glio di divorziati e per me e le mie sorelle la separazione dei genitori è stata so�erenza vera.Che senso ha fare �lm, creare sogni, in una realtà piena di orrori?Più questo mondo peggiora, più abbiamo tutti quanti bisogno di magia per andare avanti. Cosa l’ha folgorata nel GGG di Dahl?Il personaggio di Sophie. È una ragazzina eppure ha la capacità di adattarsi a circostanze bizzarre, pericolo-se. Viene portata via dall’orfanotro�o, entra nel Paese dei Giganti eppure inizia a dialogare subito con il suo rapitore, mettendo da parte la paura per capire se questo gigante sia buono o malvagio. Mi son fatto guida-re dalla sua empatia per questa strana creatura. Sono due anime solitarie che incontrandosi trovano il proprio posto nel mondo.
orizzonti di luceorizzonti di luce 7
terri�cante, come in un racconto horror. Anche se, a dire il vero, Il GGG rispetto agli altri libri di Dahl è più tenero, divertente, probabilmente perché l’autore l’ha scritto come una delle tante �abe della buona notte che doveva portare serenità alle sue �glie prima e alle sue nipotine dopo. Forse la più grande di�erenza tra Spielberg e Dahl sta nel fatto che il primo intravvede sempre la luce pur attraversando le tenebre, il secondo la luce non riesce neanche a scorgerla e i suoi racconti spesso lasciano una certa amarezza, una sensazione profondamente legata alla realtà, pur essendo la sua scrittura molto creativa e fantasiosa. Anche qui dobbiamo scomodare l’infanzia e ancor di più l’adolescenza dell’autore, segnate da morti importanti e da un’educazione sin troppo rigida. Dahl ad esempio perse sua madre all’età di soli quattro anni. Per un po’ visse con la nonna che adorava ma a un certo punto suo padre decise di risposarsi e Dahl bambino dovette vivere un’altra separazione dolorosa, quella dalla nonna appunto, per dare posto ad una donna giovane ma autoritaria. Inoltre la scuola che Dahl ragazzino frequentò era un college di buona fama ma in cui l’educazione e la disciplina si trasmettevano attraverso puni-zioni corporali e psicologiche e dominavano gli atti – diremmo oggi – di bullismo feroce, da parte dei ragazzi più grandi verso quelli più piccoli. E Dahl, pur essendo alto già a quindici anni 1 metro e 98 centimetri, non riuscì a sottrarsi alle violente pratiche dei college inglesi di quegli anni. Ma riuscì a resistere. Il suo modo per a�rontare e sopportare la brutalità del college consisteva nel reprimere le emozioni, nel non con�darsi mai con nessuno, chiudendosi anche lui come Spielberg nel silenzio e nella solitudine, più tardi riem-piti dalla loro fervida immaginazione. Anche la vita di Dahl adulto è stata costellata da lutti importanti: a 7 anni muore sua �glia Olivia che ispira la �gura proprio di Sophie per Il GGG. «Fumava sigarette Dunhill, odorava di sapone da barba e aria fresca, aveva la voce calda e famigliare come il rumore di passi su pavimento di legno» ha raccontato al Guardian sua nipote Sophie, �glia di Tessa, secondogenita di Dahl. Sono state le sorelle minori Olivia e Lucy, ad ascoltare per prime, in forma di racconto della buona notte quello che sarebbe stato Il GGG. Quando le bambine andavano a letto il “gigante” Dahl saliva su una scala, prendeva una lunga canna di bambù e giocava a so�are sogni per tutta la stanza. L’idea del gigante che raccoglie sogni chiudendoli in delle scatole per poi o�rirli ai bambini per farli felici durante il sonno, è un’idea che inseguiva da tempo lo scrittore anglo-nor-vegese. Ed è così che i bambini di Dahl sono creature che resistono alle crudeltà dei più grandi, che a�rontano le peggiori di�coltà senza mai abbattersi e senza mai mostrarsi sentimentali, che a�rontano la morte come qualcosa di terribile ma reale. Ad esempio in Matilda vediamo genitori che non capiscono la propria �glia, anzi la detestano perché chiede regole ed educazione, in Willy Wonka i bambini possono scomparire per sempre o tornare a casa dopo molto tempo, in Le streghe i bimbi vengono trasformati in topi e ci rimangono! A Dahl insomma non interessa il lieto �ne, il �nale consolatorio del “vissero tutti felici e contenti”! Ed è per questo che mentre i �lm di Spielberg sono stati sempre ben accolti dal pubblico in tutto il mondo, i libri di Dahl furono molto ostacolati perché considerati volgari, violenti, non adatti ai ragazzi. Nell’unica autobiogra�a autorizzata da Dahl e scritta da Donald Sturrock si racconta di un’editrice orgogliosa di aver ri�utato per due volte di pubbli-care i suoi libri. Ad esempio Eleanor Cameron, autrice per bambini canadese de�nì La fabbrica di cioccolato un libro scadente, di cattivo gusto, sadico e orribile e pericoloso per i bambini. Un’altra scrittrice di fantascienza, Ursula K. Le Guin, scrisse che sua �glia era diventata una villana dopo la lettura de La fabbrica di cioccolato.Oggi fortunatamente i libri di Roald Dahl sono ampiamente apprezzati per la sua scrittura libera, fuori da regole e schemi, ricca di parole inventate (basti pensare a come parla il Grande Gigante Gentile), pervasa da un umori-smo a volte feroce ma divertente, una scrittura così vicina all’immaginazione che ogni bambino ha dentro di sé e così carica di quella sana ribellione utile ad ogni bambino per crescere libero e indipendente.
UNA STRAORDINARIA STORIA DI AMICIZIA Possiamo considerare Il GGG la storia di due solitudini che un giorno si incontrano e, superate le prime di�den-ze, sentono che uno può essere utile all’altro, capiscono che stanno bene insieme perché ognuno ha qualcosa di buono da mettere a disposizione. Ma soprattutto ciò che li incoraggia a darsi una mano, a credere l’uno nell’altro e a farsi accettare per quello che sono, è la gentilezza! E che cos’è la gentilezza se non la via per stare insieme senza farsi male, la via per dialogare con l’altro senza costruire muri e senza sopra�azioni, la via per rispettare la dignità dell’altro, indipendentemente da come si è? La Sophie che conosciamo all’inizio del �lm è una bambina vispa, intelligente, consapevole del posto in cui si

1. Descrivi Sophie. Che tipo di bambina è? Come si comporta? Ti assomi-glia? In cosa in particolare?
2. All’inizio del �lm Sophie legge un libro di Dickens? Ricordi il titolo? Perché lo legge di nascosto? Perché proprio Dickens? Che tipo di bam-bini ha raccontato Charles Dickens?
3. Ricordi la prima scena in cui appare il GGG? Descrivila. Che sensazioni esprime, per te?
4. In che senso Sophie e il GGG sono due “diversi”?5. E tu ti senti “diverso” rispetto ai tuoi compagni? In cosa esattamente?
Confrontati con i tuoi compagni di classe.6. Cosa contengono i barattoli che il GGG conserva nella sua caverna?
Qual è il compito che si è dato?7. A cosa servono i sogni che regala il GGG?8. Chi sono gli altri giganti presenti sull’isola? Come sono e cosa rappre-
sentano nella realtà?9. Come mai Sophie porta il GGG dalla Regina d’Inghilterra?10. Cosa la Regina ammira del GGG?11. Il suo modo “strano” di parlare a cosa corrisponde secondo te?12. Cosa impara Sophie dal GGG?13. Che �ne fa fare la Regina agli altri giganti? Sei d’accordo con la soluzio-
ne della Regina o tu ne avresti trovata un’altra? Quale ad esempio? Come interpreti la scelta della Regina?14. E tu cosa hai appreso da questa storia? Confronta la tua risposta con quella dei tuoi compagni.
L’INCONTRO TRA DUE GIGANTIPrima o poi sarebbe accaduto: il più grande regista vivente, che ha celebrato in molti suoi �lm l’incanto dell’infa-nzia, ha scelto di trasporre in immagini il romanzo più noto del più bizzarro scrittore per ragazzi che la letteratura abbia mai conosciuto. Stiamo ovviamente parlando di Steven Spielberg e Roald Dahl. Abbiamo ammirato negli anni passati la maniera in cui Spielberg ha raccontato l’infanzia in �lm come E.T., Ai con�ni della realtà, Jurassic Park, A.I. Intelligenza Arti�ciale ma anche in �lm storici come L’impero del sole, Schindler’s list e War Horse. Un’infan- zia segnata dalla necessità di fuggire dal mondo troppo piccolo creato dagli adulti, desiderosa di conoscere l’Altro, di ampliare lo sguardo e soprattutto desiderosa di scoprire il nuovo, il diverso che agli occhi dei bambini è meraviglia dell’universo. Non è un caso che i bambini di Spielberg non sono mai davvero arrabbiati, anche quando subiscono cattiverie da parte degli adulti. Semmai hanno lo sguardo aperto, gli occhi spalancati a volte spaventati ma non per paura quanto per aver colto l’inaspettato, per aver scoperto qualcosa che il mondo reale ha nascosto loro. I bambini di Spielberg insomma sono a loro modo ribelli e positivi, non distruttivi, sono attivi, si muovono nel mondo cercando, esplorando e così costruiscono speranze. D’altronde è l’infanzia stessa dell’auto-re che irrompe sullo schermo: «Non sono stato un bambino felice – racconta Spielberg – quando i miei genitori si sono separati ho so�erto tantissimo, mi sono sentito abbandonato. E questa sensazione dell’abbandono me la sono portata dentro per molto tempo, non solo, ma mi faceva sentire diverso dai miei compagni. A scuola poi, mi sentivo socialmente abbandonato. Non ero popolare. I ragazzi che ammiravo non mi permettevano di giocare con loro. Sono stato solo una comparsa nella mia vita, per molti anni. E questo sentimento ho provato a raccon-tarlo nei miei �lm». Anche Sophie è a suo modo una ribelle. Anzi è la prima cosa che ci viene raccontata di lei: mentre tutti gli altri nell’orfanotro�o dormono, lei legge romanzi e siccome è vietato, lo fa nascondendosi sotto la coperta facendosi luce con una torcia. E il libro che sta leggendo è la storia di altri bambini come lei, orfani, soli e ribelli come tutti i protagonisti dei libri di Dickens. Quando Sophie si avvicina alla �nestra per guardare in strada sa che sta facendo una cosa proibita: «Mai scendere dal letto, mai andare alla �nestra, mai vedere cosa c’è dietro la tenda» sono le regole dette e ripetute dell’orfanotro�o. Regole a cui lei verrà meno, senza ripensamenti. D’altr-onde se non avesse disubbidito non avrebbe mai conosciuto il Grande Gigante Gentile, cioè non avrebbe avuto un amico straordinario seppur immaginario. Sarebbe rimasta nel suo letto, schiacciata dalla solitudine.Anche i bambini raccontati da Roald Dahl sono ribelli, ma in modo diverso rispetto a quelli di Spielberg. Vivono storie decisamente più cattive, più buie, in cui la presenza degli adulti è davvero un peso insopportabile e a tratti
trova, delle regole che le sono state date, ma non si rassegna alla sua condizione. La curiosità, il bisogno di a�etto e di calore umano, il desiderio di scoprire mondi diversi da quello che già conosce la spingono a immaginare, immergendosi nella lettura di libri che divora in maniera segreta sotto le coperte, al buio, come se legge-re/fantasticare fosse l’attività più pericolosa di questo mondo. E che dire della possibilità di scorgere dalla �nestra le luci della strada che appaiono come fantasmi nel buio della notte e scoprire che di notte vive un mondo fantastico, a volte spaventoso, sicuramente strano e proibito? Sophie non vuole sottrarsi a questa possibilità. Come tutti i bambini e le bambine, Sophie si sente attirata e spaventata da ciò che non conosce e prova a fare piccoli passi in avanti per assaporare l’imprevisto. Ma questa volta lo sconosciuto è molto molto più grande di lei ed entra all’improvviso nella sua vita, prima che lei se ne accorgesse, in una scena bellissima in cui il nuovo, lo spaventoso, il meraviglioso l’accoglie nella sua mano gigantesca. È una delle scene simbolo del �lm perché racconta della delicatezza, della dolcezza con cui il magico, il fantastico accoglie la bam-bina e la trasporta in una terra in cui tutto è possibile anche creare sogni e regalarli ai più piccoli. Non è straordi-nario tutto questo? Sì, ma bisogna fare attenzione perché se lasciamo che i piccoli siano troppo liberi nella loro immaginazione, avremmo troppi ribelli nel mondo e questo non piace a chi decide quali debbano essere le regole da seguire. Per questo a un certo punto appaiono i giganti cattivi, i cui nomi ci dicono molto delle loro atroci abilità e abitudini: la loro missione non è tanto quella di mangiare Sophie (piccola com’è non basta a soddisfare l’appetito di nessuno di loro), ma quello di distruggere i sogni. Vomitoso, Strizza-teste, San-Guinario, Inghiotti-cicciaviva, Trita-bimbo, Spella-fanciulle, Scotta-dito sono avidi, violenti, rozzi, ignoranti, stupidi esatta-mente come chiunque usi la violenza per piegare l’altro alla propria volontà. È una lotta impari quella che si viene a creare tra loro e il fratello più piccolo (il nanerottolo lo chiamano) e Sophie. Ma a vincere saranno proprio loro due, i più piccoli, perché hanno armi più intelligenti, più profonde, più ra�nate che sono la gentilezza, l’ami-cizia necessarie per raggiungere obiettivi più alti (non già il riempirsi la pancia) come l’a�ermazione della giusti-zia, l’accettazione delle diversità, il potere dell’immaginazione, la difesa della libertà.
LA GENTILEZZA RENDE GRANDILa gentilezza non è solamente forma, se si riduce a questo diventa ipocrita. La gentilezza di cui ci parla Il GGG è sostanza e coerenza. Basti pensare alla maniera in cui il Gigante Gentile protegge Sophie dai suoi fratelli cattivi o alla maniera in cui difende la sua diversità (è il più basso dei Giganti e per questo deriso) o alla maniera in cui custo-disce il suo dolore più profondo. A un certo punto il GGG mostra a Sophie il vaso in cui ha racchiuso il suo incubo peggiore: dentro ci sono i rimorsi e il dolore per qualcosa da cui non può più tornare indietro ovvero la scomparsa del bambino che per primo era diventato amico del GGG, scoperto e divorato da altri giganti cattivi. Da allora lo scopo del GGG è proteggere tutti i bambini che decide di portare con sé perché nel mondo reale nessuna infan-zia deve essere o�esa, violata, nessun bambino deve diventare vittima delle disattenzioni, delle distrazioni. Sophie per lui diventa quindi il simbolo dell’infanzia, un’età in cui l’idea del mondo che ci si fa, dipende soprat-tutto dai buoni o dai cattivi esempi che si ricevono. Il GGG arriva in un momento particolare della vita della bam-bina: ha dieci anni, che rappresentano un po’ il con�ne tra l’infanzia e la preadolescenza, cioè è una fase in cui il fantastico e il reale assumono dei contorni più chiari e �nalmente ci si può prendere la responsabilità e la libertà di farli comunicare per creare qualcosa di diverso. Magari più giusto… e più divertente. Si, perché un concetto chiaro che Il GGG esprime con forza è che non è vero che se si è gentili si è deboli, s�gati, come dicono alcuni. Al contrario, se si è gentili e leali e amici veri, si fanno esperienze strabilianti come essere invitati dalla Regina e risultare interessanti, originali, divertenti. Di contro chi usa la forza, l’arroganza, la violenza non è per niente �go, anzi è davvero ributtante come i giganti del �lm, ma contro di loro il Gigante Gentile e Sophie non sentono desiderio di vendetta, solo giustizia. Per questo il �nale non vede l’eliminazione del nemico ma viene data loro una specie di punizione “educativa”, ripa-ratoria: vengono mandati su un’altra terra a imparare a coltivare e mangiare cetrionzoli. «La magia ci fa essere intraprendenti – ha detto Spielberg – la speranza viene da lì».
Seven Spileberg nasce il 18 dicembre del 1946 dall'ingegnere elettrico Arnold Spielberg e dalla pianista concertista Leah Adler. La sua famiglia, di origine ebraica, vive per qualche
tempo nel New Jersey, poi si trasferisce a Scottsdale, in Arizona, dove Steven cresce. Desti-nato a diventare uno dei più grandi registi del suo tempo, Spielberg rimane l'unico tra i maggiori cineasti della sua generazione – a cominciare da George Lucas, amico di una vita – a non avere alle spalle studi universitari di cinematogra�a. Sostituisce però la
scuola con una pratica da autodidatta cominciata �n da ragazzino quando i genitori gli a�dano l'uso di una cinepresa ad 8 mm per registrare le gite di famiglia. In realtà, oltre alle
gite, il giovane Steven prende l'abitudine di girare �lmetti a soggetto in cui dà già prova della sua propensione per il fantastico e del suo gusto per gli e�etti speciali. Uno di questi �lmetti, Escape to Nowhere, vince un concor-so cineamatoriale; un altro, il fantascienti�co Firelight viene proiettato in una sala e incassa 500 dollari. Da giova-ne comincia a frequentare gli studi della Universal e la leggenda vuole che vi si sia introdotto allestendo clande-stinamente un u�cio nei locali vuoti di una portineria, e che i custodi, ai quali si presenta sempre in giacca e cravatta, lo lasciassero passare credendolo di casa. In ogni modo, Spielberg non riesce a far vedere le sue prime prove a qualcuno che conti e solo quando Amblin', il suo primo �lm in 35 mm, un cortometraggio di 24 minuti, vince premi al Festival di Venice e di Atlanta, la Universal si accorge di lui e lo mette sotto contratto nella sua sezione televisiva. Per la TV, nel 1971, gira Duel che è considerato a tutti gli e�etti il primo �lm di Spielberg. In questo primo �lm si vedono già le caratteristiche della sua narrazione: la propensione agli e�etti speciali e il tema l'uomo comune che si trova a misurarsi con circostanze eccezionali e a tirare fuori l'eroismo che non pensa-va di avere. Il �lm diventerà un cult per l'eccezionalità dell'essere stato girato in soli tredici giorni. Nel 1974 gira The Sugarland Express: road movie ispirato a un fatto di cronaca, racconta la tragica fuga attraverso il Texas di un evaso e di sua moglie, i quali corrono a riprendersi il �glioletto dato in adozione; con questo lavoro il regista ottiene il premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes, ma non un grande successo di pubblico, probabilmente per i toni troppo cupi e drammatici della pellicola. Un anno più tardi, con Lo squalo, si fa conosce-re al grande pubblico; nonostante le di�coltà legate alla sua inesperienza, a un malfunzionante squalo mecca-nico, alle di�coltà climatiche che lasciano pochissime ore al giorno per le riprese in esterni (in mare aperto) il �lm è campione d'incassi (470 milioni di dollari), vince tre Oscar, e causa addirittura una sorta di psicosi colletti-va, tanto da far registrare un calo di turisti nelle località balneari. Nel '77 ottiene un altro clamoroso successo con Incontri ravvicinati del terzo tipo e di fatto riscrive le regole del genere fantascienti�co, che volevano gli alieni nei panni dei mostruosi conquistatori, dandone una visione assai più benevola, "umanizzante". Con questo �lm ottiene la prima nomination agli Oscar, per la miglior regia. Dopo lo scarso successo di 1941: allarme a Hollywood (1979), commedia sull'isteria collettiva antigiapponese che si di�use in America dopo Pearl Harbor, torna ad incassi da record nel 1980 con I predatori dell'arca perduta, scaturito da un'idea sviluppata insieme a George Lucas (reduce dall'enorme successo della saga di Guerre Stellari), con cui nasce il personaggio dell'avventuroso archeologo Indiana Jones, che Spielberg riprenderà nell'84 (Indiana Jones e il tempio maledetto) e nell'89 (India-na Jones e l'ultima crociata). Nel frattempo torna alla fantascienza con un �lm che meglio di altri rappresenta la sua idea di cinema come strumento per accendere sogni, stupori, fantasie: E.T. L'extraterrestre del 1982, storia del piccolo alieno dimenticato dalla sua astronave, solo e smarrito sulla Terra: è così che batte tutti i record d'incasso della storia del cinema. La pellicola vale al regista la terza nomination agli Oscar. A partire dal 1982 Spielberg comincia a occuparsi anche di produzione e fonda la Amblin Entertainment (in omaggio al titolo del suo primo cortometraggio) assieme ai colleghi Kathleen Kennedy e Frank Marshall: la casa produce �lm campioni di incassi come la trilogia di Ritorno al futuro di Robert Zemeckis. Nel 1985 gira Il colore viola, storia tratta da un romanzo di Alice Walzer che racconta di una donna di colore salvata dai maltrattamenti del marito grazie ad un'amica. Del 1987 è L'impero del Sole, in cui racconta le vicissitudini di un bambino inglese che, al momento dell'occupazione giapponese di Shangai nel '41, perde i genitori e si ritrova a trascorrere gli anni della guerra da solo, passando da un campo di prigionia all'altro. Dopo il romantico Always – Per sempre (1988), in cui recita anche Audrey Hepburn, gli anni 90 si aprono con il ritorno di Spielberg al genere fantasy: Hook – Capitan Uncino (1991), in cui immagina un Peter Pan sposato e con �gli, e tuttavia coinvolto in misteriose avventure: il �lm ha un chiaro riferi-mento alle dinamiche di relazione fra adulti e ragazzi, fra genitori e �gli, e quindi ad una componente autobio-
gra�ca. Ma è soprattutto con Jurassic Park (1993), che avviene la consacrazione a re del genere fantascienti�co e il raggiungimento di un nuovo record storico di incassi. Non ancora terminata la post produzione di quel �lm, Spielberg si lancia nell'avventura di Schindler's List (1994), in cui riesce a raccontare la tragedia dell'olocausto attraverso l'itinerario umano e morale di un imprenditore iscritto al partito nazista, che si ritrova a mettere in salvo migliaia di ebrei dapprima quasi per caso, poi con consapevolezza e dedizione sempre maggiori. Con Schindler's List, vince sia il premio per il miglior �lm sia quello per la miglior regia. Spielberg è particolarmente legato a questa sua opera, essendo lui stesso di origini ebraiche e avendo provato sulla propria pelle, soprattut-to in gioventù, gravi episodi di discriminazioni, come ricorda in numerose interviste. Dopo questo enorme successo dà un seguito a Jurassic Park con Il mondo perduto (1997) e realizza Amistad (1997) – storia della rivolta di un gruppo di neri contro l'equipaggio della nave che, nel 1839, li porta da Cuba agli Stati Uniti per venderli come schiavi. Nel 1998 è la volta di Salvate il soldato Ryan con quest'ultimo �lm, ottiene anche il suo secondo Oscar come miglior regista, ma la pellicola ne ottiene altri quattro per la fotogra�a, il montaggio, il sonoro e gli e�etti sonori. Nel 2002 esce Minority Report, tratto dall'omonimo romanzo di P. K. Dick, interpretato, fra gli altri, da Tom Cruise e arricchito da echi di Kubrick e Hitchcock. Sempre del 2002 è Prova a prendermi, con Leonardo Di Caprio. Nel 2004 dirige The Terminal con Tom Hanks, ispirato alla vera storia del rifugiato iraniano Mehran Nasseri bloccato all'aeroporto di Parigi. Del 2005 è, invece, La guerra dei mondi – girato in soli tre mesi sgomberando un intero quartiere di una cittadina del New Jersey – in cui il regista torna a collaborare con Tom Cruise: l'atmosfera cupa e drammatica del �lm è certamente ancora in�uenzata dai fatti dell'11 settembre. Sempre di un episodio terroristico racconta anche Munich, grande successo dello stesso anno, ispirato al terribile massacro di israeliani perpetrato durante i Giochi Olimpici di Monaco '72 e la cui ossatura è costituita dall'adattamento del libro-in-chiesta del giornalista canadese George Jonas. Nel 2008 Spielberg torna al passato girando il quarto episodio di "Indiana Jones”. Nel 2011 decide invece di misurarsi con la spettacolare animazione in 3D con Le avventure di Tintin: il segreto dell'unicorno. Nel 2012 è di nuovo un tema politico e storico a ispirarlo: la biogra�a del presiden-te degli Stati Uniti che abolì la schiavitù cambiando la storia per sempre Lincoln. Del 2015 è Il ponte delle spie. Il GGG è il suo ultimo �lm.
Con quali libri per l’infanzia è cresciuto lei?Ai miei tempi c’era un numero pietosamente limitato di libri per ragazzi, rispetto alla massiccia o�erta di oggi, con libri illustrati meravigliosi. I miei genitori mi leggevano i Little Golden Books, libri pratici sui mestieri. Dopo Five little �remen volevo fare il pompiere. Poi al libro successivo volevo fare il poliziotto. Poi sono arrivati i romanzi come Black Beauty di Anna Sewell e le avventure degli Hardy Boys di Franklyn Dick-son. Poi mi compravano anche storie terri�canti. Stavano sullo sca�ale per ragazzi, ma erano horror. Racconti che mi facevano paura pur attraendomi. Credo che molto del mio mondo fantastico provenga da ciò che mi spaventa.Com’è cambiato il mondo dell’immaginazione tra rete e tablet?Noi eravamo abituati a qualche programma tv, una manciata di classici, un libro da colorare. Oggi, dalla libreria al tablet, si trova di tutto. Questo signi�ca che siamo noi genitori a mettere i �ltri, creare la biblioteca. Stabilire senza delegare agli altri, cosa è appropriato per l’età dei nostri �gli, quali sono i giusti valori.Ha avuto un amico immaginario a farle compagnia?Non un bambino. La mia fantasia non aveva corpo. Era l’abilità di immaginare e di spaventare me stesso con la stessa immaginazione. Se mi guardavo allo specchio per più di un minuto mi venivano in mente orribili immagini. Le nuvole in cielo, le guardavo sdraiato a cinque anni, mi sembravano cigni bellissimi che subito dopo si trasformavano in orribili mostri.
(dichiarazioni tratte dall’intervista di Maurizio Turroni per Famiglia Cristiana del 25.12.2016 e dall’intervista di Arianna Finos per la Repubblica del 14.12.2016)
Qual è l’elemento del romanzo che l’ha conquistata?Dahl racconta i valori in cui credo, a partire dall’accettazione del diverso. E poi è la storia d’amore che avevo sempre cercato: quella di un bambino per il genitore e di un genitore per un bambino. Adoro l’assoluta man-canza di cinismo dei protagonisti. Sono due anime solitarie che, pur appartenendo a mondi diversi, hanno lo stesso grande cuore.Lei ha mai letto il romanzo di Dahl ai suoi �gli?Certo che sì. A tutti e sette! Innumerevoli volte. Ognuno ha avuto reazioni diverse. C’è chi si è identi�cato nel gigante, chi in Sophie o in Peter, uno persino nel maggiordomo. Tutti poi ridevano alle bu�e parole di inventate da Dahl: i popolli, Inghiotticicciaviva, Ciucciabudella, San Guinario, Vomitoso.Sophie è un’orfana. Nei suoi �lm Lei spesso parla di famiglie assenti o disfunzionali…Conosco il senso di abbandono. Il personaggio che ha un trauma e trova il modo di superarlo è il vero eroe. Sono �glio di divorziati e per me e le mie sorelle la separazione dei genitori è stata so�erenza vera.Che senso ha fare �lm, creare sogni, in una realtà piena di orrori?Più questo mondo peggiora, più abbiamo tutti quanti bisogno di magia per andare avanti. Cosa l’ha folgorata nel GGG di Dahl?Il personaggio di Sophie. È una ragazzina eppure ha la capacità di adattarsi a circostanze bizzarre, pericolo-se. Viene portata via dall’orfanotro�o, entra nel Paese dei Giganti eppure inizia a dialogare subito con il suo rapitore, mettendo da parte la paura per capire se questo gigante sia buono o malvagio. Mi son fatto guida-re dalla sua empatia per questa strana creatura. Sono due anime solitarie che incontrandosi trovano il proprio posto nel mondo.
FERMO IMMAGINE
orizzonti di luceorizzonti di luce 8
Scheda a cura di Rosa Ferro
terri�cante, come in un racconto horror. Anche se, a dire il vero, Il GGG rispetto agli altri libri di Dahl è più tenero, divertente, probabilmente perché l’autore l’ha scritto come una delle tante �abe della buona notte che doveva portare serenità alle sue �glie prima e alle sue nipotine dopo. Forse la più grande di�erenza tra Spielberg e Dahl sta nel fatto che il primo intravvede sempre la luce pur attraversando le tenebre, il secondo la luce non riesce neanche a scorgerla e i suoi racconti spesso lasciano una certa amarezza, una sensazione profondamente legata alla realtà, pur essendo la sua scrittura molto creativa e fantasiosa. Anche qui dobbiamo scomodare l’infanzia e ancor di più l’adolescenza dell’autore, segnate da morti importanti e da un’educazione sin troppo rigida. Dahl ad esempio perse sua madre all’età di soli quattro anni. Per un po’ visse con la nonna che adorava ma a un certo punto suo padre decise di risposarsi e Dahl bambino dovette vivere un’altra separazione dolorosa, quella dalla nonna appunto, per dare posto ad una donna giovane ma autoritaria. Inoltre la scuola che Dahl ragazzino frequentò era un college di buona fama ma in cui l’educazione e la disciplina si trasmettevano attraverso puni-zioni corporali e psicologiche e dominavano gli atti – diremmo oggi – di bullismo feroce, da parte dei ragazzi più grandi verso quelli più piccoli. E Dahl, pur essendo alto già a quindici anni 1 metro e 98 centimetri, non riuscì a sottrarsi alle violente pratiche dei college inglesi di quegli anni. Ma riuscì a resistere. Il suo modo per a�rontare e sopportare la brutalità del college consisteva nel reprimere le emozioni, nel non con�darsi mai con nessuno, chiudendosi anche lui come Spielberg nel silenzio e nella solitudine, più tardi riem-piti dalla loro fervida immaginazione. Anche la vita di Dahl adulto è stata costellata da lutti importanti: a 7 anni muore sua �glia Olivia che ispira la �gura proprio di Sophie per Il GGG. «Fumava sigarette Dunhill, odorava di sapone da barba e aria fresca, aveva la voce calda e famigliare come il rumore di passi su pavimento di legno» ha raccontato al Guardian sua nipote Sophie, �glia di Tessa, secondogenita di Dahl. Sono state le sorelle minori Olivia e Lucy, ad ascoltare per prime, in forma di racconto della buona notte quello che sarebbe stato Il GGG. Quando le bambine andavano a letto il “gigante” Dahl saliva su una scala, prendeva una lunga canna di bambù e giocava a so�are sogni per tutta la stanza. L’idea del gigante che raccoglie sogni chiudendoli in delle scatole per poi o�rirli ai bambini per farli felici durante il sonno, è un’idea che inseguiva da tempo lo scrittore anglo-nor-vegese. Ed è così che i bambini di Dahl sono creature che resistono alle crudeltà dei più grandi, che a�rontano le peggiori di�coltà senza mai abbattersi e senza mai mostrarsi sentimentali, che a�rontano la morte come qualcosa di terribile ma reale. Ad esempio in Matilda vediamo genitori che non capiscono la propria �glia, anzi la detestano perché chiede regole ed educazione, in Willy Wonka i bambini possono scomparire per sempre o tornare a casa dopo molto tempo, in Le streghe i bimbi vengono trasformati in topi e ci rimangono! A Dahl insomma non interessa il lieto �ne, il �nale consolatorio del “vissero tutti felici e contenti”! Ed è per questo che mentre i �lm di Spielberg sono stati sempre ben accolti dal pubblico in tutto il mondo, i libri di Dahl furono molto ostacolati perché considerati volgari, violenti, non adatti ai ragazzi. Nell’unica autobiogra�a autorizzata da Dahl e scritta da Donald Sturrock si racconta di un’editrice orgogliosa di aver ri�utato per due volte di pubbli-care i suoi libri. Ad esempio Eleanor Cameron, autrice per bambini canadese de�nì La fabbrica di cioccolato un libro scadente, di cattivo gusto, sadico e orribile e pericoloso per i bambini. Un’altra scrittrice di fantascienza, Ursula K. Le Guin, scrisse che sua �glia era diventata una villana dopo la lettura de La fabbrica di cioccolato.Oggi fortunatamente i libri di Roald Dahl sono ampiamente apprezzati per la sua scrittura libera, fuori da regole e schemi, ricca di parole inventate (basti pensare a come parla il Grande Gigante Gentile), pervasa da un umori-smo a volte feroce ma divertente, una scrittura così vicina all’immaginazione che ogni bambino ha dentro di sé e così carica di quella sana ribellione utile ad ogni bambino per crescere libero e indipendente.
UNA STRAORDINARIA STORIA DI AMICIZIA Possiamo considerare Il GGG la storia di due solitudini che un giorno si incontrano e, superate le prime di�den-ze, sentono che uno può essere utile all’altro, capiscono che stanno bene insieme perché ognuno ha qualcosa di buono da mettere a disposizione. Ma soprattutto ciò che li incoraggia a darsi una mano, a credere l’uno nell’altro e a farsi accettare per quello che sono, è la gentilezza! E che cos’è la gentilezza se non la via per stare insieme senza farsi male, la via per dialogare con l’altro senza costruire muri e senza sopra�azioni, la via per rispettare la dignità dell’altro, indipendentemente da come si è? La Sophie che conosciamo all’inizio del �lm è una bambina vispa, intelligente, consapevole del posto in cui si