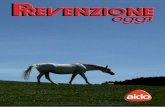00 cop somm edit nov 15:Prevenzione 2009 · lizzato l’intervista che pubblichiamo qui di seguito,...
Transcript of 00 cop somm edit nov 15:Prevenzione 2009 · lizzato l’intervista che pubblichiamo qui di seguito,...


Ricette d’autunno29pagina
32pagina
Notizie dalle Sezioni
36pagina
Notizie dal mondo
2pagina
Prelievo di fegatoin paziente a cuore fermoIl Policlinico di Paviaè già nel futuro
Home: qui nessuno è stranieroAccoglienza per i trapiantati e le loro famiglie
19pagina
Aperte con l’Aido Lombardia le celebrazioni per i 60 anni dalla morte del Beato don Carlo Gnocchi
15pagina
A proposito di... cellule staminali25pagina
Spazio ai lettoriPer gli interventi dei lettori:
È attivo il sito dell’Aido Regionale:
www.aidolombardia.it
SommarioP
revenzioneO
gg
i
Mensile di cultura sanitaria del Consiglio RegionaleAido Lombardia - ONLUS
Anno XXIV n. 230 - novembre 2015
Editore: Consiglio Regionale Aido Lombardia - ONLUS 24125 Bergamo, Via Borgo Palazzo 90Tel. 035 235327 - fax 035 244345 [email protected]
Direttore ResponsabileLeonio Callioni
Direttore EditorialeLeonida Pozzi
Collaborazioni scientificheDott. Gaetano Bianchi
Dott.ssa Cristina Grande
Regione Lombardia - SanitàProf. Sergio VesconiCoordinatore regionale prelievo/trapianto
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo
Dott. Michele ColledanDirettore Chirurgia Generale III Direttore Centro Trapianti di fegato e di polmoni
Dott. Giuseppe LocatelliConsulente del Dipartimento di Chirurgia Pediatrica
Prof. Giuseppe Remuzzi Direttore Dipartimento di Medicina
Azienda Ospedaliera A. Manzoni di Lecco
Dott. Amando GambaDirettore U.O. Cardiochirurgia
Università Milano Bicocca
Prof. Roberto FumagalliDocente
NITp - Nord Italia Transplant
Dott. Massimo Cardillo - Presidente
Dott. Giuseppe Piccolo - Direttore Cir
Istituto Mediterraneo Trapianti e Terapie di alta specializzazione - ISMeTT di Palermo
Prof. Bruno GridelliDirettore Medico scientificoProfessore di Chirurgia Università di Pittsburgh
Istituto Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” - Bergamo
Prof. Giuseppe Remuzzi - Direttore
Yale University School of Medicine
Prof. Mario StrazzaboscoProfessor of Medicine,Director of Transplant HepatologyDepartment of Internal MedicineSection of Digestive Diseases
Redazione esternaLaura Sposito; Clelia Epis; Fernanda Snaiderbaur
Redazione tecnicaBergamo [email protected] Seminati
Segreteria e Amministrazione24125 Bergamo, Via Borgo Palazzo 90Tel. 035 235327 - fax 035 [email protected]@aidolombardia.itC/C postale 36074276Marzia TaiocchiLaura Cavalleri
SottoscrizioniSocio Aido Simpatizzante Sostenitore Benemerito € 40,00 € 50,00 € 80,00 € 100,00
C/C postale 36074276 Aido Cons.Reg.LombardiaONLUS Prevenzione OggiC/C UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMOIT 57 R 05428 11106 000 000 071 903
Riservato ai Soci.
Il socio sostenitore ha diritto ad omaggiare un’altra per-sona previa segnalazione all’atto della sottoscrizione.
StampaCPZ - Costa di Mezzate BG
Finito di stampare prima decade di dicembre
Reg. Trib. di Milano n. 139 del 3/3/90Le informazioni contenute in questo periodicovengono trattate con liceità, correttezza e tra-sparenza conformemente al D.lgs. n. 196 del 30giugno 2003 “Codice in materia di protezionedei dati personali”.
Questo periodico è associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
800 20 10 88NUMERO VERDE
Risponde l’Aido Lombardia

Inco
pertin
a
1
Editoriale
In copertina:«BRIVIO BACIATA»foto di MMassimo Spinelli - Fotoclub Airuno (Lc)
Non si sorprendano i nostri affezionati lettori: al prelievo e al succes-sivo trapianto di fegato a cuore fermo abbiamo dedicato molto spa-zio. La ragione di questa scelta editoriale è semplice: mettere ingiusta luce un avvenimento che potrebbe essere e probabilmente saràl’inizio di una nuova era dei trapianti. Dentro la notizia dell’uti-
lizzo di un fegato prelevato a una persona in asistolia (definizione tecnica del“cuore fermo”) c’è infatti la grande novità della nascente “clinica degli organi”.Questa innovativa forma di prelievo, ideata dal vulcanico dott. Paolo Geraci, co-ordinatore di zona dei trapianti a Pavia, operativo presso il Policlinico pavese,prevede infatti un passaggio per il “ricondizionamento”, una vera e propria “re-visione” dell’organo, allo scopo di pulirlo, guarirlo dalle sofferenze dovute allamancanza di ossigeno durata diversi minuti, eliminare ogni possibilità di infe-zione. Insomma, nel futuro dei trapianti c’è la possibilità di utilizzare organi re-
cuperati riportati alla condizione migliore. E’ un sogno che siavvera; ancora una volta nel più totale silenzio della stampa,della tv e della comunicazione in generale. Ma questo non sor-prende. E’ purtroppo più facile inseguire scandaletti o rovistarenel torbido per offrirlo poi in prima serata ad un pubblico sem-pre più massificato che fare la fatica di andare a cercare ciò chedà speranza. Ma questa ricerca del buono e del bello, che pureesistono, non è fine a sé stessa, non è per “fare una cosa moral-mente giusta”. Raccontare la buona sanità significa raccontarele fatiche, le intuizioni, le potenzialità scientifiche di medici, ri-cercatori, chirurghi, infermieri, responsabili nei diversi settori.Significa portare la comunità a riconoscerne i meriti affinchéla politica li valorizzi e li sostenga. Basta vedere le sorti delPoliclinico di Pavia per capire il succo del mio ragionamento.
Con grandi uomini è un grande Policlinico; senza i grandi uomini rischierebbedi impoverirsi scientificamente e chirurgicamente. Con il risultato che diminuirela potenza di contrasto alla malattia, alla sofferenza, al dramma di tante fami-glie. Nella sanità, non in altri settori, si gioca la partita più importante per unacomunità. Ma la sanità ha bisogno di essere sostenuta da cultura, etica, educa-zione, buona stampa.
Su questo numero della rivista concludiamo il racconto delle manifestazionidedicate al beato don Carlo Gnocchi, un grande dell’umanità, che ha contribuitoad aprire le nuove frontiere dei trapianti con la sua ferma volontà di offrire le cor-nee per il trapianto quando ancora la legge non lo permetteva.
A mio avviso interessanti tutti gli altri articoli sui quali non posso qui soffer-marmi ma di cui raccomando la lettura. Un cenno prima di chiudere la voglio fareinvece alle Sezioni e ai Gruppi. I responsabili attivi su tutto il territorio regio-nale hanno potuto constatare che, se vogliono, lo spazio alle loro iniziative più in-teressanti su “Prevenzione Oggi” c’è sempre e ben curato. Si tratta però dicontinuare a fare due cose: la prima è scriverci; la seconda è quella di fare un po’di selezione, cercando quello che può essere utile non solo ai lettori ma anche aglialtri dirigenti dell’Associazione.
Quindi, coraggio, continuate a scriverci. “Prevenzione Oggi” è il nostro stru-mento di dialogo privilegiato.
Leonida Pozzi
Nella notizia del trapianto di fegato prelevato a cuore fermo la grande novità
di una futura “clinica degli organi”?
Pre
venz
ione
Og
gi
Alba sul paese di Brivio,uno dei più caratteristici sull'Adda.

2
Prevenzione
Og
gi
Sono almeno due i rischi del-le notizie positive, così rareai nostri tempi, quando ar-rivano dal mondo della sa-nità: il primo è che la noti-
zia interessi poco a stampa, tv e radio; ilsecondo è la distorsione che questo mon-do della comunicazione fa, ormai invo-lontariamente e inconsapevolmente, del-la notizia stessa perché diventi interes-sante agli occhi del grande pubblico.Il prelievo di un fegato da un paziente “acuore fermo”, avvenuto al Policlinico SanMatteo di Pavia e il successivo esito po-sitivo del trapianto effettuato all’ospedaleNiguarda di Milano, ha corso entram-bi i rischi. Solo pochi ne hanno colto lareale e rivoluzionaria portata, ma pur-troppo anche questi pochi hanno rivesti-to gli articoli di un’enfasi per nulla scien-tifica e perciò pericolosa per gli effetti chepotrebbe avere se questo trapianto nel tem-po non dovesse dimostrare tutta la sua ef-ficacia. Da sottolineare che di questo ge-nere di trapianti ne è stato realizzato unaltro, pochi giorni dopo, ancora da do-natore “a cuore fermo”, ancora preleva-to al San Matteo e ancora trapiantato al-l’Ospedale Niguarda di Milano.
PRELIEVO DI FEGATOIN PAZIENTE A CUORE FERMO
IL POLICLINICODI PAVIA
È GIÀ NEL FUTURO

“Prevenzione Oggi” ha ritenuto dove-roso approfondire questo fatto e ha rea-lizzato l’intervista che pubblichiamo quidi seguito, con la speranza di avere fat-to un buon servizio sia ai lettori che allacultura della donazione nel senso più am-pio del concetto. Perché non è vera cultura se non si fon-da su basi scientifiche. L’intervista, rea-lizzata a Pavia, presso il San Matteo, èstata resa possibile dalla signorile, attentae competente disponibilità del coordina-tore ospedaliero ai trapianti, dott. Geraci,che ci ha accolti in équipe con la dott.ssaZanierato e con l’infermiera dott.ssaTosi. A Pavia siamo stati accolti e accompa-gnati dalla dott.ssa Enrica Negroni, ef-ficiente e ottima presidente della Sezio-ne Aido della provincia pavese, che ci haaiutato in questa nuova e bella avventu-ra comunicativa di cui vogliamo ora farpartecipi i lettori. Punto d’incontro,presso l’ospedale San Matteo, la “Stan-za della vita”, unica nel suo genere inLombardia e probabilmente in Italia, dicui “Prevenzione Oggi” ha dato notiziain occasione della inaugurazione. Da quiparte il nostro dialogo.P
reve
nzio
neO
gg
i
3
Cur
ricu
lum
vita
e
PAOLO MARIA GERACI Consegue la maturità classica (1970) aNovara, sua città natale (1951). Si laurea inMedicina e Chirurgia presso l’Università diPavia (1976). Si specializza in Anestesiologia eRianimazione (1979) e in Scienzadell’Alimentazione (1982) presso la stessaUniversità. Svolge attività di anestesista-rianimatore con il prof. Giulio Frova pressol’Ospedale Predabissi di Melegnano (1978-79) e, dal 1979, di rianimatore con il prof.Arturo Mapelli presso il Policlinico San Matteodi Pavia. Assiste, tra gli anni ’70 e ’80, ai primiprelievi di organi a scopo di trapianto di cuiMapelli è un precursore in Italia. Dal 2001 èstato “coordinatore locale del prelievo di organie tessuti” dell’area provinciale di Pavia.Attualmente dirige il centro di Coordinamentoper le Donazioni e i Trapianti del San Matteo.È stato membro eletto del Consiglio Direttivodel NITp (2007-2009). È docente TPM eprofessore di Trapiantologia all’Università diPavia. Ha progettato e realizzato nellaFondazione IRCCS Policlinico San Matteo diPavia, primo in Italia (2007), il programma diprelievo di organi da donatori a cuore fermo,“Programma Alba”. Fa parte del gruppo diesperti sul prelievo a cuore fermo del CentroNazionale Trapianti (CNT). È autore dipubblicazioni scientifiche (e non solo) ed èstato relatore invitato a numerosi corsi econgressi. Ha scritto (2015) le Linee guidaCNT (“Criteri clinici e raccomandazioni praticheinerenti l’accertamento di morte in soggettisottoposti ad assistenza circolatoriaextracorporea”) e la Position Paper del CNT(“Determinazione di morte con criteri cardiaci.Prelievo di organi a scopo di trapianto dadonatore in asistolia”).

4
Prevenzione
Og
gi
Pozzi: Davvero accogliente questasala. Nella sua semplicità e nella so-brietà permette di ricreare un climafamigliare, affettuoso, mi verrebbe dadire quasi protettivo.Negroni: Ci pensavamo da tempo. Èun impegno di Aido Pavia che nellarealizzazione di questa “Stanza del-la vita” è stata aiutata dal Rotary del-la provincia di Pavia. Ed è un impe-gno che ha portato alla realizzazio-ne di questo luogo di composizionedel dolore, di facilitazione del dialo-go. In questo modo pensiamo diconseguire due diversi obiettivi: dauna parte accogliere in modo degnodel rispetto che dobbiamo ai fami-gliari di una persona appena decedutae dall’altro, proprio grazie a questamodalità più “umana”, facilitare lascelta della donazione. Se vogliamoche il valore del dono degli organi edei tessuti passi attraverso la sensi-bilità e la condivisione di un proget-to etico e morale, dobbiamo fare inmodo che tutto concorra. Non si puòaccogliere queste persone, in uno deimomenti più brutti e difficili della lorovita, in ambienti anonimi o addiritturaostili. Le persone devono essere mes-se in condizione di aprirsi, di fidarsi,di poter chiedere e avere tutte le ri-sposte che si aspettano. Per questo lastanza ricorda il salottino di casa. Quiil medico può, con calma e serenità,spiegare la situazione, dimostrareche per salvare la vita della personache è appena deceduta è stato fattotutto il possibile, e quindi introdur-re il concetto di donazione nel modomigliore. Per l’Aido provinciale di Pa-via è un bel risultato, considerato chemi sembra sia il primo e per ora uni-co non solo in Lombardia ma anchenel Nord Italia. Pozzi: Una domanda per il dott. Ge-raci, nella sua veste di coordinatoreprovinciale ai prelievi: abbiamo se-guito attraverso la stampa le notiziesul prelievo a cuore fermo e sul tra-pianto di questi organi. A Pavia si èavviata l’esperienza del prelievo a cuo-re fermo, che non è cosa semplice,perché chi lo fa deve camminare sulC
urri
culu
mvi
tae
MARINELLA ZANIERATO Nata a Vercelli il 12 gennaio 1969
1988 Maturità Classica (60/60) pressoLiceo Classico Lagrangia di Vercelli
1994 Laurea in Medicina e Chirurgia (110 e lode) presso l’Università
degli Studi di Pavia
2000 Specializzazione in Anestesia eRianimazione presso
l’Università degli Studi di Pavia
Dal 2000 Dirigente Medico I livello a tempoindeterminato presso il Servizio di
Anestesia e Rianimazione I IRCCSPoliclinico San Matteo
Dal 2002 Professore a contratto presso laScuola di Specializzazione
in Anestesia e Rianimazione
Dal 2011 titolare esclusivo come docentedelle Scuole di Specializzazione inNeurologia, Neurofisiopatologia e
Psichiatria e dei seguenti Corsi di studio:tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoriae perfusione cardiovascolare, tecniche di
laboratorio biomedico, tecniche dineurofisiopatologia, tecniche di radiologia
medica, tecniche ortopediche
2013 conseguimento di MasterIntenazionale in “donation of Organs,
Tissues and Cells for Transplantation”presso l’Università di Barcellona
2015 titolare di Struttura Semplice“Rianimazione in ambito
di donazione e trapianti d’organo”

5
Pre
venz
ione
Og
gi
filo di una normativa molto garanti-sta. Ho letto la vostra relazione su“Certificazione di morte con critericardiaci. Prelievo di organi a scopo ditrapianto da donatore in asistolia”. Lechiedo anche conferma: asistolia si-gnifica cuore fermo, è corretto?Geraci: Sì. La contrazione del ven-tricolo è la “sistole”; asistolia signi-fica mancanza di questa contrazione.Questo è il termine che preferirei usa-re al posto di “cuore fermo”. Infatti,sebbene i due termini siano equiva-lenti, dicendo cuore fermo si è forsepiù portati a pensare all’arresto car-diaco come causa di morte. L’impie-go della “circolazione extracorporea”(extra-corporeal membrane oxyge-nation: ECMO) ha molto cambiatol’approccio verso i pazienti in arrestocardiaco. Infatti quando il cuore si fer-ma – come ben sappiamo – la perso-na non è certamente morta. Se il cuo-re riparte in tempi brevi l’encefalo sisalva e la persona è viva. Se la riani-mazione non riesce a far ripartire ilcuore ma è stata in grado di prevenirela morte dell’encefalo, si può spingerea un livello più avanzato che preve-de l’impiego dell’ECMO. In questicasi il paziente è vivo, ma il suo cuo-re è fermo, cioè in asistolia. Se il suoencefalo subisce un danno irrepara-bile, quel paziente muore. Dal mo-mento che la circolazione del sangueè garantita dall’ECMO, la morte sideve accertare come se il cuore bat-tesse, cioè con criteri neurologici. Inquesti casi ci troviamo di fronte a unpaziente morto in asistolia (e non“per” asistolia). La ECMO, sebbenenon sia riuscita a salvare l’encefalo delpaziente (che quindi è morto), può sal-vare gli altri organi, garantendone laperfusione artificiale con sangue os-sigenato. Questa dei donatori “inasistolia in ECMO” è una categoriadi donatori “a cuore fermo” moltopromettente sia per numeri sia perqualità degli organi utilizzabili. Noiper primi li abbiamo osservati e de-scritti nel 2007, all’inizio della nostraesperienza con il Programma Alba,e li abbiamo inseriti nella classifica-
zione internazionale. Attualmentel’Ospedale San Raffaele, con il dott.Dell’Acqua, ne ha la casistica più nu-merosa e interessante in Italia. Pozzi: Converrà con me, però, chedire “a cuore fermo” è molto più ef-ficace che non dire “asistolia”. Ab-biamo letto con interesse del tra-pianto di fegato effettuato dal dott. DeCarlis, dell’Ospedale Niguarda diMilano e abbiamo poi verificato chein realtà la stampa e la tv hanno in-sistito solo sull’eccezionalità del tra-pianto. Per noi è invece spunto di ri-flessione l’eccezionalità del prelievo.E in ciò il Policlinico di Pavia, è al-l’avanguardia assoluta. Ricordo chegià da tempo avete proposto un pro-tocollo per il prelievo di rene in ca-davere a cuore fermo. Di questo pe-
raltro i lettori di “Prevenzione Oggi”ricorderanno l’intervista che lei ciconcesse alcuni anni fa. La possibili-tà di eseguire tale intervento di pre-lievo peraltro è stata elaborata al-l’interno della legge vigente, senza at-tendere nuovi decreti o modifiche le-gislative parlamentari. Geraci: Va bene, oggi parleremo di“cuore fermo”. In effetti le basi giu-ridiche sono state da noi ampiamen-te esplorate. Ricordo che all’inizio de-gli anni 2000, quando sognavo – ra-zionalmente - che anche in Italia unsoggetto morto con il cuore fermo po-tesse diventare un donatore non solodi tessuti ma anche di organi, non rac-coglievo molto consenso. Qualchesorriso e molto scetticismo. Mi si ri-spondeva che non si poteva fare e chebisognava prima cambiare la legge.Soltanto i chirurghi renali, MassimoAbelli e la allora giovanissima ElenaTicozzelli (ancora in Pronto Soc-corso), mi affiancavano e sosteneva-
Negroni: «Non si può accogliere queste persone, in unodei momenti più brutti e difficili della loro vita, inambienti anonimi o addirittura ostili. Le persone devonoessere messe in condizione di aprirsi, di fidarsi, di poterchiedere e avere tutte le risposte che si aspettano. Perquesto la stanza ricorda il salottino di casa».

no con il loro entusiasmo. Poi ho avu-to la fortuna di incontrare un giuri-sta “illuminato”, oggi caro amico, ilprofessor Giampaolo Azzoni del-l’Ateneo Pavese. Insieme abbiamo la-vorato sulle basi teoriche del Pro-gramma e verificato che, senza cam-biare nulla a livello legislativo, anchenel nostro Paese è assolutamentepossibile, lecito e, ancor più, dovero-so avviare il processo di donazione eprelievo di organi anche dopo lamorte “a cuore fermo”, qualunque siastata la causa per cui il cuore si è fer-mato. Anche nei casi – ma non vor-rei fare un salto troppo in avanti – incui il cuore si ferma dopo la sospen-sione delle cure rianimatorie. Non c’ènessuna legge che limita il prelievodegli organi dopo la morte, qualun-que tipo di morte. Le uniche due con-dizioni per poter avviare il processodi donazione e quindi il prelievo, siadi organi sia di tessuti, sono 1) la vo-lontà positiva del soggetto e 2) l’ac-certamento della morte secondo lalegge. Questo può essere fatto con cri-teri neurologici (6 ore, Collegio me-dico, Elettroencefalogramma, ecce-tera) o con criteri cardiaci (20 minu-ti di elettrocardiogramma: Ecg). Nondimentichiamo che nei paesi delmondo dove si fanno prelievi di or-gani da donatori a cuore fermo, lamorte per causa cardiaca viene de-terminata in tempi molto più brevi deinostri 20 minuti. In questi 20 minu-ti di registrazione Ecg la circolazio-ne è del tutto assente e il soggettonon può essere toccato; la nostra leg-ge è molto garantista perché 20 mi-nuti sono molto più che sufficienti perassicurarsi che l’encefalo si distrug-ga completamente. La scommessa ita-liana è quella di riuscire a prelevaree utilizzare gli organi dopo un periodocosì lungo di mancata perfusionesanguigna, obbligatorio per leggenei casi di accertamento con critericardiaci. Abbiamo prelevato e tra-piantato reni (che vanno benissimodopo anni), prelevato e valutato pol-moni, e ora anche fegati, di cui ci par-lerà Marinella, che sta raccogliendo
Prevenzione
Og
gi
6
Cur
ricu
lum
vita
e
SILVANA TOSI Nasce a Broni (Pv) nel 1974 e, dopo il diploma diInfermiere professionale (1993) inizia l’esperienzalavorativa sul campo, come infermiera, presso la
Rianimazione 2 del Policlinico San Matteo diPavia (1993-98), quindi presso la Centrale
Operativa Emergenza Urgenza 118 Pavia (1998-2009). Successivamente entra nel mondo
dell’Università come Infermiera “Tutor Clinico diarea critica” presso il Corso di Laurea
Infermieristica, con sede nel Policlinico di Pavia(2009-14). Nel 2013 consegue la laureaspecialistica in Scienze infermieristiche e
ostetriche a Pavia e, nel 2014, il Master di 1°livello in “Gestione del coordinamento delle
professioni sanitarie” a Roma. Dal 1 agosto 2014 è Coordinatore Infermieristicodel Centro Coordinamento Donazioni e Trapianti
della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico SanMatteo di Pavia. Oltre al Coordinamento
infermieristico delle attività di reperimento, prelievoe trapianto di organi e tessuti, tra cui il
Programma Alba di prelievo a cuore fermo,svolge intensa attività di docenza e formazionedegli operatori sanitari e non sanitari nel campo
dell’urgenza- emergenza, del soccorso extra-ospedaliero e delle attività relative al prelievo e al
trapianto di organi e tessuti. Ha insegnato pressol’Università degli studi di Pavia “Infermieristicaclinica in area critica”, “Infermieristica clinica in
Medicina”, “Infermieristica Generale” ed èattualmente Professore a contratto per il Master
di 1° livello di “Infermiere di Area Critica” presso lastessa Università.
Fa parte del Comitato Scientifico del master di 1°livello “Infermiere di Area Critica” dell’Università diPavia, iniziato nell’anno 2015-2015. Fa parte delGruppo infermieri dell’Area NITp e ha partecipatocome relatore a congressi in Italia ed è autore di
numerose pubblicazioni sul tema della emergenza-urgenza
e del prelievo di organi e tessuti.

la mia eredità e portando avanti, daprossimo Coordinatore locale di Pa-via, i progetti iniziati da anni con rin-novato entusiasmo e grande compe-tenza, affiancata in questo da Silva-na, validissima infermiera coordina-trice. Desidero però, prima di dar lorola parola, spiegare in breve quella cheè oggi la mia nuova “visione” del mon-do dei trapianti. Che cosa è stato fat-to in questi anni? Abbiamo modificatol’approccio al problema del migliorutilizzo degli organi. Siamo passati dauna realtà in cui, appena prelevato unorgano, bisognava trapiantarlo, aun’altra realtà che si sta via via con-solidando. Mi piace immaginarlacome “la cura degli organi”, o addi-rittura come “l’ospedale degli orga-ni”. Io credo che in questo momento,prima che si arrivi alla “fabbrica de-gli organi” dobbiamo pensare a or-ganizzare la cura degli organi, comese fossero veri e propri pazienti au-tonomi. Già oggi in molti casi, quan-do un organo viene prelevato, nel ri-spetto dei termini di legge, viene va-lutato, studiato e talvolta “ricondi-zionato” in laboratorio prima del-l’eventuale trapianto. Questo significa“curare” gli organi. Sottolineo: cura-re. Perché già si pensa di sommini-strare antibiotici, farmaci e altro, alsingolo organo, e anche di nutrirlo:l’amico Franco Valenza, ricercatore dilivello presso il Policlinico di Milano,ci stupirà in questo senso, credo, tranon molto. Se isoliamo l’organo i far-maci possono agire specificamente econ tutta l’efficacia potenziale, senzagli effetti collaterali sull’intero or-ganismo. Fino a ieri e, in parte, ancoraoggi si fa il possibile per accorciare itempi di attesa dell’organo primadel trapianto, la cosiddetta “ischemiafredda”. Il “ricovero” nel cosiddetto“ospedale per organi”, invece, non do-vrebbe essere necessariamente breve.Il “paziente-organo” dovrebbe rice-vere le cure necessarie per il temponecessario. Alla fine della degenza,dopo l’iter diagnostico-terapeutico,potrà essere dimesso dalla clinica. Serisulterà idoneo, proporzionalmente
alla sua qualità, sarà proposto e uti-lizzato per un ricevente adatto. Que-sto, a mio modo di vedere, è uno sce-nario straordinario e possibile: l’ospe-dale degli organi, che cura gli orga-ni dopo che sono stati prelevati, con-sentirà ai medici prelevatori di lavo-rare tranquillamente senza ansie esenza fretta, anche su donatori oggiforse non proponibili. Non sarà piùnecessario prelevare organi sapendoprima a quali pazienti trapiantarli. Eun po’ questo già succede. I nostri reniprelevati a cuore fermo sono da annivalutati con una macchina di perfu-sione; oggi il nostro fegato, di cui po-tevamo soltanto immaginare – sen-za certezza - che sarebbe stato unbuon fegato, è stato “curato” e portatoalla miglior condizione possibile pri-
ma del trapianto, a garanzia dellamassima sicurezza per il ricevente. Pozzi: Se non mi trovassi di fronte alei mentre sta dicendo queste cosepenserei che si tratta di fantascienza.Invece mi dice che è già in atto. Zanierato: È proprio così. Già oggipossiamo parlare di cura e di ricon-dizionamento degli organi.Pozzi: Mi permetta però di tornare unattimo al prelievo a cuore fermo. E lechiedo: perché solo a Pavia si fannoquesti interventi? Avete un’organiz-zazione più avanzata di altri?Zanierato: Il protocollo della dona-zione a cuore non battente prevedeun’organizzazione di persone prepa-rate che sappiamo bene quali sono ipropri ruoli, soprattutto in una si-tuazione di emergenza come è il do-natore a cuore non battente. Il luogoin cui si svolge la donazione a cuorefermo è nella maggioranza dei casi ilPronto Soccorso, ma talvolta anchela Rianimazione. Si fa in Pronto Soc-P
reve
nzio
neO
gg
i
7
Geraci: «Abbiamo modificato l’approccio al problema del miglior utilizzo degli organi. Siamo passati da unarealtà in cui, appena prelevato un organo, bisognavatrapiantarlo, a un’altra realtà che si sta via viaconsolidando. Mi piace immaginarla come “la cura degliorgani”, o addirittura come “l’ospedale degli organi”».

corso solo perché lì arriva il pazien-te dall’extraospedaliero, ma non èl’unica opzione. In altri centri almondo questi interventi vengonofatti in Rianimazione. In alcuni casisiamo andati direttamente in sala ope-ratoria. Adesso stiamo cercando distandardizzare alcune variabili, equindi sarà o Pronto Soccorso oRianimazione. L’equipe che si dedi-ca al trattamento del donatore acuore non battente è mista: il perso-nale presente nel reparto che accoglieil potenziale donatore e gestisce la pri-ma fase, è affiancato da una equipe de-dicata che gestisce il processo intoto sino al prelievo di organi ed è co-stituita da un rianimatore che ha ilruolo di coordinatore ma che sa at-tuare alcune pratiche di preservazione
che sono quelle illustrate dal prof. Ge-raci; un cardiochirurgo, che arriveràa impiantare l’ECMO (per la circo-lazione extracorporea); un infermie-re di coordinamento che si occuperàin tempi rapidi – massimo quattro ocinque ore – di organizzare il prelie-vo (invio prelievi per idoneità, reclu-tamento personale per l’equipe di pre-lievo, predisposizione della sala ope-ratoria per il prelievo stesso) . Il do-natore a cuore fermo, come ha dettoil prof. Geraci, è un donatore la cuimorte è accertata con criteri cardia-ci (ECG per 20 minuti), e nel quale siha un arresto di circolo per tempi an-che prolungati. Ciò di cui ha bisognoun organo per essere vitale è sangueossigenato, altrimenti si produce undanno ischemico. Circolazione e os-sigenazione vanno ripristinati il piùin fretta possibile. Lo possiamo fareartificialmente con la circolazioneextracorporea (appunto ECMO): unamacchina cuore-polmone che svolge
le funzioni del cuore e del polmone.Quindi ossigena e perfonde. Questoristora gli organi. Li riporta allavita. Fa sì che il sangue circoli di nuo-vo, che il danno ischemico che c’è sta-to in qualche modo venga “ripara-to”(anche se non abbiamo ancora lacertezza che ciò avvenga e in che mi-sura). Con L’ECMO teniamo in vitaartificialmente gli organi di quellapersona. La circolazione extracor-porea si attiva dopo che è stato fattol’accertamento di morte con critericardiaci. Ricordo che siamo l’unicoPaese che prevede 20 minuti di veri-
fica dell’avvenuta morte per arrestocardiaco. Nel resto del mondo si va daidue-tre minuti degli Stati Uniti ai cin-que minuti di alcuni Paesi d’Europa,come la Francia e la Spagna. LaGran Bretagna è su questi standard.In quei venti minuti il paziente nonviene massaggiato ventilato. Dopoquesto periodo di registrazione, vie-ne istituita la circolazione extracor-porea normotermica regionale, chesarà poi mantenuta per un tempo va-riabile, da un minimo di un paiod’ore a un massimo di quattro-sei ore.Durante la circolazione extracorpo-rea, la perfusione degli organi ga-rantisce il ripristino di flusso emati-co e quindi di metaboliti energetici,di ossigeno. Nella nostra esperienza
Prevenzione
Og
gi
8
Prevenzione
Og
gi
Zanierato: «Con L’ECMO teniamo in vitaartificialmente gli organi di quella persona. La
circolazione extracorporea si attiva dopo che è statofatto l’accertamento di morte con criteri cardiaci.
Ricordo che siamo l’unico Paese che prevede 20 minutidi verifica dell’avvenuta morte per arresto cardiaco».

recente i fegati prelevati da donato-ri a cuore fermo sono stati mantenutiperfusi “in vivo” mediante ECMO per6 ore circa e successivamente, vistoil prolungato tempo di ischemia, ri-condizionati “ex-vivo”, a Milano,dopo il prelievo dal donatore e primadi essere impiantato nel ricevente. Ilricondizionamento “ex-vivo”, cheviene effettuato perfondendo l’orga-no con una soluzione “acellulare”(non più sangue), rappresenta un’ul-teriore garanzia di idoneità dell’or-gano, in quanto durante il periodo diperfusione viene valutata con più
precisione la funzione dell’organo. Callioni: La soluzione con cui vieneperfuso il fegato ha la funzione di so-stituire la circolazione sanguigna.Zanierato: Preciso meglio come vie-ne attuata la circolazione extracor-porea regionale “in vivo”, per diffe-renziarla dalla perfusione “ex vivo”.Attraverso la cannulazione veno-ar-teriosa femoro-femorale si inizia lacircolazione extracorporea; il posi-zionamento di un “palloncino” inaorta discendente impedisce la per-fusione degli organi toracici e del-l’encefalo e fa sì che la circolazione ex-tracorporea diventi “regionale” per-fondendo unicamente gli organi del-l’addome (fegato, reni). Nel corsodella perfusione, che dura da un mi-
nimo di due ore ad un massimo di sei,vengono valutati una serie di valoriematochimici che sono gli indici diadeguata perfusione. Questo rappre-senta il primo step di valutazione diidoneità dell’organo, seguito, dopo ilprelievo, dalla valutazione “ex-vivo”sia di reni che di fegato mediante unaapparecchiatura dedicata. Presso il no-stro centro questa procedura è in attogià dal 2008 per i reni, che dopo ilprelievo, vengono riperfusi all’inter-no della “perfusion machine” e defi-nitivamente ritenuti idonei o meno altrapianto. Recentemente, abbiamoiniziato a prelevare il fegato che su-bisce il medesimo ricondizionamen-to, attualmente presso il centro di tra-pianto di Milano. Fino a oggi (20 novembre, data suc-
cessiva all’intervista) sono stati pre-levati, con questa modalità, tre fega-ti. Gli organi sono stati prelevati a Pa-via, preparati a Pavia (l’intervento diprelievo è stato attuato dall’équipe delNiguarda) e ricondizionati e tra-piantati al Niguarda. Pozzi: Mi spiace però che stampa e tvsi siano concentrati solo sull’inter-vento di trapianto, lasciando un po’ inombra i meriti del Policlinico SanMatteo di Pavia.Zanierato: Avviene sempre così. Perla stampa e i mass-media in genere fascalpore il trapianto. Lei ha ragione:il lavoro maggiore è stato fatto qui aPavia però bisogna poi trovare chi ab-bia il coraggio di trapiantare un or-gano prelevato e preparato con unamodalità che finora nessuno avevamai utilizzato. Ma è chiaro che si trat-ta di una organizzazione complessache deve essere coesa in tutti i pas-saggi. Finora i fegati da noi propostisono stati prelevati sempre dall’equipeP
reve
nzio
neO
gg
i
9
Pre
venz
ione
Og
gi
Zanierato: «Nel corso della perfusione, che dura da unminimo di due ore ad un massimo di sei, vengonovalutati una serie di valori ematochimici. Questorappresenta il primo step di valutazione di idoneitàdell’organo, seguito, dopo il prelievo, dalla valutazione“ex-vivo” mediante una apparecchiatura dedicata»

trapiantologica di Niguarda. In fu-turo, è possibile che più centri par-tecipino a questo progetto. Pozzi: Che i chirurghi cerchino di in-tervenire con la massima probabili-tà di successo possibile sulla riusci-ta del trapianto è cosa risaputa. Cosìcome è risaputo che alcuni non ne vo-gliono sapere di utilizzare organinon perfetti, figuriamoci quelli co-siddetti marginali. Zanierato: Non dimentichiamo cheper il fegato il tempo di ischemia lun-go (come è tipico nei donatori a cuo-re fermo) rappresenta un serio fattoredi rischio ed espone il paziente tra-piantato a complicanze anche mortali.È quindi abbastanza ovvio che ci siaattenzione nell’uso degli organi dautilizzare.
Pozzi: Adesso però avete l’onere difare più esperienze di modo che siconfermi la bontà delle procedure davoi elaborate.Zanierato: È vero. Non è un percor-so facile. Se sui reni, per esempio, cisono importanti riferimenti in lette-ratura di prelievi di organi che non ri-cevono sangue ossigenato per cosìtanto tempo (si dice anche “ischemiacalda”), sul fegato è tutto un altro di-scorso. Non ci sono studi cui riferir-si con tempi di ischemia così lunghi.Nella letteratura mondiale i fegati tra-piantati non hanno subìto tempi cosìlunghi di mancata perfusione. I nostri20 minuti di ischemia assoluta rap-presentano, come abbiamo già detto,una unicità nel panorama scientificodei trapianti. Quindi il lavoro da fareper costruire un protocollo sicuro èun lavoro molto articolato e non fa-cile. Il percorso intero del donatorea cuore non battente è estremamen-te impegnativo in quanto coinvolge
più figure sanitarie; ricordo che sitratta di pazienti che, a causa di un ar-resto cardiaco, sono sottoposti a cureintense e tecnicamente avanzatissimeper essere salvati. Solo nel momen-to in cui le cure risultano inutili aduna ripresa dell’attività cardiaca delpaziente e viene constatata la morte,subentra una seconda equipe di spe-cialisti per attuare il programma acuore non battente. Nel momento incui la persona viene dichiarata mor-ta, per noi inizia la nuova proceduraper la cura non più della persona stes-sa, ma dell’organo o degli organi che
possono essere prelevati. Pozzi: Questi che noi stiamo defi-nendo tempi molto lunghi però per-mettono probabilmente anche una mi-gliore verifica dell’anamnesi dell’or-gano da prelevare.Zanierato: Certamente. È importan-te, se non fondamentale, anche perpermettere ai familiari di rimanere ac-canto al proprio congiunto deceduto,e a noi permette di ricostruire la sto-ria clinica del deceduto. Per quanto ri-guarda invece il rischio infettivo ditrasmissione di malattie virali o bat-teriche, vengono eseguite in tempi ra-pidi le sierologie, che sono le stesseche si eseguono su donatore a cuorebattente in rianimazione. Entroun’ora noi abbiamo l’esito delle sie-
Prevenzione
Og
gi
10
Geraci: «Questo programma di prelievo diorgani da soggetti morti a causa di un arrestocardiaco improvviso ha, di fatto, trasformato ilprocesso di donazione di organi in una vera e
propria urgenza clinica assoluta».

rologie. Il rischio zero non esiste mala garanzia per il ricevente, con gliesami attuali, è altissima. Sono le stes-se procedure previste per i prelievi acuore battente, con la differenza chedevono essere effettuati in tempi piùbrevi e in qualunque momento dellagiornata, anche a notte fonda.Pozzi: Emerge una forte necessità or-ganizzativa.Geraci: Sì. Questo programma diprelievo di organi da soggetti mortia causa di un arresto cardiaco im-provviso ha, di fatto, trasformato ilprocesso di donazione di organi in una
vera e propria urgenza clinica asso-luta. Mi spiego meglio. Davanti a unpotenziale donatore a cuore batten-te ricoverato in Rianimazione, nel cor-so delle sei ore di osservazione perl’accertamento di morte, si ha tempodi organizzarsi, valutare, studiare, ap-profondire senza fretta – anzi con cal-ma - molti aspetti diagnostici senzatimore di aggiungere sofferenza agliorgani. Nel caso invece di un arrestocardiaco improvviso e refrattario allemanovre di rianimazione, ogni in-tervento finalizzato al recupero degliorgani per un prelievo-trapianto,deve svolgersi in tempi brevissimi -dopo la dichiarazione di morte e il suoaccertamento – per evitare la soffe-renza ischemica degli organi stessi. È
- direi – un intervento di massima ur-genza in cui sono i minuti a fare la dif-ferenza quanto a qualità degli orga-ni. È paragonabile, per chi ne sa unpo’ di medicina, alla rottura di un’aor-ta, di un gande vaso sanguigno che ri-chiede un intervento efficace nellospazio di pochi minuti, non certo diore. Siamo quindi di fronte ad un sal-to culturale importante. Avere rea-lizzato un tale programma è il segnoche in questo ospedale la culturadella donazione è sempre più patri-monio condiviso. Questo ci ha con-sentito di mettere in cantiere il pro-getto “Alba” che, visto da fuori, qual-che tempo fa, poteva sembrare unafollia. Pozzi: Non posso evitare di fare unadomanda provocatoria: se lo fa Pavia,
perché non lo fanno altri grandiospedali?Geraci: Queste cose si fanno quandosi verificano contemporaneamentealcune condizioni che le rendonopossibili. E si fanno perché ci sonopersone che hanno la visione, che han-no il sogno, che lo trasformano in pro-getto, che credono in un certo pro-gramma e lo intendono realizzare an-che a costo di sacrifici non sempre ri-conosciuti. In questi ultimi dieci,quindici anni di sforzi e di entusiasmipersonali e collettivi, oltre alla sod-disfazione di aver portato l’Italia nelnovero dei Paesi con un programmadi prelievo di organi a cuore fermo,posso ritenermi ulteriormente sod-disfatto nel vedere le nuove prospet-tive che si stanno aprendo sia in Ita-lia sia nel nostro ospedale, grazie a chiha saputo raccogliere il seme ger-mogliato e intende farlo crescerecon vigore. Certe cose non si posso-no neppure ipotizzare senza personeP
reve
nzio
neO
gg
i
11
Geraci: «Queste cose si fanno quando si verificanoalcune condizioni che le rendono possibili. E si fannoperché ci sono persone che hanno la visione, che hannoil sogno, che lo trasformano in progetto, che credono in un certo programma e lo intendono realizzare anche a costo di sacrifici non sempre riconosciuti».

determinate che abbiano voglia di fare.Se si riesce a formare un gruppo dimedici, infermieri e altri tecnici, tut-ti entusiasti e disposti a mettercil’anima, allora il progetto si concre-tizza. Altrimenti è meglio lasciarperdere. Zanierato: Ci sono poi da considera-re i fattori organizzativi sanitari.Ogni Regione ha la propria organiz-zazione, le proprie strutture, le pro-prie modalità di intervento. Perfinomentre diciamo “intervento a cuorefermo” non diciamo una realtà uni-voca. Le procedure sono diverse. La-scio stare gli altri e ricordo che Pa-via è il centro dell’area della Pianu-ra. Qui la centrale operativa accogliegli arresti cardiaci. Nell’area metro-politana gli arresti cardiaci non van-
no al Niguarda ma al San Raffaele,dove si sta facendo una cosa non cosìma similare, adattata alla realtà del-la sua organizzazione. Ogni centroquindi sta adattando regole diverseper arrivare a risultati simili. Geraci: Dipende, come detto, dal-l’organizzazione, dipende dalle per-sone. Certamente questo protocollonasce a Pavia perché a Pavia c’è unabuona esperienza di utilizzo dellaECMO per salvare i pazienti che han-no avuto un arresto cardiaco diffici-le, che non si riprende. Pavia ha co-minciato perché c’era un gruppo dimedici (rianimatori, di Pronto Soc-corso, cardiochirurghi e non solo) etecnici perfusionisti esperti, bravi, ca-paci di applicare in urgenza la circo-lazione extracorporea in soggettivivi, nella speranza di salvarli perchési poteva sperare che il loro cervellofosse ancora vivo e vitale. E penso aimedici rianimatori e agli infermieridel 118 capitanati da Maurizio Rai-
mondi, al professor Carlo Pellegnini,cardiochirurgo responsabile dellastruttura ECMO, che ha avuto unruolo importante nello sviluppo pra-tico del programma; e a quel follet-to efficientissimo che è Antonella De-gani, a capo dei tecnici perfusionisti.E ai medici e agli infermieri delPronto Soccorso della dott.ssa Bres-san, che ha consentito - soprattuttoall’inizio della vicenda - di lavorare se-renamente, sebbene fossimo visti daalcuni come “marziani”. Lo stessostrumento usato per salvare la vita diuna persona, in caso di fallimento,
avrebbe potuto salvare almeno i suoiorgani. Questa è stata la mia idea – madirei la “nostra” idea - all’inizio del-la vicenda, quando in Italia non lo sicredeva possibile: moltiplicare le vitesalvate grazie ai reni, ai fegati, ai pol-moni prelevati da soggetti che allo-ra nessuno avrebbe osato considera-re donatori di organi. Recuperare in-somma organi aggiuntivi rispetto aquelli tradizionalmente prelevati daidonatori a cuore battente in Riani-mazione. Zanierato: Sull’utilizzo del fegatoprelevato a donatore a cuore fermoperò richiamo alla necessaria pru-denza. Siamo all’inizio di una nuovaesperienza e dobbiamo avere la ri-sposta nei fatti. Dobbiamo vedere in-
Prevenzione
Og
gi
12
Zanierato: «Sull’utilizzo del fegato prelevato adonatore a cuore fermo però richiamo alla
necessaria prudenza. Siamo all’inizio di unanuova esperienza e dobbiamo avere la risposta nei
fatti. Dobbiamo vedere innanzi tutto come sicomporteranno questi due fegati nei prossimi mesi».

13
Pre
venz
ione
Og
gi
nanzi tutto come si comporterannoquesti due fegati nei prossimi mesi. Epoi valutare quanti anni di aspettati-va di vita offrono ai riceventi. Perchéaltrimenti dovremo fare serie valu-tazioni sullo sforzo organizzativo edeconomico a fronte di risultati di-scutibili. Noi aspettiamo i dati scien-tifici. Il ricevente è sacro: ha dirittodi ricevere un organo perfetto, che gligarantisca una condizione di vitamigliore e più lunga rispetto a quel-la che avrebbe avuto con altre cure.Altrimenti rischiamo di fare un’azio-ne propagandistica che finisce per fare
danni irreparabili. Ma soprattuttoavremmo fatto un’azione immorale. Geraci: Stiamo facendo il possibile el’impossibile perché, da anni, siamo difronte a una situazione drammatica,di grave carenza di organi da tra-piantare. Le stiamo studiando tutte.Ma il messaggio forte della dott.ssaZanierato è che la comunità scienti-fica che si occupa di queste cose è mol-to prudente e attenta, non certo agliscoop giornalistici, ma alla concretasicurezza del paziente. Anzi, gli sco-op talvolta fanno danni e non aiuta-no chi lavora ed è impegnato sul cam-po. Pozzi: Quale è il ruolo dell’infermie-re in questo contesto?Tosi: È già stato detto tanto rispet-
to all’importanza dell’organizzazio-ne complessiva di più persone e piùprofessionalità. Ribadisco che si trat-ta di una organizzazione difficile,complessa, che funziona se funzio-nano tutti i meccanismi. Il compitodell’infermiere è di essere pronto ecompetente per poter collaborarein un ambito ultraspecialistico. Si-curamente è una figura indispensa-bile perché collega tutte le varie fi-gure – dal rianimatore al transplantcoordinator, al chirurgo e via dicen-do – e si occupa della parte organiz-zativa-burocratica proprio nel mo-mento del processo. Quindi i colle-gamenti con il laboratorio analisi econ tutti che hanno compiti in undato momento del prelievo e deltrapianto. Sembrano processi bana-
li e scontati ma in realtà, se non si co-nosce molto bene il proprio ospeda-le, come funzionano i servizi, il per-sonale, le strutture… Il mio compi-to è, pur essendo al di fuori della Ria-nimazione e del Pronto soccorso, dicollaborare con il dott. Geraci e ladott.ssa Zanierato però poi mi trovoa tenere le relazioni e ad interagirecon tanti miei colleghi all’interno del-le varie strutture. Il tutto, devo am-mettere, è complesso. Anche solo in-staurare e mantenere i rapporti sulpiano della reciproca stima, fiducia edisponibilità totale per il bene delprogetto e quindi dei pazienti. Neimomenti critici, che spesso sonoconcitati, tutto il meccanismo devemuoversi in sincrono. I minuti sonopreziosissimi e quindi è fondamentalefare determinate cose in un deter-minato momento. Essendo un’attivitàdai numeri non altissimi, bisogna te-nersi pronti più che nella normaleroutine. Certamente alla base del no-
Tosi: «Il compito dell’infermiere è di essere pronto ecompetente per poter collaborare in un ambitoultraspecialistico. Sicuramente è una figuraindispensabile perché collega tutte le varie figure e si occupa della parte organizzativa-burocratica proprio nel momento del processo».

14
Prevenzione
Og
gi
stro impegno c’è la motivazione, lacondivisione di un progetto alto.Non mancano i momenti difficili, maquesto non ci ferma. Le difficoltà or-ganizzative, strutturali ed economi-che degli ospedali sono conosciute datutti, ma in questo ospedale è possi-bile andare oltre perché c’è una cli-ma particolare che ci entusiasma e dàuna coloritura, una carica particola-re al nostro lavoro. Così superiamotutte le difficoltà, anche la fatica fi-sica e mentale. Pozzi: A noi il compito di intensificare,credendoci fino in fondo, la culturadella donazione. Solo così rendiamoonore al vostro impegno. Del quale viringraziamo. Così come sarà nostrocompito rendere sempre di pubblicodominio il gande patrimonio profes-sionale e culturale da voi rappresen-tato in termini di prelievo, donazio-ne e trapianto. Il San Matteo è sem-pre stato all’avanguardia in Europa enel mondo. Deve continuare ad es-serlo per offrire il miglior serviziopossibile alla comunità delle personee delle famiglie sofferenti. Il San
Matteo di Pavia non può perdere nul-la della enorme forza e della gran-dissima capacità di fare che finora hasaputo esprimere. Negroni: Dopo quanto appreso sul-l'attività del dott. Geraci e delladott.ssa Zanierato, il nuovo compitodell'Aido pavese sarà quello di sup-portarli nel loro delicato compito ditrapiantatori, nelle nostre riunioni enelle serate scientifiche alle qualiparteciperemo e nei nostri incontricon le scolaresche saremo preparatie chiari nello spiegare le nuove, in-novatrici tecniche dei trapianti che iricercatori stanno offrendo a chi è inlista d'attesa.Il Policlinico San Matteo, che è pro-motore con i suoi specialisti di que-ste nuove tecniche, sarà sempre piùcentro di eccellenza e di riferimentoe noi faremo la nostra parte nel di-vulgare la cultura del dono, perchéAido vuol dire vita.
Testi a cura di Leonio CallioniHa collaborato Leonida PozziFotografie di Paolo Seminati

15
Pre
venz
ione
Og
gi
La grandezza di don CarloGnocchi, il prete dei mutila-tini, il prete degli Alpini, ilprete della donazione di or-gani, è in tutto quello che fece
in vita e nelle opere che proseguonoora nel solco della sua illuminata e il-luminante capacità di amare. L’annoprossimo si compiranno i 60 annidalla morte di don Carlo, sei anni fa,assurto agli altari come Beato, puntodi riferimento morale, spirituale e so-ciale della comunità cristiana e anchedi quella civile.Come abbiamo ampiamente illustratonello scorso numero di “Prevenzione
Oggi”, all’Aido è stato affidato l’ono-re di aprire le celebrazioni che, inizia-te sabato 24 ottobre, presso la chiesadi Santa Maria Nascente, a Milano,proseguiranno poi attraverso molte-plici avvenimenti, incontri, conferen-ze, manifestazioni, fino alla conclusionenel febbraio dell’anno prossimo.La folta delegazione dell’Aido prove-niente da tutta la Lombardia - anchegrazie al prezioso e intenso lavoro dicoordinamento e sensibilizzazionecondotto dalle responsabili in segre-teria, Laura Cavalleri e Marzia Ta-iocchi -, con numerosi labari, si è rac-colta nella mattinata sul piazzale del-
Aperte con l’Aido Lombardia le celebrazioni per i 60 anni dalla mortedel Beato don Carlo Gnocchi
Don
Gno
cchi
60an
nida
llam
orte

16
Prevenzione
Og
gi
la sede della Fondazione per dareluogo ad un breve e composto corteoche ha portato nella chiesa-santuariodiocesano del Beato don Carlo Gnoc-chi, per la partecipazione alla SantaMessa presieduta da mons. GiovanniGiudici, Vescovo di Pavia, già VicarioGenerale con il cardinale Martini,allora Arcivescovo di Milano, e da sem-pre particolarmente vicino alla Fon-dazione don Gnocchi e all’Aido.Prima della formazione del corteo ipartecipanti alla manifestazione han-no avuto la possibilità di visitare l’in-teressante museo aperto presso ilCentro, dove sono raccolti tanti ricordidel percorso umano di don Carlo,nella sua vita sacerdotale, in guerra congli amati Alpini, come promotore del-la cultura della donazione degli orga-ni (fatto allora, fortemente rivoluzio-nario). Il saluto introduttivo, prima del-la Messa, condecorata da un magnifi-co coro di Alpini insieme con il coroS. Innocenzo di Trecella (diretti dalmaestro Emilio Scarpanti) è stato af-fidato al presidente del Consiglio re-gionale Aido, cav. Leonida Pozzi. Lopubblichiamo integrale in queste pa-gine. Particolarmente toccante è stato poil’intervento del celebrante, il Vescovomons. Giovanni Giudici, che ha ri-cordato: “A 60 anni dalla morte e a seianni dalla beatificazione, celebriamodon Gnocchi, eroe della carità, pro-posto dalla Chiesa alla devozione e allaimitazione dei cristiani. La sua gran-dezza è certamente la carità, attiva, in-telligente, organizzata. È tuttavia uti-le ricordare che la sua attenzione diuomo e di credente è straordinaria an-che perché ha saputo interpretare unfatto epocale. Abbiamo sentito questaparola utilizzata per cercare di legge-re, e di far comprendere, il dolorosis-simo esodo dei popoli dalla terra stra-ziata dalla guerra, dai paesi in cui nonc’è un futuro per la propria vita, a cau-sa di povertà, disordini, diseguaglian-ze. Un singolo, grande avvenimentostorico, non solo singole storie”.Il Vescovo Giudici ha arricchito ogniconcetto con momenti di approfondi-
Non bisogna sempre pensare al raccoltoquando si semina, ma imparare a fare
le cose e a compiere opere, senzaocchieggiare in continuazione ai vantaggi.
Questo ha insegnato il nostro Beato don CarloGnocchi. Non è necessario essere grandi
uomini per fare qualcosa di utile per gli altri:basta agire nella nostra vita per amore e non
per interesse personale, come è stata la vita didon Carlo. Infatti la bellezza del dono sta
nell’essere possibile per tutti, per i grandi e pergli umili, per i giovani e per gli anziani.
Noi abbiamo scelto di essere dono totale pergli altri, per strapparli alla sofferenza facendo sì
che il soffio vitale scorresse dalla morte allanuova vita, dal donatore all’ammalato che
riceve. Con questi sentimenti vogliamo iniziarela nostra partecipazione alla Celebrazione
eucaristica, con questa Santa Messa con laquale AIDO Lombardia ha l’onore di aprire lemanifestazioni in occasione dell’apertura del
60° anno anniversario dalla morte del Beato don Carlo Gnocchi.
L’introduzione alla Santa Messa
Don
Gno
cchi
60an
nida
llam
orte

17
Pre
venz
ione
Og
gi
mento dettati da una partecipazionesincera. Ha aggiunto: “Il beato donGnocchi ha saputo cogliere la vastitàe la profondità dello strazio lasciato dal-la guerra, attraverso le ferite in mas-sima parte non più curabili dei muti-lati bambini, attraverso la scomparsadi padri uccisi o dispersi, da madri se-gnate dal dolore morale che indeboli-sce e sfibra le persone. Anche qui, nonuna serie di singoli fatti, ma un tre-mendo debito della società verso cia-scuno. Per avere saputo leggere, e farcomprendere la drammatica pagina delsuo tempo, don Gnocchi ha trascina-to con sé semplici e autorità, singoli estrutture sociali. Da qui poi l’am-pliarsi dell’opera per tutti i piccoli sof-ferenti, per le più varie ragioni. Finoalla fine don Gnocchi è stato qualchepasso avanti rispetto alla opinionepubblica del suo tempo; ricordiamo iltrapianto della cornea. Oggi, l’operabenemerita dell’Aido”. Il Vescovo Giu-dici ha ricordato che alla Messa era pre-sente uno dei riceventi le cornee di donGnocchi, quel Colagrande che, allorabambino, era diventato cieco per un ba-nale incidente di gioco. “È molto consolante e incoraggiante– ha aggiunto il Vescovo – penare chetutto quanto egli ha vissuto e realiz-zato nasce da una ispirazione evange-lica che oggi abbiamo ascoltato dallapagina dell’evangelista Matteo. Inessa il Signore ci invita a domandarcicome si compie una vita umana, la no-stra vita.Il quadro che ci è proposto: un silen-zioso prendere posizione del Pastoreche sembra dividere due tipi umani; inrealtà sono le persone che sono diverseper il comportamento che qualifica laloro vita. La vita vale se hai prestatoattenzione a un piccolo, minimo. Diceil Signore. Chi è questo piccolo?Chiunque è indifeso e non ha voce;chiunque ha bisogno. E si tratta di ognicategoria di persone. L’avvertimentoforte e deciso rivolto a ciascuno di noiriguarda la maniera di stare nella vita– la propria conversione -: Gesù si iden-tifica con questo piccolo. E noi, da cheparte staremo? È affidata a noi la scel-
Nel 1956 l’estremo gesto di carità di don Carlonella donazione delle proprie cornee ruppe glischemi normativi e sociali aprendo la stradaalla donazione di organi. Nel lontano 1971,proprio in occasione della consacrazione dellanuova chiesa del Monterosso, un quartierepopolare di Bergamo, nacque per opera diGiorgio Brumat l’Associazione Donatori diOrgani, Associazione che aveva lo scopo diraccogliere la disponibilità a donare, dopo lamorte, i propri organi a scopo di trapiantoterapeutico. Semplicità, famigliarità, solidarietà e speranzasono stati i valori di riferimento dell’AIDO intutti questi anni col risultato di rendere semprepiù concreta, diffusa e sostenibile la delladonazione di organi.Offriamo a Dio insieme al pane e al vino, 44anni di storia associativa per dire GRAZIE alBeato don Carlo Gnocchi e con lui a tutte lepersone che con il loro amore per la vita, conla loro generosità, con la loro passione, hannocreato, sostenuto e diffuso la cultura dellasolidarietà e della donazione.Per merito loro AIDO continua ad essereun’Associazione a completo servizio dell’uomosofferente, dedita alla formazione di unacoscienza che porti ogni cittadino alladecisione personale di una libera e volontariadonazione, dopo la morte, di parte del propriocorpo da destinare a trapianto terapeutico.La solidarietà è un preciso dovere per tutti, è lastrada per uscire dall’egoismo, dalla miope einutile ricerca del proprio egoistico interesse.C’è urgente bisogno, oggi più che mai, dipersone capaci di visione lungimirante, chesappiamo dimostrare che la speranza veradella vita sta nel donare, nell’impegno a dare ilproprio contributo, perché la presenza di vita edi amore si renda presente nel vissuto dellastoria. Occorrono oggi più che mai profeti, portatoridi un’altra parola, di un’altra luce, voci cherispondano alla verità della coscienza. Con questi sentimenti di gratitudine viviamoquesta Celebrazione eucaristica conl’esigenza di rispettare, servire e promuoverel’uomo nella sua integralità, in ogni momento,specialmente quando è più debole ed indifeso.La vita del Beato don Carlo Gnocchi ci siasempre testimonianza e guida. D
onG
nocc
hi60
anni
dalla
mor
te

18
Prevenzione
Og
gi
re che sei presente. Se ti vedessimo, sa-premmo agire con diverso slancio, econ rinnovata generosità.3. Riflettiamo sulla nostra condizionedi uomini. L’incontro con Dio si attuasempre, comunque, in ogni condizio-ne di vita e in ogni incontro con le al-tre persone. Invito ad essere persua-si della presenza reale, nella storia diDio, e nelle possibilità di riscatto e dibene per ciascuno di noi.4. Applichiamo a noi stessi questa con-dizione di persone di cui il Signore vuo-le prendersi cura. Se è il Signore chesi identifica con noi, allora possiamosmetterla di difendere noi stessi, di ri-cercare consenso o applauso.La certezza che ci dà il Signore in que-sta pagina del Vangelo sia per noi unacoraggiosa occasione di conversione:se il Signore è così vicino e presente,che cosa cambia nella mia vita? Se siidentifica con i piccoli, come devoguardali?”.Parole che sono calate sui partecipantialla Santa Messa con tutto il peso del-la loro profondità e hanno dato anco-ra maggior significato ad un “esserepresenti” a testimonianza della soli-darietà e dell’amore per gli altri. So-prattutto, appunto, per “i più piccoli”. Durante la Messa esponenti dell’Aidosi sono avvicendati per le letture:Giovanni Ravasi, Enrica Negroni,Gianpaolo Zanoli; per le preghiere deifedeli: Carla Cova, Duilio Villa, Do-menica De Vecchi. All’offertorio, su let-tura di Lorenzo Lucido, hanno porta-to i doni: Monica Bolis, Sorzi, e Ric-cardo Redaelli. La preghiera del do-natore, è stata letta da Corrado Valli.Il grazie e il saluto finale sono statiespressi dal presidente della Fonda-zione don Carlo Gnocchi, mons. An-gelo Bazzari. In realtà mons. Bazzaridi grazie ne ha espressi moltissimi, aipartecipanti, all’Aido, alla Fondazione,al Vescovo Giudici, ai sacerdoti con-celebranti, ai coristi, e tanti altri gra-zie che hanno rappresentato il più ade-guato compendio di una giornatadavvero speciale, appena vissuta e giànella storia della nostra comunità.
L.C.
ta. Sullo stimolo e l’esempio che ci vie-ne da don Gnocchi, Beato, proviamo adapplicare questa parabola di Gesù allanostra vita. 1. Ciascuno di coloro che noi cono-sciamo ha degli aspetti di piccolezza,vulnerabilità. Gesù è presente in cia-scuno di loro. Se essi sono tra i picco-li di cui ci parla la parabola… Qualeconsiderazione, quale attenzione.2. Il grande pericolo che corriamo: nonmi hai visto, non hai sentito…, non tisei accorto che io ero in sofferenza. Sen-tiamo di far diventare preghiera la no-stra meraviglia e sconcerto: o Signo-re, tu dacci la luce interiore per vede-D
onG
nocc
hi60
anni
dalla
mor
te

19
Pre
venz
ione
Og
gi
Aprire la porta d’ingresso eleggere “Qui nessuno è stra-niero”: accade a Verdello, inprovincia di Bergamo, pres-so la Casa Accoglienza del-
l’Associazione Home. Aprire la porta esentirsi a casa: accade a Luciano, Cin-zia, Angela, Yasna e sua figlia Mashache al ritorno quotidiano dall’Ospeda-le Papa Giovanni XXIII di Bergamo aVerdello trovano accoglienza, dialogo,sapore di famiglia. Aprire la porta, quel-la della propria abitazione, e sapere checon te vivranno 35 ospiti: accade a Mas-simo Chiesa e a sua moglie Selma, vo-lontari della onlus, che hanno deciso ditrasferirsi negli ambienti della Casa Ac-coglienza come riferimento costante pergli ammalati e le loro famiglie. Sulle pa-reti azzurre ornate dagli arazzi ricamatida Selma, da tempo si specchiano le sto-rie di chi è statao curato prima agliOspedali Riuniti e ora al Papa GiovanniXXIII di Bergamo.
L’AssociazioneHome Onlus è nata dalla voglia di ungruppo di trapiantati di fare qualcosadi concreto per ricambiare un dono ri-cevuto: un grazie che si è trasformatoin accoglienza e servizio, così come spie-ga il presidente Carmine Acerbis:“Molti di noi che già aderivano all’As-sociazione Amici del Trapiantato di fe-gato di Bergamo, hanno sentito la vo-glia di impegnarsi fattivamente per aiu-tare quanti si trovassero in situazionisimili a quelle vissute personalmente.Un progetto, però,che non voleva tra-dursi solo nelle corsie d’ospedale dovel’attività di assistenza può solo esseresporadica, bensì un progetto più ampioe radicato che ci vedesse maggiormentecoinvolti. Home onlus è nata da que-st’idea e ora è una associazione di vo-lontariato, onlus di diritto”.Carmine Acerbis ha 72 anni, da 20 haun fegato nuovo. È un uomo attento, ca-pace di scegliere le parole: il suo rac-
HOME: QUI NESSUNOÈ STRANIERO
Accoglienza per i trapiantati e le loro famiglie

20
Prevenzione
Og
gi
conto è essenziale eppure preciso, sen-za mai essere distaccato. Con equilibrioriesce a spiegarci perchè un trapianta-to abbia ancora voglia di stare vicino alladimensione della malattia : “Essere tra-piantato significa vivere la vita come undono quotidiano, senza perdere co-scienza della morte a cui ti sei trovatofaccia a faccia; si matura un nuovo sen-so sulla caducità della natura umana. Sientra in una dimensione di accettazio-ne entro la quale è possibile, come ac-cade per noi, occuparsi di altri amma-lati senza cercare di fuggire dall’idea cheesiste un termine ad ogni cosa. Per al-cuni di noi, inoltre, impegnarsi nelle at-tività dell’Associazione ha significatorientrare nella vita civile, perché, la-sciato libero dal lavoro, vuol dire ri-
trovare un impegno quotidiano, trovarenuovi obiettivi e nuovi scopi”.
Le strutture2011
L’occasione si è presentata nel 2011quando la Parrocchia di Verdello hadato la disponibilità ad utilizzare unospazio in via Solferino :”Abbiamo pre-sentato un progetto che ha portato allarealizzazione di 5 camere per un tota-le di 11 posti letto, 1 soggiorno, 1 cu-cina e 4 bagni”. Un luogo piacevole edaccogliente, con le travi a vista, i diva-ni in velluto verde e una cucina ampiadove è facile incontrare mamme ebimbi con le labbra rosse di pomodo-ro davanti ad un piatto di pasta: “Perl’utilizzo di questa unità - continuaAcerbis - è stato definito un comoda-to gratuito proprio con la Parrocchia,
si è provveduto alla ristrutturazionecompleta, e si è definito che gli spazi fos-sero adibiti all’ospitalità dei trapianta-ti (e delle loro famiglie) in cura pressogli Ospedali Riuniti di Bergamo”.
2014 Nel 2014 una nuova possibilità : “In pocotempo si è arrivati alla saturazione e allanecessità di nuovi spazi. E’ stata una scel-ta meditata ed importante, ma abbiamodeciso di continuare. In accordo con laFondazione Brolis proprietaria dellaCasa di Ricovero di Verdello, (trasferi-tasi nel frattempo fuori dal paese), ci sia-mo concentrati nel recupero di due pia-ni della ex struttura quale secondo luo-go di accoglienza aumentando il nostroimpegno e la nostra presenza”. I lavo-
ri, realizzati grazie al sostegno dellaFondazione della Comunità Bergama-sca, della Fondazione Banca Popolaredi Bergamo, dell’Associazione Amici delTrapiantato di Fegato, dell’Associa-zione Cuore Solidale e di alcuni priva-ti hanno portato (per un ammontare di40.000 euro) alla riqualificazione di 16ambienti per un totale di 33-35 posti :“Nel nuovo spazio - commenta Acerbis- abbiamo fatto in modo che insieme asemplici stanze, si ricavassero anche 6mini appartamenti dotati di cucina cosìda garantire la migliore autonomiaagli ospiti impegnati a Bergamo per lun-ghi periodi. Dalla ristrutturazione sonostati inoltre ricavati un soggiorno, unacucina comune, una lavanderia, ungiardino attrezzato per i bimbi e un bi-locale per Massimo e sua moglie che vo-lontariamente si sono trasferiti qui per

21
Pre
venz
ione
Og
gi
occuparsi degli ammalati”. Massimo viveinfatti al 1 piano della palazzina e allasua porta, giorno o notte, tutti posso-no bussare, al suo telefono tutti posso-no chiamare.
Accoglienza senza frontiereGli ospiti giungono da molte Regioniitaliane e da altrettanti Paesi europei edextraeuropei : “Nei primi anni di atti-vità Gigi, nostro associato attivo so-prattutto sul fronte ospedaliero, si oc-cupava di segnalare la disponibilità deinostri spazi; oggi la struttura è cono-sciuta sia dentro che fuori dall’Ospedalema per chi ha bisogno di ricevere in-formazioni abbiamo una brochure ag-giornata e un sito internet”. I dati di-cono che nel 2015 fino ad oggi il 62%
dei pazienti ospitati è italiano e il 38%estero proveniente soprattutto dallaSerbia (in virtù di una partnership trail Papa Giovanni e alcuni dei maggio-ri ospedali del Paese slavo). Nel 2015da gennaio a settembre compreso l’As-sociazione ha assistito 66 famiglie pro-venienti da Italia, Serbia, Albania, Slo-venia, Egitto, Macedonia e Cina con unaoccupazione per camera di 1402 notti;la media presenza per camera è statadi 2,2 persone, la permanenza media percamera è stata di 21,21 notti con unapunta massima di 159 notti: “Per gli ita-liani con maggior frequenza ospitiamopugliesi, naturalmente lombardi, cala-bresi e siciliani e si tratta di pazientiadulti o di ragazzi sopra i 18 anni, ec-cezione fanno i bambini serbi che confrequenza sono curati presso il PapaGiovanni XXIII”. Al servizio di ospi-
talità si lega anche quello di aiuto neltrasporto quotidiano verso l’Ospedale:“Ci siamo dotati di due autovetture chequotidianamente effettuano una mediadi 3-4 viaggi. Per l’Associazione èun’attività impegnativa e onerosa, masappiamo anche che è fondamentale, inquanto il più delle volte le persone nonsono autonome o per problemi di saluteo perché provenendo da lontano arri-vano in aeroplano”.
Con il malato in ogni momentoI risultati positivi e il continuo aumentodi richieste suggerirebbero un ulterio-re ampliamento, ma Acerbis sottolineaun aspetto peculiare dell’attività diHome : “Essere nostri ospiti significaessere accolti in una famiglia, aiutiamo
gli ammalati e i loro cari non solo dalpunto di vista pratico ma anche emo-tivo e affettivo. Nessuno è mai lascia-to solo, si creano momenti di aggre-gazione e condivisione, nascono lega-mi di affetto e amicizia che portano aforme di solidarietà soprattutto tra gliospiti oltre che con noi. Tutto questoè possibile perchè a nessuno viene mainegata l’attenzione della quale ha bi-sogno. Home non è un albergo, bensìuna casa di accoglienza. Ampliare ul-teriormente la struttura, considerandoche il numero dei volontari è di 6, conaltri 5 che ad oggi hanno espresso la vo-glia di dare una mano, sarebbe un az-zardo e rischieremmo di perdere il cli-ma affettuoso, comprensivo e attentoche sempre ha contraddistinto il nostrooperare, proprio come in una famiglia”.
Clelia Epis

22
Prevenzione
Og
gi
Yasna e Masha SerbiaYasna è alta, mora e sottile, Masha èpiccola, bionda e ha il viso tondo.Yasna e Masha sono madre e figlia,giunte in Italia dal Kossovo perchè lapiccola aveva urgente bisogno di untrapianto di fegato. Yasna racconta lasua storia in un inglese incerto eMasha si guarda attorno con occhiacuti.Masha era in pericolo di vita, un peri-colo vero e concreto, drammatico, sof-focante come il caldo dell’estate :”Ora- dice Yasna baciando la figlia - dopo ilTrapianto al Papa Giovanni XXIIIMasha sta bene. E’ vivace, allegra, eha appena festeggiano i due anni e unmese”.Dal 29 luglio Masha e la mamma sonoospiti dell’Associazione Home a Ver-dello “Con noi è arrivato in Italiaanche mio marito. Quando noi era-vamo in ospedale lui era alloggiato quie ci raggiungeva ogni giorno, poi
Masha ha cominciato a stare meglio enoi ci siamo spostate in questa casa”.Yasna usa proprio il termine casa(Home e non House inteso come edi-ficio): “Meglio ancora, dice, dovrei direfamiglia. Non mi sono mai sentitasola, mi sono sentita ascoltata, tuttihanno avuto cura di noi e abbiamocreato una piccola comunità”. Come avete conosciuto la Casa Acco-glienza di Home? “Un amico di miomarito era già entrato in contatto coni volontari così abbiamo chiesto seanche per noi ci fosse spazio e subito cisono state aperte le porte. La piccolaora sta meglio e presto torneremo acasa, ma saremo ancora qui in occa-sione dei controlli periodici. Sarà belloriabbracciare le persone e tornare inuna città che ci ha dimostrato tanto af-fetto”. Yasna sorride, Masha si toglie ilciuccio e manda un bacio allegro.
Cinzia PalermoCinzia ha capelli scuri, occhi dolci, un
STORIECome a casa per cominciare un nuovo percorso

23
Pre
venz
ione
Og
gi
viso femminile e un caldo accento delSud. Ha 42 anni e da quasi nove lottaogni giorno con le malattie : “A Ber-gamo - spiega commossa - grazie altrapianto - ho ritrovato la mia vita.Non ci credevo più, non volevo piùnemmeno sentire parlare di opera-zioni e invece ora sto bene”. Il 2006per Cinzia è l’anno del dramma : “Miè stata diagnosticata la sclerosi multi-pla e per due anni sono stata sottopo-sta solo a controlli, poi nel dicembre2008 mi hanno riscontrato una nuovaplacca al cervello. Da li ho iniziato conl’interferone che ha cominciato adarmi gravi problemi e dal 2009 al2011 sono stata sottoposta a dialisi.Nell’agosto del 2011 a Palermo ho ri-cevuto un nuovo rene, ma il trapiantonon è andato a buon fine e tra innu-merevoli sofferenze sono tornata indialisi. Avevo perso ogni speranza, mami è stato suggerito l’Ospedale di Ber-gamo dove sono stata inserita in listad’attesa per un nuovo rene e poi ope-rata il 22 settembre”.Con l’aiuto di Massimo per le fasi dicontrollo raggiunge l’Ospedale abordo della navetta di Home: “Miomarito e i miei figli sono a Palermo,qui sto in uno dei monolocali dell’As-sociazione ma so sempre che per qual-siasi cosa posso chiedere aiuto. Qui horitrovato gli stimoli. E’ una sensazionespeciale capire da ogni gesto e da ogniparola che si è circondati da personeche ti rispettano. E’ bellissimo”.
Angela Serbia“Bene Massimo, bene Massimo” cosìcomincia Angela che ha 15 anni e ar-riva da Belgrado. E’ arrivata a Ber-gamo 6 mesi fa accompagnata damamma Daniza perchè il suo fegatoera ammalato; il trapianto è andatobene e tra due mesi potrà tornare acasa : “Anche questa - accenna in ita-liano - è una casa. Mi piace stare qui,mi piace quando tutti ceniamo in-sieme, ho tutto quel che mi serve e conil computer del soggiorno mi possocollegare in skype per salutare papàMirioljub e mio fratello maggiore”.Angela racconta di Milano, di quanto
Massimo e Selma hanno scelto divivere presso la Casa AccoglienzaHome, di aprire e aprirsi a chi ne
abbia bisogno, a chi, come Massimo, haavuto bisogno di un trapianto o a chigiunge a Bergamo perchè in lista diattesa.Massimo ha 53 anni, un’epatite C lo haportato urgentemente al trapianto difegato nel 2013. Dopo un anno in cui hatrovato l’equilibrio nella sua nuovadimensione di vita ha sentito dentro di sèla voglia di mettersi in gioco per gli altri:“Volevo rendermi utile e fare qualcosa, manon volevo più stare a contatto diretto conl’Ospedale, così due anni fa susegnalazione di Roberto, un caro amicoanche lui trapiantato, ho cominciato acollaborare con Home e da subito misono dedicato all’accoglienza, al trasportoe all’assistenza degli altri ammalati. Erosempre stressato, ma sentivo che stavofacendo la cosa giusta”.Nell’inverno del 2014 il grande passo:“Quando è stata disponibile la nuovastruttura io e mia moglie ci siamo resi
Una scelta coraggiosa

24
Prevenzione
Og
gi
le piacciano Verdello e soprattuttoBergamo, lo fa con allegria spensierataadatta finalmente ai suoi 15 anni.
Luciano LeccePer Luciano, Verdello è una secondacasa, ci è arrivato la prima voltaquando, in gravi condizioni a giugno,malato ormai da dieci anni, attendevaun trapianto di fegato. A luglio l’ope-razione è andata bene e ora torna nellanostra città per i controlli mensili :“Ho riscoperto la gioia di vivere nellostupore. Dopo l’operazione tutto hapreso la giusta importanza, anche iparticolari. Ho capito come ogni cosasia degna di attenzione e abbia un va-lore del quale si sente la mancanza nelmomento in cui viene negata”.Nella Casa di Accoglienza di HomeLuciano è giunto su segnalazione diun amico pugliese: “Un compagno diviaggio, anche lui stava male e con meha effettuato il percorso pre operatorioa Bergamo. Quando attendevo il tra-pianto ero disperato, chiamavo qui etrovavo sempre una risposta. Mas-simo è come un padre, mi ha accoltocon un giorno di preavviso, anche suamoglie mi è molto vicina. Insieme aloro e agli altri ospiti ho capito comeanche nella malattia si possano risco-prire i valori che contano, quelli che cirendono umani, quelli fondamentaliche la frenesia della vita di oggi ci faaccantonare. Ho imparato a non darenulla per scontato, ho cominciato unnuovo percorso”.
C. E.
conto che per fornire al meglio accoglienzae assistenza non vi era altra soluzione che
abitare qui. Non è stato facile lasciare lacasa di Bergamo, ma ero profondamente
convinto di fare una cosa giusta e Selma mi ha seguito”.
Vivere qui significa abitare in unadimensione unica: “E’ tanto bello quanto
difficile, a pieno regime possiamo ospitareanche 35 persone e tutte hanno
problematiche ed esigenze differenti. Mioccupo del servizio navetta, della
manutenzione delle zone comuni, diorganizzare momenti di festa, ma soprattutto
di ascoltare e incoraggiare. Qui cerchiamodi costruire una parentesi di pace, dove
riprendere fiato, dove alleggerire il cuore“.Ad una festa è legato un ricordo speciale:
“Il giorno del mio compleanno mia figlia e gliospiti hanno organizzato una festa asorpresa: c’erano tutti, persino il mio
nipotino di 4 mesi”Non tutto è facile, siamo uomini:
“Rimaniamo ancora convinti dell’impegnoche ci siamo presi, ma sentiamo di aver
bisogno di un giorno di pausa ogni tanto.L’Associazione ci sta aiutando e a breve per
un giorno riuscirò ad avere un sostituto.Questo ci permetterà di garantire continuità
al progetto e avere sempre energiefresche”. Le sollecitazioni alle quali Massimo
e la moglie sono sottoposti sono tante,grandi le gioie quanto profonde le amarezze
: “Abbiamo conosciuto tante persone,incontrato famiglie, sperato, festeggiato e
pianto con loro. Non dimenticherò lafamiglia del piccolo Samuele, un bimbo di
Pordenone che non ce l’ha fatta. I suoigenitori si erano legati a Gigi, uno dei nostri
volontari, ma nel momento in cui hannoricevuto la drammatica chiamata
dall’Ospedale ero in casa ed è stato Gigi aportalo subito al Papa Giovanni. Quello di
Samuele è un ricordo grande in tutti noi e alui abbiamo dedicato una targa al 2 pianodella nuova struttura nell’area dedicata al
gioco dei bimbi. Ricordo anche un bimboserbo di 8 mesi: è arrivato a Bergamo in
condizioni disperate, ora ha 2 anni e grazieal trapianto di fegato sta bene. Si è legato
molto a me, cercava sempre il mioabbraccio e i genitori mi dicono che oggi
neanche a casa sia così socievole con altri.Ci sentiamo e vediamo via skype, sono stato
anche invitato al suo compleanno, ma nonsono andato e la famiglia ha capito: qui
c’erano altri piccoli da accompagnare”. (C.E.)

25
Pre
venz
ione
Og
gi
Molti ettori ricorderanno ilclamore e lo sconcertosuscitati dalla vicendacosiddetta “Vannoni”, le-gata alla proposta di
cura di bambini affetti da malattie gra-vissime attraverso l’infusione di cellule sta-minali. Il paradosso di quella vicenda fuanche lo scontro indiretto all’internodella magistratura, con giudici che im-ponevano agli ospedali la cura e altri cheinvece la vietavano. In mezzo, dramma-ticamente in cerca di una certezza, i bam-bini stessi e le loro famiglie. Giornali, tv,radio e riviste specializzate hanno trat-tato lungamente di questo problema ed èfacile, oggi, ricostruirne il percorso acce-dendo alla ponderosa letteratura presen-te in internet (ricerche accurate si posso-no fare anche nelle bilbioteche più at-trezzate). Ma ancora oggi la gente si chie-de: cosa sono esattamente le cellule sta-minali? Che cure sono possibili con l’usodi queste cellule? Ricordando un nostro
precedente servizio giornalistico con in-tervista al prof. Martino Introna, re-sponsabile scientifico del Laboratorio diTerapia Cellulare “G.Lanzani” della Uscdi Ematologia dell’Ospedale Papa Gio-vanni di Bergamo, ma consapevoli che c’èancora tanto bisogno di parlarne, cer-chiamo di offrire alcune ulteriori preci-sazioni nella speranza di fare un po’ dichiarezza. Abbiamo perciò chiesto al no-stro esperto, dott. Gaetano Bianchi, di of-frirci un quadro sintetico ma esaurientesu questo tema. Con la consueta cortesiae la riconosciuta chiarezza, ecco la suaspiegazione:Quella che tratta delle cellule stami-nali è una branca della medicina mol-to recente. Anche se nel 1963 McCul-loch e collaboratori avevano segnala-to la presenza di cellule staminali nelmidollo di topo, ci sono voluti anco-ra 50 anni per capire come queste cel-lule capaci di autoriprodursi funzio-nano ad esempio nel midollo osseo
A proposito di...
cellule staminali

26
Prevenzione
Og
gi
(Calvi e Zang 2003). Negli ultimi ven-t’anni, gli studi sulle cellule stamina-li e sulle loro caratteristiche, sulla loropossibilità di intervenire nella cura dialcune malattie si sono moltiplicati adismisura: si calcola che attualmentesiano state pubblicati più di 200 milalavori riguardanti sia la biologia chela eventuale terapia in ambito dellaMedicina riparativa. Le cellule staminali sono alcune cel-lule in grado di autorigenerarsi al-l’infinito, rimanendo indifferenziate,ma con la possibilità di dare origine aduna serie di cellule specifiche di sin-goli tessuti. L’autorinnovamento è unprocesso di divisione cellulare e quin-di di duplicamento che consente dimantenere le caratteristiche della cel-lula madre. Si producono così divisionicellulari in serie con un aumento delnumero di cellule tutte eguali. È que-sto il caso delle cellule di tessuti “la-bili” come quelle del sangue, della pel-le, del rivestimento intestinale ecc., chedevono essere continuamente sosti-tuite per il mantenimento sia anato-mico che funzionale di questi tessuti. L’altra caratteristica di alcune cel-lule staminali è la capacità didifferenziarsi, cioè la cellulamadre ha la capacità di dareorigine a cellule giovani concaratteristiche strutturali,molecolari e funzionali di-verse mediante la cosiddettadivisione asimmetrica. Questecellule “nuove” hanno quindiaspetti e caratteristiche diverse ri-spetto alla madre. Cellule staminali presenti nel-l’uovo fecondato (zigote) già aiprimi stati di divisione e nell’embrio-ne, in queste strutture embrionali e fe-tali sono in attiva riproduzione esono “programmate” in modo tale che,pur partendo dalla unione di un uovoe di uno spermatozoo, nel giro di po-che settimane e mesi permettono laformazione e la crescita dei numero-si tessuti ed organi che comporrannoil nuovo corpo, portando alla nascitadi un nuovo essere vivente. Se le cellule staminali sono prevalen-
ti nell’embrione, man mano che si hala differenziazione cellulare e quindilo sviluppo dei singoli tessuti ed or-gani caratteristici somatici, diminui-scono di numero. Nell’adulto sano lecellule proliferanti sono concentratein poche e limitate zone del nostro or-ganismo.Le cellule dello zigote sono quindi to-tipotenti, cioè danno luogo ad ognitipo di cellula e tessuto; le embriona-
Cellule staminali
Cellule nervose Cellule del sangue
La ricerca biologica e medica è indirizzata ad evidenziare come le cellule staminali sianoregolate nei diversi tessuti del nostro organismo da fattori sia fisiologici che patologici. Alcunirisultati di tali ricerche sono già attualmenteutilizzati in alcune limitate patologie, soprattuttodella pelle, del sangue, della cornea.

27
Pre
venz
ione
Og
gi
li sono considerate pluripotenti, cioèpossono dar luogo a cellule e tessutidiversi, mentre quelle fetali ed adul-te sono multipotenti cioè la loro ca-pacità di differenziarsi diventa sempremeno evidente ed intensa e sono ingrado di dar origine a tutti i tipi di cel-lule tipiche di uno specifico tessuto.L’esempio più facile da capirsi è quel-lo della riproduzione di tutti i tipi dicellule del sangue (globuli rossi, bian-
chi, piastrine ecc.) per l’intera vita del-l’individuo. La ricerca biologica e medica è indi-rizzata quindi ad evidenziare comequeste cellule speciali siano regolatenei diversi tessuti del nostro organi-smo da fattori sia fisiologici che pa-tologici. I risultati sempre più appro-fonditi di tali indagini sono la condi-zione indispensabile per poter utiliz-zare queste cellule a scopo curativo, so-prattutto nei casi di malattie rare. Al-cuni risultati di tali ricerche sono giàattualmente utilizzati in alcune limi-tate patologie, soprattutto della pelle,del sangue, della cornea. Nel caso dilesioni della pelle estese, a seguito adesempio ad ustioni, da alcuni anni èpossibile effettuare dei trapianti di pel-le “nuova” generata in vitro su matricidi collagene e matrigel a partire daprogenitori e cellule staminali ottenutemediante piccole biopsie di pelle del-lo stesso paziente. Questi nuovi tessutiperò sono privi di ghiandole sudori-pare e bulbi piliferi: per questo la ri-cerca sta cercando nuove metodologie
che permettano la produzione dipelle qualitativamente uguale a
quella del paziente. Anche nelcaso di gravi lesioni cornea-li si è ora in grado di pro-durre in vitro un nuovo tes-suto corneale che abbia lacapacità di trasparenza tale
da assicurare la vista al pa-ziente. Molto si discute circa
la possibilità di produrre cellu-le di miocardio che siano efficaci di
riparare le zone colpite da in-farto miocardico. Ma a tut-t’oggi non si è raggiunta una
metodologia accettabile, se non par-tendo da cellule di origine embriona-li, pluripotenti, ma che ovviamente sesono disponibili nel campo animale, nelcampo umano pongono problemi tec-nici, di facile disponibilità ed etici didifficile risoluzione. Analoghe ricerchesono in corso nel caso di cellule mu-scolari scheletriche, così come in cam-po neurologico, ma si è ben lontani dagarantire una loro utilizzazione incampo medico umano.
La ricerca studia la lorocapacità di generarecellule “specifiche”
Cellule del fegato Cellule del muscolo

28
Prevenzione
Og
gi
Negli ultimi due decenni sono stateiniziate sperimentazioni con cellulestaminali “adulte” opportunamentemodificate per la terapia di alcune ma-lattie attualmente non curabili, ma sisono dovute interrompere precoce-mente per la comparsa di effetti col-laterali dannosi. Attualmente si ha no-tizia di alcune applicazioni pilota di cel-lule staminali in casi clinici affetti damalattie rare, di cui non esiste terapiaefficacia e dalle quali sembra vi sianosperanze per una applicazione futuraallargata. Ma i tempi per ottenere deidati certi soprattutto nei riguardidella non lesività sono lunghi anchealcuni anni, anche nel caso delle co-sidette cellule staminali pluripotenti,ottenute con sofisticate metodiche ditrasferimento nucleare. Il primo pro-blema sia per importanza che dalpunto di vista etico è quello della si-
curezza, cioè bisogna avere la certez-za che queste cellule modificate noncausino danni, soprattutto di tipo tu-morale. Il secondo problema, che in-teressa anche le cellule di origineembrionale, è rappresentato dalla dif-ferenziazione, in particolare è neces-sario che queste cellule diano luogo altessuto desiderato, di cui il paziente habisogno. Nel caso di molte malattie delsangue il problema sembra risolto, nelsenso che basta introdurre nel sanguele cellule per ottenere un ripopola-mento del midollo osseo. I risultati favorevoli sono peraltro sta-ti ottenuti dal prelievo e dalla con-servazione di sangue del cordoneombelicale alla nascita: questa meto-dica permette una facilità di approv-vigionamento, lavorazione e stoccag-gio delle cellule staminali, senza alcunrischio per il donatore, permette di ac-certare la eventuale incompatibilità per
il ricevente, ha un minor rischio di tra-smettere malattie infettive ed è ac-cettabile dal punto di vita etico, reli-gioso e legale. Ma anche per questi casiesistono dei limiti: mancato attecchi-mento, possibilità di trasmettere ano-malie genetiche ecc. Studi promettenti sono in corso per lecellule staminali di origine mesen-chimale ed endoteliale e da questi si hala speranza di giungere a poter effi-cacemente combattere alcune malat-tie attualmente non curabili, ma i tem-pi di attuazione sono ancora lunghi.Un altro problema di natura legale emorale incombe:l’uso commerciale enon controllato di queste nuove me-todiche. “Il commercio delle staminaliè fenomeno planetario che coinvolgescienza, economia e politica. Chemuove enormi volumi di affari po-tenziali e reali e tenta di erodere la vi-gilinza regolatoria sul mercato delleterapie avanzate” (Bencivelli “Le scien-ze” ottobre 2013, pag 58). “Allo statoattuale delle conoscenze, le cellule sta-minali mesenchimali non si sono maidimostrate utili per la cura delle ma-lattie per le quali Stamina sostiene diimpiegarle”(Bencivelli S. “Le Scienze”ottobre 2013, pag 60 e seguenti). Quando ci si trova di fronte a malat-tie “inguaribili”, in particolare quan-do colpiscono bambini anche in tene-ra età con un alto coinvolgimentoemotivo, psicologico ed umano, sipuò comprendere che i genitori si ag-grappino a tutto quanto offra loro unaminima speranza di aiuto. Per questoè importante che l’informazione siasempre corretta ed estremamentecauta nel non dare per certi risultatiche rappresentano il più delle voltesolo una speranza, anche se supportatada dati iniziali favorevoli ma non an-cora definitivi. La prudenza in questicasi non è mai eccessiva. Comunqueè sempre utile rivolgersi a centri al-tamente specializzati nelle terapiegenetiche e con cellule staminali,centri che anche in Italia non manca-no e la cui professionalità è nota an-che all’estero.
Dott. Gaetano Bianchi
Studi promettenti sono in corso per le cellule staminali di origine mesenchimale ed endoteliale e da questi si ha la speranza
di giungere a poter efficacemente combatterealcune malattie attualmente non curabili,
ma i tempi di attuazione sono ancora lunghi

29
Pre
venz
ione
Og
gi
Funghi, agrumi, cachi, frut-ta in guscio, zucca, sono iprofumi e i colori dell’au-tunno che ci consolano del-l’estate perduta.
FRUTTA IN GUSCIOLa frutta in guscio, come noci, noc-ciole e mandorle contiene già, natu-ralmente una bassa percentuale d’ac-qua e un’alta percentuale di grassi ecalorie. Con l’essiccamento la per-centuale di acqua si abbassa ancora econseguentemente aumenta il teno-re di grassi e calorie di circa il 20%.La frutta secca oleosa fornisce al-l’organismo una buona quota di gras-si insaturi che svolgono un ruolo pro-tettivo per la salute. Le noci contengono grassi insaturidella serie omega 3,particolarmenteutili al buon funzionamento dell’ap-
parato cardiovascolare. Fa eccezionea questo gruppo di frutti, la castagnache, più ricca di acqua e amido, con-tiene pochissimi grassi e con l’essic-camento quasi raddoppia le sue ca-lorie. In un’alimentazione equilibrata, le ca-stagne possono sostituire il pane,perché hanno simili caratteristichenutrizionali. Dalle castagne si ricavaanche la farina e la polenta.
AGRUMIGli agrumi sono ricchi di sostanze chesvolgono un ruolo protettivo per lasalute. Consumati quotidianamente,arance, mandarini, limoni e pompel-mi, arricchiscono la dieta di vitami-na C, in grado di contrastare i fami-gerati radicali liberi coinvolti neiprocessi di infiammazione e in mol-ti altri processi morbosi.
e|vxààx wËtâàâÇÇÉ

30
Prevenzione
Og
gi
Gli agrumi possono essere consumatifuori pasto perché costituiscono unottimo spuntino, che sazia senza ap-pesantire, ma sono indicati anche a ta-vola perché la vitamina C aumenta l’assorbimento del ferro inorganico, ge-neralmente poco assorbibile, conte-nuto negli altri alimenti che com-pongono il pasto.
LA ZUCCACome molti altre verdure e ortaggi,ha poche calorie, perché è costituitadi acqua per oltre il 90% del suo peso.100 g di zucca forniscono solo 26 ka-lorie e, grazie al suo sapore dolciastro,può essere usata per preparare dolci,risparmiando su altri ingredienti piùcalorici. La zucca può essere utilizzataanche nella preparazione di primipiatti come, pasta, gnocchi e risotti e,preparata al forno, non ha bisogno digrassi per la cottura. La zucca è ric-ca di luteina che si deposita nella re-tina e la protegge dalla maculopatia,una malattia degenerativa degli oc-chi. La zucca è anche fonte di beta ca-rotene che si trasforma in vitamina Anell’organismo, utile alla vista, comela luteina, e importante per combat-tere i radicali liberi.
FOCACCIA DOLCE ALLA ZUCCAINGREDIENTI: farina (g 250), lievito (g 15), latte magro mez-zo bicchiere (60 ml), zucchero ½ etto, zucchero a velo 1 cuc-
chiaio (g 10), cannella in polvere un pizzico, burro (50 g), zuc-ca (g 200 g), un pizzico di sale, olio per ungere la teglia.
CUOCERE LA ZUCCA: cuocete la fetta dizucca nel forno a 200 gradi. Quando la zucca ècotta, privatela della buccia e dei semi e frulla-tela.
PREPARARE L’IMPASTO: disponete lafarina a fontana con un incavo al centro. Intie-
pidite il latte e versatelo nel mezzo insieme allievito polverizzato e a una parte dello zuc-
chero. Aggiungete la purea di zucca. Lavo-rate il composto finché non avrà assunto un
aspetto omogeneo. Lasciate riposare l’impasto al caldoper 15 minuti. Trascorso il quarto d’ora, incorporate al panet-
to il resto del latte tiepido e lo zucchero, la cannella, il sale, il bur-ro a fiocchetti. Lavorate il tutto con energia. Sbattete bene l’im-pasto sul tavolo finché non produrrà delle bolle d’aria. Lasciate an-cora riposare la pasta coperta per 20 minuti.
STENDERE LA PASTA NELLA TEGLIA: ungete conl’olio una teglia lunga e stretta. Stendetevi dentro la pasta. Accende-te il forno e aspettate che diventi caldo. Infornate la focaccia per cir-ca 40 minuti a 200°. A cottura ultimata, tirate fuori dal forno il dolce.Lasciatelo raffreddare. Spolverizzatelo di zucchero a velo e servite.
TORTA DI CASTAGNEINGREDIENTI: 1 kg di castagne fresche, burro (100 g), zuc-
chero (100 g), uova 3, latte parzialmente screma-to, mezzo litro, fecola 3 cucchiai, una baccadi vaniglia.
PELARE LE CASTAGNE: incidete labuccia delle castagne e mettetele a bollire 5 mi-
nuti, poi scolatele e pelatele.
PREPARARE L’IMPASTO: cuocete le ca-stagne nel latte con la bacca di vaniglia e 50 g di
zucchero per 15 minuti. Scolatele e frullatele. Sbat-tete i tuorli d’uovo con lo zucchero, unite le casta-
gne,il burro a temperatura ambiente e la fecola e la-vorate il composto fino a che diventerà liscio e omo-
geneo. Montate gli albumi a neve e uniteli al composto.
STENDERE L’IMPASTO: stendete l’impasto inuna teglia foderata da carta da forno e cuocete in forno già cal-
do a 180° per 50 minuti.

31
Pre
venz
ione
Og
gi
I FUNGHII funghi, come la zucca sono ortaggie, se freschi o surgelati, hanno pochecalorie, circa 22 kcal per 100 g. I fun-ghi arricchiscono i primi piatti, i ripienidelle torte salate e costituiscono un ot-timo contorno, trifolati in padellacon aglio e prezzemolo. La racco-mandazione è quella di acquistare fun-ghi sicuri, come quelli della grande di-stribuzione o quelli raccolti solo dopoaverli fatti visionare ad un micologo.Gli avvelenamenti da funghi sono an-cora molto diffusi e molte persone per-dono la vita o si ammalano grave-mente a causa dell’ingestione di fun-ghi non commestibili.
CACHII cachi sono un po’ più zuccherini ri-spetto ad altri frutti e apportanocirca 70 kcalorie per 100 g ma pos-sono tranquillamente essere inseritiin una dieta equilibrata. Bisogna,inoltre considerare che, grazie alloro gusto, particolarmente dolce, icachi possono sostituire il dessert per-ché offrono la stessa gratificazionesenza appesantire la dieta di grassi econ un notevole risparmio di calorie.
Cristina Grande
CREMA DI CACHIINGREDIENTI: cachi 6, fecola 6 cucchiai, zuc-chero 6 cucchiai, cacao amaro 6 cucchiai.
MESCOLARE GLI INGREDIENTI: uni-te insieme i cachi pelati e frullati con tuttigli altri ingredienti.
PREPARARE LA CREMA: mettete tut-to in una casseruola e mescolate gli in-gredienti a fiamma bassa fino a che non rag-giungeranno una maggiore consistenza.Spegnete la fiamma, lasciate intiepidire e por-zionate la crema in piccoli bicchieri. Lasciate riposare2 ore in frigorifero e servite.
PENNE INTEGRALI AI FUNGHI E PEPERONIINGREDIENTI: pasta integrale (g 320), olio di oli-va extravergine due cucchiai (g 20), funghi freschi (g500), pomodoro 1, peperone 1, aglio e prezzemoloquanto basta.
CUOCERE LE VERDURE: lavate deli-catamente le verdure e tagliatele a fette, sbuc-ciate l’aglio e fatelo rosolare in una casseruo-la. Aggiungete le verdure e fatele cuocere se-micoperte, a fiamma bassa.
PREPARARE LA PASTA: Mettete trelitri d’acqua in una casseruola. Portate ad ebol-lizione e salate. Cuocete la pasta per il tempoindicato sulla confezione. Scolatela e unitela alleverdure cotte nella casseruola. Saltate qualche mi-nuto a fuoco vivo, spolverizzate con il prezzemolo la-vato e tritato e servite.
POLLO AL MANDARINOINGREDIENTI: petto di pollo (g 500), cipolle2, olio di oliva extravergine 2 cucchiai, mandarini4, pepe.
SBUCCIARE E TRITARE LE CIPOL-LE: Sbucciate e tritate le cipolle e fatele appas-sire in una casseruola con poco olio.
CUOCERE LA CARNE: Ag-giungete alle cipolle il petto di polloe rosolatelo da entrambi i lati. Spre-mete i mandarini e aggiungete il suc-co al petto di pollo. Completate la cot-tura, pepate e servite.

Pre
venz
ione
Og
gi
32
Prevenzione
Og
gi
Notizie dalle Sezioni
Da sinistra: la presidente del Gruppo AidoAlta Valsassina Mariateresa Volpe.A fianco: Giacomo Colombo vicepresidentedell’Aido Provinciale di Lecco.
Venerdì 9 ottobre si è tenuta, con l’aiuto della Sezione localedell’Avis e il patrocinio dell’Amministrazione comunale, nellasala “Gaber – Jannacci” di Villa Sandroni a Colnago, frazionedi Cornate, l’interessante conferenza dal titolo: “Donazionedegli organi e dei tessuti: un gesto per la vita”. Presentati dallasig.ra Guerrina Frezzato, segretaria della Sezione provincialeAido di Monza Brianza e alla presenza dell’avv. Cristina Te-ruzzi, assessore alle Politiche sociali del Comune di Cornatee del presidente dell’Aido di Cornate sig. Davide Vecchi, sonointervenuti il sig. Lucio D’Atri, consigliere nazionale dell’Aidoe la dott.ssa Raffaela Mistò, responsabile della Banca degliocchi di Monza. Dopo la proiezione di un interessantissimofilmato sull’attività di questa speciale “banca” di Monza è in-tervenuta anche la sig.rina Gloria Cantù, trapiantata di en-trambi i polmoni, che ha portato la sua toccante esperienzadi giovane ammalata in lista d’attesa, poi di trapiantata e cheha potuto rientrare finalmente nella società attiva e goderedi una vita normale dopo il trapianto di cinque anni fa. Se-
rate come questa aiutano a diffondere la cultura della do-nazione di organi e tessuti fra i nostri concittadini, aumen-tando così il numero delle donazioni e di conseguenzaquello dei trapianti, in modo da diminuire il numero degliammalati in lista d’attesa per un innesto di tessuto od un tra-pianto d’organi.
Conferenza Aidosul tema della donazione
CORNATE D’ADDA (MB)
È nato il Gruppo AidoAlta Valsassina
Il 16 ottobre è stato costituito un nuovo Gruppo Aido nellaprovincia di Lecco. Per la precisione il 36.mo! Si tratta delGruppo intercomunale Alta Valsassina, comprendente i Co-muni di Taceno, Crandola Valsassina, Margno, Casargo, Pa-gnona e Premana! Un evento alquanto atteso e sofferto! Daalcuni anni, infatti, si erano instaurati contatti a questo scopo,tra la Sezione provinciale Aido di Lecco e alcuni iscritti di Pre-mana, ai quali era stato proposto di farsi promotori di que-sta iniziativa. L’Associazione che si è spesa maggiormenteper questo progetto è stata la Delegazione Cri di Premana,nelle persone di Sem Rusconi, Sandro Sanelli, Erika Ambro-sioni, più avanti affiancati da altri Volontari Cri di Casargo,ovvero da Lino Regazzoni e Mariateresa Volpe.L’azione promotrice di queste persone, si è sviluppata inquesti ultimi 3 anni, coinvolgendo altri iscritti, raccoglien-done di nuovi, ma anche con serate tematiche, a Premanae Casargo (deludenti sotto l’aspetto della partecipazione) equelle di Taceno lo scorso dicembre e di Pagnona il 16 otto-bre, proprio nel corso della quale è stato raggiunto l’ago-gnato obiettivo. Perchè un Gruppo Aido? Il motivoprincipale è quello di mirare ad una presenza molto diffusae capillare sul territorio, al fine di diffondere sempre di più e
sempre meglio la cultura del dono, al fine di far giungere apiù persone possibili l’invito a manifestare in vita, la scelta didonare i propri organi, post-mortem. Obiettivo finale èquello di ridurre il più possibile il divario numerico che esi-ste, tuttora, tra i pazienti in lista d’attesa per un trapianto d’or-gani ed il numero degli organi disponibili. Per questo primo importante traguardo, un sincero ringra-ziamento lo si vuole rivolgere al dott. Lusenti ed al dott. Del-l’Oro, conduttori della serata tematica del 16 ottobre; al prof.Martini e a Sabina Baggioli, relatori delle serate precedenti aTaceno e Casargo! Un grazie doveroso va anche ai sindaci
LECCO

33
Bella e toccante, la cerimonia svoltasi ad Alzano Lombardo,per celebrare il 40° di fondazione del nutrito gruppo Aidolocale. Gruppo, che in questi lunghi anni di militanza, ha su-perato momenti di difficoltà e che, grazie alla tenacia di al-cuni soci convinti della necessità di far esistere il sodalizio,ha continuato non senza problemi l’opera dei suoi fonda-tori. La convinzione e l’amore verso il prossimo, sono il va-lore fondamentale che la nostra società deve sostenere conimpegno. La cerimonia si è svolta in due giornate; sabato 26settembre nella basilica di Alzano; il coro “Harmonia Nova” diBergamo diretto da Laura Pellicioli, ha eseguito un’eccellenteelevazione musicale dedicata ai donatori e ai soci scomparsi.Il nuovo parroco di Alzano don Filippo Tomaselli, ha rivoltoai presenti il benvenuto e con orgoglio, ha detto che anchelui è iscritto da parecchi anni all’Aido, ribadendo quanto ènecessaria la donazione di organi.Domenica 27 si è svolta la cerimonia ufficiale; ricevuti dalsindaco dottoressa Annalisa Novak e da alcuni consiglierinella sala del palazzo comunale, dove sono stati rivolti i sa-
luti all’Aido e alla sua storia. Ha parlato per primo il presi-dente Loredano Signorelli, che ha tracciato la storia delGruppo e illustrato le attività che si svolgono durante l’anno.Il Sindaco Novak, ha rimarcato l’importanza della donazione;essendo lei medico e tesserata all’Aido, conosce le sofferenzedella gente- Ha esortato i presenti a divulgare la pratica delladonazione. Infine il presidente del Consiglio regionale AidoLombardia, Leonida Pozzi ,con una toccante relazione ha il-lustrato tutte le problematiche sia giuridiche che morali, in-sistendo che la donazione degli organi è un atto libero madovuto e che ognuno di noi deve sentirla come una neces-sità. La donazione, ha concluso, deve essere fatta nelle strut-ture pubbliche e deve essere del tutto gratuita, “ gli organinon si vendono”. Di seguito, sono stati consegnati i diplomial Gruppo e un riconoscimento all’insostituibile segretarioMario Cazzaniga che tanto si prodiga e tanto ha fatto per ri-costituire il nuovo Direttivo. Terminate le cerimonie di rito, incorteo accompagnati dal gonfalone comunale, da alcunigagliardetti dell’Aido, dell’Admo, dell’Avis locale e delGruppo Alpini di Alzano, ci si è recati alla Basilica per assi-stere alla Santa Messa officiata da don Tiziano curato del-l’oratorio. Un bel gruppo di soci e amici, ha concluso la bellagiornata con un ottimo pranzo in un ristorante del posto.
Pierfranco Marchesi
Notizie dalle Sezioni
40º di fondazione del Gruppo Aidodi Alzano Lombardo
ALZANO LOMBARDO (BG)
Maria Luisa Fondra di Taceno, Mariacristina Coppo di Pa-gnona e Pina Scarpa di Casargo, la cui azione di supporto èrisultata determinante. Solamente un caso, che siano tuttedonne?Molto colorato di rosa è anche il giovane Consiglio direttivodel Gruppo con Mariateresa Volpe, presidente, Alessia Ta-gliaferri e Francesca Denti, vice presidenti, insieme agli altriconsiglieri Sem Rusconi, Roberto Regazzoni, Bortolino Re-gazzoni, Erika Ambrosioni, Noemi Rasa e Silvano Invernizzi.Questo nuovo Gruppo si aggiunge a quello dell’Altopiano
Valsassinese, costituitosi nel 2013!Per completare il mosaico della presenza Aido in Valsassina,mancherebbe un Gruppo che rappresenti i Comuni delfondo valle, ovvero Pasturo, Introbio, Primaluna, Cortenovae Parlasco che, affiancati dal già esistente ed attivissimoGruppo di Ballabio, darebbe un senso compiuto al lavoro diquesti ultimi 5 anni!E’ infatti dal 2010 che si lavora a questo obiettivo, che ci era-vamo prefissati come “ciliegina sulla torta” del lavoro svoltoin quegli anni dal Presidente Provinciale Vincenzo Renna.

Paderno d’Adda: I trapianti pediatrici. Daldolore alla speranza di una nuova esistenza
Venerdì 13 novembre, presso Cascina Maria a Padernod’Adda, il Gruppo comunale Aido ha proposto una seratamedico informativa sul tema, molto delicato, dei trapiantipediatrici, con la presenza di ospiti illustri come il dottor Da-niele Bonacina, medico in terapia intensiva all’Ospedale diBergamo, e il professor Michele Colledan, direttore del di-partimento di Chirurgia e trapianti del medesimo ospedale. Dopo i saluti da parte del sindaco Renzo Rotta, del presi-dente della sezione provinciale Aido di Lecco Carlo Casari edel presidente del Gruppo Aido di Paderno Daniele Sorzi,che ha voluto ricordare nel suo intervento la scomparsa nel2014 della piccola Natalie Casati di Robbiate, la parola è pas-sata al cavalier Leonida Pozzi, presidente del Consiglio re-gionale Aido Lombardia, in qualità di moderatoredell’incontro. “Voglio ringraziare il gruppo Aido di Paderno e il suo presi-dente non solo per questa serata - ha sottolineato il cavalierPozzi - ma soprattutto per quanto sono riusciti a fare nel tes-suto sociale di questa comunità per diffondere la culturadella donazione”.“Il tema che proponiamo oggi - ha continuato il presidentePozzi - lo affrontiamo di rado. Nel pensiero comune i bam-bini non vengono associati ai trapianti e il dolore degli in-nocenti è qualcosa che ci lascia atterriti, come avvenne perdon Gnocchi quando in un suo celebre scritto chiese a Dioil motivo della sofferenza che vedeva negli occhi dei bam-bini malati. Per fortuna in Lombardia abbiamo centri al-l’avanguardia come quello della terapia intensiva pediatricadell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, voluto e rea-lizzato anche grazie ad opere di volontariato”.Il lavoro di questa struttura è stato descritto dal dottor Bo-nacina, che ha specificato come nel reparto, a pochi letti didistanza, possano trovarsi sia il bimbo che supererà la ma-lattia grazie alla donazione di un organo sia quello che in-vece non ce la farà e i cui organi doneranno a qualcun altrola vita. “Per quanto riguarda i bambini, nei casi in cui siamo certidella diagnosi di morte, che per la legge italiana si identificacon la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’ence-falo, abbiamo l’obbligo di richiedere ai genitori il consensoper la donazione degli organi”, ha spiegato il dottor DanieleBonacina. “È la parte più difficile del mio lavoro, ma da unareazione di disperazione può anche nascere la necessità diriaprirsi alla vita. A quel punto noi medici diventiamo cu-stodi del dono che significherà la vita per qualche altro bam-bino”. “I potenziali donatori in età pediatrica - ha continuatoil medico - sono sostanzialmente i pazienti che perdono la
vita per alcuni casi di meningite o a seguito di arresto car-diaco. Mano a mano che cresce l’età del bambino cresceanche l’opposizione dei genitori al prelievo degli organi. Equesto perché, superati i primi anni di vita, le cause più co-muni di morte riguardano eventi fortuiti e traumatici a cui igenitori non erano preparati e che li lasciano nello sgo-mento e nella rabbia”.In Italia il fegato è l’organo più soggetto a trapianti in età pe-diatrica, anche grazie al fatto che i bambini possono rice-verlo dagli adulti, aumentando la speranza della donazione.Nei casi di insufficienza epatica acuta o avvelenamento dafunghi i pazienti entrano in emergenza in terapia intensivae qui inizia il conto alla rovescia in attesa dell’organo chepossa salvare loro la vita. Proprio dal trapianto di fegato il professor Michele Colledanha scelto di iniziare il suo intervento. “Il primo trapianto di fegato riuscito avvenne nel 1967 suuna ragazza di 19 anni, considerata ancora in età pediatrica.Tutt’oggi questo trapianto è un’operazione complessa mal’intervento è scomposto in tante piccole parti riproducibili”,ha spiegato il luminare. “Sono state le operazioni per salvarela vita ai bambini il vero motore dell’evoluzione tecnica diquesta procedura perché un fegato non funzionante negliinfanti non porta solo, nel peggiore dei casi, alla morte maanche a danni irreparabili nello sviluppo. A fronte di una for-bice tra i 1650 e i 4400 adulti all’anno che avrebbero bisogno
PADERNO D’ADDA (LC)
34
Prevenzione
Og
gi
Notizie dalle Sezioni
Il dottor Daniele Bonacina e il professor Michele Colledan
Daniele Sorzi, presidente del Gruppo Aido di Paderno

35
Pre
venz
ione
Og
gi
Magnifica serata dedicata al Beato don Carlo Gnocchi sa-bato 31 ottobre 2015 al Teatro Jolly di Olginate. Organizzatadai gruppi comunali Aido di: Olginate/Valgreghentino, Gar-late, Pescate, Airuno, Vercurago, Calolziocorte e Monte Ma-renzo, in collaborazione con gli Alpini, la serata ha visto lapartecipazione di Silvio Colagrande, uno dei due bambiniche nel 1956 hanno ricevuto le cornee di Don Carlo. In si-lenzio e partecipazione oltre 500 persone hanno ascoltatoil coro Ana dell’Adda di Olginate e Calolziocorte, poi ilgruppo folkloristico I Picétt del Grenta di Valgreghentino edinfine il coro Grigna dell’Ana di Lecco che con le loro canzonihanno richiamato alla memoria gli eventi che hanno ac-compagnato la vita del Beato. La stessa attenzione è statadedicata al breve video che racconta dell’opera del Beato,prodotto dalla Fondazione don Gnocchi e alla successiva te-stimonianza di Silvio Colagrande, che con parole semplicima intense ha raccontato la sua personale esperienza, oltrea parlare dei fugaci incontri con don Carlo. Il gruppo “ CheBordello “ di Olginate, che ogni anno organizza una giornataper ricordare Davide, donatore di cornee, ha informato delleloro attività di solidarietà a favore della comunità Olginatese.Una serata tutta all’insegna della donazione, a tutti i parte-
cipanti sono stati consegnati: una copia di “PrevenzioneOggi, un atto olografo e del materiale informativo della Fon-dazione don Gnocchi, oltre al giornale Penna Nera. È statoun bel lavoro di squadra dei diversi gruppi Aido con gli Al-pini, la serata riuscitissima testimonia l’importanza della col-laborazione dei Gruppi della nostra associazione con le altreassociazioni per diffondere al meglio il nostro messaggio. Vidiamo appuntamento per l’anno prossimo, ripeteremol’esperienza in occasione del 60°.
Notizie dalle Sezioni
Un pieno di emozioni ricordando il Beato Carlo Gnocchi
OLGINATE (LC)
di un trapianto di fegato, sono soltanto 100 i bambini in Ita-lia che devono subire l’operazione: una richiesta che la listadei donatori riesce fortunatamente a soddisfare”.A questo punto anche il professor Colledan è entrato nellospecifico del lavoro che viene svolto all’Ospedale di Ber-gamo.“Il centro di Bergamo è uno dei principali in Italia e il piùgrande in Lombardia per numero di trapianti di fegato. Dallafondazione nel 2006 alla fine del 2014 sono stati 1200 i tra-pianti eseguiti, di cui 56 su 47 bambini dal peso medio di 9kg e 1,39 anni di età”, ha spiegato ancora il chirurgo. “Numerisimili ci sono solo nelle strutture di Londra, Parigi e Los An-geles. In 10 anni di attività mai nessun bambino è morto aBergamo aspettando la donazione di fegato e i tempi di at-tesa sono in media di 55 giorni”. Il dipartimento di chirurgia e trapianti dell’ospedale PapaGiovanni XXIII è dunque un’eccellenza del nostro Paese perquanto riguarda questo tipo di operazione. Risultati menobuoni si riscontrano per i trapianti di intestino e polmone,legati però alla complessità degli interventi. “Il trapianto di intestino è quello che in assoluto ha i risultatimeno buoni e che si esegue con più difficoltà. Nel caso deibambini motivi di intervento possono essere difetti conge-niti della mucosa, intestino corto o inesistente mobilità del-l’organo. In tutto il mondo ci sono soltanto 127 trapianti
l’anno, il 61% sopravvive all’intervento e di questi solo lametà avrà un intestino totalmente funzionante; questo èdovuto a crisi di rigetto o gravi infezioni. In Italia esistonosolo due centri per il trapianto in età pediatrica: Roma e Ber-gamo, da noi dal 2006 al 2012 sono stati eseguiti 10 trapianticon una curva di sopravvivenza superiore a quella del Regi-stro mondiale della sanità. Sono numeri ridotti, ma per il si-stema sanitario un solo paziente costretto a emigrareall’estero per essere curato costava svariati miliardi di vec-chie lire”, ha sottolineato il professor Colledan prima di con-cludere la sua relazione parlando anche dei 17 trapianti dipolmone su 13 bambini che dal 2004 sono stati eseguiti al-l’Ospedale di Bergamo, primo centro in Italia per trattare ma-lattie legate soprattutto alla fibrosi cistica e che costringonoal trapianto circa 100 bambini all’anno nel mondo.Al termine della serata i relatori hanno mostrato le foto di al-cuni dei bambini che grazie alla donazione hanno avuto lapossibilità di una nuova vita; ed è proprio per loro che, a pre-cisa domanda da parte del pubblico, i medici hanno spie-gato di riuscire a superare la tragedia della morte di unbambino: per fare in modo, con il proprio lavoro, che altriabbiano delle possibilità.
Matteo FratangeliPer gentile concessione di Merate Online
www.merateonline.it

36
Prevenzione
Og
gi
NOTIZIE DAL MONDO
USAE TORNARONO A RIVEDER LE STELLE. NUOVE FRONTIERE PER RIMEDIARE ALLA CECITÀ
C’e’ motivo per essere ottimisti nel campo della ri-cerca per curare la cecità. Tre diverse sperimenta-zioni stanno infatti portando ottimi risultati andandoad infoltire le fila di medici e scienziati che di-chiarano che ciò che era impossibile solo 5 o 10 annifa adesso non lo è più. Parliamo di trattamenti perla cecità a base di cellule staminali, terapie geneti-che e impianti bionici. Nel caso di quest’ultimo me-todo, l’occhio bionico in questione di chiama l’”Ar-gus II”, l’impianto va inserito con una operazionechirurgica piuttosto complicata nell’occhio del pa-ziente e lavora in tandem con un paio di occhiali dasole che vanno sempre tenuti inforcati. La visionepare non sia ancora perfetta ma coloro che hannodeciso di provare Argus II raccontano di progres-si notevoli ed un aumento nel tempo della sensibilitànella percezione di forme e volti. La terapia a basedi cellule staminali funziona invece tramite iniezionediretta di queste cellule nell’occhio di pazientiaffetti da degenerazione maculare dovuta all’età oalla genetica. Le cellule staminali sono trattate perevolversi in cellule epiteliali e dare nutrimento allaretina per riacquistare cosí la visione persa. Infinela terapia genetica, attualmente un trattamento spe-rimentale che prevede l’iniezione nell’occhio di geninon mutati che producono una proteina necessa-ria per i fotorecettori. Iniettata in un solo occhio,per vedere i progressi rispetto all’altro, questa tera-pia ha dato benefici che in certi casi si sono rive-lati non permanenti. La ricerca continua. (F.S.)
GIAPPONEINDIVIDUATE LA ZONA DEL CERVELLOLEGATA ALLA FELICITÀ
Uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reportsmostra che individui che presentano (alla risonan-za magnetica) un precuneo di dimensioni maggiori,tendono ad essere più felici e soddisfatti della pro-pria vita. Lo studio è stato condotto presso l’Uni-versità di Kyoto da Wataru Sato.Il precuneo è una regione piuttosto piccola del cer-vello che si trova nei lobi parietali. È coinvolto invarie funzioni importanti tra cui la memoria epi-sodica, l’immaginazione visuale-spaziale, la capacitàdi riflettere su se stessi e aspetti della coscienza. Gliesperti hanno coinvolto un gruppo di soggetti e po-sto loro domande di vario tipo per “misurare” il lorolivello di benessere psicologico, o in altri termini
quanto si sentissero felici e appagati della propriavita. I ricercatori hanno poi confrontato le infor-mazioni raccolte sul campione con i risultati di unarisonanza magnetica del cervello di ciascuno. Èemerso che i soggetti tendenzialmente più felici ave-vano un precuneo di volume maggiore. Numerosistudi hanno dimostrato che un programma di me-ditazione è in grado di aumentare la materia gri-gia del precuneo, dunque potrebbero aumentare lanostra felicità. (C.E.)
USATRATTAMENTI ANTISTRESS. DALL’AMERICA UNA TERAPIA BASATASUL GALLEGGIAMENTO NELL’ACQUA TIEPIDA
Trovare un rimedio “per lo stress della vita moder-na”, come recitava una vecchia pubblicità, è una at-tività che da molti anni ormai coinvolge ricercato-ri e scienziati di tutto il mondo. In America da qual-che tempo si stà diffondendo a macchia d’olio unapossibile, nuova, soluzione al problema chiamata “flotation tank”, letteralmente vasca di galleggia-mento. Si tratta di sorte di vasche da bagno atte acontenere una singola persona per volta, dotate diun coperchio per una chiusura ermetica e riempi-te di acqua alla temperatura corporea di chi vi si im-merge. Il paziente che decide di utilizzarle vi en-tra per 90 minuti e si ritrova in un ambiente buioe privo di rumori dove gli unici suoni che ode sonoil suo respiro ed il battito cardiaco. Secondo chi pra-tica questa attività, consigliata una volta a settima-na, fluttuare nell’acqua al buio aiuterebbe la men-te a rilassarsi, liberandosi dallo stress quotidiano pro-curato dai rumori dell’ambiente in cui si vive quo-tidianamente e dal continuo contatto con il mon-do esterno. L’International Journal of Stress Ma-nagement ha recentemente riportato i risultati di unostudio condotto su persone affette da crisi di pani-co collegate a stress che si sono immerse per un pe-riodo nella flotation tank. Secondo quanto pubbli-cato sembra che questo trattamento abbia permessoai pazienti trattati di diminuire notevolmente i li-velli di ansietà e depressione. IL direttore di uno deicentri più noti, il Float Clinic and Research Cen-ter di Tulsa in Oklahoma, ha annunciato per il pros-simo anno una scansione della mente delle perso-ne con problemi di panico prima e dopo le im-mersioni nelle vasche di galleggiamento confidan-do negli ottimi risultati fino ad ora conseguiti. At-tualmente in America vi sono 271 centri che per-mettono questa attività, mentre nel 2011 erano solo85. (F.S.)
NEWS OF THE WORLD

98_terza copertina nov_15.ai 1 26/11/2015 10:37:39