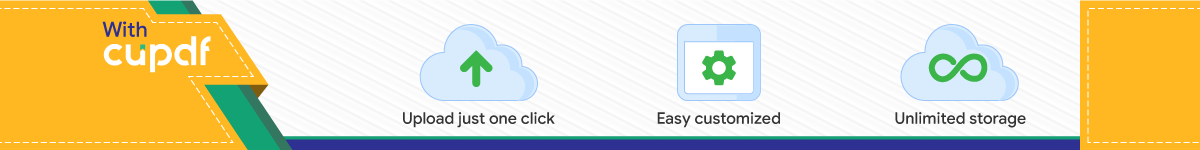

la vita finisce?
“La fine” e “il fine” della vita : una sfida per l’antropologia, la scienza e la fede.
Cessare di sperare è cessare di vivere:
si spira quando non si spera!
Fino ad una trentina d’anni fa, forse anche meno, una domanda come quella che accompagna questa nostra riflessione, sarebbe stata fuori luogo, perché aveva già la sua risposta nell’evidenza del morire “normale” quasi sempre in famiglia e il medico, tutto al più, ne certificava l’avvenuto processo (morte non medicalizzata).

Per una medicina (ed una consapevolezza sociale e
personale diffusa)
che accetti
di curare senza guarire.
Se sei malato, vieni e ti guarirò;
Se non potrò guarirti, ti curerò;
Se non potrò curarti, ti consolerò!

1. La vita va trattata come un che si auto-accredita nella storia e non ha bisogno di altre forme di presentazione o di sostegno (Perché ci poniamo la domanda “QUANDO” inizia/finisce la vita?).
2. L’uomo nella sua identità di essere umano – individuale- personale dipende solo dai signae personae?
3. È necessario mantenere ben salda la priorità del piano dell’essere sul piano dell’agire: io SONO il mio corpo oppure io HO il corpo? Körper vs. Leib!
4. Non invertire le precedenze: piano ontologico etico giuridico.
5. Sensibili non alla CENTRALITA’ della vita (suscettibile di interessate fluttuazioni) ma alla SACRALITA’ dell’esistenza (sostanziata su piano non più sottoponibile a referendum).
6. La statistica può fare l’etica?

Che cosa è cambiato dunque nel morire e quindi nel vivere dell’uomo moderno?
Problemi antichi e nuovi vengono vissuti in un complesso orizzonte culturale in cui predominano:
• la rimozione dell’idea stessa di morte (viene prospettata l’immagine e soprattutto l’idea di una morte “dolce”, addomesticata, civile, non-selvaggia: una morte “confortevole”, come del resto ha da essere nella vita della civiltà del benessere. Il CONFORT sembra costituire l’assurdo criterio etico della civiltà del BEN-ESSERE);
• la medicalizzazione estrema dell’assistenza al morente;
• la tendenza ad escludere dalla vita una dimensione di trascendenza;
• la privatizzazione della coscienza (da frater a socius a civis: ciò che regola le relazioni sono le norme asettiche nella convinzione che garantiscano spazi “neutri” di decisione per il singolo, svincolate da forme di pre-giudizio sociale) formata e gestita secondo la categoria dell’auto-determinazione (su un’esperienza complessiva – la Vita – che non-è-disponibile),
e soprattutto
• una considerazione efficientistica dell’esistenza umana (oggi parliamo spesso di “qualità di vita”, con una visione addizionale (1+1+1…) e non moltiplicativa (1x1x1…) della vita, per cui sembra che sottraendo un fattore (inizio o fine, o sezioni intermedie dell’esistenza), il risultato finale resti inalterato).
Ci confrontiamo con questioni di vita e di morte che richiedono l’interazione di ambiti esistenziali fra loro molto diversi, con metodi, contenuti, prospettive molto diverse e la confusione certamente non aiuta: tecnica, etica, diritto, sentimento, … mettono in gioco dei parametri diversi per intendere cosa vogliamo dire quando parliamo di morte e quindi di vita!

• Faccio solo un esempio, di quanto voglio dire: abbiamo molto sentito parlare in tempi recenti di “morte cerebrale”: ma in quel caso non era forse solo “morte corticale”? Lo stato vegetativo persistente (ossia lo stato di vita in cui non funziona la corteccia cerebrale) anche tecnicamente non è morte cerebrale, al punto tale che in un soggetto in svp non si possono asportare organi fosse anche per il nobile obiettivo di trapiantarli in altre persone bisognose.
• Lo svp è “semplicemente” “vita di basso livello”: non è morte cerebrale, ma è morte corticale, in cui vengono meno alcune delle attività umane “cosiddette superiori” (autocoscienza, vigilanza, relazionalità), ma possono restare attive le capacità centrali di regolazione dell’organismo e le capacità di espletare in modo integrato alcune finzioni vitali, inclusa la respirazione autonoma e quindi si mantiene comunque l’unitarietà funzionale dell’organismo.
• A questo punto, capite bene, non stiamo più discutendo su dati tecnico-scientifici-sanitari, ma siamo già passati ad un ambito ancora più coinvolgente (piano del senso): che cosa intendiamo per vita umana “degna” di essere vissuta? Anche perché se parliamo di vita “degna” vuol dire che ammettiamo anche, magari inconsciamente che ci sia una vita “indegna” di essere vissuta, e questo poi apre scenari quotidiani molto diversi.

L’idea sottesa al concetto di vita “degna o indegna” di essere vissuta, per me, è pericolosa, anche se ne possa intuire tutto il fascino seducente che porta con sé.
L’idea sottesa in questa posizione è che un essere umano sia una persona soltanto se può svolgere alcune performances, o funzioni, ritenute caratteristiche, come l’essere autocosciente o responsabile .
Coloro che non hanno ancora alcune caratteristiche qualificanti (come gli embrioni – e ciascuno di noi lo è stato), coloro che non le hanno più (come i soggetti in SVP), coloro che non le avranno mai (come i cerebrolesi gravi – che ormai al di là della retorica buonista “buttiamo via” prima di nascere, come i bimbi down) non sono ritenute persone in senso proprio.
Dal momento che i confini della vita e della morte umane sono indicati dall’apparire e dal cessare delle funzioni corticali, esistono esseri appartenenti alla specie umana che vivono di vita biologica, ma non vivono una vita biografica che sarebbe LA vita veramente umana. Gli eventuali diritti sono loro attribuiti, attraverso il consenso e l’accordo, dalla comunità morale formata dalle persone umane in senso pieno.
In questa prospettiva si comprende la nozione di brian life in modo speculare a quella di brian death nel senso, rispettivamente, dell’inizio e della cessazione delle funzioni cerebrali superiori.

Qui possiamo intuire che spesso il “problema” non è la “pietà” verso il malato “poverino”, ma la nostra difficoltà a prendercene cura, spesso per tempi lunghi anni, spesso in famiglie lasciate “sole” dalle istituzioni che “fanno quello che possono”, abbandonate dalle nostre stesse comunità ecclesiali che spesso “dicono ma non fanno” per sostenere non solo con la “preghiera”, ma anche con l’intervento concreto a favore del sostegno, della sostituzione, dell’agevolazione di chi deve accudire, assistere queste persone malate. Io ritengo che ciò che ci spaventa in queste situazioni di salute così impegnative non sia la malattia in sé della persona, ma il “come fare- cosa fare” per affrontarla, con dei tempi così lunghi: realisticamente i soldi sono necessari, il lavoro dei familiari va mantenuto, le strutture che possono accogliere questi malati non sono sufficienti, le incertezze verso il futuro sono molte (cfr. l’associazione “dopo di noi”), le famiglie di questi malati spesso sono “sequestrate” nei loro spazi esistenziali dai malati stessi (che necessitano di una presenza continua) … e si potrebbe continuare.
Pongo solo una domanda: sopprimerli può essere una soluzione? È una soluzione pietosa per loro o per me, per le loro sofferenze o per le mie ansie e difficoltà?
Vedete che ancora una volta la domanda si sposta su un versante fondamentale che nessuno di noi, credente o meno, può trascurare: la vita, come la interpreto, secondo quali coordinate fondamentali, secondo quali priorità, secondo quali stili principiali, … secondo quale “fine”: perché è evidente che è “il fine” della vita che già da ora, condizionerà anche “la fine” della vita che vivrò più avanti.

• Il criterio della morte corticale presuppone un’antropologia – secondo me – inaccettabile che identifica la vita personale con la possibilità di esprimere peculiari attività e che discrimina gli esseri umani in base alle loro prestazioni, ancorchè prestazioni nobili e tipicamente umane. Le conseguenze di questo atteggiamento mentale sono “aberranti” perché, quand’anche si ritenesse di tutelare per legge queste esperienze escluse dai confini della piena umanità, in caso di conflitto con gli interessi degli agenti morali veri e propri è ovvio che prevarranno i diritti di questi ultimi (si pensi alla legge 194: tra madre e figlio, ahimè prevale l’interesse della madre!) come il diritto ad avere organi per i trapianti.
• Se avessimo la pazienza di ripercorrere la genealogia di queste idee ci accorgeremmo che non si tratta di un semplice aggiornamento dei criteri di morte reso necessario dai progressi della medicina, ma di un preciso modo di leggere la vita umana, un modo di leggere e interpretare rispondente a logiche di dominio e di uso (“a cosa serve una vita del genere?”).
•

Quando le forze vengono meno, l’esistenza volge al declino e l’ombra della morte si allunga inesorabilmente sugli ultimi barlumi di una vita che si spegne, il nostro atteggiamento verso la persona è messo a dura prova. Mentre il non-senso sembra insidiare e appannare il valore della vita, la coscienza si dibatte tra
• il rispetto vitalistico e quasi feticistico della vita biologica ormai languente e
• la tentazione di abbandonare o, addirittura, sopprimere colui che è segnato ormai da un destino fatale.
Il dolore e la morte mettono in crisi la pretesa narcisistica dell’uomo moderno che ritiene di poter controllare e programmare tutta la sua vita attraverso la scienza e la tecnologia. La morte estingue l’esistenza terrena e svela la radicale fragilità di cui è impastata l’esistenza umana, ponendoci di fronte ad una tragica ed ineluttabile esperienza di fallimento.
Davanti alla morte l’enigma della condizione umana diventa sommo: essa viene percepita come l’annientamento della persona e la perdita definitiva della possibilità di relazioni umane e questa disperata convinzione si traduce concretamente nella paralisi relazionale che si instaura intorno al morente e alla sua famiglia, vera e propria anticipazione della morte fisica.

• La rimozione dell’idea della morte fa sì che i familiari, gli amici e persino gli operatori sanitari si dimostrino sempre più incapaci (ma questa NON è una loro colpa, sia chiaro!) di accompagnare il morente per aiutarlo a vivere bene l’ultimo atto della sua esistenza. In passato si moriva a casa, circondati dalle persone care, sostenuti dai simboli e dai conforti della propria fede, mentre oggi sempre più spesso si muore in ospedale, assistiti, ma isolati e spesso “abbandonati”. Alla naturale repulsione verso la realtà della morte, si aggiunge perciò una particolare difficoltà nell’accettare l’idea della propria morte e a integrare nel proprio progetto di vita l’esperienza del morire, preludio al momento della morte.
Prima di affrontare le questioni etiche emergenti nella situazione terminale della vita, vorrei ulteriormente richiamare la differenza tra malati inguaribile e malato terminale.
• Il malato inguaribile è il malato affetto da una malattia che non può essere guarita (es. AIDS), ma che spesso può essere ancora suscettibile di interventi terapeutici i quali ne possono modificare e rallentare, anche notevolmente, il decorso.
• Il malato terminale è un malato ormai prossimo alla morte, nel quale gli interventi terapeutici specifici non possono più modificare l’andamento della patologia e lo scivolamento verso la morte e nel quale sono utili solo le cure minimali e le cure palliative. Questo stato può prolungarsi per settimane o mesi.
Il malato terminale è una persona che sta vivendo un’esperienza esistenziale dolorosa e sgomentante, che dipende ormai del tutto, come un bambino, da coloro che lo assistono, che presenta non di rado gli aspetti della decadenza fisica e psichica e che, in preda all’angoscia e al dolore, talvolta “sembra” aver perso ogni dignità. La vita umana conserva il suo altissimo valore anche se la sua qualità è scarsa e sempre si devono riconoscere alla persona i suoi inalienabili e fondamentali diritti.

Possiamo elencarne alcuni di questi diritti che costituiscono il nucleo non tanto del diritto a morire ma piuttosto a morire con dignità cioè in modo degno dell’uomo:
• diritto a non soffrire quando il dolore può essere attenuato;
• diritto alle cure ordinarie e sintomatiche;
• diritto alla verità;
• diritto alla libertà di coscienza;
• diritto all’autonomia;
• diritto al dialogo confidente;
• diritto a non essere abbandonato
• diritto alla comprensione.

La terapia del dolore
• Nel malato terminale, per definizione, le cure specifiche sono ormai inefficaci, ma egli ha diritto alle cure ordinarie quali idratazione, alimentazione, detersione delle ferite … (è già qui sorgono dei problemi sulla definizione di “ordinarietà”!) e alle cure palliative e sintomatiche, quelle cure, cioè, che non eliminano la causa dei sintomi ma semplicemente ne attenuano la violenza coprendoli come di un pietoso mantello (pallium).
• Fra le cure palliative un ruolo cardinale è svolto dalla terapia del dolore. Il dolore, nella sua multidimensionalità fisica e psichica, costituisce una ferita profonda all’integrità della persona, pervade tutta la sua vita, la soggioga, la getta nell’ansia e nello scoraggiamento, la può portare a desiderare la morte come unica via di fuga da una situazione insostenibile.
• È chiaro che un credente può significare e trasfigurare questa sofferenza in unione con le sofferenze di Cristo (Salvifici Doloris) ma è altrettanto chiaro che l’accoglienza di tale sofferenza non può essere mai imposta e che esiste, anzi, un preciso dovere di carità che ci obbliga ad offrire ai malati, per quanto possibile, adeguato sollievo al dolore (CCC 2279 qualifica le cure palliative come di una forma eccellente di carità disinteressata).

• Le terapie analgesiche favorendo un decorso meno drammatico, concorrono all’umanizzazione e all’accettazione del morire. Spesso infatti dietro la richiesta di eutanasia da parte di alcuni malati terminali non c’è l’intenzione diretta alla morte, ma l’intensità di una sofferenza che ha raggiunto livelli non più tollerabili: in questo senso un’appropriata terapia del dolore dev’essere uno dei cardini di un’assistenza centrata sulla persona.
• L’uso degli analgesici è lecito anche se ne derivassero torpore o minore lucidità nel malato, tuttavia bisognerebbe evitare di privarlo totalmente della sua coscienza, se non per gravi ragioni, quali potrebbero essere dolori violenti e insopportabili e in ogni caso dopo avergli dato la possibilità di soddisfare – se lo vuole – i suoi doveri morali, familiari e di giustizia. Il malato infatti ha diritto a vivere la propria morte con dignità e libertà e a prepararsi ad essa dal punto di vista umano e spirituale.

• Un tempo l’impiego di analgesici molto potenti e poco maneggevoli poteva avere come effetto secondario l’affrettarsi della morte. Oggi noi affermiamo la liceità dell’uso degli analgesici che allevino la sofferenza fisica, anche se si prevede che questo possa portare più rapidamente alla morte, (attenzione alle condizioni) * se l’unico scopo dell’intervento è lenire il dolore, * se la morte non è ricercata né voluta in nessun modo, * se il dolore è di violenza tale da giustificare il rischio. È un’applicazione classica del principio dell’atto a duplice effetto. È bene sottolineare anche che gli enormi progressi delle terapie antalgiche rendono, oggi, questo rischio molto più gestibile.
• Né dal punto di vista medico, né da quello morale esistono, quindi, impedimenti insormontabili ad un uso corretto e generoso dei farmaci analgesici. Tuttavia esistono ancora oggi molte incomprensioni ed ignoranza nei confronti della terapia del dolore (analgesici oppiacei): al punto che in Italia la prescrizione di tali farmaci resta ancora al di sotto della media europea.

L’accanimento (ostinazione/futilità) e l’abbandono terapeutico
• Accanimento terapeutico (futility / ostinazione) e abbandono terapeutico sono due facce di uno stesso atteggiamento della medicina e della società in generale nei confronti del malato inguaribile o terminale. * Il rifiuto dell’idea della morte (“dottore lei deve fare l’impossibile per salvarlo”), * la spersonalizzazione dell’assistenza sanitaria (ritmi, tempi, mansioni molto veloci), * la fiducia illimitata nel mezzo tecnico, possono portare ad un dispiego eccessivo, ostinato ed inutile di presidi terapeutici finché l’ineluttabile approssimarsi della morte, la ridotta qualità di vita residua o la crescita dei costi non spingono ad abbandonare il malato al suo destino, configurando talora una forma di eutanasia passiva.
• Lo sforzo che tutti siamo chiamati a fare è quello di elaborare un principio di adeguatezza terapeutica che ci permetta di distinguere con sufficiente certezza, almeno nella maggioranza dei casi, il limite tra * una doverosa insistenza terapeutica e una * dannosa ed inutile ostinazione .
• Una prima distinzione che possiamo fare è quella tra mezzi terapeutici ordinari e straordinari o fra mezzi proporzionati e sproporzionati. Ovviamente per dare una valutazione di ordinarietà o straordinarietà si deve tener conto della situazione concreta delle persone: un mezzo che può esser ordinario in un luogo, e per una certa persona, può risultare straordinario per un'altra persona, perché, per esempio, un mezzo è disponibile in un luogo, ma non è disponibile in un altro o una persona percepisce un mezzo troppo gravoso, mentre un’altra lo sopporta più agevolmente.

• La nozione di proporzione riguarda prima di tutto un giudizio medico oggettivo sul rapporto tra il mezzo impiegato e gli effetti positivi in termini di salute e qualità della vita che esso produce. Un mezzo molto impegnativo che ottiene, nel caso specifico, minimi miglioramenti o che addirittura si rivela inefficace è un mezzo oggettivamente sproporzionato. In linea di principio un mezzo proporzionato è da ritenersi un mezzo ordinario, cioè di un impiego ragionevole e, quindi, obbligatorio, a meno che non intervengano situazioni particolari che lo rendano di impiego difficoltoso o rischioso o addirittura impraticabile per quel paziente.
• Il CCC 2278 insegna che “può essere legittima la sospensione di mezzi terapeutici gravosi, rischiosi, straordinari o tali che non sono proporzionati con gli effetti ottenuti”.
• Da qui possiamo dare una definizione di accanimento terapeutico, in cui l’espressione accanimento aggiunge alla inutilità l’idea di una ostinazione perversa. Si può infatti definire l’accanimento terapeutico come l’insistenza nel ricorso a presidi medico-chirurgici che non modificano in modo significativo il decorso naturale ed irreversibile della malattia, non migliorando le condizioni del malato, ma addirittura peggiorandone la qualità di vita o prolungandone, senza speranza di miglioramento, l’esistenza penosa.
• Gli elementi chiave in questa definizione complessa sono: l’insistenza, l’inutilità, e la gravosità. La parola accanimento sottolinea, accanto alla sproporzione fra impegno medico-assistenziale e benefici, la gravosità inutile e quasi crudele degli interventi praticati, facendo pensare ad una forma gratuita di aggressività del medico nei confronti del paziente.

• Rifiutare l’accanimento diventa a questo punto non solo legittimo, ma anzi doveroso, come segno di autentica responsabilità e rispetto verso la persona umana.
• Rifiutare l’accanimento terapeutico non significa, pertanto, abbandonare il malato, ma significa rifiutare di prolungare inutilmente l’agonia o di tormentare con atti medici che non incidono significativamente sulla qualità della sua vita. Ognuno ha diritto a morire con dignità, a vivere la propria morte in modo umano, senza trasformare la propria fine in un artificio tecnico disumanizzante o in un inutile dispiegamento di mezzi eroici. C’è una fase della malattia nella quale, per esempio, insistere con estenuanti e ormai inutili terapie antiblastiche, gravate da pesantissimi effetti collaterali, o sottoporre il paziente ad esami clinici indaginosi o ad interventi chirurgici che servono solo a rendere più dolorosi gli ultimi giorni di vita.
• Chi rifiuta l’accanimento terapeutico non facilita né affretta la morte della persona, ma semplicemente accetta i limiti della vita umana. Obbligo morale del medico è quello di conservare la salute e la vita, non quello di prolungare l’agonia o di infliggere sofferenze causate dalle stesse terapie e non dalla malattia.
• Una medicina umana deve saper tenere per mano chi se ne va, accettando di curare senza guarire e coprendo con un pallium, un mantello misericordioso la devastazione del male e della paura e ricordando che quando tecnicamente “non c’è più niente da fare”, umanamente c’è spesso ancora molto che si può fare .

Eutanasia
• L’eutanasia, intendendo con questo termine la morte cercata o data per evitare un qualche dolore, ha una lunga storia ed una diffusione ubiquitaria nelle diverse culture umane (cfr. l’esposizione dei bimbi handicappati presso gli spartani o presso la rupe tarpea dei romani).
• La parola eu-tanasia in greco significa bella morte (e fa pendant ideologicamente con la eu-genetica).
Attualmente con il termine eutanasia si intende ogni azione od omissione compiuta per sopprimere la vita di un malato inguaribile o terminale, di un anziano, di un soggetto malformato o portatore di handicap (eugenetica) al fine di evitargli sofferenze fisiche o psichiche.
Nell’eutanasia del malato terminale o inguaribile si cerca di fuggire la durezza del morire o di una malattia dolorosa, negli altri casi (anziani, handicappati) si cerca di fuggire una vita divenuta ormai insopportabile o non desiderabile.
Qualunque sia il motivo, opera nell’eutanasia la volontà di dare o di darsi la morte: essa è, quindi, una forma di omicidio o di suicidio. Si parla anche di omicidi pietosi, invocando per giustificazione la pietà e lo spirito di umanità (“Non potevo più vederlo in quello stato”), ma molte volte quelli che non riescono più a sopportare la situazione creata dalla malattia, dalla menomazione, dalla vecchiaia sono i familiari e il personale sanitario.
• La parola eutanasia dovrebbe indicare una morte cercata per fuggire il dolore (l’accento è posto sullo scopo), ma sta diventando una morte data con dolcezza, senza che l’ucciso se ne avveda o ne soffre, una morte dolce (l’accento è posto sui mezzi/modi).

Alcune distinzioni terminologiche per capirci e non fare di tutta un’erba un fascio.
• La prima distinzione è quella che riguarda l’intenzione dell’agente per cui si può distinguere fra eutanasia diretta e indiretta, così come si distingue tra suicidio diretto e indiretto, fra aborto diretto e indiretto, fra sterilizzazione diretta e indiretta.
• Di fatto con la parola eutanasia ci si riferisce di solito alla sola eutanasia diretta intendendo con questo termine qualsiasi intervento (commissivo, es. somministrazione di veleno, od omissivo, es. non esecuzione di un intervento chirurgico) che in sé o nell’intenzione che lo dirige tende ad accelerare o procurare la morte. Si tratta di eutanasia in senso stretto, nella quale si vuole la morte o comunque si contribuisce immediatamente a procurarla.
• Si parla invece di eutanasia indiretta in riferimento ad ogni atto che può affrettare o procurare la morte di un malato, ma senza che questo sia voluto direttamente dall’agente: manca quindi una intenzione direttamente ed esplicitamente uccisiva. L’accelerazione della morte può essere la conseguenza o effetto collaterale non voluto, anche se previsto, di un atto medico, quando ci sia proporzione ragionevole tra beneficio prodotto e danno arrecato (principio dell’atto a duplice effetto: es. in una terapia analgesica molto aggressiva che aggrava la già precaria situazione respiratoria o cardiaca di un malato terminale). Per evitare confusioni una simile eutanasia indiretta di solito si evita di chiamarla con la parola eutanasia.

• Riguardo ai mezzi con cui si ottiene l’eutanasia si parla di eutanasia attiva o commissiva, se la morte avviene in seguito ad un atto, come la somministrazione di dosi letali di un antiaritmico, e di eutanasia passiva o omissiva, se la morte avviene per l’omissione di un atto o intervento essenziali, come la somministrazione di cibo.
• Dal punto di vista etico, se esiste una volontà eutanasica diretta, non fa ovviamente molta differenza uccidere una persona in un modo o in un altro. Bisogna, però stare attenti che non ogni astensione da una certa terapia o cura è eutanasica. A volte l’astensione da una certa terapia non è mossa da intenzione eutanasica, ma è invece una legittima e talora doverosa astensione dal ricorso a terapie non adeguate: questa non può dirsi eutanasia ma è piuttosto una saggia rinuncia a terapie sproporzionate o addirittura all’accanimento terapeutico.

Mentalità eutanasica e testamento biologico
• Abbiamo assistito in questi ultimi decenni allo sviluppo di movimenti di opinione a favore dell’eutanasia sull’onda di casi clamorosi (Terry Schiavo per es.) enfatizzati dai media per i quali tutto diventa gesto pietoso e in qualche modo giustificabile.
• La cultura secolarizzata, che esalta gli aspetti edonistici ed utilitaristici dell’esistenza, ha diffuso un senso crescente di angoscia per il dolore e la morte e una ripulsa per le espressioni fragili e decadenti dell’esistenza. Eminenti scienziati fra i quali il premio nobel J. Monod, Paulin, Thompson, firmarono nel luglio del 1974 un Manifesto sull’eutanasia nel quale si affermava che “è immorale la tolleranza, l’accettazione o l’imposizione ad altri di sofferenza inutile” nell’idea che impedire ad una persona sofferente di togliersi la vita equivale ad imporgli la sofferenza, facendo così dell’eutanasia non solo un diritto, ma addirittura un dovere morale.
• Per molti ormai il concetto di eutanasia coincide infatti, con quello di dignità della morte, o con quello di una umanizzazione del dolore e della morte.

• L’ideologia della qualità della vita, basata su criteri prestazionali ed efficientistici, sta favorendo la pratica del Living will o Testamento biologico.
• Con questo “testamento” una persona chiede ai familiari e al personale sanitario che qualora venga a trovarsi in uno stato di grave sofferenza o di condizioni di vita qualitativamente scadute e non possa disporre di sé, siano sospese le terapie specifiche e persino le terapie e le cure di sostentamento vitale.
• Si parla, più propriamente, di direttive anticipate o, meglio, di dichiarazioni anticipate di trattamento: il termine “direttive” sta a significare una obbligatorietà nell’applicazione delle indicazioni date previamente dal malato, mente il termine “dichiarazioni anticipate” lascia aperta la porta ad una decisione clinica che, pur tenendo conto delle volontà precedentemente espresse dal malato, le attualizza nel contesto reale in cui la persona non più competente si trova ad essere. Una forma di testamento biologico prevede che, oltre ad indicazioni sulle proprie preferenze, la persona indichi un soggetto fiduciario che, in caso di sua impossibilità a decidere autonomamente, sia autorizzata a intervenire nel processo decisionale insieme ai medici.

• In linea di principio un documento del genere non è illecito, perché un soggetto ha diritto di essere il protagonista delle scelte cliniche che lo interessano e i suoi legittimi desideri devono essere vincolanti per l’operato dei medici.
• Il profondo scarto in medicina tra tecnologia e umanizzazione insinua sempre più nell’opinione pubblica il timore, non sempre infondato, dell’accanimento terapeutico e quindi di una sopravvivenza assurda e indegna della persona, permessa dagli artifici di una scienza spesso prometeica che non si arresta neppure sulla soglia della morte.
• Il fatto è che l’esperienza di quei paesi che hanno legalizzato le DAT, come l’Olanda e la Francia, ammettono il diritto non solo di sospendere terapie sproporzionate, ma anche di sospendere alimentazione e idratazione, scivolando ( ) de facto in forme di eutanasia passiva, anche se viene ufficialmente negata la natura eutanasica di queste pratiche: lo sfondo ideologico è quello della piena disponibilità della vita sino alla sua autodistruzione.

L’eutanasia, sia nella forma dell’abbandono o astensione terapeutica, quando la terapia avrebbe ancora ragione d’essere praticata, sia nella forma della soppressione attiva tanto di consenziente o richiedente quanto dell’incapace di esprimere una deliberazione, è soltanto un altro volto dell’accanimento, è l’estremo approdo dell’hybris umana che cerca di impadronirsi della vita e quando questa sfugge, nonostante tutto, al suo controllo, cerca allora “di impadronirsi della morte, procurandola in anticipo”. Il dramma del dolore e della malattia meritano umano rispetto e profonda compassione, ma non può trasformare la morte in un diritto e peggio ancora in un’espressione di libertà.
Top Related