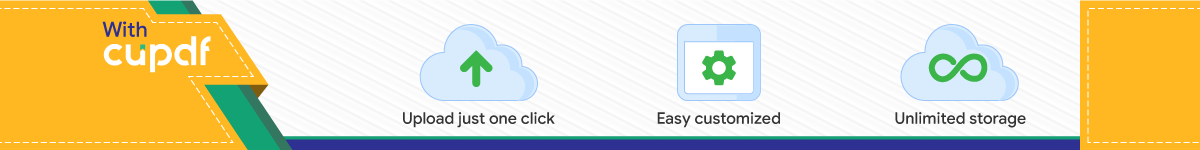
La Rassegna d’Ischia 5/1996 5
Allosaurus fragilis (scheletro di dinosauro carnivoro). Provenienza: Stati Uniti d’America. Età: Giurassico sup., Titonico (da 139 a 135 milio-
ni di anni fa). Lo scheletro di Allosaurus fragilis in possesso dell’Università di Napoli Federico II è stato ritrovato
negli Stati Uniti d’America nell’estate del 1993.
II Museo di Paleontologiadell’Università di Napoli
L’11 giugno 1996 è stato presentato il nuovo allestimento
Un dinosauro per la città
di Carmine Negro
Lunedì 11 giugno 1996, alla pre-senza delle autorità cittadine e accademiche, è stato presentato il nuovo allestimento del Museo di Paleontologia appartenente al Centro Musei delle Scienze Naturali istituito dall’Università degli Studi di Napoli Federico IL Le raccolte del Centro Mu-sei delle Scienze Naturali, nato per aggregazione degli storici Musei di Mineralogia, Zoologia, Antropologia e Paleontologia, erano state accumulate nel cor-so degli anni senza logica espo-sitiva, in quanto non destinati a essere mostrati al pubblico ma a fungere da materiale da con-sultazione per gli studiosi spe-cializzati. Con l’istituzione del Centro, l’Università ha voluto rivalutare le antiche collezioni, non riservarle a pochi speciali-sti eruditi ma aprirle all’interes-se degli scienziati e alla curiosità dei visitatori comuni. Per rag-giungere questo obiettivo è sta-to necessario un lungo lavoro di preparazione, che ha richiesto il consolidamento strutturale e il restauro di antichi saloni il cui interesse architettonico non è inferiore al valore degli esem-plari in essi accumulati. Per il nuovo allestimento del Museo di Paleontologia si è do-vuto
6 La Rassegna d’Ischia 5/1996
procedere al recupero del com-plesso e al restauro del pavi-mento dell’ex Monastero di San Marcellino, sede del Museo, ad una nuova disposizione degli oltre cinquantamila reperti che rappresentano i maggiori rag-gruppamenti animali e vegetali
- i più antichi risalenti a seicen-to milioni di anni fa - e all’espo-sizione del nuovo ospite, l’unico esemplare di dinosauro esposto in Italia centro-meridionale, il più completo presente attual-mente nel nostro paese : l’Allo-saurus fragilis.
Il Complesso di San Marcellino e l’intervento di recupero
Il Museo di Paleontologia, annes-so agli Istituti di Geologia, Paleon-tologia, Geografia e Fisica terrestre dell’Università, è situato in uno dei locali di quell’edificio religioso che era il convento dei SS. Marcellino e Festo (1). Questo edificio risale al secolo XVI, quando le nuove rego-le del Concilio di Trento imposero la fusione di due antichissimi mo-nasteri, entrambi risalenti all’VIII secolo, dei SS. Marcellino e Pietro e dei SS. Festo e Desiderio. La tra-dizione vuole che il convento delle monache di S. Marcellino, di rito basiliano, sia stato fondato nel 795 da Teodonanda, vedova di Antimo console e duca, utilizzando una parte dello stesso Palazzo Ducale che sorgeva in questa area, cuore della città medioevale. Il Praeto-rium Civitatis, palazzo dimora dei consoli e dei duchi, sede del gover-no e del tribunale, che, secondo al-cune fonti e purtroppo assai scarsi ritrovamenti archeologici, doveva sorgere sulla collina del Monte-rone, nell’area gravitante intorno all’attuale via Paladino. Più antica, ma di poco, risalente probabilmente alla metà del secolo Vili, la fondazione dell’altro mona-stero, quello dei SS. Festo e Desi-derio, ad opera di Stefano II, duca dal 755 al 766 e vescovo di Napoli dal 767 (2). Basiliano in origine, il monastero aderì nel X secolo alla regola benedettina. Come risulta da numerosi documenti d’archivio, tra i due monasteri contigui non correvano buoni rapporti. Le mo-nache di S. Marcellino, più ricche e potenti, fin dalla metà del Quat-
trocento, avevano tentato di an-nettersi l’attiguo convento che, per questo, era stato costretto a pagare il prezzo della propria indipenden-za con la cessione di parte del suo giardino, utilizzato per l’amplia-mento del monastero vicino. In seguito alle direttive del Concilio di Trento sulla riforma degli ordi-ni religiosi e dei conventi, il cardi-nale Antonio Carafa, arcivescovo di Napoli nel 1564, prescrisse l’u-nione al convento di S. Marcellino di quello di S. Festo, malgrado le violente e prolungate proteste del-le suore di quest’ultimo. L’osser-vanza delle regole della clausura, imposte dal Concilio tridentino, richiese la radicale trasformazione degli edifici ed, in particolare, del chiostro e del dormitorio. I lavori, che si protrassero dal 1567 al 1595, furono affidati a Giovan Vincenzo della Monica di Cava dei Tirreni. Terminati i lavori si decise di rifare anche la Chiesa, che sarà realizzata da Pietro d’Apuzzo, probabilmente su disegno di Giovan Giacomo di Conforto, e che subirà nel ‘700 un restauro ad opera del Vanvitelli. Il Chiostro si presenta con una in-solita caratteristica : esso è aperto su di un lato per consentire la vista del panorama; in quella direzione, infatti, era possibile, all’epoca, la vista del mare. In funzione del pa-norama appare studiata la disposi-zione di tutto l’edificio conventua-le, come testimoniano i piani alti che sovrastano il porticato: il primo con l’ampio terrazzo balaustrato; il secondo con la balconata continua. Lo sviluppo delle terrazze, sempre
più arretrate nei piani soprastanti il porticato, accentua nell’edificio il carattere di vasto belvedere, assi-cura ad ogni cella l’apertura verso lo splendido panorama del Golfo, la cui naturale bellezza era accre-sciuta dal verde del giardino posto al centro del chiostro e, con la rico-struzione della Chiesa, dalla cupo-la maiolicata ornata, negli spicchi scanditi dai costoloni, da un motivo geometrico a rombi, dalla raffinata bicromia giallo-nero. L’esigenza di conservare la veduta del mare an-che dal livello del chiostro, oltre che dalle terrazze digradanti superiori, fu rispettata dallo stesso Vanvitelli quando intervenne sull’edificio per realizzare una delle sue ultime ope-re: il piccolo oratorio della Scala Santa. Disposto a livello inferiore rispetto al grande spazio claustrale, il chiostrino, inglobato agli inizi del secolo negli edifici della Università, appare oggi come un piccolo cor-tile chiuso, visibile solo affaccian-dosi dal terrazzo in cui il chiostro superiore si prolunga. Il monaste-ro fu soppresso nel 1808, con un decreto di Giuseppe Bonaparte, e il complesso fu prima ceduto alla Real Casa Carolina (1809) e poi alle suore della Visitazione (1810). Nel 1829 divenne sede di un Edu-candato femminile, conservando questa destinazione anche dopo la fine del regno borbonico. Nel 1907 l’edificio fu assegnato all’Universi-tà degli Studi di Napoli e nel 1912, dopo la esecuzione dei lavori di adattamento, si insediarono i vari istituti. Il Museo di Paleontologia è situa-to nei locali attigui alla chiesa dove nel 1738 ebbero inizio i lavori per la realizzazione del nuovo comunichi-no successivamente abbellito con marmi, grate “a giarrette” in ferro e ottone e con cornici dorate. Tra i locali degno di nota c’è la sala del coro. Secondo la descrizione redat-ta nel 1742 in occasione della Sacra visita che doveva fare il cardinale Spinelli, aveva ai lati “sedili con spalliere di legname” ed era coper-ta con volta affrescata con “effigie di Santi”. Successivamente, proba-bilmente nel 1810, il comunichino e il salone attiguo furono trasformati
La Rassegna d’Ischia 5/1996 7
in teatro secondo quanto attesta il Ceci in “Napoli Nobilissima”. Nel 1740 Giuseppe Massa ebbe il paga-mento per il “pavimento di riggiole impetenate e dipinte con fogliami, ornati e paesaggi ..poste nelle sale del comunichino...” e “ ... nella stan-za del grande capitolo”. “Il restau-ro dei pavimenti maiolicati della Sala Capitolare, del Comunichino, e dell’ex-teatrino nel Convento di San Marcellino, scrive Luciana Ar-bace, ha consentito il recupero di tre opere di straordinario pregio, che interventi precedenti avevano completamente stravolto, mutilan-do i disegni originali o addirittura modificando completamente il pri-mitivo tessuto ornamentale”. Il restauro del Museo di Paleonto-logia non è ancora concluso; sono in programma la sistemazione delle altre due sale poste a ridosso di quelle oggi ultimate. I progetti dell’Università verso il complesso di S. Marcellino prevedono altri interventi quali il completamento della sistemazione del giardino, del porticato del chiostro e soprattutto il restauro della chiesa.
Le raccolte del Museo
La Paleontologia (dal greco “di-scorso sugli antichi esseri viven-ti”) è la scienza che si occupa dei fossili, e cioè dei resti degli orga-nismi animali e vegetali vissuti nelle epoche geologiche passate e che sono giunti fino a noi con-servati nelle rocce. Essa ha lo scopo di ricostruire, attraverso lo studio dei fossili, gli organi-smi che vissero sulla Terra, le loro trasformazioni nel tempo, il loro modo di vita, le loro reci-proche relazioni, nonché i cam-biamenti geografici e biologici. Raramente un organismo si conserva integro come fossile : ciò è accaduto per insetti, foglie e pollini rimasti inclusi nell’am-bra, una resina emessa da anti-che conifere e dotata di azione
antibatterica che ha impedito la corruzione delle sostanze or-ganiche. In generale lasciano resti fossili gli organismi dotati di porzioni del corpo dure e re-sistenti : il legno dei vegetali, le costruzioni coralline, le conchi-glie dei molluschi, le ossa dei vertebrati, le corazze chitinose di insetti e crostacei. Sono con-siderati fossili, anche, impronte, tracce di camminamenti, cavità nelle roccia riconducibili a tane o escavazioni di organismi per-foranti, uova o escrementi di or-ganismi scomparsi. L’esposizione museale, dopo aver preso in considerazione reperti di vegetali molto primi-tivi, Cianoficee ed altri gruppi di alghe, si sviluppa con i resti dei principali gruppi animali e vegetali che hanno popolato il nostro pianeta. Tra gli organi-smi fossili più caratteristici si possono osservare Ammoniti (molluschi, cefalopodi), Trilo-biti (artropodi) e Foraminife-ri (protozoi). Provengono da tre giacimenti ittiolitiferi della Campania le collezioni dei pesci fossili. Sono presenti con circa
Comunichino, metà del secolo XVIII - Marmi connessi, ferro e ottone - Sala dei rettili estinti
100 esemplari i pesci del Trias-sico medio risalenti a circa 210 milioni di anni fa e trovati a Gif-foni Vallepiana in provincia di Salerno. Ci sono poi i pesci fos-sili di età cretacica, di circa 115 milioni di anni fa, trovati a Capo d’Orlando tra le città di Castel-lammare e Vico Equense. Ed infine, sempre di età cre-tacica e quindi risalenti a 115 milioni di anni fa i pesci fossili provenienti dalla località fossi-lifera di Pietraroia in provincia di Benevento. Tra le curiosità un cranio di Elephas antiquus italicus trovato nel giacimento di Pignataro Interamna nella valle del Liri (FR) che raggiunse durante il Pleistocene una gran-de diffusione in tutte le vallate dell’Appennino. I Dinosauri: l’Allosaurus fragilis
L’era secondaria o Mesozoico iniziata circa 230 milioni di anni fa e durata 165 milioni di anni vede il predominio sulla Ter-ra dei grandi rettili. Nel corso del Mesozoico le diverse masse
8 La Rassegna d’Ischia 5/1996
continentali, derivate dell’unica terra emersa, la Pangea, si an-davano allontanando tra loro con rari fenomeni di collisioni tra placche. La frammentazione dei supercontinenti e la disloca-zione definitiva in diverse regio-ni della superficie terrestre, crea una estrema varietà di situazio-ni ambientali che favorisce la
Giuseppe Massa, 1739-40Pavimento maiolicato dell’ex Capitolo (particolari dei medaglioni raffigu-ranti un paesaggio marino e un paesaggio montuoso)
diversificazione degli organismi viventi. Prosperano i pesci osseie i molluschi (tra i quali le am-moniti), ma soprattutto la dif-fusione del gruppo di rettili Diapsidi, caratterizzati dalla presenza di due fosse nella pa-rete laterale del cranio. I Diapsi-di ben presto raggiunsero un tale grado di diversificazione da
riuscire ad adattarsi a tutti gli ambienti: nei cieli volavano gli pterosauri, nelle acque nuota-vano i coccodrilli e gli ittiosauri e sulle terre emerse regnavano incontrastati i rettili Saurischi ed Omitischi, noti a tutti con il nome di dinosauri. Un esame approfondito dei dati paleonto-logici suggerisce che i dinosauri del Mesozoico erano più atti-vi di quanto si fosse sospettato e che probabilmente avevano un’organizzazione sociale para-gonabile a quella degli attuali coccodrilli e degli uccelli. Ana-tomicamente i dinosauri erano caratterizzati da una disposi-zione delle ossa del bacino e dei femori rivoluzionari per l’epoca. Questa caratteristica fornì ai dinosauri la capacità di cam-minare sollevati da terra, ritti sugli arti posteriori, bilancian-dosi con la testa e possibilmente con la coda. La tendenza al bi-pedismo risultò vantaggiosa e consentì di invadere nuovi am-bienti. Tra i dinosauri carnivori i più grandi furono i Camosauri. Il loro cranio era alleggerito da due grandi cavità ed era munito di una robusta dentatura; gli arti anteriori erano corti e talvolta molto ridotti mentre quelli po-steriori erano robusti, ed adatti alla corsa. I Camosauri erano diffusi nell’America del Nord, in Asia e forse in Africa. Nel Giu-rassico superiore i Camosauri erano rappresentati in America settentrionale dal genere Allo-saurus, che poteva raggiungere i 12 metri di lunghezza. Gli Allo-sauri avevano le orbite disposte in modo da consentire agli occhi una visione quasi binoculare, si-mile a quella degli attuali mam-miferi predatori. Da impronte rinvenute nelle rocce del Meso-zoico si può dedurre che gli Al-losauri conducevano vita socia-le cacciando in branchi. I denti grandi e seghettati dovevano
La Rassegna d’Ischia 5/1996 9
conferire al loro morso capaci-tà di taglio notevole. Le zampe anteriori portano tre dita e sono più sviluppate di quelle dei fa-mosi Tirannosauri. Lo scheletro di Allosaurus fra-gilis in possesso dell’Università di Napoli Federico II, è stato ritrovato negli Stati Uniti d’A-merica, al confine tra lo sta-to del Wyoming e dello Utah, nell’estate del 1993. Esso ha una lunghezza di 8,5 metri, un’altez-za di 3,4 metri ed un peso com-
plessivo di circa 600 Kg. In otti-me condizioni di conservazione delle ossa, rappresenta l’unico esemplare di dinosauro esposto nell’Italia centro-meridionale e il più completo attualmente presente nel nostro Paese. La preparazione dello scheletro ha richiesto circa 6000 ore di lavo-ro. L’esemplare è sospeso su tre serie di cavi d’acciaio per non danneggiare il pavimento ma-iolicato del settecento presente nella sala e porta montato un
calco del cranio originale, siste-mato, quest’ultimo in una ba-checa separata.
Carmine Negro (1) “Napoli, città d’arte”, Electa (1986)(2) “Napoli sacra” (1994) Elio De Rosa Editore pag. 350(3) “Il Museo di Paleontologia dell’Università di Napoli”, Elec-ta (1996)
La Rassegna d’Ischia 5/1996 11
Giotto a Napoli di Mario Mirenghi
È noto che le ultime grandi opere di pittura compiute da Giotto a Napoli, nella Basilica di S. Chiara e nella Cappella Palatina in Castelnuovo, sono purtroppo scomparse. Della dimora di Giotto nella nostra città, dove venne a ses-santa anni, invitato da re Roberto d’Angiò, e soprattutto degli ultimi avanzi di pittura nella Cappella Palatina Angio-ina, dopo gli ultimi ritrovamenti, si occupa con la compe-tenza e diligenza che tutti gli riconoscono in Italia il conte Riccardo Filangieri, Soprintendente del nostro Archivio di Stato. Dopo aver riassunto le fonti, il Filangieri dice che dei due grandi cicli di pitture eseguite da Giotto a Napoli è molto probabile che quello di S. Chiara fosse stato iniziato pri-ma di quello di Castelnuovo. Difatti mentre Giotto era già a Napoli il 1° dicembre 1328, non prima del 13 febbraio 1339 il Re ordinò le pitture della Cappella Palatina e il compi-mento di quelle della “Cappella segreta” e non prima del 5 agosto successivo fu fatto il primo pagamento per tali opere. Le pitture di S. Chiara, secondo il Vasari, sarebbero state il movente della chiamata di Giotto a Napoli. Se non è da escludere che in queste pitture fossero state rappresentate scene dell’Apocalisse, è favola certamente che Dante ne ab-bia personalmente ispirata la concezione. Non già lui, già morto da vari anni, ma soltanto il divino poema potette, se mai, ispirare il pennello di Giotto. Circa l’ubicazione di questi affreschi il Filangieri è del parere di Fausto Niccolini, e cioè che essi adornassero il grandioso coro delle monache, che sorge dietro l’abside della chiesa. È quindi nel grandioso coro delle monache, dove ancora si vedono le pareti scompartite per accogliere numerose isto-rie, che Giotto compose un ampio ciclo di pitture. Nella pri-ma metà del Settecento, un ignorante reggente della Chie-sa, il Barrianovo, fece coprire vandalicamente gli stucchi e vi fece narrare da un mediocre pittore le istorie della Ver-gine. Le pitture della grande Cappella della Reggia hanno una larga documentazione. Sappiamo dal Summonte che esse rappresentavano il Vecchio ed il Nuovo Testamento. Al tempo di Ferrante d’Aragona un suo consigliere, ignorante di cose d’arte, fece coprire di nuove pitture quelle di Giotto. Le indagini fatte durante i recenti lavori di restauro della cappella hanno meglio spiegato il perché della distruzione di questi dipinti. Nel catastrofico terremoto del 4 dicembre 1450 la parte superiore del lato meridionale della cappella dovette o crol-lare o più probabilmente esser ridotta in tale stato da ren-dersene necessaria la demolizione. Certo è ch’è stata rinve-nuta la muratura delle chiavi degli archetti dei finestroni intieramente ricostruita con conci di tufo del tipo adopera-to nella ricostruzione aragonese del Castello. Nello stesso tempo i finestroni gotici originari sono stati trovati aperti nelle chiavi da larghe fenditure e tutti murati a fabbrica piena. Da ciò appare chiaro che buona parte delle pitture giottesche soggiacquero alla rovina del terremoto, mentre la muratura dei vani dei finestroni creò nelle pareti lacu-ne in mezzo ai dipinti. E non è improbabile che altri danni avesse prodotto agli affreschi qualche parziale caduta di intonaco. La decorazione della grande cappella non fu terminata da Giotto perché in un apodisario del 6 dicembre 1333 e an-cora in un ordine dato ai tesorieri il 30 luglio 1336 si parla
della pittura che ancora si stava eseguendo in quella cap-pella. All’epoca della seconda di tali date Giotto non era sicuramente a Napoli. Fra le opere di cui è notizia nel rendiconto presentato il 20 marzo 1331 da Giovanni Preposito, Castellano di Ca-stelnuovo ed amministratore delle opere che si facevano nella Reggia, vi è una cona che Giotto dipingeva nella pro-pria casa per ordine del Re. Di questo dipinto non c’è più traccia. Nello stesso rendiconto si parla anche del compi-mento della decorazione pittorica di un’altra cappella del-la Reggia, detta “Cappella segreta” egualmente affidata a Giotto, che di tutte queste opere è detto “Prothomagister^. Questa cappella non esiste più, essendo andata distrutta nella totale trasformazione del Castello attuata da Alfon-so d’Aragona verso la metà del quindicesimo secolo. Essa
“... Roberto, re di Napoli, scrisse a Carlo re di Calabria suo primogenito, il quale si trovava in Firenze, che per ogni modo gli mandasse Giot-to a Napoli (alla fine del 1326 o nel principio del seguente anno, ndr), perlocché, avendo finito di fabbricare Santa Chiara, monasterio di donne e chiesa reale, voleva che da lui fusse di nobile pit-tura adornata. Giotto, dunque, sentendosi da un re tanto lodato e famoso chiamare, andò più che volentieri a servirlo; e giunto, dipinse in alcune cappelle del detto monasterio molte storie del vec-chio testamento e nuovo(l). E le storie dell’Apoca-lisse, che fece in una di dette cappelle, furono (per quanto si dice) invenzione di Dante; come per avventura furono anco quelle tanto lodate dell’A-scesi; e sebbene Dante in questo tempo era morto, potevano averne avuto, come spesso avviene fra gli amici, ragionamento. Per tornare a Napoli, fece Giotto nel castello dell’ Uovo molte opere e particolarmente la cappella che molto piacque a quel re, dal quale fu tanto amato che Giotto mol-te volte, lavorando, si trovò essere trattenuto da esso re che si pigliava piacere di vederlo lavorare e di udire i suoi ragionamenti.(...) Essendo, dunque al re molto grato, gli fece in una sala che il re Alfonso I rovinò per fare il ca-stello, e così nell’Incoronata (2) buon numero di pitture”.
1 Le pitture di Giotto in S. Chiara furono nei primi anni del secolo scorso ricoperte di stucchi.2 Le pitture dell’Incoronata, che tuttora esistono, non possono essere di Giotto, perché tra le altre cose è in esse rappresentato lo sposalizio di Gio-vanna I con lodovico di Taranto, che accadde nel 1347, cioè dieci anni dopo la morte di Giotto.
(da Le Vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti di Giorgio Vasari, scelte e annotate da Gaetano Milane-si, Firenze 1880).
12 La Rassegna d’Ischia 5/1996
stava accanto all’appartamento reale e non è da confondersi né con la cappel-la di S. Martino, né con la cappella del parco. L’altra opera importante del Maestro in Castelnuovo fu la decorazione della grande sala angioina. Questa sala, co-struita da Roberto accanto alla Cap-pella Palatina, sostituì nella funzione di sala maggiore del Castello l’antica sala del Tinello, trasformata poi in appartamento privato dopo l’incendio del 1317. La nuova sala doveva essere da poco terminata quando Giotto vi presentò - secondo autorevoli testimo-nianze - un ciclo eroico con immagini di illustri personaggi della mitologia e della storia. Ciò è anche confermato dal Vasari il quale dice che in uno dei nove eroi dipinti da Giotto, il Maestro avreb-be rappresentato sé stesso. L’epoca in cui la grande sala fu terminata, 1328, corrisponde con la venuta di Giotto a Napoli. Qualche scrittore afferma che Giotto avrebbe dipinto anche in Castel dell’O-vo. Nessun dipinto è ora in questo Ca-stello che possa attribuirsi a Giotto. Non è però totalmente da escludersi che, per adornare qualche sala dei reali appartamenti o di una delle due cap-pelle che vi erano, il Re si fosse servito dell’opera del grande fiorentino. Neanche c’è più traccia delle piccole tavole con immagini di santi che sareb-bero state portate dalla Regina Sancia in S. Chiara quando, morto il marito, ella abbracciò la vita religiosa. Di tutte le altre opere ora superstiti, che furono un tempo legate al nome del Maestro, nessuna purtroppo è sua. Negli affreschi dell’Incoronata, in quel-li di S. Chiara e di S. Lorenzo, la critica moderna ha dovuto necessariamen-te escludere l’opera sua. Ed i modesti avanzi della decorazione pittorica della Cappella Palatina, da poco venuti alla luce, e che pure le fonti documentali legano al suo nome, neppure possono attribuirsi alla sua mano. Un’avversa fortuna pare incombesse sulla vasta e magnifica fioritura di arte che Giotto aveva prodotto sul suolo di Napoli: ora le forze della natura, ora le trasformazioni edilizie, ora l’ignoranza degli uomini, hanno annientato ogni cosa. E così è venuto a mancare quasi per intero l’ultimo capitolo della vita artistica di Giotto. Se però le opere della sua mano sono tutte perdute, tracce dell’arte sua an-cora sopravvivono nelle pitture dei suoi seguaci, nella seconda metà del Trecento. Gli affreschi dei Sacra-menti nella chiesa dell’Incoronata, che sono i più importanti che quel
secolo ci abbia tramandato e che fu-rono un tempo attribuiti allo stesso Giotto, sono invece, come attesta il Summonte, opera dei suoi discepoli. Molto si è scritto su questi dipinti e chi vi ha riconosciuto un’arte prevalente-mente giottesca, chi ha veduta l’opera di pittori senesi e chi più esattamente vi ha riconosciuto eclettici artisti napole-tani. Similmente il grande affresco del refettorio dei monaci di S. Chiara, più giottesco nella maestosa figura centra-le del Redentore, tende invece all’arte senese nelle più dolci e serene figure di santi che gli stanno ai lati. Sempre nel-la stessa chiesa più giottesca è la Pietà della quarta cappella a destra, mentre più senese è la Madonna della terza cappella dal lato opposto. Quando furono eseguiti tutti questi di-pinti e quegli altri dello stesso periodo che ancora si veggono nelle altre chiese di Napoli, i grandi maestri non esiste-vano più, ma essi vi avevano lasciato una cospicua eredità. In un documento angioino citato dal Filangieri è scritto che Giotto, proto-mastro delle opere di pittura di Ca-stelnuovo, aveva la collaborazione di molti artisti fra i quali parecchi napole-tani. Furono questi aiuti che, partito il Maestro, mandarono a compimento la grande Cappella e la Cappella Segreta ove lavorarono almeno fino al 1336. Poco sappiamo dei discepoli napoleta-ni o collaboratori o seguaci di Giotto e degli altri grandi maestri di quel tem-po. I napoletani in genere non sentirono - dice il Filangieri - la maestosa solen-nità delle semplici composizioni di quel grande, ma si orientarono volentieri alla ridente espressione ed alla ricchez-za decorativa della pittura senese. Non riuscirono però neanche a rendere tut-ta la grazia ingenua dell’arte di Duccio e dei suoi seguaci, perché nella loro cul-tura fondamentale eclettica la contami-nazione dei tre stili e delle tre concezio-ni artistiche è quasi un fatto costante. Quest’arte, oltre che nei freschi e nelle tavole, ebbe largo riflesso nella minia-tura; vari codici, alcuni dei quali assai pregevoli, tuttora ne fanno testimo-nianza, primo fra tutti forse quello de-gli Statuti dell’Ordine del Santo Spirito della Biblioteca Nazionale di Parigi, alluminato presso la corte angioina nel 1352. Le pitture rinvenute nel 1928 nella Cappella Palatina di Castelnuovo non sono che resti importanti di una parte secondaria della sua decorazione pitto-rica, e precisamente quella delle strom-bature degli altissimi e sottili finestroni gotici.
Essendo stati questi finestroni mu-rati in seguito al terremoto del 1456, quando verso il 1470 re Ferrante fece asportare dalle pareti della cappella gli affreschi di Giotto, questi resti di pittu-re si trovavano già chiusi nella fabbrica e potettero così giungere fino a noi. Ciascuna di queste strombature è par-tita da un solco longitudinale in due fasce, oltre la sottile cornice che reg-geva le vetrate. Le fasce esterne sono decorate della solita imitazione musiva cosmatesca, quale vediamo nella cap-pella degli Scrovegni e in San Fran-cesco d’Assisi, mentre le interne sono messe a decorazione vegetale stilizzata. Soltanto nell’ampio ed unico finestrone biforo, che si apre in fondo all’abside, appare una decorazione di fogliame, ove è già un certo senso naturalistico che par quasi preludere al Rinascimen-to. La stessa decorazione troviamo, alcuni decenni più tardi, nelle pitture dell’Incoronata.
Ma l’elemento interessante di questi resti sono i medaglioni che ricorrono in ciascuna fascia delle strombature, originariamente in numero di circa dieci da ogni lato e per ciascuna fascia. Essi sono inscritti in cornici esagone oppu-re quadrilobate o polilobate con inflessioni in alcuni lobi, e vi sono rappresentate per lo più teste, ed a volte, alternativamente con quelle, armi angioine. Le teste rappresentano, alcune santi e profeti, altre con tutta pro-babilità ritratti di personaggi della Corte. Le armi sono a loro volta alternate, di Francia (di azzurro seminato di gigli d’oro) e di Gerusalemme (di argento alla croce potenziata d’o-ro).
La varietà di stile e di tecnica che si riscontra nei vari medaglioni dà la nozione precisa della molteplicità dei già documentati collaboratori di Giotto, il quale evidentemente affidava loro i compiti secondari: e dà ancora la sicurezza che essi non erano per lo più usciti dalla sua bot-tega, ma erano stati raccolti in Na-poli stessa, certamente fra i miglio-ri che in quel tempo coltivassero in questa città l’arte del pennello.
Mario Mirenghi
La Rassegna d’Ischia 5/1996 13
Rassegna Libri Premi a cura di Raffaele Castagna Ritorno da Stige di Enrico Monti
Aetas Edizioni Internazionali, Roma 1996 In copertina illustrazione di Maria Pia Perrella
“Sembrava.... che la tanto attesa liberazione non poteva ormai più tardare”; eppure si faceva strada “il dubbio che le ore pia brutte sta-vano per scoccare per noi: erano le ore dell’imminente disfatta dei nostri padroni, che avevano tutto l’interesse, per sotterrare colpe na-scoste, ma non tanto, a sbarazzar-si di incomodi testimoni, quali noi potevamo essere”. Intorno a queste due sensazioni si svolge la narrazione di Enrico Monti in questo suo nuovo lavoro, Ritorno da Stige, dove Stige (nella mitologia fiume infernale, imma-ginato come un paludoso ramo dell’Oceano circondante coi suoi meandri l’intero oltretomba) rap-presenta la condizione esistenziale suscitata dalla guerra e dalle sue atrocità, in cui l’uomo tutto intero, spirito e corpo, è costretto ad af-frontare prove terribili: una infer-nale palude della ragione da cui è possibile fuggire solo non dimen-ticando mai, e soprattutto mai tra-dendo, a qualsiasi costo, la propria umanità. Si tratta della continuazione di quel Kappusta edito negli anni ‘70 e che ha riscosso enorme successo tra i lettori: da una parte la depor-tazione in Germania durante l’ulti-mo conflitto mondiale e gli anni bui della guerra; dall’altra una testimo-nianza preziosa della vita tedesca nei giorni che segnarono la fine del Terzo Reich. Su tutto aleggiano e si riaffermano quelle convinzioni che sono parte sostanziale dell’autore e che nelle sue opere trovano sempre esplicitazione: “l’uomo disarma-to, ma corroborato nell’animo, è in grado di vincere ogni bruttezza ed ogni sopraffazione” - “la liber-tà, nella sua più alta espressione,
è sofferta conquista dello spirito, non dato di acquisizione naturale”. In marcia. Da Holzminden (“si spezzava il filo che ci aveva uni-ti alla vita della fabbrica per tanti mesi”) verso l’ignoto che, “a mo’ di falco impietoso piombava sulla pre-da stanca e alla deriva, per finirla, ghermirla, portarsela via”. Si parte, si marcia, si cammina, ma non si sa la destinazione, non si intravede quale destino attenda questi uomi-ni; forse ne sono ignari anche colo-ro che li mettono in riga. Ed allora nella mente brulicano le speranze, le illusioni, le delusioni, la paura.... Ma ci sono anche i morsi della fame che di giorno in giorno si avvertono sempre di più e se ne vedono i se-gni sul fisico di ciascuno. Sofferen-ze e privazioni ovunque, di contro alle quali si pongono come uniche risorse “la nostra intensa forza di resistenza, la nostra volontà di non soccombere”. Un lungo viaggio si svolge attra-verso luoghi ovviamente scono-sciuti, ora ospitali ora meno; si av-
verte qualcosa di nuovo, di diverso, nelle contrade, nelle città, tra la gente: situazioni e circostanze della vicenda bellica che, in un modo o nell’altro, si sta avviando verso una conclusione. Poi finalmente “quel pomeriggio afoso, ma lassù fresco abbastanza, del 19 agosto 1945, lo salutiamo tutti più o meno malinconicamente come il momento del nostro bat-tesimo civile”. Lassù, cioè alla sta-zione del Brennero, ormai liberi! Un momento pensato, intravisto spesso in maniera veramente meno amorfa e impersonale: “Chissà come ci accoglieranno, quanto sarà e dovrà essere commovente l’in-contro con gente della nostra terra; sbucheremo da un mondo perduto, vedranno visi e volti di uomini, di ragazzi che sentono, pensano, par-lano come loro!” In realtà “Niente bande, niente canti, niente abbracci che non fos-sero i nostri, quelli scambiati tra miserabili, vittime della stessa sor-te, gente che aveva avuto la fortuna di ricalcare il suolo della patria”. Ma perché stupirsi? “In Italia, la patria mostrava subito il suo vero volto: era il volto della miseria, del-la distruzione, era il volto di una terra vinta e distrutta. I fischi len-ti e lunghi della locomotiva nella discesa verso Bolzano testimonia-vano della difficoltà di aprirsi la giusta strada sui binari divelti, di riprendere il cammino di una ita ordinata, in mezzo alle rovine e alle devastazioni di ogni genere”. La riconquista della libertà e il ri-torno alla normalità sono duri per tutti! “Rinascere nell’umanità e nella fratellanza era l’opera più ardua, perché investiva tutti noi stessi, il
14 La Rassegna d’Ischia 5/1996
nostro sangue, i nostri sentimenti: più difficile” che provvedere alla mancanza di case, alla penuria di cibo, alla riconsacrazione di fem-mine senza più pudore né amore, mentre i bambini maledivano chi
aveva voluto darli alla luce in que-sto mondo di pazzi, essi che per vo-lontà del padre avrebbero dovuto essere lo specchio della nostra co-scienza pulita”.
Raffaele Castagna
Sono uno di loro!(...) Il grido di gioia per la recuperata libertà resterà nella mia gola ancora per tre giorni: tanti saranno quelli della lunga attesa, della lunga corsa attraverso la penisola, prima di intravedere, nel lontano e per me in-dimenticabile 23 agosto 1945, Il Vesuvio, l’ancora Istintiva di salvezza per ogni napoletano malato d’amore per la sua terra, gigante di bontà e di morte, di feracità e di distruzione. Vi arrivo di mattino, a Napoli, in quella che mi dicono essere la sua stazione, un groviglio di binari divel-ti, di vagoni sventrali, che giacciono immoti al sole, mula testimonian-za di un passaggio di distruzione di rapaci venuti dal cielo per segnare il volto di questa città. Sono chilometri di squallore, tre o quattro, che ci separano dal centro della città, chilometri che scompaiono sotto l’in-cedere delle nostre incerte gambe, tra strade polverose, piene di buchi, sconnesse, smangiate, sfregiate. Gli occhi osservano, sentimenti di gioia e di paura si mescolano con l’accoglienza muta di isole di miseria, ridotte a fredda testimonianza di vita consunta di ragazzi che guazzano in una pozzanghera, di gente che vende sigarette di fabbricazione americana. Procediamo in tanti, in una teoria di fagotti, di pacchi, di stracci, di vali-gie, di sacchi, di corpi smagriti, di gambe esili, di fanciulli denutriti che si sforzano di tenere il passo sotto l’azione degli incitamenti materni. Questa città morta e viva, questa terra di dolore e miseria, mi accoglie così, come uno dei tanti suoi figli che In un giorno qualsiasi del suo triste dopoguerra è sceso da un treno al binario X, il solo funzionante, in una stazione spettrale, presente più nella fantasia che nella realtà. Man mano che cammino, man mano che la mia ansia, la mia paura, la mia voglia di confondermi, di far mostra di comportarmi come uno qual-siasi mi prendono, sento che si libera in me un qualcosa di indefinibile, una commozione vecchia e nuova, profonda e singolarissima. Ilo tutta-via la forza di chiedere spiegazioni ad uno dal viso aperto, intelligente; gli chiedo se, per il centro della città, devo continuare a procedere così, per quella strada polverosa e sconnessa. La stessa naturalezza, lo stesso senso di leggerezza conservo quando metto piede su di un tram, uno qualsiasi di quelli che andavano a Capo-dimonte, collegando la periferia al cuore di Napoli, e mi trovo davanti ad un fattorino, un tipo smunto e sottile come uno spillo, che ripetendo una cantilena abituale mi fa: - Signori, biglietti! -. Conservo ancora tanta dignità da nascondere a me stesso che sono uno di quelli che possono aver titolo a viaggiare così, senza l’obolo per il tra-sporto.- Prego, faccio! - Tiro fuori dalla tasca un rettangolo di carta grande come un fazzoletto: la testimonianza di un affetto che mio padre mi soffiò nelle carni, nel tri-ste giorno della mia deportazione, porgendomi con le lagrime agli occhi un foglio da cento lire, fruito di oneste fatiche.Lo do al fattorino e aspetto il resto. Nascondo talloncino e soldi nuovi in una tasca sdrucita del mio logoro e sporco vestito.Seduto vicino a un finestrino aspiro l’aria calda, l’aria della città.Sono veramente uno di loro, mi sento finalmente libero!
(da Ritorno da Stige di Enrico Monti - cap. LIII)
I GIOCHI DELLE SCIENZEla edizione -1995-96
In occasione dell’Anno Europeo dell’I-struzione e della Formazione l’IRRSAE Campania ha attuato il progetto / Giochi delle Scienze -1995-96 insieme con Fare Scienza, Associazione per l’educazione e la formazione scientifica e tecnologica, che ha elaborato il progetto e si è avvalsa della direzione scientifica del prof. R. Ca-puto, ordinario di Chimica organica della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Finalità prioritarie del progetto sono la promozione, la diffusione e il rafforza-mento della cultura scientifica e tecnolo-gica di base, indirizzata alla formazione di un cittadino scientificamente educato all’osservazione di fenomeni e processi e all’analisi dei problemi con concretezza operativa. Questa iniziativa di sperimentazione, che è la prima attuata in Italia, ha visto impe-gnati docenti dell’Università e della scuo-la e rappresentanti del mondo del lavoro ed è stata rivolta specificamente a docenti di Scienze e ad alunni della Scuola Media dell’obbligo, favorendo contatti cultura-li tra allievi e docenti di scuole diverse e promuovendo un’ampia socializzazione delle esperienze formative tra gli opera-tori scolastici, la ricerca scientifica e tec-nologica e il mondo del lavoro. Il progetto / Giochi delle Scienze ha im-pegnato nelle ore curricolari ed extracur-ricolari e attraverso attività di aggiorna-mento, svoltesi presso l’ITI “F. Giordani” di Napoli, 60 scuole della Regione Cam-pania e oltre 3000 alunni, che in parte hanno prodotto lavori grafici e in parie sono stati preparati alle selezioni, consi-stenti nella risoluzione di un test di que-siti a scelta multipla. Circa 1200 alunni hanno preso parte alle selezioni effettuate nelle singole scuole, 800 hanno parteci-pato alle selezioni provinciali (6 maggio) in 10 scuole della Campania e 250 alla selezione regionale (25 maggio) presso il Dipartimento di Chimica organica della Facoltà di Scienze. Gli altri alunni hanno presentato i lavori grafici in mostre tema-tizzate organizzate in contemporanea alle selezioni provinciali. La I edizione 1995-96 de / Giochi delle Scienze si è conclusa il 7 giugno 1996, presso la Facoltà di Farmacia dell’Univer-sità degli Studi di Napoli Federico II, con la mostra dei migliori lavori degli alunni e con la premiazione dei vincitori della selezione regionale. Visto il notevole in-teresse suscitato, si ritiene che l’iniziativa verrà estesa a livello nazionale. Inoltre, nella prima decade di settembre i docenti delle 60 scuole della Campania partecipanti al progetto esporranno e il-lustreranno in una mostra di base il ma-teriale prodotto durante sperimentazioni finalizzate alla promozione della cultura scientifica.
16 La Rassegna d’Ischia 5/1996
Rassegna Libri Premi
Continua tuI racconti scritti a quattro mani con ... Cerami, Frutterò & Lucentini, La Capria, Maraini, Nievo, Ravera, Starnone, Tabucchi
A cura di Antonio Pascale e Francesco Piccolo Edizioni minimum fax, Roma, 1996
I racconti sono il risultato di un concorso in cui, partendo dall’in-cipit di un autore illustre, bisognava inserire la storia raccontata dall’aspirante scrittore. Pubblichiamo il lavoro di Carla Pesciolini, già nota ai lettori della Rassegna d’Ischia.
A sudRacconto scritto a quattro manida Vincenzo Cerami e Carla Pesciatini
C’è chi sorride al padrone per paura che il cane gli salti addosso. E c’è anche chi sorride al cane per rispetto del padrone. Fortunato apparte-neva a questa seconda specie umana. Tanta era la sua ansia di piacere che aveva imparato a indossare con naturalezza ogni abito. Riusciva sempre a incarnarsi nell’idea che gli altri si erano fatta di lui. Per que-sto si sentiva amato e poteva fare sogni tranquilli. Ma quel giorno la sorte gli tirò un brutto scherzo. Qualcuno gli chiese involontariamente di essere ciò che mai avrebbe potuto essere. Forse se stesso, chi sa.Finalmente, quando ormai era convinto di aver sbagliato strada, vide il bivio con la Madonnina di pietra. Girò e si vide di fronte una sali-ta dall’asfalto sconnesso. In alto sulla sinistra, circondato dai piop-pi, apparve un convento monumentale, austero come la faccia d’un vecchio. Senza fermarsi Fortunato guardò la mappa segnata a matita sul foglietto, calò la marcia e prese una mulattiera ripida, subito sulla destra. Chiuse i finestrini perché il vento spingeva in macchina la terra sollevata dalle ruote. Dietro a quella polvere il sole s’era ingiallito. Un arbusto secco rimbalzò sul cofano e volò via. Da un momento all’altro
s’aspettava un grande cancello di ferro fuso, con le colonnine di granito rosso.
Oltre il cancello sarebbe apparsa la costruzione massiccia: agli angoli i contrafforti, sporgenti sul traccia-to perimetrale, quasi delle torri che, però, restavano mozzate all’altezza del letto; questo concluso a filo delle mura, l’intonaco grigio come le crete circostanti; al primo piano le anguste finestre e a pianterreno le feritoie, protette da sbarre longitudinali. Così la ricordava Fortunato. Né ca-stello, né villa, ma casa baronale da paese dei briganti, dove i briganti
peggiori non sempre erano quelli di strada. Già una volta c’era stato, ma senza la mappa che Caterina, sua so-rella, aveva disegnato, non avrebbe saputo ritrovarla. Nel passato appartenevano ai Leosi-no, i quali, alla fine di ogni estate, l’a-bitavano per qualche settimana; poi tornavano a vivere a Roma o a Na-poli o dove loro piaceva. Lo zio aveva ‘persuaso’ i vecchi proprietari che a vendere a lui la proprietà si sareb-bero risparmiati noie e guai. Forma-lizzato l’acquisto, si era poi installato in quella specie di fortilizio. Intorno vigilavano i campieri, Caterina aveva
assicuralo a Fortunato. Poteva anda-re tranquillo, senza temere agguati. Ogni volta che tornava in Calabria, l’impatto con l’ambiente era per il ragazzo traumatico. A Firenze, dove dagli anni del liceo si era trasferito per studio, dimenticava gli odi che alimentavano la faida fra la sua fami-glia, i Cutro e i Mammoliti, i nemici. 14 a 15,16 a 15 e così via. 19 a 20 era l’ultimo punteggio, segnato dai morti ammazzati, di una interminabile par-tita di sangue. Per reazione all’educazione della famiglia e alla cultura della paura, del sospetto, della violenza e della vendetta, a Firenze Fortunato aveva valorizzato della propria personalità gli aspetti più amabili: la disponibi-lità, la gentilezza, la generosità. Que-sto atteggiamento accattivante verso tutti e in ogni circostanza lo ripagava ampiamente: si sentiva amato e pote-va fare sogni tranquilli. Poteva vivere senza paura, godersi la sua giovinez-za, felicemente vivere la storia d’a-more con Simonetta che lo amava. La sua era, tuttavia, una identità schi-zofrenica, perché, tornando in Ca-labria, ripiombava nell’incubo. Non poteva sottrarsi alla tragedia: gliela ricordavano le vesti nere e il pianto delle congiunte per qualche morto ammazzato di recente; la quieta de-menza della madre, diagnosticata dai medici morbo di Alzheimer, ma per sua sorella una conseguenza della paura e dei dispiaceri. Caterina era la grande officiante della tragedia. Viveva al solo fine della ven-detta. Una crinni, vittima essa stessa della propria spietatezza. Mai un sor-riso. Aveva i caratteri somatici delle donne della famiglia paterna: alta, statuaria, scura, eternamente corruc-ciata come l’immagine della Patria in armi e dura come l’Aspromonte. Sembrava la clonazione di nonna An-gela, che portava quel nome immeri-tamente: era la maga più rinomata di San Luca. Con la stessa indifferenza preparava filtri d’amore e di morte. «Se e destino», diceva, consegnan-doli ai committenti. Credeva davvero di essere nient’altro clic lo strumento di una volontà superiore e questo la liberava dal peso della responsabilità e dai sensi di colpa. A un tale mondo di sentimenti vio-lenti e primordiali, totalmente pri-vo di pietà, Fortunato sempre più si sentiva estraneo. Tuttavia i lacci dell’amore e dell’odio, amore per i
La Rassegna d’Ischia 5/1996 17
suoi, vivi o morti, e odio verso i ne-mici, sentimenti indissolubilmente intrecciati, chiudevano pure lui in spire malefiche. Come poteva dimen-ticare, sulla tomba del padre, la sua maschera di morte, le care sembian-ze ridotte a una massa informe di carne e di sangue? Sempre più For-tunato stentava a capire, ma doveva adeguarsi alla realtà della sua terra, anche contro la propria filosofia e la propria indole. Erano gli anni settanta: a Firenze si esaltava nell’atmosfera libertaria dell’università, in Calabria si ritrova-va nell’abisso degli odi tribali. Quando il padre era stato ucciso, aveva raccontalo la storia familiare a Simonetta, per onestà, per esorcizza-re le paure e per trovare un conforto. La ragazza lo aveva consiglialo a re-agire in modo civile, a denunciare, cioè, gli assassini. Si era lasciato con-vincere, anche perché lui stesso non poteva più tollerare, né tanto meno giustificare la violenza, e aveva rive-lalo a un magistrato tutto quello che sapeva sui delitti. Aveva credulo di poter in tal modo sconfiggere il de-stino.Il cancello si aprì davanti alla mac-china e così la porta d’ingresso da-vanti ai passi di Fortunato, senza che lui avesse toccalo un pulsante di campanello o visto qualcuno. Entrò nell’atrio. «Sali». La voce dello zio proveniva dall’alto, rauca a causa di una ferita riportata in un agguato. Il vecchio attendeva in piedi, in cima allo scalone. Dall’ultimo incontro la sua canizie e la sua magrezza si era-no accentuate. Era sempre più simile a un personaggio biblico, disposto a brandire il coltello anche contro chi amava, per compiacere il suo dio di vendetta, pensò Fortunato. La pelle bruciata dal sole, alla quale le vene davano sfumature violacee, modella-va sulle scarne ossa del cranio un vol-to gotico, dolorosamente espressivo. Filtrava da un lucernario un raggio di sole e un pulviscolo d’oro danzava intorno a lui. «Vieni», invitò lo zio, e Fortunato lo seguì in una stanza. Quello che era stato un salotto pre-tenzioso, era diventato una specie di magazzino. Sui mobili, un tempo di pregio, adesso tarlali e semidistrutti, sulle sedie, sui divani dalla cui tap-pezzeria lacerala fuoriuscivano mol-le e imbottitura di crine, e per terra c’erano giare, casse, ceste, sacchi di iuta, bollicine, damigiane, contenen-
ti concimi e prodotti della terra. Gli specchi damascati dalle muffe, riflet-tevano quel marasma. Nell’aria rista-gnava un odore di polvere e di stantio che toglieva il respiro. «Siediti». Lo zio indicò una sedia libera, di fronte alla poltrona sul-la quale lui già si era accomodato. «È vero quello che dice tua sorella? Che sci un traditore? Ci hai ingua-iati tutti, lo sai? Se nemmeno delle persone di famiglia possiamo più fidarci, non ci sarà più scampo per nessuno». L’amarezza, che accom-pagnava le parole del vecchio, era per Fortunato più dura da sopportare dei rimproveri. Amava suo zio e gli di-spiaceva di essere da lui tacciato da traditore. Si difese dall’accusa di tradimento con veemenza. Spiegò che soltanto quella da lui imboccala era la stra-da per porre fine alla sequela di lutti familiari. Fu un colloquio dramma-tico. E inutile. Alle sue ragioni, lo zio opponeva la propria irremovi-bile convinzione. «Ciò che hai fatto è tradimento e nient’altro». «Hai preso da tua madre, sci un debole. Ora devi ritrattare, non hai alterna-tiva. Non vorrai essere considerato nemico. Con tutte le conseguenze...» Una pausa aveva sottolinealo lugu-bremente l’avvertimento. Così lo zio aveva concluso l’incontro. Quando già Fortunato era in fondo alle scale, gli aveva raccomandato ancora: «Ricordati, devi far venire la ragazza in Calabria. Qui possiamo aggiustare la cosa». Erano ordini dati con tono quasi di supplica. Lo zio era vecchio, forse pure lui stanco di pian-gere. Fortunato non dubitava che avrebbe organizzato senza esitare l’e-liminazione di un nipote-nemico, ma al dolore che ciò avrebbe comportato sperava di sottrarsi. Fortunato uscì quasi di corsa. Salì in macchina, ingranò la marcia e si lasciò alle spalle la casa, ma non i problemi che lo angustiavano. Era confuso e pieno di risentimento. Caterina aveva riferito allo zio i falli in modo da rintuzzarne l’ira, ne era certo: un comportamento spiegabile soltanto con la cattiveria che anima-va sua sorella. La vita a lei non sorri-deva: il ruolo di vestale in una casa ove albergava il lutto era ingrato ma lei trasformava il dolore in rancore e malanimo verso tutti e lutto. Era pure in preda ai dubbi: la scelta che a Firenze era sembrata giusta, ora gli
appariva affrettata, se non sconside-rata. Non aveva riflettuto che anche alcuni membri della propria famiglia avevano da saldare i conti con la giu-stizia. Guidava immerso nei propri pensie-ri, tuttavia non insensibile alla bellez-za della sua Calabria. Il paesaggio era cambialo rapidamente. Lasciata la mulattiera e la collina riarsa, la mac-chia correva sulla strada provinciale, in mezzo agli olivcli, una boscaglia di piante secolari cresciute senza pota-tura, che proiettavano a terra la loro ombra generosa. La frescura permet-teva un rigoglio spettacolare di erbe e di fiori. Il sole, che qua e là penetrava fra i rami, accendeva i colori: verde smeraldo, rosso carminio, giallo. Il grigio argento degli ulivi si stagliava contro il ciclo di cobalto. Il mare da lontano partecipava alla festa, riflet-tendo la folgorante luce del mezzodì. Le cinciallegre si lanciavano richiami e le cicale stridevano rumorose e in-stancabili. Amore per la propria terra e orgoglio di appartenerle, nonostante tutto; questi sentimenti per un attimo can-cellarono dalla mente di Fortunato ogni preoccupazione. La donna si materializzò all’improv-viso davanti alla macchina e Fortu-nato nemmeno frenando con tutta la prontezza e la forza delle quali era capace, riuscì a evitarla. Per fortuna, intento come era a godere il panora-ma e la musica della terra, aveva ri-dotto la velociti!. La donna per l’urto era caduta a terra, ma era rimasta seduta, apparentemente illesa. Una mucca che la stava inseguendo si era arrestata di colpo sul ciglio della stra-da; forse spaventata dalla macchina, o sorpresa per il proprio ardire, os-servava attonita la scena. La donna piangeva sommessamente e si scu-sava, riconosceva il suo torto. Fortu-nato l’aiutò ad alzarsi e la fece acco-modare in macchina. La poveretta, fra le lacrime, raccontò che, mentre raccoglieva i pomodori nella propria terra, era stata caricata dalla mucca eccitata probabilmente dal rosso di un fazzoletto e dei pomodori o chissà da che altro. Per sfuggire all’anima-le, spaventata, si era precipitata in strada. Erano animali bradi, perfidi come i loro proprietari, spiegò. Cal-pestavano e distruggevano i raccolti, ma bisognava sopportare e tacere. Se qualcuno osava recingere la pro-prietà, nottetempo le reti venivano
18 La Rassegna d’Ischia 5/1996
tagliate, divelte le staccionate e per punizione i filari di viti o gli olivi tagliati e i campi di grano bruciati. «Maledetti, maledetti!» Un’ira impotente scuoteva la donna. «Chi riuscirà a liberarci da questo flagello? Chi mai?» Dopo lo sfogo, riprese a piangere quietamente, vittima rassegnata. Fortunato interpretò le ultime parole della donna e il suo pianto come una involontaria richiesta di aiuto. Si sentiva confortato nella sua scelta: avrebbe lottato e avrebbe aiutalo anche la donna a reagire alla sopraffazione.. Se lo voleva, lui era pronto a testimoniare, disposto anche a sostenerla economica-mente in una causa contro chi la vessava. «Non si può fare niente. Sono persone potenti, spietate. Corrompono i giudi-ci. Ma tu chi sci, per credere di poterli contrastare?»Lui disse il proprio nome.«Sei nipote di Antonino ‘u braghatu?» Alla risposta affermativa del ragazzo, la donna prese a strilla-re come un’ossessa nel giorno di San Valentino: «Ferma! Ferma! Fammi scendere!» Fortunato non sapeva a che cosa attribuire quella furia improvvisa. Pensò a un malore della donna, che intanto, discesa a terra, sfogava la sua ira, batten-do con forza i pugni sul cofano della macchina e urlando invettive. «Vigliacco come i tuoi parenti. Non sai chi e tuo zio? Te lo dirò io! E il proprietario delle mucche. Mi hai fatto parlare, vuoi rovinarmi! E allora, devi sapere tutto quello che ho in cuore. Siete la disgrazia nostra, la peste della Calabria. Vai, fai la spia. Vi odio, maledetti! Anche se mi uccidete, vi odierò; vi odierò anche da morta!» Si allontanò, poi, in gran fretta. Correva per la campagna come un animale braccato, che si dovesse nascondere per sopravvivere. Fortunato non aveva avuto il tempo di reagire: era rimasto seduto in macchi-na, pallido, con la mente e il cuore in tumulto. Interpretò l’incontro con la donna come un segno, un tiro della sorte. Tutti na-scono sotto una stella: la sua era una cattiva stella ed era inutile ribellarsi. «Vi-gliacco!»: l’offesa gli bruciava. Anche lo zio gli aveva rimproverato il carattere debole. E se la sua ansia di piacere, il suo bisogno di consenso fossero soltanto paura di farsi dei nemici, pura vigliaccheria’? «Vuoi che ti consideri nemico? ...Con tutte le conseguenze», aveva detto lo zio. La vita non aveva alcun valore per certe persone. Lo sapeva bene. E là, sulla strada assolata, nel paesaggio incantato della bella Calabria, For-tunato prese la decisione: avrebbe ritrattato. In quel momento, forse, chissà, fu veramente se stesso. Sì, avrebbe ritrattato, avrebbe scritto a Simonetta di raggiungerlo e l’avrebbe costretta a ritrattare. Non considerò la possibilità che lei non si piegasse ne alla sua volontà, né alle pressioni e alle minacce di altri. Simonetta bionda, Simonetta sorridente, Simonetta che lo amava non ritrat-tò. Scomparve, vittima della lupara bianca, in un gelido giorno di febbraio, alla vigilia del processo, per il quale era stata convocata come testimone.
La Questione meridionale(Studi e Testi) di Pietro BorzomatiSocietà Editrice Internazionale, Torino - pp. VI+213 lire 23.000
Raccolta antologica, accuratamente contestualizzata da un saggio intro-duttivo che ristruttura il problema meridionale liberandolo da stereotipi e luoghi comuni, il cui pregio sta nel fornire una esauriente panoramica di lutto il pensiero “meridionalista”. L’Autore infatti riserva una particolare attenzione ai “minori” rappresentanti di questo pensiero, normalmente ignoti alle antologie tradizionali, fornendo in questo modo criteri di giudi-zio più che convincenti per valutare le contemporanee riduzioni e sempli-ficazioni (a volle di comodo) della questione meridionale. La documentazione comprende studi, analisi e proposte dal 1655 al 1987 di estrazione diversa, ecclesiastica, civile, culturale, letteraria. Mette in tutti i casi a diretto contatto con protagonisti, noti, meno noti e sconosciu-ti, i quali con il pensiero e l’azione, con amore e intelligenza, hanno pro-posto o attuato programmi volli alla formazione delle coscienze e alla re-sponsabilizzazione per il bene comune. È soprattutto in piccoli centri che
questi interventi sono stati attuali, centri isolati per l’assenza di vie di comunicazione, nei quali prospera-vano le clientele e la rassegnazione produceva apatia e autoemargina-zione. Uno strumento di lavoro ricco di potenzialità per l’abbondanza dei materiali e per l’approccio storico di grande respiro con cui il tema viene affrontato.
La Rassegna d’Ischia 5/1996 19
Le pagine 19 -34 contenevano l’inserto riguardante il libro
di Giulio Iasolino, che pubblichiamo, qui allegato,
nell’edizione integrale
Top Related